Fonti del diritto nella storia italiana
description
Transcript of Fonti del diritto nella storia italiana
PERIODO MONARCHICO LIBERALEIn tale periodo la forma di governo una monarchia costituzionale pura di tipo dualista fondata su due centri di potere, Parlamento e Sovrano, ma nella quale il secondo ha un ruolo predominante. Il re ha poteri sostanziali: non solo titolare dell'esecutivo ma concorre a quello legislativo mediante il potere di sanzionare le leggi e di nomina dei membri del Senato.
Sistema delle fonti: Carta costituzionale, leggi materialmente costituzionali, fonti regolamentari, consuetudini.
Statuto albertino. Lo statuto una Carta concessa dal re di Sardegna Carlo Alberto, in cui manca la partecipazione popolare (elemento imprescindibile nella moderna concezione di Costituzione). Lo Statuto nasce in un periodo (rivoluzione francese) in cui emerge l'esigenza di mettere per scritto alcuni diritti e libert fondamentali, indipendentemente poi dalla loro effettiva garanzia. Pi che la sinteticit ci che caratterizza lo statuto l'ampia discrezionalit riconosciuta al legislatore nel definire concretamente i limiti di esercizio dei diritti disciplinati: lo statuto , infatti, una costituzione flessibile che pu essere modificata con legge ordinaria, non essendovi tra queste fonti alcun rapporto gerarchico (la concezione di legge, a meta '800, quella di legge senza limiti). Lo Statuto resta, tuttavia, una Carta che tendenzialmente si impone al legislatore grazie in particolare alla generalit dei principi contenuti (esso scritto in francese e poi tradotto in italiano: non fa riferimento alla realt concreta italiana).
Leggi materialmente costituzionali. Oggi le leggi costituzionali sono formalmente cost., essendo sottoposte ad un iter aggravato che le differenzia da quelle ordinarie. Nel periodo liberale non sono sottoposte ad alcun procedimento aggravato ma hanno ad oggetto materie costituzionali (cittadinanza, sistemi elettorali, organi statali).
Legge ordinaria. Il Parlamento formato da due camere, Camera dei
deputati e Senato: solo la prima effettivamente rappresentativa del
corpo elettorale (anche se eletta su base censitaria e maschile),
essendo la seconda composta esclusivamente da membri nominati dal
re con carica vitalizia.
Il Re interviene nel procedimento di formazione della legge
mediante la sanzione (terza approvazione), necessaria affinch la
legge entri in vigore:
sanzione, tuttavia, scontata e di valore limitato.La legge ha
carattere illimitato, non essendovi alcun rapporto gerarchico. Non
esclusa la possibilit che si verifichino vizi formali (di
procedimento): ma in tal periodo non si manifestano e, in ogni
caso, il soggetto predisposto al controllo
(magistratura-Cassazione) fortemente influenzato dalle forze
politiche.
Potere normativo del Governo. Esso si estrinseca attraverso i
decreti e i regolamenti, rispettivamente fonti primarie e
secondarie del diritto.Il decreto legislativo approvato dal governo
sulla base della delega conferitagli preventivamente dal
Parlamento.Il decreto legge approvato dal governo in caso di
necessit urgenza (intervento successivo del Parlamento).I decreti
non sono disciplinati dallo Statuto ma si affermano nella prassi:
durante le guerre di indipendenza emerge l'esigenza del Parlamento
di delegare alcuni compiti legislativi al Governo, affinch
intervenga tempestivamente. Quanto ai regolamenti, in questo
periodo, vi solo il r. esecutivo con cui il Governo d attuazione
alla legge parlamentare.
Contratto collettivo di lavoro. Esso disciplina le condizione
giuridiche ed economiche di una determinata categoria di
lavoratori. Il sindacato dei lavoratori la linea attraverso cui si
fa strada l'esigenza di attribuire ai contratti collettivi il
riconoscimento di fonte del diritto.
PERIODO FASCISTAA partire dal 1925, Mussolini procedette alla
formulazione di nuove leggi destinate a stravolgere definitivamente
i connotati dello stato liberale:per questo motivo dette esse sono
dette leggi fascistissime, pur essendo approvate in seguito leggi
ancor meno liberali (l. razziali). Esse sono 4:
L. sulle attribuzioni capo del Governo sui poteri normativi del
governo - sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro sulla
magistratura.
Di rilevante importanza la prima di esse, la legge 100/1926, relativa alle fonti del diritto (prima disciplina in materia di decretazione del governo).Non un caso che ci si interessa d specificare la potest normativa primaria del governo: in uno stato che si trasforma in stato totalitario del tutto naturale l'accentramento dei poteri normativi del Governo a scapito del Parlamento, perch la gestione dello stato trova il maggiore significato nella eliminazione del pluralismo (a livello istituzionale, ideologico).L'eliminazione del pluralismo, trasportata al sistema delle fonti del diritto, si traduce nell'accentramento dei poteri nel soggetto pi omogeneo e controllabile del Governo, nonostante il Parlamento sia scarsamente rappresentativo perch eletto ad una sola camera e perch il corpo elettorale ridotto. Ma anche questa parvenza di rappresentanza viene eliminata: una ulteriore legge elimina la camera dei deputati trasformandola in camera dei fasci e corporazioni (rappresentativa di categorie).
A livello di fonti del diritto si ha la prima disciplina dei
decreti governativi:gi nel periodo monarchico liberale, pur in
assenza di disciplina, si ha un duplice intervento normativo del
governo, mediante decreto legge e legislativo.
DECRETO LEGGE. Attualmente, in base all'art. 77, il Governo pu lo
adottare quando ricorrano casi straordinari di necessit ed urgenza.
I suoi effetti sono immediati ma provvisori: il Governo, il giorno
stesso della adozione del decreto, deve presentare questo alle
Camere affinch sia convertito in legge.Se le camere non convertono
il decreto in legge ordinaria entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione, il decreto decade con effetto retroattivo (perde
efficacia ex tunc): viene ripristinata la situazione precedente
alla sua entrata in vigore.La legge del 1926 prevede il presupposto
di situazioni straordinarie di necessit ed urgenza ma intervento
delle Camere nei due anni successivi alla sua immediata entrata in
vigore: la mancata approvazione determina inefficacia del decreto
non retroattiva (ex nunc), facendo salvi dunque gli effetti
prodotti.DECRETO LEGISLATIVO. Attualmente, in base all'art. 76,
l'esercizio della funzione legislativa non pu essere delegato al
Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e oggetti definiti. Se la legge
delega non contiene tali elementi imprescindibili o il Governo non
si attiene a quanto stabilito dal Parlamento si ha
incostituzionalit rispettivamente della legge delega e del decreto
legislativo.
La legge del 1926 prevede la delega del parlamento senza imporre
alcun contenuto: possibile quindi la delega in bianco (senza
limiti). Trasferimento del potere normativo al governo sulla base
di una semplice delega.
FONTI IN MATERIA DI LAVORO.Il contratto collettivo di lavoro dal
punto di vista sostanziale un atto normativo (perch riguarda una
intera ampia categoria di persone): per questo i sindacati chiedono
che abbia valore di legge. Questo accade nel 1926 con la legge n.
563, la quale raggiunge un risultato che paradossalmente
sembrerebbe accogliere le aspettative e le richieste del movimento
operaio (paradossalmente dato che il regime fascista non di certo
caratterizzato da principi favorevoli al pluralismo, tra cui quello
sindacale). Questo apparente paradosso storicamente chiarito dal
patto di Palazzo Vidoni stipulato l'anno precedente tra i datori di
lavoro (la Confindusria) e il Governo, in base al quale i datori
stipuleranno contratti solo con il sindacato nazionale fascista:
fine sostanziale del pluralismo sindacale, essendo poi lo strumento
essenziale del sindacato, per realizzare i suoi fini, quello di
stipulare i suoi fini, se si decide che con determinati sindacati
non potranno essere pi stipulati contratti chiaro che il ruolo di
quel sindacato si verr ad annullare.
Solo apparentemente paradossale perch, in realt, pienamente in
linea con le finalit proprie dell'ordinamento fascista: essendo il
sindacato fascista strettamente legato con il Governo (come del
resto il partito unico fascista), anche la stipulazione di
contratti viene regolata e disciplinata sotto il controllo di
quest'ultimo: quindi conveniente che si riconosca al contratto
collettivo stipulato da questo unico sindacato la finalit e
l'efficacia di fonte del diritto.Il risultato lo stesso dei
decreti, accentrare la decisione e i poteri normativi nel
Governo.
Anche la principale novit dell'ordinamento fascista viene di
fatto a non realizzarsi: fonti corporative.Nell'articolo delle
preleggi che elenca le fonti del diritto vi sono tra parentesi
quadra le fonti corporative. Tra parentesi poich non pi esistenti,
anche se sarebbe pi corretto affermare che non sono mai
esistite.
Le fonti corporative sarebbero dovute essere una fonte sostitutiva
dei contratti collettivi di lavoro: perch le corporazioni,
comprendendo al suo interno sia la rappresentanza dei datori di
lavoro sia la rappresentanza dei lavoratori, avevano la possibilit
di stabilire regole che riguardassero sia la disciplina giuridica
del rapporto di lavoro sia la disciplina economica. La
realizzazione dell'ordinamento corporativo non viene realizzata
perch manca quel minimo di democraticit all'interno delle
corporazioni che renda possibile l'esercizio di questi poteri. I
contratti collettivi continueranno, nonostante la previsione, ad
essere approvati da parte del sindacato fascista.
PERIODO COSTITUZIONALE PROVVISORIO (transitorio)Fase provvisoria che si estende dalla caduta del fascismo all'entrata in vigore della Costituzione: situazione istituzionale difficile dove parte degli organi indispensabili non esiste pi e parte neutralizzata in attesa della scelta tra repubblica-monarchia, ma in cui si fondano le radici delle scelte, molte delle quali saranno tradotte nella Costituzione e in cui essa nasce come fonte del diritto.
25/7/1943 (revoca di Mussolini incarico a Badoglio). Il tentativo delle forze politiche di Governo quello di restaurare la forma di stato liberale precedente al periodo fascista: si tratta della cosiddetta visione parentetica del fascismo o di restaurazione. Si tenta di ripristinare la situazione precedente mediante l'eliminazione, in primo luogo, degli elementi pi evidenti del periodo fascista: scioglimento del Gran consiglio del fascismo, del Partito nazionale, degli organi corporativi, del Tribunale speciale per la sicurezza dello stato e della Camera dei fasci e delle corporazione (con la previsione che entro 4 mesi debba essere eletta direttamente dal corpo elettorale la nuova Camera dei deputati).
Ma i Comitati di liberazione nazionale si oppongono alla
restaurazione e pongono il problema istituzionale: esigenza di un
testo che fissi regole nuove e che segni una rottura con il periodo
precedente (in forte contrapposizione con la visione parentetica).
Questa richiesta sfocia nel patto di Salerno che d vita
normativamente alla prima fonte che disegna l'assetto provvisorio,
il decreto legge 151/1944 noto come Prima costituzione provvisoria,
il quale non alcun elemento proprio di una Costituzione, ma cos
definito in quanto fissa un assetto momentaneo (soprattutto delle
fonti) in attesa di quello che sar l'atto fondamentale che fisser
le nuove regole. Si tratta di un Decreto legge poich esiste solo la
possibilit di questa fonte: essendo stata sciolta la Camera dei
fasci e non essendo ancora stata eletta la nuova camera, infatti,
il Parlamento non esiste come bicamerale e dunque le leggi non
possono essere approvate. Il decreto traduce a livello normativo il
patto di Salerno con la tregua istituzionale (tra Cnl e
monarchia).
In primo luogo, la prima Costituzione provvisoria fissa il problema
istituzionale stabilendo come realizzare la partecipazione popolare
alla nuova Costituzione: si sceglie la forma della Assemblea
costituente, e cio si decide che la nuova Costituzione sia
approvata da parte di una assemblea eletta secondo il criterio
proporzionale direttamente dal corpo elettorale. Si tratta di una
decisione che assume una portata di rilievo se integrata con la
legge elettorale dell'anno successivo ('45), che riconosce per la
prima volta il voto alle donne.Il decreto stabilisce poi che
l'assemblea dovr, in primo luogo, scegliere tra Monarchia e
Repubblica: presupposto essenziale per costruire una
costituzione.
Il decreto stabilisce che il potere normativo, nel frattempo,
spetti al Governo, essendo esso l'unico organo ad avere effettiva
possibilit di operare.
Il decreto 98/'46 apporta delle modifiche alla prima Costituzione provvisoria: per questo motivo detto Seconda Costituzione Provvisoria.In primo luogo viene attuata la previsione della Assemblea costituente, fissando nel 2/6/1946 la data della sua elezione. Una volta eletta, l'Assemblea sar l'unico organo rappresentativo: per questo si stabilisce che il Governo abbia nei suoi confronti un rapporto di fiducia.Data la presenza di un organo direttamente rappresentativo, vengono poi sottratte al Governo tre materie e assegnate alla competenza dell'assemblea: materia elettorale, costituzionale, internazionale.Quanto alla scelta istituzionale, il secondo decreto stabilisce che essa non spetti pi all'Assemblea costituente bens al popolo, che esprimer la propria volont mediante referendum indetto lo stesso giorno della sua elezione.
Il referendum istituzionale d come risultato la vittoria della Repubblica, ma mostra un'Italia spaccata in due (dalla circoscrizione umbra di Perugia-Terni-Rieti al Nord vince la repubblica, da questa circoscrizione al Sud la monarchia). Se fosse rimasta la prima Costituzione provvisoria, la assemblea avrebbe votato ugualmente per la Repubblica ma in una proporzione enormemente superiore (85%).Quanto alla elezione della Assemblea costituente, tre sono i partiti che emergono sugli altri raccogliendo da soli il 75% dei voti: Democrazia cristiana (35%) Partito socialista (20%) Partito comunista (19%).
Si costituisce cos la Assemblea che ha, al suo interno, due
profili differenti:
- assemblea come Parlamento, che ha il compito di approvare leggi e
dare la fiducia al Governo (aspetto che guarda al
contingente);
- assemblea come Costituente, che ha il compito di creare la
Costituzione.In questo secondo senso la Assemblea non deve andare a
colpi di maggioranza ma, anzi, trovare raccordo tra le varie forze
politiche componenti la stessa: creare una Costituzione significa
individuare punti condivisi, di fissarli come principi generali e
attribuirli un carattere quanto pi duraturo.
Primo profilo: assemblea come Parlamento. Il potere normativo
essendo il pi importante spetta all'organo direttamente
rappresentativo del corpo elettorale: nella situazione
immediatamente successiva alla elezione, invece, esso riconosciuto
(tranne che in tre materie) ad un organo non rappresentativo. Per
questo, si tenta di far riappropriare l'assemblea del potere
normativo generale mediante una modifica del regolamento della
Camera dei deputati, con cui si prevede che:
- siano istituite in seno alla Costituente 4 commissioni in sede
legislativa competenti per materia;
- che il Governo obbligato a sottoporre tutte le sue iniziative
all'esame di una delle 4 commissioni della Assemblea che, a loro
giudizio insindacabile, decideranno se dare il nulla osta al
Governo (come generalmente avviene) oppure trattenere la materia e
farne una legge dell'Assemblea costituente.
Cos si ottiene il risultato che almeno teoricamente titolare del
legislativo torna ad essere l'assemblea costituente: tutte le volte
che il Governo fa un decreto, esso deve essere necessariamente
autorizzato dalla Commissione competente.Ma essendo l'assemblea
impegnata ad elaborare una Costituzione, quasi sempre viene dato il
nulla osta al Governo.
Seconda profilo: assemblea come Costituente.La riunione della
assemblea fa emergere evidente come non sia possibile realizzare
all'interno della stessa l'elaborazione del testo costituzionale:
viene nominata una commissione di 75 costituenti con il compito di
elaborare un progetto di costituzione. Prima della elezione (tra 44
e 46), era stata creata la commissione Forti che affrontasse gli
aspetti pi importanti e discussi cos da fornire alla assemblea,
senza alcun carattere vincolante,una serie di strumenti.La
commissione dei 75 si divide in 3 sottocommissioni, che affrontano
temi ed argomenti differenti: 1) diritti civili e politici; 2)
organizzazione dello stato e degli enti locali; 3) rapporti
economici e sociali.
La seconda sottocommissione, essendo particolarmente ampia, si
divide in due sezioni (stato regioni ed enti locali).
L'assemblea ha al suo interno tre diverse culture:
social-comunista, cattolica, liberale. Nel fare la Costituzione
necessario superare le particolarit e stipulare un compromesso tra
forze politiche che su molti temi si trovano su posizioni
nettamente contrapposte: per cui il compromesso fondato
essenzialmente su un principio di tolleranza delle varie
posizioni.L'elemento che comunque rende unite e concordi tutte le
varie ideologie e posizioni presenti in assemblea quello di evitare
per il futuro i rischi di un assetto statale totalitario. E' molto
chiaro e presente il periodo nazifascista appena trascorso cos come
le limitazioni dei diritti fondamentali avute sotto forma di
apparente democrazia (di voto da parte della maggioranza): lo scopo
fondamentale della Costituzione , quindi, quello di fissare alcuni
valori e principi che devono essere preservati e osservati da
chiunque perch posti su un livello superiore. Questo spiega il
carattere rigido della costituzione e l'impossibilit della legge di
modificare o negare questi principi fondamentali.
Evitare il totalitarismo e un ritorno al passato, necessita di
garanzie che tali principi siano effettivamente tutelati: oltre al
carattere rigido della Costituzione occorrono soggetti garanti
devono essere neutrali (e non di parte, altrimenti non sarebbe
eliminato il rischio di totalitarismo). La costituzione prevede:-
il Capo dello stato: fuori dai poteri statali, espressione della
unit nazionale;- la Corte costituzionale: giudice della conformit
della legge alla costituzione;
- la Magistratura: definita imparziale, autonoma, indipendente (dal
potere politico, per garantire al di fuori da qualunque tipo di
indirizzo politico il rispetto di alcuni valori
fondamentali).
La Costituzione ha alla base due esigenze, che nelle prime
moderne espressioni di testi costituzionali, sono anche visivamente
separate:
- la prima di stampo giusnaturalistico, in base a cui esistono dei
diritti inviolabili dell'uomo (fondamentali) che prescindono dalle
scelte di uno Stato perch propri, connaturati all'essenza stessa
della persona umana.
La tutela della persona umana rappresenta generalmente la prima
parte della costituzione;- la seconda che si richiama al contratto
sociale (Rousseau): la sovranit popolare, nelle democrazie moderne,
viene inevitabilmente trasferita ai rappresentanti che la
esercitano secondo regole, modalit e procedimenti espressamente
regolati. Ecco che la seconda parte della Costituzione riguarda,
invece, il tema della organizzazione dello Stato apparato e,
dunque, prevede gli organi di vertice, i rapporti che vi
intercorrono, le loro funzioni, i garanti.
Spesso i diritti fondamentali sono contenuti in un preambolo
(Cost. francese) separato dal resto della Costituzione,
rappresentata poi dal tema della organizzazione dello stato. Questo
caratterizza le prime costituzioni di fine 700 e della prima met
800 (Statuto albertino), per poi arrivare al concetto moderno di
costituzione che richiede la presenza di almeno tre elementi:
- e. formale: la costituzione deve risultare dalla redazione di
testo scritto, solenne, pubblicato, conoscibile;
- e. finalistico: la costituzione ha la funzione di limitare il
potere politico e di tutelare le libert dei cittadini;
- partecipazione popolare, motivo per cui lo statuto albertino non
per questo qualificabile come costituzione. La partecipazione pu
avvenire in maniera diversa: in Italia si ha una votazione con cui
si elegge una Assemblea con il potere costituente, e cio col potere
di elaborare una carta costituzionale.
Il concetto di potere costituente si contrappone a quello di potere
costituito.
Il primo, pur eletto in maniera identica a quella in cui si elegge
un Parlamento, ha il potere di stabilire regole a livello
costituzionale, e cio il potere di fissare il nuovo ordinamento
costituzionale senza incontrare alcun tipo di limite.Il Parlamento,
massimo organo rappresentativo del corpo elettorale eletto nel
1948, un potere costituito: i suoi poteri sono limitati dalla
Costituzione.
Il parlamento pu operare al massimo livello, anche modificando la
Costituzione con una legge di revisione, ma tutto entro i limiti e
le regole fissati dal potere costituente. Se non rispetta quelle
regole compie un colpo dello stato, consistente nel cambiamento
delle regole costituzionali senza il rispetto dei principi, delle
modalit e dei procedimenti previsti a livello
costituzionale.
TIPI DI COSTITUZIONEIl potere costituente ha di fronte a s una
pagina bianca, nel fissare i contenuti ma anche nel determinare
nell'insieme le caratteristiche della costituzione.
1. Costituzione rigida o flessibile.
Ne sono esempio la nostra Costituzione e lo Statuto
albertino.
Per assicurare alla Costituzione una continuit nel tempo e per
evitare che il suo contenuto sia facilmente modificato, i
costituenti hanno previsto che la costituzione possa essere
modificata o integrata attraverso un particolare procedimento
connotato da una serie di aggravamenti, togliendo al Parlamento la
possibilit di modificarla mediante semplici leggi ordinarie.Questa
qualit differenzia la Costituzione dallo Statuto albertino che, in
quanto modificabile con atti normativi del parlamento e del
governo, era caratterizzato dalla flessibilit, pur essendo
collocato al vertice del sistema delle fonti.
Il passaggio dallo stato di diritto allo stato costituzionale la
conseguenza della rigidit della Cost. poich la legge incontra dei
limiti: scopo della Cost. quello di porre limiti alla maggioranza
(essa per definizione anti-maggioritaria).Stato di diritto come
caratterizzato dalla subordinazione di tutti i soggetti (compresi
quelli pubblici) alle regole del diritto, che trovano la loro
massima espressione nel principio di legalit (la legge non ha alcun
limite).
2. Lunga o breve.
La Costituzione pu essere composta da una pluralit o meno di
articoli. Generalmente le costituzioni lunghe sono espressione di
situazioni politico-sociali particolarmente complesse, in relazione
alle quali si pone l'esigenza di una rappresentazione globale delle
stesse.3. Costituzione Programma o bilancio.
Questa distinzione fa riferimento al particolare momento storico e
situazione politica in cui si inserisce la necessit di una
Costituzione: pu capitare che ci sia l'esigenza di rottura con
l'ordinamento precedente e di creazione un nuovo ordinamento
costituzionale fondato su basi e principi diversi. In tal caso, la
costituzione fissa una serie di previsioni, istituti, principi da
realizzare ma che inevitabilmente non esistono nel momento in cui
essa entra in vigore.L' assemblea Costituente prevede le Regioni,
il CSM, la Corte costituzionale, il Referendum abrogativo, tutti
istituti che non esistono: l'obbiettivo proprio quello di creare un
ordinamento nuovo e diverso dal precedente.
Queste Costituzioni sono dette programma in quanto pongono alle
forze politiche un programma vincolante, dovendo i principi e gli
istituti previsti essere attuati e rispettati: ecco perch l'entrata
in vigore di una C. programma apre necessariamente una fase di
attuazione della costituzione.Le Costituzioni bilancio
rappresentano, invece, una situazione in cui ci sono forze
politiche che hanno raggiunto un certo risultato
politico-istituzionale e che vogliono formalizzare lo stesso: la
Costituzione, dunque, contiene istituti preesistenti ed attuati ed
ha l'obbiettivo non di modificarli bens di confermarli e
stabilizzarli.
Formale e vivente (o materiale/sostanziale).Con Costituzione
formale, come si desume dal termine, si fa riferimento a quello che
il contenuto oggettivo del testo (139 articoli + disposizioni
transitorie e finali). Con Costituzione vivente si indica una parte
ristretta rispetto alla C. formale, ed in particolare quella
effettivamente attuata.
Es. Le regioni a statuto ordinario sono attuate a partire dal
1972-73, 25 anni dopo entrata in vigore della Costituzione; ma la
loro disciplina presente nella Cost. (al Titolo V Parte II) sin dal
1/1/'48: si tratta, dunque, di C. formale dal 1948 ma vivente dal
72-73 quando effettivamente quella parte viene attuata.
Secondo significato: Costituzione materiale come materia
costituzionale, riguardante temi, principi ed istituti che sono
tradizionalmente oggetto della Carta costituzionale (nessuno dubita
che il principio di uguaglianza, la libert di manifestazione del
pensiero, cos come l'organizzazione del Parlamento, del Governo e
la forma di governo siano materia da trattare in
Costituzione).
In questo secondo significato bisogna distinguere la Costituzione
formale dalla materia costituzionale: con la prima si indica ci che
previsto in costituzione, indipendentemente dal fatto che riguardi
una materia tipicamente cost. (il 3 comma dell'art. 111 contiene
una norma del codice di procedura penale).Viceversa materie
tipicamente costituzionali sono contenute in leggi ordinarie: la
Costituzione afferma che la sovranit appartiene al popolo, ma la
nozione di popolo chiarita dalla legge ordinaria sulla
cittadinanza; allo stesso tempo mediante le leggi elettorali si
incide su una materia tipicamente costituzionale (formazione del
Parlamento) con legge ordinaria. In entrambi i casi si parla di
materia costituzionale, ma non di costituzione materiale.
Terzo significato: Costituzione materiale come nucleo
immodificabile della costituzione. Costituzione rigida non vuol
dire costituzione immodificabile:la stessa costituzione prevede un
procedimento di revisione costituzionale, attraverso cui possibile
modificare la costituzione formale. Una disposizione, dunque, per
il fatto di essere formalmente costituzionale, per essere
modificata, deve essere sottoposta al procedimento aggravato di
revisione.Tuttavia, la parte della Costituzione che contiene i
principi fondamentali su cui si fonda in nostro ordinamento
costituzionale non pu essere modificata neppure con il procedimento
di revisione: si tratta di principi che rappresentano un quid
intangibile ad opera di qualunque fonte,la cui revisione
comporterebbe non la modifica della costituzione bens il passaggio
ad una nuova costituzione, e dunque ad un diverso
ordinamento.
Per cambiare la Costituzione (art. 3 per es.) occorre di nuovo un
potere costituente (non basta pi il potere costituito col
procedimento dell'art. 138): se lo stesso risultato cerca di
ottenerlo il Parlamento come potere costituito, esso compie un
colpo di stato, supera cio i limiti previsti dall'ordinamento
costituzionale dal quale ha ottenuto legittimazione.Ecco perch
esistono due nozioni: c. formale relativa a qualsiasi disposizione
formalmente costituzionale e materiale come nucleo di principi
fondamentali assolutamente immodificabili.
COSTITUZIONE ITALIANALa costituzione italiana una c. programma, al
cui interno possono distinguersi due diversi tipi di
previsioni:
- previsioni immediatamente applicabili per il modo in cui sono
formulate e per la regola che esprimono (Tutte le sentenza che
incidono sulla libert personale sono ricorribili in Cassazione:
disposizione applicabile il giorno stesso dell'entrata in
vigore);
- previsioni che necessitano di una attuazione per la generalit del
modo in cui sono formulate. Alcuni istituti previsti dalla
Costituzione (Parlamento, Corte, CSM, Regioni) hanno bisogno, al
fine di venire ad esistenza, di norme di organizzazione: senza una
legge elettorale che fissa i criteri sulla base dei quali il voto
si trasforma in seggi e, dunque, in rappresentati e in composizione
del Parlamento, quest'ultimo non potrebbe giungere ad
esistenza.
Se non fosse stata approvata la legge elettorale, nel '48 in Italia
non si poteva eleggere il Parlamento: ipotesi paradossale che
avrebbe comportato l'impossibilit per l'intero Paese di esistere,
funzionare ed operare.
Se questo paradossale per il Parlamento, altrettanto non si pu dire
per certi istituti. La Calamandrei parler di ostruzionismo di
maggioranza, con un apparente contraddizioni in termini essendo
esso uno strumento tipico della minoranza, per sottolineare come la
maggioranza uscita dalla votazione del 48 tenda a congelare la
Costituzione, non approvando specifiche norme di organizzazione. La
Corte costituzionale sar attuata dopo 8 anni, il CSM dopo 10, il
Referendum dopo 22, le Regioni dopo 25. Questo perch, pur essendoci
un sostanziale obbligo del legislatore di approvare norme di
organizzazione per dare attuazione alla Costituzione (stante
livello e la forza che essa ha), non vi alcun obbligo
giuridicamente sanzionabile.
Diverso quando le norme di organizzazione sono state approvate: queste leggi non possono pi essere abrogate se non per essere sostituite con altre (altrimenti si verifica una situazione di vuoto nell'ordinamento). Si tratta di leggi costituzionalmente necessarie, indispensabili al fine di realizzare la presenza nell'ordinamento di certi istituti. Non ci sono obblighi per il legislatore neppure quando la previsione costituzionale risulta pi stringente: in alcune disposizioni transitorie il costituente ha fissato anche un termine entro cui il legislatore tenuto ad intervenire (entro 5 anni il Parlamento deve prevedere i giudici speciali; entro 5 anni la legge sull'ordinamento giudiziario dovr essere conformata ai principi costituzionali); ma in mancanza della previsione di specifiche sanzioni per un legislatore che non rispetta questi principi, le previsioni rimangono non sanzionate. Rimane soltanto la sanzione politica: il corpo elettorale reagisce all'inerzia del Parlamento nel momento del voto, votando per partiti diversi rispetto a quelli che hanno la guida del Paese in quel momento e che non hanno attuato la costituzione).
Necessit di attuare principi, processo molto pi complesso
rispetto a quello di attuazione di istituti mediante la previsione
di norme di organizzazione.Attuare il principio di uguaglianza
significa far s che tutti dal punto di vista sostanziale siano
uguali, eliminando gli ostacoli che si frappongono tra persone e
che impediscono la realizzazione della persona umana (processo
senza fine).
In un primo momento, attuare i principi contenuti nella
Costituzione significa defascistizzare lo Stato: togliere regole
che non solo non danno attuazione ma che sono palesemente in
contrasto con questi principi: difficile dire quando il principio
di uguaglianza possa dirsi davvero realizzato ma non comprendere
che certe discriminazioni siano palesi (fino al 63 la donna non pu
fare il concorso per la magistratura; il diritto di famiglia viene
modificato solo nel 75).
Dopo la fase di ripulitura dell'ordinamento, la realizzazione dei principi viene a crearsi mediante il bilanciamento tra valori aventi entrambi fondamento costituzionale ma non contemporaneamente realizzabili: soppesamento dei vari principi nel caso concreto. Es. indubbio che il diritto di cronaca abbia fondamento costituzionale ma altrettanto che lo abbia la tutela della privacy: dato che nella realt una certa espressione del primo si pone necessariamente in contrasto con la seconda necessario procedere alla individuazione del principio che nel caso concreto prevalga sull'altro.
I diritti sociali che caratterizzano il nostro Stato come stato
sociale sono previsti al pari degli altri diritti. Mentre della
prima generazione (classici: libert personale, manifestazione del
pensiero, riunione) prevedono sopratutto una libert dallo Stato, e
cio una libert che lo stato si deve limitare ad assicurare; i
diritti della seconda generazione (sociale: diritto al lavoro,
all'istruzione, alla salute, alla previdenza sociale) fanno
riferimento al necessario intervento dello Stato per la loro
realizzazione.
Questi secondi sono caratterizzati dal fatto di essere diritti che,
al di l della affermazione di principio (valida e condivisibile),
richiedono spese.
Il disoccupato non pu fare causa allo Stato per vedersi
riconosciuto il diritto al lavoro perch, pur essendo
costituzionale, esso e un diritto sociale: i diritti sociali
possono essere realizzati come valori tendenziali, ma siccome
costano necessario il raffronto con la situazione economica del
paese.Alo stesso modo vale per il diritto all'istruzione o alla
salute: scontrandosi con la situazione economica del paese, al fine
della loro realizzazione necessario fare riferimento alla effettiva
possibilit del paese di sostenere certe spese.
Di stato sociale si realizza, in sostanza, quanto stabilito nella
legge finanziaria, in cui stabilita la distribuzione tra le varie
destinazioni delle risorse del paese (la cui consistenza varia a
seconda del particolare periodo storico).Quindi, oltre alla
situazione oggettiva del paese c' la scelta politica.
I diritti sociali, nella attuazione della Costituzione, hanno
collocazione particolare proprio perch diritti che si debbono
rapportare alla condizioni economiche e hanno fatto s che in altre
Costituzioni (anche pi recenti della nostra) si abbia una netta
distinzione tra i diritti della prima generazione e diritti
sociali, riconosciuti con una serie di limitazione derivanti dal
loro carattere peculiare: la costituzione spagnola ( approvata 30
anni dopo la nostra, 1978) non contiene nell'elenco de diritti
fondamentali quelli sociali, ma sono previsti a parte.






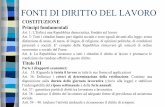

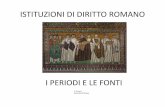



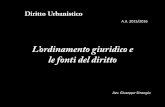






![CONOSCERE E APPLICARE IL DIRITTO COMMERCIALE€¦ · 2 Le fonti del diritto commerciale [Omissis] 2.1 Fonti interne Le fonti interne sono date prima di tutto dalla costituzione che](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/604acd87c17c4b44676e37ba/conoscere-e-applicare-il-diritto-commerciale-2-le-fonti-del-diritto-commerciale.jpg)
