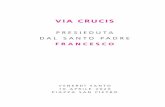Società postmoderna e mutamento corpo identità nell'individuo contemporaneo
Fede ed incredulità nella cultura postmoderna · caratteristica più importante è il pluralismo,...
Transcript of Fede ed incredulità nella cultura postmoderna · caratteristica più importante è il pluralismo,...
Arcidiocesi di Modena - Nonantola
Perché dovrei credere?Fede ed incredulità
nella cultura postmoderna
Atti del corso di aggiornamento del Clero
Anno pastorale 2010 - 2011
Perché dovrei credere? Fede ed incredulità nella cultura postmoderna.Copyright © Arcidiocesi di Modena – Nonantola 2011.
Il presente testo può essere liberamente stampato e distribuito a condizione che non venga modificato in alcun modo, che la distribuzione avvenga esclusivamente a titolo gratuito e che su ogni copia sia mantenuta la citazione del copyright e di questa nota.
Immagine di copertina: Raffaello, S. Paolo predica nell'agorà di Atene.
I relatori del corso
Prof. Don Ermenegildo Conti Professore di filosofia presso il Seminario Arcivescovile di Milano, la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano.
Prof. Don Gian Domenico Cova Professore di esegesi biblica presso la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna.
Prof. Don Marco Settembrini Professore di esegesi biblica presso la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna.
Prof. Don Massimo Nardello Professore di teologia sistematica presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Modena, lo Studio Teologico Interdiocesano di Reggio Emilia e la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna.
I testi delle relazioni non sono stati rivisti dai rispettivi autori.
2
Introduzione
Una delle esperienze più frustranti nell'ambito pastorale è la percezione del disinteresse per la fede cristiana così come è testimoniata dalla chiesa. Se si hanno diversi strumenti per sostenere chi desidera vivere una vita evangelica ma è penalizzato dalla propria debolezza o dalla propria fatica a trovare il volto di Dio, spesso ci si trova disarmati davanti alla dichiarata autosufficienza di alcune persone che ritengono di non aver bisogno di credere, almeno nel senso ecclesiale del termine. Per costoro la fede appare come qualcosa di inutile semplicemente perché non serve a migliorare la qualità della vita, come una proposta di una salvezza di cui in realtà non c'è alcun bisogno.
Sarebbe semplicistico identificare le cause di queste opzioni personali solamente in quelle alcune dinamiche negative della nostra società, come l'influenza negativa della televisione o la crisi della famiglia, a cui spesso si dà ogni genere di colpa. In realtà le ragioni del disinteresse per l'esperienza cristiana sono molto più profonde: attingono anzitutto a diversi aspetti della cultura postmoderna nella quale viviamo e, ancora più radicalmente, ad una fatica della fede che è radicata nel cuore di ogni persona indipendentemente dall'ambito culturale a cui appartiene.
La risposta a tale sfida è, ovviamente, l'azione pastorale della chiesa sostenuta dallo Spirito del Signore. Tuttavia non è sufficiente reiterarla in quelle modalità che l'hanno caratterizzata nei tempi passati: non è più possibile, infatti, raggiungere le persone nella loro condizione culturale concreta al fine di condurle a quella forma di vita cristiana che ha caratterizzato i decenni passati. Occorre invece orientarle ad un cristianesimo che sia frutto di una reinterpretazione e riespressione della fede ecclesiale alla luce delle istanze della postmodernità, che se per diversi aspetti è sua antagonista, per altri può essere sua preziosa alleata. Solo mettendo in rapporto la cultura degli uomini e delle donne postmoderni con la rivelazione cristiana quest'ultima potrà essere ricompresa e riespressa in modo più significativo per il nostro tempo e quindi più facilmente accolta.
L'intento del corso di aggiornamento – tenuto sia a Quercianella che a Modena – è stato quello di offrire anzitutto una riflessione sulle ragioni culturali (relazione filosofico-sociologica) e antropologiche (relazione biblica) dell'incredulità. In secondo luogo si è tentato di cogliere come sia possibile reinterpretare la fede cristiana in rapporto alle istanze della postmodernità, e come in questo modo se ne maturi una comprensione più piena e nello stesso tempo più rilevante per gli uomini e le donne del nostro tempo (relazione teologica).
A conclusione del corso, è emerso come l'ascolto delle istanze positive della postmodernità ci inviti a valorizzare la ricerca individuale del senso della vita e del volto di Dio, nella consapevolezza che essa – pur essendo estremamente varia e ambigua – è in qualche modo animata dallo Spirito del Signore che agisce nell'intimo dei cuori. In tal senso, le comunità cristiane dovrebbero diventare, prima che centri di attività operosa, luoghi di ricerca in cui i cammini individuali, nella loro estrema varietà, possano incontrarsi nel confronto con la fede ecclesiale in Gesù Cristo.
3
Sintesi delle relazioni
La relazione filosofico-sociologica, tenuta dal prof. d. Ermenegildo Conti a Quercianella e a Modena, ha messo in evidenza i tratti principali della cultura postmoderna. La sua caratteristica più importante è il pluralismo, cioè il fatto che i punti di riferimento teorici e pratici della persone sono diversi e spesso in contraddizione tra loro; questo aspetto viene ulteriormente accentuato dall'ampia circolazione delle persone originarie di vari paesi a causa della globalizzazione. La matrice teorica di questo processo è il misconoscimento di qualsiasi riferimento valoriale assoluto e la convinzione che la vita possa reggersi solamente su verità soggettive e mai definitive. Lo stile di vita indotto da questa prospettiva è quindi quello della semplice sopravvivenza e della ricerca del benessere; le relazioni interpersonali, poi, tendono ad essere vissute con uno stile narcisista, con il quale si usano gli altri per avere conferma di sé e della propria immagine. Sul piano pastorale, è molto importante suscitare di nuovo le domande fondamentali della vita, che la postmodernità tende a rimuovere; solo a partire da una ritrovata ricerca esistenziale, infatti, sarà possibile aprire la strada ad un'esperienza religiosa autentica che non sia strumentale alla ricerca del proprio benessere.
La relazione biblica tenuta dal prof. d. Gian Domenico Cova a Quercianella ha trattato dell'incredulità, cioè della mancanza di fiducia in Dio, nella testimonianza della Scrittura. Essa nasce dal non riuscire a cogliere l'intervento salvifico divino nella storia; quando questo avviene, nasce un atteggiamento falsamente religioso, cioè l'idolatria, e ci si appoggia su se stessi anziché su Dio. Proprio questo contare sulle proprie forze è ciò che Paolo vede nell'osservanza della legge mosaica da parte dei giudeo-cristiani. In realtà, l'agire salvifico di Dio ha un segno ben visibile nella storia: si tratta della comunità cristiana in quanto composta di persone che non avrebbero alcuna ragione per stare insieme e che tuttavia in virtù della loro fede in Gesù riescono a vivere in comunione.
La relazione biblica tenuta dal prof. d. Marco Settembrini a Modena ha parlato della mancanza di fede di Israele nel deserto (Nm) e nella terra (Dt). Nel primo caso la fatica del popolo a vivere nella fede è dovuta al fatto che Dio ha operato cose straordinarie a suo vantaggio, ma pure gli chiede di compiere cose impossibili, superiori alle sue capacità, perché non dimentichi di avere bisogno di lui. Nel secondo caso la mancanza di fede deriva dai doni di Dio di cui Israele beneficia nella terra che ha ricevuto, che gli consentono di pensare che non ha più bisogno dell'aiuto divino per vivere in quanto può contare su se stesso. In ambedue i casi, quindi, l'incredulità nasce all'interno della stessa esperienza di fede.
La relazione teologica tenuta dal prof. d. Massimo Nardello a Quercianella e a Modena ha cercato di costruire un dialogo tra la postmodernità e l'azione pastorale della chiesa a partire dalla convinzione che le istanze della cultura possano spingere la riflessione teologica e pastorale a riscoprire e a riappropriarsi di alcuni aspetti dell'esperienza cristiana che rischiano di essere dimenticati. Il dialogo è stato sviluppato su due temi in cui la postmodernità e il cristianesimo sono in forte contrasto, cioè la pretesa di quest'ultimo di conoscere la rivelazione ultima e assoluta di Dio e la sua richiesta di un'appartenenza forte alla chiesa. L'esito della riflessione è che la postmodernità può effettivamente spingere la chiesa a riscoprire e a valorizzare la soggettività delle persone, cioè la loro capacità di mettersi alla ricerca del volto di Dio guidate dal suo Spirito.
4
Fede ed incredulità nella cultura postmodernaErmenegildo Conti
Il senso e il limite della ricerca
Il termine “postmoderno” si attesta intorno agli anni '30 nell'ambito letterario per indicare uno nuovo stile contrapposto a quello modernista; passa poi a connotare un tipo di filosofia che vuole porsi "dopo" la modernità e mettere in crisi le sue certezze (il soggetto, la ragione, ecc.) e acquisisce poi un senso generico che connota le odierne società. In realtà questo termine appare nel 1917 per indicare l'uomo “oltre l'uomo” (non il superuomo) della visione di Nietzsche (a cui peraltro la filosofia postmoderna si rifà ampiamente).
Nel suo senso corrente, il termine “postmoderno” indica un modo di pensare e di agire. Dunque per coglierne il contenuto occorre guardare alla società, al suo comportamento, al suo costume, ma anche alle teorie e alle filosofie che si stanno sviluppando oggi. L'intento della relazione è quello di tenere insieme il versante sociologico (gli usi e i costumi del nostro tempo) e quello più teorico, per scoprire le giustificazioni di tanti comportamenti caratteristici del nostro tempo.
I due approcci vanno considerati in modo unitario poiché si sorreggono a vicenda. La teoria produce cambiamenti nel comportamento della società, e parimenti l'abitudine consolidata invita a pensare in modo diverso; c'è insomma interazione tra teoria e azione. Ad esempio, certi tabù vengono abbattuti perché qualche teorico invita a superare paure e timori, ma anche certi comportamenti consolidati diventano uno stimolo per elaborare nuove prospettive sul piano teorico.
Per delineare al meglio la situazione è necessario mantenersi il più possibile aderenti alla situazione attuale, conservando uno stile di osservazione che non ha la pretesa di fare sintesi o di formulare giudizi di valore (su questo ci si soffermerà negli interventi seguenti). La nostra società, infatti, è costituita da diversi aspetti contraddittori tra loro, per cui se volessimo cercarne una comprensione sintetica prima di aver condotto un'analisi accurata, finiremmo per darne una lettura parziale e inesatta.
Ci soffermiamo ora su alcune caratteristiche che possono descrivere la nostra società.
Una società pluralista
Viviamo in una società pluralista, in cui i punti di riferimento teorici e pratici della persone sono diversi e spesso in contraddizione tra loro; nelle nostre città vi sono molte culture che faticano ad andare d'accordo. Vi sono autori che pensano che questo sia il dato più importante, che può spiegare tanti aspetti del nostro vivere sociale, compresa la secolarizzazione: non sarebbe la secolarizzazione ad aver prodotto il pluralismo, ma al contrario il pluralismo ha indotto a pensare in termini di secolarizzazione.
La modernità non ha pensato la società e lo stato secondo il modello pluralistico; al contrario, ha costruito ambienti uniti e coesi: un solo territorio, una sola razza, una costituzione, un modo unico di pensare, una sola religione “ufficiale” (le altre confinate al margine). Così si è prodotto il nazionalismo dell'800 e le ideologie della razza nel '900. Ancora oggi, davanti ad un conflitto sociale tra gruppi contrapposti, la soluzione viene trovata nella linea della segregazione e dell'indipendenza (vedi ad esempio l'Irlanda, la ex Yugoslavia, ecc.).
In verità, ci sono stati casi in cui questi processi si sono sviluppati in modo contrario: alcuni esempi sono gli USA e l'impero britannico (che ha dovuto interagire con le popolazioni delle colonie, dando vita ad una società pluralista). In realtà nella modernità
5
Fede ed incredulità nella cultura postmoderna
questo modello è stato perseguito solo a livello teorico; per lo più si è dato credito alla convinzione secondo cui in uno stato ci deve essere una sola cultura, una sola religione, ecc. Il modo in cui si è tentato di risolvere il problema dei conflitti religiosi è la tolleranza (che prevede il punto di equilibrio nello stato laico). L'interazione tra mondi culturali diversi è un problema iniziato con le guerre di religione, ma esploso nel mondo attuale: oggi nell'agenda culturale e politica c'è sempre il tema della multiculturalità, anche perché ci accorgiamo che il problema non si può risolvere come nel passato, dal momento che viviamo in un mondo globalizzato.
Globalizzazione e localizzazione
La globalizzazione è un aspetto fondamentale del nostro tempo: non perché vi siano maggiori scambi tra le nazioni rispetto al passato (anche nel medioevo il commercio era fiorente), ma per il fatto che oggi si assiste ad una circolazione delle persone (soprattutto nell'ambito lavorativo) molto più alta che in passato. Questo tende a sradicare gli individui. Chi vive in questa nuova condizione, non si sente vincolato ad un territorio; viceversa, chi non riesce a salire sul “carro” della globalizzazione avverte il legame con la sua terra, ma deve ammettere che il mondo è in mano agli altri. La divisione oggi non passa per le frontiere statali; le barriere presenti nella nostra società sono invisibili e molto più alte che in passato: le persone che gestiscono il mondo (perché “vivono globalizzati”) risiedono vicini ad altri che non la sanno utilizzare, ma la separazione tra i due mondi è netta. Chi sa sfruttare l'interazione tra mondi economici diversi sa dare un impulso diverso alla gestione (economica) della propria vita. Si governano i fenomeni economici senza tenere conto del territorio; chi non riesce a rientrare in questa logica si accorge quanto questo gli “rubi” la propria vita. Non di rado si rivendica la localizzazione, cioè ci si ribella (invano) a questo modello di società che tende ad abbattere i confini statali perché pensa in modo più grande.
Ciò ha portato ad una crescita dei flussi migratori, processo inevitabile perché legato al nuovo modo di pensare il lavoro. Nasce così una nuova figura dei migranti: non sono più quelli dell'inizio del '900, che si spostavano per cercare lavoro con l'intento di rimanere nel paese in cui entravano e quindi di integrarsi in maniera attiva al suo interno; oggi c'è un legame più forte con il lavoro rispetto al territorio in cui si vive: i migranti arrivano con l'obiettivo di restare finché c'è impiego. Se una residenza può essere cambiata improvvisamente perché cambia il flusso di lavoro, si è meno motivati all'integrazione nel territorio.
Questi sono i fattori principali del pluralismo delle nostre società. I modelli di gestione della situazione attuale sono vari: ad esempio, l'idea del meticciato in cui tutto si mescola (come nella marmellata), o della commistione delle diverse culture senza perdere l'originalità dei punti di partenza (come nella macedonia).
Una società senza padri
La postmodernità segna non solo la società e la politica, ma anche la persona. Un'osservazione che coglie aspetti importanti del nostro vivere è quella secondo cui siamo in una società senza padri. Questa idea è stata avanzata nel 1963 in un contesto anti-autoritario (derivato dall'opposizione all'ideologia nazista) che aveva finito con l’indebolire la figura paterna e la sua autorità nella famiglia. Oggi scopriamo che il segnale lanciato allora è stato “profetico”. Ai nostri giorni, chi ha problemi in famiglia è il padre: fa fatica a trovare il proprio ruolo, quello in cui trovarsi a proprio agio e fare il
6
Fede ed incredulità nella cultura postmoderna
bene dei figli. Forse potremmo ampliare l'osservazione dicendo che siamo in una società senza padri anche dal punto di vista biologico: un quinto delle nascite alla clinica Mangiagalli di Milano avviene senza dichiarazione di paternità.
In effetti, il padre soffre oggi di queste difficoltà perché non riesce a trovare il suo ruolo nella famiglia e quindi a dare indicazioni autorevoli ai figli. L'adulto di sesso maschile si identifica sovente in tanti gruppi e appartenenze, ma non tanto con ciò che dice il suo legame con la donazione della vita e l'educazione dei figli. Il tema della genitorialità è comunque problematico oggi, ma sembra esserlo meno per la donna. Così la gestione dei figli è affidata a lei e al suo stile materno/accogliente; più attenuata invece è la figura paterna e il suo compito di indicare le norme di comportamento e di proporsi come modello significativo, in particolare per i figli maschi.
L’obiettivo sopravvivenza
La condizione in cui molte persone vivono oggi è quella in cui si gestisce la propria vita senza aspettative, con il solo obiettivo della sopravvivenza. Si vive al minimo e si guarda solo a ciò che permette di sopravvivere. Tuttavia, coloro che sono sopravvissuti alla II guerra mondiale avevano grandi ideali, e solo grazie ad essi sono riusciti a ricostruirsi e a far ripartire la società. Oggi ci si propone semplicemente una sopravvivenza senza ideali; ma proprio la loro mancanza non consente di vivere.
Si tratta di una mentalità minimalista, nella quale il proprio io è ridotto al minimo. È una prospettiva molto vicina al nichilismo, al pensare alla realtà come nulla, come vuoto.
Felicità e benessere
Ci si propone qualcosa di minimo perché si cerca solo il proprio benessere: non la felicità, che, essendo al di là di qualsiasi sua concretizzazione ipotizzata, resta un perenne stimolante traguardo, ma il benessere, evidentemente realtà molto più limitata. Oggi è importante stare bene, non avere ansie, evitare il decadimento fisico, essere il più giovanili possibile, non sentire la vecchiaia.
Il rapporto con il corpo è segnato dalla logica del benessere: da un lato è esaltato, dall'altro è umiliato in quanto è pensato solo come uno strumento. Si condanna la visione di Platone e di Cartesio, che hanno pensato il corpo come oggetto o come macchina, ma lo considera nei medesimi termini: esso può essere fatto e rifatto, può essere modificato per dargli nuove potenzialità, senza che se ne avverta il problema. Questo porta ad un senso di onnipotenza.
Il narcisismo e la ricerca degli identici
Nella percezione dell’assenza di limiti si riscontra uno stile narcisista. Si confondono i confini tra la propria persona e l'altro, si pensa all'altro come qualcuno che può/deve sempre confermarci; si usano gli altri perché ci rimandino un'immagine positiva di noi stessi. A causa della propria scarsa stima di sé, siamo in conflitto con noi stessi, cercando l'altro solo perché ci dia ragione.
Di conseguenza si cerca un gruppo limitato nel quale esibirsi (nella convinzione che i suoi membri ci daranno ragione). Perciò non si coltiva l'interiorità, l'introspezione, non si accoglie la frustrazione, ma la si scarica cercando la conferma degli altri.
7
Fede ed incredulità nella cultura postmoderna
Uno stile liquido e «autocentrato»
L’aggettivo “liquido” (Bauman) indica che non c’è nulla di solido nella vita umana, che si può assumere un volto diverso a seconda dei gruppi di cui si fa parte, che si può sempre cambiare idea e convinzione. Non esiste una verità che si deve difendere sempre, non esiste un'identità personale definitiva. Questo è un atteggiamento comprensibile nell'adolescenza, ma segno di patologia se vissuto nell'età adulta.
Questo meccanismo è descritto da un altra metafora: proprio perché viviamo in una società narcisista e cerchiamo un altro che sia identico a noi e ci possa dare ragione, viviamo le relazioni con gli altri come se fossero una connessione ad internet, al quale si accede quando si vuole e il cui utilizzo dipende solo dall'utente. Si pensa che le relazioni interpersonali si possano stabilire nello stesso modo, iniziare e terminare quando si vuole, senza che ci siano conseguenze, senza dover pagare nessun prezzo; così, se si interrompe la relazione, l'altro non deve lamentarsi, non deve esigere nulla. È così che funziona la relazione tra identici: si forma l'altro a propria immagine e, se diventa una figura scomoda, si stacca la connessione, cioè si interrompe la relazione, pretendendo che tutto ciò avvenga senza sentimenti. In realtà, gli affetti non si lasciano così in fretta...
La fragilità dell’io
Questa condizione della società esercita rilevanti influssi sull'individuo. In effetti, c'è un'interazione tra gli stili sociali e quelli personali: quando si assume un ruolo nella società, quando si appartiene ad un gruppo, non si svolge solamente un'attività che occupa alcune ore della giornata; l’appartenenza influisce sul soggetto, sul proprio modo di pensarsi, di intendere l’esistenza. L'identità di una persona infatti dipende principalmente dall'appartenenza al gruppo e al ruolo e non tanto dai contenuti che vengono veicolati.
Ora, nel contesto attuale, caratterizzato dalla pluralità e dalla molteplicità, si rischia di appartenere a gruppi diversi che hanno un retroterra culturale differente, che hanno visioni del mondo non coerenti tra loro. L'individuo che vive diverse appartenenze risolve spesso il loro eventuale conflitto con l'eclettismo (nel caso della religione con il sincretismo), identificando un aspetto che faccia da catalizzatore delle altre realtà. In fondo si ha sempre bisogno di una sintesi, ma talvolta essa è cercata semplicemente attorno a ciò che è emotivamente gratificante. Questo vale sia sul versante teorico (il proprio mondo di valori “zoppica” perché composto di elementi non sempre coerenti tra loro) che nella prassi (queste appartenenze creano una confusione interiore che genera indecisione). Si pensa che si possa sempre revocare una scelta, che si possa decidere senza aderire veramente all’opzione preferita. Vi è sempre la riserva di riprendere in mano la decisione e cambiarla.
I fattori principali
Quali fattori hanno prodotto questa situazione? Occorrerebbe menzionare elementi di tipo economico, situazioni internazionali complessive, variazioni etiche intervenute in diverse popolazioni, cambio delle ideologie. Ci soffermiamo solo su due aspetti, uno pratico e uno teorico.
8
Fede ed incredulità nella cultura postmoderna
L’influsso della tecnologia e in particolare dei mass-media
Negli ultimi decenni tra gli elementi che hanno cambiato il modo di pensare c'è la tecnologia. Questo è vero sia sul versante delle situazioni di emergenza (ad es. la medicina, che ha introdotto problematiche prima impensabili) che sul fronte della vita quotidiana. Abbiamo a disposizione strumenti molto sofisticati che hanno cambiato il nostro modo di pensare e di pensarci, di comprendere chi siamo e quindi il nostro modo di agire.
La novità si vede soprattutto con i mezzi di comunicazione. Merita considerare la loro diversità: si sono affermati come strumenti “generalisti” (si pensi alla radio e alla televisione), in grado di produrre un pensiero unico (ad es., in Italia la RAI ha unificato la lingua nel dopoguerra). Oggi con internet siamo in una condizione diversa; è un mezzo più universale (perché può essere consultato in qualsiasi condizione e luogo) ma nello stesso tempo non crea delle masse ma delle comunità interessate ad uno specifico argomento (che quindi possono vivere nell’isolamento reciproco): su internet si va a cercare quello che interessa, e spesso si tralasciano aspetti che non si ritengono rilevanti, ma che potrebbero essere importanti.
Questi strumenti rendono meno rilevante il ruolo del corpo: si può parlare con una persona che vive dall'altra parte del mondo senza conoscersi fisicamente. Soprattutto però cambia la nozione di decisione: di per sé essa è qualcosa di critico, di drammatico, perché costringe a scegliere qualcosa e a rinunciare al resto; ma gli strumenti tecnologici consentono di fare più cose in contemporanea (ad es., prima che fosse disponibile il videoregistratore, si poteva vedere un programma televisivo solo rinunciando ad altre attività; ora invece è possibile non scegliere, non rinunciare a due attività concomitanti). La decisione non è più avvertita con la stessa drammaticità di un tempo, anzi la si ritiene qualcosa di reversibile, come se quello che si è già deciso non abbia influenzato la vita. Questo modo di prendere decisioni porta a non precisarsi mai, per mantenere aperte tutte le possibilità.
Ciò crea difficoltà anche nell'ambito dei desideri: se un desiderio non giunge mai a parziale compimento, se non si raggiunge mai un obiettivo, si affievolisce la voglia di desiderare (e ci si limita a sognare di sopravvivere, come si diceva).
Le nuove tecnologie hanno aumentato questi rischi: nel mondo virtuale si confonde il piano della realtà e della fantasia. È giusto sognare, vivere momenti in cui non ci sono compiti impegnativi! E’ tuttavia necessario un istante che segna il limite e il passaggio alla realtà e alla responsabilità.
La fine delle ideologie e la filosofia postmoderna
La filosofia postmoderna ha il suo alveo nella fine delle ideologie. Nel secolo scorso esse erano dominanti e hanno avuto effetti problematici, ma hanno anche dato un'identità chiara alle persone. Oggi sono crollate; è un dato positivo perché siamo più liberi di esprimerci, c'è più democrazia nei dibattiti, si è più sfumati, meno grezzi. Tuttavia c'è una moltiplicazione di posizioni sui diversi problemi che sembrano dipendere solo dall'individuo. Uno dei processi più “energici” della modernità, la privatizzazione della coscienza, diventa oggi più evidente, perché ciascuno pretende di dire la sua opinione su tutto come se fosse il massimo esperto del settore che non può essere contraddetto. In altri termini, c'è un pensiero frammentato, una moltiplicazione delle posizioni teoriche, che non trovano una vera e propria sintesi coerente.
Questa è la condizione per lo sviluppo della postmodernità, secondo la quale non
9
Fede ed incredulità nella cultura postmoderna
abbiamo più sintesi in grado di fondare il nostro sapere, non sappiamo più costruire delle teorie forti che ci permettano di giustificare il sapere; non abbiamo una visione del mondo capace di una sintesi autorevole (come quella hegeliana), non c'è un pensiero forte e unitario capace di dire l'insieme della nostra esistenza. Secondo G. Vattimo la filosofia deve ridursi ad essere un commento agli autori del passato ritenuti più significativi, più rappresentativi della nostra società (soprattutto Nietzsche ed Heidegger). Negli ultimi testi (quelli ripresi da Vattimo) Heidegger ritiene che ha diritto ad essere pronunciata solo la parola allusiva, poetica: è impossibile una parola concettuale sull'essere e sulla verità perché la nostra ragione è limitata e non può avanzare simili pretese, perché l’essere si ritrae di fronte allo sguardo indagatore dell’uomo. Questo porta al relativismo e al nichilismo: le parole sono sempre espressione di opinioni, non possono affermare una verità. È ciò che G. Vattimo chiama il pensiero debole per contrapporlo alle grandi sintesi del passato.
Questa prospettiva cambia anche la concezione dell'ermeneutica, la scienza dell'interpretazione, intesa nei secoli precedenti come la teoria che doveva occuparsi di ciò che non si capiva. Con Gadamer l’ermeneutica è passata ad indicare la teoria che interpreta ogni realtà, i testi come anche gli altri dati dell'esistenza. In effetti, la nostra ragione è interpretativa, dà una visione del mondo, che, partendo dai dati, offre un significato complessivo che li integra in un orizzonte di senso più ampio. Questo filone della filosofia contemporanea allarga l'uso della ragione, non più circoscritta all'uso scientifico. G. Vattimo pensa che questo modo di ragionare abbia condotto a ritenere che esistano solo interpretazioni: così ermeneutica non indica solo un metodo (l’interpretazione), ma anche come contenuto (il nichilismo).
La religione, in questo contesto
L’indifferenza diffusaUn primo tratto della cultura postmoderna in rapporto alla religione è l'indifferenza a
riguardo dei contenuti del cristianesimo ma anche nei confronti della religione in quanto tale e delle domande esistenziali che potrebbero condurre ad essa. Anche i passaggi decisivi della vita (nascita, morte, ecc.) non sembrano più porre delle questioni ampie relative al senso della vita; aprono solo a condizioni emotive particolari (es. al pianto per la morte di un amico) che però non lascia spazio a riflessioni di più lunga durata e coinvolgenti il tenore di vita.
Questo stile emerge in particolare nell'incapacità di disegnare un progetto di vita. Siamo davanti ad un atteggiamento di agnosticismo pratico (si ritiene di non avere strumenti adeguati per rispondere alla domanda sul senso e dirigere di conseguenza la propria vita); in qualche caso si danno risposte, ma non sono ritenute mai convincenti. Nell'ambito della comunicazione, vi è una forte pressione sociale verso un'assenza di un'indicazione di vita e anche le persone più motivate sono in difficoltà a reagire.
Se come chiesa possiamo fare qualcosa, è proprio all'interno della dimensione umana della vita; è più importante suscitare le domande e far sì che siano accolte che dare delle risposte. Essendo in un tempo confuso, spesso siamo preoccupati di dare indicazioni chiare sulla fede, ma non bisogna illudersi sull’efficacia di tali interventi: saranno mescolate e riadattate in un contesto diverso rispetto a quello in cui sono state elaborate, per cui difficilmente serviranno allo scopo. È meglio suscitare le domande giuste. Il modo in cui è stato impostato il recente convegno di Verona va in tale direzione: si è tentato di identificare gli ambiti antropologici per far capire che la chiesa
10
Fede ed incredulità nella cultura postmoderna
ha un'interpretazione da dare a queste esperienze che interessano tutti. La lettera che hanno stilato i vescovi lombardi sul primo annuncio riprende questo stile: chi vive particolari esperienze significative può affacciarsi alla fede; è dunque compito dei credenti aiutare queste persone con l’incontro e la testimonianza personali (la “Lettera ai cercatori di Dio” è pensata invece come uno strumento da consegnare a chi si sta interrogando perché conosca i contenuti essenziali della fede).
Il ritorno del sacroDa diversi decenni si è abbandonata la tesi secondo la quale le nostre società sono
immerse in una secolarizzazione inesorabile che terminerà solo con la cancellazione della fede. Ci si accorge invece che l’esperienza religiosa è sempre presente, anche se adattata e vissuta in contesti e forme differenti: il devozionalismo, la ricerca dei miracoli, il folclore delle manifestazioni religiose, la rinascita di spiritualità “fai da te”, create attorno ad elementi strani ed esoterici che non appartengono alla tradizione cristiana. Insomma, non si può dare un giudizio solo positivo: ci sono anche elementi problematici. Ne citiamo due.
1. Il peso dei sentimenti: la religione è cercata perché offre dei sentimenti buoni, che fanno riconciliare con se stessi e con la vita, che consentono una rappacificazione interiore. Non importano i contenuti, i dogmi, ma quello che la religione può produrre: se serve ad essere in pace con se stessi e con gli altri, a togliere ansie interiori, allora è valutata positivamente. Se il razionalismo criticava la religione per il suo tratto sentimentale, oggi esso è valutato positivamente. In realtà, si tratta di un uso funzionale della religione.
2. La religione ritorna come elemento di identità: poiché si sperimentano personalità frammentate, si cerca ciò che dà una struttura. Rinasce l'integralismo perché si è confusi e si ha bisogno di certezze (dogmatiche) e di identificazioni (anche civili): per questo si vive (solo) la forma esteriore della religione. Così capita che talvolta a prendere la bandiera della religione siano coloro che non frequentano i suoi riti (l'identità civile italiana, essendo debole, viene molto spesso surrogata da quella cristiana). Così si apprezzano talora le nuove sette o l'Islam (che ha riproposto la funzione pubblica della religione nella società, confinata dall'illuminismo nel privato) più per la loro visibilità che non per la loro spiritualità. Anche in questo caso la religione è funzionale ad altro: non è importante in quanto tale, ma solo perché serve ad un'identità sociale.
Un ateismo aggressivo
Come in filosofia vi sono alcuni segnali di una presa di distanza dalla mentalità postmoderna, così vi è anche un ritorno ad un pensiero forte contro la religione; esso tende a limitarne lo spazio nella società, rifiutando decisamente l'esistenza di Dio. Le forme di tale contestazione sono riedizione dell'ateismo dell'800, fondato su una visione positivista, secondo la quale la vera ragione è solamente quella delle scienze naturali. In realtà, nel'900 la ragione è stata descritta in modo più articolato ed equilibrato.
L'ateismo attuale coglie poi la presenza delle diverse religioni nelle nostre società come occasione e strumento per giustificare le proprie tesi: ad es., si sostiene che non si può dire nulla di religioso in pubblico perché altrimenti non si rispetterebbero le religioni diverse da quella menzionata.
Anche la reazione (cattolica e protestante) di tornare all'apologetica rischia lo stesso difetto, accettando la visione della ragione latente in queste teorie, cercando argomenti
11
Fede ed incredulità nella cultura postmoderna
contrari a quelli proposti da esse. In realtà, potrebbe essere più utile mostrare che la ragione è più ampia di quella formulata dalla scienza, che esclude la ricerca sul senso della vita.
Bibliografia
Il presente contributo è stato ricavato da un articolo del prof. Ermenegildo Conti che verrà pubblicato sulla rivista “La Scuola Cattolica” nell'anno in corso.
Testo non rivisto dall'Autore.
12
Incredulità e fede nella testimonianza biblicaGian Domenico Cova
Introduzione
Il tema in esame, ovviamente, può essere affrontato da molti punti di vista; ho cercato di delineare un percorso che ci faccia incontrare sia l 'AT che il NT, privilegiando però quest'ultimo.
Anzitutto occorre porsi il problema della distanza tra i termini nei quali la Bibbia tratta dell'argomento in esame e il modo in cui ce lo poniamo noi. Dobbiamo allora chiederci: la Bibbia parla di noi, e in che termini? Cosa dobbiamo assumere di quello che ci dice, come possiamo tradurre nei nostri giorni il messaggio biblico? Più specificamente, visto che nelle Scritture non si usa quasi mai il termine “incredulità”, questo tema è affrontato al loro interno e in che senso?
L'incredulità nell'AT
Il termine “ateo” nella Bibbia ricorre 1 sola volta in Ef 2, 12 e mantiene il suo significato etimologico: Paolo si rivolge alle genti per mostrare cosa è accaduto in Cristo e dice agli Efesini che prima della sua venuta erano “atheoi”, cioè "senza Dio" senza nessuna accezione soggettivistica. In altre parole, il termine non significa non avere fede in Dio, ma non averlo dalla propria parte perché egli sta con Israele. Nel pensiero greco coevo a questo testo cominciava a farsi strada una riflessione filosofica che poi porterà nel corso dei secoli all'accezione odierna del termine “ateo”, ma sarebbe una forzatura del pensiero e della lingua attribuirla al testo paolino in esame.
Questo vale a maggior ragione per Israele: l'idea che Dio non esista è semplicemente insensata per il popolo di Dio; l'incredulità di cui parlano le Scritture è semplicemente il rifiuto di Dio e non la dichiarazione della sua inesistenza. In effetti, Israele è continuamente accusato di allontanarsi da Dio, di lasciar cadere la relazione (alleanza) che egli ha costruito con il suo popolo. Questo è il senso in cui si deve intendere la mancanza di fede: i termini ebraici che hanno a che fare con ciò che poi nel NT diventerà la fede sono tutti connessi con l’alleanza e al credito che le si dà. L'aspetto paradossale ma molto importante di questo rifiuto è che esso si traduce normalmente in un'attitudine molto religiosa: diventa infatti la pratica delle religioni dei popoli circostanti. Il termine più ricorrente per esprimere questo atteggiamento è quello dell'adulterio di Israele che tradisce il Signore e va con altri dei. L'incredulo è molto religioso in quanto pratica tutte le religioni che viene a conoscere. Insomma, se vogliamo riflettere sul tema dell'incredulità nella Bibbia dobbiamo entrare in questa mentalità.
Nei testi in cui si parla dell'atteggiamento di Israele di fronte a Dio il tema fondamentale è l'adesione all'alleanza o il tradimento; certi testi, poi, pongono questo problema in termini più sottili. Ad esempio, il Sal 14 recita: "Dice lo stolto: Dio non c'è", e questo testo si ripropone anche nel Sal 53. Di quale negazione di Dio si parla? Non si tratta dell'ateismo, ma del ritenere che Dio non agisca, non intervenga, nonostante abbia promesso di farlo nell'elezione di Abramo, Isacco e Giacobbe. In tanti salmi si prega Dio di intervenire, lo si invita a non starsene fermo, in silenzio, perché si è nella prova. Si tratta dunque di una negazione di carattere esistenziale e non di tipo teoretico. Per Israele, il fascino delle culture e delle religioni diverse dalla propria risiedeva nel fatto che esse offrivano delle forme di presenza di Dio molto più forti e persuasive, grazie alla pratica di una serie di atti cultuali. A questo riguardo
13
Incredulità e fede nella testimonianza biblica
occorrerebbe parlare della polemica dei profeti verso un certo culto nel tempio a Gerusalemme, che privilegiava gli atti di vicinanza visibile del divino rispetto alla pratica della giustizia (carità). Israele richiede manifestazioni tangibili di Dio, dei segni, ma la presenza divina è un'altra cosa: riguarda l'intimo del cuore (cfr. la circoncisione del cuore). Così alla fine del Sal 14 viene chiarito che è lo stolto che conclude che Dio non agisce, ma Dio è con la discendenza del giusto e con il povero. Lo stolto sostiene che Dio non esista perché non si manifesta nelle forme che una certa concezione del divino presuppone, ma in realtà Dio sta dalla parte di chi è giusto, dell'orfano e della vedova.
Il momento storico in cui emerge questa comprensione dell'agire di Dio nella storia è la prova dell'esilio. Per qualcuno esso dimostrava che Dio non c'è (non è presente), visto che non è intervenuto per impedirlo nonostante il suo impegno ad essere fedele al suo popolo. Per altri invece Dio c'è, e questo verrà dimostrato dal fatto che farà ritornare il suo popolo nella terra (cfr. deuteroisaia). Questa svolta è il fondamento della fede dell'Israele postesilico, detto a volte giudaismo, nel quale vive anche il NT.
L'incredulità nel NT
Il NT segue questa stessa comprensione dell'esistenza di Dio come indicativa della sua azione salvifica concreta. Nei segni evangelici ritorna l'idea che è la fede che salva, cioè chi crede (si affida) viene salvato. Ci sono però alcuni testi in cui Gesù si trova di fronte alla mancanza di fede del suo popolo messo a confronto con la fiducia di alcuni gentili. Ad esempio, in Mt 8, laddove si parla della guarigione del servo del centurione (un non ebreo), troviamo la dialettica tra la fede di quest'uomo e quella di Israele sul fatto che Dio intervenga o si astenga dal farlo.
Dobbiamo considerare ora quei testi biblici che verranno utilizzati nelle lettere paoline. Anzitutto Gen 15, 6, in cui si dice che Abramo credette nel Signore, nella sua presenza concreta, e Ab 2, 4 in cui si afferma che “il giusto vivrà nella sua fede”. Questi due testi saranno scelti da Paolo per presentare la sua visione della fede, e da allora saranno ripresi da tutta la teologia. In realtà, questi due testi sono riferiti alla fede di Israele, mentre i Paolo sono applicati alla fede di tutti i popoli. Per alcuni autori Paolo sottolinea questo aspetto universale facendo violenza ai testi; oggi però si è molto più persuasi della continuità della tradizione biblica per le ragioni seguenti. Gen 15, 6 si riferisce esplicitamente ad Abramo, mentre in Ab 2, 4 il profeta è chiamato a testimoniare la parola di Dio al suo popolo, ma rispetto al peccato è portatore di una speranza e di una visione messianica. Ora, Paolo in Rm 1, 16-17 parla della salvezza prima del giudeo e poi del greco, e quindi cita Ab 2, 4 per dire che il gentile che crede è giustificato proprio come l'ebreo. In Gal 3, 6-11 abbiamo sia la ripresa del testo di Gen che di Ab. Per Paolo l'opposto della fede non è l'incredulità, ma la legge: come per la tradizione profetica, l'opposto della fede è l'affidarsi all'opera delle proprie mani (l'idolatria), mentre il credente si fonda su quello che fa Dio. L'osservanza della legge per Paolo esprime la pretesa di essere giusti per quello che si fa. Infine menzioniamo Eb 10, 38 cita Ab 2, 4 , ma qui il giusto diventa "il mio giusto": si tratta di una rilettura cristologica vale poi per chiunque è in Cristo.
Ritorniamo alla domanda iniziale. Questi testi sono pertinenti rispetto ai problemi posti dalla postmodernità? Certamente il problema della contrapposizione tra l'opera di Dio e quella “delle nostre mani” può essere ben presente in alcune tendenze del pensiero e nella vita individuale. Inoltre è interessante il riferimento all'attesa dell'azione di Dio: se viviamo in un'epoca in cui le ideologie sono cadute, in questo riecheggia qualcosa che attiene al tempo del compimento. Tutto è stato sperimentato e
14
Incredulità e fede nella testimonianza biblica
nulla ha funzionato, e non se ne esce: dov'è la presenza di Dio in questo mondo? La risposta è che questo mondo non è concluso, attendiamo la sua trasformazione.
I segni della fede
Secondo la tradizione biblica, la salvezza realizzata da Dio ha una sua visibilità nella storia. I testi più significativi al riguardo sono At 2, 42-47 e At 4, 32-35. Dopo la Pentecoste, la comunità delle origini conduce una vita comune che nasce dalla fede in Cristo. Ora, nella prima parte di At leggiamo che inizialmente questa comunità era gradita a tutti, mentre i conflitti inizieranno quando essa inizierà ad accogliere al proprio interno anche i gentili. La chiesa come comunità messianica si manifesta propriamente quando stanno insieme persone diverse che al di là della fede potrebbero non avere nulla in comune. Questo è il punto critico nell'esperienza del cristianesimo, che è in continuità con un tipo di attesa e di speranza messianica ben presente nella Bibbia.
Un testo molto significativo che ha un'immediata valenza cristologica è il Sal 22, citato dal Signore in croce. Occorre analizzarlo nella sua completezza, visto che Gesù lo cita per intero, menzionandone il primo versetto. Lo schema è il seguente: al grido iniziale segue la motivazione dello stato di abbandono in cui si trova il salmista, cioè la sua persecuzione; c'è poi uno stacco improvviso, non motivato, tra questa prima parte che sembra giungere fino alla morte e una seconda che ha una tonalità di lode per la salvezza ricevuta. Il testo che inizia questa seconda parte nella vecchia versione della CEI recitava: "Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli...": non si capisce cosa sia successo, perché da uno stato di abbandono si passi a questa lode addirittura nell'assemblea. C'è però una glossa, un'aggiunta posteriore che esce dalla metrica del salmo, che recita: "tu mi hai risposto", e nella nuova traduzione della CEI è aggiunta al v. 22. Dunque in seguito a questa risposta - che corrisponde a quanto detto prima sulla risposta di Dio - si danno le condizioni per la seconda parte del salmo. Ora, qui emerge che questa nuova vita è immediatamente comunitaria: prima il giusto era solo ed era schernito, ora è in mezzo all'assemblea; poi si parla della stirpe di Israele, del misero, del povero, e quindi della grande assemblea (i diversi luoghi biblici in cui si apprezza la differenza tra assemblea e grande assemblea fanno capire che la seconda è quella escatologica, non quella di cui si abbia esperienza immediata). Si parla di Israele, dei confini della terra, delle famiglie della terra (citazione precisa della promessa ad Abramo) e infine di quanti dormono sottoterra, i morti: anch'essi sono destinatari della salvezza finale. Questo è un testo fondamentale per percepire la portata della speranza messianica veterotestamentaria: la comunità messianica è il popolo che nasce composto da tutti; di fatto non ci sono ancora tutti, ma per quanto attiene all'azione di Dio è come se tutti fossero già al suo interno.
Ancora un testo di Paolo, Ef 2, 13: letteralmente “voi eravate quelli che erano lontano, ora siete diventati quelli che sono vicini”; Paolo è sempre più attento all'oggettività delle cose che all'aspetto soggettivo, e anche qui afferma che in Cristo chi se ne stava lontano è ora vicino. "Egli è infatti la nostra pace, quello che dei due ha fatto una cosa sola" (v. 14): la nuova realtà che nasce dalla salvezza di Cristo, la chiesa, è costituita in modo tale che sia una. C'era una separazione precedente, quella tra ebrei e le genti, ed è servita all'economia salvifica, ma ora nasce una comunità che è una e che dovrebbe aver coscienza di questa unità da cui è costituita. Questo si manifesta nella vita comune
15
Incredulità e fede nella testimonianza biblica
di quelli che prima erano lontani e tendenzialmente nemici. Subito dopo, in Ef 3, 4-6, Paolo introduce il termine "mistero" per indicare la modalità della presenza dell'azione salvifica di Cristo nel mondo. Il contenuto di questo mistero è che le genti sono chiamate ad essere in comunione con Israele. Per questo Paolo ritiene fondamentale la non necessità della circoncisione per essere cristiani: se i gentili cristiani devono diventare anche ebrei praticando la legge, è ovvio che gli ebrei cristiani siano in comunione con loro; solo se i primi non diventano ebrei, questi ultimi possono stare con loro unicamente in ragione della fede. Così stanno insieme persone che non dovrebbero stare insieme, garantiti solo dalla grazia di Dio. La ragione della vita comune dei cristiani è solo il sangue di Cristo.
Così in Gal 3, 25 ss Paolo scrive che "appena giunta la fede non siamo più sotto un pedagogo". L'evento salvifico si è dato, e ad esso si può aderire; non ci si può illudere che le nostre appartenenze scompaiano, ma l'adesione a Cristo non è un'appartenenza in più in quanto spinge a non mettersi insieme solo con i propri amici. Così in Gal 6, 15 Paolo scrive che non è la circoncisione che conta, ma l'essere "nuova creatura" o "nuova creazione", ancora una volta non in senso soggettivo ma oggettivo.
Dunque, quando parliamo del “noi” in senso cristiano indichiamo tutti gli esseri umani in quanto chiamati da Dio nella sua chiesa, senza limitazioni di alcun tipo. Se non nasce questo “noi”, la fede confessata non c'è. Questa unità è l'unica realtà che si può vedere del tempo messianico.
Testo non rivisto dall'Autore.
16
Incredulità e fede nella testimonianza biblicaMarco Settembrini
Introduzione
Il tema della fede nell'AT è ampiamente trattato mentre lo è molto meno quello dell'incredulità. Cercherò di offrire una riflessione sulla testimonianza biblica relativamente ad ambedue gli aspetti.
Per introdurci al tema prendiamo in esame Gen 15, in cui si parla della fede di Abramo. Si tratta di un testo tardivo, dell'esilio, scritto in un momento in cui sembra che il Signore si sia dimenticato delle sue promesse. Non c'è più re, sacerdote, ed Israele è una provincia dell'impero persiano. Che ne è delle promesse di Dio? Si ricorda allora la fede pura di Abramo, che si appoggia solo alla promessa che gli viene dal Signore; questa sua fede è il nucleo della giustizia: non è sufficiente lo sforzo umano, cioè mettere in pratica i comandamenti, ma occorre appoggiarsi al Signore.
Ora ci chiediamo: cosa mina questo atteggiamento confidente, cosa erode lo slancio della fede? Ci sono diversi testi che presentano la protesta del salmista davanti all'ingiustizia; come si può credere che Dio sia attento alla storia se prevale il violento, se il malvagio prospera, se si muore senza figli, se c'è la malattia? È l'ingiustizia intesa come rottura dell'ordine delle cose che mette in discussione la fedeltà di Dio. Egli deve garantire l'ordine delle cose, fare giustizia, e se questo non avviene è un problema.
Vi sono diversi passi biblici in cui si dice che Israele non ascolta, non vede, indurisce il cuore, ma vi sono anche testi in cui si dice espressamente che Israele non crede. Sono relativi a due luoghi, il deserto e la terra. La conclusione a cui arriveremo è che la difficoltà della fede dipende dalla sua stessa struttura; c'è qualcosa nel rapporto con Dio che sembra determinare l'incredulità dell'essere umano. La fede è qualcosa di spinosa, l'abbandono a Dio sembra portare alla morte.
La mancanza di fede nel deserto.
Considerare la vicenda di Israele nel deserto significa aprire il libro dei Nm. In esso si parla di un viaggio di attraversamento: con la costruzione della tenda del convegno, realizzata in obbedienza alle parole di Mosè ispirate dal Signore, Israele può mettersi in marcia verso la terra dei padri (Es 35–40). Si tratta di un viaggio, tipicamente caratterizzato dalle zone che si attraversano, dal tempo che scorre e, soprattutto, dal desiderio di arrivare. Con l’assommarsi delle giornate di cammino si intensifica la voglia di trovare finalmente riposo ma, con ciò, si impone anche la fatica, il rimpianto di essere partiti, la rabbia per le continue difficoltà. Le frontiere che si varcano segnano così il passaggio a dimensioni sempre più profonde dell’animo dell’israelita, che si scopre entusiasta e fragile, affamato e ingordo, pio ma superbo. È l’epoca del deserto, nella quale si entra con la speranza di una vita nuova, nella quale sembra di morire ma, infine, si rinasce.
La terra promessa è infatti vicinissima e nondimeno inaccessibile, sarebbero sufficienti undici giorni per raggiungerla e invece debbono trascorrere quarant’anni (cf Dt 1,2s), lungo i quali una generazione succede a quella dei genitori (Nm 14,31). Quanto più Israele fatica, tanto più è necessario che capisca che la terra non è guadagnata con le proprie forze, bensì elargita da Dio per pura grazia. Il luogo in cui finalmente si trova riposo, si pianta la vigna e si costruisce la casa, metafora della vita felice e simbolo del Regno che deve venire, è un’eredità riservata ai figli, ai bambini (cf Mt 19,14). Sono dunque i figli della generazione del deserto ad entrarvi, in rappresentanza dei figli del
17
Incredulità e fede nella testimonianza biblica
popolo, ossia dell’intero popolo in quanto figlio di Yhwh-Padre (cf Es 4,22).Sinteticamente si può raccogliere il contenuto del libro attorno a tre momenti:
• Israele al Sinai (1,1–10,10);• la marcia dal Sinai alle pianure di Moab (10,11–21,35);• Israele nelle pianure di Moab (cc. 22–36).
Nelle tre differenti situazioni nelle quali Israele si trova si intravede un percorso spirituale in cui la fede iniziale, pura, si incrina, per trovarsi infine rinnovata e matura. Dapprima il popolo è fermamente rivolto al Signore e alla terra che egli ha promesso, poi è disorientato dal prolungarsi della marcia e dalla debolezza dei segni della presenza di Dio, finché la grazia non prevale sull’ostinazione del cuore umano (“retto orientamento” – “disorientamento” – “nuovo orientamento”). Se all’inizio si leggono infatti episodi caratterizzati da un’esatta obbedienza alla richieste divine, corrisposta dalla presenza numinosa di Dio (9,15-23), in seguito si rinvengono tre episodi di lamento che sfociano nel drammatico rifiuto della terra (cc. 13–14). Alle successive mormorazioni (c. 21) succedono invece inaspettatamente le profezie di Balaam (cc. 22–24) con le quali, nonostante un’isolata défiance (c. 25), cominciano le vittorie in Transgiordania.
Nel corso del racconto Israele è simbolicamente impersonato da due generazioni: una ribelle, destinata a soccombere nel viaggio, e una apparentemente debole e inadeguata eppure idonea a ereditare il paese dei padri (14,29-32). Alle due generazioni corrispondono due sezioni del libro, ciascuna delle quali è avviata da un censimento (cc. 1–25, cc. 26–36).
Individuando nella “campagna militare” il grande genere letterario di Nm, si possono diversamente riconoscere le due sezioni maggiori in 1,1–10,10 e 10,11–36,13:
1,1–10,10 preparazione cultuale e militare alla campagna (piano)10,11–36,13 marcia e battaglia (esecuzione)
10,11–21,20 dal Sinai verso la terra promessa21,21–36,13 inizio della conquista (in Transgiordania)
La prima sequenza della seconda sezione del libro (da 10,11 sino alla fine di 36,13) comincia con una nuova formula di datazione: “Il secondo anno, il secondo mese, il venti del mese, la nube si alzò da sopra la dimora della testimonianza” (10,11). Allo spostamento della nube segue immediatamente la decisione di Israele di levare l’accampamento. All'interno di questa sezione consideriamo alcuni testi.
Nm 10, 29-32: il cammino nel deserto è guidato da Obab; c'è la nube, ma chi ha gli occhi e chi fa la funziona di guida è uno straniero. Si tratta del suocero Ietro, che qui viene chiamato Obab, amante, termine peraltro riferito solo a Dio; sembra che quest'uomo sia reso a Dio. Da un lato Israele è preoccupato della sua purezza (cfr. la cura delle genealogie all'interno dell'AT), dall'altro qui il Signore è guidato da uno straniero. La fatica della fede è legata da un lato alla fatica di seguire Dio e dall'altro di seguire degli uomini.
Poi vi è una sequenza di testi che si estende da 11,1 a 20,13. Siamo nella parte di Nm dedicata alle mormorazioni, che danno voce alla fatica della fede nel popolo. Si comincia al cap. 11, dove si dice che il popolo cominciò a lamentarsi. La lingua ebraica accentua questi collegamenti: c'è la nube, "'anan", e il popolo si lamenta, "mit’ōnenîm". Inspiegabilmente la fede si incrina e sorge la mormorazione. Vi sono motivi individuabili per questa crisi di fede: forse a motivo dei tre giorni appena citati (Nm 10,33 ss.), forse perché l’arca non si vede (c’è la nube e l’arca è andata avanti, 10,33); in ogni caso, il
18
Incredulità e fede nella testimonianza biblica
Signore ha promesso il bene e lo fa (10,29.32) mentre il popolo parla male (11,1). Ci sono motivi tangibili per lamentarsi, ma vi è anche una certa inspiegabilità.
Poi si legge di come il popolo si lamenti della manna (11, 4-35), che è leggera e sparisce velocemente; è un cibo che imputridisce se non lo si consuma presto. I doni del Signore sembrano troppo transitori, sfuggono dalle mani; in realtà, proprio perché il Signore domanda una ricerca continua di lui e della sua parola non consente che i suoi doni possano creare un divario con lui. Vi è allora la fatica di attendere ogni giorno il suo dono, e a lungo andare questo può creare stanchezza.
Dopo essersi lamentato di Dio, Israele si lamenta anche della guida umana: Miriam e Aronne mettono in discussione l'autorità di Mosé (c. 12), aprendo poi la strada ad altre mormorazioni (c. 15-17). Così si arriva a rifiutare la terra: in Nm 13-14 Mosé invia uomini ad esplorarla, e al loro ritorno la comunità reagisce piangendo e dicendo di voler tornare in Egitto. Mosé e Aronne intervengono, ma compare la gloria del Signore che emana la sentenza: tutti coloro che non vogliono entrare nella terra moriranno nel deserto mentre i loro figli, che si ritenevano destinati a morire, entreranno in essa. Vediamo più in dettaglio questo testo.
Mosè invia degli esploratori per accertare la bontà della terra e per vedere quali sono le vie di accesso. Attraversare la terra è un primo atto di possesso nel quale si ha una percezione della bontà della promessa del Signore. Nel cammino di fede Dio concede di pregustare il pieno possesso della vita. Ora, in Nm 13, 26 tutta la comunità si raccoglie, e al c. 14 si dice che c'è tutta la comunità: si parlerà quindi del peccato non di qualcuno, ma di tutto il popolo, di tutta la generazione del deserto. Gli esploratori dicono che la terra è buona, per cui la ribellione resta ancora inspiegabile. La fede viene meno non perché la vita credente non contempli l'esperienza della promessa: ci è dato di pregustare, ci sono segni. La vita di fede non è quella di chi non sperimenta nulla, che crede cose assurde; anzi si fa esperienza di come Dio elargisca i suoi doni, eppure ci si lamenta, la fede viene meno. La ragione è che il dono sembra impossibile: per quanto si faccia esperienza di Dio e della sua fedeltà, i suoi doni e le sue richieste sembrano inarrivabili. La crisi della fede dipende insomma dal fatto che Dio opera l'impossibile (es. Gen 18, “nulla è impossibile a Dio”; così il nome che Dio rivela al padre di Sansone in Gdc 6 è “colui che compie l'impossibile”), compiendo meraviglie; entrare in rapporto con lui significa entrare in un orizzonte in cui occorre vincere la verosimiglianza. Allo stesso modo Abramo, vecchio, deve mettersi in cammino ed avere un figlio da una donna anziana; Elia deve vivere nel deserto, nella carestia, e poi andare in una terra straniera e affidarsi ad un vedova ormai vicina alla morte, e lei deve dare al profeta quello che possiede non pensando né a sé né a suo figlio. Così nelle vocazioni profetiche si dice che Dio si impone nell'udito, tocca le labbra, e il profeta si sente come schiacciato. Ora, la generazione del deserto constata come la richiesta di Dio sia impossibile: la terra è buona, ma è abitata da giganti e il popolo si sente piccolo come un cavalletta. Il dono è impossibile; per questo, quanto più si è vicino alla terra, quanto più aumenta la tentazione di tornare indietro in Egitto. La mancanza di fede è quindi strutturale nella vita del credente.
Perché promesse di Dio sono impossibili? Il testo della manna (c. 11), che viene prima del testo in esame (c. 13-14) ci dice che Dio, promettendo l'impossibile e chiedendo l'impossibile, costringe l'essere umano a stare con lui. La lotta con i giganti presenti nella terra costringerebbe Israele a confidare solo nel Signore, a restare nella relazione con lui. In Gen 3 la donna e l'uomo pensano di poter stendere la mano al frutto dell'albero per darsi la vota da soli e non attenderla dal Signore. È un voler diventare
19
Incredulità e fede nella testimonianza biblica
adulti e dimenticarsi di essere figli, un ritenere di poter vivere grazie a se stessi. Si entra nella terra solo con il cuore di figli: infatti i padri moriranno nel deserto, entreranno solo i loro figli. Così nel NT si dirà che solo i bambini entrano nel regno dei cieli.
Un testo simile è quello del serpente di bronzo, al c. 21. Si parla di una mormorazione sanzionata con la morte. Se si ricorda che nell'AT vige la legge del taglione, cioè che la pena è commisurata alla colpa, comprendiamo di essere davanti ad un peccato molto grave. Il popolo è uscito dall'Egitto per servire il Signore, ma qui gli Israeliti dicono "uscire dall'Egitto per farci morire": Dio è compreso come colui che produce la morte. Questo pensiero uccide: i serpenti velenosi sopraggiungono a mostrare l'esito di questi ragionamenti, visualizzano questi pensieri di incredulità. Il serpente attraverso cui si può ricevere la guarigione (di bronzo) è indicato dal nome “serpente serpente” (il grande serpente), che rimanda a quello di Gen 3: quando si pensa che servire il Signore significhi morire, occorre pensare alla donna e alla tentazione originale, e in questo modo si può vincere la tentazione.
La mancanza di fede nella terra.
Prenderemo in esame Dt 8 e 2Re 17. Il primo testo presenta un lungo discorso di Mosé alla popolazione che sta per entrare nella terra. Il testo è diviso in tre blocchi: uno riguarda quello che è già avvenuto, uno l'oggi e l'ultimo il futuro.
La lezione del passato: nel deserto, attraverso l'umiliazione della fame e la fatica del cammino, il Signore ha inteso aiutare il popolo a riconoscere che è figlio. Il Signore si comporta come un padre e la vita di fede è la vita filiale. I segni sono inizialmente molto grandi (il mare Rosso che si apre), poi un po' meno (la manna), poi diventano ancora più piccoli (il piede non si gonfia, il mantello non si logora). Lo sguardo del popolo deve affinarsi, devono bastare segni sempre più piccoli. La vita di fede è un abituare l'occhio a riconoscere l'intervento di Dio.
A riguardo del presente, il testo richiama il fatto che nella terra non ci sarà la manna, il piede si logorerà e il mantello si logorerà, e il popolo potrà coltivare e disporre di rame e ferro per farsi armi. Le difficoltà nella terra dipendono dal fatto che si può vivere da soli. Proprio l'esito della benedizione di Dio può incrinare la fede. Per questo non si deve dimenticare: la presenza del Signore andrà vista nel lavoro quotidiano, non più nelle cose straordinarie.
La parola per il futuro è quindi “guardati dal dimenticare”. La tentazione della terra è nascosta nell'abbondanza che ottunde i sensi, che incrina ogni sentimento di solidarietà, di dipendenza dagli altri, che rende egoisti, e in questo rende chiusi a Dio.
2Re 17 è un testo che colloca nel tempo dell'abbondanza. I testi dell'AT vengono da Gerusalemme, perché Samaria è distrutta nel 721, ma la religione del Dio d'Israele nasce al nord; le tradizioni del deserto e dell'uscita dall'Egitto maturano in quel contesto geografico. Infatti anticamente Israele era conosciuto come la casa di Omri, costruttore di Samaria; per questo è la caduta di questa città a costituire l'evento più tragico nella storia di Israele. In seguito tutte le tradizioni sono riscritte attorno a Gerusalemme. Ora ai vv. 6-23 del testo in esame si offre una riflessione sulla caduta di Samaria.
"Seguirono le leggi delle nazioni" è la prima ragione che la spiega: Israele si è conformato alle usanze e alle vie di altri, ha dimenticato la propria storia. Se i precetti fanno riferimento alla legge di Dio, accogliere i precetti delle genti significa accogliere un'altra sapienza, lasciarsi educare da qualcosa d'altro. In realtà, Dio non è stato ripudiato direttamente, ma si sono messi di fianco a lui molti dei (steli, pali sacri, altri luoghi di culto). L'idolatria arriva in questo modo: ci sono i precetti del Signore e accanto
20
Incredulità e fede nella testimonianza biblica
ad essi le usanze dei popoli, e alla fine una scelta è ineludibile (cf. Mc 6: Erode ascolta il Battista e anche la donna, ma alla fine deve decidere da che parte stare). Il fatto di aver affiancato il Signore agli dei, i suoi precetti a quelli delle genti fa sì che al v. 14 si parli di “non fede”
Una seconda ragione per la caduta di Samaria è il non aver ascoltato la voce dei profeti (v. 13-14). Se in Dt si chiedeva di aguzzare la vista per vedere la presenza di Dio, qui occorre affinare l'udito, cioè distinguere la voce dei profeti. La vita di fede è sostenuta da mediazioni (Mosé, Aronne, ecc.) e quindi essa si incrina quando esse non sono riconosciute. I mediatori hanno una forte responsabilità, perché il popolo conosce la legge di Dio solo se essi ne parlano correttamente. Israele indossa ora i panni del faraone: ascolta la voce di Dio ma la rigetta.
Le cause dell'incredulità nella terra sono dunque la presunzione di vivere grazie alla proprie forze e l'idolatria; ambedue sono frutto dell'abbondanza.
In conclusione, l'incredulità nasce dallo stesso rapporto con Dio, che chiede l'impossibile per ottenere un rapporto figliale, che dona una prosperità che spinge a ritenere di poter fare a meno di lui.
Testo non rivisto dall'Autore.
21
Elementi teologici per una rilettura dell'esperienza cristiana nella cultura postmodernaD. Massimo Nardello
Il dialogo tra il cristianesimo e la postmodernità
L'obiettivo di questa relazione è quello di fondare sul piano teologico una possibile forma di dialogo tra la postmodernità e la fede cristiana che possa stimolare l'azione pastorale della chiesa.
Una relazione dialogica si dà quando gli interlocutori sono consapevoli di poter offrire qualcosa, ma nello stesso tempo di poterlo ricevere dagli altri. Ora, gli aspetti fortemente problematici della cultura in cui viviamo potrebbero farci pensare che tale dialogo tra la cultura postmoderna e il cristianesimo non sia possibile, e che il compito della chiesa sia semplicemente quello di opporsi drasticamente alla mentalità comune al fine di trasformarla. Secondo questa prospettiva, le persone andrebbero raggiunte nella condizione in cui si trovano, ma dovrebbero poi essere condotte all'esperienza cristiana così come è stata compresa nei decenni passati, senza dare peso al fatto che essa è in forte conflitto con la cultura odierna.
Per valutare questa posizione occorre fare alcune premesse, utili ad inquadrare meglio il tema in esame e ad evitare pericolosi fraintendimenti. Ci muoviamo anzitutto nella convinzione che l'umanità e l'intera creazione sia già stata oggettivamente salvata da Dio attraverso la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo e il dono del suo Spirito. Ovviamente perché questa azione di salvezza divenga fruttuosa nella vita dei singoli individui, deve essere liberamente accolta attraverso la fede. Una seconda premessa è data dal fatto che l'ostacolo più rilevante nei confronti dell'esperienza religiosa non è rappresentato dalla postmodernità o da qualsiasi altra cultura, ma da quella fatica o paura a fidarsi di Dio che si determina all'interno dello stesso rapporto con lui (cf. relazione di Settembrini), e che soltanto la sua grazia può vincere.
Ora, il fatto che la salvezza cristologica debba essere liberamente accolta dai singoli individui comporta che essa debba essere proposta in modo visibile e comprensibile all'interno della storia umana. Questo rende necessaria la mediazione ecclesiale, che – resa possibile dall'azione dello Spirito – consente gli uomini e alle donne di ogni tempo di venire in contatto con la salvezza. L'azione pastorale della chiesa, dunque, non mira propriamente a salvare le persone, ma a consentire loro di fare esperienza della salvezza cristologica.
A partire da queste premesse, possiamo allora riformulare il problema in esame nei termini seguenti: la mediazione ecclesiale della salvezza può essere meglio attuata nella linea del conflitto o in quella del dialogo rispetto alla cultura postmoderna?
Sul rapporto tra evangelizzazione e culture, il Vaticano II ci insegna che
La Chiesa, cioè il popolo di Dio, introducendo questo regno nulla sottrae al bene temporale di qualsiasi popolo, ma al contrario favorisce e accoglie tutte le ricchezze, le risorse e le forme di vita dei popoli in ciò che esse hanno di buono e accogliendole le purifica, le consolida ed eleva (LG 13).
E ancora:
[La Chiesa] Procura poi che quanto di buono si trova seminato nel cuore e nella mente degli uomini o nei riti e culture proprie dei popoli, non solo non vada perduto, ma sia purificato, elevato e perfezionato a gloria di Dio, confusione del demonio e felicità dell'uomo (LG 17).
Questi testi sono molto significativi. Anche se non si parla del rapporto tra vangelo e culture in una prospettiva dialogica, nel senso che non si accenna al fatto che esse
22
Elementi teologici per una rilettura dell'esperienza cristiana nella cultura postmoderna
possano spingere la chiesa a riscoprire aspetti della propria fede, si difende comunque la convinzione secondo cui in una cultura non tutto è da buttare: ci saranno elementi problematici da purificare ma altri da valorizzare. Se la postmodernità è la cultura in cui viviamo, il Concilio ci invita ad avere un approccio di questo genere nei suoi confronti. Del resto, se si può chiedere alle persone di prendere le distanze da alcuni aspetti della propria cultura, non si può chiedere loro di rinunciare completamente ad essa perché questo è sostanzialmente impossibile.
In ogni caso, in questa sede ci muoveremo in una prospettiva esplicitamente dialogica. Non ci limiteremo quindi a distinguere gli elementi negativi della postmodernità da quelli positivi, ma cercheremo di mostrare che, se alcuni elementi della cultura odierna devono essere rifiutati in quanto intrinsecamente incompatibili con l'esperienza cristiana, altri possono aiutarci a riscoprire e ad approfondire diversi aspetti del cristianesimo che rischiano di essere marginalizzati. Vedremo insomma come la fede cristiana, e in particolare l'azione pastorale della chiesa, sia fortemente avvantaggiata da un approccio dialogico e non integralmente conflittuale con la postmodernità.
In questo percorso procederemo in modo induttivo: prenderemo in esame due aspetti della cultura postmoderna che di primo acchito sembrano incompatibili con il cristianesimo per chiederci se in realtà essi possano essere non solo realtà da purificare e perfezionare, ma anche stimoli che consentono una comprensione più piena dell'esperienza cristiana.
Il carattere assoluto del cristianesimo
Le difficoltà della postmodernitàUna difficoltà particolarmente rilevante della postmodernità nei confronti del
cristianesimo è la sua pretesa di aver conosciuto la rivelazione assoluta e ultima del Dio creatore di ogni cosa, avvenuta nel suo Figlio, e la conseguente convinzione che ogni altra comprensione del mistero divino non possa essere che erronea o incompleta. Da tale conoscenza del mistero divino derivano altri pretese che la cultura postmoderna rifiuta, come quella di regolare il linguaggio della fede, talora in modo strettamente normativo, di avere una parola autorevole da dire sui quasi tutti i temi relativi alla vita personale e sociale, di orientare (per qualcuno, controllare) le coscienze.
La postmodernità contrappone a tutto questo il valore della soggettività (cf. relazione Conti): essa si esprime nel pluralismo, per cui i punti di riferimento teorici e pratici della persone sono diversi e spesso in contraddizione tra loro, e nello stile liquido, per cui non c’è nulla di solido nella vita umana e si può sempre cambiare idea. In particolare, la visione dell'ermeneutica caratteristica del pensiero debole ritiene che le parole siano sempre espressione di opinioni, che non possono affermare una verità oggettiva, per cui non ci può essere una parola autorevole e normativa né su Dio né sull'essere umano.
Per cercare un dialogo tra il cristianesimo e la postmodernità su questo tema è importante ripartire dall'idea di rivelazione insegnata dal Vaticano II.
Rivelazione e fede nella prospettiva dei concili Vaticano I e Vaticano IILa visione della rivelazione del Vaticano I la intende principalmente come conoscenza a
cui si accede attraverso la via naturale e soprattutto quella soprannaturale:
La medesima Santa Madre Chiesa professa ed insegna che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza dal lume naturale della ragione umana attraverso le cose create; infatti, le cose invisibili di Lui vengono conosciute dall’intelligenza della creatura umana attraverso le cose che furono fatte (Rm 1,20). Tuttavia piacque alla Sua bontà e alla
23
Elementi teologici per una rilettura dell'esperienza cristiana nella cultura postmoderna
Sua sapienza rivelare se stesso e i decreti della Sua volontà al genere umano attraverso un’altra via, la soprannaturale, secondo il detto dell’Apostolo: “Dio, che molte volte e in vari modi parlò un tempo ai padri attraverso i Profeti, recentemente, in codesti giorni, ha parlato a noi attraverso il Figlio” (Eb 1,1-2). Si deve a questa divina Rivelazione se tutto ciò che delle cose divine è di per sé assolutamente inaccessibile alla ragione umana, anche nella presente condizione del genere umano, può facilmente essere conosciuto da tutti con certezza e senza alcun pericolo di errore. Tuttavia non per questo motivo deve dirsi assolutamente necessaria la Rivelazione, ma perché nella Sua infinita bontà Dio destinò l’uomo ad un fine soprannaturale, cioè alla partecipazione dei beni divini, che superano totalmente l’intelligenza della mente umana; infatti Dio ha preparato per coloro che Lo amano quelle cose che nessun occhio vide, nessun orecchio mai udì, nessun cuore umano conobbe (1Cor 2,9) (Dei Filius, dal cap. II).
La visione del Vaticano I – che è peraltro fortemente ancorata a diverse tradizione teologiche antiche e soprattutto medievali – dipende da una concezione della salvezza che si ispira alle filosofie di matrice platonica. Essa consiste nella conoscenza della verità, che questa si impone alla mente umana come una sorta di illuminazione e che non presuppone nulla sul piano antropologico che non sia la semplice capacità di conoscere. In realtà, però, in tale prospettiva la rivelazione non raggiunge direttamente tutti i credenti, ma solo i vertici della gerarchia ecclesiale, che poi la divulgano all'interno del popolo di Dio come mediatori di salvezza. Così la fede è primariamente conoscenza di ciò che Dio ha voluto rivelarci e pratica degli aspetti etici di tale rivelazione, ovviamente con il sostegno della grazia; tuttavia tale conoscenza è attingibile direttamente solo dall'insegnamento della gerarchia ecclesiastica, che acquisisce così un ruolo di enorme autorità. In questa visione è difficile pensare che la verità della rivelazione non sia stata già tutta svelata e che Dio resti un mistero: perché avrebbe voluto tenerci nascoste delle informazioni su di sé e su di noi?
La visione della rivelazione nel Vaticano II è molto più marcatamente relazionale rispetto a quella del Vaticano I:
Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà (cfr. Ef 1,9), mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura (cfr. Ef 2,18; 2 Pt 1,4). Con questa Rivelazione infatti Dio invisibile (cfr. Col 1,15; 1 Tm 1,17) nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si intrattiene con essi (cfr. Bar 3,38), per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa economia della Rivelazione comprende eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto. La profonda verità, poi, che questa Rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli uomini, risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la Rivelazione (DV 2).
Con la divina Rivelazione Dio volle manifestare e comunicare se stesso e i decreti eterni della sua volontà riguardo alla salvezza degli uomini, «per renderli cioè partecipi di quei beni divini, che trascendono la comprensione della mente umana». Il santo Concilio professa che « Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza con il lume naturale dell'umana ragione a partire dalle cose create» (cfr. Rm 1,20); ma insegna anche che è merito della Rivelazione divina se «tutto ciò che nelle cose divine non è di per sé inaccessibile alla umana ragione, può, anche nel presente stato del genere umano, essere conosciuto da tutti facilmente, con ferma certezza e senza mescolanza d'errore» (DV 6).
Nella visione del Vaticano II la fede non è primariamente adesione intellettuale alla verità rivelata ma esperienza salvifica di Dio che si autocomunica all'umanità in Gesù Cristo ; questa prospettiva relazionale è molto più ampia rispetto alla dimensione della
24
Elementi teologici per una rilettura dell'esperienza cristiana nella cultura postmoderna
conoscenza e della vita etica, ed ha implicazioni molto importanti.Anzitutto, essa ci consente di cogliere come Dio resti comunque un mistero. Se egli si
rivela non nel senso che ci comunica delle verità su di sé e su di noi ma in quanto si dona, la sua alterità resta il presupposto necessario perché noi possiamo accogliere tale autodonazione. Dal punto di vista antropologico, infatti, una relazione autentica è possibile solo in quanto l'altro resta misterioso; in assenza del mistero, la relazione non può darsi. Ora, se Dio resta non pienamente conoscibile anche per la chiesa, il popolo di coloro che hanno accolto la sua autodonazione, essa non può esprimere un pensiero arrogante che nasce dalla pretesa di possedere la verità ultima su Dio e quindi si ritiene in diritto di sentenziare in ogni ambito.
La prospettiva della Dei Verbum suggerisce poi una seconda considerazione. Nell'ambito antropologico il dono di sé non è compiuto se non c'è anche la sua accoglienza; poiché questo vale analogamente anche per l'autocomunicazione di Dio, ne consegue che non solo la chiesa implica la rivelazione – nel senso che il popolo di Dio è costituito da coloro che accolgono il Dio che si comunica – ma pure la rivelazione implica la chiesa. Se nessuno accogliesse l'autodonazione di Dio, essa non esisterebbe nella sua realtà. Così è la chiesa, in quanto popolo che accoglie l'autocomunicazione di Dio, che consente alla rivelazione divina di rendersi presente nella storia, divenendone la mediazione fondamentale.
A conferma del fatto che è la chiesa, in tutti i suoi membri, a svolgere questo compito di mediazione della rivelazione, possiamo leggere un passaggio della Lumen Gentium
Per quel senso della fede che è suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, il popolo di Dio, sotto la guida del sacro magistero al quale fedelmente si conforma, accoglie non la parola degli uomini, ma, qual è in realtà, la parola di Dio (cfr. 1 Ts 2,13), aderisce indefettibilmente "alla fede una volta per tutte trasmessa ai santi" (cfr. Gdc 3), con retto giudizio penetra in essa più a fondo e più pienamente l'applica nella vita (LG 12).
Se la fede ecclesiale è la risposta all'autocomunicazione di Dio, secondo il Vaticano II la comprensione del contenuto di questa fede – il mistero di Dio, dell'essere umano, della creazione – è compito di tutti coloro che sono nella chiesa, pur sotto la guida del magistero, in virtù di quel senso di fede che è suscitato in essi dallo Spirito Santo. Questa dinamica ha i tratti di un vero e proprio processo ermeneutico, così caro alla postmodernità, anche se ha caratteristiche sue proprie. In primo luogo esso è orientato non solo alla conoscenza ma all'esperienza salvifica di una realtà del tutto oggettiva, cioè il mistero di Dio. In secondo luogo, tale processo ermeneutico non scade nel relativismo nella misura in cui nasce dalle domande antropologiche esistenziali – ogni percorso di ricerca suppone interrogativi iniziali – ma scopre poi che le risposte della rivelazione trascendono queste domande, e anzi ne suscitano di nuove e più grandi (metodo della correlazione). Così la comprensione del mistero divino da parte del popolo di Dio è un processo ermeneutico non nel senso che ciascuno si costruisce una sua verità soggettiva sul divino, ma nel senso che il volto di Dio, nella sua oggettività, non potrà mai essere scoperto in modo esaustivo ed assoluto.
Visione conciliare e istanze della postmodernità.Mettendo a confronto la visione conciliare del cristianesimo e la postmodernità sul
tema in esame possiamo cogliere diversi elementi di sintonia. Nell'esperienza cristiana si può e si deve valorizzare la soggettività, così importante per la cultura postmoderna, che viene declinata come capacità dei singoli di ricercare continuamente il volto di un Dio che resta ultimamente misterioso. Il cammino della fede può essere compreso come un processo ermeneutico, non in quanto produce solo opinioni soggettive ma in quanto
25
Elementi teologici per una rilettura dell'esperienza cristiana nella cultura postmoderna
capacità di cogliere il volto di un Dio che è sempre al di là dei nostri tentativi di comprenderlo.
Tale volto ultimamente misterioso di Dio fa sì che il cristianesimo sia capace di inserirsi nel dibattito pubblico postmoderno senza quello stile arrogante che deriva dalla pretesa di conoscere già il fondamento ultimo delle cose e quindi tutto ciò che da esso deriva, e che si esprime nella rivendicazione di dire autorevolmente una parola ultima su quasi ogni tematica. L'esperienza salvifica di Dio di cui ci parla la visione conciliare rende il cristianesimo capace di dire parole molto significative ma nello stesso tempo umili, che possono quindi entrare nel dibattito pubblico rispettandone il carattere democratico.
Occorre poi rilevare gli elementi di contrasto tra la visione cristiana e quella postmoderna. Anzitutto il cristianesimo ritiene che l'evento cristologico sia la salvezza assoluta e oggettiva dell'intera creazione, contro ogni riduzione soggettiva della postmodernità. Anche la necessità di valorizzare le domande esistenziali, che la cultura odierna tende a rimuovere, e di accogliere le risposte della rivelazione nella loro alterità rispetto alle domande di partenza rappresenta un ulteriore elemento di grande differenza. Infine il riconoscere il carattere normativo alla Scrittura e, soprattutto nel cattolicesimo, l'autorità del magistero segnano ulteriori differenze tra le due visioni.
In conclusione, vi è una certa sintonia tra alcune istanze della postmodernità e la visione conciliare del cristianesimo, anche se vi sono diversi elementi di difformità. L'approccio seguito fin qui consente all'azione pastorale di cogliere cosa purificare nella cultura postmoderna, ma nello stesso tempo che cosa valorizzare per giungere ad una comprensione più piena dell'esperienza cristiana.
Suggerimenti pastoraliPresentiamo alcuni semplici spunti di riflessione per ripensare l'azione pastorale della
chiesa a partire dalle riflessione svolta fin qui.Se il senso di fede è la via cristiana per valorizzare la dimensione soggettiva così cara
alla postmodernità, nell'azione pastorale le persone dovrebbero essere valorizzate non anzitutto coinvolgendole nelle attività ecclesiali, ma in primo luogo per la loro capacità soggettiva di ricercare il volto del Signore. La comunità cristiana dovrebbe pensarsi come un popolo di cercatori di Dio che si confrontano continuamente con l'oggettività della fede ecclesiale a partire dalla loro soggettività animata dallo Spirito Santo. Le convinzioni soggettive sul senso della vita, gli innumerevoli itinerari esistenziali individuali dovrebbero essere stimati e valorizzati, e non immediatamente svalutati in quanto difformi dall'oggettività della fede. Questo forse potrebbe favorire la partecipazione a percorsi formativi nelle comunità cristiane.
Se occorre valorizzare la soggettività di tutti i credenti in quanto cercatori di Dio, i presbiteri potrebbero limitarsi ad usare la loro autorità per tutelare il carattere evangelico delle scelte delle comunità cristiane e per garantire che siano in sintonia con il cammino pastorale della chiesa. Per il resto, potrebbero porsi come guide che sanno far emergere e valorizzare il senso di fede delle persone.
Infine, se Dio resta ultimamente un mistero, come anche l'essere umano e il mondo, nel dibattito pubblico occorrerebbe trovare parole umili che sanno dire la fede e le sue implicazioni, ma senza l'arroganza caratteristica di chi pensa di avere certezze definitive su ogni cosa.
26
Elementi teologici per una rilettura dell'esperienza cristiana nella cultura postmoderna
L'appartenenza ecclesiale
Le difficoltà della postmodernitàUna delle difficoltà più significative della postmodernità nei confronti dell'esperienza
cristiana è la piena appartenenza che essa richiede alla chiesa, perché tale forma di adesione viene percepita come qualcosa che limita la propria libertà. Ad essa la cultura postmoderna contrappone il valore della pluralità delle appartenenze, per cui si può essere parte di gruppi diversi che hanno un retroterra culturale differente e visioni del mondo non coerenti tra loro (cf. relazione Conti).
Occorre chiedersi, dunque, se il cristianesimo, oltre a dover purificare queste istanze, possa parimenti lasciarsi stimolare da esse, oppure se siano irrimediabilmente negative. Una risposta a questo interrogativo la si può trovare studiando il tema dell'appartenenza ecclesiale nel Concilio Vaticano II.
L'appartenenza ecclesiale nel concilio Vaticano IISul tema dell'appartenenza ecclesiale, il Vaticano II riprende i tre vincoli con cui essa è
stata declinata nella tradizione teologica, cioè la professione di fede, la recezione dei sacramenti e l'accettazione del ministero dei ministri ordinati:
Sono pienamente incorporati nella società della Chiesa quelli che, avendo lo Spirito di Cristo, accettano integralmente la sua organizzazione e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti, e che inoltre, grazie ai legami costituiti dalla professione di fede, dai sacramenti, dal governo ecclesiastico e dalla comunione, sono uniti, nell'assemblea visibile della Chiesa, con il Cristo che la dirige mediante il sommo Pontefice e i vescovi (LG 14).
Questi tre vincoli, che sono attestati in diversi testi patristici, vengono ribaditi nella teologia medievale quando la dimensione visibile della chiesa diviene prevalente, e quindi anche l'appartenenza viene compresa in termini societari. Questo processo culmina nella controriforma, durante la quale Roberto Bellarmino scrive:
La Chiesa è la società degli uomini in cammino sulla terra, unita dalla professione della medesima fede cristiana e dalla partecipazione ai medesimi sacramenti, sotto il governo dei pastori legittimi e in primo luogo del romano pontefice. (Disputationes de Controversiis Christianae Fidei adversus hujus temporis hereticos III, 2).
Questa stessa prospettiva viene ampiamente ripresa nella trattazione teologica seguente, e la si ritrova nella Mystici Corporis al numero 22:
In realtà, tra i membri della Chiesa bisogna annoverare esclusivamente quelli che ricevettero il lavacro della rigenerazione, e professando la vera Fede, né da se stessi disgraziatamente si separarono dalla compagine di questo Corpo, né per gravissime colpe commesse ne furono separati dalla legittima autorità. "Poiché — dice l’Apostolo — in un solo spirito tutti noi siamo stati battezzati per essere un solo corpo, o giudei o gentili, o servi, o liberi" (I Cor. XII, 13). Come dunque nel vero ceto dei fedeli si ha un sol Corpo, un solo Spirito, un solo Signore e un solo Battesimo, così non si può avere che una sola Fede (cfr. Eph. IV, 5), sicché chi abbia ricusato di ascoltare la Chiesa, deve, secondo l’ordine di Dio, ritenersi come etnico e pubblicano (cfr. Matth. XVIII, 17). Perciò quelli che son tra loro divisi per ragioni di fede o di governo, non possono vivere nell’unita di tale Corpo e per conseguenza neppure nel suo divino Spirito.
Questa visione suppone l'idea secondo cui l'appartenenza ecclesiale può solo esistere integralmente oppure non esistere; non esistono vie intermedie. Questo è espresso molto chiaramente dalla categoria statica di “membro della chiesa”.
La LG recupera la dimensione misterica della chiesa, caduta in oblio dal secondo millennio. Grazie a questa ritrovata convinzione che la chiesa non si identifica con
27
Elementi teologici per una rilettura dell'esperienza cristiana nella cultura postmoderna
l'istituzione o con la comunità ma è anzitutto una realtà spirituale, in LG 13-17 si può parlare di diverse forme e gradi di appartenenza o di ordinamento al popolo di Dio, cominciando dai cattolici – pienamente appartenenti – per finire con i non credenti. In effetti, se la chiesa è primariamente una società, l'appartenenza ad essa può solo esistere o non esistere; se invece essa è una realtà misterica, può sussistere anche un'appartenenza parziale.
Il Vaticano II introduce così una novità importantissima parlando di comunione “piena”, “integra”, “non piena”, “non perfetta”, “graduale” (LG 15; UR 2, 3, 4, 14, 17; OE 4, 30), e usando le espressioni “ordinazione”, “orientamento”, “incorporazione”, “appartenenza” (LG 13, 14, 16; UR 3, 22). In questo modo si sostituisce il termine classico “membro” e si mette in evidenza il carattere processuale e dinamico dell'appartenenza alla comunità ecclesiale.
Non si tratta di una prospettiva completamente nuova. LG 16 cita un testo emblematico di Tommaso in cui egli parla di una partecipazione potenziale alla chiesa dei non cristiani:
Gli infedeli, sebbene non appartengano in atto alla chiesa, le appartengono però in potenza. E questa potenza ha due fondamenti: il primo e principale è la virtù di Cristo che è sufficiente alla salvezza di tutto il genere umano; il secondo è il libero arbitrio (di ciascuno individuo) (Sth III, q. 8, a. 3, ad 1).
Evidentemente, però, la prospettiva conciliare resta comunque innovativa rispetto al testo tommasiano in quanto non si limita a parlare di un'appartenenza potenziale alla chiesa dei non cattolici, ma di una loro appartenenza vera a propria sebbene incompleta.
Nel dibattito teologico seguente il Concilio l'idea di un'appartenenza parziale alla chiesa è stata applicata anche a coloro che si professano cattolici ma che non vivono un'esperienza cristiana ed ecclesiale completa. Così negli anni '70 K. Rahner parla della Chiesa dalle porte aperte, che dovrebbe considerare in maniera positiva l'elasticità e l'indeterminatezza dei suoi confini dovuta al fatto che le persone che vivono una fede implicita sono in qualche modo parte di essa:
Bisogna però combattere il sentimento molto diffuso secondo cui o si è un membro deciso della chiesa con tutti gli obblighi che ne conseguono oppure ci si pone nei confronti di essa in un atteggiamento necessariamente ostile o assolutamente indifferente. […] È teologicamente permesso e moralmente comandato di considerare tali marginali come dei fratelli, senza far loro notare ad ogni occasione che, a rigore, non sono dei veri cristiani nella chiesa. Essi cioè, per esprimerci con Agostino, quanto al "cuore" appartengono alla Chiesa più salutarmente di coloro che sono in essa "corporalmente" quindi solo in maniera sociologica (K. Rahner, Trasformazione strutturale della chiesa come compito e come chance, Queriniana, Brescia 1973, pp. 90-92).
Nello stesso periodo Y. Congar sostiene che si debbono favorire spazi che rappresentino una forma di “chiesa della soglia” o chiesa catecumenale, in cui possano condurre una certa vita religiosa persone che non hanno una fede solida e soprattutto che non praticano una vita sacramentale completa. Ovviamente non deve trattarsi di un contesto ecclesiale alternativo a quello “normale”, ma di qualcosa che ha il suo senso in riferimento all'esperienza ecclesiale completa.
Ben prima della postmodernità la riflessione teologica postconciliare ha ritenuto di considerare componenti del popolo di Dio tanti cattolici che vivono un'appartenenza ecclesiale debole; non si tratterà di una condizione ideale, ma essa resta comunque una forma possibile di rapporto con la chiesa. La cultura postmoderna, che orienta a vivere appartenenze di questo genere, ci obbliga a riconoscere che le persone che si trovano in questa condizione devono e possono essere considerate come cattolici destinatari
28
Elementi teologici per una rilettura dell'esperienza cristiana nella cultura postmoderna
dell'azione pastorale.
Suggerimenti pastoraliForse tra alcuni anni la pastorale delle persone che vivono un'appartenenza debole alla
chiesa rappresenterà quella più importante. Occorre allora cogliere ciò che vi è di positivo in questa situazione – pur non ideale – evitando di porre le persone davanti all'alternativa di una scelta radicale di appartenenza o dell'abbandono della vita cristiana. Nel contesto della postmodernità, la scelta di appartenere completamente a qualcosa può essere estremamente difficile, se è frutto di una decisione libera e non indotta da dinamiche di dipendenza.
È anche urgente rispettare la gerarchia delle verità di cui parla il Vaticano II:
Nel mettere a confronto le dottrine [i teologi cattolici] si ricordino che esiste un ordine o «gerarchia» nelle verità della dottrina cattolica, in ragione del loro rapporto differente col fondamento della fede cristiana (UR 11).
È più importante che le persone credano agli elementi centrali della fede (quelli cristologici e trinitari) che accettino altri contenuti ad essi relativi, compresi quelli in materia di etica. Soprattutto poi sembra urgente creare nell'ambito ecclesiale dei contesti relazionali (gruppi) di ricerca della fede in cui sia possibile entrare pur senza aderire pienamente alla chiesa e senza sentirsi gravati da giudizi negativi. Forse il futuro della nostra azione pastorale passerà anche da queste esperienze.
Bibliografia
S. PIÉ-NINOT, La sacramentalità della comunità cristiana, Brescia 2008, pp. 292-303.G. LAFONT, Immagine la Chiesa cattolica. Linee e approfondimenti per un uovo dire e un
nuovo fare della comunità cristiana, Cinisello Balsamo 1998, pp. 40-47.F. ARDUSSO, Magistero ecclesiale. Il servizio della Parola, Cinisello Balsamo 1997, pp. 15-24.
Testo non rivisto dall'Autore.
29