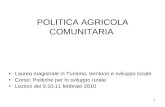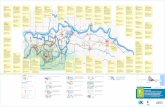FARE politica, FARE sviluppo locale.
-
Upload
circolo-partito-democratico-biella -
Category
Government & Nonprofit
-
view
167 -
download
0
Transcript of FARE politica, FARE sviluppo locale.
1
Biella, 12 settembre 2015 “Fare politica, Fare sviluppo locale”
INTERVENTO DI FABRIZIO BARCA
C’è in tutto il nostro paese una domanda molto forte di costruzione di strategie di alleanza
(dalla Valtellina fino alla Calabria, alla Sicilia…), alleanze funzionali, istituzionali, territoriali,
di ridisegno di un’offerta di prodotti, di servizi: questa domanda ha tre ragioni che è bene
comprendere perché ci fa sentire parte di un processo nazionale, oltre che di una ricerca
locale.
La prima: ci sono delle dimensioni minime al di sotto delle quali non ci sono le competenze,
la massa critica, la disponibilità finanziaria, le capacità da parte dello stato di organizzare la
parte istituzionale di servizi significativi.
La seconda ragione ha a che fare con sommovimenti recenti, in corso negli ultimi 30 anni,
che sono emersi anche durante questo incontro. La natura violenta, affascinante, della sfida
concorrenziale che viene dagli altri paesi (che ha riguardato i due terzi della nostra
discussione con riferimento al tessile) fa sì che le decisioni siano prese su una scala
territoriale significativa e la seconda, l’opportunità, è la straordinaria modificazione della
domanda sul mercato capitalistico dei consumi, consumi che chiedono, pretendono e
hanno la possibilità di conoscere dei prodotti che comprano non solo per le caratteristiche
apparenti ma anche le caratteristiche nascoste nella filiera storica e territoriale della sua
produzione. Questo era stato previsto da un economista, che solo quelli che hanno dalla
mia età in su possono conoscere (John Lancaster) che 40-50 anni fa spiegò che con
l’aumento del reddito medio pro-capite i cittadini si sarebbero potuti permettere di
sindacare sulle caratteristiche dei prodotti, non il pomodoro ma i pomodori, non il tessuto o
la lana ma le lane, non il grano ma le tipologie di grano. Ciò ha avuto una forte rilevanza in
tutto il mondo: come avviene la produzione, con quale lavoro, quale modalità, quale
territorio, quale storia, quando si è cominciato a produrre.
La terza ragione che determina questa sensazione che bisogna tornare alle alleanze di aree
vaste è invece indotta dai nostri comportamenti politici e istituzionali, dal ridisegno caotico
delle istituzioni all’italiana: prima tutto decentramento, poi tutto accentramento.
Oscillazione tipicamente italica, noi non compiamo mai le riforme che facciamo, diciamo
che non funzionavano e le modifichiamo prima di averle realizzate. Ad esempio l’abolizione
delle province, una possibile area vasta amministrativa non indotta dal basso, che sta
ponendo anche istituzionalmente il problema di quali sono i soggetti a cui trasferire le
2
funzioni, domanda che all’italiana ci si pone dopo aver chiuso le province e non prima, e
non in modo nazionale ma regione per regione.
Raccogliere le tessere di un mosaico possibile.
Questa domanda di area vasta il PD di Biella, i 5 circoli che hanno organizzato questo
incontro, l’hanno raccolta in modo coraggioso, costruendo se capisco nei mesi passati
(capisco dal tessuto di oggi che ci sono stati mesi di lavoro) una ricognizione e
individuazione di alcune finestre, schede, tessere di un mosaico possibile di cui si vedono i
pezzi, ognuno di voi alla fine di questa giornata avrà visto un mosaico diverso, che potrebbe
diventare una strategia e da questo punto di vista è così che si fa, e non è che c’è un altro
modo, ed è significativo che l’abbiate fatto e che siate riusciti a ottenere tante persone in
sala e a convincerle che era questo che andava fatto oggi. Perché certe volte noi
invochiamo i processi partecipati però poi non abbiamo nessuna voglia di dedicarvi tempo e
fantasia, li invochiamo a chiacchiere ma quando si tratta di partecipare e stare a sentire, di
ritornare a casa e ripensare a quello che si è sentito non lo facciamo. I processi partecipati
hanno questa esigenza: che la volta dopo si ritorni e si parli solo dopo averci lavorato sopra
per un po’.
E questo mi sembra il senso che ho colto, la ragione per cui sono venuto qui molto
volentieri, ma sta avvenendo in altre forme e in altre parti del paese. Se fossimo in
Germania o in Gran Bretagna un processo di questo tipo sarebbe governato dallo stato
centrale. Io non mi lamento perché in Italia non lo è, non è nelle corde della storia di questo
paese, non ce la fa questo paese a costruire un processo di questo tipo e quando lo fa lo
proceduralizza e diventa una roba burocratica insopportabile, altri paesi riescono a
costruirlo secondo un processo, che hai dei rischi di degenerazione. Noi però abbiamo nella
pancia una caratteristica nazionale che ci rende particolarmente imprenditoriali e che è la
forza nostra, abbiamo un alto tasso di imprenditorialità nel nostro paese, anche non
considerando l’imprenditorialità che sta dentro alla pubblica amministrazione (e io la vedo
in quanto dirigente pubblico, perché esiste l’imprenditorialità nel settore pubblico che non
si manifesta, se imprenditorialità vuol dire rischiare capitale finanziario, cioè un reddito
cessante, e tempo di vita, c’è anche nell’amministrazione pubblica dove rischiano molti
dipendenti pubblici preferendo imbarcarsi in progetti piuttosto che fare una vita facile) ma
misurandolo anche solo come imprenditorialità privata questo paese ha un tasso di
imprenditorialità, dato dal numero di famiglie italiane che hanno almeno un imprenditore
in famiglia, del 16%, un numero che non ha paragoni nel resto del mondo, e forse non è
casuale che questo paese abbia un forte bisogno di aggregazione territoriale e poi i territori
rispondano con loro modalità. Giusto o sbagliato che sia è così che sta avvenendo e questa
è la riflessione interessante che proviene dal Partito Democratico.
Nelle cose che dirò mi dimentico del PD per un istante e ragiono sulle cose che ho sentito
come se le avesse come dire cucinate qualunque altro, dopo tornerò sul fatto che il
3
soggetto che ha pensato di farle sia il PD chiedendomi se è ragionevole per il partito
suscitare queste riflessioni, che è la domanda che avete posto a tutti gli interventi.
Dimenticandomi quindi del partito faccio due gruppi di osservazioni, alcune orizzontali,
altre sul mosaico che ho intravisto o non ho intravisto.
Quelle orizzontali: sono 7 osservazioni puntuali e non fantasiose.
1.Si vede che pur avendo fatto descrivere singole intuizioni e singoli progetti il tentativo è di
cucirli insieme in una cosa che è la strategia. L’errore che abbiamo compiuto ripetutamente
in questo paese è di essere corsi ai progetti, perché si dovevano poi rapidamente spendere i
fondi comunitari, ed abbiamo fatto un disastro. Quindi non progetti, i progetti vengono
dopo, prima ci vuole una strategia, la strategia banalmente è una via di fuga dalle
difficoltà, l’abbiamo chiamata così nel lavoro che sto facendo nelle aree interne, voi sapete
che me ne occupo amministrativamente (ad esempio la Regione Piemonte ne ha scelte
quattro, dove la situazione demografica è ancora peggiore di quella che avete presentato,
es la Val Maira…) quindi una via di fuga, che sostanzialmente fa sì che uno debba essere in
grado di scrivere in una pagina e mezzo, alla fine, quale idea si ha di questo territorio tra 25
anni, non tra 10… che cosa c’è ancora in piedi, che cosa c’è di nuovo, come si camminerà
per le strade, quali sono gli edifici, un’immagine che sia anche raccontabile, che ricolleghi
da questo punto di vista la tecnica alla politica, che a volte non si parlano più. Questa è la
prima osservazione.
2.In tutte le cose che avete descritto io leggo non una lista di progetti, perché non era nelle
vostre intenzioni e non deve esserlo, ma le tessere di un mosaico, poi magari alcune di
queste cose non sono quelle che verranno fatte ma servono a costruire il mosaico. Tutto ciò
che avete raccontato ha una cosa che ci siamo persi per strada per costruire la
pianificazione strategica, che invece quelle città che ce l’han fatta, Cuneo, Rimini, Torino,
hanno invece messo al centro del loro ragionamento, cioè la filiera della conoscenza. Alla
fine della storia un cambiamento è un’innovazione, l’innovazione è fondata su elementi
cognitivi di conoscenza, il cambiamento è innovazione, l’innovazione (lo sa bene chi lavora
in azienda e in parte chi lavora nella PA) è scontro di idee, conflitto, non c’è innovazione
senza conflitto, è una parola di cui reimpossessarsi, e quindi bisogna costruire dei luoghi
dove ci sia del conflitto, letture diverse della realtà, conflitto non solo tra interessi diversi,
ma anche tra diversi modi di rispondere allo stesso interesse. Quindi conoscenze, voi ne
avete nominate molte: rete, coworking, scuola di impresa.
3.Vi dico due o tre luoghi fondamentali di conoscenza che invece ho sentito mancare, sui
cui invece investirei, la mia presenza qua ha anche lo scopo di individuare i punti che vedo
mancare. La scuola è stata sfiorata da due-tre interventi, ma ci deve stare da protagonista,
con i suoi due-tre dirigenti scolastici straordinari che ci saranno, ci sono in ogni territorio, i
4
suoi docenti particolarmente avventurosi e innovativi. La seconda cosa che vi ho sentito
citare nelle statistiche iniziali “sono pochi, ma poi stando dentro giustamente saranno una
percentuale altissima”, di cui non ho sentito palpitare la presenza in termini di conoscenza,
sono gli immigrati. Sono una fonte straordinaria di conoscenza e di innovazione, come ci
ricorda Amartya Sen e come ci ricorda la pratica di questo paese, che è un paese che non ha
strategie per l’arrivo degli immigrati ma per fortuna compensa questo con quella
straordinaria sua capacità imprenditoriale. Per cui scopriamo questa cosa straordinaria, non
so il numero di Biella ma lo andrei a guardare, per cui la percentuale di imprese condotte da
cittadini stranieri è molto spesso più alta della percentuale dei cittadini stranieri sulla
popolazione. Cosa significa (a volte si vuole sminuirli e si dice ”sono solo…”)? Sono
imprenditori, gestiscono aziende, ad esempio la zootecnia, con una grande attenzione, sono
una fonte di conoscenza, di intelligenza e hanno un pregio: non hanno ancora fatto in
tempo a prendersi la malattia del nostro paese che è quella di diventare dei lacchè. Cioè
sedersi in una posizione, anche bravi e svegli, ma poi da quella non muoversi più. La terza
fonte di conoscenza interessante, ce lo ricorda l’OCSE quando ci aiuta a ragionare di
sviluppo e ce lo ricorda anche la Commissione Europea, è quella di lavorare, scambiarsi
informazioni, con territori simili che hanno avuto problematiche simili in altri paesi
d’Europa soprattutto. Non sono un conoscitore del comparto tessile e tantomeno se ci
siano e quali altre aree e quali nel territorio europeo che abbiano caratteristiche simili, ma
la vera traduzione dell’idea europea di Smart Specialization è che i territori devono
identificare le loro opportunità e cambiarle: perché non si riparte da un’idea ma da quello
che hai, ma non mantenendolo invariato ma innovandolo. Ci sono territori in Europa che ce
l’hanno e quindi una fonte importante di conoscenza sono i soggetti che abbiano
caratteristiche di territorio simili alle vostre.
Questa è la seconda cosa, la terza che è legata a questa e’: non i progetti, ma le persone.
Solo per catturare la vostra memoria, che rimanga impressa, cito Raffaele Mattioli “noi del
settore pubblico, e le banche, non sappiamo in generale finanziare i progetti” ed è un bene,
per definizione, perché un progetto veramente innovativo è un progetto che io non posso
essere in grado di individuare. Se sono una brava banca, un bravo amministratore, posso
individuare i progetti “sola”, cioè quelli che non hanno i requisiti minimi. Ma non sono in
grado di discriminare i progetti buonissimi, per cui per definizione un progetto innovativo è
un progetto che ha degli elementi idiosincratici, che conoscono soltanto quelli che lo
presentano; diceva Mattioli che invece si possono finanziare le persone. Le persone le puoi
giudicare secondo due criteri, gli puoi chiedere: perché dovrei stare a parlarti, cioè che hai
fatto fino a oggi, non che reddito hai acquisito, che patrimonio hai, e quindi che garanzie mi
dai, ma perché mi chiedi di finanziare un progetto, ma la cosa più grande che hai fatto
cos’è? E poi la seconda cosa, più imbarazzante, è “perché dovrei avere fiducia in te”? Che è
la domanda che varrebbe sempre la pena di porre ed è il motivo per cui i processi di
assegnazione delle risorse fatti in modo negoziale a volte sono più efficaci di quelli fatti a
5
bando, perché a quella domanda un imprenditore se non sa dove andare gli occhi li
abbassa. Che cosa voglio dire con questo: i processi partecipati hanno un rilievo non solo e
non tanto perché consentono di costruire un percorso di consenso, ma perché
consentono di portare in partita dei personaggi, dei protagonisti, magari protagonisti che
non hanno voce (gli immigrati di prima, i giovani organizzati che abbiamo sentito all’inizio
delle esposizioni...), ed estrarre conoscenza. Punto. I processi di cambiamento strategico,
cioè il disegno del mosaico, cioè il passaggio da alcune tessere al mosaico, avvengono se le
conoscenze si mettono in comune attraverso processi come questo di oggi, ripetuti, ripetuti.
Oggi è una forma piuttosto “cattedra/sala”, questo è un modo con cui si capisce dove si va
ma poi i processi partecipati sono dei processi complessi, che hanno molte forme, che molti
di voi in questa sala conoscono meglio di me. Quindi protagonisti, in questo senso, e di
nuovo, come ho già fatto per la scuola, anche della pubblica amministrazione, perché una
cosa è l’amministrazione pubblica come istituzione, una cosa sono i suoi componenti, quel
dirigente dell’ASL, quel dirigente scolastico, quell’insegnante, quel medico. Nel modo con
cui lavoriamo nelle “aree interne” facciamo i focus-group, rischiando di sbagliare (“ma
allora come li scelgo? Tutti? No, si sbaglia... se ne portano alcuni... poi gli altri si arrabbiano
che non sono venuti... non ha importanza...). Ma non è più possibile, con le caratteristiche
che hanno i corpi intermedi in questo paese, che qualcuno rappresenti in maniera assoluta.
Questa è la terza cosa.
4.La quarta cosa l’ha detta benissimo Roberta Varoli, a proposito della necessità di fornire
servizi, specialmente a un comparto come quello artigiano che non ha la massa critica di
potersi permettere di costruirli: la cooperazione tra i Comuni. E’ una cosa implicita, bella,
racchiusa nel simbolo dell’incontro, ogni cerchio è un Comune o insieme di Comuni. Sistemi
intercomunali permanenti, non roba normativa, non c’è nessuna legge dietro, è un’alleanza
tra Comuni, i quali decidono attraverso convenzioni, e quindi attraverso la forma più
leggera che esiste, senza neanche unioni, di associare servizi che sono funzionali al
raggiungimento di un obiettivo condiviso. In Toscana in questo momento il processo di
chiusura delle Province è andato, la Toscana da questo punto di vista è piuttosto rapida
nelle sue scelte amministrative, e ha scelto di decentrare ai Comuni una parte significativa
dei poteri delle Province: quindi c’è un fenomeno in corso molto interessante di
associazione di Comuni, sul tema del turismo ad esempio, che è una funzione nella quale è
ragionevole che l’area vasta sia un’area vasta autorganizzata, come dire relativa ad un’area
che è congruente dal punto di vista delle strategie.
5.La quinta osservazione è invece un punto che non è emerso, perché siamo ancora nella
fase ascendente. Però mi permetto di dirlo perché subito dietro l’angolo diventa per noi
fondamentale e per chi spende uno solo euro dei fondi comunitari dovrebbe essere una
regola, ossia prima di arrivare ai progetti, appena la strategia esiste, e appena la strategia si
è tradotta nell’identificazione di alcuni obiettivi, prima ancora di individuare le azioni con
cui raggiungere questi obiettivi, bisogna individuare i risultati che si intende raggiungere, i
6
risultati attesi, che siano traducibili in indicatori misurabili. Questa cosa nel nostro paese è
indigeribile, non è il modo in cui lavoriamo e abbiamo mai lavorato, non è un’invenzione del
sottoscritto ma e’ una regola europea. Non un euro andrebbe speso senza che i soggetti
che lo spendono individuino qual è il risultato atteso. Che cosa voglio dire (tanto per essere
chiari)? Che se si finanzia in formazione, perché nel processo di oggi è un termine che è
uscito fuori, non mi interessa quanti soggetti vengono formati, non mi frega nulla del
numero di ore di formazione, voglio capire qual è l’obiettivo, es di ridurre da 22 settimane a
15 settimane il tempo di attesa medio per trovare un lavoro. Benissimo, questo è il risultato
atteso, e viene misurato e verrà giudicato in base al risultato che abbiamo fatto. Lo stesso
dicasi se faccio una strada, se la faccio perché voglio ridurre l’incidentalità, quanti sono i
morti mediamente all’anno, quanto voglio che resteranno i morti e feriti dall’anno
prossimo? Questo dovrebbe diventare il modo con cui si lavora. Il pregio di questo modo di
lavorare, e chi volesse andare a vederne un’applicazione (non una teoria) la può cercare nel
sito http://www.dps.tesoro.it/aree_interne/ml.asp, è che riconnette di nuovo la tecnica alla
politica. Che cosa vuol dire? Che se l’unico modo per giudicare il successo dei fondi
comunitari è il fatto di averli spesi, o è il fatto di aver realizzato l’intervento, questo tipo di
intervento alla gente non interessa niente, certo interessa ai formatori non ai formati.
Avere ristrutturato domani l’ex-ospedale di Biella interessa a quelli del cantiere, ma ai
cittadini non interessa nulla se la mattina dopo quel luogo non diventa un luogo
straordinario dove entrano, escono e ci sono servizi… Quindi ai cittadini (e per un istante
guardo il Sindaco di Biella parlandogli come ex Ministro della Repubblica) noi, quando
svolgiamo queste funzioni esecutive, dobbiamo restituire il linguaggio: ho fatto questo
intervento ma io dopo sto meglio, perché? Stai meglio perché, parlando di scuola, il livello
misurato dall’INVALSI (se non mi convince l’Invalsi trovo un altro metodo...) rispetto alla
competenza in matematica dei ragazzi di questo territorio tra tre anni deve migliorare.
Quindi risultati attesi, prima delle azioni, e misurabili.
6.Sesta cosa, che ha a che fare con le risorse finanziarie. Ho visto i riferimenti e nel
territorio avete diverse fonti: ci sono le fonti ordinarie (comunali, regionali, nazionali), poi ci
sono in fondi comunitari di varia natura e poi, in questo contesto e a differenza del sud, ci
sono i fondi che vengono dalle fondazioni. E’ importante che l’insieme di queste risorse, io
non so se qui c’è presente qualche rappresentante delle fondazioni che operano sul
territorio, venga orientato a vantaggio di una strategia. Una volta che la strategia esiste
tutti possono orientare l’impiego di fondi ordinari, comunitari o derivanti dai patrimoni
fondazionali, impiegandoli nella strategia, anziché a “tacconare” le esigenze che arrivano.
Quindi il vantaggio di avere una strategia in un territorio è che rimette in ordine l’insieme
delle risorse, ridà a tutti i soggetti che devono decidere l’allocazione di fondi una stella
polare sulla quale concentrarsi. Nel fare questo la seconda attenzione molto importante è
la seguente, sto per dire una cosa banale ma l’abbiamo sbagliata negli anni passati: con i
fondi delle fondazioni e quelli comunitari, che non hanno la caratteristica di essere
7
permanenti, non possiamo e non dovremmo mai finanziare nulla di permanente, (perché
noi invece abbiamo utilizzato quei fondi anche per cose permanenti, nel “noi” metto anche
le responsabilità centrali... perché avevamo l’acqua alla gola...). Non puoi finanziare così dei
servizi scolastici, o un pezzo di Trasporto Pubblico Locale come molte aree hanno fatto, per
cui i cittadini si ritrovano poi ad avere un sistema di servizi in discussione (con giovani che
hanno preso la decisione di andare a vivere in quei territori) che poi vengono chiusi perché
sono finiti i fondi comunitari. No! Gli interventi che riguardano la scuola, la salute, il
trasporto pubblico locale devono incidere nella carne del disegno della politica ordinaria,
diventarne parte, avere natura di permanenza. Quindi alcuni degli interventi che avete
accennato possono essere soggetti a progetti una tantum, altri no.
7.L’ultima osservazione: sono emerse dalle cose che avete detto due tipologie di interventi
che ovviamente travalicano l’area, entrambe fondamentali. A) il sistema generale di
regole relative a “tessile e salute”, che è utile per tutti i paesi, ma per un territorio come
questo è come per gli amici agricoli della piana di Sibari, che vendono arance in Germania e
devono essere sicuri di poterle vendere a un prezzo al kg più alto là in Germania, rispetto ai
produttori del Nord Africa e senza imbrogliare o lavoro in nero, perché quell’arancia è
prodotta nella piana di Sibari, ha una storia, caratteristiche e garanzie certificate, che se
non riescono a darle sono persi. Quindi si tratta di scelte razionali. B) C’è una seconda cosa
che avete evocato che è nazionale, anche se le Regioni hanno un ruolo molto importante,
che è il digitale, perché moltissime idee che avete detto richiedono che non avvenga una
cosa che sento spesso in giro per i territori, che è “- Sì, noi fino alle 7-7,30 di sera ce la
facciamo, ma dalle 7.30 di sera dobbiamo decidere se beve solo un bicchiere uno di noi o
beviamo tutti un sorso. - Ma di che state parlando? – Sì, perché se ci colleghiamo tutti alla
rete internet è finita...”. Quindi nei territori discorsi del tipo “Mettiamo la medicina a
distanza” sono collegati alla reale possibilità della rete: se devi controllare una terapia ma
non hai più il collegamento come puoi farlo?
E’ evidente che molte delle cose che andiamo dicendo, che riguardano la scuola, il
marketing delle imprese, la possibilità delle persone di arrivare in un luogo, il sistema
ricettivo, riguardano un’area vasta che si organizza, diventa un punto di forza negoziale,
un soggetto unitario che negoziando a livello regionale o nazionale, o in maniera
istituzionalizzata in generale, diventa un interlocutore unitario, quindi può ottenere delle
garanzie in relazione a una manifestazione di effettiva esigenza. Non semplicemente “voglio
il digitale” ma perché nell’analisi che ho fatto ti dimostro che la disponibilità di 30 mega non
potenziali ma effettivi diventano il requisito fondamentale: altrimenti dimmelo subito
perché faccio un’altra strategia.
Finisco le osservazioni: con riferimento al mosaico che si intravvede è evidente che l’idea
forza, l’idea leader, ha il tessile al centro. Tessile mi pare declinato in diversi colori: verde,
visibile nelle esperienze e nelle caratteristiche della domanda descritta prima (c’è una
8
assonanza con questo “museo del falso” appena inaugurato, quali sono i “tessuti falsi”? Il
territorio si sente forte di poter dire “io faccio tessuti veri e racconto i falsi che ci sono...). Il
tessile ha un’identità storica importante: chi analizza le differenti domande di turismo nel
mondo ci racconta che il turismo che viene dalla Cina, a differenza di quello che veniva dal
Giappone e che viene negli ultimi anni dalla Corea, è un turismo che chiede la storia, cioè
vuole sapere, quando si muove, cosa vede, come si è arrivati a produrre, in quale modo,
dove, quindi idee culturali su come si potrebbe raccontare in relazione al territorio, tessile e
identità storica, quale è il colore della storia? Il giallo? Mi viene da pensare al rosso se
penso ad una terza caratteristica che ho sentito poco e forse il Partito Democratico
dovrebbe averla a cuore, che è la sicurezza e la partecipazione nel lavoro. Non è irrilevante,
e mi auguro che diventerà sempre più importante: le produzioni realizzate in condizioni di
sicurezza, senza che i lavoratori abbiano incidenti, senza che abbiano effetti nocivi e che
siano prodotte con un lavoro che abbia dato in fabbrica la chance di partecipare. Questo ci
ricorda che nei processi “partecipati” un partito che si chiama democratico dovrebbe
inserire in maniera profonda il fatto di mettere in grado i lavoratori di raccontare e di dire
che in un progetto di rilancio del tessile ci sta anche un lavoro appunto “partecipato”. Penso
al lavoro di Giuseppe Berta (Produzione intelligente, Einaudi, 2014) sulle produzioni
partecipate collaborative, con esperienze interessanti proprio in Piemonte, in questa Italia
dove siamo disattenti al lavoro e dove in realtà si vanno diffondendo nel sistema delle
medie imprese forme molto interessanti di rapporto tra lavoro e capitale di tipo
collaborativo, con risultati da valorizzare. L’ultimo tessile che avete espresso è bianco, ed è
la salute, il legame raccontato tra la salute di un territorio e la produzione. Quindi il tessile
aggettivato è la cosa che ricavo più forte dai vostri racconti.
In un’idea guida non ci deve stare tutto, anzi la forza di un’idea guida è proprio quella che
non ci deve stare tutto. Però non ci devono stare cose a metà...
La cultura è uscita pochissimo dai racconti, e mi domando invece cosa ci potrebbe essere,
mentre il paesaggio c’è stato di più, mi sono virgolettata la frase “ci sono pezzi di pessimo
paesaggio urbanistico in questo territorio” e ci possono essere progetti come quello che ci è
stato presentato di ricucitura o di riqualificazione di questo, costruiti in maniera
partecipata, sia in aree rurali, sia in aree urbane.
Terzo e ultimo gruppo sono le funzioni di servizio: digitale, formazione, salute. Una frase
che mi ha colpito perché è fortissima, ed è un vantaggio comparato, è questa: “...Biella ha i
problemi che l’Italia avrà tra 20 anni”. Se la valutazione è condivisa avete una chance
straordinaria, perché lavorando bene su questa questione potete proporvi come un centro
di riflessione sui servizi per il resto del paese, questo è un punto fondamentale.
Vedo invece un tema non esplorato e che mi sembra inevitabile, che è la scuola, la
conoscenza della storia, la formazione sin dall’infanzia, sull’identità di questo territorio, nel
9
sentire questo territorio, la combinazione con il paesaggio, la conoscenza delle
caratteristiche dei prodotti e dell’orgoglio di dire “questa è roba che facciamo noi”, sono
degli elementi fondamentali per l’identità di un territorio che perde popolazione, perché
impattano sulle scelte che faranno i giovani, all’università e nel futuro. E’ stata citata invece
una nuova pedagogia che riguarda il paesaggio e che in molte parti d’Italia sta emergendo
come elemento di estrema importanza.
Chiudo facendo delle osservazioni che riguardano il Partito Democratico.
Perché questa azione attraverso il partito? E’ solo il generoso lavoro di iscritti e di
responsabili di Circolo che hanno fatto una cosa… o c’è un senso per cui il PD dovrebbe
farlo? Chi ha organizzato l’incontro in realtà si è posto il problema, perché l’ha domandato a
tutti gli intervenuti ed è diversa la risposta. In un caso stiamo parlando di un pur giusto
volontarismo, nell’altro stiamo parlando dell’assolvimento di una funzione. Penso che sia la
seconda la risposta, esistono tre ragioni per cui è sacrosanto che questo avvenga e non è
casuale che in questo momento in giro per l’Italia sia proprio un partito ad intercettare
questa domanda di area vasta, questo bisogno di costruzione di strategia.
La prima ragione è la conoscenza, che è necessaria sia per costruire la visione (e quindi per
le cose difficilissime che sono le scelte, cosa faccio, cosa non faccio, non faccio tutto, qual è
l’azione, cioè la fase ascendente) e sia per quella cosa che noi facciamo pochissimo in Italia
che è il processo di attuazione. L’80% del successo di una cosa è nel farla, e l’80% della
conoscenza che è necessario avere non ce l’hai: nella fase ascendente hai avuto le intuizioni
ma la forza, ormai l’abbiamo imparato, dell’attuazione delle strategie è evitare di decidere
tutto all’inizio e costruire un processo che nel corso della sua attuazione si arricchirà di
conoscenza. Chi svolge questa funzione di “polmone di conoscenza”? Quale soggetto più
ovvio di un partito, non 100 anni fa ma ora, per farsi carico dell’interesse pubblico? E non di
essere uno strumento di innalzamento personale o per trovare lavoro più facilmente?
Questo ha in comune il partito di oggi con il partito di massa del novecento, fosse esso la DC
in Italia, o la CDU in Germania, o il partito labourista o comunista o socialista in Gran
Bretagna, Francia.. Quello era un partito con milioni di iscritti (tra Dc, Pci, Pri... in Italia si
facevano 6 milioni di iscritti) che sceglieva le proprie avanguardie che studiavano e
andavano avanti.
Noi siamo in un altro mondo, con un numero enorme di persone in grado di dare un
apporto cognitivo, un partito molto più piccolo dove però una grandissima parte di quelli
che stanno dentro può dare un contributo, quindi, è un’altra cosa, può cioè svolgere
un’attività di palestra, può essere parte di un processo come avete fatto voi o come stanno
facendo in giro per l’Italia da Parma a Catanzaro. Quindi la prima cosa è palestra della
conoscenza.
La seconda è stata detta all’inizio. Ma perché non bastano le organizzazioni dei cittadini?
Le organizzazioni di cittadinanza attiva sono una grande risorsa di questo paese, Giovanni
10
Moro nel suo splendido libro ci dice che in Italia sono circa 105mila, (il che vuol dire, mi
sono segnato il numero detto prima rispetto al Biellese, che voi ne avreste il doppio)
raccolgono in Italia 2 milioni di volontari e 500 mila occupati: parliamo di una massa d’urto
di enormi proporzioni che produce servizi di cura, di organizzazione, ecc. ma che ha un
problema, cioè organizza interessi identici, uno organizza interessi ambientali, uno si
occupa di infanzia, anziani, ciclisti, ecc. Sono una parte della nostra società, i partiti non
possono pensare di inglobarle oppure di farne a meno, ma non ce la fanno a svolgere quella
funzione di collage, tra interessi diversi, avendo in comune alcuni valori, come richiamato
all’inizio dell’incontro.
Rimane il fatto che gli interessi sono molteplici, ci stanno i lavoratori, ci stanno gli
ambientalisti, ci stanno quelli antiambientalisti, ci stanno gli insegnanti che vogliono il
dirigente scolastico al potere, … e quelli che dicono che non serve a niente. La caratteristica
di un partito è quella di avere interessi diversi al proprio interno, questa è una ricchezza
straordinaria perché ti consente di assorbire dentro a un’organizzazione il conflitto tra
persone che hanno però in comune dei valori. I valori: solo in Italia continuiamo a pensare
“è finito il tempo dei valori”, non c’è più la sinistra, non c’è più la destra…, siamo solo noi
che continuiamo a ripeterlo... in tutto il mondo... gli americani lo hanno detto per 18-24
mesi, poi hanno capito che era una fesseria, diciamo l’America è un paese altissimamente
ideologico, anzi pure troppo ideologico, ma perché? Perché i valori sono quelli che
determinano il fatto che si spende del tempo per andare ad un incontro, per fare delle
cose... (se no rimane solo la propria casa e il proprio lavoro)… in nome di cosa devi dedicare
il tuo tempo come volontario? quelli che si occupano di Emergency… perché lo fanno se
non hanno dei valori? Quindi valori simili ma con interessi diversi. Pensate a come sarebbe
stato bello per il PD se un documento valido come quello sulla buona scuola fosse stato
discusso nel partito, pensate a quanta ricchezza di idee sarebbe uscita fuori, con gli
insegnanti che si sono sentiti disintermediati dalla possibilità di commentarla, ma
avrebbero avuto modo di parlarne all’interno del partito e alcune questioni sarebbero state
risolte. Ma il partito non ce l’ha fatta, ho fatto l’esempio su un buon documento di una
legge che ha un pezzo secondo me importante.
La seconda cosa è allora quella di avere interessi diversi e quindi, una volta coagulati, terzo
vantaggio, (e parliamo di noi, del nostro ruolo formale) di poterci incalzare.
Faccio un esempio. C’e’un momento nella giornata, verso le 11.30, mezzanotte, a seconda
di quando ha finito di lavorare chi fa questi strani mestieri di “governare”, c’è un momento
in cui avremmo piacere che nessuno ci rompesse le scatole. Ad un certo punto della
legislatura dove ero ministro, Monti mi affida la responsabilità di L’Aquila. Ho svolto quella
funzione insieme al Sindaco e siamo rimasti amici, che è un segno straordinario data la
difficoltà nel compito della ricostruzione. … quindi alle 11.30 di sera pensando di essere
tranquillo entravo su twitter e speravo di non vederlo… Chi era? Un consigliere comunale
dell’Aquila, che faceva veramente politica in città. Puntualmente ogni sera mi faceva notare
11
quello che non avevo fatto; lo avrei “strangolato” ma la mattina dopo quando andavo in
ufficio, grazie a lui, chiamavo i miei dirigenti e dicevo “ragazzi, sapete che c’è? non abbiamo
fatto questo e quello”.
Attraverso queste ed altre esperienze abbiamo maturato l’idea forte dell’autonomia del
partito dall’amministrazione, anche quando amministra il tuo partito. Da esperienze di
forti contrasti personali tra partito e governo è rimasta nel PD la sensazione della necessità
di avere identità tra le funzioni di partito e di governo: un partito che non coincide, che non
è identificato con l’amministrazione, si argomenta, inevitabilmente lavorerà a corromperla
per il prossimo mandato. Mentre invece esiste una funzione del partito che è quella di
lavorare serenamente intercettando le idee che vengono, le persone, le conoscenze, come
del resto fatto in questa sede, quando ad esempio Simona Perolo ha detto “ipotesi che ho
già posto sul tavolo” sul tema Burcina, questa è la funzione. Ovviamente il dovere di un
partito è di non farlo in una maniera sindacale, un partito non è un sindacato, non rivendica
ma elabora una strategia, e il suo dovere è di mettere sul tavolo dell’amministrazione e del
governo delle idee che abbiano un capo e una coda.
C’è un’ultima ragione, importante, che è metodologica: tutto questo che avete fatto voi,
dove si vedono elementi importanti di metodo, non è mica facile. Soprattutto non è facile in
Italia, dove, l’ho già accennato, è facile fare male questo lavoro di partito-palestra: fare un
dibattito partecipato, dove in realtà gli elementi non sono rigorosamente raccolti, dove non
vengono filtrati i partecipanti, dove non vengono invitati quelli appropriati, dove non
vengono curate le occasioni concrete di incontro. Proprio per questo, per chi di voi avesse
voglia di dargli un’occhiata, sul web trovate il sito www.luoghideali.it, che racconta una
storia di un anno di lavoro in tredici luoghi del paese, da Milano fino a Catanzaro, dove
abbiamo provato a vedere se questa idea di partito, che di fatto qui a Biella state
sperimentando con un modo vostro, fosse realizzabile. In nove casi ce l’abbiamo fatta, ce
l’hanno fatta gli iscritti al Circolo di La Spezia, di Parma, di un quartiere di Roma…
raggiungendo l’obiettivo che si erano dati. Ma l’hanno fatto, ed ecco l’ultimo punto, con
un metodo, costruendo cioè un confronto che fosse informato, che fosse basato sulla
raccolta di conoscenza, dove veniva dato conto pubblicamente dei passi che venivano
compiuti. Figuratevi un metodo in base al quale era stato identificato un valutatore del
progetto, cioè come se fossimo in un’azienda, in una scuola, come dovrebbe essere
un’associazione moderna, cioè se Enrico ed io ci mettiamo a fare un progetto è tale
l’entusiasmo, che è bene che ci sia una terza persona che ci guarda con un certo distacco,
che ogni mese ci dice con sincerità “non ci siamo”: questo è un metodo. L’esperienza
realizzata ha un rapporto finale presentato a Roma nella sede del Nazareno suggerendo al
PD di farlo proprio, come modello di sperimentazione, e mi auguro che ad un certo punto
possa diventarlo. Ma anche se non dovesse accadere, questo è un metodo che può essere
utilizzato, modificato, e ci ricorda che anche quando ci si imbarca in una creazione come la
vostra poi è necessario costruirla con una competenza, con una continuità tecnica: per un
12
motivo molto banale, perché se poi non ce la fai, o lo fai male, è peggio. In alcune parti del
nostro paese la parola processi partecipati quasi non la si può dire perché noi ne abbiamo
abusato (siamo dei consumatori di parole, le uccidiamo), abbiamo chiamato processo
partecipato, o democrazia deliberativa della robaccia, che non è riuscita. Ricordo l’esempio
di Bergamo, due anni a discutere nel partito su quale posizione prendere per l’aeroporto,
assemblee enormi..., è chiaro che a Bergamo la parola era bruciata: è importante che
processi di questo tipo possano avere risultati anche molto diversi ma devono essere fatti
con una metodologia molto forte.
Da questo punto di vista io credo che lo sforzo che ho raccolto oggi, che ho sentito oggi, il
metodo, la struttura degli interventi, del disegno, mi sembra che siano tali e mi auguro che
voi troviate la voglia e la forza di continuare e se continuerete potrete fare riferimento alle
mie reazioni e ai miei commenti.
Nel dibattito:
Sul rapporto tra partito e territorio frammentato in comuni e liste civiche.
Barca: Il vantaggio dal punto di vista dei cittadini di un partito che si concepisca come un
partito-palestra, aperto, non è tanto nell’andare ad iscriversi ma nel dedicare un’ora di
tempo per riversare in quella sede loro idee e conoscenze; il fatto di avere liste civiche e di
partito nei paesi dal punto di vista del nostro lavoro non cambia, a parte il fatto che
sappiamo benissimo che la maggioranza delle liste civiche sono solo delle denominazioni,
con precisi orientamenti politici.
Sui comportamenti in Senato di una parte del PD.
Quando parlo di conflitti nelle organizzazioni mi riferisco, idealmente in un partito che
funzioni, a una struttura che discute fino a un certo punto e finito di discutere marcia
insieme, purtroppo sono abbastanza vecchio stile e l’ho detto e scritto pubblicamente. Nel
PD la funzione dell’organo di indirizzo è rappresentata dalla direzione del partito, che oscilla
tra i 150 e i 200 membri, non esiste nessun organo di indirizzo di qualunque organizzazione
del mondo che abbia questi numeri. Quando tu non hai un organo di indirizzo vero, più che
di indirizzo è un organo di comizio, tu hai perso il luogo dove te le puoi dare di santa
ragione, che non è un caminetto ma un organo di indirizzo. Io sono cresciuto in Banca
d’Italia, e ricordo cos’era il fascino delle discussioni nel gruppo dirigente: si discuteva e
vigeva il vecchio sistema, che vigeva sempre nella Dc e nel Pci, cioè che l’incarico di
attuazione veniva affidato a chi si era opposto nelle riunioni. Se non ti va bene te ne vai, lo
puoi fare, però se hai avuto un luogo dove tutti hanno potuto dire tutto. Oggi il PD non ha
nel suo massimo livello un luogo di dibattito senza dover parlare alla stampa, con gli effetti
della comunicazione che si conoscono.
13
Sulla criticità dell’utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie.
I fondi comunitari sono uno strumento geniale inventato da Jacques Delors la cui utilità
rimane oggi legata a un fatto molto semplice: quando apri le frontiere del lavoro, delle
merci, dei capitali (una realtà indispensabile e una delle bellezze dell’Unione Europea)
questi notoriamente tendono ad andare dove la redditività è più alta. Se io nell’istante in
cui apro le frontiere non costruisco uno strumento con cui poter intervenire, nei luoghi dai
quali i capitali e il lavoro fuggiranno, mi ritrovo con uno squilibrio fenomenale: questa è
stata l’idea geniale. Gli stati nazionali sono responsabili della loro attuazione, in Italia in
larga misura le Regioni, quindi a mio avviso è un sistema valido. Concordo sull’idea che
accanto ai fondi strutturali l’UE dovrebbe avere un proprio bilancio per le funzioni essenziali
e credo, la domanda posta è molto precisa, che il Partito Socialista Europeo abbia scritto le
cose giuste ma non abbia fatto l’azione politica sufficiente per accelerare il processo di
identificazione politica. Molti sono convinti in questo momento che, soprattutto dopo la
gravissima crisi greca, è evidente che l’Europa non può non avere una unione monetaria
senza un proprio bilancio che alimenti alcuni interventi sul debito e di stabilizzazione fiscale.