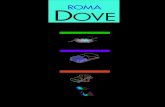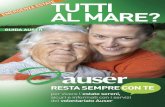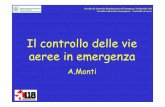Emergenza
-
Upload
massimiliano-parisi -
Category
Documents
-
view
15 -
download
1
description
Transcript of Emergenza
-
62 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
APPROFONDIMENTI
in collaborazione con l'ISEM di Palermo
con interventi di
Franco Carlini, Marcello Cini, Martino Incarbone
Ignazio Licata, Gianfranco Minati
Le emergenze della complessit
Vedere la complessit significa costruire uno spazio aperto transdisciplinare dove idee, concet-ti, metodi e stili si incrociano per descrivere e gestire le emergenze della conoscenza. Le teoriestesse sono dunque ponti emergenti tra l'osservatore e il mondo.Da questa prospettiva, compito cognitivo e responsabilit etica della descrizione del mondo siscoprono aspetti inscindibili di un unico atto epistemico. Attraverso il contributo offertodallISEM (Institute for Scientific Methodology) di Palermo, scopriamo nuovi orizzonti diricerca nel campo della complessit, e delle sue ricadute metodologiche.
-
I G N A Z I O L I C A T A
63 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
IGNAZIO LICATA
Complessit come Apertura Logica
1) Il mito del metodo unicoLa matrice fondamentale del pensiero razionale moderno
e di quella sua caratteristica creatura che la scienza, consi-ste nellidea di poter disporre di un Metodo in grado dicostruire un percorso ordinato di pensieri ed esperienze egarantire con cristallina evidenza la Verit delle varie acquisi-zioni, pensate come una successione crescente verso la con-quista definitiva del Sapere Assoluto ed Incontrovertibile.Man mano che questo ambizioso programma laico di con-quista del cielo si sviluppava, fu necessario ammettere la suadifficile realizzabilit, ma questa non veniva imputata ad undifetto di principio, bens ad intoppi pratici e contingenti,ad una non perfetta applicazione del metodo.
Limperfezione umana veniva cos ad essere valutata inbase ad un ideale di perfezione che continuava a funzionarecome principio regolatore della concezione del Sapere intesocome possibilit di accesso alla Totalit del Reale. Sotto que-sto profilo emblematica lavventura intellettuale di Cartesioe l onda lunga della sua eredit, che ancora oggi permea ilsenso comune nella concezione della scienza. La propostametodologica cartesiana centrata su unaserie di assunzioni che indicheremo global-mente con E. Morin come PensieroSemplice, le cui caratteristiche riduzioniste,lineari e dicotomiche, possono cos essereriassunte:
- laccumulo di conoscenza inversamenteproporzionale alla variazione dellignoranza;
- se un problema troppo complesso perpoter essere risolto pu sempre essere suddi-viso in tanti sotto-problemi, per i quali possibile una spiegazione. La sommatoriadelle micro-spiegazioni fornir la soluzione almacro-problema di partenza;
- proprio come in matematica, il metododeve permettere di distinguere tra questionivalide, suscettibili di chiara definizione edimostrazione, e idee irrimediabilmenteconfuse, da rigettare nel flusso temporaledel gioco delle opinioni, dei desideri e dellechimere;
- il metodo permette dunque di fissare una direzione delProgresso, una rotta ben definita rispetto alla quale even-tuali blocchi, deviazioni, ritorni e convergenze sono sempresubordinati e riassumibili nella storia globale della stradamaestra della conoscenza.
La separazione tipica del cartesianesimo tra ego cogitanse res extensa una conseguenza necessaria delladozionedel metodo. Questo infatti, prima ancora di fornire uno stru-mento di conoscenza, un esercizio di purificazione ed ascesiintellettuale, capace di mettere la mente razionale in grado dicogliere gli aspetti universali, necessari ed atemporali dellor-dine del creato, lasciando il resto al suo destino contingentedi accidente deteriorabile, prima tra tutte la corporeit.
Anche lepurazione delle tonalit emotive si rende neces-saria, nella misura in cui vengono a distorcere con capriccisoggettivi la riflessione asettica sulla realt esterna oggettivaed immutabile. Dunque la novit che definisce la razionalit
moderna, dal 600 ad oggi, consiste nellessersi auto-costituitacome strumento unico nella costruzione del territorio dellaconoscenza, grazie alladozione di un metodo privilegiato. Inseguito a questatto di hybris, il suo primo provvedimento stato quello si espellere dalle sue colonie ogni altro approc-cio con il reale incapace di esibire le necessarie caratteristichedi chiarezza, costringendolo o ad auto-confinarsi nelle riser-ve protette del sacro, oppure a nascondersi nei boudoirdel privato o nelle caverne di una vaga spiritualit, fondan-do quel gioco schizofrenico tipico della civilt moderna che stato cos acutamente analizzato da M. Foucault.
Le avventure della conoscenza negli ultimi due secolihanno visto lincrinarsi progressivo e inesorabile dello sche-ma monolitico del pensiero semplice, con la conseguentenecessit di esorcizzare definitivamente il fantasma del meto-do assoluto . Lerosione di una visione monolitica dellascienza allinterno della comunit non ha per sostanzial-mente intaccato il mito del metodo come garanzia di un cor-retto approccio con lacquisizione di conoscenza. E interes-sante infatti notare che anche scienziati estremamente com-
petenti nella loro specifica area di indagine,fuori dal loro laboratorio o dal loro ambitoteorico, mostrano un ingenuit epistemolo-gica spesso disarmante. Infine, la visionemitologica del metodo ancora la garanziasu cui poggia lo status sociale della scienzanella nostra societ.
2) Linguaggi formali e universi semanti-ci
Limpetuoso sviluppo delle conoscenzescientifiche porta, intorno all800, allacostituzione dell epistemologia come disci-plina autonoma dedita allo studio dello sta-tuto delle teorie scientifiche. Va rilevato chequesto bisogno di controllare il funziona-mento della propria disciplina non ha maicoinvolto in maniera particolare gli scien-ziati, non pi di quanto i mistici si sianointeressati allo statuto linguistico-procedu-rale della teologia.
Il dibattito epistemologico classico si incentrato essenzial-mente su tre temi principali:
IL PROBLEMA DEI CRITERI DI SCIENTIFICITIl proliferare delle conoscenze, ed in particolare la nascita
delle cosiddette scienze umane, pose il problema di stabili-re dei criteri in base ai quali una certa procedura dindaginepoteva essere giudicata scientifica oppure lasciata nellambitodellingenua empiria o della sporcizia della prassi.
evidente che a questo stadio di sviluppo della civilt occi-dentale il certificato di scientificit
gi una vera e propria garanzia di conoscenza solida, sullaquale costruire tecnologie e definire
linee terapeutiche, garante perci anche dellordine sociale.Per lungo tempo la conditio sine qua
non per giudicare scientifica una disciplina stata la suacapacit di reggere il confronto con la fisica (fisicalismo),
Ignazio Licata
-
64 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
L E E M E R G E N Z E D E L L A C O M P L E S S I T
la scienza che ha beneficiato pi di tutte le altre, almenofino agli inizi del nostro secolo, degli assunti del pensierosemplice, sviluppandosi secondo uno schema sostanzialmen-te meccanicista, riduzionista e lineare, e potendosi cosavvantaggiare di una forte matematizzazione che deriva dallapossibilit di identificare chiaramente un sistema e le suerelazioni interne ed esterne.
Questo confronto veniva ad essere penalizzante per lescienze umane ma anche piuttosto difficile da sostenere perdiscipline come la biologia o persino la geologia. Uno dei cri-teri richiesti sui quali si era trovato un certo accordo era infat-ti quello della consistenza interna, secondo il quale allinter-no di una teoria non dovevano trovare posto proposizionicontraddittorie. Questo un criterio certamente ragionevole,ma tendente a privilegiare come scientifiche le discipline conun elevato livello di formalizzazione, situazione nella qualeverificare la soddisfazione del criterio di consistenza una fac-cenda praticamente immediata. La richiesta di consistenzapu infatti considerarsi come unipotesi sullarcipelago delleconoscenze. Ci che appare separato superficialmente, devemostrare una serie di connessioni profonde ad un maggiorlivello di analisi. Questa la linea che la fisica teorica ha sem-pre seguito con successo ed ha portato oggi ad un interessepredominante verso le Teorie del Tutto. Lidea che ognimomento teorico pu essere alla fine ordinato secondo unasequenza del tipo: dove ogni teoria compresa nella successi-va secondo una relazione di pi forte di.
Unaltra questione quella della testabilit di una teoria,ossia del procedimento tramite il quale connettere gli enun-ciati della teoria ai dati osservativi-sperimentali. Anche inquesto caso le discipline altamente matematizzate sono favori-te, poich si tratta di confrontare un valore ottenuto tramitela soluzione delle equazioni che descrivono il fenomeno conla misura ricavata dalla situazione di laboratorio. Un terzo cri-terio di rilevante importanza costituito dalla fecondit diuna teoria, cio dalla capacit di risolvere un maggior nume-ro di problemi rispetto alle teorie concorrenti e di fornirenuove previsioni. Questo criterio implica per un certo gradodi commensurabilit tra le teorie in gioco. Questa com-mensurabilit, come del resto una precisa valutazione delgrado di fecondit, sicuramente agevolata dalladozione diun linguaggio formale, capace di fornire strumenti di confron-to quantitativi. Come nei due casi precedenti, anche questocriterio pi adatto ad analizzare discipline costruite secondoil modello fisicalista, o meglio,
a valutare singole teorie fisiche.
IL PROBLEMA DELLA SCELTA TRA TEORIEQuesto problema strettamente connesso alla questione
della consistenza. In questo caso per laccento spostatosullaspetto architettonico della teoria da valutare e sul tipodi connessione con il corpus di conoscenze gi acquisite. Adesempio, ci si aspetta che in una teoria fisica mirata alla spie-gazione di un certo fenomeno non vengano introdottenozioni in aperto contrasto con le leggi note. Se pensiamoallo sviluppo della fisica quantistica, per, si capisce come,pi che un astratto problema della scelta, abbiamo qui ache fare con processi di adattamento evolutivo nel senso dar-winiano, e come tali possono essere valutati soltanto aposteriori, dopo una storia articolata di tentativi e modifica-zioni. Ci fu un lungo periodo - pi lungo in effetti di quantonon si riporti nei testi di fisica -durante il quale si continua pensare che fosse possibile spiegare la struttura atomica uti-lizzando le leggi della meccanica e dellelettromagnetismoclassici, derivando da queste la costante di Planck ed i model-li chiave della prima fisica dei quanti.
Questo periodo somiglia al tentativo di salvare la teoria
degli epicicli attraverso assunzioni sempre pi complicateprima della deviazione di Keplero. In seguito, com noto,si accett lidea della necessit di principi fisici radicalmentenuovi, dove il problema era costituito piuttosto dallemerge-re del mondo classico da un background quantistico. Anchein questo caso, per, il modo di intendere questo back-ground non univocamente fissato dal formalismo, e trovia-mo uno spettro di posizioni interpretative variegate ed ispira-te ognuna ad uno scenario meta-teorico che va dallacausali-smo radicale dellinterpretazione standard, che trova la non-localit e gli aspetti contestuali della fisica quantistica comeinaspettata sorpresa, allontologia di Bohm e Hiley, che laincorporano ab initio nella struttura concettuale della teoriasalvando in qualche modo gli elementi di realt fisica cosimportanti per Einstein.
Questo esempio pu farci capire come la configurazionedelle teorie scientifiche, ad un dato momento, il risultato diuna serie di assestamenti pi o meno tellurici avvenutidurante un dibattito storicamente articolato ed, in genere,mai definitivamente concluso.
IL PROBLEMA DELLA STRUTTURA DELLA SPIE-GAZIONE SCIENTIFICA
La necessit dellanalisi storica per arrivare a stabilire leragioni di una teoria su unaltra mise in crisi definitivalideale neo-positivista di mettere a punto una volta per tutteuna sintassi generale delle procedure scientifiche, quasi si trat-tasse delle regole degli scacchi. Questo ideale, diretto erededella concezione onnipotente del metodo, mirava allacostruzione di un linguaggio formale universale, di leibnizia-na memoria, tramite il quale mettere a punto una sorta digrammatica dove trovassero posto non soltanto le regoledella scienza ma anche i risultati di ogni singola disciplinache via via si andavano accumulando. Un simile programmaappare retrospettivamente ingenuo per la sua inutilit, pi omeno come i Principia Mathematica di Russel e Whiteheadche risultarono pi interessanti per i logici che per i matema-tici; ancora di pi per la sua concreta irrealizzabilit, legata aiteoremi di Gdel ed in generale allimpossibilit di chiude-re formalmente un sistema di conoscenze in fieri. Eppurepi di un tentativo fu fatto, il pi famoso dei quali resta cer-tamente labbozzo della Encyclopedia of Unified Science,pubblicato intorno agli anni 40. Influenzati dalla filosofiaanalitica inglese, dagli sviluppi della logica simbolica e dal-limpostazione fisicalista, unintera generazione di epistemo-logi tent ripetutamente di inquadrare il problema della strut-tura della spiegazione scientifica come un procedimentoessenzialmente formale. Infatti, sia per il verificazionismodegli empiristi logici (Circolo di Vienna, 1928), che per il fal-sificazionismo di Popper (1934) e dei suoi numerosi seguaci,la spiegazione scientifica consiste nel connettere enunciatiparticolari ed enunciati generali attraverso una catena dedut-tiva, dalla quale poi possibile ricavare un enunciato base dasottoporre a verifica per gli uni o che funga da falsificatorepotenziale per gli altri. Gi i lavori di P. Duhem e poi di G.Bachelard avevano minato alla base questa concezione forma-le dellepistemologia, mostrando che non c comprensionedella scienza senza lanalisi storico-critica delle modalit dicostituzione del sapere scientifico. Del resto anche R. Carnap,uno dei fondatori del Circolo di Vienna, dal 1947 in poi, con-centr la sua attenzione sulla semantica delle teorie, abbando-nando la vecchia visione puramente sintattica e rendendosiconto di come anche i termini scientifici fossero soggetti avariazioni di significato in relazione dinamica al contestodel discorso entro il quale venivano inquadrati, analogamen-te al processo di semiosi illimitata studiato da C. S. Peirce.
Lidea di una scienza pura, chiaramente distinguibile dal
-
I G N A Z I O L I C A T A
65 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
contesto culturale e storicamente continua e lineare attraver-so un progressivo accumulo di conoscenze, fu messa in crisidalle analisi di G. Bachelard (1938) e di H. Blumemberg(1979), che mostrarono come lo spirito scientifico sia sem-pre stato imprescindibilmente collegato al bagaglio di imma-ginario e mito che parte integrante e fondamentale del rap-porto Uomo-Natura, e come la stessa scienza moderna, nellasua assiomatica infallibilit, tenda di fatto a costituirsi comeuna sorta di mito contemporaneo che trova il suo narratoreomerico nella persuasivit mass-mediatica.
Un altro contributo decisivo verr dallarcheologia delsapere elaborata negli anni 60 da M.Foucault con la dottri-na delle epistemi, reti concettuali sotterranee che caratterizza-no latmosfera comune dei saperi di unepoca. Le mutazioniepistemiche non si succedono secondo un ordine lineare, maper discontinuit enigmatiche; non c una Ragione, adispetto dell autobiografia che la scienza costruisce a suouso e consumo, ma una successione di ragioni che cambianosenza ragione (Piaget), attraverso biforcazioni improvvise ecatastrofi momentanee. in questo clima di demitizzazionedella scienza che appaiono gliormai classici lavori di T. Kuhn edi P. Feyerabend, durante gli anni60 e 70. Riprendendo daBachelard la nozione di rotturaepistemologica, che indica la crisidelle abitudini di pensiero e degliatteggiamenti psicologici cultural-mente consolidati durante i pas-saggi da una visione scientifica adunaltra, Kuhn si concentr sul-lanalisi dei modi storici in cui difatto la scienza procede, in chiaraopposizione con la vecchia episte-mologia formale degli empiristilogici e di Popper. Nella suaStruttura delle RivoluzioniScientifiche (1962) delinea unmodello non cumulativo dellosviluppo delle scienze che avvienesecondo il passaggio da un para-digma ad un altro, dove con para-digma si intende una solida strut-tura di assunti concettuali, teorici,strumentali e metodologici cheguida la comunit scientifica nella ricerca su un determinatocampo; il crollo avviene quando allinterno del vecchio para-digma si accumulano tante anomalie tali da far saltare loschema in favore del nuovo. Bisogna dire che Kuhn utilizzquesta nozione nellanalisi dei processi macro -storici, come ilpassaggio dal sistema tolemaico a quello copernicano o dallafisica classica alla quantistica. In seguito il concetto di paradig-ma stato utilizzato anche come nozione micro-storica, perrendere conto delle divergenze di vedute che possono con-trapporre micro-comunit scientifiche che si trovano comun-que daccordo sugli asserti generali.
Anche P. Feyerabend, basandosi su unanalisi prevalente-mente storico -critica della scienza, mostra non soltanto chele regole metodologiche proposte dalle epistemologie forma-li sono state pi volte violate nella prassi della ricerca, ma chequeste trasgressioni si sono rivelate estremamente feconde.Da questopera di liquidazione del metodo(inteso comemetodo generalista e meramente formale!) Feyerabend giun-ge ad un radicale anarchismo metodologico. In Contro ilMetodo (1975) sostiene che la scienza crea di volta in voltale regole di cui ha bisogno, in relazione allo specifico proble-ma trattato. Non esiste dunque un metodo generale, ma
una pluralit dinamica e mutevole di strategie ed atteggia-menti teorici. Coerentemente con le proprie posizioni con-trometodologiche, in La Scienza in una Societ Libera(1978), mostrer che impossibile distinguere in modo rigo-roso fra scienza e non-scienza e giustificare la posizione pre-dominante che la scienza pretende di avere nel sistema cultu-rale e sociale contemporaneo. Questa posizione ha suscitatoaspre polemiche, poich il senso della provocazione cambiase viene proposta in una realt dove la scienza forte,oppure in realt culturali dove il suo ruolo pi sfaccettatoed incerto, come possono essere lItalia, che risente ancoradelleredita di Croce e Gentile, o la Russia post-comunista,con il suo revival di magia e parapsicologia. E evidente cheanche lintento democratico della provocazione assume con-notazioni diverse in contesti diversi, confermando la tesi difondo che un esauriente concetto generale di scienza troppo povero per poterne cogliere i nodi cruciali interni allacomunit ed i meccanismi di consenso e comunicazione conil contesto socio-politico.
In questo senso stimolante la proposta di N.Goodman(1978) di una commensurabilittra lo scienziato e lartista comefabbricanti di mondi, superan-do cos la dispotica dicotomiatra modelli formali e contesti, esostituendola con un bacino frat-tale di sottili interpenetrazioni.
Comincia cos ad apparire chia-ro che non si danno fatti se nonallinterno di un contesto teorico;modificando il contesto cambia-no le relazioni tra i fatti e il lorostesso significato (tesi di Duhem-Quine). In questa direzione va ilmodello a rete di M. Hesse, secon-do il quale non vi differenza diprincipio tra enunciati teorici edosservativi. Infatti, se non sidanno fatti se non allinterno diunarticolazione teorica di questi, vero pi in generale che non esi-ste scienza che non sia inserita inun pi ampio assetto culturale esocio-economico.
H. Marcuse in LUomo a unaDimensione (1964) individua nelle epistemologie formali enella stessa immagine asettica del modello di produzionescientifica delle vere e proprie filosofie dellintegrazionenellambito del sistema di produzione neo -capitalista. Piavanti J. Habermas riprender il tema analizzando la connes-sione cruciale tra scienza e dominio tecno-burocratico, conlalienante conseguenza della scissione tra le crescenti ten-denze auto-refenziali della produzione scientifica ed i biso-gni della gente.
La separazione tra scienza e cultura rivela che il saperescientifico non una strategia pura per la comprensionedella natura, ma si ormai costituito come lultima roccafor-te ideologica della cultura occidentale. ormai chiaro, soprat-tutto dopo lo sviluppo delle nuove impostazioni di sociologiacritica della scienza e di analisi scientifica della ricerca stessa apartire dal saggio di D. Bloor(1976) che il binomio scien-za/metodo un pretesto per dare un senso unitario e fonda-tivo ad un modello di sviluppo economico e sociale impos-sibile negare limportanza della ricerca scientifica, ma dobbia-mo interrogarci se lassetto scienza-cultura tradizionalmenteproposto ed ancora garante della comunicazione ufficialetra ricercatori, gruppi di ricerca e societ sia lunico possibile
Arte e complessit. Escher, Caos e Ordine
-
66 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
L E E M E R G E N Z E D E L L A C O M P L E S S I T
o se non sia invece un meccanismo logoro e sclerotizzato cheimpedisce a s stesso nuove possibilit evolutive.
3) La complessit tra cibernetica e teoria dei sistemiLa storia scientifica della complessit nasce con le esigenze
interdisciplinari sempre pi marcate della ricerca moderna, esuggerisce un approccio epistemologico radicalmente diversoda quello tradizionale. Non c pi una realt esterna fissada rappresentare mediante luso di principi universali dipartenza e una successione di teorie organizzate secondouno schema lineare. Piuttosto, il sistema della conoscenza caratterizzato da un processo di evoluzione ed auto-organizza-zione delle informazioni che procede per successivi anelli diretro-azione dai risultati ai principi, modificando gli uni e glialtri, in una progressiva costruzione della realt. Alla defini-zione di questa linea di pensiero hanno dato un contributodecisivo le ricerche di W.Mc Culloch,Von Bertalannffy, N.Wiener, J. Piaget, H. von Foerster, G. Bateson, H. Maturana,F. Varela ed H. Atlan.
Per fissare le idee, ricordiamo la definizione di sistema diHall-Fagen (1956): un sistema un insieme di elementi (azio-ni, individui, concetti, teorie) in relazione tra loro. Nella suaapparente semplicit questa definizione nasconde insidie con-cettuali formidabili, che furono al centro dei dibattiti dellaMacy Foundation, tra il 1946 ed il 1957, una serie di incon-tri trans -disciplinari che passarono in seguito alla storia conil termine in verit un po genericoed ormai irrimediabilmente inflazio-nato di cibernetica.
Durante il dibattito emersero conparticolare evidenza due posizionidiverse nel considerare sistemi divaria complessit e lo scambio din-formazioni tra loro. J.vonNeumann, interessato pi alla teoriadegli automi e degli elaboratori digi-tali, mise laccento sull eteronomiadel sistema e sulla sua capacit diessere in -formato dagli input del-lambiente che ne determinano gliout-put; in questo modo si stabilisceuna corrispondenza tra sistema edambiente attraverso una relazioneche pu essere definita di tipo istrut-tivo-rappresentazionale. Lambienteistruisce il sistema in modo chequesto sia in grado di rappresentar-lo. Vediamo in questa concezione un legame stretto con lavecchia epistemologia formale e soprattutto lintuizione innuce del paradigma della mente come elaboratore digitaleche ispirer la prima Intelligenza Artificiale.
N. Wiener, interessato alle macchine ma anche alla biologiae pi in generale ad un uso umano degli esseri umani -come recita il titolo originale del suo famoso Introduzionealla Cibernetica (1950) -, mise in evidenza i limiti della con-cezione di von Neumann, osservando che macchine di queltipo andrebbero in tilt in presenza di paradossi, entrandoin cicli ricorsivi senza fine. Pass in seguito ad analizzare glielementi di novit contenuti nella motrice a vapore di Watt,capace di essere informata sui cambiamenti del mondoesterno da un meccanismo di auto -regolazione, e sviluppquestultimo concetto in relazione al gioco stimolo -rispostanegli organismi viventi. La posizione di Wiener si contrappo-neva a quella di von Neumann perch centrata sulla nozionedi autonomia del sistema rispetto allambiente e di come que-sta autonomia permetteva una chiusura operazionale capa-ce di garantire dei processi di auto-adattamento, secondo una
visione sistemica molto pi adatta allo studio dei sistemi bio-logici e cognitivi.
dallimpostazione di Wiener che ha origine la nozione disistema autopoietico utilizzata nella teoria di Maturana -Varela-Bateson. I sistemi autopoietici sono sistemi dotati diuna struttura a rete che connette gli elementi in gioco trami-te una gerarchia di anelli di feed-back. Un sistema di questotipo in grado di mantenere la propria configurazione graziea cicli di auto-rinnovamento e di modificarla attraverso nuoveconnessioni nella struttura a rete. In questo modo si auto-organizza, modificandosi ed al contempo conservando la pro-pria identit.
I sistemi autopoietici sono in continua relazione dinamicacon lambiente circostante tramite interazioni ricorrenti e per-turbazioni, un procedere fianco a fianco che detto accop-piamento strutturale. importante sottolineare la differenzacon il modello di von Neumann: in quel caso lambiente for-niva degli input di tipo istruttivo al sistema, mentre nel casodellaccoppiamento strutturale la natura stessa del sistema,in base alla sua peculiare configurazione dinamica a rete edalle sue soglie di sensibilit, a selezionare gli input del-lambiente e ad assestarsi internamente, in un modo chelambiente non pu ne specificare ne dirigere. I cambiamen-ti strutturali interni sono cambiamenti evolutivi. Questomodifica profondamente la visione tanto diffusa quantoimprecisa, se non ideologicamente viziata, dellevoluzione
come un processo di ottimizzazione.Ritornando alle idee originali diDarwin, bisogna invece dire cheambiente ed organismi co-evolvo-no (J. Lovelock). Nella concezionedellaccoppiamento strutturale implicita lidea dellevoluzionecome possibilit di compatibilit traorganismo ed ambiente e tra sistemidiversi. Nel corso del processo onto-genetico, esiste perci uno strettolegame tra evoluzione, sviluppo edapprendimento, poich i vari livelligerarchici di un sistema si riconfigu-rano continuamente sulla base dellestrutture interne precedenti e dellastoria del sistema.
qui che entra in gioco unanuova visione della conoscenza edei compiti di unepistemologiadella complessit. Scrive efficamen-
te Maturana : I sistemi viventi sono sistemi cognitivi ed ilvivere in quanto processo un processo di cognizione. Neiprocessi auto-poietici si viene cos a stabilire una rete seman-tica che definisce il dominio cognitivo di ogni sistema; que-sto dominio non caratterizza soltanto quello che ci arriva ecome ci arriva, ma anche - e forse in misura maggiore - tuttoci che non vediamo del mondo. La rete semantica anchessa un processo e dunque il dominio cognitivo cambiain continuazione. Dunque ogni organismo non rappresenta ilmondo, ma lo genera continuamente. In questo senso Varelaafferma che la mente ed il mondo sorgono assieme. Vienecos re-integrato ad un livello fondamentale losservatore nelprocesso della conoscenza: non si d alcun Mondo indipen-dente
dagli osservatori, bens un mondo per ogni osservatore.Questo non significa in alcun modo rinunciare ad ogni formadi elementare e sano realismo, ma semplicemente afferma-re che esiste un circolo virtuoso tra la biologia della conoscen-za (R. Reidl) e le strategie epistemologiche che produciamo inrelazione ad un problema.
-
I G N A Z I O L I C A T A
67 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
4) Il ruolo dellosservatore e lapertura logicaUn esempio illuminante della diversa strategia epistemica
sono i cosiddetti processi emergenti tipici delle aree inter-disciplinari. Bisogna sottolineare con forza la relazione tracrossing disciplinare e fenomeni emergenti, perch la possi-bilit di identificare lemergenza strettamente connessaallutilizzazione di approcci metodologici diversi convergen-ti su un problema, in modo tale da determinare un amplia-mento del dominio cognitivo delle discipline di partenza inuna nuova visione prospettica. Una prima definizioneintuitiva di emergenza quella di novit. Una novit tale sempre in relazione ad uno schema o un modello pre-definito, unottica epistemica, anche questo significatonaive dunque utile per fissare le idee. Pi significativa ladistinzione tra due tipi di emergenza, lemergenza computa-zionale e lemergenza intrinseca (Baas- Emmeche,1997). Nelprimo caso il ruolo dellosservatore quello identificareuna forma che pu comunque essere prevista in base almodello teorico del sistema. Questo significa che il proces-so individuato, per quanto non banale, pu comunqueessere ricondotto, tramite lanalisi del modello, ad unadescrizione computazionale. Questo il caso di molti siste-mi non-lineari, come i sistemi dissipativi e caotici, e ci sonobuoni motivi per supporre che ogni tipo di emergenza com-putazionale rientri strutturalmente in una delle quattroclassi di automi cellulari di Wolfram-Langton. Lemergenzaintrinseca invece appare pi radicale, poich non soltan-to non pu essere prevista in base alleassunzioni di modelli precedenti, anche secompatibili con questi, ma richiede allos-servatore la formulazione di un nuovomodello mirato alla comprensione di carat-teristiche peculiari. Questo equivale allacreazione di unottica epistemica nuovaper vedere ci che in altri modelli invi-sibile. In questo senso parliamo anche diemergenza osservazionale, poich essadipende dalle scelte dellosservatore e daisuoi obiettivi.
Questo aspetto stato inquadrato concet-tualmente e formalmente nella recente teo-ria dellapertura logica dei sistemi (Minati,Penna, Pessa,1998; Licata, 2006, 2007) cheindaga e sviluppa la nozione di accoppia-mento strutturale dal punto di vista matema-tico. Sugli aspetti formali non ci soffermeremo in questa sede,ricordando soltanto che in atto unintensa ricerca in variedirezioni che include la logica formale, la teoria delle catego-rie ed alcuni modelli basati sulla sintassi della teoria quantisti-ca. Dal punto di vista concettuale possiamo limitarci a direche la teoria fornisce gli strumenti per ordinare i sistemi inuna gerarchia di classi di complessit individuata dal tipo direlazioni con lambiente prese in considerazione in ognimodello. E interessante notare che in questo caso non sem-pre possibile ordinare i vari modelli in una sequenza regolatadalloperatore pi forte di, e che modelli diversi hannopotenzialit descrittive diverse e complementari, cosa che haportato naturalmente alluso di un principio di indetermina-zione generalizzato tra modelli (Volkenshtein). Nella teoriagiocano un ruolo chiave i cosiddetti indici di apertura logica,che individuano la complessit informazionale delle relazionisistema-ambiente. Sistemi tipicamente a bassa apertura logicasono i sistemi classici dellintelligenza artificiale, che sonodescritti da modelli formali su domini semantici limitati,mentre i processi cognitivi mostrano unapertura logica altis-sima, non riconducibile ad un singolo modello formale. Unsistema ad alta apertura logica (tipicamente un organismo bio-
logico), non pu essere catturato da un unico modello for-male, ed in particolare da un modello formale con un minorgrado di apertura, che al pi potr coglierne soltanto alcuniaspetti. Tutto ci porta naturalmente ad una sorta di indeci-dibilit formale tra modelli diversi, ed possibile infattimostrare che lapertura logica lequivalente dei teoremi diGodel-Turing-Chaitin applicati ai modelli formali di sistemicomplessi. La visione della complessit che deriva da questaimpostazione teorica va in direzione radicalmente diversa diquella delle tradizionali teorie del tutto della fisica. Infattiin queste ultime la ricerca va in direzione di un modello uni-ficato delle diverse teorie fisiche in una struttura coerente edindipendente dalla descrizione dellosservatore, mentre nelleteorie dellorganizzazione e della complessit laccento postosulla triade osservatore-sistema-ambiente. In altre parole, lim-postazione delle teorie del tutto fondamentalmente quelladi una fisica delle leggi, mentre lo scenario dellaperturalogica soprattutto una scienza del processo e dei vincoli.
Nella concezione tradizionale dellepistemologia linforma-zione, attraverso una serie univoca di procedimenti, venivapresa dal mondo ed andava poi a costituirne una rappresen-tazione la cui ambizione era quella di essere una fotografiadel mondo. In unepistemologia della complessit si ha lasituazione esattamente inversa: ogni dominio cognitivo, ad unmomento del suo sviluppo, una rappresentazione delmondo peculiare del sistema ed entro questa rete semanticache le perturbazioni esterne diventano informazioni ed assu-
mono una valenza significativa. Al posto diuna rappresentazione ultima troviamoinvece una galleria di quadri del mondo,ciascuno diverso dallaltro, con soggetti,colori, prospettive e stili estremamentediversificati: un paradigma artistico dellaconoscenza.
Questi approcci alla complessit possonoessere applicati anche alla dinamica internadelle teorie, ed ai loro processi evolutivi, algioco reciproco dei conflitti ed assestamen-ti strutturali, permettendo cos allepiste-mologia di costituirsi come disciplina degliorganismi teorici, capace di coniugare glistrumenti formali per lo studio dei processidi produzione della conoscenza scientificasia di mantenere il proprio ruolo meta-teo-rico, facendo convergere le intuizioni filo-
sofiche sul ruolo dellosservatore e lanalisi formale della suaattivit rappresentazionale. Tutto ci stabilisce una connessio-ne naturale e profonda tra biologia e cognizione, particolar-mente evidente nei recenti studi sulla embodied cognition ( vediCappuccio, 2006; Freitas, Maldonato, Pietrobon, 2006).
Il sistema della scienza- in modo analogo, sotto molti aspet-ti, al sistema dellarte (vedi Poli, 2006 )- un sistema ad altaapertura logica, non riconducibile ad un unico schema forma-le. In particolare, losservatore ed il costruttore di modellisono in modo ovvio, un sistema con unapertura logica assaipi alta di quella del suo prodotto, e dunque lattivit epi-stemologica non pu prescindere dal prendere in esame, inmodo esplicito, il gioco complesso di finalit e ruoli che unmodello viene ad avere allinterno della dinamica culturale esociale in cui si sviluppa ogni impresa scientifica.
5) Stili nella scienza ed ecologia dei saperiLesplorazione della dimensione della complessit intesa
come recupero del ruolo centrale dellosservatore non puridursi semplicemente ad una nuova e diversa concezionedella conoscenza. Il rischio che si corre infatti quello gi sto-ricamente attraversato sia dalla cibernetica che dalla teoria dei
Natura e complessit. L'uragano Linda
-
68 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
L E E M E R G E N Z E D E L L A C O M P L E S S I T
sistemi, ossia di essere risolte ad una dimensione appiattita dimere strategie ingegneristiche. Avremmo in questo caso unasorta di sottile rivincita del pensiero semplice, riduttivo emutilante, sostenuto non pi dal vecchio fondamentalismoepistemologico, ma da una nuova ed articolata logica di domi-nio e manipolazione in accordo con lattuale assetto sociale edeconomico. In tal modo laNatura e complessit. L'uraganoLinda complessit diventerebbe, in un modo sottilmenteparadossale, uno strumento di parcellizzazione del mondo edun epigono post-moderno del riduzionismo.
Il punto essenziale che la complessit non l, ma qualcosa in cui siamo dentro e ci riporta a quella radice ori-ginaria del processo di conoscenza che il dialogo tra los-servatore ed i sistemi che esso definisce nella sua esplorazionedel mondo. Questo pone naturalmente la questione tra eticae conoscenza come nucleo centrale di una nuova epistemolo-gia della complessit. Se nelle impostazioni tradizionali infat-ti lespulsione del soggetto portava inevitabilmente con s unaseparazione tra scienza, intesa come luogo dei fatti, ed etica,considerata come dibattito sui giudizi morali e di valore, lacentralit ed il ruolo attivo dellosservatore impongono diriconsiderare anche questo aspetto delle dicotomie ereditatecome deriva dei dualismi precedenti.
Laccento sul nuovo ruolo attivo dellosservatore come rile-vatore di complessit - o potremmo anche dire come comples-sit che osserva e descrive se stessa - implica la necessit diprendere in considerazione esplicita le motivazioni e le finali-t che hanno fatto da sottodominante allo sviluppo delleimprese scientifiche. La visione della scienza come gestionedinamica di modelli porta naturalmente ad includere nellat-tivit scientifica una dimensione di auto-descrizione criticache si realizza pienamente nello sviluppo di una concezione
etica della propria attivit. In altre parole, ogni attivitscientifica, lungi dallessere asettica, nasce gi con una seriedi assunzioni meta-teoriche che ne regolano non soltanto lafilosofia interna ed il rapporto con le altre teorie, ma ne gui-dano anche la vita sociale ed il destino ideologico. Questo,ancora una volta, non significa in alcun modo negare validitalle procedure scientifiche, ma riconoscere che la scelta trauna descrizione del mondo ed unaltra contiene in s elemen-ti che non riguardano soltanto la prassi scientifica, ma piut-tosto il suo background filosofico e sociale. In questo senso iltermine etica va inteso non puramente come giudizio divalore sulleventuale impatto sociale dellimpresa scientifica,ma come una forma di emergenza dal tessuto stesso del siste-ma di produzione scientifica che regola il rapporto della scien-za con le forze produttive e, non ultimo, con limmaginariocollettivo ed il consumo culturale(Cini). Letica scientificanon dunque, in unottica di complessit, semplicementeuna valutazione a posteriori dei contenuti e dei fatti dellascienza, ma pi in generale il sistema di gestione delle risorseculturali che emerge allinterno di ogni rappresentazione delmondo e che viene codificato nelle scelte teoriche operate.
In questo senso la nuova epistemologia chiamata ad unadiversa consapevolezza dellattivit scientifica e non limitarsia definire criteri di scientificit, ma, conseguentemente con lavisione artigianale del prodotto scientifico, a configurarsicome analisi critica della pluralit di stili e tendenze nellascienza. Si delinea cos un compito per lepistemologia che ladefinisce come attivit che coniuga strumenti formali e anali-si meta-teoriche per esplorare il dominio cognitivo di una teo-ria e studiare larticolazione dialogica ed il gioco di convergen-ze ed interferenze allinterno dellirriducibile complessit del-lecologia dei saperi.
Nota bibliograficaNils A. Baas & Claus Emmeche, On Emergence and Explanation, in Intellectica 2, 25, 67-83,1997Ludwig von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi,MOndadori, Milano,2004David Bloor, Knowledge and Social Imaginery, Chicago Univ. Press, 1976Massimiliano Cappuccio (a cura di), Neurofenomenologia. Le scienze della mente e la sfida dellesperienza cosciente, Bruno MondatoriEd., Milano, 2006Marcello Cini, Un paradiso perduto, Feltrinelli, Milano,1998Marcello Cini,Il supermarket di Prometeo.La scienza nellera delleconomia della conoscenza, Codice edizioni, Torino,2006F. Conway & J. Siegelman,Leroe oscuro dellet dellinformazione. Alla ricerca di Norbert Wiener, il padre della cibernetica,Codice Ed.,Torino, 2005Renan S. Freitas, Mauro Maldonato, Ricardo Pietrobon, Ricerca sulla ricerca. Verso una fondazione teoretica, in Dedalus, 1,56-62, 2006Steven Heims, I cibernetici. Un gruppo e unidea, Ed. Riuniti, Roma,1997Ignazio Licata, Physics and Logical Openness in Cognitive Models, e.print in http://arxiv.org/abs/nlin/0703066 Ignazio Licata, Comunicazione, Emergenza, Apertura Logica, in Giornale Storico del Centro Studi di Psicologia e Letteratura, 4,41-73,2007Humberto Maturana & Francisco Varela, Lalbero della conoscenza, Garzanti ,Milano, 1987Gianfranco Minati, Maria P. Penna, Eliano Pessa, Thermodynamic and Logical Openness in General Systems, in Syst. Res. And Beh.Sci.,15,3, 131-145, 1998Francesco Poli, Il sistema dellarte contemporanea. Produzione artistica, mercato, musei, Laterza, Bari,2006Mark C. Taylor, Il momento della complessit. Lemergere di una cultura a rete, Codice Ed., Torino,2005F. Varela, E. Thompson, E. Rosch, La via di mezzo della conoscenza, Feltrinelli edizioni , Milano, 1992
Ignazio Licata un fisico teorico ed epistemologo. Ha studiato con D. Bohm, J. P. Vigier, A. Salam e G. Arcidiacono. I suoiinteressi principali sono i fondamenti della meccanica quantistica, la teoria dei campi, la struttura dello spazio-tempo sullascala di Planck, gli approcci gruppali in cosmologia quantistica, la teoria dei sistemi e lepistemologia costruttivista, il ruolodella computazione nei sistemi fisici e biologici. Ha scritto il libro Osservando la Sfinge. La realt Virtuale della FisicaQuantistica, (1a ed. 1992, 2a editione 2003, Di Renzo Editore, Roma), ed ha curato le antologie Informazione & Complessit(Andromeda, Bologna,1998), Majorana Legacy in Contemporary Physics (EJTP/Di Renzo, 2006); Physics of Emergence andOrganization (EJTP/World Scientific, in press). Membro di numerose istituzioni scientifiche, come la NY Academy ofSciences, lInternational Society of Systems Sciences (ISSS), lAssociazione Italiana Ricerche Sistemiche (AIRS). editordelle riviste Electronic Journal of Theoretical Physics (EJTP) e Quantum BioSystems. In 1998 ha fondato lIxtuCyber forComplex Systems il cui progetto confluito nelle recente costituzione dellISEM, Institute For Scientific Methodology, unprogetto sostenuto dal CNR e dallUniversit di Palermo con la partecipazione della Confindustria, dedicato allo studiodella complessit ed allanalisi dei processi di produzione e comunicazione della conoscenza scientifica.
-
I G N A Z I O L I C A T A
69 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
Sorge nellaffascinante scenario di Villa dei Principi a BagherialInstitute for Scientific Methodology, il nuovo centro inter-disciplina-re siciliano dedicato allo studio della complessit e dellemergenza.Ne parliamo con il direttore scientifico, il fisico teorico IgnazioLicata, che ci racconta origine e vocazione del progetto.
[Dedalus] Ci racconti come questo progetto legato al tuo per-corso di ricerca? In particolare vorrei sapere che collegamento c conunarea di cui ti sei occupato a lungo come i fondamenti della fisi-ca quantistica.
[Ignazio Licata] Sono un fisico teorico e dunque, come midicono scherzando alcuni amici non-fisici, sono afflitto daltipico imperialismo dei fisici, che sarebbe poi il voler invade-re i campi altrui! In realt, anche al di l delle fortissime ten-sioni inter-disciplinari che caratterizzano la scienza oggi, la fisi-ca teorica ha mostrato sempre vitalit proprio quando si occu-pata di problemi che sorgono sul confine frattale di due ottichedisciplinari. Tutta la storia delle teorie unificate pu essere vistain questo modo, ma ci sono anche altri esempi. Qui mi limitoa ricordare lincontro tra le reti neurali ed i vetri di spin nellor-mai classico lavoro di Hopfield dell1982. Posso anche fareappello ad un dato: il maggior numero di articoli sulle riviste difisica oggi non riguardano pi le particelle e la cosmologia, mail cervello e le proteine. Venendo al mio percorso, il lavoro sullateoria di Bohm ha avuto durature conseguenze epistemologi-che. E un caso esemplare per comprendere a fondo come unateoria pu essere non soltanto letta ma anche sviluppata edusata in direzioni diverse a seconda dellinterpretazione adotta-ta, e questo in senso anche molto concreto che si riflette diret-tamente nellambito sperimentale, ad esempio il quantum com-puting. In altre parole, la comprensione profonda di ci cheavviene sul territorio della scienza implica ladozione di unapluralit di mappe meta-teoriche e dunque di unautenticasensibilit epistemologica.
Infatti mi sono sempre chiesto qual , al di l delle dichiarazioniufficiali, il reale impatto del dibattito epistemologico sullattivitdegli scienziati.
Se concepiamo lepistemologia in modo tradizionale, comeun insieme di prescrizioni, bisogna ammettere che lo scienziatoin genere non ritiene che questi temi abbiano a che fare reali-sticamente con il suo lavoro. Parliamo di quella che potremmodefinire epistemologia top-down. Se partiamo invece da unavisione dellepistemologia bottom-up, come la consapevolezza cri-tica della propria cassetta degli attrezzi, per usare unespressio-ne di Feynman, allora lepistemologia sempre stata un ele-mento fondante e centrale del lavoro scientifico. Ogni proble-ma infatti richiede un approccio globale che raramente puridursi a considerazioni meramente formali o di laboratorio. Lascelta di un pezzo di mondo sul quale indagare, ed il tipo dirisposte che vogliamo ottenere, tutto ci gi carico di episte-mologia. Di pi, una teoria spesso nasce gi con una vocazioneculturale e sociale connessa al tipo di immagine del mondo chepropone. In questo senso pi profondo, ogni attivit scientifi-
ca, ed ogni gruppo di ricerca, in un senso piuttosto politi-co- un insieme, pi o meno dichiarato, di scelte epistemiche.Ogni teoria scientifica ha un dominio cognitivo.
E veniamo al collegamento tra il progetto dellISEM e la culturasistemico-cibernetica e lepistemologia costruttivista
Lidea essenziale del costruttivismo e dellapproccio sistemi-co-cibernetico che ogni epistemologia, per quanto possaanche presentarsi con ambizioni ontologiche forti, di tipobottom-up. E centrata dunque sulla nostra attivit di osserva-tori e costruttori di modelli spinti da un gioco complesso discelte e finalit che rimandano da un lato alla bio-logica dellacognizione, dallaltro al nostro essere sociale. Oggi i terminiteoria dei sistemi e cibernetica sono piuttosto screditatiper due motivi opposti: un uso improprio ed eccessivamentegenerico dellapproccio ed una serie storica di contrazionidi sapore ingegneristico che ne hanno diminuito la portataculturale. Fortunatamente il dibattito ha ripreso vita con illavoro di Maturana e Varela sulla teoria dellautopoiesi, che un esempio brillante di ci che dicevamo prima: una posizio-ne epistemologica che genera al suo interno una teoria com-pleta dei rapporti tra vita e cognizione. E interessante notareil ruolo culturale delle etichette. Marvin Minsky ha dichiara-to spesso che avrebbe di gran lunga preferito scienze cogniti-ve a intelligenza artificiale, ma nel primo caso non sarebberiuscito probabilmente a mobilitare le risorse (e le aspettati-ve!) necessarie. Maturana una volta mi confid che uno deisuoi problemi allinizio, da cibernetico, era quello di evitare iltermine cibernetica! Sicuramente nella filosofia del nuovoistituto confluita la mia frequentazione con queste idee e lalunga collaborazione con il Santa F Institute, La LondonSchool of Economics ed in particolare gli amici sistemici,come Gianfranco Minati, presidente dellAIRS (Associazioneitaliana ricerche sistemiche).
Qual il vostro approccio alla complessit?
Oggi c il rischio che la complessit, paradossalmente,diventi un termine-totem onnicomprensivo, una forma dineo-riduzionismo e dunque uno slogan vuoto. Il problemacentrale che la complessit la dimensione originaria delrapporto osservatore-sistema, ed in un senso molto pi radi-cale di quanto non sia inteso in fisica quantistica, dove losser-vatore gi altamente formalizzato, o nelle dinamiche non-lineari, dove troviamo complessit computazionale.Prima diuna scelta osservazionale non c sistema. Dopo una sceltaabbiamo definito un confine arbitrario tra il sistema ed ilmondo. Questo significa che abbiamo di fatto operato unariduzione di complessit per trarre linformazione su cuicostruiremo il nostro modello. E possibile dare una versioneformale piuttosto sofisticata di questo processo che conflui-ta nella teoria dellapertura logica, sviluppata riflettendo suilimiti dellintelligenza artificiale e di certi modelli bio-mate-matici. In sintesi, ogni modello pu essere inquadrato in unagerarchia di complessit sulla base delle scelte operate dal-losservatore nella costruzione del modello, e caratterizzatocon un opportuno indice di apertura logica. Ad esempio imodelli tradizionali dellIA hanno un basso grado di apertu-
La complessit in gioco
L'ISEM E LEPISTEMOLOGIA SISTEMICA
Intervista a
IGNAZIO LICATA
-
70 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
L E E M E R G E N Z E D E L L A C O M P L E S S I T
ra logica ed infatti funzionano allinterno di domini semanti-ci molto ristretti, come gli scacchi. Altri modelli basati sugliagenti autonomi o sulle reti neurali sono pi articolati edhanno una maggiore plausibilit biologica. Non si tratta diteorie rivali, ma di scelte diverse, e spesso complementari,sulla scelta operata sul grado di apertura logica del sistemache si vuole descrivere. Un risultato interessante che pi alto il grado di apertura logica, cio pi ambiziosa la teorianel voler descrivere le inter-relazioni tra il sistema e lambien-te, meno possibile comprimerla in un singolo modello for-male. Losservatore cos incluso nella teoria con il ruolo cen-trale di gestore dinamico di modelli. La complessit un prez-zo da pagare per ogni scelta descrittiva, ed il grado di apertu-ra logica, in un certo senso, misura questo prezzo.
Questo suona molto simile ai risultati di Goedel-Turing. Che rap-porto c con la questione della computazione?
Infatti la teoria dellapertura logica pu essere consideratail corrispettivo dei teoremi limitativi di Godel-Turing appli-cata ai modelli formali dei sistemi. In generale il rapporto traapertura logica e computazione pu essere sintetizzato dicen-do che pi un sistema ha bassa apertura logica pi compri-mibile in un modello algoritmico. In un sistema ad altissimaapertura logica come la mente umana, invece, bisogna ricor-rere ad una pluralit di approcci diversi, ed ogni tentativoalgoritmico, per quanto utile e suggestivo, deve essere conside-rato come una sezione limitata di un singolo aspetto dellacomplessit originaria del sistema. La cosa importante chetutto ci legato ai processi di emergenza intrinseca. Per usareun termine caro a Maturana e Varela, nel corso del suo accop-piamento strutturale con lambiente, in un sistema ad altaapertura logica si ha un processo continuo di assestamenti dilivelli gerarchici, transizioni da un parametro ordinatore adun altro, modifiche del dominio informazionale e delle suesoglie critiche. Questo porta allemergenza di nuovi codici edunque ai limiti della teoria della computazione tradizionalenei sistemi cognitivi e biologici, che infatti non rientranonella giurisdizione della diagonalizzazione di Cantor e neilimiti dellhalting problem. Per questi sistemi si sta sviluppan-do una nuova teoria, ancora in fase embrionale, che la teo-ria della computazione bio-morfa. Non possiamo costruireuna teoria del tutto dei sistemi complessi perch un sistemaad altissima apertura logica mostra aspetti di emergenzaintrinseca che non possono essere catturati da un unicomodello teorico. Se pensi alla visione di Gregory Chaitindella matematica come sistema aperto, ecco che il legame coni teoremi di Godel-Turing diventa evidente.
Come nasce ISEM e che obiettivi si propone?
Come tutte le emergenze, nasce in modo imprevedibile ecasuale, ma dallincontro di percorsi ben radicati. Con il chi-mico Mario Magliaro, un esperto di nuovi materiali e nanotec-nologie, abbiamo scoperto di avere in comune una passioneper le transizioni di fase, Feyerabend e per il famoso libro diRobert Pirsig, Lo Zen e larte della manutenzione della motociclet-ta. E naturalmente una certa dose di incoscienza. Da qui lideadi un centro dove studiosi di provenienze diverse potesserofare il punto sui processi di crossing disciplinare che caratteriz-zano gli aspetti pi vitali della ricerca contemporanea. Vorreisottolineare che un conto parlare di inter e trans disciplina-riet, un conto praticarla davvero. Ogni studioso ha nella suaformazione un nucleo forte e spesso non esplicito, di posizio-ni, convinzioni, approcci metodologici. Rimetterli in discus-sione in un circolo che si vorrebbe virtuoso non facile!Naturalmente questo possibile soltanto se il Centro mantie-
ne un rapporto vivo con la ricerca di base ed applicata, altri-menti si rischia di lavorare su materiale archeologico. La par-ticolare natura del consorzio su cui ISEM centrato- CNR,Universit di Palermo e Confindustria- ci permette di tenerealto il livello di attenzione sia sul fronte della ricerca che suquello della formazione. In particolare il ruolo dellaConfindustria un indicatore attivo di una delle nostre preoc-cupazioni, ossia il dialogo tra i ricercatori ed i policy makers.Una volta, durante la polemica che Sciascia ebbe con Amaldie Segre a ridosso delluscita del pamphlet sulla scomparsa diMajorana, il grande illuminista di Racalmuto scrisse- credo suLa Stampa del 24 dicembre 1975- che viviamo come cani per colpadella scienza. Una frase forte ma che contiene un quantum veri-tatis: si vive come cani se la scienza la si subisce. Bisogna cono-scerla per prendere decisioni difficili in un mondo complesso.Decodificare posizioni, stili e miti della ricerca, denunciare gliatteggiamenti auto-referenziali. Questo presuppone un rappor-to diverso e pi articolato tra scienza, societ e politica allin-terno di una nuova ecologia dei saperi.
Mi hai raccontato la storia di una e scomparsa
Allinizio il nome dellistituto era Institute for ScientificEthics and Methodology. Poi, per qualche oscura ragioneburocratica, il comitato del CNR che pianifica i nuovi istitutiha cancellato Ethics, che rimasta per nellacronimo esoprattutto nello spirito del nuovo istituto. Il termine pernoi strettamente connesso al ruolo centrale dellosservatore ecostruttore di modelli ed alla necessit di prendere in consi-derazione le ragioni meta-teoriche che lo guidano nella suaattivit, i contesti della scienza. Pi concretamente c il biso-gno di sviluppare modelli dimpatto dellattivit scientificasulla societ, tenendo in conto anche i parametri culturali edeconomici dentro cui la scienza si fa effettivamente.Intendiamo letica dunque come lo studio dei comporta-menti emergenti che regolano il rapporto tra i sistemi dellaricerca ed il pi vasto ambiente in cui sono immersi e dalquale traggono, in ogni senso, nutrimento. Tutto ci con-nesso anche ai temi della complessit aziendale e dei modellieconomici. Questo un campo in cui si possono dire e farecose effimere- come la dichiarazione di qualche anno fa diChris Langton di poter predire landamento dei mercati!-oppure che va dritto al cuore di uno dei problemi vitali delrapporto scienza-societ, ossia la gestione delle risorse neisistemi complessi, lo sviluppo sostenibile, ed il ciclo di vitadella conoscenza. Questultimo un argomento di cui mi stooccupando da qualche anno utilizzando la teoria delle reticomplesse. Ormai non si tratta pi di discutere astrattamentedellimpatto della scienza sul nostro modo di vivere, ma divalutare attraverso quali processi diffusivi e quali modalitsarebbe desiderabile che i risultati dellattivit scientifica con-fluiscano nella vita della gente.
Ritieni che i modelli attuali di comunicazione della scienza sianoefficaci?
Assolutamente no. Sin dallinizio abbiamo pensato diconiugare lanalisi dei processi di produzione della scienza conuna riflessione sulle forme di comunicazione. Il modello reto-rico della divulgazione ampiamente insufficiente e con lui ipi recenti meccanismi di spettacolarizzazione con cui la scien-za entrata nel circuito del consumo culturale. Non soltantoinfatti questa informazione generica ed imprecisa- pensiamoad esempio ai modi di presentare la fisica quantistica, fermi algatto di Schrodinger e ai suoi paradossi-, ma pi spesso anche volutamente parziale. Oggi certa comunicazione ha lafunzione pervasiva di un moderno ipse dixit. In genere funzio-
-
I G N A Z I O L I C A T A
71 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
na cos: un guru riconosciuto scrive un libro o partecipa ad unFestival ed indica una teoria come buona, giusta e vincente.Fornisce al pubblico una descrizione immaginifica del nuovoscenario- per comprenderlo realmente sarebbe necessario inve-ce spiegare da quali problemi sorto, e quali teorie concorren-ti o alternative esistono-, ed in questo modo si raggiungonodue obiettivi: la conquista del consenso ed il messaggio traver-sale al resto della comunit, del tipo o ti adegui o sei fuori.Consideriamo ad esempio un libro come lUniverso elegante diBrian Greene. E un libro di grande suggestione che rifletteleleganza matematica della teoria, ma soltanto nellultimocapitolo, e di sfuggita, si accenna ai grossi problemi irrisoltidella teoria. Un testo sicuramente meno famoso quello diPeter Woit, Neanche sbagliata, in corso di pubblicazione pressoCodice. Woit, da serissimo teorico della teoria quantistica deicampi qual , smonta criticamente molte ambizioni degli strin-ghisti. Personalmente trovo il libro di Woit pi utile di quellodi Greene, ma il maggior successo di questultimo porta inevi-tabilmente la gente a farsi lidea di Woit come una sorta dieretico. E questo influenza anche le scelte dei giovani studio-si. In tal modo si innescano meccanismi auto-referenziali nelletendenze della ricerca. Un altro caso esemplare sono le primedichiarazioni iperboliche sulla decodifica del genoma. Delresto la logica dei Festival e della divulgazione spettacolare pro-duce forse risultati in termini di pubblico, ma se analizziamole statistiche non mi sembra che il numero di studenti dellefacolt scientifiche sia influenzato da queste iniziative, anzisiamo in una fase decisamente regressiva. Bisogna puntare suiproblemi, ed educare i giovani a riconoscerli, approfondirli,insegnare loro a smontare le teorie. Diceva saggiamenteBohr che i grandi problemi restano, le risposte- soprattutto sedoccasione e di tendenza- passano.
Qual il rapporto di ISEM con il territorio?
Sappiamo di aver accettato una sfida difficile, sotto moltipunti di vista. A Catania la collaborazione tra universit e priva-ti ha permesso lo sviluppo di quella che ormai chiamata EtnaValley. Palermo ancora un potenziale largamente inespresso,che riposa su una grande eredit storica. Non dimentichiamo lastagione culturale del Circolo Matematico di Palermo, i cuiRendiconti furono tra fine 800 ed inizi 900 una delle principa-li pubblicazioni matematiche del mondo. O in tempi pi recen-ti la formidabile sequenza di nomi che hanno insegnato e lavo-rato a Palermo, da Emilio Segre a Lucio Lombardo Radice.Figure come il geochimico Marcello Carapezza, cui intitolatauna serie di seminari allISEM organizzati da Mario Pagliaro, edil biologo Alberto Monroy hanno creato a Palermo brillantiscuole scientifiche e posto le basi per un dialogo culturale trastudiosi di formazioni diverse. Il nostro obiettivo anche quel-lo di riprendere e continuare questa tradizione e creare nuoveoccasioni di collaborazione tra universit, CNR e industria.Inoltre, consapevoli di vivere in un territorio difficile, siamoconvinti che una proposta culturale forte possa costituire uncontributo contro le derive di legalit che minacciano la ricercacome ogni altro ambito della societ civile, questione di cui ingenere si parla poco. Abbiamo in programma alcune iniziativein questa direzione. E stata dunque una grande gioia per noivedere quanti amici e colleghi hanno risposto allappello per lacostituzione dellAdvisory Board: David Avnir, Marcello Cini,Liane Gabora, Jean Marc Levy Leblond, Gianfranco Minati,Gloria Origgi, Eliano Pessa, Nicla Vassallo.
Quali iniziative sono gi in programma?
Il Master Paul K. Feyerabend ha gi ricevuto numero ade-sioni e partir ad ottobre. Stiamo organizzando dei seminari
con il cattivo maestro Marcello Cini e con Nicla Vassallo.Per i convegni Focus abbiamo previsto due appuntamentiimportanti, uno dedicato alla struttura dello spazio-temposulla scala di Planck ed un altro sulle nanotecnologie. Unappuntamento importante poi la cerimonia annuale per ilMajorana Prize, organizzata in collaborazione con lElectronicJournal of Theoretical Physics di cui sono co-editor. E come sai,uno dei progetti che pi mi sta a cuore un incontro sullaNeurofenomenologia con voi di Dedalus.
Lidea di intitolare il Master a Feyerabend ha un intento polemico?
Chi ha letto con attenzione i lavori di Paul Feyerabend,ed ha anche avuto il piacere di conoscerlo personalmente,sa bene che il suo anarchismo metodologico stato sem-pre assai pi rigoroso dellimmagine che solitamente se neoffre. Negli ultimi anni stava preparando un libro doveavrebbe corretto certe interpretazioni del suo lavoro, mapurtroppo la morte ha impedito che questo progetto, a cuilui teneva molto, potesse vedere la luce. Bisogna ricordareche le sue provocazioni si inserivano in un contesto, quel-lo anglo-americano, dove la cultura scientifica pi radica-ta e solida che da noi, e dunque molto pi in grado di assi-milarne le suggestioni senza rischiare reazioni visceralmen-te anti-scientifiche. Il famoso anything goes non mai stato,come a volte si dice, unequivalenza tra scienza e non-scien-za, ma il bisogno di distinguere tra le vicende intricate dellimpresa scientifica e la loro rappresentazione razionalecostruita a posteriori. Inoltre Feyerabend stato uno deiprimi, con la sua scrittura paradossale e provocatoria, aporre efficacemente il problema del decision making nellesociet tecnologicamente avanzate in cui si ripropone con-tinuamente una situazione di squilibrio tra il sistema dellascienza ed i meccanismi decisionali della democrazia.
Che mi dici del logo dellISEM, Twistors?
E un lavoro di Teresa Iaria che ho visto questanno adArtissima a Torino e lho subito adottato. Oggi si fa ungran parlare del rapporto tra scienza ed arte, in genere inmodo piuttosto banale. Nella maggior parte dei casi unmatrimonio forzato che nasce allinterno del carrozzonedella scienza- spettacolo di cui abbiamo discusso. Larteispirata alla scienza non dovrebbe essere una mera rap-presentazione dei concetti scientifici- pensiamo ad esem-pio ai famigerati frattali colorati!-, proprio come la scien-za non in alcun modo una fotografia della realt. Ilvero punto di contatto tra scienza ed arte che sonoespressioni profonde della nostra attivit cognitiva, delbisogno di dare una forma allesperienza. Si tratta diapprocci diversi che devono rivendicare la loro autono-mia e non appiattirsi in una simbiosi didascalica. Perusare unefficace espressione dellartista guardarsi dasponde opposte. In Twistors la risonanza gioiosa traun concetto della fisica teorica pi ardua ed una trot-tola infantile rende benissimo lidea dei creatori dimondi e fissa in modo inequivocabile lo spirito e lavocazione del nuovo istituto.
Una tua immagine finale sulle necessit della ricerca scien-tifica.
Meno dichiarazioni faustiane e titaniche e pi artigianato.E necessario, per citare la bellissima lezione inaugurale diJean Marc Levy Leblond, Re-mettre la Scienze en Culture, contutte le sfumature irriducibili ed incomputabili dellespres-sione. Meno Achab e pi Ismaele.
-
72 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
L E E M E R G E N Z E D E L L A C O M P L E S S I T
LIsem (Institute for scientific methodology) nasce comeluogo di riflessione critica e di formazione sui processi di pro-duzione e comunicazione della scienza contemporanea. Il suoobiettivo quello di sviluppare una visione sistemica meta-disciplinare che favorisca laffrancamento da una concezionerigida, lineare e piramidale del processo di produzione scien-tifica, che recuperi e valorizzi pienamente il ruolo del ricerca-tore come costruttore e gestore dinamico di modelli negli sce-nari post-industriali delle relazioni tra scienza, tecnologia esociet. In questo modo la questione metodologica si collegadirettamente al ruolo culturale e sociale dellimpresa scienti-fica ed alla necessit di una valutazione globale del valore edellimpatto della produzione di conoscenza scientifica. Lanuova necessit della formazione e di un feedback costante conle realt politiche e sociali che alimentano la scienza portanaturalmente ad un bisognonuovo di comunicazione scienti-fica, ispirato non pi al modelloretorico della divulgazione, maalla necessit di uninformazionecritica e pertinente sui granditemi della ricerca e sul loroimpatto sociale a medio e lungotermine.
Formazione - Master Paul K.Feyerabend
LIstituto condurr il Masterannuale di alta formazione sullametodologia della ricerca scienti-fica Paul K. Feyerabend rivoltoa corsisti selezionati a livellointernazionale fra laureati ericercatori di tutte le disciplinescientifiche. I corsi si svolgeran-no nei pressi di Palermo, a Bagheria, nella splendida sede diVilla Cattolica, gi sede permanente del Museo Guttuso. IlMaster inizia a gennaio e dura fino a giugno. Le lezioni saran-no condotte interamente in lingua inglese da docenti scelti fraalcuni dei migliori ricercatori internazionali. I temi chiave delMaster saranno lepistemologia, i processi di produzione ecomunicazione della conoscenza ed il quality managementnella ricerca scientifica.
Majorana PrizeLIsem, in collaborazione con lElectronic Journal of
Theoretical Physics, sar sede della cerimonia per lassegnazionedella Majorana Medal per la categoria Best Person in Physics.
Convegni FocuslIsem curer la promozione di corsi e convegni focus sui
temi caldi della ricerca scientifica, da quelli pi specificata-mente teorici che coinvolgono temi di vasto impatto cultu-rale (come le teorie unificate, la genomica e le teorie dellamente) a quelli di interesse pi direttamente tecnologico-produttivo, con particolare riguardo ad aree inter-disciplina-
ri (nuovi materiali, bio- informatica, nano tecnologie,quan-tum computing, information tecnology).
RicercaAccanto alle attivit formative, lIstituto operer attivit di
ricerca di frontiera in chimica e in fisica teorica. In chimica,nel segno della versatilit con cui il Laboratorio diretto daMario Pagliaro al Cnr di Palermo si distinto negli ultimicinque anni fra i principali gruppi di ricerca internazionalicon decine di lavori scientifici riguardanti i pi svariaticampi (dalla catalisi alla sensoristica; dalla scienza dei mate-riali alle sostanze rinnovabili; dalla fotochimica alla sintesi)condotti in collaborazione con ricercatori di 11 Paesi. In fisi-ca teorica, modelli matematici in biologia teorica ed episte-mologia cognitiva con la guida di Ignazio Licata, full profes-
sor di fisica teorica negli StatiUniti, Palm Harbor, recente-mente ritornato in Sicilia.Anche qui le aree privilegiatesaranno quelle con forti caratte-ristiche interdisciplinari: bio equantum computing, nanotec-nologie, sistemi simbolici e sub-simbolici per la rappresentazio-ne della conoscenza, quantumsystemics.
Contatti:[email protected]@ejtp.info
I ricercatori dellISEM: MarioPagliaro
Mario Pagliaro holds a Ph.D.in chemistry from Palermos
University (1998) with a thesis on the Selective oxidations ofcarbohydrates carried out with his two mentors: David Avnirin Jerusalem and Arjan de Nooy in Holland. In 1993 hegraduated cum laude in chemistry studying one of the firstapplication of fractal geometry to chemistry (Structural char-acterization of palladium catalysts supported on silica). He hasstudied and worked in Israel, Netherlands, France andGermany and currently collaborates with Rosaria Ciriminnaand researchers of eight Countries doing research on newfunctional materials of scientific and industrial interest. In2005 he was appointed Matre de confrences associ atthe Frances ENSCM and was invited speaker at the XV edi-tion of the International Symposium on Fine Chemistryand Functional Polymers in Shangai (Cina). Between 1993and 1994 he worked in Holland (first at Leidens RijksUniversiteit and then at the TNO Food Research Institutein Zeist). In 1998 he was at Grenobles Cnrs with Dr. MichelVignon, and in 2001 he joined Carsten Bolm at AachensPolytechnic. In 2004 and in 2005 he has worked with JolMoreau and Michel Wong at Montpelliers Ecole NationaleSuperieure de Chimie.
ISEMInstitute for Scientific Methodology
-
I S E M
73 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
ISEMMaster "Paul K. Feyerabend"
Master & Corsi
- Verso unEpistemologia della Complessit Un quadro prospettico delle evoluzioni dellepistemologia, da discor-
so normativo esterno sulla pratica scientica a disciplina, pas-
sando per la critica politica della scienza.A sinistra e a destra di
Popper.
- Informazione, Complessit e SistemiIl problema del riduzionismo mono-disciplinare.Dagli Insiemi ai
Sistemi: Una Scienza che parla di Scienza, Wiener e Co.- il proble-
ma della falsificabilit degli approcci metodologici
- Modelli di produzione di conoscenzaCrossing:Mono, multi, inter, trans disciplinare. Il ruolo dellosser-
vatore nella scienza.
- Apertura SistemicaModelli sistemici basati su apertura termodinamica e logica. Teorie
e Modelli Isomorfi. Gerarchie modellistiche
- Utilizzo Dinamico dei Modelli (DYSAM)Il problema della scelta modellistica tra teoria e fenomenolo-
gia. Produzione di conoscenza, oggettivismo, costruttivismo.Le
Mappe Fuzzy.
- Modelli computazionali ed Emergenza IntrinsecaLa conoscenza come novit irriducibile- Simulazione e mondi gio-
cattolo- Il ruolo dellosservatore come rilevatore demergenza.
Emergenza e Fenomeni Collettivi.
- Sistemi di produzione della conoscenza ed eticaValori, Valutazioni e Bilancio Etico come fattore di crescita e svi-
luppo. La conoscenza nella societ post- industriale.
- Intelligenza CollettivaLa scienza al tempo di internet, nuovi processi di produzione e
comunicazione della scienza. Le riviste on-line. Il Caso di ArXiv.
- Il Laboratorio ed il problema della condivisione delle com-petenzeDa Gottinga a Los Alamos- La Big- Science- Il ruolo storico
dellUniversit- Il Modello del CNR- LEsperienza di Santa F.
Strumenti teorici per unepistemologia sistemica
- Linguaggi Formali, Automi e Modelli- Teoria classica della computazione- Teoria dei sistemi dinamici- Formalismi Quantistici, Sistemi Complessi e Fuzziness- La Scienza Classica: oggettivismo, riduzionismo e causalit- Principi Generali della Sistemica- La nozione classica di Emergenza e loggettivismo causale- Emergenza ed Auto-Organizzazione: Automi Cellulari, ArtificialLife, AlChemy (Artificial Chemistry),Algoritmi Genetici, IA Forte,
Sistemi Dissipativi, Sinergetica, Connessionismo e Reti Neurali
- Una Teoria Generale dei Sistemi Osservanti: Emergenza e dina-mica delle Distinzioni,HyperSTructure, Apertura Logica,
Quantum Systemics
- Processi Cognitivi e Psicologia Connessionistica- Ingegnerie della Conoscenza.
26 Marzo 2002. Inaugurazione dell'ISEM con Armando Massarenti e Jean Marc Levy Leblond
-
74 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
L E E M E R G E N Z E D E L L A C O M P L E S S I T
Professore emerito, Universit di Roma La Sapienza
MARCELLO CINI
La scienza e i suoi valoriVerit, etica, ricerca
1. Conoscenza scientifica e veritNonostante gli anni trascorsi dal famoso Convegno di
Londra del 1965 di filosofia della scienza nel quale si confron-tarono sulla natura della verit scientifica i pi famosi protago-nisti del dibattito epistemologico del Novecento - ThomasKuhn e Paul Feyerabend, Karl Popper e Imre Lakatos la que-stione oggi sempre pi aperta. Dopo avere, infatti, instaura-to, nel secolo appena finito, il suo dominio sulla materia iner-te, luomo si avviato, nel nuovo secolo, a stabilire il pienocontrollo sulla materia vivente e sui suoi stessi fenomeni men-tali. essenziale a questo punto riconoscere che questa svoltacambia profondamente la natura stessa della scienza.
infatti venuto al pettine cla-morosamente il nodo che con-cettualmente fin da allora con-trapponeva chi negava la possi-bilit di definire un criterio didemarcazione netto fra la scien-za e le altre verit sulla realtcircostante, e chi, vedendo nellascienza lunica forma di cono-scenza oggettiva e razionale delmondo, cercava di individuareun metodo certo e universaleper distinguerla da tutte le cre-denze soggettive e irrazionali dialtra natura.
Prima di analizzare meglio lanatura di questo nodo alla lucedella svolta epocale che stiamovivendo, vorrei tuttavia riassu-mere brevemente il mio puntodi vista sul complesso rapportofra loggettivit del mondo realenel quale viviamo e la soggettivi-t della rappresentazione che nediamo come esseri umani ingenere e come scienziati inparticolare. Ho avuto infattianchio modo - non come filosofo ma pi modestamentecome fisico interessato a capire i limiti e le potenzialit cono-scitive dellattivit di ricerca mia e dei miei colleghi di riflet-tere, scrivendone per pi di quarantanni in numerose occa-sioni e in vario formato.
Per esempio, nel 1981 scrivevo: Mi sembra dunque diffici-le negare che siamo noi, con le nostre scelte soggettive, i nostrischemi concettuali, i nostri criteri di validit e di priorit acostruire - ritagliando pezzi [di realt] che acquistano significa-to, individuando elementi che ci appaiono semplici, isolandocatene di eventi che secondo una certa ottica si mostrano cor-relati - gli oggetti della conoscenza allinterno di una realt che
si presenta a priori come un flusso fenomenico continuo eproteiforme privo di connessioni significative di per s.
Tredici anni dopo ribadivo: Se si riconosce, e mi pare chenon ci sia altra alternativa, che il metodo universale per arri-vare alla verit non esiste, il massimo di oggettivit dellaconoscenza raggiungibile assicurato soltanto dal carattereintersoggettivo del giudizio di validit [sulla proposta di inno-vazione avanzata dai singolo scienziato] pronunciato dai depo-sitari del sapere.
Cerchiamo a questo punto di approfondire meglio la que-stione Conviene distinguere, secondo me, le diverse fasi delprocesso di scoperta/creazione di verit nellambito della
scienza, facendo anche qual-che riferimento a un conte-sto pi vasto. Uso un termi-ne composto per sottolinea-re il nesso indissolubile trasoggetto e oggetto che il con-cetto di verit implica.Queste fasi sono almeno tre.
La prima quella del con-cepimento del nucleo diverit che il soggetto intui-sce. In questa fase emozionee riferimento ai dati senso-riali (i fatti) si intreccianoi n d i s s o l u b i l m e n t e .Chiunque faccia il miomestiere sa, per averlo pro-vato nel mio caso pochissi-me volte, purtroppo - chelintuizione di unidea chefunziona per far tornarecerti fatti, produce unaemozione fortissima, assen-te invece quando si tratta diuna semplice ipotesi razio-nale sul come essi potrebbe-ro essere collegati tra loro.
noto, tanto per fare un esempio, che il chimico Kekulracconta di aver intuito la struttura ad anello della molecoladi benzene avendo sognato un cerchio di ballerine che danza-vano tenendosi per mano. La danza fu per il suo inconscio ilsimbolo di un legame flessibile, regolare e stabile tra gli atomidi carbonio della molecola in questione. C forse, in questafase della formazione di una nuova idea scientifica, un nessocon la creazione artistica. Mi vengono in mente, per restare intema, i grandi quadri di Matisse in cui la danza diventa sim-bolo di grazia e di leggerezza depurate da ogni gravame mate-riale. In sostanza linvenzione di una metafora appropriata,con la sua anbiguit essenziale, gioca sempre un ruolo fonda-
Hermes e Athena, giustizia e verit
-
M A R C E L L O C I N I
75 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
mentale nella formulazione di verit individuali.La seconda fase, spesso indistinguibile dalla prima, ma con-
cettualmente molto diversa, quella del tentativo di dareallintuizione una forma capace di comunicarne agli altri lanatura della verit intuita. Nei grandi scienziati questaforma consiste nellinvenzione di un vero e proprio nuovo lin-guaggio. Per esempio, il linguaggio inventato dai padri dellameccanica quantistica, a partire da Einstein fino a Heisenberge Schrdinger, rappresenta gli oggetti del mondo atomicocome dotati, a seconda del contesto, di propriet ondulatorieo corpuscolari, che nel mondo macroscopico sarebberoincompatibili. Non tuttavia questo lunico linguaggio possi-bile, anche se quello di gran lunga pi diffuso. Wigner,tanto per fare un nome, ne ha inventato un altro che mettedirettamente in evidenza la natura intrinsecamente aleatoriadegli eventi quantistici. In modo del tutto analogo i grandipittori del primo Novecento, uno per tutti Picasso, hannoinventato un linguaggio in cui lo stesso soggetto pu essererappresentato simultaneamente di lato e di fronte: una visio-ne anche questa incompatibile con lesperienza comune.
So bene che gli scienziati non amano questo genere diparagoni, ma mi sembra necessario insistere sul fatto cheogni rappresentazione della realt sceglie necessariamentealcuni aspetti, ritenuti essenziali, di quella ontologicamenteesistente indipendentemente dalla percezione che ne possia-mo avere. La differenza dunque fra i linguaggi delle scienze equelli delle arti, non che i primi si riduconoallunica vera rappre-sentazione della realtcos com mentre isecondi sono metaforetutte pi o meno accetta-bili. Le rappresentazionidel mondo sono tutteparziali e ognuna portalmpronta ineliminabiledel soggetto che lha con-cepita e realizzata.
Esiste certamente unadifferenza fra i linguaggiinventati per comunicarele verit scientifiche equelli che esprimono leverit artistiche. Ma ladifferenza non dicoto-mica. C un continuumche ha ad un estremo larazionalit pura ed allaltro la pura emozione, allinterno delquale ogni linguaggio si colloca pi meno vicino alluno oallaltro. Chiunque abbia sperimentato, nel corso di una psica-nalisi individuale, in che modo si possa arrivare, attraverso ilmetodo freudiano delle libere associazioni, a stabilire il carat-tere di verit della interpretazione di un determinato sogno,sa bene che questa comprensione essenzialmente emotiva: inquesto caso la parte inconscia dellindividuo crea il sogno e lasua parte conscia ne coglie la verit. Comunque, capire unaverit provoca sempre una emozione. vero per una dimo-strazione matematica come per un quadro.
La terza fase della formulazione di una verit scientifica quella della sua accettazione (o del suo rifiuto) da parte dellacomunit degli esperti. Questo giudizio di validit si basa suun insieme informale di criteri metateorici che si riferiscononon soltanto alla corroborazione empirica, alla completezza,alla coerenza interna della proposta, ma anche alla sua utilitpratica, alla sua coerenza rispetto alle tradizioni culturali, alla
sua adeguatezza rispetto alle aspettative sociali nei confrontidella disciplina e cos via.
In particolare un elemento importante per la comprensio-ne da parte degli altri della verit scoperta/inventata anche la bellezza. Questo appare ovvio per lopera darte,ma vero anche per il linguaggio scientifico. Diceva PaulDirac, uno dei fondatori della formulazione universalmenteaccettata della meccanica quantistica, che un formalismomatematico bello trova sempre, prima o poi, una realt fisi-ca che gli va a pennello. Ma vero anche linverso. Non cdubbio, ad esempio che linvenzione della prospettiva, concet-to geometrico e razionale per eccellenza, caratterizza in modoassolutamente dominante la straordinaria bellezza delle operedi Paolo Uccello e di Piero della Francesca.
2. Dalla scienza della materia inerte a quelle della vita edella mente
Il passaggio dalle scienze della materia inerte a quelle dellavita e della mente deve infatti tener conto della differenza trai principi organizzativi che caratterizzano le due diverse sfere.La logica che tradizionalmente sta dietro ai grandi successidella fisica del Novecento nella interpretazione delle proprie-t della materia inerte riduzionista: dalla conoscenza deicomponenti elementari e delle loro interazioni si risale allepropriet del sistema. Da questo deriva anche che queste pro-priet sono indipendenti dal contesto.
stato tuttavia unNobel della fisica, PhilipAnderson, a mettere indiscussione, nel 1972, inun intervento ormai sto-rico molto controverso, ildogma del riduzionismo.Lipotesi riduzionista scrive non ne implicaaffatto una costruzioni-sta: labilit di ridurretutto a leggi semplici fon-damentali non implica lacapacit di partire daquelle leggi per ricostrui-re luniverso. Infatti,quanto pi i fisici delleparticelle elementari cidicono sulla natura delleleggi fondamentali, tantomeno sembra siano ingrado di farlo per i veri
problemi degli altri settori della scienza, e ancor meno suquelli della societ. Lipotesi costruzionista crolla quando siconfronta con le difficolt gemelle della scala e della comples-sit. Ne segue che il comportamento di un aggregato vastoe complesso di entit elementari, non pu essere compresoin termini di semplice estrapolazione delle propriet di pocheparticelle. Perci, anche se possono esserci suggestive indica-zioni sul modo di mettere in relazione un livello con laltro, praticamente impossibile dedurre la complessit e la novitche emergono in questo passaggio.
In contrasto con la chiara presa di posizione di Anderson,viene tuttavia ancora attribuita nella comunit dei fisici unaimportanza primaria alla ricerca della Legge Fondamentale (lacosiddetta Teoria del Tutto) che regolerebbe luniverso intero.Personalmente ritengo che cos facendo, la fisica abbia imboc-cato una strada sterile. Per fortuna sono in buona compagnia.In un libro appena uscito in edizione italiana, intitolato UnUniverso diverso, il Nobel per la fisica Robert Laughlin, dopo
Marcello Cini
-
76 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
L E E M E R G E N Z E D E L L A C O M P L E S S I T
aver definito ccome definitivamente infalsificabili, e quindiassimilabili ai miti greci della creazione del mondo, le teo-rie cosmologiche che parlano dei primi istanti infinitesimidella vita delluniverso dopo il Big Bang, estende il suo giudi-zio critico alla teoria delle stringhe, che della Teoria del Tuttodovrebbe essere la base.
Si tratta della teoria di un tipo immaginario di materia,costituita da oggetti allungati che esistono in uno spazio amolte dimensioni (alcuni dicono dieci, altri addirittura ven-totto), della cui esistenza non esiste n potr mai esistere alcu-na prova sperimentale. La teoria scrive - non ha alcuna uti-lit pratica, se non quella di sostenere il mito della teoria ulti-ma. Per giunta, la speciale matematica, peraltro bella ed ele-gante, che la contraddistingue, non permette di calcolare oprevedere pi facilmente alcun comportamento sperimentaleconosciuto. La teoria delle stringhe conclude un belsistema concettuale che rimarr allinfinito fuori della nostraportata sperimrentale.
La logica invece che occorre adottare per spiegare le proprie-t di un organismo vivente radicalmente diversa. Essa sifonda su due principi: la dipendenza dal contesto e la dipen-denza dalla storia passata. La prima permette allorganismo didare risposte differenti allo stesso stimolo a seconda delle cir-costanze nelle quali si trova ad agire: un comportamento cheun pezzo di materia inerte non in grado di avere. La secon-da implica che le pro-priet di un organismonon sono riducibili allasua struttura (spiegazio-ne sincronica) ma sonoanche frutto di unalunga successione tem-porale (spiegazione dia-cronica) di due momen-ti indipendenti e com-plementari ma intrec-ciati che agiscono sul-linsieme degli organi-smi simili vissuti in pas-sato al quale esso appar-tiene: quello della gene-razione aleatoria delladiversit tra loro e quel-lo della selezione diquelli pi compatibilicon i vincoli esterni einterni allinsieme aiquali sono sottoposti.
In sostanza si passada una scienza galileiana, tesa a individuare la legge comu-ne che regola fenomeni che appaiono differenti a causa di fat-tori secondari e contingenti (diffalcando gli impedimentidiceva Galileo) a una scienza darwiniana (Non ci sono, peri fenomeni biologici, altre spiegazioni possibili che quelle evo-lutive, affermava gi una trentina di anni fa il pioniere dellabiofisica Mario Ageno) che cerca di spiegare come possa avve-nire che piccole differenze esterne possano indurre organismiidentici a imboccare percorsi spaziali o temporali radicalmen-te differenti.
3. Barriere che cadonoIl mutamento epistemologico e metodologico legato allo
spostamento del baricentro dello sviluppo della scienza dallasfera della materia inerte a quella della materia vivente anche alla base dello sgretolamento dei due steccati che tradi-zionalmente separavano la scienza dalle altre attivit sociali
umane: uno separava la scienza (in quanto conoscenza disin-teressata della natura ottenuta attraverso la scoperta) dalla tec-nologia (in quanto utilizzazione pratica dei risultati dellaprima realizzata attraverso linvenzione), e laltro separava leattivit che si occupano di fatti da quelle che si occupano deivalori che stanno alla base delle norme (etiche e giuridiche)intese a regolare le finalit e i comportamenti degli individuinei loro rapporti privati e nelle loro azioni sociali.
Per quanto riguarda il primo steccato, il nesso tra la ricercascientifica pura, cio perseguita al solo scopo di conoscerein modo disinteressato la natura, e linnovazione tecnologica,stimolata dallinteresse a inventare continuamente nuovi stru-menti per soddisfare la domanda di un mercato sempre piesigente e sofisticato. La ragione semplice: le leggi della natu-ra non si possono brevettare, mentre conoscenza e applicazio-ne si intrecciano nellindividuazione delle modalit che ren-dono efficace un processo rispetto a un altro apparentementesimile che non lo .
Anche per quanto riguarda la separazione fra fatti e valori lasvolta ha un effetto dirompente. ormai esperienza comuneche i dibattiti e le polemiche interne alla scienza comincianoa entrare nelle arene del discorso e dellazione non scientifi-che. Le scoperte scientifiche sono messe in discussione, criti-cate o utilizzate insieme ad altre fonti di conoscenza disponi-bili da parte di un pubblico sempre pi vasto. Una cosa
infatti manipolare,controllare, forgiareun oggetto fatto dimateria inerte e altracosa compiere le stes-se operazioni su unorganismo vivente oaddirittura sulluomo.Nel primo caso il lecitopu coincidere conlutile, nel secondo illecito dovrebbe per lomeno dipendere ancheda una valutazione dinatura etica. Dunqueanche la seconda sepa-razione tende a svani-re: diventa sempre pidifficile decontamina-re i fatti dai valori edestirpare gli interessidalla conoscenza. Leverit della scienza egli strumenti della
tecnologia acquistano propriet che dipendono dal contesto.Nasce il problema del rapporto fra conoscenza e valori, cio delnesso fra la ricerca della verit e il perseguimento di retticomportamenti individuali e collettivi.
Lo sgretolamento di questi due steccati tradizionali va a suavolta collocato, per valutarne appieno le conseguenze sociali,allinterno di unaltra svolta epocale compiuta, al passaggiodel secolo, dalleconomia capitalistica globalizzata. Vediamorapidamente di che si tratta.
4. La produzione di merci immaterialiNella societ contemporanea tutto ormai ridotto a merce.
Da questo punto di vista diventa naturale attribuire le fat-tezze di merce a ogni componente - dal singolo gene alinteroorganismo - della straordinaria variet di forme viventi e aogni manifestazione - dal singolo bit allopera pi monumen-tale - delle infinite possibili espressioni del pensiero umano.
-
M A R C E L L O C I N I
77 DEDALUS N.2/3 GIUGNO / LUGLIO 2007
Nel XX secolo il meccanismo di accumulazione del capitalesi fondato sulla formazione del profitto nel processo di pro-duzione delle merci materiali (molecole) e sullespansione delloro consumo da parte dei lavoratori stessi (fordismo). NelXXI secolo il meccanismo di accumulazione del capitale sem-pre pi si fonder sulla formazione del profitto nella produ-zione di merci immateriali. La propriet fondamentale deibeni immateriali infatti che, a differenza di quelli materiali,la fruizione da parte di un consumatore non ne impediscela fruizione da parte di altri. Anzi, improprio parlare di con-sumatori, perch le merci immateriali, in realt non si con-sumano. In un disco non la plastica che conta, la canzo-ne che c incisa. Ma la canzone non si consuma se io lascol-to: la possono ascoltare altre milioni di persone.
La riduzione dellinformazione a merce destinata ad essereacquistata e fruita individualmente in esclusiva, dunque unaartificiosa reificazione di un bene che, se da un lato fruttodella creativit individuale di persone eccezionalmente dotate,dallaltro non nasce dal nulla ma trae ispirazione dal patrimo-nio culturale comune dellumanit e a sua volta acquista sensosoltanto se va ad accrescere questo patrimonio. A confermadella natura p