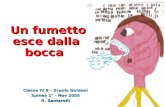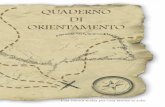DAMS – Università Roma Tre Corso di Storia e Critica della ... · Usi e funzioni sociali di...
Transcript of DAMS – Università Roma Tre Corso di Storia e Critica della ... · Usi e funzioni sociali di...

DAMS – Università Roma TreCorso di Storia e Critica della FotografiaA.A. 2013/2014Elio Ugenti
Usi e funzioni sociali della fotografia. Ieri e oggi.
«Se nella fotografia c’è una forza viva irresistibile, se in essa c’è qualcosa che sembra essere di una gravità assoluta, […] allora dobbiamo dire che con la fotografia non ci è più possibile pensare all’immagine al di fuori dell’atto che l’ha creata. La foto non è solamente un’immagine (il prodotto di una tecnica e di una azione, il risultato di un fare o di un saper fare, un’immagine di carta che si guarda semplicemente nella sua chiusura di oggetto finito), è anche, anzitutto, un vero atto iconico, un’immagine se si vuole, ma “attiva”, qualcosa che non si può
concepire al di fuori delle sue circostanze […], precisando che questo “atto” non si limita al solo gesto di produzione propriamente detta dell’immagine (il gesto di “scattare”) ma che include tanto l’atto della sua ricezione quanto della sua
contemplazione». (Philippe Dubois, L’atto fotografico, 1986) La proposta metodologica di Pierre Bourdieu
Il libro di Pierre Bourdieu La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media esce nel 1965 in Francia e si propone di utilizzare gli strumenti della sociologia per operare una riflessione sistematica sulla fotografia. L’obiettivo è dunque quello di comprendere quali siano le
relazioni che si instaurano tra la pratica fotografica e una serie di dinamiche sociali
entro le quali essa si attualizza, focalizzando l'attenzione sulla Francia, ma elaborando poi delle considerazioni che risultano - per molti versi - generalizzabili.

Questione metodologica di partenza: superamento della contrapposizione (storicamente radicata negli studi di filosofia) tra oggettività e soggettività.
Tesi di Bourdieu: esistenza di una profonda compenetrazione che rende inscindibili questi due concetti nel momento in cui li si cala nella realtà (al di là di qualunque forma di astrazione filosofica) ricercando i loro effetti in alcuni fenomeni sociali specifici. Argomentazione: le pratiche soggettive non possono in alcun modo prescindere dall’oggettività (o meglio da fattori oggettivi) poiché l’oggettività in quanto tale non
esiste. Essa può manifestarsi soltanto attraverso l’agire individuale e soggettivo. Ricordare che – a partire dalla considerazione di Philippe Dubois riportata in apertura – stiamo considerando la fotografia come un atto iconico inscindibile dalle circostanze che
lo determinano (produzione + fruizione).
OGGETTIVITÀ --> Esteriorizzazione dell’interiorità
SOGGETTIVITÀ --> Interiorizzazione dell’esteriorità
Coesistenza dei due termini (interiore/esteriore) nella definizione di entrambe i macro-concetti (oggettivo/soggettivo).Bourdieu: "Le relazioni oggettive NON ESISTONO e non si realizzano effettivamente che entro e attraverso quel prodotto dell’interiorizzazione delle condizioni oggettive che è il
sistema delle disposizioni".È importante per il procedere del nostro discorso rimarcare l’importanza delle forme di relazione che si instaurano tra il piano soggettivo-individuale e quello oggettivo-transindividuale, anche al di là delle modalità di utilizzo di questi concetti da parte di Bourdieu.L’impostazione sopra descritta deve servire a spiegare le motivazioni della diffusione della fotografia, le pratiche a essa correlata, i differenti utilizzi che se ne fanno al di fuori dell’ambito artistico/autoriale.

SPIEGAZIONE PSICOLOGICA: forte impulso a possedere un apparecchio fotografico (una sorta di bene di consumo).La spinta naturale verso “l’atto fotografico” è indipendente dai condizionamenti sociali e correlata al reddito.IPOTESI DI BOURDIEU: la spiegazione psicologica scambia gli effetti per la cause. Le motivazioni addotte non sono la causa dell’uso (o dell’uso particolare) della fotografia, ma “ragioni” che fungono da copertura a dei condizionamenti sociali fortemente radicati, i quali trasformano la fotografia in un “bisogno” e fanno sì che essa sia vissuta come tale (conseguenza, dunque, non causa).Ecco alcune delle motivazioni che Bourdieu elenca, riprendendole da studi che seguono la linea della spiegazione psicologica fondata sul rapporto bisogno-soddisfacimento:1) «La fotografia avrebbe la funzione di aiutare a superare l’angoscia provocata dal fluire del tempo, sia offrendo una sorta di sostituzione magica di ciò che il tempo ha distrutto, sia colmando i vuoti della memoria e fornendo spunto all’evoluzione di ricordi associati, in breve suscitando l’illusione di VINCERE IL POTERE DEL TEMPO».A bene pensarci, si tratta di qualcosa di molto prossimo al complesso della mummia di cui parlava esattamente venti anni prima André Bazin nel suo saggio Ontologia dell’immagine
fotografica.2) «[La fotografia] saprebbe favorire la comunicazione con gli altri permettendo di rivivere in comune i momenti trascorsi».Questa funzione risulta importantissima per il nostro discorso. Vanno tenuti a mente principalmente due aspetti: la comunicazione e i momenti trascorsi.In questo frangente, e alla luce delle caratteristiche della fotografia – in quanto medium – nel momento in cui Bourdieu conduce la sua ricerca, i due aspetti sono tenuti insieme in una sorta di relazione causa-effetto. Vedremo poi come la loro relazione diventa più complessa e sfaccettata nella riflessione di uno studioso contemporaneo come José Van Dijck.

3) «La fotografia offre al fotografo la possibilità di “realizzarsi” sia facendogli sperimentare la propria “potenza” mediante l’appropriazione magica […] della cosa
rappresentata, sia consentendogli di esprimere un’intenzione artistica o di manifestare la sua padronanza tecnica».Qui si va nel campo delle caratteristiche “tecniche” del medium fotografico e sulle capacità specifiche che consentono il suo utilizzo, oltre che sulla sua capacità di consentire una riproduzione tecnico-meccanica dell’immagine. 4) «La fotografia fornirebbe un mezzo d’evasione o una semplice distrazione al pari di
un gioco».E qui è chiamata in causa quella che possiamo definire come la funzione ludica della pratica fotografica. Una funzione, questa, che è chiamata in causa anche da alcuni studiosi che si occupano del contemporaneo, come per esempio Peppino Ortoleva che se ne occupa in relazione all’ampia diffusione di video su YouTube.I freni che si oppongono al soddisfacimento di questi bisogni sarebbero invece la mancanza
di denaro e la paura del ridicolo e del fallimento.Valore culturale e valore espositivo della foto di famiglia
Queste necessità individuali non forniscono – secondo Bordieu – alcuna risposta soddisfacente se non si tiene conto di alcuni altri fattori.Uno di questi, forse il più importante e certamente quello su cui soffermeremo la nostra attenzione, è legato proprio alle circostanze.Nel momento in cui Bordieu porta avanti il suo studio sul campo, appare evidente che la pratica fotografica comune (non artistica, non autoriale, potremmo dire amatoriale) si lega fortemente a occasioni precise in cui si ritiene giustificato il ricorso alla fotografia, con delle differenze di grado che si possono riscontrare nel passaggio da una classe sociale all’altra.

Scrive Bourdieu:«Più dei due terzi dei fotografi sono dei conformisti stagionali che si dedicano alla fotografia sia in occasione di cerimonie familiari o di riunioni amichevoli, sia nel periodo delle vacanze estive».

Le immagini qui riportate sono prese dall’archivio “ImagoOnline” nato nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca intitolato “Memorie del quotidiano”, condotto dall'Università di Bologna e coordinato da Paolo Sorcinelli. In questo archivio sono raccolte fotografie amatoriali (che possiamo definire come “foto di famiglia”) scattate in Italia tra il 1846 e il 2009. Le utilizziamo perché ci consentono di attingere dal contesto italiano per cogliere l'universalità di alcune riflessioni che Bourdieu elabora a partire dai suoi studi sul campo condotti in territorio francese.

Bourdieu individua dunque la funzione familiare – intesa come la funzione che le conferisce il gruppo familiare – come una delle funzioni principali (la più importante) della pratica fotografica occasionale.La motivazione che è alla base di questa funzione ha una connotazione tipicamente sociologica, ed è descritta dallo studioso francese in questi termini:«Solennizzare ed eternare i grandi momenti della vita familiare, in breve, rinsaldare
l’integrazione del gruppo riaffermando il sentimento che esso ha di sé e della propria
unità».C’è dunque alla base della pratica fotografica familiare una necessità autorappresentativa mirata a lasciare (letteralmente) agli altri una certa immagine di sé.Ecco dunque che la “questione metodologica” posta all’inizio (e affrontata da Bourdieu nell’introduzione del suo libro) trova qui una concreta applicazione: mentre l’approccio psicologico resta ancorato all’ambito soggettivo, l’approccio sociologico proposto si propone di coniugare il piano soggettivo con quello oggettivo, muovendo da quest’ultimo per
cogliere e analizzare i processi di interiorizzazione che lo riguardano.Anche per quanto concerne le specifiche modalità attraverso cui si ricorre alla fotografia, Bordieu si ripropone di dimostrare una forte connessione con dinamiche sociali più ampie che – in quanto tali – interessano il piano interindividuale. È possibile prenderne atto anche riportando semplicemente la dichiarazione di un abitante di una piccola città di provincia intervistato da Bourdieu, il quale – a proposito delle fotografie nei matrimoni – afferma:«Le fotografie dei dilettanti non possono sostituire le fotografie ufficiali, che ci si fa fare in studio per inviarle a parenti e amici. Ci vanno tutti allo studio, anche i più poveri».Da questa affermazione si evince chiaramente la predominanza della funzione sociale
sull’impedimento economico.L’occasione sociale, in funzione del suo livello di importanza, accresce la possibilità (e quasi la necessità) dell’atto fotografico.

Si apre poi un discorso legato alla funzione della fotografia all’interno del gruppo familiare, che concerne però la fruizione delle immagini.Sarà interessante prendere atto di alcune considerazioni di Bourdieu per iniziare poi a spostarci al di fuori del suo discorso specifico per avviare un confronto con l’oggi.Scrive Bourdieu:«Nella maggior parte delle case contadine, le fotografie sono custodite in una scatola, ad eccezione della fotografia del matrimonio e di alcuni ritratti. Sarebbe scarso decoro o ostentazione esporre agli sguardi del primo venuto le immagini dei membri della famiglia. […] Le fotografie rituali sono troppo solenni o troppo intime per essere esposte nello spazio della vita quotidiana».A questo punto del nostro discorso può venirci incontro la riflessione di Walter Benjamin nel suo celebre saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Non intendo riprendere qui la celebre questione della perdita dell’aura, né problematizzare l’artisticità dell’immagine tecnicamente riprodotta. Mi interessa piuttosto concentrare l’attenzione su una questione a mio parere sottovalutata, che – se spostata al di fuori dell’ambito delle immagini artistiche che erano poste al centro dell’interesse nella riflessione di Benjamin per estenderlo alle immagini tout court – ci consente di cogliere alcuni aspetti importanti legati alla presenza e alla circolazione delle immagini nel panorama visuale contemporaneo, nonché di operare un confronto con un modo di fruizione ormai sorpassato, e che è proprio quello preso in considerazione da Bourdieu al tempo della scrittura del suo libro. Mi sto riferendo alla relazione tra valore culturale e valore espositivo delle immagini, due parametri – o due polarità, per usare le parole dello stesso Benjamin – considerate da lui come inversamente proporzionali.
Il valore culturale è infatti legato a un “utilizzo” dell’immagine quanto più possibile intimo
e direttamente collegato a un “rituale”. È lo stesso Benjamin a sostenere che «il valore culturale come tale induce a mantenere l’opera d’arte [l’immagine più in generale nel nostro caso] nascosta». Un’idea questa che sembra descrivere molto bene la relazione con l’immagine familiare descritta da Bourdieu e che si confà – più in generale – all’immagine di famiglia

tradizionalmente intesa, l’immagine intima che veniva conservata in un album, riposta in
un cassetto ed esposta solo in momenti in cui una ritualità – strettamente collegata
all’esercizio della memoria e del ricordo – veniva innescata in un ambito ristretto che
coinvolgeva pochi intimi (amici e familiari per lo più). Ma possiamo pensare anche alle foto gelosamente custodite nel portafoglio, le quali erano spesso legate al ricordo di una persona cara e venivano esposte e mostrate “in pubblico” solo in rarissime occasioni.Nel caso della foto privata – così come accadeva per l’opera d’arte posta da Benjamin al centro della propria riflessione – l’elevato valore culturale si lega dunque storicamente a un
bassissimo valore espositivo.Autorappresesentazione VS Preservazione della memoria
Stando alle considerazioni di Bourdieu e alle dichiarazioni delle persone da lui intervistate nel corso della sua indagine sociologica, la pratica occasionale della fotografia sembra essere principalmente collegata a due processi: la preservazione della memoria da una parte e la rappresentazione del nucleo familiare e della sua unità dall’altra.Queste tematiche sono oggi riprese alla luce del nuovo scenario mediatico e dei processi di digitalizzazione che riguardano tanto la produzione di immagini fotografiche quanto le loro molteplici e complesse forme di fruizione. In particolare, i processi autorappresentativi e le pratiche di preservazione della memoria sono oggetto di interesse di una serie di studiosi afferenti ai cosiddetti Memory Studies, un’area di studio che può essere considerata come una sottocategoria degli studi sociologici interessata alle modalità attraverso cui i media concorrono alla costruzione della memoria, mostrando interesse anche per quelle che sono le relazioni in questo senso tra il piano individuale e il piano collettivo.Una studiosa contemporanea molto interessante da questo punto di vista è certamente José Van Dijck, docente di Comparative Media Studies presso l’Università di Amsterdam.È molto utile ai fini del nostro discorso prendere in considerazione alcune sue riflessioni all’interno di un saggio pubblicato sulla rivista “Visual Communication” nel 2008, e cioè in un momento storico in cui alcuni importanti sviluppi nell’ambito dei cosiddetti “nuovi media” stavano definendo delle nuove forme di socialità in Rete, con forti ripercussioni sul piano della cultura visuale, modificando notevolmente l’uso e le funzioni dell’immagine privata. Ripercussioni e modificazioni che la Van Dijck coglieva sostanzialmente in tempo reale.

La studiosa prende atto di una serie di fattori che caratterizzavano la foto personale in età analogica. Prendiamoli in considerazione schematizzando:- In era analogica era fortemente correlata al ricordo autobiografico- Le fotografie erano fondamentalmente dei ricordi da conservare in un album di famiglia o all’interno di una scatola.- La formazione dell’identità personale era un elemento presente ma secondario rispetto alla funzione della preservazione della memoria.I due elementi che vengono contrapposto sono dunque:PRESERVAZIONE DELLA MEMORIA (legata principalmente all’intero ambito familiare)eCOSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ (intesa per di più come identità individuale)La conclusione a cui la Van Dijck giunge – e che io personalmente condivido in pieno – è che oggi la crescente presenza di dispositivi preposti alla produzione di immagini fotografiche e, soprattutto, la possibilità di inserire le fotocamere in dispositivi preposti alla
comunicazione sposta nettamente la funzione dell’immagine fotografica da un oggetto fisico
legato alla preservazione della memoria e al ricordo a un oggetto (non più
fisso/materiale) finalizzato principalmente alla comunicazione istantanea.Sulla scia di queste considerazioni si potrebbe dire che seppur in molti casi la tipologia di immagini resta immutata, cambia il messaggio che essa vuole veicolare.

Prendiamo in considerazione queste due immagini. Se nel primo caso la foto è stata scattata per essere inserita in un album al fine di ricordare il primo compleanno del bambino a distanza di anni, nel secondo caso le due foto sono state realizzate e immediatamente condivise su facebook con una funzione molto più marcatamente comunicativa, in funzione cioè di una loro spendibilità immediata. Notare – peraltro – i complessivi 113 like totalizzati dalle due immagini e gli 11 commenti, molti dei quali saranno probabilmente messaggi di augurio che palesano dunque la finalità comunicativa dell’immagine postata.L’evento rappresentato è lo stesso. La funzione principale delle immagini è profondamente mutata, ed è profondamente mutato anche il livello di esponibilità dell’immagine
privata, familiare.L’obiettivo della Van Dijck – dato anche il suo ambito di ricerca – è comunque quello di dimostrare che ciò che avviene non è un processo di sostituzione di una funzione (quella

comunicativa) rispetto a un’altra (quella legata alla preservazione della memoria). L’una – che era prima secondaria – diventa ora dominante, ma entrambe coesistono così come coesistevano in era analogica.Scrive la Van Dijck:«In recent years, we have seen profund shifts in the balance between these various social use: from family to individual use, from memory tools to communication device and from
sharing (memory) to sharing experience».
Abbiamo molto soffermato l’attenzione sul primo e sul terzo punto individuati dalla studiosa, ma anche il secondo è di notevole importanza. Se, infatti, Bourdieu a suo tempo individuava la famiglia – e le relazioni familiari – come soggetto principale di molte foto familiari, oggi sembra che la direzione intrapresa da questa pratica assecondi un crescente individualismo che – a livello sociale – si manifesta in molti aspetti della vita del soggetto contemporaneo. L’autorappresentazione mirata a una costruzione (e all’esibizione) dell’identità
individuale è preponderante sui Social Network, e passa attraverso l’accostamento di
immagini personali, contenuti audiovisivi, frammenti testuali e molti altri contenuti
che riempiono le nostre bacheche su facebook.
Prosegue la Van Dijck:«Showing pictures as part of conversation or reviewing pictures to confirm social bonds between friends appears more important than organizing photos in albums and looking at them».La studiosa olandese precisa tuttavia che, seppur non sia più considerabile come la funzione principale della condivisione di immagini, la preservazione della memoria non viene meno. Non fosse altro che per il fatto che le immagini sono lì, e ogni forma di visualizzazione o ricondivisione successiva fa sì che esse appaiano come il ricordo di un evento passato. L’esempio che la Van Dijck utilizza per dimostrare la sua tesi concerne le tristemente celebri fotografie scattate dai soldati americani nel carcere di Abu Ghraib, immagini che le consentono – peraltro – di analizzare uno slittamento dalla “funzione privata” di alcune
fotografie verso il loro affermarsi come parte integrante della nostra memoria
collettiva. Quelle immagini, come noto, non furono pubblicate nel contesto di un reportage di

denuncia, ma sono immagini che sfuggirono al controllo di chi le aveva realizzate, finendo per svolgere una funzione profondamente differente da quella che doveva essere la loro funzione originaria.
Un’immagine in particolare tra quelle scattate nel carcere diverrà una vera e propria icona, nota come la fotografia del “Cristo di Abu Ghraib”.
Questo aspetto della riflessione della studiosa olandese può essere facilmente individuato anche al di fuori di un esempio così specifico come quello delle immagini di Abu Ghraib, all’interno di un fenomeno sociale molto recente come il “film” di Facebook
automaticamente generato da un’applicazione creata per il decennale della nascita del
social network, il quale ha spopolato per molti giorni sulle bacheche degli utenti di tutto il mondo.

Questi film altro non erano se non il tentativo di “vivificare” in un minuto la memoria dell’agire di ciascun utente all’interno di questo social network dal momento della sua iscrizione fino a oggi, mediante l’assemblaggio di una serie di testi e di immagini (principalmente fotografiche) che originariamente svolgevano quella funzione di comunicazione istantanea presa in analisi dalla Van Dijck.Moto spesso – e questo è un aspetto assolutamente interessante – si trattava infatti di immagini che non rappresentavano un evento eccezionale, una “circostanza extra-ordinaria” capace di “giustificare” il ricorso all’atto fotografico (come avrebbe detto Bourdieu). Si trattava molto spesso di immagini che rispecchiavano situazioni assolutamente ordinarie, rispetto alle quali la preservazione del ricordo non avrebbe mai potuto essere il motivo principale posto alla base della loro produzione (e condivisione). Eppure quanti utenti hanno scritto di essersi commossi di fronte a quel breve film, motivando la loro reazione con parole chiave quali “nostalgia”, “ricordo” e una gran quantità di termini correlati all’esercizio della memoria?
Autorappresentazione individuale
Anche Bourdieu prende in considerazione alcuni aspetti a proposito del ritratto fotografico come oggettivazione dell’immagine di sé. Eppure, ciò che emerge dalle sue valutazioni anche in questo caso è qualcosa che resta fortemente correlato a una serie di convenzioni e le relazioni sociali.La goffaggine di alcuni contadini in posa davanti all’obiettivo della macchina fotografica è interpretata dallo studioso francese come il segnano tangibile di un disagio provato al momento dello scatto. Un momento nel quale il contadino finisce per «interiorizzare
l’immagine peggiorativa che i membri degli altri gruppi hanno di lui». E Bordieu rintrax1cia come una costante di queste fotografie un rapporto inquieto del soggetto col proprio corpo, con la propria postura. E la riflessione di Bourdieu rimanda direttamente a una considerazione straordinariamente affascinante di Roland Barthes nel suo libro La camera chiara.Scrive Barthes:«Ah, se solo potessi riuscire sulla carta come sulla tela d’un quadro classico, on un’espressione nobile, un’aria pensosa, intelligente, ecc.! Insomma, se solo potessi essere “diponto” (da

Tiziano) o “disegnato” (da Clouet)!Ma siccome ciò che vorrei che si captasse è una delicata testura morale e non una mimica, e siccome la Fotografia, salvo nel caso dei grandi ritrattisti, è poco sottile, io non so come agire
all’interno sulla mia pelle. Decido allora di lasciar aleggiare sulle mie labbra e nei miei occhi un sorriso che vorrei “indefinibile”, col quale, insieme alle qualità della mia natura, darei a leggere la consapevolezza divertita che io ho di tutto il cerimoniale fotografico: io mi presto al gioco sociale, poso, so che sto posando, voglio che voi lo sappiate, ma questo supplemento di messaggio non deve assolutamente alterare (vera e propria quadratura del cerchio) l’essenza della mia persona: solo ciò che io sono, al di fuori di ogni effigie». Prosegue più avanti Barthes:«La Foto-ritratto è un campo chiuso di forze. Quattro immaginari vi s’incontrano, vi si affrontano, vi si deformano. Davanti all’obiettivo io sono contemporaneamente: quello che io credo di essere, quello che vorrei si creda io sia, quello che il fotografo crede io sia, e quello di cui egli si serve per dar mostra della sua arte».Pensiamo a quanto la pratica foto-ritrattistica più in voga in questo momento, il selfie, faccia scomparire in un solo colpo gli ultimi due “immaginari” descritti da Barthes. Pensiamo a come restino in vita, in realtà, solo gli aspetti più marcatamente individualistici della sua riflessione (i primi due, i più autoreferenziali).Pensiamo a come le questioni della postura, di un’immagine di sé socialmente accettata, che risultavano un problema per le persone intervistate da Bourdieu, vengano meno per lasciare spazio al senso di istantaneità che questo tipo di rappresentazione deve trasmettere.Pensiamo dunque a come il selfie più che “nutrirsi” di una serie di convenzioni esterne
che storicamente regolavano il momento dell’auto-rappresentazione detti esso stesso
dei modelli di rappresentazione. Pensiamo a come abbia reso lecite una serie di elementi
che erano considerati contrari a una certa “estetica” del ritratto fotografico, anche di quello non autoriale, di quello privato-familiare, primi tra tutti la distanza molto ridotta
dalla macchina fotografica e la visibilità del braccio teso all’interno della foto. Sono ormai numerosissimi i selfie postati quotidianamente sui social network. Dai più bizzarri ai più “tradizionali”, come è possibile vedere dai due esempi sotto riportati.

Fino ai selfie delle celebrità, tra le quali è diventata ormai una moda quella di veicolare un’immagine di sé che in molti casi non è più realizzata secondo i canoni della professionalità, ma mediante al ricorso a un’estetica amatoriale che in questo momento è incarnata appieno dal selfie, come nel caso delle immagini che seguono, rispetto alle quali va notato un aspetto particolare. Non si tratta di veri e propri selfie, ma di fotografie di vip nell’atto di realizzare un selfie. Molto spesso, quasi senza che noi ce ne accorgiamo, è questa la tipologia di immagine che circola, e questo fatto è tutt’altro che trascurabile: sta a indicare come l’atto in sé sia
diventato rappresentativo di qualcosa, anche al di là e in assenza dell’immagine
fotografica che se ne ricava.
Sembra palesarsi in questi scatti un’inversione di tendenza per cui – nel mondo “virtuale” della rete e dei social network – non è più il soggetto comune a tendere verso il “divo” e a emularne i codici rappresentativi, ma è il divo a emulare i codici rappresentativi per “avvicinarsi” alla persona comune. Il messaggio implicito in questi scatti è evidentemente: “We are just like you!”.

Dall’amatoriale al promozionale
Non sarà possibile scendere qui nello specifico di questo argomento, ma è interessante almeno accennare ad alcuni casi di pratiche correlate in maniera più o meno netta ed evidente alla fotografia che vengono in qualche modo riutilizzate per scopi differenti rispetto a quella che era la loro funzione di partenza.Il primo caso concerne proprio il riutilizzo della pratica amatoriale appena presa in considerazione, il selfie, per uno scopo pubblicitario, attraverso una strategia mediatica molto raffinata capace di generare una complessa relazione tra pratica, tecnologia ed evento.
Mi sto riferendo all’ormai celebre selfie realizzato da Bradley Cooper e che si è certamente imposta come l’immagine più rappresentativa dell’ultima edizione della notte degli Oscar, fino al punto da diventare l’immagine più ritwittata di sempre.

Il ricorso a una pratica nata come amatoriale diviene un potentissimo mezzo promozionale per uno degli eventi più importanti del mondo e – contemporaneamente – per un colosso mondiale come la Samsung che si è rivelato essere il vero artefice di un semplice gesto che apparentemente risulta spontaneo e – per l’appunto – familiare. Per concludere…
Alla luce delle riflessioni sin qui condotte, può essere molto utile ripercorrere schematicamente i punti chiave di un articolo pubblicato qualche giorno fa dal fotografo americano Trevor Paglen all’interno del blog “Fotomuseum” per inaugurare una rubrica dedicata alla fotografia, intitolata An Online Discourse on Photography.L’articolo di Paglen riprende esattamente il titolo di un convegno teutosi qualche anno fa a San Francisco: Is Photography Over? Quell’occasione ha rappresentato secondo Paglen una vera e propria sfida (sin dal titolo così provocatorio) lanciata ai convegnisti e a tutto il pubblico presente con l’intento di mettere insieme tutta una serie di saperi critici e teorici sulla fotografia accumulati e affinati negli anni per comprendere «che cosa è cambiato - se qualcosa è cambiato - per la fotografia nell'ultimo decennio circa».A detta di Paglen, la domanda provocatoria posta dai due curatori del convegno Sandra Philips e Dominic Wildson rappresentava l'aspetto più interessante dell’intero evento, anche più della maggior parte dei contenuti del convegno stesso. Perché si tratta di una domanda che cela in sé un profondo disagio che accomuna gli studiosi di fotografia e i fotografi stessi. È interessante per noi notare come questa considerazione di Paglen ponga in relazione teoria e pratica della fotografia:- Riflessione intorno alla fotografia --> ricerca di adeguati strumenti metodologici e critici- Pratica fotografica --> ricerca del proprio ruolo, della propria "posizione" all'interno del nuovo panorama visuale all'interno del quale la fotografia è inclusa

Due aspetti che sono (potrebbero essere?) messi in crisi - o quantomeno in discussione - dalle trasformazioni che stanno avvenendo nel campo della fotografia. Scrive molto esplicitamente Trevor Paglen:“La fotografia si sta profondamente modificando in quelle sono le sue componenti tecniche, culturali e critiche”.E ancora più importante appare la questione posta immediatamente dopo: "These changes are difficult to make sense of within photo theory's existing critical and practical framework; hence the question 'is photography over?'".L’attuale quadro critico, teorico e pratico riesce con difficoltà a dare un senso a questi cambiamenti. Dunque, la domanda che si pone: “La fotografia è superata?”.Paglen coglie dunque la centralità dell’aspetto tecnico-produttivo dell’immagine:Certamente lo sviluppo di tecnologie che consentono un processo produttivo automatizzato di alta qualità hanno sancito col tempo la fine del fotogiornalista professionista, contribuendo dunque a rendere "superata" una certa concezione della fotografia. Ma coglie anche la centralità dell’aspetto culturale:
I processi di digitalizzazione hanno causato un ingresso della fotografia nelle nostre vite quotidiane che è senza precedenti. 350 milioni di fotografie vengono quotidianamente caricate su facebook, e ciascuno di noi è mediamente sottoposto alla visione di circa 5000 pubblicità al giorno.Alla luce di questi numeri, è fuori discussione che oggi la fotografia influenza fortemente il
nostro MODO DI VEDERE e - aggiungo io - si impone come un elemento fondamentale
all'interno della cultura visuale contemporanea.
Sostiene Trevor Paglen che i termini "FOTOGRAFARE E GUARDARE stanno diventando

sempre più dei sinonimi".
Ed è ovvio che quest'affermazione è tutt'altro che provocatoria, dal momento che è davanti ai nostri occhi un fenomeno per cui l'attestazione di un'esperienza (anche non extra-
ordinaria) è delegata oggi alla fotografia più che alla visione. La certificazione
dell'esperienza passa oggi attraverso il FOTOGRAFARE tanto quanto l'ESSERCI, o -
potremmo dire in altri termini - PASSA ATTRAVERSO L'ESSERCI PER POTER
FOTOGRAFARE.E questo è fondamentale, perché segna una differenza molto netta rispetto al panorama illustrato da Bourdieu negli anni '60, dal momento che la fotografia sembra dettare oggi dei modelli sociali più che esserne determinata. Impone dei modi di vedere più che adeguare i propri a una particolare visione della società. Rimando a un articolo di Federico Chiacchiari comparso non molto tempo fa sul blog della rivista online Sentieri Selvaggi L’aura digitale, la visione senza sguardo. http://blog.sentieriselvaggi.it/laura-digitale-la-visione-senza-sguardo/Chiacchiari pone un’interessante domanda, muovendo da alcune riflessioni stimolate in lui da una visita al Louvre di Parigi: "Perché fotografare delle opere che su Internet troviamo sicuramente e con grande facilità riprodotte con migliore qualità? Cosa fotografiamo?"E risponde poco più avanti:"Fotografiamo l'attimo. Segniamo il nostro ESSERCI lì, in quel luogo. Dimostriamo al
mondo, magari condividendo in tempo reale la fotografia sui social network, che noi
siamo lì, in persona, di fronte alla vera e unica opera d'arte, non a una sua riproduzione
tecnica".
Nel prendere in considerazione fenomeni molto simili, correlati alla produzione di immagini finalizzate all’immediata condivisione, Trevor Paglen da parte sua evidenzia il fatto che queste fotografie vengono poi spesso gettate all'interno di un contesto dove convivono con milioni di altre immagini, tanto che - SUL PIANO METODOLOGICO - diventa quasi inutile ragionare sulla singola immagine, e persino sulla "fotografia" come una pratica dissociata da altre pratiche di produzione visiva.

Su queste parole di Paglen si aprirebbe una questione metodologica complessa e ampia che è al centro dei più recenti sviluppi degli Studi Visuali. Questione metodologica che al momento è in grado di aprirsi a una gran quantità di domande senza riuscire ancora a fornire risposte assolutamente certe. La proposta di alcuni studiosi va nella direzione di un'ecologia dell'immagine da intendersi come una VALUTAZIONE DELLE RELAZIONI CHE SI INSTAURANO TRA LE SINGOLE IMMAGINI E POI TRA ESSE E IL SISTEMA MEDIATICO CHE LE CONTIENE E CHE LE VEICOLA. Non ci sarà tempo qui di approfondire questo aspetto che è comunque fondamentale ai fini di una riflessione esaustiva sulle metodologie di studio: l’ INTRECCIO TRA VISUAL STUDIES E i MEDIA STUDIES (studi sulle immagini e studi sui media). Tutti questi aspetti fanno sì che forse, come sostenuto anche da Trevor Paglen, una concezione della FOTOGRAFIA come singolo oggetto di studio sia anch'essa superata, e possa dirsi anch’essa “over”.In realtà - afferma Paglen, e io condivido in pieno la sua affermazione - AD ESSERE SUPERATA
NON E' LA FOTOGRAFIA, MA UN MODO PARTICOLARE (TRADIZIONALE) DI INTENDERE
LA FOTOGRAFIA. Quello che queste riflessioni devono stimolare, dunque, non è il totale abbandono del proprio oggetto di studio da parte d una disciplina (né, tanto meno, l’abbandono delle pratiche a esso correlate), ma una sistematica riflessione sui modi della sua ridefinizione, e sui modi in cui la riflessione critico-teorica può riallacciare i rapporti con una pratica che non è più quella che abbiamo visto nascere nel diciannovesimo secolo e svilupparsi nel ventesimo, ma che è e resta fondamentale ai fini della comprensione dell'immaginario di questo ventunesimo secolo.

![SI ESCE! Basilicata n.69 [19-25 Luglio 2012]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/568c4b191a28ab49169ada83/si-esce-basilicata-n69-19-25-luglio-2012.jpg)
![SI ESCE! Basilicata n.59 [19-25 Aprile 2012]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/568c0db41a28ab955a8dc080/si-esce-basilicata-n59-19-25-aprile-2012.jpg)








![SI ESCE! Basilicata n.60 [10-16 Maggio 2012]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/568c4b391a28ab49169b62b8/si-esce-basilicata-n60-10-16-maggio-2012.jpg)