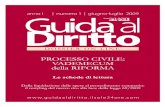CONVEGNO DEL 28 FEBBRAIO 2011 - ANCL Unione … · La materia delle controversie individuali di...
-
Upload
trannguyet -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of CONVEGNO DEL 28 FEBBRAIO 2011 - ANCL Unione … · La materia delle controversie individuali di...
Filiale PIEMONTE
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Sede operativa: C.so Lombardia, 69 10099 San Mauro T.se (TO) Tel. +39 011 273661 Fax +39 011 27366241 www.osra.it [email protected]
S.r.l. a Socio Unico Dir. Coord. di Wolters Kluwer N.V. Sede legale: Centro Direzionale Milanofiori Strada 1, Pal. F6 - 20090 Assago MI Capitale sociale: 19.640.000 int. vers. Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 10209790152 R.E.A. di Milano N. 1353036
CONVEGNO DEL 28 FEBBRAIO 2011
Titolo: Contenzioso in materia di lavoro contro il lavoratore.
Risoluzione arbitrale delle controversie - Parte Prima.
Relatore: Dott. Francesco Natalini Avv. Gianpaolo Alice
1
CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
Sommario 1. Il Giudice competente 2. Giudizio di primo grado: instaurazione 3. svolgimento 4. pronunzia della sentenza 5. Impugnabilità della sentenza di primo grado 6. Giudizio d'appello 7. Impugnabilità della sentenza d'appello.
1. Il Giudice competente La materia delle controversie individuali di lavoro è di competenza, a norma dell'art. 413, cod. proc.
civ., del tribunale in funzione di giudice del lavoro; tale competenza è inderogabile ed è rilevabile anche d'ufficio, non oltre l'udienza di discussione di cui all'art. 420 cod. proc. civ..
In particolare, a prescindere dal loro valore, sono in primo grado di competenza del tribunale (c.d. competenza per materia) le controversie relative:
- ai rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa (art. 409, n. 1, cod. proc. civ.);
- ai rapporti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, nonchè ai rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie (art. 409, n. 2, cod. proc. civ.);
- ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica (art. 409, n. 4, cod. proc. civ.);
- ai rapporti di pubblico impiego, se non sono devoluti dalla legge ad altri giudici (art. 409, n. 5, cod. proc. civ.);
- ai rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e agli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.).
Competenza territoriale Per quanto concerne il profilo territoriale (cioè la competenza per territorio) la cognizione delle
controversie in oggetto spetta, a norma dell'art. 413, cod. proc. civ., al tribunale nel cui mandamento: - è sorto il rapporto sul quale si controverte, intendendosi come tale, secondo la giurisprudenza, il
luogo in cui è stato stipulato il contratto (cioè il luogo dove la parte che ha proposto la stipulazione del contratto di lavoro è giunta a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte), e non già quello in cui abbia avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa rilevante invece nel caso di rapporto sorto di fatto;
- ha sede l'azienda o nel quale vengono effettivamente esercitate le funzioni di direzione ed amministrazione della stessa;
- è ubicata la dipendenza dell'azienda alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale lo stesso era occupato al momento dell'estinzione del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purchè la domanda sia presentata entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Ove non sia possibile applicare alcuno dei criteri suesposti, è ammesso il ricorso alle norme ordinarie sul foro generale delle persone fisiche (art. 18 cod. proc. civ.), vale a dire che l'azione può essere proposta al giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio.
Competenza per territorio - Agenti e rappresentanti Per controversie relative a rapporti di agenzia e assimilati è competente, in deroga a quanto sopra, il
tribunale nel cui mandamento si trova il domicilio dell'agente, rappresentante di commercio o titolare degli altri rapporti di collaborazione indicati al n. 3 dell'art. 409, cod. proc. civ.
Inderogabilità della competenza per territorio In base all'art. 428, cod. proc. civ., l'incompetenza per territorio può essere eccepita dalla parte
convenuta in giudizio (la quale è tenuta, ex art. 38, comma 2, cod. proc. civ., ad indicare il foro competente) solamente nella prima memoria difensiva, di cui all'art. 416 nonchè rilevata d'ufficio fino e non oltre alla prima udienza di discussione di cui all'art. 420; in tali ipotesi il giudice adito rimetterà la
2
causa al giudice competente fissando un termine non superiore a 30 giorni entro il quale la causa deve essere riassunta, pena l'estinzione del procedimento.
Al riguardo è bene tenere altresì presente che sono nulle le clausole contrattuali che derogano alla competenza per territorio stabilita dall'art. 413 cod. proc. civ.
2. Giudizio di primo grado: instaurazione La legge n. 183/2010, riformulando l'art. 410 cod. proc. civ. ed abrogando l'art. 412-bis cod. proc.
civ., ha eliminato l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le controversie di lavoro, rendendolo facoltativo, e, conseguentemente, l'espletamento dello stesso non costituisce più condizione di procedibilità della domanda.
Il processo del lavoro in primo grado si instaura con la proposizione da parte dell'attore al tribunale in funzione di giudice del lavoro di un ricorso che deve contenere, a norma dell'art. 414, cod. proc. civ.:
- l'indicazione del giudice; - le generalità e la residenza, domicilio o sede delle parti; - la determinazione dell'oggetto della domanda; - l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative
conclusioni; - l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente vuole avvalersi e dei documenti offerti
in comunicazione; - la delega autenticata e la firma del difensore (art. 83, cod. proc. civ.) (salvo i casi in cui è ammessa
la difesa personale della parte, vale a dire, a norma dell'art. 417, cod. proc. civ. se il valore della causa non è maggiore di 129,11).
Ove il tentativo facoltativo di conciliazione sia stato, comunque, richiesto dalle parti e non sia riuscito, al ricorso devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione. In essi, infatti, sono contenuti la proposta formulata dalla commissione di conciliazione per la definizione bonaria della controversia e le valutazioni espresse in proposito dalle parti, delle quali il giudice deve tener conto in sede di giudizio (art. 411, comma 3, cod. proc. civ.).
La verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito; pertanto, ove il ricorso sia nullo (per mancanza dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti od elementi di diritto) il giudice deve dichiarare la nullità insanabile del ricorso stesso e pronunciare l'inammissibilità della domanda, senza dichiarare l'infondatezza della domanda al cui esame non può evidentemente procedere.
L'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che si offrono in comunicazione deve essere fatta a pena di decadenza nel ricorso iniziale. L'onere di allegare le prove non condiziona la validità del ricorso, ma il mancato assolvimento dello stesso ha rilievo ai fini del soddisfacimento o meno dell'onere della prova.
Deposito del ricorso e fissazione dell'udienza Ai sensi dell'art. 415, cod. proc. civ. il ricorso, con i documenti in esso indicati, va depositato nella
cancelleria del tribunale competente. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il giudice fissa con decreto la data dell'udienza di
discussione della causa, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Se necessario, con lo stesso provvedimento può nominare il consulente tecnico d'ufficio, convocandolo in una udienza interlocutoria, precedente quella del dibattimento.
Costituzione del convenuto Il successivo art. 416 dispone che il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni - termine perentorio
- prima della data dell'udienza fissata, depositando nella cancelleria del giudice adito una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte - a pena di decadenza - le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio.
In particolare, nella memoria difensiva il convenuto deve indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e i documenti, che deve depositare contestualmente; inoltre, deve confutare in modo specifico (e non limitarsi ad una generica contestazione) i fatti affermati dall'attore e proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto.
Contumacia del convenuto
3
Se il convenuto non si costituisce, il giudice lo dichiara "contumace"; ciò comunque non equivale ad
ammettere l'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esime il giudice dall'accertare se siano stati provati i fatti costitutivi della pretesa.
Domanda riconvenzionale Se il convenuto intende proporre domanda riconvenzionale, deve farlo espressamente nella memoria
di costituzione e, a norma dell'art. 418, comma 1, cod. proc. civ. deve chiedere contestualmente, a pena di decadenza dalla domanda stessa, che il giudice pronunci, entro 5 giorni - termine ordinatorio - un nuovo decreto che, a modifica di quello ex art. 415, comma 2, cod. proc. civ., fissi una nuova udienza.
3. svolgimento Secondo il modello di processo del lavoro delineato dal codice di procedura civile, nell'udienza di
discussione (la prima, in cui le parti sono tenute a comparire personalmente) si dovrebbe svolgere l'intera istruzione della causa e si dovrebbe arrivare alla discussione finale e alla risoluzione della controversia con la pronuncia della sentenza; nella pratica, tuttavia, ciò accade raramente e il processo si articola in varie udienze.
Interrogatorio libero delle parti e tentativo di conciliazione Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice è tenuto, ex art. 420, comma 1, cod.
proc. civ., a procedere all'interrogatorio libero delle parti, al fine di trarre elementi utili ad individuare i fatti controversi e a pervenire alla decisione della causa, a meno che le dichiarazioni rese dalle parti siano contraddette da elementi probatori contrari; la mancata comparizione personale di una delle parti, senza giustificato motivo, non costituisce elemento di prova contro la parte non comparsa, ma solo un comportamento valutabile ai fini della decisione. Le parti possono peraltro, in base al comma 2 dello stesso articolo, farsi rappresentare da un procuratore speciale o generale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa; la procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La circostanza che il procuratore non sia a conoscenza dei fatti della causa, senza gravi ragioni, è valutata dal giudice ai fini della decisione.
Il giudice è altresì tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione della lite, tentativo che, se riesce, dà luogo al verbale di conciliazione che, ex art. 420, comma 3, ha efficacia di titolo esecutivo.
Il giudice, nel tentare la conciliazione, deve anche formulare alle parti una proposta transattiva ed il rifiuto della stessa, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione (art. 420, comma 1, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 31, comma 4, legge n. 183/2010).
Sia l'interrogatorio che il tentativo di conciliazione sono obbligatori. Se la conciliazione tentata dal giudice non riesce, si possono verificare diverse situazioni (art. 420,
comma 4 e ss.): - la causa è matura per la decisione; - la causa non è matura e richiede una istruzione; - sorgono problemi di competenza, giurisdizione o altre questioni pregiudiziali la cui decisione può
definire il giudizio; in quest'ultimo caso, il giudice pronuncia sentenza anche non definitiva.
Mezzi di prova proposti dalle parti Il comma 5 dell'art. 420 prevede poi che nell'udienza di discussione, il giudice ammette i mezzi di
prova proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto oggettivamente proporre prima, se li considera rilevanti, disponendo con ordinanza la loro immediata assunzione.
Accertamento pregiudiziale sulle clausole contrattuali Ai sensi del nuovo art. 420-bis del cod. proc. civ., quando per la definizione di una controversia
individuale di lavoro è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa, fissando una successiva udienza in data non anteriore a 90 giorni. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza
4
impugnata entro 20 giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.
Poteri istruttori del giudice Rispetto al processo ordinario di cognizione, in cui sono le parti a dare impulso all'attività istruttoria,
nel processo del lavoro il giudice ha ampi poteri istruttori. In particolare, in virtù dell'art. 421, cod. proc. civ., il giudice può: - indicare alle parti in ogni momento le irregolarità sanabili degli atti onde assegnare un termine per
rimediarvi, salvi gli eventuali diritti quesiti; - disporre d'ufficio in ogni momento l'ammissione di ogni mezzo di prova - ad eccezione del
giuramento decisorio - anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile; - richiedere alle organizzazioni sindacali informazioni attinenti l'oggetto della causa (art. 425, cod.
proc. civ.); - disporre su istanza di parte l'accesso sul luogo di lavoro, semprechè necessario al fine di accertare i
fatti, e, se lo consideri utile, l'esame dei testimoni sul luogo stesso; - ordinare la comparizione delle parti per interrogarle liberamente, e avvalersi di dichiarazioni rese
da persone che, secondo le norme processuali generali (art. 246 e 247, cod. proc. civ.), non potrebbero essere sentite, valutandole liberamente per trarre da esse ulteriori e integrativi elementi da utilizzare nel complesso del materiale probatorio acquisito;
- autorizzare, ex art. 422, cod. proc. civ., la sostituzione della verbalizzazione del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni dei testimoni e delle audizioni di parti o consulenti;
- se la natura della controversia lo richiede, nominare, ex art. 424, cod. proc. civ., uno o più consulenti tecnici.
Limiti al potere di controllo del giudice La legge n. 183/2010 ha previsto dei limiti al potere di controllo giudiziale in tema di: - clausole generali; - qualificazione del contratto di lavoro ed interpretazione delle sue clausole; - valutazione delle motivazioni poste alla base del licenziamento e del risarcimento danni in caso di
suo annullamento. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'art. 409 cod. proc. civ.
contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente (art. 30, comma 1, L. n. 183/2010).
Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione (art. 30, comma 2, L. n. 183/2010).
Infine, nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice deve tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione. Inoltre, nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice deve tener egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento (art. 30, comma 3, L. n. 183/2010).
Pagamento di somme in corso di causa Nel rito del lavoro, stante il disposto dell'art. 423, cod. proc. civ., il giudice, su istanza di qualsiasi
parte, in ogni stato del giudizio, può disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate. La giurisprudenza ha chiarito in proposito che la sola contumacia del convenuto non è sufficiente perchè l'attore ottenga l'ordinanza di pagamento, in quanto a tal fine è necessario che il giudice disponga di elementi di valutazione che gli permettano di convincersi che il credito preteso, in tutto o in parte, non sia stato contestato.
5
Benchè vi sia stata contestazione, su istanza del solo lavoratore il giudice può comunque disporre
con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti dell'ammontare per cui ritiene raggiunta la prova.
Tali ordinanze costituiscono titolo esecutivo, pur essendo provvedimenti emessi a cognizione sommaria e con finalità cautelari, privi di decisorietà e revocabili con la sentenza che definisce la causa.
Riunione di cause connesse Nel processo del lavoro la riunione dei procedimenti relativi a cause connesse anche solo per identità
delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere disposta dal giudice, salvo che ciò renda troppo gravoso o ritardi eccessivamente il processo (art. 151, disp. att. cod. proc. civ.). In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è comunque disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase procedurale.
Modifica di domande, eccezioni, conclusioni Nel corso del giudizio le parti, se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice,
possono, ex art. 420, comma 1, cod. proc. civ., modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate.
I "gravi motivi" che possono consentire l'"emendatio libelli" possono essere desunti dal comportamento delle parti e:
- possono consistere, (ad esempio), nella scoperta di circostanze o documenti prima ignorati o nell'intervento nelle more del giudizio di norme retroattive o sentenze d'illegittimità costituzionale;
- non possono mai dipendere dalla negligenza della parte.
4. pronunzia della sentenza Per i giudizi instaurati dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, che ha, fra
l'altro, modificato l'art. 429, comma 1, cod. proc. civ., il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice può dare in udienza lettura del solo dispositivo, fissando nello stesso un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.
Per i giudizi instaurati antecedentemente alla data del 25 giugno 2008, il giudice continuerà a dare lettura del solo dispositivo e a depositare successivamente in cancelleria il testo della sentenza.
Al successivo comma 2 dell'art. 429 cod. proc. civ., è previsto che, se lo ritenga necessario, su richiesta delle parti, il giudice, terminata l'istruzione, anzichè procedere alla discussione, concede loro un termine per il deposito di note difensive e rinvia la causa a nuova udienza, per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice peraltro può anche emettere ad istanza di parte: - una sentenza non definitiva, vale a dire una sentenza che disponga su una questione preliminare o
pregiudiziale (es. competenza, legittimazione ad agire, etc.) senza però definire il giudizio; - una sentenza di condanna generica che presuppone l'instaurazione di un ulteriore giudizio per la
determinazione degli specifici contenuti della condanna non determinabili in base a semplici calcoli aritmetici.
Rivalutazione dei crediti di lavoro Il giudice, quando condanna al pagamento di una somma di denaro in favore del lavoratore, deve,
secondo l'art. 429, comma 3, cod. proc. civ., determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno da svalutazione monetaria del credito, con decorrenza dal giorno di maturazione del diritto.
Liquidazione equitativa Qualora sia certo il diritto ma non l'ammontare dello stesso, questo, in base all'art. 432, cod. proc.
civ., può essere liquidato dal giudice equitativamente.
6
Deposito della sentenza La sentenza per esteso - comprensiva cioè della motivazione oltre che del dispositivo - è resa
pubblica, ex art. 430, cod. proc. civ., mediante deposito nella cancelleria entro 15 giorni dalla lettura del dispositivo. Di ciò il cancelliere dà alle parti immediata comunicazione.
La sentenza di primo grado è appellabile dalla parte soccombente a meno che il valore della controversia non sia inferiore a 25,82 (art. 440, cod. proc. civ.).
Efficacia esecutiva della sentenza di condanna a favore del lavoratore In conformità dell'art. 431, comma 1, cod. proc. civ., la sentenza di condanna di primo grado a
favore del lavoratore per crediti derivanti dal rapporto di lavoro o dagli altri rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. è provvisoriamente esecutiva, sin dalla data della lettura del dispositivo; vale a dire che, come specificato al comma 2 dello stesso articolo, all'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
A decorrere dal 1º gennaio 1993, tale esecutorietà è stata estesa anche alle sentenza di condanna in favore del datore di lavoro.
Sospensione dell'esecutorietà I successivi commi dell'art. 431, cod. proc. civ., sanciscono che il giudice d'appello può disporre
totalmente o parzialmente - con ordinanza non impugnabile - la sospensione dell'esecuzione promossa dal lavoratore (c.d. azione inibitoria), quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno e semprechè, il processo esecutivo sia effettivamente iniziato (cioè vi sia stato il pignoramento ex artt. 491 e 492, cod. proc. civ.).
L'esecuzione comunque resta autorizzata nei limiti di 258,23 (lire 500.000). Nel caso di condanna in favore del datore di lavoro, l'esecuzione può invece essere sospesa quando
ricorrano gravi motivi.
5. Impugnabilità della sentenza di primo grado Ai sensi dell'art. 433, cod. proc. civ., la sentenza di primo grado del tribunale in funzione di giudice
del lavoro - ivi compresa, come si evince dall'art. 340, cod. proc. civ., quella non definitiva o generica - può essere impugnata dalla parte soccombente con ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro, secondo i termini perentori comuni alla generalità delle impugnazioni civili e cioè:
- se la sentenza è stata notificata, entro 30 giorni dalla data di notificazione (artt. 325 e 326, cod. proc. civ.);
- se non è stata notificata, entro un anno dalla data del deposito della stessa presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata (art. 327, comma 1, cod. proc. civ.).
L'inutile decorso di tali termini comporta il passaggio in giudicato della sentenza. Al riguardo va tenuto presente che nel rito speciale del lavoro i termini processuali - ivi compresi
quelli di impugnazione - non si sospendono durante il periodo feriale.
Acquiscenza alla sentenza In ogni caso, la sentenza non può essere impugnata se la parte soccombente vi abbia fatto
"acquiscenza", cioè, secondo il dettato dell'art. 329, cod. proc. civ., l'abbia espressamente accettata, ovvero abbia compiuto atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.
6. Giudizio d'appello L'appello si propone con ricorso che, a norma dell'art. 434, comma 1, cod. proc. civ., deve contenere,
oltre alle indicazioni prescritte per il ricorso in primo grado dall'art. 414, cod. proc. civ., l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici di impugnazione.
Appello con riserva dei motivi Qualora la parte vincitrice in primo grado abbia iniziato l'esecuzione forzata della sentenza prima
della notificazione della stessa per esteso (cioè comprensiva della motivazione), la parte soccombente
7
può, in virtù dell'art. 433, comma 2, cod. proc. civ., impugnarla immediatamente, riservandosi di presentare i motivi d'appello entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della sentenza così impugnata; la giurisprudenza considera la omessa presentazione dei motivi riservati come tacita volontà di rinunciare all'impugnazione stessa.
Deposito del ricorso in appello Il ricorso deve essere depositato, ex art. 434, comma 2, cod. proc. civ., nella cancelleria della corte di
appello competente nel rispetto dei termini illustrati al p. 5. L'art. 435, ai commi 1-3, dispone che entro 5 giorni dal deposito del ricorso in appello il presidente
della corte di appello fissa l'udienza di discussione a non oltre 60 giorni dalla data del deposito stesso con decreto generalmente apposto in calce al ricorso stesso; entro dieci giorni successivi al deposito del decreto - termine ordinatorio - e almeno 25 giorni - termine perentorio - prima della data dell'udienza stessa , l'appellante deve notificare all'appellato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza.
Costituzione dell'appellato Almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione - termine anch'esso perentorio - l'appellato, a
norma dell'art. 436, commi 1 e 2, deve costituirsi in giudizio, depositando in cancelleria il fascicolo di parte del primo grado e una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta la dettagliata esposizione di tutte le sue difese.
Appello incidentale Il comma 3 del citato art. 436 prevede poi che, se intende proporre appello incidentale, l'appellato
deve farlo, a pena di decadenza, nella stessa memoria di costituzione, in cui vanno esposti i motivi specifici su cui si fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere notificato all'appellante almeno 10 giorni - termine perentorio - prima dell'udienza di discussione. E' ammesso anche l'appello incidentale tardivo - cioè presentato oltre i termini per impugnare la sentenza - se l'interesse a proporlo discenda direttamente dalla proposizione dell'impugnazione principale.
Svolgimento del giudizio di appello La trattazione della causa in appello avviene generalmente nell'udienza di discussione della causa
stessa davanti alla corte di appello. Stante il disposto dell'art. 437, commi 2 e 3, cod. proc. civ., nel grado di appello non sono ammesse
nuove domande e nuove eccezioni a meno che ricorrano gravi motivi e vi sia l'autorizzazione del giudice. In grado d'appello non sono altresì ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio,
salvo che la corte di appello li ritenga indispensabili per la decisione della causa. E' comunque sempre salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.
In base al comma 4, qualora vengano ammesse nuove prove, il Collegio fissa, entro 20 giorni, l'udienza nella quale debbono essere assunte e nella quale deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso, con la stessa ordinanza, il Collegio può ordinare, ex art. 441, comma 1, il pagamento di somme che risultino non contestate oppure di somme per le quali ritenga già sufficientemente provato il diritto (art. 423, cod. proc. civ.).
Il Collegio nell'udienza di discussione può altresì nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza a non oltre 30 giorni; il consulente deve depositare il proprio parere, ex art. 441, comma 2, almeno 10 giorni prima della nuova udienza.
Pronunzia della sentenza In conformità dell'art. 437, comma 1, cod. proc. civ., al termine dell'udienza di discussione il
Collegio pronuncia sentenza dando contestualmente lettura del dispositivo. La sentenza d'appello di condanna è esecutiva, e nel caso che sia favorevole al lavoratore, l'esecuzione è consentita anche sulla sola base del dispositivo e in pendenza del termine per il deposito della sentenza stessa.
8
7. Impugnabilità della sentenza d'appello
L'impugnazione delle sentenze d'appello con ricorso per cassazione e l'eventuale successiva fase di rinvio sono regolate dalle norme del giudizio ordinario (artt. 360-394 cod. proc. civ.).
In particolare, ex art. 360, cod. proc. civ., il ricorso in cassazione è ammesso: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione di norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali
di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Revocazione e opposizione di terzo Analogamente, alla revocazione e all'opposizione di terzo contro le sentenze in materia di lavoro si
applicano le norme del giudizio ordinario (artt. 395-408 cod. proc. civ.).
1
1
Il LICENZIAMENTO NEL Collegato lavoro
Legge 183/2010
G.U. n.243 del 9.11.2010
2
COLLEGATO LAVORO
ENTRATO IN VIGORE IL
24.11.2010
2
3
COLLEGATO LAVORO
50 ARTICOLI
NORME CON FUNZIONI DI LEGGE DELEGA
NORME IMMEDIATAMENTE PRECETTIVE
4
CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO
Art. 23 32 30 (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)
1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all articolo 409 del codice di procedura civile e all articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell ordinamento, all accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsidalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
]Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, [oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell oggettivo interesse dell organizzazione], delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
4. (VEDI SUCCESSIVE SLIDES)
5 (VEDI SUCCESSIVE SLIDES)
6. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3
5
CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO
Comma 1
1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui:- art.409 c.p.c. (lavoro subordinato e parasubordinato)- Art.63, comma 1, D.Lgs n. 165/2001 (lavoratori dipendenti del pubblico impiego),
contengano clausole generali, (norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso)
il controllo giudiziale solo peraccertamento del presupposto di legittimità
No sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive (art.41 cost.).
Lo diceva già la giurisprudenzaTra tutte: Cass. civ., Sez. lavoro, 04/11/2004, n.21121
6
CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO
Comma 3
Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento
il Giudice
tiene conto
- fondamentali regole del vivere civile- oggettivo interesse dell organizzazione- tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi - tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione.
CHE VUOL DIRE: TIENE CONTO ?
LO IMPEGNA O NO AL RISPETTO DELLE CLAUSOLE ?ELIMINATE
NELL ULTIMO ESAME DELLE CAMEREDOPO LA CENSURA PDR
4
7
CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO
Comma 3, (2° periodo)
Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell art. 8 della legge 604/1966 (da 2,5 a 6 mensilità, ovvero fino a 10 o 14 in alcuni casi)
di elementi e di parametri fissatidai contratti collettivi
ed individuali
le dimensioni della struttura del datore di lavoro
condizioni dell attività esercitata dal datore di lavoro
la situazione del mercato del lavoro locale
l anzianità del lavoratore
le condizioni del lavoratore
il comportamento delle parti anche prima del licenziamento
Il Giudice
Tiene conto
considera
8
DECADENZA IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO
Art. 25. 34 32(Decadenze)
Il primo e il secondo comma dell articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dal seguente:
«Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l intervento dell organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento
stesso».
però
Vedi slide successiva
5
9
DECADENZA IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO
L impugnazione nei 60 gg. è inefficace se entro i successivi 270 gg. non si:
1) deposita il ricorso2) non si chiede il tentativo di conciliazione o arbitrato (*)
(*) in questo secondo caso il ricorso deve essere presentato entro 60 gg. dal rifiuto o mancato accordo
10
DECADENZA IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTOLe disposizioni in materia di decadenza si applicano a tutti i
casi di:invalidità del licenziamento
E per il licenziamento inefficace ?E per i licenziamenti collettivi ?
Il licenziamento è inefficace se manca la forma scritta.
Se però manca la forma scritta = NO decadenza se non si impugna nei 60 gg. (la legge fa partire i 60 gg. dalla comunicazione scritta: art.32, comma 1)
segue
Anche i licenziamenti NULLI ?
6
11
DECADENZA PER ALTRE CAUSE DI CONTENZIOSO
I termini di decadenza sopra richiamati, si applicano inoltre:a) ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) all azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ai sensi degli artt.1, 2 e 4 del D.Lgs 368/2001, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
12
DECADENZA PER ALTRE CAUSE DI CONTENZIOSO
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge.
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l ipotesi prevista dall articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
1
IL CONTENZIOSO CON IL LAVORATORE IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Quando si può licenziare ?. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, della legge 604/19661 e salvi i pochi casi di libera recedibilità il datore di lavoro non
può licenziare il lavoratore se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo o di giustificatezza (nel
caso di dirigente).
Quindi il licenziamento è possibile in caso di
- 1) giusta causa
- 2) giustificato motivo
- 2.1. soggettivo
- 2.2. oggettivo
- 4) libera recedibilità (laddove permessa), ovvero giustificatezza , per i dirigenti
1) Licenziamento per giusta causa
Ai sensi di quanto previsto dall art. 2119, cod. civ., il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro senza
preavviso nel momento in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche solo provvisoria del
rapporto.
Nozione di giusta causa
Secondo la nozione elaborata dalla giurisprudenza costituisce giusta causa di licenziamento ogni fatto o comportamento
- anche diverso dall'inadempimento contrattuale - obiettivamente idoneo a far venir meno il vincolo fiduciario tra datore di
lavoro e lavoratore che costituisce il presupposto essenziale della collaborazione e, quindi, della sussistenza del
rapporto di lavoro subordinato.
Analisi del caso concreto per accertare la giusta causa
Ai fini dell'accertamento della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza ha escluso la
possibilità di un giudizio in astratto circa l'idoneità del fatto contestato al lavoratore ad incidere sul vincolo fiduciario del
rapporto di lavoro.
1 Lart. 1 della legge n. 604/1966 statuisce che nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercorrente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norma di legge, di regolamento o di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può che avvenire per giusta causa ai sensi dell art. 2119 c.c. o per giustificato motivo"
2
La Cassazione ha infatti stabilito che occorre valutare, caso per caso, la qualità del rapporto intercorso tra le parti (a
seconda dell'inquadramento e delle mansioni affidate al lavoratore) e lo specifico comportamento posto in essere dal
dipendente (a seconda della sua gravità e della sussistenza dell'elemento doloso o colposo dell'agente).
In effetti un fatto può incidere irreparabilmente sul vincolo fiduciario se imputabile ad un impiegato con funzioni direttive,
può risultare meno grave se commesso da un addetto alle pulizie, per il quale tale vincolo non è di regola altrettanto
intenso.
E però vero che l esperienza pluriennale ha ormai coniato una serie di fatti comportamentali che per giurisprudenza
consolidata tendono ad evidenziare o meno la sussistenza della giusta causa
Rilevanza di fatti estranei all'attività lavorativa
Sempre secondo la giurisprudenza i comportamenti del lavoratore estranei all'attività lavorativa possono costituire giusta
causa di licenziamento solo se - per la loro natura e gravità - evidenziano obiettivamente l'inaffidabilità professionale del
lavoratore a svolgere le specifiche mansioni alle quali è stato assegnato. (Cass. 27/12/1999, n. 14567; Cass.
22/05/1995, n. 5742; Cass. 22/03/1994, n. 2715). In altri termini, può riscontrarsi una giusta causa di licenziamento
anche in un evento extra
lavorativo, laddove questultimo
in relazione alla natura e alla qualità del rapporto, al livello
di affidamento che esso richiede e al tipo di mansioni
sia in grado di riflettersi negativamente sulle attitudini
professionali del lavoratore (Cass. 27/01/2004 n. 1475; Cass. 10/12/2002, n. 17562; Cass. 27/08/2002, n. 12577; Cass.
26/05/2001, n. 7192).
Un caso tipico in tal senso è quello che è avvenuto più volte nel settore bancario, nel quale si è ritenuto legittimo il
licenziamento del dipendente responsabile di una fattispecie di reato, commessa in ambito extralavorativo (Cass.
23/05/1992, n. 6180; Cass. 3/10/1988, n. 5321), valorizzando l affidamento riposto nella correttezza e lealtà dei
dipendenti non solo dal datore di lavoro, ma anche dalla generalità del pubblico2.
Ma se ad esempio, la condanna per furto compiuto fuori dal lavoro potrebbe integrare gli estremi della giusta causa di
licenziamento nei confronti di un cassiere di banca non trova applicabilità per un addetto alle pulizie.
Parimenti la cassazione ha previsto la possibilità di valutare ai fini del licenziamento la rilevante esposizione debitoria
nei confronti di terzi del dipendente di un istituto bancario, in violazione di una direttiva del datore di lavoro.
Sulla tenuità o meno del danno provocato dal lavoratore
Le ultime tendenze a livello giurisprudenziale stabiliscono che, ai fini della sussistenza di una giusta causa di
licenziamento non è necessario che il lavoratore abbia provocato un danno patrimoniale di rilevante entità al suo datore
di lavoro, nè che un danno si sia in concreto verificato, essendo, invece, sufficiente un mero pericolo obiettivo di danno.
Quello che conta è quindi che si sia leso il vincolo fiduciario, valutabile non tanto rapportandolo al valore patrimoniale del
pregiudizio eventualmente subito, bensì all incidenza del fatto sull affidamento futuro (Cass. 23/06/1998, n. 6216; Cass.
23/08/1996, n. 7768; Cass. 11/2/1995, n. 1505; Cass. 18/11/1994, n. 9773; Cass. 16/6/1994, n. 5843; Cass. 23/05/1992,
n. 6180).
2 Si è altresì sostenuto che la condotta del lavoratore, oltre a dover rispondere agli assunti obblighi contrattuali di diligenza e di fedeltà, può assurgere a modello diseducativo per la specifica posizione professionale e di responsabilità nel servizio svolto, disincentivando al rispetto di detti obblighi nei confronti degli altri dipendenti, eventualmente a lui sottordinati, posti alla base del rapporto fiduciario (Cass. n. 17208 del 4/12/2002).
3
Ai fini della concreta individuazione delle fattispecie che possono dar luogo a giusta causa di licenziamento, stante
l assenza di una elencazione specifica e tipologica contenuta nell art.2119 cod.civ., ha sopperito la contrattazione
collettiva la quale ha proceduto ad una tipizzazione di tali ipotesi.
Resta il dubbio però se il giudice, qualora chiamato a valutare la legittimità del licenziamento, debba limitarsi a recepire
le disposizioni del CCNL oppure se possa verificare la corrispondenza tra le ipotesi tipizzate contrattualmente e la
definizione legale di giusta causa.
Esiti del giudizio penale e giusta causa.
Muovendosi su piani separati si ritiene che il datore di lavoro che contesti al dipendente la commissione di un reato non
debba necessariamente attendere la sentenza di condanna del giudice penale per l'intimazione del licenziamento.
Fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'azienda
Non costituisce giusta causa di licenziamento il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa
dell'impresa che, al più, possono rilevare ai fini della sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento.
Onere della prova
Ovviamente, l 'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al
datore di lavoro. (art. 5, Legge n. 604/1966).
Licenziamento per giusta causa e Licenziamento disciplinare
Il licenziamento per giusta causa può assumere la natura di licenziamento disciplinare ma è altrettanto vero che può
esservi un licenziamento per giusta causa non di tipo disciplinare (esempio per carcerazione del lavoratore). Il
licenziamento per g.c. assume le connotazioni di licenziamento disciplinare ogniqualvolta sia stato intimato in relazione
alla violazione da parte del lavoratore degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Laddove si verta in tale ambito il recesso deve essere intimato, pena l'illegittimità, con l'osservanza della procedura
prevista dall'art. 7, Legge. n. 300/1970.
A tal riguardo è bene anche aver riferimento alle previsione della contrattazione collettiva.
4
2) Licenziamento per giustificato motivo
In presenza di un rapporto a tempo indeterminato il datore di lavoro può, in presenza di un giustificato motivo, licenziare
il lavoratore, nel rispetto del periodo di preavviso.
Il giustificato motivo può assumere due differenti varinti:
a) giustificato motivo soggettivo: in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del
prestatore di lavoro.
b) giustificato motivo oggettivo, generato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al
regolare funzionamento di essa
Il giustificato motivo soggettivo. Presupposti
Secondo la giurisprudenza costituisce giustificato motivo soggettivo di licenziamento il comportamento del lavoratore
che sia - anche solo potenzialmente - tale da arrecare grave pregiudizio al datore di lavoro e che si traduca nella
obiettiva - e cioè a prescindere dalla valutazione soggettiva del datore di lavoro - impossibilità di un ragionevole
affidamento di una gestione corretta delle mansioni affidate al prestatore di lavoro.
Si tratta secondo alcuni, tra cui si associa anche chi scrive, di una sorta di mini giusta causa o di una giusta causa
affievolita , da cui fermo restando la sussistenza della sua natura disciplinare, comporta il rispetto del periodo di
preavviso o l erogazione della indennità sostitutiva nei confronti del lavoratore e non il recesso in tronco .
Ovviamente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto intimato in relazione ad un inadempimento del
lavoratore e quindi riconducibile alla natura disciplinare deve essere intimato con l'osservanza della procedura di cui
all'art. 7, Legge n. 300/1970 (vedasi anche lo schema precedentemente esposto).
Da ultimo si ricorda che in sede processuale, viene ammessa la conversione del licenziamento
intimato per giusta
causa, poi ritenuta insussistente, in un recesso per giustificato motivo soggettivo, da cui deriva il solo diritto del
lavoratore all indennità per mancato preavviso. Ovviamente ciò è possibile solo qualora i motivi addotti a giustificazione
del recesso sono i medesimi e siano in ogni caso legittimi ad escludere il lavoratore, pur se ammettendolo al beneficio
del preavviso e non sottoponendolo alla risoluzione in tronco.
Il giustificato motivo oggettivo. Presupposti
Stante la definizione sibillina e troppo generica offerta dalla legge ( ragioni inerenti all'attività produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa ) la giurisprudenza è stata chiamata a ricostruire la
ratio legis arrivando alle seguenti conclusioni che vedono il licenziamento giustificato qualora si verifichino due
condizioni:
1.che il recesso sia stato generato da obiettive esigenze organizzative o produttive aziendali;
5
2. che il lavoratore licenziato non possa essere reimpiegato in altro settore aziendale (c.d. "obbligo del repechage").
Inoltre la giurisprudenza ha ritenuto che:
- si configura giustificato motivo oggettivo non solo in caso di modifiche strutturali e organizzative, ma anche laddove
sussista la necessità di ridurre i costi di esercizio eliminando l'onere eccessivamente gravoso costituito da un numero
esuberante di dipendenti;
- non dovrebbero essere vincolanti ai fini della scelta del lavoratore da licenziare per giustificato motivo oggettivo
eventuali situazioni personali del lavoratore quali, ad esempio, il carico di famiglia o l'anzianità di servizio;
Nella prassi, quindi i motivi della risoluzione del rapporto sono essenzialmente riconducibili ai processi di riassetto
organizzativo, da indicare nella lettera di licenziamento3, finalizzati a raggiungere una maggiore economicità ed
efficienza nella gestione dei processi aziendali.
Il g.m.o. è però integrato anche per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore.In tale ipotesi di giustificato motivo la
giurisprudenza è solita ritenere che la sussistenza dello stesso prescinda - a differenza degli altri casi di licenziamento
per giustificato motivo oggettivo - dalla impossibilità o meno di riutilizzare il lavoratore in mansioni diverse. In sostanza
non sarebbe richiesto il repechage, né è chiesto che il datore di lavoro modifichi ed adegui la propria struttura aziendale
per mantenere il posto al lavoratore .
Si ricorda che, ai sensi di quanto stabilito dall art.41 della Costituzione, nel caso di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo il giudice, una volta dimostrate dal datore di lavoro le circostanze che ne giustificano la fattispecie e valutato
che non via discordanza tra la situazione di fatto e quella invocata a sostegno della decisione di risolvere il rapporto,
non può sindacare l'opportunità delle scelte organizzative effettuate dall'imprenditore che sono "a monte"
dell'intimazione del licenziamento stesso (es. la scelta di terziarizzare
la gestione contabile del personale ad un C.d.l.
che ha condotto al licenziamento dell impiegato addetto alle paghe)4. (cfr Cass. 29/3/2001 n. 4670 in Rep. Giur. Lav
2000-2001, pag. 347, mass. 76; Cass. 19/3/2001 n. 3905 in Rep. Giur Lav. 2000-2001, pag. 346, mass. 70; Cass.
14/9/95 n. 9715 in Il Lav. nella Giur.1996, pag. 426).
La Giurisprudenza ha incluso nell ipotersi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo la specifica fattispecie della
soppressione del posto di lavoro
(cfr. Cass. 15/11/1993 n. 11241 in Riv. It Dir. Lav. 1994 pag. 766; Trib Milano 4/6/94 in
Riv. It. Dir. Lav. 1995, pag. 614; Cass. 14/6/2000 n. 8135 in Not. Giur. Lav. 2000 pag. 747; Trib Cuneo in Giurisprudenza
Piemontese 1995, pag. 54; Pretura di Torino in Giurisprudenza Piemontese 1995, pag. 54).
Peraltro ai fini della soppressione del posto di lavoro, integrante giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non è
necessario che vengano soppresse tutte le mansioni
in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le
stesse essere solo diversamente ripartite
ed attribuite secondo insindacabili scelte imprenditoriali relative
all organizzazione aziendale, senza che con ciò venga meno l effettività di tale soppressione (cfr. Cass. 23/8/2000 n.
11028 in Rep. Giur. Lav. 2000-2001, pag. 343, mass. n. 61; Cass. 14/6/2000 n. 8135 in Rep. Giur. Lav. 1999 - 2000,
pag. 342, mass. 75, Cass. 15/11/93 n. 11241 in Riv. It Dir. Lav. 1994, II, pag. 766).
In conclusione va rilevato che secondo la giurisprudenza (cfr. fra tutte Cass. 9.07.2001, n. 9310)
è necessario un
nesso tra licenziamento ed esigenza aziendale,
precisando che quando tale nesso, da giudicare caso per caso, non sia
rilevabile si può ricondurre il licenziamento ad un atto arbitrario del datore di lavoro. In particolare, ad avviso del
Supremo Collegio, nel caso di specie la norma in oggetto era stata interpretata in sede di merito con eccessiva rigidità
3 Cfr, i relativi modelli ai par. 5.2 e 5.3 4 E infatti pacifico che, in conformità alle più ampie garanzie costituzionali sancite dall art. 41 della
Costituzione, il potere di iniziativa imprenditoriale comprende non solo il diritto di creare un impresa, ma anche quello di ristrutturarla ed estinguerla.
6
nel senso che la medesima consentirebbe il licenziamento solo per far fronte a circostanze sfavorevoli che impongano
una riduzione dei costi, mentre - stante il principio di libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41 Costituzione - il
controllo giudiziale sulla legittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo deve essere limitato alla
esistenza e non pretestuosità dei motivi addotti dall'imprenditore e non può estendersi al sindacato sulla validità dei
criteri di gestione dell'impresa. Peraltro, il licenziamento sarebbe legittimo non solo per ridurre i costi in un frangente
economico sfavorevole, ma anche in presenza di reali esigenze organizzative che comportino la necessità di mantenere
il profitto attraverso una migliore organizzazione della forza lavoro. In ogni caso le ragioni inerenti all'attività produttiva,
all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa possono essere le più diverse e non solo quelle
dirette a fronteggiare situazioni sfavorevoli. Più nel dettaglio, le ragioni inerenti all'attività produttiva - sia che derivino da
esigenze di mercato ed attengano perciò a motivi estranei alle determinazioni imprenditoriali, sia che conseguano invece
a riorganizzazioni o ristrutturazioni operate dall'imprenditore (quali ne siano le finalità, comprese quelle dirette alla
introduzione di innovazioni produttive ovvero al risparmio di costi o all'incremento dei profitti) - devono essere, nella loro
oggettività, tali da determinare il venire meno della posizione lavorativa; ciò si verifica quando la prestazione divenga
inutilizzabile a causa della diversa organizzazione.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quindi, non può trovare la sua legittimazione solo in un momento di
grave crisi economica, bensì in tutti i casi in cui sia avvertita la necessità di una oggettiva modifica organizzativa
nell ambito dell azienda.
Onere di repechage A carico del datore di lavoro opera, però, il cosiddetto onere di repechage, per cui
prima di procedere al recesso - egli
deve verificare l esistenza in seno all azienda di posti di lavoro o attività a cui il prestatore possa essere ancora
effettivamente addetto, in coerenza con le professionalità di cui dispone (cfr. Cass. 2/4/87 n. 3198 in Mass. Foro It.
1987, pag. 545; Cass. 14/9/95 n. 9715 in Il Lav. nella Giur. 1996, pag. 424, Trib. Milano 30/10/2000 in Or. Giur. Lav.
2000, pag. 1051).
A tal riguardo, in particolare per soppressione del reparto cui sono addetti i lavoratori licenziati, fino a qualche mese fa la
Corte di Cassazione aveva sancito che la verifica della possibilità di "repechage" va fatta con riferimento a mansioni
equivalenti; ove i lavoratori abbiano accettato mansioni inferiori onde evitare il licenziamento, la prova dell'impossibilità di
"repechage" va fornita anche con riferimento a tali mansioni, ma occorre, in quest'ultimo caso, che il patto di
demansionamento sia anteriore o coevo al licenziamento, mentre esso non può scaturire da una dichiarazione del
lavoratore espressa in epoca successiva al licenziamento e non accettata dal datore di lavoro, specie se il lavoratore
abbia in precedenza agito in giudizio deducendo l'illegittimità del licenziamento. (Cass. civ., Sez. lavoro, 18/03/2009, n.
6552). Recentemente, sullo stesso punto la Cassazione ha ritenuto che la verifica, ai fini del repechage, vada assolta
anche valutando se vi sono mansioni inferiori, nel senso che deve avere prospettato al lavoratore licenziato, senza
ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale,
purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito
dall imprenditore (Cass. 13.08.2009 n.21579)
Inoltre, facendo riferimento ad una ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo quale conseguenza della
chiusura di una filiale, incombe in capo al datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilità di impiegare altrimenti il
dipendente, magari perché tutti i posti sono stabilmente assegnati. L'obbligo di dimostrare l'impossibilità di impiego del
licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale va comunque tenuto entro i limiti della ragionevolezza e il compito
deve considerarsi assolto anche quando è svolto ricorrendo a risultanze di natura presuntiva e indiziaria. Spetta, invece,
al dipendente l'onere di dedurre e di allegare la possibilità di "repechage" da parte della azienda. (Cass. civ., Sez.
lavoro, 19/02/2008, n. 4068).
7
Invece nel caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore essa integra un giustificato motivo oggettivo di
recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa
attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già
assegnate, o ad altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile
nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Peraltro, nel bilanciamento di
interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32, 36 Cost.), sostiene la Cassazione (Cass. 28 ottobre 2008, n.25883) non
può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche
delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute
del lavoratore.
Giustificato motivo oggettivo e giustificatezza
E noto che il licenziamento del dirigente non soggiace alle normali regole sulla sussistenza del giustificato motivo ma
richiede, per la sua legittimità, il solo presupposto della giustificatezza .
In considerazione di quanto sopra è opportuno precisare che la nozione di giustificatezza del licenziamento del
dirigente, posta dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento di
cui all art. 3 della Legge n. 604/1966, nel senso che l area di applicazione della giustificatezza è più ampia di quella di
quella insita nelle nozioni di giusta causa e di giustificato motivo (cfr. Cass. 5.10.2002 n. 14310), finendo
sostanzialmente con il comportare solo un dovere, per il datore, di rispettare i principi di correttezza e buona fede; ne
deriva che non è giustificato il licenziamento mosso da motivazioni puramente pretestuose e alle soglie della
discriminazione (Cass. n. 13839 del 8.11.2001). In sede di merito, si è ribadito che nel caso di licenziamento di un
dirigente la nozione di giustificatezza del licenziamento risulta notevolmente meno rigida di quella di cui agli artt. 2119
c.c. e di cui all art. 3 Legge n. 604/66,
in particolare essendole estranei i caratteri di extrema ratio attribuiti dalla
giurisprudenza al giustificato motivo oggettivo, con il conseguente obbligo di repechage
(Cass. civ., Sez. lavoro,
11/06/2008, n. 15496, Pret. Milano 22.11.1993; Trib Roma 6.7.1999).
Ne consegue che la suddetta giustificatezza non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della
continuazione del rapporto di lavoro e con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o
particolarmente onerosa tale prosecuzione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il
parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con quello di iniziativa economica,
garantita dal citato art.41 cost. che verrebbe realmente negata ove si impedisse all'imprenditore, a fronte di razionali e
non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti
livelli della gestione dell'impresa. In ogni caso, il recesso in questione non può risultare privo di qualsiasi giustificazione
sociale perché concretizzantesi unicamente in condotte lesive, nella loro oggettività, della personalità del dirigente e, al
fine di accertare la configurabilità del diritto del dirigente all'indennità supplementare di preavviso, l'ingiustificatezza del
recesso datoriale può evincersi da una incompleta o inveritiera comunicazione dei motivi di licenziamento ovvero da
un'infondata contestazione degli addebiti, potendo tali condotte rendere quantomeno più disagevole la verifica che il
recesso sia eziologicamente riconducibile a condotte discriminatorie ovvero prive di adeguatezza sociale.
Licenziamento per scarso rendimento.
E' legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento, qualora sia risultato provato, sulla scorta della
valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro,
8
una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza
dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente
realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività
tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione. Cass. civ., Sez.
lavoro, 22/02/2006, n.38765
Pertanto, nel caso in cui sia stato concordato nel contratto di lavoro un risultato minimo (come ad esempio i contratti con
i lavoratori che svolgono mansioni di produttori, propagandisti, agenti, ecc.) ed il minimo produttivo fissato rientri nelle
possibilità della media dei dipendenti di pari qualificazione professionale adibiti alle stesse attività e nelle medesime
condizioni ambientali,il mancato raggiungimento di quel risultato può integrare giustificato motivo di licenziamento se
dovuto a negligenza o irregolarità del dipendente.
Al di là di queste situazioni è sempre problematico (e rischioso viste le conseguenza sul piano sanzionatorio) invocare
un licenziamento per scarso rendimento
Giustificato motivo oggettivo e trasferimento dazienda.
Per espressa previsione di legge il trasferimento di azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento né per
giusta causa, né per giustificato motivo, in quanto trattasi di evento che non incide sul rapporto di lavoro, in quanto se è
vero comè vero che muta il titolare (elemento soggettivo) rimane immutata l azienda (elemento soggettivo). Ovviamente
lo stesso ragionamento va fatto anche per il trasferimento di ramo dazienda.
Onere della prova
Come nel caso della giusta causa, l'onere della prova della sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento spetta,
ex art. 5, Legge n. 604/1966, al datore di lavoro.
Differenza tra licenziamenti plurimi per g.m.o. e licenziamenti collettivi.
E una differenza prettamente quantitativa, atteso che le ragioni sottese ai due provvedimenti possono essere le
medesime.
I licenziamenti collettivi ex art. 24 Legge 223/91 si distinguono dai licenziamenti individuali plurimi essendo caratterizzati
in base alla dimensione occupazionale dell'impresa (più di quindici dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno 15)
e all'arco temporale entro cui sono effettuati. Per conseguenza, nell'ambito di tale disciplina, non essendo più la ragione
addotta dall'imprenditore a differenziare il licenziamento ex L. n. 223 del 1991 dal licenziamento plurimo per g.m.o., una
volta accertati gli elementi costitutivi della fattispecie (e in particolare l'indicata connessione cronologica dei
licenziamenti, tutti determinati da ragioni inerenti l'impresa), ciò che assume rilievo è unicamente il mancato
espletamento dell'iter procedurale di cui all'art. 4, L. n. 223 del 1991 che comporta l'inefficacia del licenziamento e
l'applicazione dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, restando quindi improponibile l'ipotesi di una conversione del
licenziamento collettivo in licenziamento individuale.
5 Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata affermata la legittimità del recesso datoriale in relazione alla violazione dell'obbligo contrattuale di collaborazione da parte di un ispettore dipendente di una società assicurativa secondo i programmi di produzione e le direttive impartite, ravvisando la congruità della motivazione circa la valutazione delle risultanze acquisite comprovanti il notevole calo del rendimento nell'arco degli ultimi anni del rapporto di lavoro comparato in percentuale con quello dei colleghi e l'imputabilità dello scarso rendimento alla negligenza del lavoratore.
9
Anche il Ministero del lavoro con la circolare n.155/1991 il Ministero del lavoro ha ritenuto che non possono considerarsi
licenziamenti collettivi ma licenziamenti individuali plurimi per g.m.o., con conseguente disapplicazione delle disposizioni
di cui alla legge n. 223/1991, sostituite da quelle di cui alla legge n. 604 del 1966:
- i licenziamenti intimati in un arco di tempo superiore di 120 giorni;
- i licenziamenti che, pur rispondendo ai requisiti temporali e numerici previsti dal primo comma dell'art. 24 della legge n.
223 del 1991, non siano determinati da riduzione o trasformazione di attività o di lavoro bensì da un giustificato motivo
oggettivo, anche se l ipotesi della riduzione o trasformazione di attività o lavoro di cui all'art. 24 della legge n. 223 del
1991 ingloba di norma anche le fattispecie dei motivi attinenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al
regolare funzionamento di essa di ex art. 3 Legge 604 del 1966.
Il preavviso
Il datore di lavoro all'atto del licenziamento per giustificato motivo ha l'obbligo - a norma dell'art. 2118, cod. civ. - di dare
un periodo di preavviso, mentre ciò non è previsto per i casi di licenziamento per giusta causa. 6
La legge stabilisce per gli impiegati la durata minima del periodo di preavviso (v. art. 10, comma 1, R.D.L. n.
1825/1924).7
6 Va ricordato che in materia di licenziamento di dirigenti l'esonero dall'obbligo del preavviso o da quello alternativo del pagamento dell'indennità sostitutiva presuppone esclusivamente la giusta causa di licenziamento, nozione non sovrapponibile a quella della giustificatezza del medesimo. Mentre la giusta causa consiste in un fatto che, in concreto valutato (e cioè sia in relazione alla sua oggettività, sia con riferimento alle sue connotazioni soggettive), determina una grave lesione della fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, tale da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto, tenuto conto altresì della natura di quest'ultimo ed il grado di fiducia che esso postula, la ricorrenza della giustificatezza dell'atto risolutivo, ancor più strettamente vincolata al carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale, è da correlare alla presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo come tali apprezzabili sotto profilo della correttezza, della buona fede, sicché non giustificato è il licenziamento per ragioni meramente pretestuose al limite della discriminazione, ovvero anche del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell'esercizio del diritto. Conseguentemente possono ricorrere le condizioni per non corrispondere l'indennità supplementare, in presenza della giustificatezza del licenziamento e non sussistere invece quelle per negare l'indennità sostitutiva di preavviso in assenza della giusta causa. Peraltro, un licenziamento intimato ad un dirigente per giusta causa, che risulti però, a seguito del giudizio instaurato dallo stesso lavoratore, privo della giusta causa invocata ma comunque "giustificato", da diritto al riconoscimento dell'indennità di preavviso, ma non dell'indennità supplementare di licenziamento, che spetta solo quando un licenziamento sia privo anche del requisito della giustificatezza . Cass. civ., Sez. lavoro, 27/05/2008, n. 13812.
7 Così recita l art.10 del RD 1825/1924: Il termine (di preavviso n.d.r.) di cui nell'articolo precedente, quando l'uso o la convenzione non li assegnino in misura più larga, sarà determinato nel modo seguente in caso di licenziamento da parte del principale: A) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i cinque anni di servizio: 1º mesi due di preavviso per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso o non esercenti esclusivamente in proprio: commessi viaggiatori per l'estero, direttori tecnici ed amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti; 2º mesi uno di preavviso per i commessi viaggiatori, direttori o capi di speciali servizi ed impiegati di concetto; 3º giorni quindici di preavviso per i commessi di studio e di negozio, assistenti tecnici e altri impiegati di grado comune. B) per gli impiegati che hanno raggiunto i cinque anni di servizio e non i dieci: 1º mesi tre di preavviso per la prima categoria; 2º giorni quarantacinque per la seconda categoria; 3º giorni trenta per la terza categoria. C) per gli impiegati che hanno raggiunto i dieci anni di servizio: 1º mesi quattro per la prima categoria; 2º mesi due per la seconda categoria; 3º giorni quarantacinque per la terza categoria.
10
Nella pratica la durata del periodo di preavviso è tuttavia stabilita, per la generalità dei dipendenti, dalla contrattazione
collettiva che la determina in funzione dell'anzianità di servizio e della categoria del lavoratore, introducendo di norma
termini di miglior favore.
Nulla vieta, naturalmente, che la durata del periodo di preavviso possa essere regolata anche da pattuizioni individuali
che prevedano periodi di preavviso più lunghi di quelli stabiliti nei contratti collettivi.
Il computo del periodo di preavviso deve avvenire in giorni lavorativi o di calendario, in base alle previsioni della
contrattazione collettiva. In mancanza di una specifica metodologia di computo nei contratti collettivi, secondo un
orientamento della giurisprudenza di merito, deve essere calcolato in base ai giorni di calendario e non in relazione alle
effettive giornate di lavoro.
Decorrenza
Il periodo di preavviso
Premesso che per gli impiegati il periodo di preavviso decorre per legge comunque dalla metà o dalla fine di ciascun
mese (vedasi art. 10, comma 2, R.D.L. n. 1825/1924), negli altri casi decorre dal momento in cui è pervenuta al
lavoratore la comunicazione del licenziamento, salvo diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi.
Licenziamento per raggiungimento dell'età pensionabile
Il preavviso spetta anche in caso di licenziamento dovuto al raggiungimento dell'età pensionabile intimato prima del
compimento di tale età, nel senso che esso decorre comunque dal raggiungimento da parte del lavoratore dell'età
pensionabile anche se nella lettera di licenziamento era stata prevista una decorrenza diversa ovvero sia stata inviata in
anticipo tale da comprendervi anche il preavviso contrattuale.
Rinuncia allo svolgimento del periodo di preavviso da parte del soggetto non recedente
La prevalente giurisprudenza ha ritenuto legittime le norme collettive che consentono alla parte non recedente
(lavoratore in caso di licenziamento, datore di lavoro in caso di dimissioni) di rinunciare allo svolgimento del periodo di
preavviso senza, con ciò, essere tenuta a corrispondere alla controparte la relativa indennità sostitutiva8.
Rispetto invece alla potestà a favore di chi recede di scegliere unilateralmente la monetizzazione del mancato preavviso
attraverso la prevista indennità sostitutiva esisteva un fronte di giurisprudenza teso a negare tale potere esigendo
l accettazione della parte non recedente (c.d. efficacia reale del preavviso). Vedi infra.
Oggi la giurisprudenza è schierata in senso opposto, nel senso di non riconoscere efficacia reale al preavviso, ma
obbligatoria, con la possibilità per il datore di lavoro di optare discrezionalmente per l indennità sostitutiva del preavviso.
Vedasi da ultimo recente sentenza n.22443 del 4.11.2010.
Sospensione del rapporto
La decorrenza del periodo di preavviso è sospesa qualora intervenga, durante il periodo stesso, una causa di
sospensione del rapporto di lavoro, come ad esempio malattia e infortunio.
8 Va da sé, in ogni caso, che il lavoratore e il datore di lavoro possono sempre, stipulando apposito accordo individuale, derogare alle disposizioni collettive e stabilire che la parte non recedente che rinuncia allo svolgimento del periodo di preavviso debba corrispondere alla parte recedente la relativa indennità sostitutiva.
11
Diritti ed obblighi delle parti durante il periodo di preavviso
Nel periodo compreso tra la comunicazione del licenziamento e la scadenza del termine di preavviso il rapporto
prosegue normalmente, cioè a dire che permangono tutte le reciproche obbligazioni delle parti (prestazione lavorativa,
retribuzione, obbligazioni accessorie).
Ne consegue che il lavoratore licenziato con preavviso ha diritto a prestare la propria attività durante il relativo periodo e
il lavoratore dimissionario è tenuto a prestarla fino alla scadenza di quel periodo.
Maturazione delle ferie
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il periodo di preavviso deve essere preso in considerazione ai fini
della maturazione del diritto alle ferie o della corresponsione della indennità sostitutiva semprechè il lavoratore abbia
effettivamente lavorato in tale periodo.
Qualora, invece, il datore di lavoro abbia dispensato il dipendente dal prestare servizio durante il preavviso, a
quest'ultimo non sono dovuti i ratei di ferie corrispondenti a tale periodo.
Il periodo di preavviso non può, ex art. 2109, comma 4, cod. civ., di norma essere computato nelle ferie.
Momento estintivo del rapporto
Il rapporto di lavoro si estingue allo spirare del termine del preavviso.
Secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, ove il rapporto di lavoro prosegua oltre la scadenza del periodo
di preavviso, l'atto di recesso diviene inefficace.
Ne discende che ai fini dell'estinzione del rapporto di lavoro occorre un nuovo atto di recesso - intimabile ovviamente
semprechè permangano i presupposti legittimanti ed il decorso di un nuovo periodo di preavviso.
Indennità sostitutiva del preavviso Ai sensi dell art. 2118, comma 2, cod. civ., viene stabilito che in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a
corrispondere all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.
Occorre peraltro precisare che - secondo una parte della giurisprudenza oggi minoritaria - la corresponsione
dell'indennità sostitutiva del preavviso esonera solo dal prestare materialmente l'attività lavorativa, ma non comporta la
estinzione immediata del rapporto di lavoro, di talché anche se il prestatore viene dispensato dalla prestazione lavorativa
per il periodo di preavviso e gli venga corrisposta l'indennità sostitutiva, il rapporto stesso prosegue fino alla scadenza
del periodo di preavviso, salvo che vi sia diverso accordo tra le parti.
Questo orientamento però, come si diceva, appare superato e quindi coloro che optano per pagare l indennità
sostitutiva, estinguendo il rapporto immediatamente (ciò allo scopo di evitare brutte sorprese da parte del lavoratore:
es. malattia, maternità, ecc.) oggi possono farlo senza il consenso del lavoratore.
E chiaro che se valesse l efficacia reale del preavviso ne discenderebbe che:
- qualora durante il periodo di preavviso il lavoratore si dovesse ammalare, egli avrà ugualmente diritto alla malattia così
come previsto dai CCNL (conservazione del posto e trattamento economico) con corrispondente prolungamento del
periodo di preavviso;
- il rapporto di lavoro si intende comunque cessato solo allo spirare del termine di preavviso.
A favore dell effetto estintivo immediato (c.d. efficacia obbligatoria) , oltre alla sentenza sopra citata (la n.22443/2010) si
annovera la n.21216/2009, la n.11740/2007 e più indietro nel tempo : Trib. Milano, 17/06/2002, Trib. Napoli, 26/07/1997
12
Ammontare dell'indennità di mancato preavviso In base all'art. 2121, cod. civ., ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità di mancato preavviso devono
considerarsi tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo, nonchè l'equivalente della retribuzione in natura
(vitto, alloggio) dovuta al lavoratore.
L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli
utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese.
Nell'ipotesi di retribuzioni composte in tutto o in parte da elementi variabili come ad esempio provvigioni, premi di
produzione, partecipazioni, l'indennità di mancato preavviso è calcolata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni
di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Intimazione del licenziamento
Di norma il licenziamento dovrebbe essere intimato dal datore di lavoro, da un suo rappresentante legale ovvero dai
soggetti che ne sono legittimati sulla base della distribuzione del potere di gestione del personale fissata
dall'organigramma aziendale.
In ogni caso la giurisprudenza ha ritenuto che il licenziamento intimato da un soggetto non legittimato può essere
ratificato ai sensi dell'art. 1399 cod. civ. (articolo che disciplina la ratifica del rappresentato degli atti compiuti dal
rappresentante senza potere).
La giurisprudenza ha precisato che la dichiarazione di licenziamento, quale atto (unilaterale) recettizio, può considerarsi
conosciuta dal lavoratore quando giunge al suo indirizzo, salvo che egli provi di essere stato senza sua colpa
nell impossibilità di averne notizia, in applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. (Cass. n. 4525 del 5/05/1999; Cass. n.
3707 del 14/4/1999).
Forma del licenziamento In ossequio a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, Legge n. 604/1966, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il
licenziamento al prestatore di lavoro, salvo ulteriori requisiti di forma stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Il requisito della forma scritta dell'atto di licenziamento non è soddisfatto da forme di comunicazione equipollenti. Ad
esempio non può considerarsi comunicato in modo legittimo un licenziamento portato a conoscenza del lavoratore
interessato mediante affissione nei locali dell'impresa o sulla porta degli uffici ovvero sulla bacheca del cantiere.
La comunicazione dei motivi In base a quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 2, il lavoratore può richiedere entro i 15 giorni successivi alla data
in cui ha ricevuto la comunicazione del licenziamento, i motivi che hanno determinato il recesso, nel qual caso il datore
di lavoro deve comunicare - sempre per iscritto - i motivi del licenziamento entro 7 giorni dal momento della ricezione
della richiesta.
13
Peraltro, è sufficiente che entro tale termine di 7 giorni venga inviata dal datore la comunicazione rimanendo irrilevante -
secondo la giurisprudenza - che la lettera contenente l'indicazione dei motivi venga ricevuta dal lavoratore in data
successiva.
Resta inteso che, qualora il lavoratore non abbia fatto richiesta di conoscere i motivi del licenziamento, questo è da
ritenersi valido ed efficace anche senza l'esplicazione dei motivi.
Tali motivi comunicati dal datore di lavoro al lavoratore che ne abbia fatto richiesta devono essere specifici, nel senso
che egli deve esporre i dati e gli aspetti essenziali del fatto che ha determinato il recesso, onde consentirne l'esatta
individuazione.
Immutabilità dei motivi del recesso Un principio ormai consolidato attiene l immutabilità dei motivi del recesso, nel senso che ai fini della valutazione della
fondatezza o meno del provvedimento espulsivo possono essere considerati soltanto i fatti addotti a suo sostegno al
momento della comunicazione del recesso o dei motivi che lo hanno determinato. Conseguentemente rimangono privi di
rilevanza i fatti ed i motivi non comunicati o comunicati tardivamente in ossequio al principio dell'immutabilità dei motivi
di licenziamento.
Tale principio non esclude, peraltro, che la qualificazione giuridica del motivo di licenziamento possa essere corretta o
che possano essere successivamente addotte soltanto mere circostanze confermative od integrative del fatto
contestato, applicandosi detto divieto anche alle circostanze ed agli elementi volti ad evidenziare il vincolo teleologico o
l'unicità del disegno criminoso in relazione ad una pluralità di illeciti singolarmente contestati. Cass. civ., Sez. lavoro,
09/02/1989, n.823
In particolare il datore di lavoro può ulteriormente specificare i motivi che hanno determinato il recesso, purchè
l'integrazione della motivazione non si concreti in una diversa motivazione del licenziamento rispetto a quella resa nota
all'atto della comunicazione del licenziamento stesso o dei motivi che lo hanno determinato.
Licenziamento per giusta causa. Comunicazione dei motivi. Vige il c.d. principio dell immediatezza, secondo cui il licenziamento per giusta causa deve essere intimato unitamente ai
suoi motivi immediatamente dopo che il datore di lavoro è venuto a conoscenza del fatto che costituisce la giusta causa
di recesso.
Vertendosi di norma in ambito disciplinare, il richiamato principio è, peraltro, mitigato dall'ammissibilità del decorso di un
certo lasso di tempo tra il verificarsi dei fatti e l'adozione del licenziamento, laddove sia necessario accertare la veridicità
dei fatti e valutarne la gravità, nei limiti del tempo necessario per tale accertamento e valutazione, semprechè risulti -
anche da fatti concludenti - che il datore non abbia voluto rinunciare alla facoltà di recesso.
In via esemplificativa è stato ritenuto tempestivo:
- il licenziamento intimato dopo la condanna del lavoratore per i medesimi fatti posti a base del licenziamento stesso, se
il lavoratore era stato sottoposto a procedimento disciplinare aperto subito dopo il fatto e sospeso in attesa degli esiti del
giudizio penale;
Mentre, di converso è stato ritenuto non tempestivo (e quindi illegittimo)
- il licenziamento intimato al lavoratore che, dopo essere stato condannato in sede penale, era stato riammesso in
servizio per alcuni mesi e successivamente licenziato.
14
Inosservanza dei requisiti di forma
In base all art. 2, comma 3, Legge n. 604/1966 che il licenziamento senza:
- forma scritta del licenziamento,
- obbligo di motivazione e relativi termini
-
non è nullo, bensì inefficace, cioè inidoneo ad estinguere il rapporto di lavoro9.
3) Casi di libera recedibilità
La disciplina vincolistica sui licenziamenti individuali non trova applicazione
potendosi applicare il c.d. recesso ad
nutum (cioè anche in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo) - nei seguenti casi:
- in periodo di prova: per tutta la durata della medesima e in ogni caso non oltre 6 mesi dall'assunzione;
- lavoratori domestici;
- possesso da parte del lavoratore dei requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia10 , a condizione che ai fini
della prosecuzione dell'attività lavorativa oltre l'età pensionabile, non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, D.L. n.
791/1981, convertito nella legge n. 54/1982, o quella di cui all'art. 6, L. n. 407/1990 (v. infra). 11
- dirigenti (anche se è chiesta la giustificatezza)
- apprendisti, ma solo in prossimità della fine dell apprendistato.12
Osservazioni sul licenziamento per raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia Le criticità introdotte dalla legge 247/2007 e la nuova modifica introdotta dal Decreto Milleproroghe
9 Ciò, peraltro, non esclude - secondo giurisprudenza prevalente - che il datore di lavoro possa intimare un nuovo licenziamento fondato sugli stessi motivi sui quali si fondava il primo nel rispetto, questa volta, delle modalità previste dalla legge. Ovviamente il secondo licenziamento ha efficacia dal giorno in cui è stato comunicato al lavoratore.
10 Per quanto riguarda i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, agli specifici fini dell'applicazione delle norme limitative dei licenziamenti, della previsione di un diverso limite di età per la donna (55 anni) rispetto all'uomo (60 anni). Cioè a dire che anche per la donna il licenziamento "ad nutum" può essere legittimamente intimato solo dopo il compimento del 60º anno di età. Per gli addetti alle miniere, cave e torbiere, l'art. 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, stabilisce che il limite di età pensionabile è abbassato all'età di 55 anni, purchè alla data di presentazione della domanda, tali lavoratori: 1) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa; 2) abbiano compiuto il 55º anno di età; 3) siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo; 4) siano cessati definitivamente dall'occupazione in miniere, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attività diversi da quelli predetti, con guadagno continuativo e normale.
11 Per quanto riguarda l obbligo di preventiva comunicazione dell opzione di voler proseguire l attività lavorativa fino al raggiungimento della massima anzianità lavorativa da parte della lavoratrice al datore di lavoro la giurisprudenza ritiene che questo non sussista (Cass. 6535 del 24.04.2003, 12640 del 07.07.2004, 13045 del 01.06.2006
contra vedi Cass. 2472 del 06.02.2006). Chi scrive condivide invece la tesi di Cass. 2472/2006 in quanto fondo l opzione della preventiva comunicazione è prevista da una precisa norma di legge
12 Durante il normale periodo di apprendistato, anche sulla scorta di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, con le sentenze n. 169/1973 e n. 14/1970, si applicano anche agli apprendisti le norme contenute nella L. n. 604/1966. Ne consegue che anche per licenziare un apprendista: - viene richiesta la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; - devono essere osservate le formalità prescritte per il licenziamento degli altri lavoratori.
15
Subito dopo l entrata in vigore della legge n. 247/2007 è emerso il problema della difficile situazione dei lavoratori che
avevano già rassegnato le proprie dimissioni oppure ricevuto le lettere di licenziamento da parte del proprio datore di
lavoro e che si trovano scoperti di retribuzione (o di pensione) per il periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro e la
decorrenza della pensione secondo le nuove finestre.
Con la circ. n. 5/2008 l INPS aveva precisato che la possibilità di recesso ad nutum viene differita, alla luce delle nuove
disposizioni previdenziali sulle decorrenze della pensione di vecchiaia, alla data di effettiva apertura della finestra di
accesso. Inoltre con il messaggio n. 30923/2007 è stato chiarito che non è necessario cessare l attività lavorativa
dipendente nel trimestre dove si raggiungono i requisiti.
Dato però che la mera circolare non è idonea ad incidere sul rapporto tra datore di lavoro e lavoratore è quindi
intervenuto l art. 6, comma 2-bis, del Decreto Milleproroghe (D.L. 248/2007 convertito con L 31 del 28/02/2008)
introduce una nuova modifica nel già complesso quadro del licenziamento dei lavoratori ultrassessantacinquenni:
Lefficacia delle disposizioni di cui all articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei
confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è
comunque prorogato fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore
medesimo .
Si ritiene che la formulazione scelta e il tenore letterale della norma, laddove si riferisce all art. 18 della legge n.
300/1970, crei una situazione nuova.
Lart. 18 prevede la reintegrazione nel posto di lavoro, del lavoratore illegittimamente licenziato, nei confronti dei datori di
lavoro che occupano alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori nella unità produttiva nella quale si è verificato il
licenziamento. Questa tutela reale si applica altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di
sessanta prestatori di lavoro.
I soggetti che rientrano nell ambito di applicazione dell art. 18, legge n. 300/1970 potrebbero beneficiare di questa
ulteriore tutela introdotta dal D.L. 248/2007. Coloro invece che non rientrano nell ambito della tutela reale ne sarebbero
esclusi.
Anche in questo caso si pone il problema della retroattività dell art. 6, comma 2-bis, D.L. 248/2007. Si ritiene che la
norma non possa avere effetto retroattivo in base all art. 11, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale
(Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, c.d. Preleggi ), laddove prevede che La legge non dispone che per l avvenire:
essa non ha effetto retroattivo .
Esclusione dai vincoli di forma
Ai licenziamenti "ad nutum" non si applicano le norme contenute nella L. n. 604/1966, pertanto non sono sottoposti a
particolari oneri di forma, salvo che sia stabilito diversamente dalla contrattazione collettiva, tranne che per i dirigenti ove
invece, pur non essendo richiesta la giusta causa o giustificato motivo (ma solo la c.d. giustificatezza), né l obbligo di
motivazione, il recesso deve essere comunicato per iscritto a norma dell art. 2, comma 4, Legge n. 604/1966.
Regime della libera recedibilità Anche nei rapporti di lavoro rientranti nell'area del recesso ad nutum il datore di lavoro può licenziare il lavoratore:
- con preavviso (o erogando l'indennità sostitutiva del preavviso), anche in assenza di una giusta causa o di un
giustificato motivo (si veda, al riguardo, quanto esposto in tema di obbligo di preavviso e di indennità sostitutiva);
16
- senza preavviso, se sussiste una giusta causa.
Licenziamento disciplinare nell area del recesso ad nutum
Seguendo l'oramai consolidato insegnamento giurisprudenziale anche per tali rapporti, qualora al licenziamento debba
essere riconosciuta natura disciplinare, devono essere rispettate le procedure ex art. 7 della L. n. 300/1970.
La soluzione di intraprendere la strada del licenziamento disciplinare potrebbe essere giustificata, pur in caso di libera
recedibilità, dal vantaggio di non essere soggetti alle norme sul preavviso.
Cause di illegittimità del licenziamento Riassumendo, per le ragioni sopra evidenziate, il licenziamento è illegittimo quando viene irrogato:
a) senza giusta causa o giustificato motivo, di cui all'art. 1, Legge n. 604/1966, salvo i casi di libera recedibilità esposti in
precedenza13;
b) senza l'osservanza della forma scritta, o della comunicazione degli specifici motivi dietro richiesta del lavoratore;
c) per i motivi discriminatori ex artt. 4, Legge n. 604 del 1966 e 15, Legge n. 300 del 1970:
- dal fatto che il lavoratore aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
- dalla sua affiliazione o attività sindacale ovvero dalla sua partecipazione ad uno sciopero;
- da motivi di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basate
sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.
Tutela (stabilità) reale e tutela (stabilità) obbligatoria In caso di licenziamento illegittimo il lavoratore, a seconda del tipo di attività esplicata dall'impresa e dal numero dei
dipendenti in essa occupati, può ricorrere al giudice per ottenere la:
- tutela reale di cui all'art. 18, Legge n. 300 del 1970 (reintegrazione nel posto di lavoro o indennità sostitutiva)
ovvero, alternativamente, la:
- tutela obbligatoria di cui all'art. 2, Legge n. 108 del 1990 (obbligo di riassumere o di risarcire il danno).
In base a quanto sancito dalla giurisprudenza la disciplina applicabile al licenziamento illegittimo deve essere individuata
con riguardo al posto ricoperto dal lavoratore all'epoca del licenziamento, dato che in tale "posto" - e non in quello
precedentemente occupato - egli sarebbe riammesso in caso di accoglimento dell'impugnazione del recesso. 14
13 Nell area del licenziamento "ad nutum" esso è illegittimo per: Nei rapporti di lavoro compresi nell'area della libera recedebilità il licenziamento è illegittimo se intimato: - per i motivi discriminatori (vedi infra); - per motivi illeciti; in tal senso la giurisprudenza ha ritenuto nullo il licenziamento intimato per ritorsione all'azione giudiziaria proposta dal lavoratore per ottenere una pronuncia giurisdizionale in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro e conseguenti arretrati retributivi; - per motivi disciplinari qualora tali motivi risultino insussistenti od il licenziamento sia stato intimato senza l'osservanza degli oneri procedurali previsti dall'art. 7.
14 Sulla base di tale premessa la Corte di cassazione ha, ad esempio, ritenuto che il lavoratore che abbia rinunciato alla qualifica dirigenziale precedentemente acquisita ed abbia cessato di svolgerne le relative mansioni (pur conservando il precedente trattamento retributivo dopo il passaggio alle mansioni inferiori) può essere licenziato soltanto per giusta causa o giustificato motivo, ancorchè a giustificazione del licenziamento vengano addotti fatti riferibili ad epoca in cui il lavoratore medesimo era dirigente.
17
Impugnazione del licenziamento Ai sensi di quanto disposto dall art. 6 della legge n. 604/1966 il licenziamento deve essere impugnato a pena di
decadenza mediante un atto scritto, anche extragiudiziale (di norma una lettera o un telegramma), idoneo a rendere
nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale.
L'impugnazione deve pervenire al datore di lavoro entro 60 giorni dalla ricezione da parte del lavoratore della
comunicazione del licenziamento stesso o dei motivi se richiesti15.
Attenzione! La norma si riferisce al termine di 60 gg. dalla data di comunicazione del recesso (cioè dal ricevimento della
lettera di licenziamento) e non dalla data di licenziamento. Ciò significa che se viene fatto prestare preavviso questo è
utile ai fini della decorrenza dei 60 gg. Nel caso limite di un preavviso oltre i 60 gg. l impugnativa dovrebbe essere
comunicata al datore di lavoro ancora in vigenza del rapporto di lavoro.
Va ricordato che anche la comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria
di conciliazione avvenuta nel termine di 60 gg. impedisce la decadenza sancita nella medesima norma, cioè vale quale
impugnativa del licenziamento.
La dichiarazione di impugnazione deve essere resa al datore di lavoro.
Se il datore di lavoro è una società essa deve essere effettuata - almeno secondo un orientamento della giurisprudenza
di merito - presso la sede legale o effettiva e non presso una articolazione secondaria della stessa.
In base alla giurisprudenza:
- in caso di licenziamento intimato oralmente - e quindi senza l'osservanza della forma scritta - il lavoratore non ha
l'onere di impugnare il licenziamento entro il termine di decadenza di 60 giorni previsto dalla Legge n. 604/1966, bensì
deve soltanto osservare i termini prescrizionali stabiliti, in via generale, dal codice civile;
- l'impugnazione del licenziamento disciplinare nullo per violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970 non è sottoposta al
termine di decadenza in oggetto.
- il licenziamento può essere impugnato anche da una persona diversa dal lavoratore - ad esempio lettera di
impugnazione sottoscritta da un avvocato o procuratore legale - se quest'ultimo risulta essere munito di specifica
procura scritta rilasciata prima della sottoscrizione dell'atto di impugnazione.
In materia di impugnazione del licenziamento importanti novità sono state introdotte dalla Legge 183/2010, (c.d.
Collegato Lavoro).
In esso si stabilisce che Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla
ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto
scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l intervento
dell organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. (E fin qui nulla è cambiato rispetto al regime
attuale).
La vera novità consiste nel fatto che l impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla
controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato16. Qualora la conciliazione o l arbitrato richiesti siano
rifiutati o non sia raggiunto l accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a
pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo
Casi di rinuncia espressa o tacita all'impugnazione
15 Secondo un orientamento accolto dalla Corte di cassazione la decadenza dall'impugnazione del licenziamento non preclude al lavoratore l'azione risarcitoria ordinaria.
16 Che, sempre in base a quanto disposto all interno del Collegato lavoro, torna ad essere non più obbligatorio.
18
Secondo la giurisprudenza:
- il lavoratore può rinunciare all'impugnazione del licenziamento o revocare l'impugnazione già proposta anche mediante
comportamenti concludenti quali l'accettazione del t.f.r. accompagnata dalla mancata comparizione del lavoratore alla
riunione del collegio di conciliazione, o il decorso di diversi anni tra il licenziamento e la presentazione del ricorso
giudiziario;
- l'accettazione del licenziamento da parte del lavoratore non comporta di per sè la rinuncia agli effetti giuridici scaturenti
dal licenziamento stesso ed ai relativi diritti, tra cui quello della sospensione e prolungamento del termine di preavviso in
caso di sopraggiunta malattia del lavoratore stesso.
Licenziamento di particolari categorie di lavoratori I lavoratori disabili assunti in regime di assunzioni obbligatorie ex Legge n. 68/1999 possono essere licenziati quando,
la Commissione medica di cui all'art. 4, L. 5 febbraio 1992, n. 104 accerti, su richiesta dell'imprenditore, la definitiva
impossibilità, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, di reinserire il disabile all'interno
dell'azienda (art. 10, L. n. 68/1999).
Per i lavoratori assunti in modo ordinario l incompatibilità sopravvenuta alla mansione può essere accertata dal medico
competente aziendale, ma è consigliabile venga anche suffragata da un giudizio conforme espresso dalla Commissione
medica ex art.5 legge 300/70.
Licenziamento di altre categorie Esistono particolari modalità e divieti di licenziamento nei confronti:
- della lavoratrice madre, del padre lavoratore e dei genitori adottivi o affidatari;
- della lavoratrice per causa di matrimonio.
Lavoratrice madre (o lavoratore padre) Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001, le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di
gravidanza fino al termine del congedo di maternità, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino17.
In materia di adozioni e affidamenti il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza18 e la lavoratrice, licenziata nel
corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti
l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice o il lavoratore non possono essere sospesi
dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, semprechè il reparto
stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento
17 In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. 18 Come specificato nell'art. 4 del D.P.R. n. 1026/1976, per la determinazione dell'inizio del periodo di gravidanza si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data del parto indicata nel certificato medico.
19
collettivo ai sensi della L. n. 223/1991, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività
dell'azienda cui essa è addetta, di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 54.
----------
Casi di inoperatività del divieto di licenziamento
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro (ex art. 2119
cod. civ.);
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine;
d) esito negativo della prova (v. anche ML circ. n. 113/1996).
La disposizione in esame vale anche per il padre lavoratore e per i genitori adottivi o affidatari.
Licenziamento nullo
Il licenziamento intimato in violazione delle disposizioni sopra descritte è nullo. E' altresì nullo il licenziamento causato
dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del
lavoratore (art. 54, c. 6, D.Lgs. 151/2001).
L'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 1026/1976 sancisce che la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo
intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo
a retribuzione. Tuttavia tale periodo è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla
tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Sulla bse di quanto detto se ne deduce che il datore di lavoro potrà licenziare la lavoratrice o il lavoratore solo dopo la
scadenza del periodo di conservazione del posto e purchè in tale momento sussistano - o continuino a sussistere - una
giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento (a meno che non si tratti di rapporto di lavoro dove è ammesso il
licenziamento "ad nutum", quale quello dirigenziale o domestico).
Licenziamento per matrimonio Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 198/2006, (Codice delle pari opportunità) si presume a
causa di matrimonio il licenziamento intimato nel periodo che decorre dal giorno della richiesta di pubblicazione di
matrimonio (se ed in quanto segua la celebrazione) fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso.
Lo stesso art. 35, al comma 5, prevede che durante detto periodo il datore di lavoro può legittimamente licenziare la
lavoratrice solo fornendo la prova che il licenziamento stesso dipende da una delle seguenti ipotesi:
- colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
- ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine.
Di contro, al di fuori di detto periodo, spetterà alla lavoratrice provare - se del caso - che il licenziamento è stato "attuato
a causa di matrimonio" ed è, perciò, nullo.
Dall'illegittimità del licenziamento discende quanto meno l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere alla lavoratrice le
retribuzioni decorrenti dalla data del licenziamento sino alla riammissione in servizio.
La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari, entro 10 giorni dall'invito, di recedere dal contratto, ha diritto,
ex art. 35, comma 7, D.Lgs. 198/2006, al trattamento previsto in caso di dimissioni per giusta causa (indennità sostitutiva
del preavviso), fermo restando il diritto alla retribuzione sino alla data del recesso.
20
Licenziamento "ingiurioso" Si ricorda che il licenziamento, a prescindere dalla circostanza che esso sia legittimo o meno nei suoi presupposti, può
comunque dar luogo all'obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno che il lavoratore abbia subito nel caso in cui il
recesso si concretizzi - per la forma o per le modalità del suo esercizio e per le conseguenze morali e sociali che ne
derivano - in un atto "ingiurioso", cioè lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore licenziato (es. gestore di un pubblico
esercizio che, all'atto della consegna della lettera di licenziamento additi pubblicamente il dipendente come "lavativo" e
"buono a nulla").
Abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione Conciliazione ex art. 410 cod. proc. civ.
Prima dell avvento del Collegato (legge 183/2010) entrato in vigore il 24.11.2010, ai sensi di quanto previsto dall art. 410
cod. proc. civ. chi intendeva proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di lavoro e non ritenesse di avvalersi
delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi doveva promuovere, anche tramite
l'Associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la Commissione di
conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o era addetto al
momento dell'estinzione del rapporto.
L'espletamento del tentativo di conciliazione in parola costituiva condizione di procedibilità della domanda (art. 412 bis
cod. proc. civ.).
Si tenga conto che però sembra permanere nel nostro ordinamento un regime di conciliazione obbligatoria, (non
abrogato esplicitamente) quando si verte in tema di licenziamenti ricadenti nella c.d. tutela obbligatoria, disciplinato
dall art.5, comma 1, della legge 108/90.
Arbitrato facoltativo
L'art. 5 citato stabilisce poi al comma 6 che ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di
20 giorni può promuovere, anche attraverso l'associazione sindacale a cui è iscritta o conferisca mandato, il deferimento
della controversia al collegio di arbitrato previsto dal c.c.n.l. applicabile o, in mancanza, ad un collegio composto da un
rappresentante scelto da ciascuna parte e da un Presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dal direttore della
Direzione provinciale del lavoro. Il collegio si pronuncia entro 30 giorni e la sua decisione acquista efficacia di titolo
esecutivo osservate le disposizioni dell'art. 411 cod. proc. civ.
Tutela reale19
19 Organizzazioni di tendenza
21
In caso di illegittimità del licenziamento hanno diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (o alla indennità sostitutiva
pari a 15 mensilità) - ex art. 18, comma 1, Legge. n. 300/1970 - i lavoratori dipendenti da:
- datori di lavoro, imprenditori e non, che nella sede, stabilimento, filiale (unità produttiva)20 nella quale ha avuto luogo il
licenziamento, occupino più di 15 dipendenti, o più di 5 se imprenditori agricoli;
- datori di lavoro, imprenditori e non, che nell'ambito del comune nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupino più
di 15 dipendenti, o più di 5 se imprenditori agricoli, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunga tali limiti;
- datori di lavoro, imprenditori e non, che comunque abbiano alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori;
- imprese che comunque occupano più di 15 dipendenti e che abbiano attuato le procedure di mobilità previste dalla
legge n. 223/1991, da esubero di Cassa integrazione guadagni straordinaria o da riduzione di personale (art. 5, comma
3 e art. 24, L. n. 223/1991).
- imprese che in base alla legge sarebbero escluse dalla tutela reale ma che, sulla base di previsioni della contrattazione
collettiva o da accordi individuali hanno inteso recepirla, pur se non espressamente soggetti in base alla legge.
Licenziamento discriminatorio Inoltre, a norma dell'art. 3, Legge n. 108/1990, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati dal datore di lavoro
- e quindi anche nei casi dove, di regola, vigerebbe il principio della c.d. "libera recedibilità" - il lavoratore ha diritto in
ogni caso alla reintegrazione nel posto di lavoro qualora il licenziamento sia stato intimato per motivi politici, sindacali,
religiosi, di razza, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basati sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni
personali ai sensi dell'art. 15, Legge n. 300/1970 e dell'art. 4, Legge n. 604/1966.
Computo del numero dei lavoratori occupati
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 18, L. n. 300/1970, nel numero dei prestatori di lavoro occupati nell'azienda, devono
essere computati, per espressa previsione normativa, anche i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro,
anche se ormai sono in via di estinzione (art. 18, comma 2, L. n. 300/1970).
Inoltre i lavoratori part-time devono essere computati per la quota di orario effettivamente svolta, tenendo conto, al
riguardo, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Ad es. due lavoratori che svolgono un orario di 20 ore lavorative settimanali a fronte di un orario normale di lavoro
stabilito dalla contrattazione collettiva in 40 ore settimanali si considerano come un unico lavoratore occupato
nell'impresa.
Secondo la giurisprudenza, ai fini del raggiungimento del numero minimo di dipendenti necessario per l'applicabilità della
stabilità reale devono essere altresì computati:
L'art. 4, comma 1, L. n. 108 dispone che fermo restando quanto previsto in caso di licenziamento discriminatorio, la tutela reale non è applicabile nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro (c.d. organizzazioni di tendenza) attività di natura politica (partiti), sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
20 Nozione di unità produttiva Per unità produttiva, ai fini dell'applicabilità della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi, deve intendersi qualsiasi entità aziendale (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto) funzionalmente autonoma - cioè caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica e amministrativa - in cui si svolga e si concluda il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale, rimanendo così esclusi quei minori organismi che, seppur dotati di una certa autonomia, siano destinati a scopi meramente strumentali rispetto ai fini produttivi dell'impresa.
22
- i dipendenti assenti per malattia, maternità, servizio militare o altre cause che non si concretino in un allontanamento
definitivo del lavoratore;
- i dipendenti in prova;
- i dipendenti a tempo determinato;
- i dirigenti;
- i lavoratori a domicilio ed i telelavoratori con contratto continuativo;
- i c.d. dipendenti esterni, cioè i lavoratori non occupati all'interno dell'impresa - perchè svolgono lavori che per loro
natura devono essere condotti e portati a termine fuori dello stabilimento o dell'ufficio - ma che ad essa fanno
necessariamente capo;
- i dipendenti che, pur considerati autonomi in forza di previsioni contrattuali, siano realmente impegnati nel ciclo
produttivo normale dell'articolazione aziendale;
- i lavoratori stranieri assunti all'estero.
Non si computano invece:
- gli apprendisti (art. 21, comma 7, L. n. 56/1987);
- il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea retta e in linea collaterale (art. 18, comma 2, L.
n. 300/1970);
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (art. 20, comma 4, L. n. 223/1991).
Inoltre la giurisprudenza ha ritenuto esclusi dal computo dei dipendenti occupati nell'impresa:
- i lavoratori temporaneamente impiegati in sostituzione degli assenti;
- i lavoratori occasionalmente ed eccezionalmente occupati in attività diverse da quelle costituenti l'attività normale
dell'azienda;
- i lavoratori somministrati.
- i soci di cooperative (anche se ai sensi della legge 142/2001 coloro che hanno optato per il lavoro dipendente vanno
computati);
- l'amministratore unico di una società di capitali che sia stato, al contempo, formalmente inquadrato come dipendente
della società stessa;
- i lavoratori assunti per esigenze stagionali;
- il lavoratore che svolge funzioni di fiduciario "alter ego" dell'imprenditore;
- il lavoratore che dopo il deposito della sentenza che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento sia in attesa della
effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
- i lavoratori a domicilio, purchè non vi sia una continuità nelle loro prestazioni.
Nel caso in cui si chieda l'applicazione della tutela reale contro i licenziamenti illegittimi, l'onere probatorio circa la
consistenza numerica del personale dipendente grava sul lavoratore.
Contenuto della tutela reale
In presenza di un licenziamento illegittimo, qualora trovi applicazione la tutela reale di cui all'art. 18, Legge n. 300/1970,
il giudice:
a) ordina la reintegrazione nel posto di lavoro21 o, a scelta del lavoratore, il pagamento di una "indennità sostitutiva della
reintegrazione" pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, fermo il diritto al risarcimento del danno (art. 18, commi
1 e 5, L. n. 300/1970);
21 L'ordine di reintegrazione ex art. 18, L. n. 300/1970, ripristina con efficacia retroattiva la continuità del rapporto di lavoro che, perciò, si considera come mai interrotto. Pertanto, la reintegrazione comporta:
23
b) condanna il datore a pagare una indennità a titolo di risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e, in ogni caso, non inferiore a 5
mensilità di retribuzione globale di fatto (art. 18, comma 4, L. n. 300/1970).
Provvisoria esecutorietà dell'ordine
Si ricorda che la sentenza che dichiara l'illegittimità del licenziamento e dispone la reintegrazione è, ex art. 18, comma 6,
L. n. 300/1970, provvisoriamente esecutiva.
Regime contributivo
In applicazione dell'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, qualora venga ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro, il
datore di lavoro ha l'obbligo di versare i contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al
momento dell'effettiva reintegrazione.
Una recente sentenza della Cassazione SS.UU. (sentenza n.15143 del 5 luglio 2007) ha chiarito che il contributo va
commisurato solo alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di illegittimo allontanamento dal
posto di lavoro, prescindendo dall'entità del risarcimento o dall eventuale risarcimento in misura minima (5 mensilità).
Resta fermo peraltro, come ha precisato l'INPS con la circolare n. 125/1992, che i contributi debbono essere determinati
su di una base imponibile non inferiore ai minimali di legge.
Gli obblighi contributivi sulle somme di cui sopra, peraltro:
- non vengono meno qualora il lavoratore si avvalga della facoltà di chiedere il pagamento di una indennità pari a 15
mensilità, in sostituzione della reintegrazione;
- non sussistono con riferimento alla predetta indennità, avendo questa natura risarcitoria e non rientrando quindi
nell'imponibile contributivo.
Qualora il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall'invito del datore di lavoro, nè abbia richiesto, entro 30
giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione,
intendendosi il rapporto di lavoro risolto alla scadenza dei termini predetti, i contributi sono comunque dovuti fino a tale
data.
Va ricordato che, oltre al versamento dei contributi di cui si è detto, il datore di lavoro deve pagare l'importo
corrispondente alle relative sanzioni civili amministrative per non aver versato nei termini prescritti i contributi relativi ai
periodi di paga delle singole scadenze dei contributi stessi alla data del loro versamento.
Risoluzione del rapporto di lavoro
- la concreta ed effettiva assegnazione del dipendente alle mansioni svolte in precedenza, oppure l'assegnazione a mansioni equivalenti, nel caso in cui ricorrano ragioni tecniche, organizzative e produttive sopravvenute al licenziamento; - la riammissione nel posto di lavoro, nel luogo in cui si sia verificata la interruzione del rapporto, salva la possibilità di un trasferimento del lavoratore reintegrato in presenza delle condizioni di legge (art. 2103 cod. civ.) e di contratto cui è subordinata la legittimità del trasferimento; - che il periodo intercorrente fra la scadenza e l'effettivo adempimento dell'ordine di reintegrazione deve essere considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio. Il giudice non può ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro se nel frattempo è cessata del tutto l'attività aziendale. In tal caso egli si limiterà a condannare il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore la retribuzione dalla data del licenziamento fino al momento della cessazione dell'attività, salvo - come sembra potersi ritenere dal tenore delle motivazioni delle pronunce giurisprudenziali sul punto - il minimo delle 5 mensilità.
24
Come già anticipato precedentemente, qualora il lavoratore non si sia presentato per riprendere servizio entro 30 giorni
dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro, nè abbia richiesto entro 30 giorni dalla data del deposito della sentenza
l'indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si risolve allo spirare dei termini predetti (art. 18, comma 5, L. n. 300/1970).
Secondo la giurisprudenza:
- il termine di 30 giorni dall'invito del datore di lavoro decorre non dalla generica comunicazione della disponibilità del
datore di lavoro ad ottemperare alla sentenza di reintegra, bensì dal giorno specificamente indicato dal datore di lavoro
stesso per l'effettiva ripresa della prestazione lavorativa;
- in pendenza di suddetto termine di trenta giorni è dovuta la retribuzione al lavoratore.
Risarcimento del danno
Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute e, in ogni caso, in misura non
inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, sorge per effetto dell'accertamento dell'illegittimità del
licenziamento, indipendentemente dalla prova di qualsiasi pregiudizio.
Qualora invece venga richiesto un risarcimento di maggiore entità, il lavoratore avrà l'onere di provare l'ulteriore danno
subito (ad esempio, sfratti, oneri passivi per prestiti).
Pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto che:
- la misura del risarcimento (fatte salve le 5 mensilità) può essere ridotta in proporzione agli introiti che il lavoratore
abbia eventualmente percepito da un'occupazione procuratasi dopo il licenziamento. La prova della realizzazione di altri
redditi da parte del lavoratore spetta al datore di lavoro;
- il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno - quanto meno nella misura minima di 5 mensilità - anche nell'ipotesi in
cui la reintegrazione risulti impossibile per causa sopravvenuta, per revoca del licenziamento o per il venir meno
dell'interesse del lavoratore (che, ad esempio, potrebbe aver trovato una migliore occupazione nelle more del giudizio);
- la rivalutazione monetaria prevista dall'art. 429, comma 3, cod. proc. civ., trova applicazione anche nei confronti delle
somme attribuite a titolo di risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo, ma non anche nei riguardi degli
interessi legali.
Nell'importo della retribuzione dovuta rientrano tutti gli elementi di cui era composta la retribuzione del lavoratore
illegittimamente licenziato (paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, assegni "ad personam", premi di
produzione e simili), nonchè gli incrementi retributivi derivanti dagli accordi collettivi intervenuti nel periodo compreso tra
il licenziamento e la reintegrazione applicabili al rapporto di lavoro in questione.
Tutela obbligatoria Ai sensi dell art.2 della legge 108/1990, i lavoratori licenziati illegittimamente hanno diritto ad essere riassunti, o, in
mancanza, al risarcimento del danno i lavoratori dipendenti da:
- datori di lavoro privati, imprenditori e non, che occupano fino a 15 lavoratori, o fino a 5 se imprenditori agricoli;
- datori di lavoro ai quali, pur occupando complessivamente più di 15 lavoratori (o più di 5 se imprenditori agricoli), non
trova applicazione la disciplina della tutela reale. Ciò può avvenire quando il datore di lavoro occupa un numero di
dipendenti tra i 15 e i 60 distribuiti in diversi comuni e in diverse unità produttive, e il licenziamento sia avvenuto in un
comune e in un'unità produttiva con meno di 15 dipendenti (si pensi, ad esempio, ad un'azienda che occupi 10 lavoratori
nel comune di Torino e 10 nel comune di Napoli);
- enti pubblici, ove la stabilità del rapporto di lavoro non sia assicurata da norme di legge, di regolamento o di contratto,
che occupano fino a 15 dipendenti.
Per quanto riguarda il computo dei lavoratori occupati si applicano gli stessi criteri di cui all'art. 18, L. n. 300/1970.
25
Datori di lavoro esclusi
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, L. n. 108/1990, ai rapporti di lavoro con i lavoratori domestici di cui alla legge 2
aprile 1958, n. 339, e nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici
semprechè non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 791 del 1981, o
quella di cui all'art. 6, L. n. 407/1990, non trova applicazione la tutela obbligatoria in parola.22
Contenuto della tutela obbligatoria
In caso di licenziamento illegittimo, ove trovi applicazione la tutela obbligatoria di cui all'art. 2 della Legge. n. 108/1990, il
datore di lavoro è tenuto a riassumere il lavoratore entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcire il danno
versandogli un'indennità di importo compreso tra:
- un minimo di 2,5 mensilità
- un massimo di 6 mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa,
all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.
Nel caso di datori di lavoro con oltre 15 dipendenti, la misura massima della predetta indennità può essere maggiorata:
- fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità di servizio superiore ai 10 anni;
- fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a 20 anni.
In base all orientamento della Corte di cassazione - ma contrastato dalla giurisprudenza di merito - l'obbligazione al
pagamento dell'indennità prevista dall'art. 8, L. n. 604/1966, non sussiste qualora la riassunzione sia resa impossibile dal
rifiuto del lavoratore all'invito del datore di lavoro a riprendere servizio.
Differenza fra tutela obbligatoria e tutela reale
A differenza della reintegrazione ex art. 18, L. n. 300/1970 (tutela reale), la quale ripristina la continuità del rapporto di
lavoro, la riassunzione comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
Infatti non a caso la legge parla di riassunzione .
Ne consegue che - non essendo ripristinato il rapporto di lavoro - non sussistono i connessi obblighi contributivi.
22 Per quanto riguarda le organizzazioni di tendenza, come precisato dall'INPS con circolare n. 125/1992, si può ritenere che i lavoratori illegittimamente licenziati dai datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, qualunque sia la forza occupazionale possano chiedere l'applicazione della tutela obbligatoria in quanto l'art. 4, comma 1, L. n. 108/1990, esclude espressamente tali organizzazioni dalla sfera di applicazione della tutela reale, ma non anche da quella obbligatoria.
26
Qui di seguito vengono riportate alcune bozze relative alle varie tipologie di licenziamento.
Modello di lettera di licenziamento per giusta causa
Da___________________ (indicare estremi del datore di lavoro)
A
Sig. __________________(indicare estremi del lavoratore)
Raccomandata a/r
Anticipata a mani/con telegramma
Oggetto: risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa
Facendo seguito alla nostra lettera di contestazioni del____________, da intendersi qui integralmente trascritta,
riscontriamo la Sua lettera raccomandata del _________, pervenuta in data_________________, e comunichiamo a
tutti gli effetti di legge e di contratto di non ritenere accoglibili le giustificazioni da Lei presentate.
Confermiamo, infatti, che le contestazioni avanzate nei Suoi confronti sono comprovate dalla testimonianza di persone
che hanno assistito personalmente al compimento degli atti meglio descritti nella precitata lettera di contestazione.
Nel ribadire la gravità e la fondatezza degli addebiti, osserviamo che il Suo comportamento costituisce grave
inadempimento agli obblighi di diligenza e fedeltà previsti dalla legge, ed ha irrimediabilmente incrinato il vincolo
fiduciario che deve necessariamente intercorrere tra le parti del rapporto di lavoro.
Con la presente, Le comunichiamo quindi il licenziamento per giusta causa, senza preavviso, ai sensi dell art. 2119 c.c.,
della Legge n. 604/1966 e successive modifiche e integrazioni, e degli articoli____________del vigente CCNL.
Il presente atto di recesso ha efficacia immediata e deve intendersi formulato con riserva di procedere alla tutela degli
interessi dello scrivente in ogni competente sede.
Siamo a disposizione per provvedere alla restituzione dei documenti di Sua competenza e concordare ogni altro aspetto
relativo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Distinti saluti.
_______________lì,___________
Il datore di lavoro
27
Modello di lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo senza preavviso
Da__________________________________ (indicare estremi del datore di lavoro)
A
Sig. _________________________________(indicare estremi del lavoratore)
Raccomandata a/r
Anticipata a mani/con telegramma
Oggetto: risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo
Gentile Sig.___________,
da tempo Lei opera nell ambito della divisione______________con la qualifica di ___________e le mansioni di
___________________
Come a Lei noto, la nostra Società è stata di recente interessata da una profonda ristrutturazione che ha condotto alla
dismissione di un rilevante ramo di attività ed alla riorganizzazione interna dei compiti e delle mansioni.
Considerato che nell ambito di tale riorganizzazione dell attività aziendale, relativa anche alla divisione
_______________ cui Lei è addetto, è stato deciso di cessare l attività________________e che le relative funzioni
di_________________sono state integralmente soppresse (oppure in caso di cessazione parziale: in parte soppresse e
in parte ridistribuite; oppure in caso di riorganizzazione: integralmente ridistribuite e assegnate a______ed a ______),
siamo spiacenti di comunicarLe che abbiamo deciso di sopprimere il posto da Lei ricoperto.
Rilevato, infine, che le succitate modifiche organizzative sono operanti con effetto immediato, e che non vi sono posti
utili con analoga professionalità nei quali l Azienda possa utilmente occuparLa, siamo spiacenti di comunicarLe che
abbiamo deciso di risolvere
con effetto immediato - il rapporto di lavoro con Lei intercorrente per giustificato motivo
oggettivo.
Di conseguenza, La esoneriamo dalla prestazione del periodo di preavviso contrattuale in relazione al quale Le verrà
erogata l indennità sostitutiva, unitamente alle competenze di fine rapporto.
Siamo a disposizione per provvedere alla restituzione dei documenti di Sua competenza e concordare ogni altro aspetto
relativo alla cessazione del rapporto di lavoro.
RingraziandoLa per la fattiva collaborazione, porgiamo distinti saluti.
_________________lì,___________
Il datore di lavoro
28
Modello di lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso
Da___________________________ (indicare estremi del datore di lavoro)
A
Sig. __________________________(indicare estremi del lavoratore)
Raccomandata a/r
Anticipata a mani/con telegramma
Oggetto: risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
Art.3 legge 604/1966.
Gentile Sig.__________________,
come a Lei noto nell ultimo esercizio la Divisione aziendale cui Lei è addetto ha subito una forte e prolungata
contrazione del fatturato e dei volumi di produzione, contrariamente alle attese di crescita sotto i cui auspici si era
proceduto alla Sua assunzione. Tale situazione è aggravata da una prospettiva di ulteriore contrazione peraltro
confermata dall andamento del portafoglio ordini da Lei stesso gestito.
Tale situazione comporta la necessità di provvedere senza ritardo ad una ristrutturazione della struttura finalizzata ad
una riduzione dei costi e ad un più efficiente utilizzo delle risorse umane in relazione al reale fabbisogno.
Per questi motivi la Società è addivenuta alla determinazione di sopprimere il posto da Lei occupato e la stessa funzione
di_________________della Divisione____________, le cui mansioni e attribuzioni verranno assunte direttamente dalla
Direzione___________________
Rilevato, infine, che non vi sono posti liberi con analoga professionalità nei quali l Azienda possa utilmente occuparLa,
siamo dolenti di doverLe comunicare la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso, per avvenuta soppressione del
posto e della funzione in radice di oggettive esigenze organizzative e produttive.
Atteso il periodo di preavviso che Le compete ai sensi di legge e di contratto, Le comunichiamo altresì che il Suo
rapporto di lavoro cesserà il prossimo__________, ferma restando la nostra disponibilità ad erogare l indennità
sostitutiva.
Resta inteso che, contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro, sarà Sua cura provvedere alla immediata
restituzione dei seguenti beni aziendali sino a oggi utilizzati:
- telefono
cellulare_________________e scheda telefonica;
- auto_________
_________________
- pc
portatile_____________________
La invitiamo a liberare i locali aziendali da ogni bene di Sua proprietà entro cinque giorni lavorativi dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Siamo a disposizione per provvedere alla restituzione dei documenti di Sua competenza e concordare ogni altro aspetto
relativo alla cessazione del rapporto di lavoro.
La ringraziamo per la fattiva collaborazione ed inviamo distinti saluti.
________________lì___________________
Il datore di lavoro
29
Modello di lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia
Da___________________________ (indicare estremi del datore di lavoro)
A
Sig. __________________________(indicare estremi del lavoratore)
Raccomandata a/r
Anticipata a mani/con telegramma
Oggetto: risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto
Gent.le Sig. ______________;
con la presente siamo purtroppo costretti a comunicarLe la risoluzione del rapporto di lavoro con Lei intercorrente per
eccesso di assenze, stante l avvenuto superamento del periodo di comporto così come previsto dall art._______ del
CCNL di categoria.
Lei ha infatti maturato ________giorni di assenza (alla data del______________) per malattia che superano il periodo
per la cui durata è garantita dal contratto la conservazione del posto.
La presente ha efficacia immediata, con conseguente cessazione dal servizio dalla data di domani. Lindennità
sostitutiva del preavviso che Le spetta contrattualmente verrà erogata unitamente alle residue competenze di fine
rapporto.
Siamo a disposizione per provvedere alla restituzione dei documenti di Sua competenza e concordare ogni altro aspetto
relativo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Distinti saluti.
_______________lì_______________
Il datore di lavoro
30
Modello di lettera di licenziamento del disabile per aggravamento dello stato di invalidità
Da ___________________________ (indicare estremi del datore di lavoro)
A
Sig. ___________________________(indicare estremi del lavoratore)
Raccomandata a/r
Anticipata a mani/con telegramma
Oggetto: risoluzione del rapporto di lavoro per riduzione della capacità lavorativa
Gent.le Sig. _________________;
con la presente siamo purtroppo costretti a comunicarLe la risoluzione del rapporto di lavoro con Lei intercorrente, a far
data dal ricevimento della presente.
Tale decisione trova origine e si giustifica nell aggravamento delle Sue condizioni di salute e nella conseguente riduzione
della Sua capacità lavorativa, come accertati dalla preposta Commissione sanitaria ai sensi dell art. 10 comma 3, della
legge n. 68/1999, nonché nell impossibilità di individuare, all interno della nostra struttura produttiva, mansioni adeguate
alla Sua residua capacità lavorativa.
Provvederemo a corrisponderLe quanto ancora dovutoLe in relazione all esecuzione e alla cessazione del rapporto
stesso, ivi compresa l indennità sostitutiva del preavviso.
Siamo a disposizione per provvedere alla restituzione dei documenti di Sua competenza e concordare ogni altro aspetto
relativo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Distinti saluti.
_______________lì_______________
Il datore di lavoro