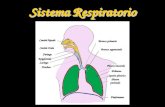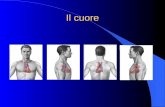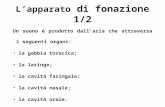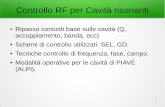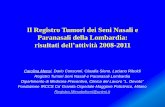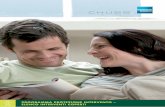Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie
Transcript of Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie

Chirurgia delle cavità posterioridell’orecchio medio e atticotomieN. Durand, F. Espitalier, O. Malard, P. Bordure
La chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio ha vari obiettivi. Essa permette l’accesso diretto e iltrattamento dei processi patologici situati a livello delle cavità posteriori ma anche delle altre regionidell’orecchio medio, come l’attico e la cassa del timpano. Le indicazioni di questa chirurgia sonodominate dal trattamento dell’otite cronica, il più delle volte colesteatomatosa. Si distinguono due granditipi di tecnica in funzione della conservazione o del sacrificio del condotto uditivo esterno osseo:antroatticotomia o mastoatticotomia conservativa del condotto e svuotamento, che impone il sacrificio diuna parte del condotto osseo. La tolleranza delle cavità di svuotamento è ormai molto migliorata dallosviluppo delle tecniche di riempimento con biomateriali. La chirurgia delle cavità posteriori è utile ancheper l’accesso otoneurochirurgico e all’orecchio interno o in caso di chirurgia implantologica. Larealizzazione corretta di queste tecniche richiede una buona conoscenza dell’anatomia complessa diquesta regione, nonché un accesso idoneo nelle parti molli.© 2011 Elsevier Masson SAS. Tutti i diritti riservati.
Parole chiave: Mastoidectomia; Svuotamento dell’orecchio; Timpanotomia posteromediale; Colesteatoma;Impianti; Meatoplastica; Riempimento; Biomateriali
Struttura dell’articolo
¶ Introduzione 1
¶ Richiami anatomici 2Cassa del timpano 2Epitimpano o attico 2Antro 2Apice della mastoide 2Lamina intersinusofacciale 2Regione sottofacciale 2
¶ Definizione 2Periantrotomia superficiale 2Antrotomia 2Mastoidectomia 2Mastoatticotomia 3Antroatticotomia o atticotomia transmastoidea 3Timpanotomia posteriore 3Cavità di svuotamento 3
¶ Tempi preparatori e prevenzione dei rischi operatori 3Preparazione dell’intervento 3Preparazione del paziente 3Precauzioni intraoperatorie 3
¶ Vie di accesso nelle parti molli e chiusura 4Via retroauricolare 4Via endoaurale prolungata 4Chiusura e zaffaggio del condotto uditivo 4
¶ Tempi ossei 5Antrotomia 5Mastoidectomia 6Antroatticotomia e mastoatticotomia 7Timpanotomia posteriore 8Atticotomia per via transcanalare 9Chirurgia endoscopica 11Cavità di svuotamento 11Riempimento delle cavità posteriori 14
¶ Cure postoperatorie. Monitoraggio 14Antibioticoterapia 14Cure locali e monitoraggio 14
¶ Complicanze 14Complicanze durante l’intervento 14Complicanze postoperatorie 15
■ IntroduzioneLa chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio ha vari
obiettivi. Il primo è rappresentato dall’accesso diretto e daltrattamento dei processi patologici situati a questo livello.
Esse sono anche una via di passaggio per aggredire le altrecavità dell’orecchio medio (quali l’attico o la cassa del timpano),in particolare nell’ambito del trattamento dell’otite cronica,colesteatomatosa o meno. Si distinguono due grandi tipi ditecniche in funzione della conservazione o del sacrificio delcondotto osseo. Si parla, allora, rispettivamente, di antroattico-tomia o mastoatticotomia e di svuotamento. La tolleranza dellecavità di svuotamento può ormai essere migliorata dalletecniche di riempimento, che traggono vantaggio dallo sviluppodei biomateriali. Questa chirurgia è utile anche in caso diaccesso otoneurochirurgico o all’orecchio interno.
Infine, la chirurgia implantologica che riguarda gli impianticocleari e dell’orecchio medio richiede la conoscenza di questetecniche.
Il corretto svolgimento degli interventi sulle cavità posterioridell’orecchio medio richiede una buona conoscenza dell’anato-mia difficile di questa regione e delle indicazioni e l’attuazionedi un certo numero di precauzioni, in particolare la realizza-zione di un buon posizionamento e di un accesso idoneo nelleparti molli.
¶ I – 46-080
1Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

■ Richiami anatomici [1, 2]
L’anatomia chirurgica divide l’orecchio medio in sei regioni.
Cassa del timpano (Fig. 1)
Essa comprende il mesotimpano, o atrio, l’ipotimpano, ilprotimpano, che è l’orifizio tubarico, il retrotimpano con ilsinus tympani e l’epitimpano o attico.
Il mesotimpano è situato medialmente rispetto alla mem-brana timpanica, sopra il canale del muscolo tensore delmartello e della seconda porzione del nervo facciale e davantialla terza porzione del nervo facciale. È la zona funzionaledell’orecchio. Deve essere esaminata preventivamente, primadella chirurgia delle cavità posteriori per otite cronica.
Epitimpano o atticoÈ situato appena sopra l’atrio, cioè sopra il canale del
muscolo tensore del martello e della seconda porzione del nervofacciale. È anch’esso una zona funzionale che comprende latesta del martello e il corpo dell’incudine. L’incudine è uneccellente repere chirurgico che permette di localizzarsi rispettoal nervo facciale grazie alla sua apofisi corta e rispetto alla staffache può essere annegata in alcune fungosità, grazie alla suaapofisi lunga. La parte anteriore di questa regione, l’atticoanteriore, crea delle difficoltà nella chirurgia dell’orecchiomedio, in quanto è mascherata da un setto osseo che discendedal tegmen tympani; a questo livello, il nervo facciale è moltovicino alla parete mediale dell’attico [3].
AntroÈ una delle principali cavità posteriori ed è costantemente
presente, anche nel lattante. Comunica con l’attico attraversol’aditus ad antrum. L’antro è limitato superiormente dal tegmenantri, posteriormente dal seno laterale e medialmente dallabirinto osseo. L’area triangolare che si trova dietro l’antro, trail seno laterale, il seno petroso superiore e il labirinto osseo, èchiamata triangolo di Trautmann. Lateralmente, l’antro èdelimitato dalla lamina petrosquamosa, con delle cellulesuperficiali che non vanno confuse con le cellule antrali.
Apice della mastoide (Fig. 2)
È occupato da due gruppi cellulari di importanza variabile,separati dalla cresta digastrica che rappresenta l’inserzione
mastoidea del muscolo digastrico. La cresta digastrica segna piùo meno profondamente il rilievo dell’apice mastoideo.
L’emergenza del nervo facciale a livello del forame stilomas-toideo si situa a livello dell’estremità anteriore della crestadigastrica. Il gruppo cellulare profondo dell’apice è in relazionediretta con il gruppo cellulare sottofacciale.
Lamina intersinusofacciale (Fig. 2)
È il gruppo cellulare situato tra la terza porzione del nervofacciale e il seno laterale.
Regione sottofaccialeÈ situata medialmente rispetto alla terza porzione del canale
facciale. Si tratta del prolungamento della lamina intersinuso-facciale. Essa è di volume molto variabile.
■ Definizione [4-6]
Sotto il termine di antroatticotomia, si indicano vari tipi diinterventi che hanno in comune l’apertura dell’antro e laconservazione del condotto osseo. Questo li distingue dallacavità di svuotamento (che sopprime la parete posteriore delcondotto osseo). Si differenziano in funzione dell’entitàdell’apertura delle cavità.
Periantrotomia superficialeÈ l’apertura delle cellule periantrali superficiali, senza neces-
sariamente aprire l’antro.
AntrotomiaÈ l’apertura mastoidea limitata all’antro; non deve confon-
dere la cellula periantrale (detta di Lenoir) con l’antro.
MastoidectomiaEssa consiste nel mettere a piatto tutte le cellule mastoidee,
compreso l’antro, e la lamina intersinusofacciale, l’apice e lecellule sottofacciali. In effetti, la mastoidectomia semplice èraramente indicata. Si tratta, il più delle volte, di una mastoat-ticotomia, in quanto, se sono presenti delle lesioni infiamma-torie, l’attico deve spesso essere esplorato.
Figura 1. Schema di una sezione coronale della cassa del timpano.1. Epitimpano; 2. mesotimpano; 3. ipotimpano.
1 2 3 4 5
6
7
8
9
Figura 2. Sistematizzazione mastoidea. 1. Cellule retrosinusali; 2. cel-lule retrolabirintiche (triangolo di Trautmann); 3. tegmen temporale;4. cellule sopralabirintiche; 5. cellule temporozigomatiche; 6. bloccolabirintico; 7. condotto uditivo esterno; 8. cellule intersinusofacciali;9. cellule dell’apice.
I – 46-080 ¶ Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie
2 Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

MastoatticotomiaÈ la messa a piatto delle cellule mastoidee completata
dall’apertura dell’attico.
Antroatticotomia o atticotomiatransmastoidea
È l’apertura dell’attico per via mastoidea. L’atticotomia per viamastoidea deve essere distinta dall’atticotomia transcanalare checomporta il sacrificio di una porzione o della totalità dellaparete della loggetta. L’atticotomia transcanalare si concepiscesolo per trattare un colesteatoma atticale anteriore o esterno, icui limiti sono stati precisati dalla TC, o, ancora, per affrontareun’anchilosi della testa del malleolo. In tutti i casi, la paretedella loggetta deve essere ricostruita.
Timpanotomia posterioreÈ l’apertura della cassa per via mastoidea a spese del recesso
facciale.
Cavità di svuotamentoProprio della letteratura francese, il significato del termine
svuotamento petromastoideo (o, più semplicemente, svuota-mento) è stato precisato da Malherbe nel 1895: «Una cavità disvuotamento è definita per la creazione di una cavità unica, piùo meno ampia, che riunisce l’insieme delle cavità atticali emastoidee con il condotto uditivo esterno, dopo l’eliminazionedella parete posteriore e del muro della loggetta» [4]. Ciòcorrisponde alla canal wall-down tympanoplasty degli autorianglosassoni. Al contrario della radical mastoidectomy anglosas-sone, la cavità di svuotamento non pregiudica lo stato delsistema timpano-ossiculare. Questo può, secondo il suo stato,essere conservato o ricostruito. Si tratta, in quest’ultimo caso, diuna cavità di svuotamento con timpanoplastica. Quando tutti iresidui timpano-ossiculari sono resecati, si tratta di uno svuota-mento totale.
La cavità di svuotamento con timpanoplastica è, a volte,denominata timpanoplastica con tecnica aperta per contrappo-sizione con la timpanoplastica con tecnica chiusa che combinaun intervento mastoatticale, se necessario con conservazione delcondotto osseo, associato alla ricostruzione della membrana.
Il termine di svuotamento parziale, fonte di confusione, nondeve più essere utilizzato, in quanto non si sa se il carattereparziale si riferisca alla cavità oppure al contenutotimpano-ossiculare.
■ Tempi preparatori e prevenzionedei rischi operatori [7, 8]
Il successo di un intervento chirurgico sull’orecchio mediodipende, ovviamente, dalla qualità della via di accesso e dallatecnica operatoria, ma anche da un certo numero di precauzionipre- e intraoperatorie.
Preparazione dell’interventoÈ ovvio che l’indicazione chirurgica deve essere posta con il
massimo rigore al momento della visita, in base ai datidell’esame obiettivo, delle esplorazioni funzionali e deglieventuali esami di diagnostica per immagini realizzati prendendosempre in considerazione i sintomi lamentati dal paziente. Ladecisione operatoria deve essere presa insieme al paziente dopol’informazione e la raccolta del suo consenso informato. Bisognaprecisare, in particolare, se lo scopo dell’intervento è quello ditrattare una patologia, di migliorare l’udito o entrambe le cosecontemporaneamente.
Si indagherà sul terreno del paziente che può comprometterei risultati operatori, come un diabete, un disturbo dell’emostasi(un trattamento anticoagulante o antiaggregante piastrinico) odella cicatrizzazione, un’allergia o l’esistenza di lesioni cutaneeperiauricolari.
Preparazione del pazientePreparazione della cartella del paziente: il paziente arriva in
sala con la sua cartella clinica, un esame audiometrico recentee gli esami di diagnostica per immagini realizzati. Questi sonoaffissi in sala operatoria.
Verifica del lato da operare: con il paziente e sulla cartellaclinica.
Installazione del paziente: una cattiva installazione puòesporre a gesti inopportuni dovuti a un’inadeguata localizza-zione dei reperi anatomici. Il piano mastoideo deve essereorizzontale quando la testa è ruotata in posizione estremaall’opposto dell’operatore, al fine di conservare il tegmentemporale in un piano verticale, qualunque sia la posizionedella testa. Ciò implica di porre un cuscino sotto la testa di unpaziente obeso o sotto le spalle di un soggetto magro o di unbambino. È meglio non fissare la testa, per poterla ruotarefacilmente e per ottenere un angolo di visione adeguato infunzione delle esigenze.
Realizzazione del campo operatorio: la rasatura deve essereeseguita preferibilmente il mattino dell’intervento con un rasoioelettrico.
L’antisepsi cutanea è realizzata con polividone iodato oexamidina. Questi prodotti hanno un’ototossicità potenziale; incaso di perforazione timpanica, bisogna badare a non introdurredirettamente dei prodotti antisettici nel condotto uditivo eriempirlo di acqua ossigenata diluita a 10 volumi o di soluzionefisiologica.
Monitoraggio del nervo facciale: il posizionamento di unsistema di monitoraggio del nervo facciale è raccomandato, inparticolare per gli operatori meno esperti, in quanto uno deirischi principali della chirurgia delle cavità posteriori è la lesionedel nervo facciale [9]. Come ogni sistema di monitoraggio, la suainstallazione deve essere particolarmente rigorosa, a garanziadella sua affidabilità, e l’operatore deve assicurarsi durante tuttol’intervento del suo buon funzionamento. Esso non ha lo scopodi sostituire la vigilanza e l’esperienza dell’operatore, macostituisce un sistema di allarme supplementare.
Precauzioni intraoperatorieRispetto degli organi nobili: si deve prestare attenzione a
rispettare l’orecchio interno, il nervo facciale, le meningi e ilseno laterale.
Prevenire il trauma cocleare: si deve evitare ogni contatto trala fresa e la catena ossiculare, in particolare con l’incudine, inoccasione di un’antroatticotomia o di una mastoatticotomia. Lefrese taglienti sono più dannose delle frese diamantate.
La durata della fresatura è, perciò, un elemento importante esi ha interesse a utilizzare delle frese ben taglienti, con unmotore potente, per ridurre la durata della fresatura. Bisognautilizzare degli aspiratori del diametro più piccolo possibile, inquanto il rumore generato dall’aspirazione è proporzionale alcalibro di quest’ultima.
Protezione del lembo timpanomeatale in caso di alesaggio delcondotto: o ponendo una piccola spugna nel condotto almomento della fresatura della porzione laterale o intercalandouna linguetta di carta della confezione del filo di sutura tra lafresa e il lembo al momento della fresatura della parte medialedel condotto.
Rispetto della mucosa della cassa.Padronanza della fresatura: bisogna utilizzare un materiale in
perfetto stato e delle frese che taglino perfettamente. Il mani-polo deve essere tenuto come una penna, mantenendo perma-nentemente degli appoggi sotto gli avambracci o le mani. Lafresatura si realizza con il lato della fresa attraverso movimentidi sfioramento e in un piano parallelo rispetto a quellodell’organo sensibile (fresatura parallela al tegmen in occasionedella sua scheletrizzazione). Bisogna evitare di lavorare inprofondità in un pozzo e, al contrario, bisogna tentare sempredi abbassare al massimo i margini di una cavità. Se si è obbligatia lavorare in un pozzo, è più prudente utilizzare il curettage.
Emostasi: deve essere effettuata regolarmente.
.
Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie ¶ I – 46-080
3Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

Pulizia delle cavità al termine dell’intervento: è importantenon lasciare nelle cavità posteriori e, soprattutto, nella cassa deltimpano dei frammenti di osso o della polvere di osso, inquanto rischiano di ostacolare il buon funzionamento delsistema timpano-ossiculare.
■ Vie di accesso nelle parti mollie chiusura [6]
La via di accesso condiziona la qualità dell’intervento. Peraggredire le cavità posteriori dell’orecchio medio, la scelta è trala via retroauricolare e la via endoaurale prolungata (o allar-gata). Esse permettono un’esposizione soddisfacente dellestrutture più profonde e il prelievo di materiali autologhi.
Via retroauricolare [6, 8]
Per offrire il campo operatorio migliore sulla mastoide e,soprattutto, sull’attico, questa incisione deve essere posteriorema anche superiore. Rispetto al solco retroauricolare, l’incisionepuò essere realizzata molto vicino al solco o al suo interno,producendo una cicatrice di solito invisibile, ma questo limitaa volte l’accesso alla parte posteriore di una cavità mastoideamolto pneumatizzata; peraltro, alcuni pazienti avvertonofastidio quando indossano gli occhiali a livello dell’estremitàdelle stanghette a contatto con la cicatrice. Essa può essereanche realizzata a distanza dal solco retroauricolare nel cuoiocapelluto, il che offre un accesso molto più ampio ma richiedeun importante scollamento mastoideo e può dare una cicatricevisibile.
Al momento della chiusura, è molto importante riancorare illembo fibroperiosteo sottocutaneo per evitare una stenosi delcondotto fibrocartilagineo per collasso della conca. La suturacutanea è realizzata in due piani, con un piano sottocutaneocon filo riassorbibile o non riassorbibile e un piano cutaneo conun filo monofilamento non riassorbibile.
Nel neonato e nel lattante, l’apice mastoideo non è svilup-pato; il rischio è di ledere il nervo facciale attraverso un’inci-sione retroauricolare classica. Nel lattante fino a 2 anni,l’incisione deve, quindi, essere quanto più orizzontale possibile.Deve evitare la regione del solco retroauricolare e l’apicemastoideo, dove il nervo facciale è molto superficiale. Inpratica, questa incisione non deve scendere sotto una lineaorizzontale che passa per il bordo inferiore del meato acustico(Fig. 3).
Via endoaurale prolungata [6]
Per offrire un campo migliore sulla mastoide, l’incisione deveessere prolungata sopra il padiglione molto all’indietro e poideve scendere, eventualmente, nel cuoio capelluto. Al terminedell’intervento, è importante assicurare la ricostruzione dellegamento anteriore del padiglione, riancorandolo alla spinadell’elice.
I vantaggi di questa via di accesso sono numerosi:• un ampio accesso a tutta la regione temporale e all’aponeu-
rosi temporale superficiale;• una visibilità molto buona dei diversi elementi anatomici del
meato, che consente una meatoplastica nelle migliori condi-zioni;
• questa via può essere prolungata secondo necessità in fun-zione delle esigenze di accesso alle cavità posteriori; unintervento per chirurgia di otite cronica può iniziare con unavia del condotto o una via endoaurale a minima, che puòessere ampliata a una via endoaurale prolungata, se è neces-sario realizzare un tempo chirurgico sulle cavità posteriori(Fig. 4).
Chiusura e zaffaggio del condotto uditivoLo zaffaggio del condotto uditivo esterno si impone dal
momento in cui è presente un’incisione a livello del meato. Lamembrana timpanica è coperta con frammenti di spugnariassorbibile. Un tampone espandibile è posizionato nelcondotto uditivo esterno al fine di riaccollare bene il lembotimpanomeatale al condotto osseo. Uno zaffo imbevuto dipomata antibiotica (tipo acido fucidico) è posto a livello delmeato, con l’orecchio protetto da una medicazione. La rimo-zione dello zaffo avviene tra il 5o e l’8o giorno postoperatorio.
“ Punto importante
La realizzazione di un intervento sulle cavità posterioridell’orecchio medio richiede un certo numero diprecauzioni:• preoperatorie:C l’indicazione operatoria deve essere posta con rigore
e il paziente deve essere chiaramente informato degliobiettivi e dei rischi dell’intervento
C la preparazione della cartella deve essere minuziosa egli ultimi esami (in particolare audiometrici eradiologici) devono essere affissi in sala operatoria;
• intraoperatorie:C un’installazione non corretta espone all’insorgenza
di complicanzeC rispettare gli organi nobili: nervo facciale, orecchio
interno, meningi, seno lateraleC proteggere il lembo timpanomeatale durante la
fresatura.
Figura 3. Via retroauricolare.A. L’incisione cutanea può essere più o meno distanziata dal solcoretroauricolare.B. Incisione del condotto nella sua porzione posteriore alla giunzionecondotto osseocondotto fibrocartilagineo.
I – 46-080 ¶ Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie
4 Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

■ Tempi ossei
Antrotomia
PrincipioTutti gli interventi chirurgici sulle cavità posteriori hanno in
comune la realizzazione di un’antrotomia che consistenell’aprire la principale cellula mastoidea. Si può distinguerel’antrotomia superficiale, dove le cellule periantrali superficialisono aperte senza arrivare fino all’antro, dall’antrotomiacompleta. Un errore è confondere la cellula periantrale (detta diLenoir) con l’antro (Fig. 5).
Indicazioni
Antrotomia superficiale
Permette di verificare la pervietà antroatriale quando lamastoide è molto pneumatizzata.
Essa costituisce una presa d’aria che neutralizza l’iperpressioneindotta dalla diffusione dei gas anestetici nell’orecchio mediodurante l’anestesia generale. Questa iperpressione è, a volte,molto fastidiosa in occasione della realizzazione di una mirin-goplastica, in quanto provoca spesso una protrusione deltrapianto.
Antrotomia
Permette di verificare la pervietà antroatriale quando l’aper-tura delle cellule superficiali è insufficiente.
Essa permette l’esplorazione preventiva delle cavità posteriorialla ricerca di eventuali lesioni infiammatorie mastoidee,precisando lo stato della mucosa della regione antrale.
Realizzazione pratica
La zona di attacco iniziale dell’antrotomia è la regione sopra-e retromeatale, situata appena posteriormente alla spina diHenlé. L’antrotomia deve essere realizzata solo dopo aver alesatola parete posterosuperiore del condotto. Questa nozione èfondamentale perché, se l’alesaggio è intrapreso dopo l’antroto-mia, la sua realizzazione può richiedere di intaccare la porzionelaterale del condotto osseo. È, quindi, preferibile realizzaredapprima l’alesaggio posterosuperiore, per poter assottigliare erendere perfettamente rettilineo il condotto osseo. Ciò facilita ilreperimento del nervo facciale e dell’incudine, così come larealizzazione di un’eventuale timpanotomia posteriore (Fig. 6).
Durante la realizzazione di un’antrotomia, si deve pensare a:• rispettare il seno sigmoide che è, a volte, fortemente proci-
dente e molto superficiale e che può essere danneggiato findai primi giri di fresa;
• evitare di ledere la dura madre temporale, scheletrizzandolacon una fresa non aggressiva e dei movimenti paralleli altegmen;
“ Punto importante
La via di accesso nelle parti molli deve essere adattataall’intervento da realizzare.Via endoaurale allargata:• permette un accesso diretto sul meato per realizzareuna meatoplastica• impone una ricostruzione rigorosa del legamentoanteriore dell’elice.Via retroauricolare:• l’accesso deve essere posterosuperiore• impone di risuturare bene il periostio durante lachiusura, per evitare di provocare un collasso del meato.
Figura 4. Via endoaurale prolungata.A. Tracciato dell’incisione cutanea superficiale.B. Aspetto generale dopo il posizionamento dei divaricatori autostaticie spostamento del padiglione verso il basso e all’indietro. Figura 5. Cellula di Lenoir.
A. Sezione TC assiale. 1. Cellula di Lenoir; 2. antro; 3. attico. Freccia:lamina petrosquamosa che divide le cellule antrali superficiali dall’antro.B. Antrotomia condotta fino alla lamina petrosquamosa.
Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie ¶ I – 46-080
5Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

• rispettare il gomito del nervo facciale e il labirinto posteriore.Per questo, bisogna, al minimo dubbio, trovarsi in profonditàrispetto al solco timpanico. Questo piano del solco timpaniconon deve mai essere superato senza assumere altri repericome l’apofisi corta dell’incudine.La fresatura deve essere realizzata con delle frese mordenti ma
non aggressive nei confronti della dura madre o del senolaterale. Bisogna evitare di realizzare una perforazione alla ciecaattraverso un orifizio stretto ma, al contrario, bisogna ampliarefin da subito le cavità, disegnando un triangolo i cui lati sonorappresentati da:• la parete anteriore parallela al condotto osseo;• la parete posteriore parallela al tragitto del seno laterale;• la parete superiore parallela al tegmen.
Mastoidectomia
Principio
Essa corrisponde alla messa a piatto di tutte le cellulemastoidee, il cui tempo iniziale è l’antrotomia. Una mastoidec-tomia è raramente realizzata senza atticotomia, in quanto, il piùdelle volte, la presenza di lesioni infiammatorie imponel’esplorazione e il trattamento dell’insieme mastoatticale.
La mastoidectomia richiede:• la scheletrizzazione del tegmen e del seno laterale situati
rispettivamente superiormente e posteriormente;• in avanti, l’assottigliamento del condotto osseo a spese della
sua parete posteriore, preliminare all’apertura delle celluleintersinusofacciali, alla realizzazione della timpanotomiaposteriore nonché alla localizzazione della parte mastoideadel VII;
• di restare sempre laterali rispetto al piano che passa perl’apofisi corta dell’incudine e al rilievo del canale semicirco-lare laterale da una parte e per la parete mediale dell’apicemastoideo dall’altra.
Indicazioni
• Mastoidite e osteite mastoidea.• Accesso alla terza porzione del nervo facciale.• Accesso al sacco endolinfatico.• Accesso translabirintico.• Accesso per posizionamento di un impianto cocleare o di
alcune protesi impiantabili dell’orecchio medio.
Realizzazione pratica
L’incisione deve essere prudente in caso di ascesso sottope-riosteo o in occasione di una ripresa chirurgica per evitare diledere la meninge o il seno sigmoide, che potrebbero esseredenudati.
Si realizza un’antrotomia (Fig. 7A).Quindi, messa a piatto delle cellule intersinusofacciali
(Fig. 7B).Svuotamento della regione dell’apice (Fig. 7C): il pericolo
principale è rappresentato dal nervo facciale, situato nellaporzione anteriore della cresta digastrica. Lo svuotamentocompleto dell’apice richiede di abbattere completamente lacorticale esterna. La cresta digastrica deve essere rapidamentereperita per localizzare il nervo facciale che emerge dallamastoide al forame stilomastoideo. Bisogna, innanzitutto,completare la scheletrizzazione del seno laterale nella suaporzione inferiore, sapendo che il punto più declive del bordoanteriore del seno si trova a una distanza di 4-9 mm posterior-mente al nervo facciale. La cresta digastrica è, successivamente,scheletrizzata in senso posteroanteriore. La sua identificazione è,a volte, difficile e si può creare facilmente una falsa crestadigastrica. Per evitare questo, si ha interesse a denudare ilmuscolo digastrico nella sua porzione posteriore e a proseguirela scheletrizzazione in avanti fino a scoprire la guaina del nervofacciale.
Svuotamento della regione sottofacciale: questa regioneappare come il prolungamento della lamina intersinusofacciale,situata medialmente rispetto alla terza porzione del nervofacciale e sotto il canale semicircolare posteriore. Il suo accessorichiede la completa scheletrizzazione del seno lateraleall’indietro e l’identificazione della metà inferiore della terzaporzione del canale facciale. Il canale semicircolare posterioredeve essere risparmiato evitando di oltrepassare verso l’alto unalinea che passa per l’asse dell’apofisi breve dell’incudine. D’altraparte, il golfo della giugulare può essere danneggiato acciden-talmente nella parte profonda della regione sottofacciale.
Si completa la mastoidectomia con la messa a piatto dellecellule retrosinusali, del recesso zigomatico e delle cellule
VII
A
Figura 6. Antrotomia.A. Sezione assiale obliquache passa per il condottouditivo esterno e la fossa an-trale. VII: nervo facciale.B. Antrotomia completa.1. Apofisi breve dell’incu-dine; 2. rilievo del canalesemicircolare laterale.
“ Punto importante
Prima di realizzare l’antrotomia: rettificare bene ilcondotto uditivo esterno, al fine di non intaccare il suobordo laterale durante quest’ultima.
I – 46-080 ¶ Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie
6 Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

temporali superficiali che sono spesso sede di osteite nelbambino che presenta una mastoidite (Fig. 7D).
Antroatticotomia e mastoatticotomia
Principio
Lo scopo di questi interventi è quello di accedere all’atticoper via mastoidea, per contrapposizione all’accesso transcana-lare, sacrificando il muro della loggetta. Il rischio è il traumacocleare in caso di fresatura accidentale degli ossicini quando lacatena ossiculare è continua. Una seconda difficoltà è laconservazione del condotto uditivo e, in particolare, del murodella loggetta, in caso di procidenza del tegmen.
Indicazioni
Le grandi indicazioni di questi interventi sono:• la cura delle lesioni infiammatorie dell’otite cronica colestea-
tomatosa o non colesteatomatosa;
• l’accesso e il trattamento delle sequele dell’otite cronica, inparticolare per la cura dell’anchilosi della testa del martello;
• nella chirurgia implantologica per gli impianti dell’orecchiomedio di tipo Otologics®, l’antroatticotomia deve essereperfettamente calibrata per controllare bene il posiziona-mento del trasduttore e la fissazione del dispositivo suimargini della cavità;
• essa rappresenta anche il primo tempo chirurgico per affron-tare le tre porzioni del nervo facciale.
Realizzazione pratica (Fig. 8)
Un tempo essenziale preliminare consiste nel verificare lacontinuità della catena ossiculare esplorando la regioneincudostapediale.
Il rischio cocleare scompare in gran parte in caso di interru-zione della catena ossiculare. Viceversa, in caso di catenacontinua, il minimo contatto ossiculare con una fresa (che hageneralmente delle conseguenze catastrofiche per l’orecchiointerno) deve essere sempre evitato.
1
2
3
4B
1
2
3
4
5 C
Figura 7. Mastoidectomia.A. Antrotomia.B. Messa a piatto delle cellule intersinusofacciali. 1. 3a porzione del nervo facciale; 2. canale semicircolare laterale; 3. seno laterale; 4. spazio intersinusofacciale.C. Svuotamento dell’apice. 1. 3a porzione del nervo facciale; 2. canale semicircolare laterale; 3. canale semicircolare posteriore; 4. seno laterale; 5. regionesottofacciale.D. Mastoidectomia completa. 1. Canale semicircolare laterale; 2. nervo facciale; 3. cresta digastrica; 4. seno laterale.
Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie ¶ I – 46-080
7Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

I diversi tempi dell’intervento sono i seguenti.Primo tempo: antrotomia ampia o mastoidectomia.Secondo tempo: reperimento della regione della fossa incudis
che è vicina alla parte posteriore del rilievo del canale semicir-colare laterale e alla parte più posteriore del condotto osseo. Avolte, il reperimento di questa zona è difficile, poiché il rilievodel canale laterale è poco visibile.
Terzo tempo: realizzazione di una trincea ossea nel massiccioatticale scheletrizzando il tegmen temporale che è un reperefondamentale in alto e il polo superiore del condotto osseo inbasso. In effetti, si riduce notevolmente il rischio di fresaturaaccidentale dell’incudine o del canale facciale rimanendo a filodel tegmen temporale. Durante la realizzazione di questa trinceaatticale, occorre conservare una lamina ossea di protezioneossiculare in profondità (Fig. 8A).
Quarto tempo: scopertura dell’apofisi breve dell’incus eaccesso alla loggetta degli ossicini in senso posteroanteriore. Lascopertura dell’apofisi breve dell’incudine viene effettuata con lacurette, esercitando dei movimenti dal basso in alto e ruotandola testa del paziente in posizione opposta rispetto a quelladell’operatore. Una volta reperita l’incudine, l’atticotomia puòessere proseguita con fresa diamantata. Quando il contattoossiculare è prossimo, è preferibile utilizzare una curette(Fig. 8B).
Timpanotomia posteriore [6, 8]
PrincipioÈ l’apertura della cassa del timpano per via mastoidea a spese
del recesso facciale (Fig. 9A).Il recesso facciale corrisponde a un triangolo osseo ad apice
inferiore delimitato medialmente dal nervo facciale, lateral-mente dalla corda del timpano e in alto dalla fossa incudis.
La realizzazione corretta di una timpanotomia posteriorerichiede di alesare il condotto uditivo esterno, che deve essereperfettamente rettilineo e assottigliato, di abbassare il piùpossibile i margini posteriori e superiori della cavità mastoidea,di scheletrizzare il tegmen mastoideo e di individuare l’apofisibreve dell’incudine.
I rischi di questo intervento sono, innanzitutto, la labirintiz-zazione per contatto della fresa con l’incudine, la lesione delnervo facciale e, infine, l’intaccatura accidentale del sulcus conuna timpanotomia posteriore troppo laterale.
Si possono distinguere tre tipi di timpanotomia posteriore:• la timpanotomia posteriore e superiore che corrisponde
all’assottigliamento della porzione posteriore del muro dellaloggetta;
• la timpanotomia posteriore e inferiore, dove persiste unponte osseo di protezione dell’incudine;
• la timpanotomia posteriore completa che comporta l’aperturadi tutto il recesso facciale.
Indicazioni
Otiti croniche: la timpanotomia posteriore può avere dueinteressi nell’otite cronica. Il primo è la possibilità di resecaredelle lesioni infiammatorie o epidermiche a livello del recessofacciale. Si tratta, in questi casi, di una timpanotomia posteriorecompleta. Essa può avere anche un ruolo di aerazione, assicu-rando una comunicazione ampia tra la cassa del timpano e lecavità posteriori. In questo caso, è sufficiente una timpanotomiaposteriore e superiore.
Chirurgia del nervo facciale: l’esposizione del gomito delnervo facciale richiede la realizzazione di una timpanotomiaposteriore completa.
Chirurgia protesica: impianto cocleare o protesi impiantabiledi orecchio medio.
Realizzazione pratica
Realizzazione preliminare di un’antroatticotomia o di unamastoatticotomia.
Abbassamento dei margini superiori e posteriori della cavitàper non limitare i movimenti della fresa a livello della regionedel recesso facciale.
Alesaggio del condotto osseo: il condotto uditivo esternonella sua porzione posteriore e superiore deve essere perfetta-mente rettilineo e, soprattutto, assottigliato, nella sua partelaterale così come nella sua parte mediale. Ciò permette divedere allo stesso tempo sul lato timpanico la regione incudos-tapediale e il sulcus e, sull’altro lato del condotto, l’incudine ela zona di accesso della timpanotomia posteromediale.
Apertura del recesso facciale: questa zona di accesso è situatain un piano che passa attraverso l’apofisi breve dell’incudine,appena al di sopra dell’estremità dell’apofisi breve (Fig. 9B). Sideve conservare un ponte osseo di protezione se la catena ècontinua e mobile. Non vi sono rischi di lesione del nervofacciale, se si presta attenzione a non oltrepassare medialmentequesto limite. Il limite laterale della timpanotomia posteriore èla corda del timpano. L’angolo inferiore è segnato dalla giun-zione della corda del timpano con la terza porzione del nervofacciale. L’integrità del sulcus è assicurata attraverso la doppiavisione da una parte e dall’altra del condotto. La timpanotomiaposteriore è, poi, prolungata verso il basso. La fresatura deve
Figura 8. Antroatticotomia.A. Realizzazione di una trincea ossea a livello della parete laterale e posteriore dell’attico. Freccia: individuazione della zona degli ossicini a livello della verticaleche passa per la parete posteriore del condotto osseo.B. Accesso alla loggetta degli ossicini.1. Apofisi breve dell’incudine; 2. rilievo del canale semicircolare laterale; 3. martello.
I – 46-080 ¶ Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie
8 Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

essere molto più prudente verso il basso, a causa della lateraliz-zazione progressiva del nervo facciale, che raggiunge la corda deltimpano nella parte inferiore della timpanotomia (Fig. 9C, D).
Casi particolari della chirurgia implantologica
Impianto cocleare [10]
Si realizza una timpanotomia posteriore e inferiore al fine diesporre la regione della finestra rotonda. Il porta-elettrodi è fattoscivolare fin nella rampa timpanica della coclea attraverso latimpanotomia posteriore. È importante non denudare il nervofacciale per evitare delle stimolazioni facciali indesiderabilidurante il funzionamento dell’impianto (Fig. 10A).
Protesi impiantabile di orecchio medio: tipo VibrantSoundbridge® [11]
Il posizionamento di questo tipo di protesi richiede larealizzazione di una timpanotomia posteriore molto ampia, diun’altezza di 3 mm, per lasciar passare la massa fluttuante(trasduttore) che deve essere ancorata all’incudine (Fig. 10B). Perquesto, è spesso necessario visualizzare perfettamente la cordadel timpano e il canale facciale a livello del suo gomito. Èimportante lasciare una tettoia ossea di protezione in corrispon-denza dell’apofisi breve dell’incudine, ma essa non deve esseretroppo marcata, per non ostacolare la visualizzazione del ramo
discendente dell’incudine sul quale sarà ancorata la massafluttuante della protesi (Fig. 10C).
Atticotomia per via transcanalare
Principio
Contrariamente all’atticotomia transmastoidea che rispettal’integrità del muro della loggetta, l’atticotomia transcanalare losacrifica tutto o in parte. Perciò, tale intervento ne impone laricostruzione al termine del gesto chirurgico.
Indicazioni
Colesteatoma saccato limitato all’attico esterno [12] i cui limitisono stati precisati da un esame TC preoperatorio. La lesionenon deve estendersi alla parte mediale dell’attico né allamastoide.
Accesso a un’anchilosi della testa del malleolo.
Realizzazione pratica
Dopo l’accesso attraverso il condotto o preferibilmente pervia endoaurale, l’atticotomia è effettuata mediante fresatura confresa diamantata, al fine di assottigliare il muro della loggetta.In caso di catena ossiculare continua, esiste un rischio di
1
2
A
1
2
3
B
Figura 9. Timpanotomia posteriore.A. Zona di resezione che corrisponde al recesso facciale. 1. 3a porzione del nervo facciale; 2. canale semicircolare laterale.B. Importanza dell’alesaggio della parete posterosuperiore del condotto che deve consentire una doppia visione allo stesso tempo sul sulcus e sulla zonadi timpanotomia. 1. Sulcus; 2. 3a porzione del nervo facciale; 3. canale semicircolare laterale.C. Timpanotomia posteriore con conservazione di un ponte osseo di protezione dell’incudine.D. Aspetto terminale. 1. Canale semicircolare laterale; 2. nervo facciale.
Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie ¶ I – 46-080
9Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

labirintizzazione per contatto tra la fresa e la catena ossiculare;inoltre, è più prudente terminare il gesto resecando la sottilelamina ossea residua con la curette (Fig. 11).
L’oto-video-endoscopia assicura il controllo della totalitàdell’exeresi di un colesteatoma e permette di completarla, senecessario.
1
2
3
4
5
6
7
A
1
C
Figura 11. Atticotomia per via transcanalare.A. Soppressione del muro della loggetta con curette. 1. Martello; 2. incudine; 3. nervo facciale; 4. piramide; 5. staffa; 6. nicchia della finestra rotonda;7. ipotimpano.B. Attico aperto.C. Ricostruzione del muro della loggetta con un innesto composito cartilagine-pericondrio (1).
Figura 10. Chirurgia implantologica.A. Impianto cocleare. Timpanotomia posteriore e inferiore prima dell’impianto.Frecce: finestra rotonda. 1. Canale semicircolare laterale; 2. apofisi breve dell’in-cudine; 3. canale facciale (3a porzione).B. Impianto cocleare. Portaelettrodo in sede. 1. Canale semicircolare laterale;2. apofisi breve dell’incudine; 3. canale facciale (3a porzione).C. Protesi impiantabile di orecchio medio.
I – 46-080 ¶ Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie
10 Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

La ricostruzione del muro della loggetta è realizzata con uninnesto condropericondrale tragale; i margini pericondralidell’innesto permettono di prendere appoggio sui margini ossei.
Chirurgia endoscopica
Principio e indicazioniL’interesse dell’oto-video-endoscopia è quello di controllare e
completare l’exeresi delle lesioni (in particolare colesteatoma-tose) in regioni di difficile accesso, come il retrotimpano e, inparticolare, il sinus tympani, l’ipotimpano, così come l’epitim-pano anteriore; ciò è utile al momento del primo tempo diexeresi di un colesteatoma e permette di ridurre in manierasignificativa il tasso di colesteatomi residui [13].
Il secondo interesse dell’oto-video-endoscopia è quello diridurre il carattere invasivo dell’accesso chirurgico alle cavitàposteriori [14] al momento di un secondo tempo di revisionechirurgica con tecnica chiusa. Si realizza una piccola incisioneretroauricolare di 1 cm; in caso di controllo visivo insufficiente,si può convertire l’accesso chirurgico in una via più ampia [15].
Realizzazione praticaLa videoendoscopia dell’orecchio medio richiede un materiale
specifico:• ottiche corte a visione retta e obliqua del diametro di 2,5 mm
con illuminazione attraverso una fonte di luce allo xeno;• la visione su monitor è preferibile alla visione diretta
nell’ottica;• microstrumenti specifici angolati (microaspiratori, uncino
bottonuto, uncino da colesteatoma, micropinze).Un operatore destrimane tiene camera e ottiche nella mano
sinistra e i microstrumenti nella mano destra, con una manipo-lazione prudente delle ottiche, in particolare in caso di sovras-truttura della staffa in sede, per non rischiare di provocare unalussazione.
L’emostasi deve essere rigorosa e richiede la resezione preli-minare di tutte le lesioni mucose; l’emostasi può essere miglio-rata dall’utilizzo di pallottoline di spugna di collagene (tipoPangen) imbevute di una soluzione di adrenalina 1/1 000.
Cavità di svuotamento
PrincipioÈ la messa a piatto dell’insieme delle cavità mastoatticali. Gli
obiettivi di questa cavità sono:• permettere un accesso permanente a tutte le zone dell’orec-
chio medio, per il monitoraggio otoscopico;• evitare ogni recesso o sacca di retrazione in grado di mante-
nere un focolaio di infezione: fossetta sopratubarica dell’atticoanteriore, salienza del becco del nervo facciale, rilievo delmuro del nervo facciale e anfrattuosità dell’apice mastoideo.Le qualità essenziali di una cavità di svuotamento sono il
carattere regolare e armonico nonché una grandezza del meatoadatta al volume della cavità.
Indicazioni
• Chirurgia dell’otite cronica colesteatomatosa [16].• Resezione dei tumori primitivi dell’orecchio medio o estesi
all’orecchio medio (per esempio, paragangliomi timpanici).La decisione di creare una cavità di svuotamento nel caso
delle otiti colesteatomatose può essere presa:• fin dall’inizio, prima dell’intervento in funzione dell’esten-
sione delle lesioni all’esame TC, delle possibilità di monito-raggio del paziente e del numero di interventi già effettuati;
• più raramente, durante il tempo di esplorazione chirurgica, infunzione dei dati anatomici. Una procidenza importante dellemeningi e del seno laterale può ostacolare la realizzazione diun’atticotomia anteriore o di una timpanotomia posteriore eporta a prendere in considerazione uno svuotamento. L’otiteosteomatosa rappresenta l’estremo in cui i reperi classici sonomascherati entro un blocco osseo. In questo caso, la cavità disvuotamento è l’opzione meno pericolosa.
Realizzazione pratica
L’intervento può essere scomposto in sette tempi operatori(Fig. 12).
Primo tempo: esplorazione della cassa e mastoatticotomiasufficientemente ampia per esplorare l’insieme delle cavitàposteriori e per realizzare un bilancio delle lesioni della pareteossea e della catena ossiculare. Essa comporta, in particolare, lascheletrizzazione del seno sigmoide e del tegmen (Fig. 13A).
Secondo tempo: soppressione del muro della loggetta e dellaparete posteriore del condotto osseo. La regione del becco delfacciale è regolarizzata con fresa diamantata per metterecompletamente a piatto il recesso facciale (Fig. 13B).
Terzo tempo: abbassamento del margine mastoideo posterioree superiore, in funzione della situazione del seno sigmoide, avolte a spese delle cellule retrosinusali. La riduzione dell’altezzadei margini della cavità è un elemento essenziale per ridurre ilsuo volume finale, diminuendo la sua altezza.
Quarto tempo: esclusione o regolarizzazione dell’apice. Nelcaso in cui la mastoide sia molto eburnea, è sufficiente unasemplice regolarizzazione della regione dell’apice. Negli altricasi, quando la mastoide è molto pneumatizzata, la corticalemastoidea dell’apice è completamente abbattuta fino a livellodella cresta digastrica, cioè dell’inserzione del ventre posterioredel muscolo digastrico. L’apice è, allora, completamente messoa piatto, conservando soltanto la sua parete mediale.
Quinto tempo: abbassamento del muro del nervo facciale.Questo tempo deve essere affrontato solo se tutti gli altri tempiprecedenti sono stati correttamente realizzati, in particolare laregolarizzazione della regione del becco del nervo facciale. Ineffetti se, da una parte, il nervo facciale è correttamente reperitoa livello del gomito, dall’altra, in basso a livello dell’estremitàanteriore della cresta digastrica, il muro del facciale può essereabbassato senza rischio. Si deve utilizzare una grossa fresadiamantata non appena ci si trova in prossimità del nervo esotto buona irrigazione (Fig. 13C, D).
Sesto tempo: regolarizzazione dell’attico. La fossetta sopratu-barica che corrisponde al recesso atticale anteriore, situatadavanti al tendine del muscolo tensore del martello, deve essere,in genere, largamente aperta per essere esplorata. La suaapertura richiede di abbattere un setto osseo la cui inserzionemediale è in rapporto molto intimo con la prima porzione delnervo facciale e con il ganglio genicolato.
1
25
4
76
3
3
Figura 12. Cavità di svuotamento: schema che rappresenta i 7 tempioperatori. 1. Mastoatticotomia; 2. soppressione del muro della loggetta eregolarizzazione del becco del facciale; 3. abbassamento dei marginimastoidei; 4. regolarizzazione dell’apice; 5. abbassamento del muro delnervo facciale; 6. regolarizzazione delle pareti anteriori e inferiori delcondotto osseo; 7. regolarizzazione dell’attico anteriore.
Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie ¶ I – 46-080
11Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

1
2
C
Figura 13. Cavità di svuotamento.A. Mastoatticotomia.B. Soppressione del muro della loggetta e regolarizzazione del becco del facciale.C. Regolarizzazione del becco del facciale. 1. 2a porzione del nervo facciale; 2. canale semicircolare laterale.D. Abbassamento del muro del facciale (vista intraoperatoria). Un frammento di carta di confezione di filo di sutura protegge il lembo timpanomeatale dallafresa diamantata.E. Svuotamento terminato. 1. Tendine del muscolo del martello; 2. canale semicircolare laterale; 3. staffa; 4. 3a porzione del nervo facciale; 5. seno laterale.
I – 46-080 ¶ Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie
12 Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

Settimo tempo: regolarizzazione delle pareti anteriori einferiori del condotto osseo.
Al termine dell’intervento, la cavità non deve presentarenessun rilievo acuto e nessun recesso. L’impressione è, in effetti,tanto tattile quanto visiva (Fig. 13E).
Cavità incompleta
Non si deve accettare alcun compromesso sull’apertura dellaparete posteriore del condotto, in quanto gli abbassamentiincompleti del massiccio del nervo facciale e le antrotomietranscanalari senza ricostruzione del muro della loggetta sonofonte di ritenzione epidermica, di sovrainfezione e di recidiva dicolesteatoma. Viceversa, la conservazione del muro dellaloggetta si può, talora, giustificare quando le lesioni rispettanol’attico anteriore. È, allora, possibile conservare il muro dellaloggetta e chiudere l’attico posteriormente con un frammento dicartilagine, evitando, così, le retrazioni atticali e sopratubariche,a volte fonte di ritenzione.
Svuotamento e timpanoplastica
Timpanoplastica e cavità di svuotamento non sono incontraddizione.
Una miringoplastica realizzata facendo scivolare un fram-mento di aponeurosi temporale o della cartilagine sotto i residuidella membrana timpanica permette di evitare un’otorreatubarica.
Un’ossiculoplastica può essere realizzata come in una tecnicachiusa, o fin dall’inizio o in un secondo tempo operatorio [17, 18].
Quando la sovrastruttura della staffa è conservata, questa puòessere rialzata semplicemente con un piccolo frammento dicartilagine. In alcuni casi, anche in assenza di ricostruzioneossiculare, una miringostapedopessi può dare un eccellenterisultato funzionale.
È spesso possibile l’uso di un innesto autologo ossiculare o diuna protesi in biomateriale.
In assenza di una sovrastruttura della staffa, il miglioramentodell’udito può essere ottenuto grazie a una piccola cassa(timpanoplastica di tipo IV di Wullstein) [19], che ripristina losfasamento fisiologico tra finestra ovale e finestra rotonda.
Rivestimento mastoideo
L’epidermizzazione della cavità è assicurata in parte dal lembotimpanomeatale riposizionato al termine dell’intervento con lanecessità di incisione di scarico. L’epidermizzazione diretta apartire dall’osso è spesso lenta e di qualità scadente. È, quindi,vantaggioso tappezzare le pareti della cavità con un frammentomolto grande di aponeurosi temporale, per fornire un sotto-suolo connettivo favorevole a un’epidermizzazione. Questaepidermizzazione può essere accelerata dall’utilizzo di fram-menti di innesto cutaneo, come gli innesti di Davis o un lemboretroauricolare [20]. La colla biologica facilita il posizionamentodegli innesti.
Meatoplastica [6, 8] (Fig. 14)
Essa rappresenta l’ultima fase dell’intervento, ma determinain gran parte la riuscita e la buona tolleranza della cavità disvuotamento [21]. La sua grandezza deve essere adattata alvolume della cavità; vale a dire che una grande cavità devebeneficiare di un’ampia meatoplastica, mentre una piccolacavità può accontentarsi di un meato acustico esterno didimensioni normali. La via endoaurale allargata offre un accessomolto comodo al meato [6]. È possibile realizzare, così, unameatoplastica extracartilaginea, che rispetta la cartilagineconcale, oppure una meatoplastica transcartilaginea, asportandoun frammento di cartilagine concale e ottenendo un meatomolto più ampio.
Figura 14. Meatoplastica a spese della conca.A. Disegno della zona meatale da resecare.B. Localizzazione della zona da resecare dopo basculamento del padiglionedell’orecchio all’indietro.C. Meatoplastica transcartilaginea: aspetto finale.
Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie ¶ I – 46-080
13Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

Chiusura
La cavità è ricoperta con un foglio di silicone (Silastic®), alfine di evitare qualsiasi aderenza tra il rivestimento della cavitàe il tampone espandibile posto in questa; quindi, uno zaffoimbevuto di pomata antibiotica (tipo acido fusidico) è inseritonel meato.
Riempimento delle cavità posterioriSi può applicare bene tanto alle tecniche chiuse quanto alle
cavità di svuotamento [21, 22].
Indicazioni
Al momento della realizzazione di una cavità di svuotamento,la presenza di cavità posteriori pneumatizzate induce a realizzareun riempimento parziale di questa cavità, per ridurre il suovolume e per assicurare una migliore tollerabilità. In effetti, lariduzione delle dimensioni della cavità facilita la cicatrizzazionee la migrazione epidermica laterale e le capacità di autopuli-mento e, quindi, sopprime quasi tutti i problemi di tollerabilitàcutanea che possono essere osservati dopo la cavità di svuota-mento. D’altra parte, il riempimento può essere realizzato in unsecondo tempo su delle cavità di svuotamento mal tollerate.
Nella tecnica chiusa, il riempimento delle cavità posteriori,sopprimendo il serbatoio aereo e lo sviluppo di una nuova saccadi retrazione, preverrà dei rischi di recidiva vera del colestea-toma. Questa concezione si oppone all’obiettivo abituale che èquello di ristabilire la fisiologia normale dell’orecchio, conser-vando gli spazi aerei [16].
Accanto ai loro vantaggi, il principale inconveniente diqueste tecniche è quello di coprire e di rinchiudere un even-tuale residuo di colesteatoma che può evolvere in profonditàe rivelarsi, a uno stadio tardivo, attraverso delle complicanze,in quanto completamente mascherato dal materiale diriempimento. È, quindi, indispensabile un monitoraggioclinicoradiologico.
Materiali utilizzati e realizzazione pratica
Differenti materiali sono stati proposti per realizzare questoriempimento [23].
Il riempimento con un lembo connettivomuscolare, il piùconosciuto dei quali è il lembo fibroperiosteo mastoideopeduncolato sul padiglione, o lembo di Palva [24]. Possono essereutilizzati altri tipi di lembi: lembo fibroperiosteo a peduncoloperimastoideo, lembo muscolo-aponeurotico temporale apeduncolo temporale anteriore o posteriore e, infine, lembo difascia temporale superficiale con un peduncolo centratosull’arteria temporale [21, 25-28].
Materiali autologhi: la polvere d’osso mescolata a collabiologica («bone paste» [29, 30]) costituisce un materiale diriempimento interessante. È importante rivestire tutta lasuperficie libera di questo riempimento con un grande fram-mento aponeurotico, tenendo a mente che una parte di questoriempimento si riassorbirà con il tempo.
I materiali biocompatibili rappresentano un’alternativainteressante, in particolare i granuli di ceramica fosfocalcica,come il calcio fosfato bifasico macroporoso (MBCP) [31-33]. Dopol’umidificazione preliminare di questi granulati nella soluzionefisiologica, essi sono mescolati alla colla biologica. Anche inquesto caso, è importante ricoprire totalmente il biomaterialecon un frammento di tessuto connettivo o di cartilagine, perevitare la sua migrazione [6]. Questa modalità di ricostruzione èstabile e ben tollerata e presenta un’osteointegrazione com-pleta [34]. Può essere realizzata fin da subito o in un secondotempo (Fig. 15).
Monitoraggio
È necessario un monitoraggio clinico e radiologico rigorosoper individuare precocemente una recidiva.
■ Cure postoperatorie.Monitoraggio
AntibioticoterapiaL’atteggiamento adottato è differente a seconda che l’orecchio
operato sia asciutto o infetto al momento dell’intervento.Se l’orecchio è asciutto, può essere proposta una terapia
antibiotica profilattica. È una terapia antibiotica intraoperatoriaed eventualmente postoperatoria di breve durata, inferiore alle48 ore. Se l’orecchio è infetto, si impone una terapia antibioticafino alla rimozione degli zaffi. Essa deve essere mirata, inparticolare contro lo Pseudomonas aeruginosa e lo stafilococcoaureo, e, idealmente, deve essere adattata ai dati di un esamebatteriologico preoperatorio.
Cure locali e monitoraggioDopo qualsiasi chirurgia delle cavità posteriori, in particolare
dopo uno svuotamento, è indispensabile monitorare lo stato delpadiglione nei giorni che seguono l’intervento, per individuareuna pericondrite. La rimozione degli zaffi è eseguita tra il 5o el’8o giorno. Un intervento su un orecchio infetto spinge arimuovere gli zaffi più precocemente, verso il 5o giorno.
Il rigore delle cure operatorie è indispensabile per ottenereuna buona cicatrizzazione. I tessuti granuleggianti sono resecaticon pinza o cauterizzati con un Cotton-Fioc® imbevuto di acidotricloroacetico diluito a un terzo. Un trattamento con gocceantibioticocorticoidi limita la granulazione e favorisce lacicatrizzazione. Si deve, tuttavia, essere sicuri che la cassa deltimpano sia a tenuta stagna per utilizzare questo tipo di gocce.In assenza di una membrana timpanica impermeabile, è impe-rativo utilizzare delle gocce non ototossiche (fluorochinolone,rifamicina). Il paziente è rivisto 15 giorni dopo e, poi, ogni 3 o4 settimane fino alla cicatrizzazione completa. Questa cicatriz-zazione avviene in media entro 2-3 mesi per le cavità disvuotamento ed entro 3 settimane per le tecniche chiuse.
Durante il periodo di cicatrizzazione, i bagni sono da vietare.Viceversa, una cavità di svuotamento ben cicatrizzata noncontroindica sistematicamente le attività nautiche, eccetto leimmersioni subacquee.
■ Complicanze
Complicanze durante l’intervento
Ferita del seno laterale
Essa è controllata, in genere, con un tamponamento inSurgicel®.
Ferita della dura madre
Può manifestarsi molto precocemente fin dall’iniziodell’antrotomia, se la dura madre è molto procidente o sel’antrotomia è iniziata troppo in alto rispetto ai reperi abituali.La denudazione della dura madre è un incidente minore, se lasua superficie è ridotta. Oltre 1 cm, la perdita di sostanza deveessere colmata con cartilagine o con un frammento di osso,in quanto può essere fonte di un’ernia meningea omeningoencefalica.
Un’emorragia di un vaso della dura madre è arrestatamediante tamponamento di Surgicel® o coagulazione bipolare.In caso di perdita di liquor cerebrospinale, si può ingrandire
“ Punto importante
Il riempimento delle cavità posteriori dell’orecchio mediorichiede uno stretto monitoraggio clinico e radiologico.
.
.
I – 46-080 ¶ Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie
14 Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

leggermente il difetto osseo con una fresa diamantata e si puòfar scivolare un frammento di aponeurosi temporale tra l’endo-cranio e la dura madre.
Fistola del canale semicircolare lateraleQuando si sospetta una fistola del canale semicircolare
laterale, o di fronte alle immagini TC o per l’entità dell’esten-sione del colesteatoma durante l’intervento, è opportunoterminare la dissezione con la regione del canale laterale.Bisogna valutare due opzioni: lasciare in sede la matrice delcolesteatoma sulla fistola tappata oppure tentare una dissezioneminuziosa della matrice epidermica che può aderire al labirintomembranoso. La seconda opzione è, generalmente, preferibile.In questo caso, la fistola deve essere ricoperta rapidamente conun innesto di aponeurosi temporale.
Lesione del nervo faccialeUna lesione intraoperatoria del nervo facciale implica la sua
riparazione immediata, che consiste, in genere, in una resezionedella parte lesa del nervo facciale con l’interposizione di uninnesto a spese del plesso cervicale superficiale.
Complicanze postoperatorie
Paralisi faccialeIn caso di paralisi facciale postoperatoria, è importante sapere
se questa è insorta fin dal risveglio o se è comparsa dopo untempo di latenza il giorno seguente o quello successivo. In casodi paralisi facciale secondaria, il trattamento consiste nellarimozione degli zaffi e in una terapia corticosteroidea sistemica.Se la paralisi facciale è sopraggiunta a priori fin dall’inizio e se
l’operatore è sicuro di non aver danneggiato il nervo facciale, sirealizza lo stesso trattamento. Se l’operatore ha dei dubbi, sideve proporre un intervento esplorativo il più rapidamentepossibile.
La comparsa di una paralisi facciale postoperatoria secondariae tardiva deve far ipotizzare uno zoster. In caso di otite cronica,si deve anche sospettare la diagnosi di otite tubercolare.
Condrite
È una complicanza temuta ma divenuta molto rara. Compare,il più delle volte, dopo uno svuotamento associato a unameatoplastica transcartilaginea. I primi segni si manifestanospesso precocemente, fin dalla 48a ora, con dolore, infiamma-zione e arrossamento dei tegumenti del padiglione dell’orecchio.La constatazione di una condrite incipiente richiede una terapiaantibiotica per via generale orientata contro Pseudomonasaeruginosa e stafilococco aureo.
“ Punto importante
La realizzazione di un intervento sulle cavità posterioridell’orecchio medio impone la prevenzione, lo screening ela gestione precoce delle complicanze:• intraoperatorie: lesione del nervo facciale, della duramadre e del seno laterale e fistola del canale semicircolarelaterale;• postoperatorie: paralisi facciale, condrite.
Figura 15. Riempimento delle cavità posteriori.MBCP: calcio fosfato bifasico macroporoso.A. Aspetto intraoperatorio di una tecnica chiusaprima del riempimento delle cavità posteriori congranuli di MBCP.B. Aspetto intraoperatorio di una tecnica chiusadopo riempimento delle cavità posteriori con gra-nuli di MBCP.C. Riempimento con granuli di MBCP di unacavità di svuotamento; aspetto otoscopico a1 anno. I granuli di MBCP sono visibili sotto la cutedel condotto.D. Riempimento con granuli di MBCP; aspetto TCpostoperatorio.
Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie ¶ I – 46-080
15Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale

■ Riferimenti bibliografici[1] Alberti P, Rubers S. Otologic medicine and surgery. New York:
Churchill Livingstone; 1988.[2] Legent F, Perlemuter L, Vandenbrouk C. Oreille. Cahiers d’anatomie
ORL. Paris: Masson; 1984.[3] Hitier M.Anatomie du nerf facial. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris),
Otorhinolaryngologie, 20-258-A-10, 2006.[4] Malherbe A. L’évidement pétro-mastoïdien dans le traitement des
suppurations de l’oreille moyenne. Paris: Masson; 1995.[5] Sourdille M. Trépanation mastoïdienne élargie et atticotomie
transmastoïdienne. Paris: Masson; 1915.[6] Bordure P, Robier A, Malard O. Chirurgie otologique et oto-
neurologique. Paris: Masson; 2005.[7] Paparella M. Otology and neuro-otology. Philadelphia: WB Saunders;
1991.[8] Portmann M, GuerrierY. Oreille et os temporal. In: Traité de techniques
chirurgicales ORL et cervico-faciale. Paris: Masson; 1986.[9] Selesnick SH, Lynn-Macrae AG. The incidence of facial nerve
dehiscence at surgery for cholesteatoma. Otol Neurotol 2001;22:129-32.
[10] Johnson IJ, Gibbin KP, O’Donoghue GM. Surgical aspects of cochlearimplantation in young children: a review of 115 cases. Am J Otol 1997;18(suppl6):S69-S70.
[11] Snik AF, Mylanus EA, Cremers CW, Dillier N, Fisch U, Gnadeberg D,et al. Multicenter audiometric results with the Vibrant Soundbridge, asemi-implantable hearing device for sensorineural hearing impairment.Otolaryngol Clin North Am 2001;34:373-88.
[12] Tarabichi M. Endoscopic management of limited attic cholesteatoma.Laryngoscope 2004;114:1157-62.
[13] Thomassin JM, Korchia D, Doris JM. Endoscopic-guided otosurgeryin the prevention of residual cholesteatomas. Laryngoscope 1993;103:939-43.
[14] Tarabichi M. Endoscopic management of cholesteatoma: long-termresults. Otolaryngol Head Neck Surg 2000;122:874-81.
[15] Thomassin JM, Braccini F. Place de l’imagerie et de l’endoscopie dansla surveillance et la prise en charge des cholestéatomes opérés en tech-nique fermée. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 1999;120:75-81.
[16] Bordure P. Otite chronique cholestéatomateuse. Aspects cliniques etthérapeutiques. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Otorhino-laryngologie, 20-095-A-20, 2008.
[17] Malard O, Daculsi G, Toquet J, Beauvillain De Montreuil C, Legent F,Bordure P. Résultats fonctionnels comparés des autogreffes et desbiomatériaux dans les ossiculoplasties a étrier intact. À propos de 100cas. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 2001;118:225-31.
[18] Schmerber S, Troussier J, Dumas G, Lavieille JP, Nguyen DQ. Hearingresults with the titanium ossicular replacement prostheses. Eur ArchOtorhinolaryngol 2006;263:347-54.
[19] Wullstein H. Operationen zur Verbesserung des Gehöres. Grundlagenund Methoden. Stuttgart: Thieme; 1968.
[20] Duckert LG, Makielski KH, Helms J. Refined mastoid reconstructionwith the pedicled postauricular perichondrial flap. Am J Otol 1997;18:10-4.
[21] Portmann M, Portmann D. Aménagement des cavités ouvertes oufermées en otologie. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 1990;111:181-3.
[22] Magnan J. Le cholestéatome. In: L’otite chronique. Paris: Société Fran-çaise d’ORL; 2005. p. 73-124.
[23] Black B. Mastoidectomy elimination. Laryngoscope 1995;105(12(Pt2)suppl76):1-30.
[24] Palva T, Palva A, Salmivalli A. Radical mastoidectomy with cavityobliteration. Arch Otolaryngol 1968;88:119-23.
[25] Kos MI, Chavaillaz O, Guyot JP. Obliteration of the tympanomastoidcavity: long term results of the Rambo operation. J Laryngol Otol 2006;120:1014-8.
[26] Yung M, Smith P. Mid-temporal pericranial and inferiorly basedperiosteal flaps in mastoid obliteration. Otolaryngol Head Neck Surg2007;137:906-12.
[27] Ramsey MJ, Merchant SN, McKenna MJ. Postauricular periosteal-pericranial flap for mastoid obliteration and canal wall downtympanomastoidectomy. Otol Neurotol 2004;25:873-8.
[28] Kahramanyol M, Ozunlu A, Pabuscu Y. Fascioperiosteal flap and neo-osteogenesis in radical mastoidectomy: long-term results. Ear NoseThroat J 2000;79:524-6.
[29] Shea Jr. MC, Gardner Jr. G, Simpson ME. Mastoid obliteration withbone. Otolaryngol Clin North Am 1972;5:161-72.
[30] Lee WS, Choi JY, Song MH, Son EJ, Jung SH, Kim SH. Mastoid andepitympanic obliteration in canal wall up mastoidectomy for preventionof retraction pocket. Otol Neurotol 2005;26:1107-11.
[31] Daculsi G. Bagot d’Arc M, Corlieu P, Gersdorff M. Macroporousbiphasic calcium phosphate efficiency in mastoid cavity obliteration:experimental and clinical findings. Ann Otol Rhinol Laryngol 1992;101:669-74.
[32] Gersdorff M, Garin P. Notre technique de réhabilitation des cavitésd’évidement pétro-mastoïdien. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 1992;113:427-30.
[33] Malard O, Corre P, Bordure P, Weiss P, Grimandi G, Saffarzadeh A.Biomatériaux de reconstruction et de comblement osseux en ORL etchirurgie cervicofaciale. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 2007;124:252-62.
[34] Bagot d’Arc M, Daculsi G, Emam N. Biphasic ceramics and fibrinsealant for bone reconstruction in ear surgery. Ann Otol RhinolLaryngol 2004;113:711-20.
N. Durand, Interne des Hôpitaux.F. Espitalier, Chef de clinique-assistant.O. Malard, Professeur des Universités, praticien hospitalier.P. Bordure, Professeur des Universités, praticien hospitalier ([email protected]).Service d’oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, 1, place Alexis-Ricordeau, 44093 Nantes cedex 1, France.
Ogni riferimento a questo articolo deve portare la menzione: Durand N., Espitalier F., Malard O., Bordure P. Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchiomedio e atticotomie. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale, 46-080, 2011.
Disponibile su www.em-consulte.com/it
Algoritmidecisionali
Iconografiasupplementare
Video-animazioni
Documentilegali
Informazioniper il paziente
Informazionisupplementari
Autovalutazione Casoclinico
.
I – 46-080 ¶ Chirurgia delle cavità posteriori dell’orecchio medio e atticotomie
16 Tecniche Chirurgiche - Chirurgia ORL e cervico-facciale