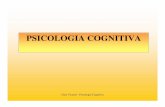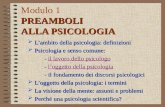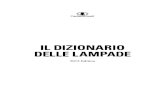CATELLANI - Psicologia Politica.doc
-
Upload
matteogiordani -
Category
Documents
-
view
227 -
download
9
description
Transcript of CATELLANI - Psicologia Politica.doc
CATELLANI – PSICOLOGIA POLITICA
CAPITOLO I. L’area di studio della psicologia politica
La psicologia politica studia le rappresentazioni e le azioni dei potenziali o attuali attori della poli-tica, cioè di qualunque soggetto in quanto cittadino, leader o membro di gruppi che abbiano fini di carattere pubblico e collettivo. Il soggetto studiato dalla psicologia politica non è un soggetto astratto, ma è un soggetto concreto, che agisce all’interno di una certa realtà, da cui è influenzato e che influenza egli stesso.L’importanza del partire dall’azione risiede nella necessità di fare riferimento alla dimensione so-ciale: è attraverso l’azione che il soggetto entra in relazione con l’ambiente esterno e con gli altri.Nell’esaminare i rapporti tra psicologia sociale e psicologia politica è importante distinguere tra:
• Ricerche di psicologia sociale estese all’ambito politicoIl soggetto, attore della realtà, porta con sé alcune caratteristiche che gli sono proprie anche come attore della realtà sociale più generale. Così i processi cognitivi che ci portano alla for-mazione di un giudizio, la scelta di far parte di un gruppo, i meccanismi di persuasione di in-fluenza e di persuasione, saranno i medesimi sia che ci si riferisca all’ambito prettamente so-ciale, sia che ci si riferisca a quello politico.Fiske e Pavelchak (1986). L’idea che ci facciamo di un candidato può dipendere da singoli ele-menti di conoscenza (piecemeal – caratteristiche fisiche o di personalità) o da conoscenze più strutturate (schematice – caratteristiche tipiche della categoria cui appartiene).• Ricerche di psicologia sociale della politicaL’accento viene posto sulla specificità del contesto politico. Un dato contesto politico porta con sé delle conseguenze in termini di: a) scopi che il soggetto o il gruppo si pongono; b) ruoli che vengono rivestiti; c) regole e vincoli ai quali conformarsi. Tutti questi aspetti, poi, esercitano un’influenza sulle rappresentazioni e sulle azioni dei soggetti.
La distinzione tra le due ricerche non va intesa in senso rigido. Ciò che importa è che in entrambi i casi la dimensione sociale viene assunta come costitutiva della politica.
Lo sviluppo della disciplina è stato fino ad ora ineguale dal punto di vista territoriale (prevalenza degli studi statunitensi). Inoltre, la scienza politica anglosassone si è caratterizzata fin dall’inizio per un’impostazione funzionalistica, che vede il sistema politico come insieme di relazioni, come espressione di coloro che agiscono nel sistema stesso. Quest’impostazione ha creato le premesse per lo sviluppo della psicologia politica (costante interazione tra politologi e psicologi).L’approccio teorico dominante in un dato periodo ha influenzato i temi affrontati in prevalenza in quello stesso periodo.
Anni ‘40-50: fattori di personalità in politica. Studio dei fattori di personalità che giocano un ruo-lo nell’esercizio della politica → importante ruolo della teoria psicoanalitica (Freud).Laswell. Si propone di spiegare, attraverso la ricostruzione delle diverse fasi evolutive, per quale motivo alcune persone decidono di impegnarsi nell’attività pubblica. Gli uomini politici sarebbero caratterizzati da ansie irrisolte relative al proprio ego e da una scarsa stima di sé, così che si rivol-gerebbero all’esterno. La dimensione conflittuale tipica dell’attività politica sarebbe funzionale alla risoluzione dei conflitti interiori, che vengono così deviati su oggetti pubblici.Barber. Tipologia di personalità nella quale collocare i presidenti USA. Ad esempio, Wilson, John-son e Nixon apparterrebbero alla categoria degli “attivi negativi”, che vanno cioè incontro a scon-fitte pur di non cambiare la propria strategia politica.Maslow. Modello motivazionale nell’ambito delle teorie personologiche: si diventa politici solo quando si ha grande stima di sé e un forte senso di efficacia personale. L’attività politica viene in-trapresa solo quando i bisogni di base son stati soddisfatti.
1
Critiche allo studio dei rapporti tra personalità e politica:1. Errore fondamentale di attribuzione (Ross): nello spiegare il comportamento politico si è
dato più rilievo ai fattori disposizionali che a quelli situazionali, cioè agli aspetti interiori piuttosto che a quelli ambientali.
2. Differenze di metodo con la conseguente difficoltà a confrontare i risultati.
Anni ‘60-70: opinione pubblica e comportamento elettorale. I protagonisti della politica sono i leader e i militanti di partito, ma anche i cittadini. Da qui l’interesse crescente per lo studio del comportamento elettorale e degli atteggiamenti politici dei cittadini.1952. Università del Michigan, primi NES (National Election Studies): monitoraggio degli atteg-giamenti politici e di voto dei cittadini.OPINIONE PUBBLICA: i soggetti non reagiscono direttamente alla realtà che li circonda , ma si costruiscono delle rappresentazioni stereotipate e semplificate di tale realtà, e sulla base di queste prendono delle decisioni.Campbell, Converse, Miller, Stokes. (rivista “The american voter”, 1960) Nozione di atteggiamen-to. Il processo di socializzazione, e soprattutto la famiglia, giocherebbe un ruolo fondamentale nel-lo sviluppo di una identificazione con il partito. Così il voto dovrebbe essere inteso come un com-portamento irrazionale, dettato da un spinta interna che sovrasterebbe i dati provenienti dall’ester-no (es. cambiamento di voto degli anni ’70). Campbell parla di homo politicus irrazionale, il cui comportamento è dettato da una povertà cognitivaAlla visione di Campbell si contrappone quella di Downs (“An economic theory of democracy”), secondo il quale l’elettore ha la possibilità di scegliere in modo razionale in base a conoscenze po-litiche limitate (si sceglie l’alternativa caratterizzata dalla massima utilità attesa).
Anni ‘80: political cognition (cui si approda a partire dalle elaborazioni della social cognition de-gli anni ’70). Estensione dell’approccio cognitivista all’ambito della psicologia politica. L’atten-zione si sposta all’esame dei processi di elaborazione delle informazioni soggiacenti agli atteggia-menti e comportamenti politici. Ora la questione è capire attraverso quali processi mentali il sog-getto arriva a pensare e a votare in un certo modo.Simon. L’uomo è un soggetto attivo dotato di razionalità limitata, dato che seleziona e d elabora le informazioni provenienti dall’esterno e in tal modo costruisce la realtà, compatibilmente con i limi-ti della mente umana. Il soggetto si presenta come economizzatore cognitivo (cognitve miser), per-ché i limiti della capacità di elaborazione fanno sì che i soggetti tendano ad economizzare le ener-gie mentali e ricorrano a scorciatoie e semplificazioni, così da poter assolvere il compito conosciti-vo.
Anni ’90. Due tendenze principali:1. tema della conoscenza politica: indagine sui fattori che influenzano l’elaborazione delle in-
formazioni → la quantità delle informazioni elaborate e la qualità delle strategie utilizzate dai soggetti variano in funzione di diversi fattori (es: motivazione; scopi; ruoli; regole; vin-coli). Il soggetto non è più un economizzatore cognitivo, ma diventa tattico motivato (moti-vated tactician, Fiske e Taylor), e ciò significa che i suoi processi cognitivi possono variare in funzione dell’origine e della meta;
2. maggiore attenzione a variabili originariamente sociali. Viene abbandonata la prospettiva sostanzialmente individualistica a favore di una prospettiva più strutturalmente sociale.
CAPITOLO 2. La conoscenza e gli atteggiamenti politici
Il mondo attuale si caratterizza per una sovrabbondanza di informazioni. Ma le informazioni politi-che cui si accede sono oggetto di diversi processi di selezione:
1. media;
2
2. esposizione involontaria: legata all’esistenza di ciascun soggetto ed indipendente dalla sua volontà;
3. esposizione volontaria all’informazione (il numero di informazioni cui prestiamo attenzione è limitato → approccio cognitivista);
4. salienza delle informazioni: informazioni che catturano l’attenzione.Cosa avviene quando ci troviamo di fronte a un’informazione? Fasi di elaborazione:
A) CODIFICAQuando entriamo in contatto con un’informazione nuova la confrontiamo con concetti già noti per darle significato. Uno o più concetti vengono richiamati dalla MLT (memoria a lungo termine) alla MBT (memoria a breve termine) e qui confrontati con l’informazione nuova, in modo da attri-buirle significato. Il modo in cui l’informazione nuova verrà interpretata dipenderà da quale con-cetto è stato richiamato, ossia da quale concetto risulta più accessibile. L’accessibilità di un con-cetto, cioè la probabilità che esso venga richiamato nella MBT e venga utilizzato in fase di codifi-ca, dipende da:
1. Recenza: un concetto che sia stato da poco richiamato nella MBT rimane per un certo tem-po più accessibile di altri e quindi verrà più probabilmente utilizzato anche nell’interpreta-zione di un’informazione successiva. Il priming consiste nel proporre ai soggetti determina-te situazione stimolo, allo scopo di innalzare l’accessibilità e rilevarne le conseguenze in termini di elaborazione delle informazioni (es. ricerca di Young).
2. Frequenza: se un concetto viene spesso attivato ciò fa sì che la sia accessibilità sia cronica-mente alta. Recenza e frequenza possono avere un effetto sommatorio nel caso in cui il con-cetto attivato di recente sia anche un concetto già frequentemente attivato in precedenza. Quando invece concetto recente e concetto frequente non coincidono, l’esito in termini di accessibilità sarà variabile: LP = prevalenza della cronicità (decenza); BP = prevalenza del priming (frequenza).
3. Obiettivi: (cognitivisti) anche gli obiettivi sono depositati in memoria, così che l’attivazione di uno di essi renderebbe le informazioni collegate più accessibili di altre. Più obiettivi pos-sono competere o coesistere, quindi questo fattore condiziona l’accessibilità in modo più complesso
Le informazioni che vengono elaborate in ambito politico sono quelle che riguardano essenzial-mente gli uomini e i partiti politici da un lato e i temi politici dall’altro.PERCEZIONE DEGLI UOMINI POLITICI. Il processo di formazione delle impressioni avviene continuamente e spontaneamente, e si basa su informazioni di vario tipo a seconda del ruolo che la persona ricopre e del contesto in cui si esprime il giudizio.Le informazioni di cui teniamo conto nel formarci un giudizio su un uomo politico sono riconduci-bili a tre categorie:
1. Caratteristiche personali2. Posizione su temi politici3. Appartenenza partitica
Miller, Wattenberg, Malanchuck (1986). In che misura ciascuna di queste tre categorie rientra nel-la formazione del giudizio? Da un’indagine preelettorale condotta degli Usa tra il 1952 e il 1984 si rilevò che i commenti relativi ai candidati potevano essere ricondotti a cinque categorie principali: competenza; integrità; affidabilità; carisma; caratteristiche personali. Tra tutti, i commenti relativi ai tratti personali erano quasi sempre quelli prevalenti.I soggetti con un più alto livello di istruzione basano i loro giudizi sulle caratteristiche personali in modo maggiore rispetto ai soggetti meno scolarizzati.Budesheim, DePaola (1994). Esposizione di un campione di soggetti a diversi tipi di informazioni su due ipotetici candidati politici (A e B). sia per il candidato A, sia per il candidato B il giudizio è più positivo quando l’informazione che lo riguarda è connotata in modo favorevole. Inoltre, il giu-
3
dizio appare influenzato sia dalle informazioni sulla personalità, sia da quelle sull’aspetto fisico dei due candidati. Ci si chiede allora quale tipo di informazioni riveste un peso maggiore nella for-mulazione del giudizio sui candidati: il grado di accordo avrebbe un peso minore sul giudizio quando i soggetti possiedono anche informazioni relative all’immagine (i soggetti venivano sotto-posti ad informazioni contraddittorie sull’immagine, così che la concentrazione su di esse aumen-tava rendendole più accessibili).PERCEZIONE DEI TEMI POLITICI. Lavine (1996). Relazione tra salienza personale, salienza per la nazione e accessibilità del tema: i temi della politica interna, ritenuti più salienti sul piano per-sonale, sono quelli più accessibili; i temi di politica estera, ritenuti più salienti sul piano nazionale, sono meno accessibili. È probabile che la decisione di voto dei cittadini sia più coerente con la loro posizione sui temi maggiormente accessibili, dunque quelli di politica interna.Young (1991). Indagine relativa all’effetto del priming del concetto di “interesse personale” sul giudizio relativo a un tema politico: il priming aumenta l’accessibilità del concetto di “interesse personale” per quei soggetti che sono direttamente coinvolti nel problema di cui si discute. Tale concetto sarà dunque largamente utilizzato nella formazione dei giudizi successivi. Un candidato politico dovrebbe perciò saper indirizzare gli elettori in modo tale che utilizzino il criterio dell’in-teresse personale per votare.I media giocano un ruolo fondamentale nell’influenzare l’importanza attribuita ai temi politici. L’agenda setting (spazio attribuito ai diversi temi politici) può contribuire ad aumentare l’accessi-bilità dei temi ed influenzare il giudizio sui candidati.
B) ORGANIZZAZIONELe informazioni codificate vengono immagazzinate, organizzate e ricostruite nella MLT. Il modo in cui le informazioni sono o non sono organizzate influenza la facilità e le modalità con cui tali infor-mazioni sono recuperate. Molti modelli che descrivono lìorganizzazione delle conoscenze sono ba-sati sulla rete semantica, costituita da una serie di nodi (singoli concetti) e di legami tra nodi (rela-zioni tra concetti). L’uomo politico rappresenta un nodo superordinato, collegato a tre nodi sottor-dinati: 1) tratti; 2) posizioni sui temi; 3) appartenenza partitica.
• Organizzazione delle conoscenze su un tema (intra-issue)Pratkanis (1989). Vi sono ambiti di conoscenza nei quali esiste una relazione diretta tra positi-vità o negatività dell’atteggiamento e quantità di conoscenza ad esso relative. In questo caso, le conoscenze si organizzerebbero secondo una struttura unipolare (solo conoscenze positive o neutre). I temi controversi, invece (temi politici), le conoscenze si organizzerebbero secondo una struttura bipolare (conoscenze positive, negative e neutre). Il confronto tra alternative op-poste gioca perciò un ruolo chiave nell’organizzazione delle conoscenze sui temi politici, so-prattutto se si pensa che l’accessibilità aumenta se le informazioni risultano essere coerenti con il nostro comportamento.• Organizzazione delle conoscenze su più temi (inter-issue)
Judd, Krosnick (1989). Ciascun concetto costituisce un nodo della rete e i diversi nodi (livello astratto: valori; livello meno astratto: temi politici, uomini politici, partiti) sono collegati tra loro da diversi possibili legami. Due nodi risultano collegati quando vengono attivati simultaneamente, e ciò avviene con più probabilità quando uno dei due nodi implica, favorisce o esclude l’altro. La correlazione tra la propria posizione rispetto a particolari temi politici e quella rispetto a candidati e partiti aumenta in funzione della competenza e dell’importanza attribuita agli atteggiamenti in esame. Il che è spiegabile dal fatto che entrambe le componenti migliorano l’organizzazione delle conoscenze. La coerenza politica è tanto maggiore quanto maggiore è il numero di legami tra i concetti e quanto maggiore è l’accessibilità di concetti e legami tra concetti.
C) RECUPEROGli atteggiamenti politici sono costituiti da tre componenti: cognitiva (credenze), affettiva (senti-menti o emozioni) e comportamentale (esperienze). Atteggiamenti e componenti hanno un legame
4
bidirezionale, cioè di reciproca influenza. Non è comunque detto che alla base di un atteggiamento ci siano sempre tutte e tre le componenti e non è nemmeno detto che esse siano coerenti tra loro. tuttavia, quanto più un atteggiamento è forte, radicato, stabile, tanto più è probabile che vi sia coe-renza tra le componenti che lo determinano.Abelson (1982). Il nostro giudizio su un uomo politico dipende anche dai sentimenti che egli suscita in noi. In particolare, le emozioni positive possono ricoprire un’importanza superiore rispetto ai tratti di personalità nel corso di una valutazione.Trentin, Monaci, Nunia (1996). I predittori migliori della valutazione sono le emozioni positive.In ambito politico è fondamentale indagare relativamente al rapporto tra atteggiamento e compro-tamenti., soprattutto per capire quanto gli atteggiamenti possano essere predittori dei comporta-menti. Quali sono i fattori che condizionano il rapporto atteggiamento-comportamento?
1. Generalità/specificità dell’atteggiamentoUn atteggiamento espresso in termini generali non conduce per forza ad un comportamento specifico (es. parlar bene di Blair non vuol di re che lo si andrà a votare).Ajzen, Fishbein (1977). Una certa tipologia di comportamento può variare rispetto a quattro diverse dimensioni: a) azione intrapresa; b) oggetto verso il quale l’azione è diretta; c) conte-sto nel quale si osserva l’azione; d) tempo nel quale si svolge l’azione. È più probabile che vi sia una relazione tra misura dell’atteggiamento e del comportamento quando tali misure sono compatibili per quanto riguarda le quattro dimensioni.2. Base soggiacente all’atteggiamentoLa coerenza nella misura di atteggiamenti e comportamenti dipende anche dal fatto di utilizza-re una misura dell’atteggiamento coerente con la base dell’atteggiamento stesso.3. Forza dell’atteggiamento(forza = chiarezza, stabilità nel tempo) La forza dipende soprattutto dalla coerenza tra la com-ponente cognitiva e la componente affettiva. La forza di un atteggiamento tende ad aumentare se esso è fondato su una base comportamentale: es. Fazio (1986). L’accumulo di esperienza nei confronti di un certo oggetto di atteggiamento fa sì che l’accessibilità dell’atteggiamento relati-vo a questo oggetto venga innalzata, soprattutto se le esperienze che si succedono risultano tra loro coerenti. Un atteggiamento forte ha dunque più probabilità di tramutarsi in un comporta-mento coerente.
Ajzen (1988). Teoria del comportamento pianificato (planned behaviour)Le determinanti dell’intenzione comportamentale, cioè del fatto che un soggetto intenda o meno compiere una certa azione, sono tre: atteggiamento verso il comportamento, norma soggettiva, percezione di controllo del comportamento. A sua volta, l’intenzione comportamentale diventa una determinante fondamentale del comportamento. Un’azione viene intrapresa se si pensa di riuscire a portala a termine.
L’influenza dell’atteggiamento sulla conoscenza può essere tanto più rilevante: a) quanto più il soggetto è coinvolto rispetto all’oggetto di atteggiamento, quindi quanto più l’atteggiamento è for-te; b) quanto più questo oggetto si presenta come ambiguo contraddittorio. Accade spesso che gli atteggiamenti politici si sviluppino nei confronti di oggetti mutevoli. Nel caso dell’uomo politico, la variabilità po’ riguardare atteggiamenti e comportamenti: 1) il politico dice cose diverse in circo-
5
Atteggiamento versoil comportamento
Norma soggettiva
Percezione di controllo del comportamento
Intenzione comportamental
e
Comportamento
stanze diverse, ritagliando il messaggio a seconda del contesto; 2) il politico cambia posizione nel tempo.La variabilità, l’ambiguità e la contraddittorietà del contesto provocano una distorsione nella per-cezione della realtà da parte del soggetto.Heider. Teoria dell’equilibrio: i soggetti si sforzano di organizzare le proprie cognizioni in modo tale da evitare tensioni e contraddizioni. Quando si rendono conto che alcuni atteggiamenti sono contraddittori, entrano in una condizione di squilibrio cognitivo.Si considerino tre elementi, cittadino, uomo politico, tema politico e le relazioni tra essi.Si ha equilibrio se tutte le relazioni sono positive o se una è positiva e le altre due sono negative. Se manca l’equilibrio, io cittadino cambierò atteggiamento o verso l’uomo o verso il tema politico, a seconda dell’importanza attribuita (tendenzialmente si cambia opinione rispetto al tema).
Come avviene il cambio di atteggiamento nei confronti di un tema o di una persona nel tentativo di ristabilire l’equilibrio?Ottati, Fishbein, Middlestadt (1988). Una tendenza che può essere ricondotta alla ricerca di equili-brio è quella che consiste nell’accentuare la vicinanza tra noi stessi e ciò verso cui abbiamo un at-teggiamento positivo (assimilazione) e la distanza tra noi e ciò verso cui abbiamo un atteggiamen-to negativo (contrasto).Sherif, Hovland (1961). La posizione del soggetto costituisce una sorta di ancora di giudizio con l quale vengono confrontate tutte le altre posizioni possibili. Gli atteggiamenti vicini alla nostra po-sizione saranno percepiti come simili ai nostri più di quanto lo siano in realtà (sovrastima della vi-cinanza del messaggio), mentre gli atteggiamenti lontani da noi saranno percepiti come differenti e negativi (sovrastima della distanza).Perciò, il soggetto tenderebbe ad accentuare la propria similarità percepita nei confronti di coloro che ha scelto di votare e ad accentuare la differenza rispetto a chi non ha scelto. La tendenza al-l’allontanamento dal candidato non favorito è meno marcata rispetto all’altra, perché i soggetti preferiscono l’accordo al disaccordo (agreement effect), il gradimento al non gradimento (positivi-ty effect).Gli atteggiamenti esercitano un’influenza sulla conoscenza, nel senso che un soggetto tende ad an-corare la codifica di nuove informazioni su un certo oggetto al giudizio di cui già dispone su quel-l’oggetto. L’entità di questo fenomeno varia in relazione a diversi fattori, tra cui il grado di ambi-guità e contraddittorietà delle informazioni, l’identità di gruppo, le relazioni del soggetto.
Competenza o expertise: capacità di utilizzare efficacemente le nozioni possedute per risolvere pro-blemi. L’expertise politica è sintesi di diverse dimensioni: a) interesse politico; b) attività politica; c) conoscenza politica; d) fruizione dei media; e) concetto di sé politico. Tali dimensioni possono essere fuse per costituire l’indice di expertise, utilizzato per distinguere soggetti esperti ed inesper-ti in politica.
6
cittadino candidato politico
tema politic
o
atteggiamento verso
atteggiamentoverso
atteggiamentoverso
percezione
guadagno
perdita
Catellani. Tutte le dimensioni dell’expertise sono altamente correlate tra loro. L’interesse politico è legato direttamente a tutti gli altri fattori; questi, invece, si legano tra loro sulla base di rapporti causali fino a formare una sorta di percorso che dall’interesse conduce all’attività politica (p. 68).Quadrio, Catellani, Sala (1988). [riferimento alla teoria delle rappresentazioni sociali di Moscovi-ci] a seconda del gruppo cui si fa riferimento, ad esempio militanti di partito e non militanti, cam-biano le definizioni date della politica e degli argomenti politici ritenuti salienti: una maggiore fa-miliarità coincide con una maggiore ricchezza nella definizione di un concetto.
CAPITOLO 3. La decisione politica
Tutti gli attori politici sono chiamati a prendere delle decisioni. L’approccio psicologico allo stu-dio della decisione politica deriva parte dei suoi fondamenti da una critica della teoria della deci-sione sviluppata prima in ambio economico, poi estesa a quello politico.Downs (1957). Teoria della scelta razionale. Muove dall’ipotesi che la decisione di voto sia guida-ta dalla ricerca dell’interesse personale di tipo economico. Di conseguenza, per massimizzare il proprio benessere economico il soggetto deve poter disporre di tutte le informazioni necessarie ad individuare la migliore strada da percorrere. Ma il soggetto non dispone mai di tutti gli elementi necessari e, non potendo prevedere con certezza gli effetti, la decisione viene presa in condizioni di insicurezza. Per comportarsi nel modo più razionale possibile, perciò, il soggetto ricorrerà quindi all’applicazione della statistica (teoria della probabilità).Edwards (1954). Teoria dell’utilità attesa soggettiva. La decisione viene scomposta in termini di valori o utilità che il soggetto attribuisce a ciascuno dei possibili esiti della decisione, e di probabi-lità soggettiva che ciascuno di questi esiti si possa effettivamente verificare. Valori eprobabilità vengono combinati attraverso la formula:
con pi = probabilità associata all’i-esimo esito di una possibile opzione; u(xi) = utilità dell’esito. L’applicazione della formula consente di scegliere l’alternativa caratterizzata dalla massima utilità soggettiva attesa.L’utilità attesa di una data alternativa è data dalla somma dei valori associati a ciascuna delle possibili conseguenze legate a quell’alternativa, somma pesata per la probabilità di ciascuna con-seguenza. Sulla base di questa teoria possiamo perciò dire che, una volta definiti gli esiti di cui si tiene conto nella scelta e i valori attribuiti a ciascuno di essi, la decisione può essere raggiunta at-traverso un processo perfettamente razionale.Assumiamo allora che gli scopi degli attori politici siano quelli previsti dalla teoria della scelta ra-zionale. Ma soggetti diversi potrebbero avere orientamenti diversi su come possa essere perseguito uno stesso scopo, quindi non possiamo predire con certezza le decisioni. Anche se lo scopo finale è lo stesso, gli scopi immediati o intermedi possono variare e incidere sulla decisione.La teoria della scelta razionale è stata sottoposta a critica da parte dell’approccio descrittivo o psicologico allo studio della decisione, il quale muove dall’assunto che la natura umana sia molto più complessa. Alcuni fattori possono agire nell’ambito della decisione politica, condizionandola. Possono cioè influire sulla determinazione di alternative, valori e probabilità considerati dal sog-getto durante il processo decisionale; possono anche intervenire a modificare l’obiettivo finale. Di-stingueremo dunque tra:
1. Fattori di matrice cognitiva: il soggetto non prende necessariamente in considerazione tutte le alternative possibili, ma si focalizza solo quella più accessibili alla sua mente e percepite come salienti. Inoltre, fattori legati alla realtà esterna e alla mia interpretazione di tale realtà possono indurmi a perseguire alcuni obiettivi specifici (intermedi) piuttosto che altri.2. Fattori di matrice sociale: possono condizionare e limitare il campo delle possibili opzioni decisionali. Fondamentale, a tal proposito, il riferimento alla teoria dell’identità sociale ela-
7
guadagno
perdita
( )iii xupΣ
borata da Tajfel e Turner, in base alla quale parte dell’identità di un soggetto è costituita dalle appartenenze di gruppo che egli sperimenta nel corso della sua vita. Anche quando il soggetto decide da solo gli altri sono comunque presenti, insieme alle norme e ai valori che caratterizza-no i relativi gruppi di appartenenza. Il fatto di sentirci appartenenti ad un gruppo può anche in-durci a non prendere nemmeno in considerazione alcune delle alternative possibili.Le appartenenze di gruppo non sono singole, ma i soggetti hanno identità multiple (IDENTITÀ SOCIALE: presenza degli altri e appartenenza a un gruppo) e la rilevanza e il peso di ciascuna varia a seconda delle circostanze. In alcuni casi il senso di appartenenza può essere talmente forte da indurre il soggetto a tenere conto, nel prendere una decisione, non tanto dell’interesse personale, quanto di quello del gruppo con cui si identifica. L’interesse personale può quindi essere egoistico o altruistico.
Le decisioni si fondano su:- valori strumentali (bisogno di perseguire un benessere materiale);- valori espressivi (bisogni di altro genere)
Tversky, Kahneman (1981). Teoria del prospetto. La decisione del soggetto è fortemente condizio-nata dal modo in cui gli si prospettano, in termini di guadagno o di perdita rispetto alla situazione di partenza, i diversi possibili esiti delle alternative decisionali.In funzione del valore soggettivo: la curva a S è più ripida nella regione delle perdite perché il di-spiacere associato a una perdita è maggiore del piacere associato ad un guadagno di eguale entità. Inoltre, è possibile notare che ad ogni incremento unitario nel possibile guadagno non corrisponde un incremento uguale nel valore soggettivo attribuito a questo guadagno (p. 89).Tutto ciò potrà essere meglio compreso specificando due importanti concetti:
1. Effetto certezza: quando ci si trova in una prospettiva di guadagno si preferisce scegliere l’opzione certa piuttosto che quella di guadagno maggiore ma incerta. In generale, le per-sone tendono a non esporsi a situazioni di rischio.
2. Effetto riflessione: in prospettiva è di perdita i soggetti tendono a cercare il rischio.
La decisione di voto è complicata da spiegare nei termini della teorie della scelta razionale.Situazione di paradosso del voto: quando andiamo a votare sappiamo che il nostro singolo voto non sarà decisivo. In altre parole il costo che comporta la scelta di andare a votare è superiore ri-spetto ai benefici che possono derivare al soggetto da quella scelta. Perché allora si va a votare?Riker, Ordeshook (1968). La scelta di andare a votare è dovuta al fattore “D”, cioè al fattore “do-vere del cittadino”, il quale dovrebbe votare per il piacere che gli deriverebbe dall’aver adempiuto ad un importante principio etico.Quattrone, Tversky (1984). Illusione del votante: percezione illusoria che la propria scelta possa influenzare quella degli altri chi condivide il mio atteggiamento nei confronti del voto andrà come me a votare (“pensiero quasi-magico”).Polmonari, Arcuri, Girotto (1994). L’efficacia politica, ossia la percezione di poter influenzare gli eventi politici con la propria azione, può giocare un ruolo nell’illusione dell’elettore.
CAPITOLO 4. L’orientamento ideologico e politico
Punto di riferimento degli studi in questo campo è la ricerca di Adorno (1950) sulla personalità autoritaria. L’autore parte dall’idea che le convinzioni politiche, economiche e sociali di un indivi-duo costituiscono un unico modello ampio e coerente, espressione di tendenze profonde di persona-lità, di disposizioni stabili dell’individuo. Il pregiudizio non è tanto legato al contesto, quanto a tratti, bisogni, motivi che risiedono all’interno dell’individuo.Adorno ha indagato quattro dimensioni:
1. Antisemitismo
8
guadagno
perdita
2. Etnocentrismo: si tratta di una tendenza inconscia, ma anche legata a una razionalizzazio-ne di tipo ideologico, per cui le caratteristiche del gruppo di appartenenza vengono valutate positivamente, mentre i membri dei gruppi esterni (minoranza sono svalutati e respinti.
3. Conservatorismo politico-economico4. Tendenze antidemocratiche e fascismo potenziale, misurati attraverso la scala F (elaborata
come misura dell’orientamento politico di destra). La scala misura 3 dimensioni della per-sonalità autoritaria: convenzionalismo (adesione rigida a valori convenzionali), sottomis-sione all’autorità (rispetto acritico), aggressività autoritaria (ostilità nei confronti di chi viola valori e norme prevalenti). Tale scala ha però dei limiti metodologici: gli item rispetto ai quali esprimere il grado di accordo/disaccordo sono tutti formulati nella stessa direzione (si rischiano risposte acquiescenti).
Altemeyer (1981, 1988). Nuova scala: RWA (Right Wing Authoritarism), che comprende una serie di affermazioni da valutare su una scala a 6 punti di accordo/disaccordo. Si tratta di una scala più attendibile ma ha ancora dei limiti: forte legame a contenuti specifici; costrutto non ben definito.È vero che esiste un legame tra autoritarismo e ideologia di destra, ma questa correlazione non è particolarmente alta (esistono autoritarismo di sinistra).Si procede così all’elaborazione di nuove idee in merito al tema dell’autoritarismo e delle sue de-terminanti.
1. Pratto ((1994). Orientamento alla dominanza sociale (SDO - Social Dominance Orientation). Esistendo nel mondo il conflitto tra gruppi, le società tendono a creare dei miti (es. nazionalismo) di legittimazione della superiorità di un gruppo sull’altro allo scopo di ridurre tali conflitti. Chi aderisce a questi miti giustifica dunque in modo aprioristico la prevalenza di alcuni su altri. Esisto-no tuttavia anche miti che enfatizzano l’uguaglianza, come il cristianesimo.Si ipotizza che tra i fattori psicologici che inducono ad accettare o meno tali miti vi sia appunto la SDO, cioè il grado in cui il soggetto desidera che il proprio gruppo (ingroup) sia superiore ai gruppi esterni (outgroup). Le SDO si presenta dunque come:
- una tendenza umana normale, non patologica;- un desiderio di dominio di gruppo, non individuale;- basata su processi psicodinamici e non evolutivi;- un costrutto più limitato e quindi meglio definito (riferimento solo alla questione generale dell’uguaglianza/disuguaglianza).
Limiti: la SDO è una variabile di personalità e viene quindi definita indipendentemente dalla situa-zione e dal contesto in cui viene misurata. Per questo si è rivelata un buon predittore degli atteg-giamenti politici, ma non altrettanto buon predittore dei comportamenti politici.
2. Rokeach (1973). Sistema dei valori del soggetto. I valori di base (terminal values) connotano gli obiettivi ultimi di qualunque azione politica. L’autore procede così all’elaborazione di una scala gerarchica di valori.A questa scala ha fatto riferimento Tetlock (1986), secondo il quale per i conservatori alcuni valori sarebbero chiaramente dominanti su altri, mentre i progressisti sperimenterebbero un maggiore conflitto tra valori (massimo nei soggetti di centro-sinistra). Per questo le strategie di ragionamen-to e le soluzioni politiche dei progressisti risultano più complesse e articolate.Ipotesi di Schwarz (1992): (elabora un sistema che ha pretese di universalità, cioè applicabile a tutti i sistemi di valore che caratterizzano le diverse culture) i valori sono organizzati in uno spazio bidimensionale (p. 111): quelli situati in quadranti opposti sono in conflitto tra loro mentre quelli adiacenti sono compatibili.La sfera politica può influenzare il sistema dei valori, non solo il contrario. Infatti, un particolare regime politico può causare alcune deviazioni sistematiche rispetto alla struttura prototipica dei valori.
9
Ricondurre l’orientamento politico al sistema di valori del soggetto significa vedere le diverse sfere presenti nella sua vita politica, sociale, morale, religiosa come tutte collegate tra loro da un unico sistema di valori.
3. Kohberg (1963, 1976). Orientamento politico e ragionamento morale. Si distinguono tre diversi livelli di ragionamento:
a) livello preconvenzionale di sviluppo morale: le regole sono percepite come qualcosa di esterno al soggetto e come qualcosa cui è necessario conformarsi;b) livello convenzionale: i soggetti si conformano alle regole socialmente approvate così le sostengono e le giustificano;c) postconvezionale: i soggetti possiedono delle norme morali legate a un sistema di princi-pi astratti e di valori universali.
Esiste un legame tra questi tre livelli di ragionamento e orientamento politico. Come può essere in-terpretato questo legame?
- lo sviluppo morale influenza l’orientamento politico;- l’orientamento politico influenza il ragionamento morale;- vi è una dimensione soggiacente sia all’orientamento politico sia al ragionamento mo-
rale.Emler, Renwick, Malone (1983). Ricerca per dimostrare la plausibilità delle ipotesi sopraelencate. Un campione di soggetti è stato diviso in tre gruppi: conservatori, moderati e progressisti. Ad ogni soggetto è stata poi sottoposta una gamma di sei dilemmi morali. Dai risultati è emerso che conser-vatori e progressisti tendono a dare risposte che si collocano a due livelli diversi della sequenza di sviluppo e che i conservatori sono in grado di riprodurre, se richiesti, le risposte prevalenti dei progressisti. Inoltre, anche chi non si colloca in una certa prospettiva è in grado di simulare la ri-sposta di chi invece si colloca in quella prospettiva. Di conseguenza, deduciamo che la differenza tra ragionamento convenzionale e postconvenzionale è legata a una differenza di contenuti, all’o-rientamento ideologico dei soggetti
4. Tetlock (1993). Orientamento politico e stile cognitivo. L’autore utilizza l’indice di complessità integrativa, che deriva dalla combinazione di due fattori:
1. grado di differenziazione: numero di dimensioni distinte di un problema individuate nel te-sto esaminato;
2. grado di integrazione: numero di connessioni che il soggetto stabilisce tra le varie dimen-sioni del problema.
I due fattori sono collegati, nel senso che il numero di dimensioni individuate condiziona il numero di connessioni che si possono stabilire.I risultati delle ricerche conducono alla formulazione di due ipotesi:
• ipotesi di rigidità della destra: i soggetti di destra sarebbero caratterizzati da modalità di ragionamento più rigide, dogmatiche, più semplici rispetto ai soggetti di sinistra;
• ipotesi ideologica: l rigidità è una peculiarità di chi si colloca agli estremi del continuum ideologico destra-sinistra.
Appare però difficile stabilire un legame diretto e univoco tra orientamento politico e stile cogniti-vo e risulta così necessario tenere conto di altre variabili legate al contesto: es. tema politico e ruolo del soggetto. Analizzando queste variabili ci si rende conto che il livello di complessità inte-grativa è più elevato quanto più simile è l’importanza attribuita dai soggetti ai due valori evocati da uno specifico tema, e quindi quanto maggiore è il conflitto percepito tra questi due valori. Inol-tre, comprendiamo che quando il soggetto riveste una posizione di potere sarà caratterizzato da un alto livello di complessità integrativa, trovandosi spesso nella posizione di dover conciliare e me-diare posizioni diverse (chi invece lotta per il potere tende a mettere in evidenza le caratteristiche che lo differenziano dagli altri e si caratterizza per un basso livello di complessità integrativa).
1
Dalle ricerche emerge infine che: a) i soggetti del centro e della sinistra moderata sono più inte-grativamente complessi dei soggetti della destra; b) indipendentemente dall’orientamento ideologi-co e dal tema trattato, vi sono situazioni che richiedono più complessità integrativa di altre.
CAPITOLO 5. La comunicazione politica
Difficile pensare alla politica senza pensare anche ai mezzi di comunicazione di massa, che aumen-tano la possibilità per gli uomini politici di raggiungere i cittadini, di informare e lanciare il pro-prio messaggio, e che offrono ai cittadini la possibilità di sapere e vedere da vicino il mondo della politica.I media sono un tramite ma offrono anche una prima codifica e interpretazione delle informazioni, contribuendo a creare la realtà politica. Essi giocano dunque un ruolo molto importamene in am-bito politico poiché sono in grado di influenzare l’elaborazione delle informazioni da parte dei sog-getti (copertura - frequenza accessibilità); certamente da soli non sono in grado di creare la per-cezione di rilevanza di un tema, ma possono contribuire ad accentuare tale percezione.Agenda setting: processo di decisione in merito allo spazio che deve essere dato alle diverse noti-zie in televisione.Siamo tutti influenzati allo stesso modo dai media?Krosnik, Brannon (1993). Indagine sui fattori che influenzano la vulnerabilità o la resistenza al-l’influenza dei media. Dai risultati è emerso che la condizione di maggiore resistenza ai media è quella dei soggetti con alto interesse, alta conoscenza e alta fruizione dei media. Certamente, an-che un alto livello di conoscenza politica favorisce la resistenza, ma da solo non basta (perché l’ef-fetto dei messaggi potrebbe essere amplificato).Davidson (1983). Effetto terza persona: le persone sovrastimano l’effetto che i media hanno sugli altri e sottostimano quello che hanno su loro stessi. Questa tendenza sarebbe dovuta al forte biso-gno di percepire di avere un pieno controllo sulle proprie azioni e così accrescere la propria auto-stima: il reale viene interpretato e spiegato in modo tale da mantenere sempre un’immagine positi-va di sé stessi (self serving biases). Si tratta di un classico processo di confronto sociale.L’effetto terza persona è accentuato se:
• la fonte di comunicazione è percepita come tendenziosa o inaffidabile;• il messaggio è percepito come dannoso o socialmente indesiderabile;• gli altri sui quali i media hanno un’influenza sono percepiti come una categoria molto am-
pia e socialmente distante.Duck, Hogg, Terry (1993). Indagine relativa all’influenza dei media durante la campagna elettora-le per le elezioni politiche australiane: una più forte identificazione coincide con un’accentuata tendenza a giudicare i membri del proprio partito come meno influenzati dai media rispetto ai membri del partito avversario. Quando l’identità di partito è forte, la comparsa dell’effetto terza persona viene condizionata all’appartenenza di gruppo.“La politica è fatta di parole”. Ma anche la realtà in generale è fatta di parole, che ci garantisco-no la possibilità di interagire efficacemente. Il linguaggio, dunque, gioca un ruolo determinante nella costruzione della realtà. La politica non è tanto fatta di oggetti concreti, tangibili, quanto di nozioni astratte, di concetti che esistono in quanto diamo loro un nome e un significato condiviso. Le parole della politica non hanno un referente concreto attuale e questo fa si che nel linguaggio politico si ritrovino caratteristiche quali la polivalenza, la polisemia e l’ambiguità. La possibilità di disambiguare un testo è favorita dall’esame del contesto in cui questo è pronunciato, ma, nel lin-guaggio politico, la disambiguazione può essere molto difficile a causa della scarsità referenziale e della presenza di scopi e sovrascopi spesso diversi.L’attenzione degli studiosi è rivolta soprattutto alle produzioni discorsive, intese come espressione di un soggetto locatore che è mosso da motivazione e scopi che presuppone sempre la presenza di un altro, anche se non fisicamente presente. Quindi, anche una situazione di monologo può essere vista e studiata con i criteri del dialogo. In particolare, l’attenzione è rivolta ai soggetti in quanto
1
attori della politica. Studiare il linguaggio significa studiare il canale privilegiato attraverso cui i soggetti entrano in relazione.(N.B. linguaggio politico ≠ componente politica del linguaggio, che rimanda agli scambi comuni-cativi caratterizzata da una relazione di potere) Il rapporto tra cittadini e politici è quasi sempre mediato dai mezzi di comunicazione di massa. procediamo perciò all’analisi di alcune particolari situazioni comunicative nelle quali si manifesta tale mediazione.1. INTERVISTE A UOMINI POLITICI. Bull, Mayer (1993).Una delle strategie linguistiche mag-giormente utilizzate è quella della non-risposta, cioè il modo con cui i politici eludono o trasforma-no le domande a loro rivolte.2. FACCIA A FACCIA TELEVISIVI (tra uomini politici). La dimensione conflittuale è una dimen-sione tipica della politica. E nella discussione politica, conoscere gli argomenti dell’altro diventa essenziale per poter prevedere le mosse e controbattere con facilità.Il dibattito pubblico è una messa in scena(poco è lasciato al caso) rivolta ad un pubblico non diret-tamente coinvolto ma comunque protagonista. Anche nei faccia a faccia televisivi, dunque, il vero obiettivo di chi parla non è convincere l’interlocutore ma gli spettatori. Lo scopo ultimo è quello di ottenere il consenso degli elettori, ma è anche vero che questo scopo si articola in una serie di sot-toscopi (es. difendere la propria immagine o attaccare quella dell’altro) e l’analisi deve partire dall’individuazione di questi (componente pragmatica: come e perché si dice una certa cosa)Converso, DePiccoli (1996). Analisi del faccia a faccia televisivo del 1994 tra Berlusconi e Occhet-to: applicazione dell’Analisi Preposizionale del Discorso (APD). Si tratta di un modello di analisi del discorso in cui la proposizione (argomento – ciò di cui si parla + predicato – ciò che si afferma sull’argomento) viene assunta come unità base per individuare i punti principali affrontati nell’am-bito della produzione discorsiva (referenti nodali). Si utilizzano poi diverse altre categorie di anali-si (verbi, congiunzioni…) come indicatori delle strategie discorsive adottate dal soggetto. L’atten-zione deve essere rivolta non tanto a ciò che gli attori politici dicono ma al modo (riferimento sia a sé che all’altro; messa in evidenza della propria identità; attacco agli argomenti dell’altro).3. DISCORSI DEGLI UOMINI POLITICI. Reicher, Hopkins (1996). Analisi dei discorsi politici di M. Thatcher e N. Kinnock ai rispettivi congressi di partito, incentrati sul tema dello sciopero dei minatori inglesi tra il 1984 e il 1985 (assumono come riferimento la teoria della categorizzazione del sé, Turner): si utilizzano il linguaggio e l’argomentazione allo scopo di creare nell’uditorio un’identità collettiva consonante con l’orientamento del proprio partito (ingroup) e dissonante con quello del partito opposto (outgorup).→ LINGUAGGIO DEI CITTADINI. Reicher (1996). Analisi della “Battaglia di Wetsminster”, con-dotta dall’Unione Nazionale degli Studenti nel novembre 1988: le produzioni discorsive dei parte-cipanti sono analizzate in quanto indicatori dei processi relativi alla definizione di sé, e delle rela-tive conseguenze in termini di predisposizione all’azione collettiva (se inizialmente mi riferisco a gruppi di studenti diversi, l’azione collettiva mi porta a ridefinire il criterio di appartenenza). La ricostruzione di un’azione collettiva da parte di chi vi ha partecipato è un fonte di informazione im-portante per comprendere i fattori predittivi dell’azione stessa e dei suoi sviluppi.Colucci, Camussi (1996). Senso comune = modo di ragionare proprio della gente comune e della vita quotidiana (processi di semplificazione, elaborazione, costruzione della realtà). La ricerca ri-vela che:
• l’effetto terza persona si manifesta nel contesto discorsivo in cui la valutazione generale della campagna elettorale appare decisamente negativa, confusa, aggressiva, poco aderen-te ai reali problemi politici del paese;
• la televisione viene vista, in tale contesto, come una presenza intrusiva e minacciosa (anche se il danno che può fare dipende dalle caratteristiche delle persone → persone bene infor-mate vs. gente comune).
CAPITOLO 6. La partecipazione politica
1
Conoscenze, atteggiamenti, decisione, orientamenti ideologici e comunicazione sono componenti importanti della partecipazione politica. La partecipazione politica implica il riferimento all’azio-ne e quindi alla persona, inserita in un contesto reale e in una rete di relazioni con altri.Tajfel, Turner (1986). TEORIA DELL’IDENTITÀ SOCIALE: ciascun individuo, nel corso dello svi-luppo, giunge a comprendere di essere un’unità distinta dagli altri, con caratteristiche proprie. Il sentimento di IDENTITÀ consiste nella percezione che i soggetti hanno del proprio essere continui attraverso il tempo e distinti, in quanto entità, da tutti gli altri. Le componenti dell’identità sono dunque: a)continuità e stabilità; b) individualità come distinzione dagli altri.Il soggetto è originariamente sociale, ha appartenenze “date”, ma ne sviluppo anche altre → Taj-fel (1981). IDENTITÀ SOCIALE: quella parte dell’immagine che un individuo si fa di sé stesso, che deriva dalla consapevolezza di appartenere a un gruppo sociale, uniti al valore e al significato emozionale associati a tale appartenenza. Ciascuno di noi è alla ricerca di un’identità sociale posi-tiva; questo obiettivo viene raggiunto mediante il confronto del proprio gruppo con altri gruppi e attraverso la dimostrazione di una “distintività positiva”.Turner (1985, 1987). TEORIA DELLA CATEGORIZZAZIONE DEL SÉ: (enfasi sulla componente cognitiva dell’identità) l’ esigenza primaria è quella di definirsi in modo chiaro (autodefinizione), preferibilmente positivo. Importante per una buona definizione di sé è la dimensione del gruppo di appartenenza: gruppi di dimensione intermedia sarebbero più distinti rispetto gruppi troppo pic-colo o troppo estesi (TEORIA DELLA DISTINTIVITÀ OTTIMALE).Identità e azione si influenzano e si alimentano reciprocamente.Il voto è una, e per molti l’unica, delle forme principali di partecipazione alla vita politica. M come si spiega il comportamento di voto?1. Identificazione col partito (party identification). Campbell (1960). Variabile psicologica, sogget-tiva. Si presuppone che il soggetto sviluppi, nel corso dell’età evolutiva, diverse forme di identifica-zione, tra cui quella con il partito. Un ruolo determinante è giocato dalla famiglia. La scelta dell’i-dentificazione, proprio perché maturata precocemente, risulterebbe stabile e al tempo stesso si ri-velerebbe essere la spiegazione della scarsa conoscenza e dell’incoerenza dei soggetti in ambito politico (perché ha matrice affettiva).Fine anni ’60: declino dell’immagine dei partiti e del senso di appartenenza ad essi, cui è seguita una diminuzione della stabilità nelle scelte di voto dei cittadini. È aumentato, invece, il fenomeno del ticket splitting, cioè la scelta di partiti diversi in consultazioni elettorali di diversa natura.Limite: non distingue sufficientemente tra variabile indipendente e variabile dipendente (stabilità e identificazione).2. Voto basato sui candidati (traitbased voting): a partire dagli anni ’70 viene posta in evidenza la possibilità di una scelta di voto basata su una valutazione delle caratteristiche dei singoli candida-ti.Miller, Wattenberg, Malanchuk (1986). I tratti attribuiti ai candidati sono il fattore più spesso ri-corrente nei commenti fatti dai soggetti sulle proprie scelte politiche.3. Voto basato sulla prestazione (performance voting): la scelta di voto è vista come legata alla va-lutazione di come un partito o un governo si è comportato nel passato.4. Voto basato sui temi politici (issue voting): la scelta di voto è basata sui programmi dei diversi partiti politici. In questo ambito sono stati sviluppati molteplici modelli, spesso contrapposti:a) Himmelweit (1985). MODELLO DEL CONSUMATORE: il voto è determinato dall’accordo con-tingente con le posizioni di un partito piuttosto che dall’identificazione il partito stesso. L’elettore sceglie in funzione dell’esigenza del momento.b) Heath, Jowell, Curtice (1985). MODELLO IDEOLOGICO: è la condivisione di credenze gene-rali che induce i soggetti a scegliere un determinato partito. Questi principi si possono collocare lungo due dimensioni principali, 1. uguaglianza vs. disuguaglianza; 2. conservatorismo vs. pro-gressismo.La scelta di voto, così come enunciato dalla teoria della scelta razionale, è guidata dall’interesse personale: l’obiettivo è la massimizzazione del proprio benessere economico. La teoria dell’identi-
1
tà sociale suggerisce, invece, che in alcuni casi il benessere derivante dall’appartenenza a un grup-po può costituire per il soggetto un’esigenza così forte da competere con il benessere derivante dal perseguimento del proprio interesse economico immediato. Quindi, da una parte si collocano gli approcci che fondano la scelta di voto sull’azione del singolo, in quanto soggetto svincolato dal ri-ferimento alla realtà sociale, mentre dalla parte opposta si collocano gli approcci che identificano le variabili sociostrutturali e l’identificazione con il partito come variabili del voto.Esiste però la possibilità di presupporre che esista un’interazione tra fattori psicologici individuali e fattori sociali strutturali: il soggetto agisce in quanto essere sociale radicato ella realtà in cui vive, al punto che tale realtà finisce per costituire parte integrante della sua stesa identità sociale.Abrams, Emler (1992). La scelta di voto del soggetto si basa su valori espressivi → votare per un partito può essere un modo per esprimere la propria identità (vs. valori strumentali → beneficio che mi deriva dal votare per un determinato partito). Una motivazione di questo tipo è valida solo se il voto per un determinato partito costituisce uno degli attributi criteriali dell’identità (Turner, 1985): quando l’appartenenza ad un certo gruppo diviene saliente è essenziale, per il mantenimen-to e il rafforzamento dell’identità di gruppo, che il soggetto ritenga di possedere gli attributi più ti-pici e caratteristici del gruppo di appartenenza. I due autori rilevano dunque che l’identità sociale può essere più forte dell’interesse personale immediato e la scelta di voto può essere condotta sulla base di valori espressivi.Abrams (1994). Riferimento alla teoria della distintività ottimale (Brewer, 1991; 1993), secondo cui c’è un livello ottimale di dimensione del gruppo perché io mi possa identificare con questo. Per questo motivo, i valori espressivi possono avere un peso maggiore quando il partito scelto è un partito di minoranza, mentre i valori strumentali prevalgono più spesso quando si tratta di un par-tito di maggioranza.Smith, Tyler (1996). L’interesse del gruppo può competere con l’interesse personale, o addirittura prevalere su di esso nel guidare le scelte politiche. quanto più l’appartenenza a un gruppo è impor-tante per il soggetto, tanto più questi cercherà di perseguire gli interessi del gruppo stesso, in quanto ciò è essenziale alla sopravvivenza e al rafforzamento del gruppo.Sulla base di tutte queste ricerche posiamo dedurre che:
• il bisogno di esprimere e consolidare la propria appartenenza a un gruppo può costituire una motivazione delle scelte politiche più forte e immediata rispetto al bisogno di perseguire il proprio interesse personale;• quando la scelta politica viene effettuata sulla base dell’appartenenza a un gruppo “avvan-taggiato”, può essere difficile distinguere se ciò che viene perseguito è l’interesse personale o quello del gruppo. Questa distinzione può essere più semplice quando la scelta politica si basa sull’appartenenza a un gruppo senza potere o “svantaggiato” (legame tra interesse personale e interesse di gruppo meno diretto e immediato);• l’identità sociale di un soggetto può essere costituita dall’appartenenza contemporanea a più gruppi.
Oggi assistiamo a un’evidente tendenza a non coinvolgersi nella vita politica attiva, soprattutto a causa della crisi delle ideologie e dei partiti e in seguito alla nascita di nuove attività, movimenti e gruppi concentrati attorno a problemi specifici.Urbani (1980) PARTECIPAZIONE POLITICA: comportamento autonomo di chi, essendo e senten-dosi parte di una qualche collettività, concorre in vario modo (quindi esistono diverse forme e di-versi gradi di partecipazione) al processo delle decisioni che la riguardano. Precisando:
a) oltre all’appartenenza oggettiva a una collettività, tra i requisiti fondamentali della parteci-pazione vi è anche l’appartenenza soggettiva;
b) il soggetto che partecipa stabilisce delle relazioni con altri (il fine perseguito con l’azione collettiva vale per me stesso ma non solo);
c) il fine è quello di esercitare un’influenza più o meno diretta sulle decisioni che riguardano la collettività.
1
Milbrath (1965). La partecipazione è vista lungo un continuum che va da un livello minimo di atti-vità a un livello massimo di attività politica, con una serie di attività di livello intermedio. Si tratta di una scala gerarchica di attività politica, nella quale si ipotizza che le atività superiori nella sca-la siano inclusive di quelle inferiori. Tutte le attività possono essere raggruppate in tre categorie:
1. da gladiatore, quelle di chi si espone in prima persona nel circo della politica;2. di transizione, di chi si espone ma fino a un certo punto;3. da spettatori, di chi partecipa allo spettacolo della politica.
La partecipazione può dunque essere misurata sia come costrutto unidimensionale (ricerca di Mil-brath), sia come costrutto multidimensionale (altre ricerche).
Approcci sociologici al tema dell’azione collettiva:McCarthy, Zald (1979). Teoria della mobilitazione delle risorse: per ottener ciò che vogliono i soggetti sono indotti a unire i loro sforzi, ad agire collettivamente. La chiave del successo sta nel disporre di risorse appropriate: persone e mezzi economici. L’organizzazione assume un ruolo cen-trale: è necessario che le persone si organizzino in modo da disporre di uno strumento che consen-ta loro di perseguire in modo organico e d efficace gli scopi comuni (garantire l’equilibrio tra co-sti e benefici). L’organizzazione fa dunque da cerniere tra i vincoli e le opportunità offerti dal siste-ma e i comportamenti degli attori.Limiti: manca uno studio delle motivazioni che spingono ad organizzarsi; l’azione collettiva viene vista come intento di realizzare il proprio interesse individuale → individualismo radicale. Melucci (1989). Approccio sociocostruttivista: 1) i significati si creano e si costruiscono social-mente, attraverso la comunicazione impersonale, i media e così via; 2) il soggetto dell’azione col-lettiva (attore) appartiene a gruppi di vario tipo, ognuno dei quali ha un peso proprio nella forma-zione dell’identità del soggetto.
Determinanti psicologiche all’azione collettiva.Per molto tempo l’azione collettiva è stata definita come un’azione guidata da processi irrazionali e automatici.Le Bon (1895). Comportamenti generici e standardizzati, frutto di caratteristiche invarianti proprie della folla.Freud (1921). Il comportamento pubblico in situazione di azione collettiva è un modo di proiettare verso oggetti esterni a sé, un’aggressività inizialmente rivolta verso gli oggetti interni, e quindi po-tenzialmente molto pericolosa per la salute mentale e l’incolumità della persona.Smelser (1981). Evoluzione dello studio dell’azione collettiva: a) dall’esame dei processi irraziona-li, all’esame dei processi razionali e intenzionali; b) da azione collettiva scatenata sa processi au-tomatici, ad azione collettiva determinata dall’influenza di eventi concatenati; c) da approccio psi-cologico ad approccio sociologico (condizioni sociali come causa dell’azione collettiva).Fattori che possono spiegare la partecipazione indiretta all’azione collettiva:LOCUS OF CONTROL: aspettativa generalizzata in base ala quale il sogetto può essere orientato o meno a ritenere che la propria azione sarà determinante per il conseguimento dei propri scopi. distinguiamo tra: a) locus of control interno, nel caso in cui i soggetti percepiscano gli eventi come una conseguenza del loro agire e dunque suscettibili di controllo; b) locus of control esterno, se i soggetti percepiscono gli eventi come estranei alla propria sfera di controllo e azione. Chi ha un locus of control interno è più orientato alla partecipazione politica (posso condizionare gli eventi quindi partecipo; la partecipazione mi permetterà di condizionare gli eventi).EFFICACIA POLITICA: Campbell, Gurin, Miller (1954). Sensazione che l’azione politica indivi-duale abbia o possa avere un impatto sul processo politico, ossia che valga la pena di compiere il proprio dovere di cittadino. Comprende due dimensioni: 1) efficacia politica esterna, ossia la per-cezione di efficacia che deriva da componenti esterne all’individuo (fiducia nel sistema); 2) effica-cia politica interna, ossia la percezione di efficacia che dipende dalla propria forza o debolezza personale (autoefficacia). È costituita da aspettative di competenza, relative alla capacità di com-
1
piere un’azione politica, ma anche da aspettative di risultato, relative alla probabilità che l’azione abbia successo.Perché il soggetto compia un’azione deve concepirla, pianificarla ed avere il potere di compierla.→ Andrews (1991), Klandermans (1997). Efficacia di gruppo: il soggetto ha aspettative di compe-tenza e di risultato anche nei confronti degli altri potenziali o effettivi partecipanti all’azione politi-ca. la percezione di efficacia del gruppi costituita da: 1) valutazione della probabilità che anche altri intraprendano la stessa azione; 2) valutazione della competenza degli altri ad agire; 3) valu-tazione della probabilità che l’azione abbia successo se molti parteciperanno.ORIENTAMENTO INDIVIDUALISTA/COLLETTIVISTA: Triandis (1988), McCusker, Hui (1990). Gli orientamenti delle persone su temi di vrio tipo sono riconducibili a un denominatore comune, l’individualismo o il collettivismo. Si tratta di un denominatore fondato culturalmente, cioè condi-viso all’interno di una medesima cultura, che si stabilizza nel soggetto fino a divenire una caratte-ristica di personalità. La partecipazione è più probabile per i soggetti che hanno un orientamento collettivistico.DEPRIVAZIONE RELATIVA: Folger, Rosenfield, Robinson (1983). Percezione del soggetto di su-bire ingiustizie, di essere discriminato rispetto ad altri, privato di qualcosa di cui ha diritto (deriva dal confronto sociale). Sono tre le condizioni necessarie perché si possa parlare di deprivazione relativa: 1) desiderare qualcosa che non si ha e si ritiene importante; 2) sentirsi in diritto di avere qualcosa; 3) non attribuire a sé stessi la colpa di non averlo, ma avere la percezione che altri ab-biano determinato questa carenza.Distinguiamo tra: a) deprivazione egoistica (io sono discriminato rispetto ad altri); b) deprivazione collettiva (il mio gruppo è discriminato rispetto ad altri). È la deprivazione collettiva che può esse-re una determinante dell’azione collettiva.La deprivazione è costituita da una componente cognitiva (percezione dell’ampiezza della depriva-zione) e da una affettiva (percezione dell’ intensità della deprivazione).
L’identità sociale è fondata sul senso di appartenenza al gruppo, ed è sostenuta e rafforzata dalla condivisione con i membri del gruppo di credenze, ideologie e scopi. L’identità sociale risulta per-ciò essere una delle componenti che condizionano l’azione collettiva. In particolare, quando l’iden-tità sociale si basa sull’appartenenza a gruppi caratterizzati da un orientamento collettivista e re-lazionale, essa può più facilmente costituire una determinante dell’azione collettiva.Tajfel, Turner. La società è fatta di categorie e gruppi che detengono il potere (high status) e di al-tri gruppi che appaiono caratterizzati da una mancanza di potere (low status). L’appartenenza a un gruppo high status conferisce ai suoi membri benefici materiali e sociale, un’identità sociale positi-va e un alto livello di autostima; l’appartenenza a un gruppo low status, invece, non conferisce al-cun vantaggio immediato. I soggetti di low status possono perciò ricorrere a varie strategie per mi-gliorare la propria posizione:1. mobilità individuale: abbandono il mio gruppo low status e mi inserisco in un gruppo high sta-tus. Il che è possibile solo nel caso in cui i confini dei gruppi sono caratterizzati da un alto grado di permeabilità;2. creatività sociale: cerco delle dimensioni di confronto con gli altri gruppi che non siano così pe-nalizzanti per la mia identità (es. Van Knippenberg, 1978. Maggiore attitudine alla pratica dei di-plomati tecnici rispetto ai diplomati del liceo);3. competizione e cambiamento sociale: cerco di cambiare lo status quo del mio gruppo, quindi gli equilibri di potere. Questo conduce allo sviluppo di atteggiamenti o comportamenti conflittuali nei confronti di altri gruppi. Questa strategia viene messa in atto quando si concepisce un’alternativa nella gerarchia attuale, nel senso che le posizioni di status sono percepite come instabili e illegitti-me.Taylor, McKirnan (1984). Chi si trova in un gruppo svantaggiato tenderebbe inizialmente di la-sciarlo per inserirsi nel gruppo avvantaggiato e poter così perseguire l’obiettivo di sviluppare un’i-dentità sociale positiva. Se questo tentativo fallisce, il soggetto acquisirebbe una piena coscienza
1
della propria appartenenza di gruppo e ciò lo indurrebbe a intraprendere un’azione collettiva, allo scopo di modificare la situazione di potere del gruppo stesso. L’azione si rivolgerebbe perciò all’e-sterno, nel tentativo di cambiare la definizione dei rapporti con gli altri gruppi.Le ricerche dimostrano che:
• l’identità di gruppo ha un effetto diretto sull’azione collettiva (Kelly, Kelly, 1994. Parteci-pazione facile vs. partecipazione difficile; identità di gruppo – o di genere – come migliore predittore per i due tipi di partecipazione);• l’identità sociale può avere anche un effetto moderatore rispetto ad altri fattori: se l’identi-tà è forte la partecipazione sarà più determinata da fattori sociali (deprivazione relativa), vice-versa sarà determinata da fattori individuali (efficacia politica).
1