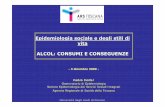Cari mamma e papa', · Web viewI libri di testo sono sostanzialmente due: (1) una dispensa, PDF,...
Transcript of Cari mamma e papa', · Web viewI libri di testo sono sostanzialmente due: (1) una dispensa, PDF,...
ECOLOGIA Integrale
È un corso monografico, cioè di approfondimento tematico. Quindi non c’è un vincolo di programma così stretto, bensì una certa elasticità.Corso monografico di Teologia Morale. L’argomento prescelto è l’ecologia (oikos = casa, ambiente; logos = discorso, studio), in riferimento all’enciclica di papa Francesco, Laudato sii. “Integrale” perché ci sono tanti modelli di ecologia che affondano le loro radici in altrettanti modelli antropologici. Un conto è pensare che l’uomo sia un intralcio allo sviluppo ambientale, altro è pensare che l’uomo sia il vertice della natura e dunque tutti sia in funzione sua.
Soprattutto leggendo l’enciclica LS sarà chiaro che il riferimento alla sola ecologia non basta in ambito cristiano, bensì occorre una premessa antropologica ben fondata. Eco-logia ed eco-nomia non vanno disgiunte (discorso e leggi sulla casa/ambiente)L’orizzonte sarà dunque quello della dottrina sociale della chiesa.
I parte – magistero della Chiesa sulla materia ecologica (testi recenti, dal 1979 a oggi; perché solo di recente ci si è posti il problema)II parte – approfondimenti sul discorso della economia (per rintracciare un nuovo modello). La crisi economica ha infatti alle sue spalle la crisi morale e antropologica.
I libri di testo sono sostanzialmente due: (1) una dispensa, PDF, nel senso di essere una raccolta di documenti e testi che verranno commentati; (2) per la seconda parte, F. Casazza, Sviluppo e libertà in Amartya Sen, sul rapporto tra etica, economia, ecologia.ESAME: si fa in unica soluzione, poiché le due parti sono molto collegate.Sfruttare bene le lezioni per comprendere gli snodi del discorso, cogliendo le diverse sfumature dei testi esaminati.
Redemptor Hominis È il primo documento che affrontiamo. Di Giovanni Paolo II, risale al 1979.Affronta le paure del mondo contemporaneo, indicando la paura come la cifra caratteristica dell’uomo oggi. Un clima che anche oggi (flussi migratori) si respira.Da dove nasce questa paura? Dal fatto che l’uomo ha un potere di dominare il creato che gli si sta rivoltando contro. Si fa fatica nel mondo d’oggi a trovare un senso in sé nel mondo, a parte quello che gli assegna egli stesso in quanto strumento di godimento e di consumo. Quindi il progresso è ambivalente: da una parte produce opportunità, dall’altra difficoltà.Questo progresso rende dunque la vita dell’uomo più umana? Sono temi che si legano agli interrogativi cristiani ma anche all’esperienza del vivere in generale. Ecco perché la Chiesa su questo tema non parla ai cristiani ma a tutti gli “uomini di buona volontà” (cfr. LS di papa Francesco).Perché facciamo progresso? Per diventare schiavi delle cose e dei sistemi economici o della produzione? La domanda di fondo è dunque: “Chi è l’uomo?”, ma questa domanda ricade su ogni minuto della vita, su tutto il mio modo d’essere. Anche perché le disparità tra popoli sono sempre maggiori (Paolo VI, Populorum Progressio: i vari “Lazzari” del ricco Epulone ancora aspettano…).Il progresso deve quindi essere sviluppo della persona umana, non solo della tecnologia. È una responsabilità morale dell’uomo. Se non fai un retto uso della tua libertà, vivrai nella paura.
ECOLOGIA – il Magistero della Chiesa non ama questo termine che può esser equivoco, infatti per alcune visioni “ecologiche” l’uomo è dannoso per l’ambiente, posizione incompatibile con la dottrina cristiana. Ecco perché si parla di ECOLOGIA INTEGRALE o di TEOLOGIA DEL CREATO o di CUSTODIA DEL CREATO.
L’enciclica RH non tratta direttamente di ecologia, ma è programmatica del pontificato ed è fondativa perché pone le fondamenta dei temi trattati nelle encicliche successive e specifica una premessa chiave del nostro discorso: non si può fare ecologia senza specificare una corretta antropologia.
LETTERA ENCICLICA REDEMPTOR HOMINIS DEL SOMMO PONTEFICE GIOVANNI PAOLO II AI VENERATI FRATELLI NELL’EPISCOPATO AI SACERDOTI E ALLE FAMIGLIE RELIGIOSE AI FIGLI E FIGLIE DELLA CHIESA E A TUTTI GLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ ALL'INIZIO DEL SUO MINISTERO PONTIFICALE (4 marzo 1979) 15. Di che cosa ha paura l'uomo contemporaneo L'uomo d'oggi sembra essere sempre minacciato da ciò che produce, cioè dal risultato del lavoro delle sue mani e, ancor più, del lavoro del suo intelletto, delle tendenze della sua volontà. I frutti di questa multiforme attività dell'uomo, troppo presto e in modo spesso imprevedibile, sono non soltanto e non tanto oggetto di «alienazione», nel senso che vengono semplicemente tolti a colui che li ha prodotti; quanto, almeno parzialmente, in una cerchia conseguente e indiretta dei loro effetti, questi frutti si rivolgono contro l'uomo stesso. Essi sono, infatti, diretti, o possono esser diretti contro di lui. In questo sembra consistere l'atto principale del dramma dell'esistenza umana contemporanea, nella sua più larga ed universale dimensione. L'uomo, pertanto, vive sempre più nella paura. Egli teme che i suoi prodotti, naturalmente non tutti e non nella maggior parte, ma alcuni e proprio quelli che contengono una speciale porzione della sua genialità e della sua iniziativa, possano essere rivolti in modo radicale contro lui stesso; teme che possano diventare mezzi e strumenti di una inimmaginabile autodistruzione, di fronte alla quale tutti i cataclismi e le catastrofi della storia, che noi conosciamo, sembrano impallidire. Deve nascere, quindi, un interrogativo: per quale ragione questo potere, dato sin dall'inizio all'uomo, potere per il quale egli doveva dominare la terra, si rivolge contro lui stesso, provocando un comprensibile stato d'inquietudine, di cosciente o incosciente paura, di minaccia, che in vari modi si comunica a tutta la famiglia umana contemporanea e si manifesta sotto vari aspetti? Questo stato di minaccia per l’uomo, da parte dei suoi prodotti, ha varie direzioni e vari gradi di intensità. Sembra che siamo sempre più consapevoli del fatto che lo sfruttamento della terra, del pianeta su cui viviamo, esiga una razionale ed onesta pianificazione. Nello stesso tempo, tale sfruttamento per scopi non soltanto industriali, ma anche militari, lo sviluppo della tecnica non controllato né inquadrato in un piano a raggio universale ed autenticamente umanistico, portano spesso con sé la minaccia all'ambiente naturale dell’uomo, lo alienano nei suoi rapporti con la natura, lo distolgono da essa. L’uomo sembra spesso non percepire altri significati del suo ambiente naturale, ma solamente quelli che servono ai fini di un immediato uso e consumo. Invece, era volontà del Creatore che l'uomo comunicasse con la natura come «padrone» e «custode» intelligente e nobile, e non come «sfruttatore» e «distruttore» senza alcun riguardo. Lo sviluppo della tecnica e lo sviluppo della civiltà del nostro tempo, che è contrassegnato dal dominio della tecnica stessa, esigono un proporzionale sviluppo della vita morale e dell’etica. Intanto quest'ultimo sembra, purtroppo, rimanere sempre arretrato. Perciò, quel progresso, peraltro tanto meraviglioso, in cui è difficile non scorgere anche autentici segni della grandezza dell'uomo, i quali, nei loro germi creativi, ci sono rivelati nelle pagine del Libro della Genesi, già nella descrizione della sua creazione, non può non generare molteplici inquietudini. La prima inquietudine riguarda la questione essenziale e fondamentale: questo progresso, il cui autore e fautore è l'uomo, rende la vita umana sulla terra, in ogni suo aspetto, «più umana»? La rende più «degna dell’uomo»? Non ci può esser dubbio che, sotto vari aspetti, la renda tale. Quest’interrogativo, però, ritorna ostinatamente per quanto riguarda ciò che è essenziale in sommo grado: se l'uomo, come uomo, nel contesto di questo progresso, diventi veramente migliore, cioè più maturo spiritualmente, più cosciente della dignità della sua umanità, più responsabile, più aperto agli altri, in particolare verso i più bisognosi e più deboli, più disponibile a dare e portare aiuto a tutti.
Questa è la domanda che i cristiani debbono porsi, proprio perché Gesù Cristo li ha così universalmente sensibilizzati intorno al problema dell'uomo. E la stessa domanda debbono anche porsi tutti gli uomini, specialmente coloro che appartengono a quegli ambienti sociali, che si dedicano attivamente allo sviluppo ed al progresso nei nostri tempi. Osservando questi processi ed avendo parte in essi, non possiamo lasciarci prendere dall'euforia, né possiamo lasciarci trasportare da un unilaterale entusiasmo per le nostre conquiste, ma tutti dobbiamo porci, con assoluta lealtà, con obiettività e con senso di responsabilità morale, le domande essenziali che riguardano la situazione dell'uomo, oggi e nel futuro. Tutte le conquiste, finora raggiunte, e quelle progettate dalla tecnica per il futuro, vanno d'accordo col progresso morale e spirituale dell'uomo? In questo contesto l'uomo, in quanto uomo, si sviluppa e progredisce, oppure regredisce e si degrada nella sua umanità? Prevale negli uomini, «nel mondo dell'uomo» - che in se stesso è un mondo di bene e di male morale - il bene sul male? Crescono davvero negli uomini, fra gli uomini, l'amore sociale, il rispetto dei diritti altrui - per ogni uomo, nazione, popolo - o, al contrario, crescono gli egoismi di varie dimensioni, i nazionalismi esagerati, al posto dell'autentico amore di patria, ed anche la tendenza a dominare gli altri al di là dei propri legittimi diritti e meriti, e la tendenza a sfruttare tutto il progresso materiale e tecnico-produttivo esclusivamente allo scopo di dominare sugli altri o in favore di tale o talaltro imperialismo? Ecco gli interrogativi essenziali, che la Chiesa non può non porsi, perché in modo più o meno esplicito se li pongono miliardi di uomini che vivono oggi nel mondo. Il tema dello sviluppo e del progresso è sulla bocca di tutti ed appare sulle colonne di tutti i giornali e pubblicazioni, in quasi tutte le lingue del mondo contemporaneo. Non dimentichiamo, però, che questo tema non contiene soltanto affermazioni e certezze, ma anche domande e angosciose inquietudini. Queste ultime non sono meno importanti delle prime. Esse rispondono alla natura della conoscenza umana, ed ancor più rispondono al bisogno fondamentale della sollecitudine dell'uomo per l'uomo, per la stessa sua umanità, per il futuro degli uomini sulla terra. La Chiesa, che è animata dalla fede escatologica, considera questa sollecitudine per l'uomo, per la sua umanità, per il futuro degli uomini sulla terra e, quindi, anche per l'orientamento di tutto lo sviluppo e del progresso, come un elemento essenziale della sua missione, indissolubilmente congiunto con essa. Ed il principio di questa sollecitudine essa lo trova in Gesù Cristo stesso, come testimoniano i Vangeli. Ed è per questo che desidera accrescerla continuamente in Lui, rileggendo la situazione dell'uomo nel mondo contemporaneo, secondo i più importanti segni del nostro tempo.
16. Progresso o minaccia? Se, dunque, il nostro tempo, il tempo della nostra generazione, il tempo che si sta avvicinando alla fine del secondo Millennio della nostra era cristiana, si rivela a noi come tempo di grande progresso, esso appare, altresì, come tempo di multiforme minaccia per l'uomo, della quale la Chiesa deve parlare a tutti gli uomini di buona volontà, ed intorno alla quale deve sempre dialogare con loro. La situazione dell'uomo nel mondo contemporaneo, infatti, sembra lontana dalle esigenze oggettive dell'ordine morale, come dalle esigenze della giustizia e, ancora più, dell'amore sociale. Non si tratta qui che di ciò che ha trovato la sua espressione nel primo messaggio del Creatore, rivolto all'uomo nel momento in cui gli dava la terra, perché la «soggiogasse». Questo primo messaggio è stato riconfermato, nel mistero della Redenzione, da Cristo Signore. Ciò è espresso dal Concilio Vaticano II in quei bellissimi capitoli del suo insegnamento che riguardano la «regalità» dell'uomo, cioè la sua vocazione a partecipare all'ufficio regale - il munus regale di Cristo stesso. Il senso essenziale di questa «regalità» e di questo «dominio» dell'uomo sul mondo visibile, a lui assegnato come compito dallo stesso Creatore, consiste nella priorità dell'etica sulla tecnica, nel primato della persona sulle cose, nella superiorità dello spirito sulla materia. È per questo che bisogna seguire attentamente tutte le fasi del progresso odierno: bisogna, per così dire, fare la radiografia delle sue singole tappe proprio da questo punto di vista. Si tratta dello sviluppo delle persone e non soltanto della moltiplicazione delle cose, delle quali le persone possono servirsi. Si tratta - come ha detto un filosofo contemporaneo e come ha affermato il Concilio - non tanto di «avere di più», quanto di «essere di più». Infatti, esiste già un reale e percettibile pericolo che, mentre progredisce enormemente il dominio da parte dell'uomo sul mondo delle cose, di questo suo dominio egli perda i fili essenziali, e in vari modi la sua umanità sia sottomessa a quel mondo, ed egli stesso divenga oggetto di multiforme, anche se spesso non direttamente percettibile, manipolazione, mediante tutta l'organizzazione della vita comunitaria, mediante il sistema di produzione, mediante la pressione dei mezzi di comunicazione sociale. L'uomo non può rinunciare a se stesso, né al posto che gli spetta nel mondo visibile; non può diventare schiavo delle cose, schiavo dei sistemi economici, schiavo della produzione, schiavo dei suoi
propri prodotti. Una civiltà dal profilo puramente materialistico condanna l'uomo a tale schiavitù, pur se talvolta, indubbiamente, ciò avvenga contro le intenzioni e le premesse stesse dei suoi pionieri. Alle radici dell'attuale sollecitudine per l'uomo sta senz'altro questo problema. Non si tratta qui soltanto di dare una risposta astratta alla domanda: chi è l'uomo; ma si tratta di tutto il dinamismo della vita e della civiltà . Si tratta del senso delle varie iniziative della vita quotidiana e, nello stesso tempo, delle premesse per numerosi programmi di civilizzazione, programmi politici, economici, sociali, statali e molti altri. Se osiamo definire la situazione dell'uomo nel mondo contemporaneo come lontana dalle esigenze oggettive dell'ordine morale, lontana dalle esigenze della giustizia e, ancor più, dall'amore sociale, è perché ciò viene confermato dai ben noti fatti e dai raffronti, che più volte hanno già avuto diretta risonanza sulle pagine delle enunciazioni pontificie, conciliari, sinodali. La situazione dell'uomo nella nostra epoca non è certamente uniforme, ma differenziata in modo molteplice. Queste differenze hanno le loro cause storiche, ma hanno anche una loro forte risonanza etica. E, infatti, ben noto il quadro della civiltà consumistica, che consiste in un certo eccesso dei beni necessari all'uomo, alle società intere - e qui si tratta proprio delle società ricche e molto sviluppate -, mentre le rimanenti società, almeno larghi strati di esse, soffrono la fame, e molte persone muoiono ogni giorno di denutrizione e di inedia. Di pari passo va per gli uni un certo abuso della libertà, che è legato proprio ad un atteggiamento consumistico non controllato dall'etica, ed esso limita contemporaneamente la libertà degli altri, cioè di coloro che soffrono rilevanti deficienze e vengono spinti verso condizioni di ulteriore miseria ed indigenza. Questo raffronto, universalmente noto, e il contrasto al quale si sono richiamati, nei documenti del loro magistero, i Pontefici del nostro secolo, più recentemente Giovanni XXIII come anche Paolo VI, rappresentano come il gigantesco sviluppo della parabola biblica del ricco epulone e del povero Lazzaro. L'ampiezza del fenomeno chiama in causa le strutture e i meccanismi finanziari, monetari, produttivi e commerciali, che, poggiando su diverse pressioni politiche, reggono l'economia mondiale: essi si rivelano quasi incapaci sia di riassorbire le ingiuste situazioni sociali, ereditate dal passato, sia di far fronte alle urgenti sfide ed alle esigenze etiche del presente. Sottoponendo l'uomo alle tensioni da lui stesso create, dilapidando ad un ritmo accelerato le risorse materiali ed energetiche, compromettendo l'ambiente geofisico, queste strutture fanno estendere incessantemente le zone di miseria e, con questa, l'angoscia, la frustrazione e l'amarezza. Ci troviamo qui dinanzi ad un grande dramma, che non può lasciare nessuno indifferente. Il soggetto che, da una parte, cerca di trarre il massimo profitto e quello che, dall'altra parte, paga il tributo dei danni e delle ingiurie, è sempre l'uomo. Il dramma viene ancor più esasperato dalla vicinanza con gli strati sociali privilegiati e con i paesi dell'opulenza, che accumulano i beni in grado eccessivo, e la cui ricchezza diventa, molto spesso per abuso, causa di diversi malesseri. Si aggiungano la febbre dell'inflazione e la piaga della disoccupazione: ecco altri sintomi di questo disordine morale, che si fa notare nella situazione mondiale e che richiede, pertanto, risoluzioni audaci e creative, conformi all'autentica dignità dell'uomo. Un tal compito non è impossibile da realizzare. Il principio di solidarietà, in senso largo, deve ispirare la ricerca efficace di istituzioni e di meccanismi appropriati: si tratti del settore degli scambi, dove bisogna lasciarsi guidare dalle leggi di una sana competizione, e si tratti anche del piano di una più ampia e più immediata ridistribuzione delle ricchezze e dei controlli su di esse, affinché i popoli che sono in via di sviluppo economico possano non soltanto appagare le loro esigenze essenziali, ma anche progredire gradualmente ed efficacemente. Su questa difficile strada, sulla strada dell'indispensabile trasformazione delle strutture della vita economica non sarà facile avanzare se non interverrà una vera conversione della mente, della volontà e del cuore . Il compito richiede l'impegno risoluto di uomini e di popoli liberi e solidali. Troppo spesso si confonde la libertà con l'istinto dell'interesse individuale o collettivo o, ancora, con l'istinto di lotta e di dominio, qualunque siano i colori ideologici con cui essi son dipinti. È ovvio che tali istinti esistono ed operano, ma non sarà possibile alcuna economia veramente umana, se essi non vengono assunti, orientati e dominati dalle forze più profonde, che si trovano nell'uomo e che decidono della vera cultura dei popoli. Proprio da queste sorgenti deve nascere lo sforzo, in cui si esprimerà la vera libertà dell'uomo, e che sarà capace di assicurarla anche in campo economico. Lo sviluppo economico, con tutto ciò che fa parte del suo adeguato modo di funzionare, deve essere costantemente programmato e realizzato all'interno di una prospettiva di sviluppo universale e solidale dei singoli uomini e dei popoli, come ricordava in modo convincente il mio Predecessore Paolo VI nella Populorum Progressio. Senza di ciò, la sola categoria del «progresso economico» diventa una categoria superiore che subordina l'insieme dell'esistenza umana alle sue esigenze parziali, soffoca l'uomo, disgrega le società e finisce per avvilupparsi nelle proprie tensioni e negli stessi suoi eccessi.
È possibile assumere questo dovere: lo testimoniano i fatti certi ed i risultati, che è difficile qui enumerare analiticamente. Una cosa, però, è certa: alla base di questo gigantesco campo bisogna stabilire, accettare ed approfondire il senso della responsabilità morale, che l'uomo deve far suo. Ancora e sempre: l'uomo. Per noi cristiani una tale responsabilità diventa particolarmente evidente, quando ricordiamo - e dobbiamo sempre ricordare - la scena del giudizio finale, secondo le parole di Cristo riportate nel Vangelo di Matteo. Questa scena escatologica dev'esser sempre «applicata» alla storia dell'uomo, dev'esser sempre fatta «metro» degli atti umani, come uno schema essenziale di un esame di coscienza per ciascuno e per tutti: «Ho avuto fame, e non mi avete dato da mangiare...; ero nudo, e non mi avete vestito...; ero in carcere, e non mi avete visitato». Queste parole acquistano una maggiore carica ammonitrice, se pensiamo che, invece del pane e dell'aiuto culturale ai nuovi stati e nazioni che si stanno destando alla vita indipendente, vengono offerti, talvolta in abbondanza, armi moderne e mezzi di distruzione, posti a servizio di conflitti armati e di guerre, che non sono tanto un'esigenza della difesa dei loro giusti diritti e della loro sovranità, quanto piuttosto una forma di sciovinismo, di imperialismo, di neocolonialismo di vario genere. Tutti sappiamo bene che le zone di miseria o di fame, che esistono sul nostro globo, avrebbero potuto essere «fertilizzate» in breve tempo, se i giganteschi investimenti per gli armamenti, che servono alla guerra e alla distruzione, fossero stati invece cambiati in investimenti per il nutrimento, che servono alla vita. Forse questa considerazione rimarrà parzialmente «astratta»; forse offrirà l'occasione all'una e all'altra «parte» per accusarsi reciprocamente, dimenticando ognuna le proprie colpe. Forse provocherà anche nuove accuse contro la Chiesa. Questa, però, non disponendo di altre armi che di quelle dello spirito, della parola e dell'amore, non può rinunciare ad annunziare «la parola ... in ogni occasione opportuna e non opportuna». Per questo, non cessa di pregare ciascuna delle due parti, e di chiedere a tutti nel nome di Dio e nel nome dell'uomo: Non uccidete! Non preparate agli uomini distruzioni e sterminio! Pensate ai vostri fratelli che soffrono fame e miseria! Rispettate la dignità e la libertà di ciascuno!
Sollicitudo rei socialisNel 1987, XX anniversario della Popolorum Progressio (1967), ripresa poi dalla Caritas in veritate, uscita nel 2009 (2 anni dopo il 40mo) per attendere quali sviluppi potessero esserci della crisi economica del 2009.Parla di preoccupazione ecologica. Nei termini di una preoccupazione morale, mirata a trattare nell’ottica della pace il tema dello sviluppo. Che non è un processo rettilineo, automatico e illimitato. Questa sarebbe una idea illuministica. Il motto di san Junipero Serra era “sempre avanti!”, ma non nel senso del progresso inarrestabile, le “magnifiche sorti e progressive” che non dovrebbero conoscere punto d’arresto. Il progresso illuministico con l’idealismo hegeliano si trasforma in un processo che annulla la tappa precedente in una sintesi superiore (i dvd sostituiscono i vhs, gli smartphone prendono il posto dei cellulari…). Una ricerca dice che 67.000 euro all’anno danno la felicità (in Occidente) mentre oltre si hanno solo preoccupazioni per la gestione, il risparmio, etc…
LETTERA ENCICLICA SOLLICITUDO REI SOCIALIS DEL SOMMO PONTEFICE GIOVANNI PAOLO II NEL XX ANNIVERSARIO DELLA POPULORUM PROGRESSIO - 30 Dicembre 1987
26. Tra i segnali positivi del presente occorre registrare ancora la maggiore consapevolezza dei limiti delle risorse disponibili, la necessità di rispettare l'integrità e i ritmi della natura e di tenerne conto nella programmazione dello sviluppo, invece di sacrificarlo a certe concezioni demagogiche dello stesso. È quella che oggi va sotto il nome di preoccupazione ecologica. È giusto riconoscere pure l'impegno di uomini di governo, politici, economisti, sindacalisti, personalità della scienza e funzionari internazionali – molti dei quali ispirati dalla fede religiosa – a risolvere generosamente, con non pochi sacrifici personali, i mali del mondo e ad adoperarsi con ogni mezzo, perché un sempre maggior numero di uomini e donne possa godere del beneficio della pace e di una qualità di vita degna di questo nome. A ciò contribuiscono in non piccola misura le grandi Organizzazioni internazionali ed alcune Organizzazioni regionali, i cui sforzi congiunti consentono interventi di maggiore efficacia. È stato anche per questi contributi che alcuni Paesi del Terzo Mondo, nonostante il peso di numerosi condizionamenti negativi, sono riusciti a raggiungere una certa autosufficienza alimentare, o un grado di industrializzazione che consente di sopravvivere degnamente e di garantire fonti di lavoro alla popolazione attiva. Pertanto, non tutto è negativo nel mondo
contemporaneo, e non potrebbe essere altrimenti, perché la Provvidenza del Padre celeste vigila con amore perfino sulle nostre preoccupazioni quotidiane (Mt 6,25); (Mt 10,23); (Lc 12,6); (Lc 22,1); anzi i valori positivi, che abbiamo rilevato, attestano una nuova preoccupazione morale soprattutto in ordine ai grandi problemi umani, quali sono lo sviluppo e la pace. Questa realtà mi spinge a portare la riflessione sulla vera natura dello sviluppo dei popoli, in linea con l'Enciclica di cui celebriamo l'anniversario, e come omaggio al suo insegnamento.
IV - L'autentico sviluppo umano 27. Lo sguardo che l'Enciclica ci invita a rivolgere al mondo contemporaneo ci fa costatare, anzitutto, che lo sviluppo non è un processo rettilineo, quasi automatico e di per sé illimitato, come se, a certe condizioni, il genere umano debba camminare spedito verso una specie di perfezione indefinita. Simile concezione, legata ad una nozione di «progresso» dalle connotazioni filosofiche di tipo illuministico, piuttosto che a quella di «sviluppo», adoperata in senso specificamente economico-sociale, sembra posta ora seriamente in dubbio, specie dopo la tragica esperienza delle due guerre mondiali, della distruzione pianificata e in parte attuata di intere popolazioni e dell'incombente pericolo atomico. Ad un ingenuo ottimismo meccanicistico è subentrata una fondata inquietudine per il destino dell'umanità.
Oggi si può avere di tutto, anche la frutta fuori stagione, ma questo super-sviluppo rende gli individui schiavi del possesso e del consumo senza sosta (consumismo). Questo causa molti rifiuti (la cultura dello scarto, di cui parla Papa Francesco) che si legano al nostro tema generale.
28. Al tempo stesso, però, è entrata in crisi la stessa concezione «economica» o «economicista», legata al vocabolo sviluppo. Effettivamente oggi si comprende meglio che la pura accumulazione di beni e di servizi, anche a favore della maggioranza, non basta a realizzare la felicità umana. Né, di conseguenza, la disponibilità dei molteplici benefici reali, apportati negli ultimi tempi dalla scienza e dalla tecnica, compresa l'informatica, comporta la liberazione da ogni forma di schiavitù. Al contrario, l'esperienza degli anni più recenti dimostra che, se tutta la massa delle risorse e delle potenzialità, messe a disposizione dell'uomo, non è retta da un intendimento morale e da un orientamento verso il vero bene del genere umano, si ritorce facilmente contro di lui per opprimerlo. Dovrebbe essere altamente istruttiva una sconcertante costatazione del più recente periodo: accanto alle miserie del sottosviluppo, che non possono essere tollerate, ci troviamo di fronte a una sorta di supersviluppo, egualmente inammissibile, perché, come il primo, è contrario al bene e alla felicità autentica. Tale supersviluppo, infatti, consistente nell'eccessiva disponibilità di ogni tipo di beni materiali in favore di alcune fasce sociali, rende facilmente gli uomini schiavi del «possesso» e del godimento immediato, senza altro orizzonte che la moltiplicazione o la continua sostituzione delle cose, che già si posseggono, con altre ancora più perfette. È la cosiddetta civiltà dei «consumi», o consumismo, che comporta tanti «scarti» e «rifiuti». Un oggetto posseduto, e già superato da un altro più perfetto, è messo da parte, senza tener conto del suo possibile valore permanente per sé o in favore di un altro essere umano più povero. Tutti noi tocchiamo con mano i tristi effetti di questa cieca sottomissione al puro consumo: prima di tutto, una forma di materialismo crasso, e al tempo stesso una radicale insoddisfazione, perché si comprende subito che – se non si è premuniti contro il dilagare dei messaggi pubblicitari e l'offerta incessante e tentatrice dei prodotti – quanto più si possiede tanto più si desidera mentre le aspirazioni più profonde restano insoddisfatte e forse anche soffocate. L'Enciclica di Papa Paolo VI segnalò la differenza, al giorno d'oggi così frequentemente accentuata, tra l'«avere» e l'«essere», in precedenza espressa con parole precise dal Concilio Vaticano II. L'«avere» oggetti e beni non perfeziona di per sé il soggetto umano, se non contribuisce alla maturazione e all'arricchimento del suo «essere», cioè alla realizzazione della vocazione umana in quanto tale. Certo, la differenza tra «essere» e «avere», il pericolo inerente a una mera moltiplicazione o sostituzione di cose possedute rispetto al valore dell'«essere» non deve trasformarsi necessariamente in un'antinomia. Una delle più grandi ingiustizie del mondo contemporaneo consiste proprio in questo: che sono relativamente pochi quelli che possiedono molto, e molti quelli che non possiedono quasi nulla. È l'ingiustizia della cattiva distribuzione dei beni e dei servizi destinati originariamente a tutti. Ecco allora il quadro: ci sono quelli – i pochi che possiedono molto – che non riescono veramente ad «essere», perché, per un capovolgimento della gerarchia dei valori, ne sono impediti dal culto dell'«avere»; e ci sono quelli – i molti che possiedono poco o nulla –, i quali non riescono a realizzare la loro vocazione umana fondamentale, essendo privi dei beni indispensabili. Il male non consiste nell'«avere» in quanto tale, ma nel possedere in modo irrispettoso della qualità e dell'ordinata gerarchia dei beni che si hanno. Qualità e gerarchia che scaturiscono dalla subordinazione
dei beni e dalla loro disponibilità all'«essere» dell'uomo ed alla sua vera vocazione. Con ciò resta dimostrato che, se lo sviluppo ha una necessaria dimensione economica, poiché deve fornire al maggior numero possibile degli abitanti del mondo la disponibilità di beni indispensabili per «essere», tuttavia non si esaurisce in tale dimensione. Se viene limitato a questa, esso si ritorce contro quelli che si vorrebbero favorire. Le caratteristiche di uno sviluppo pieno, «più umano», che-senza negare le esigenze economiche-sia in grado di mantenersi all'altezza dell'autentica vocazione dell'uomo e della donna, sono state descritte da Paolo VI. Le conseguenze negative di una tale consumismo sono le inique distribuzioni della ricchezza (moltissimi hanno pochissimo, pochissimi hanno moltissimo). Nasce il concetto di parametro interiore dello sviluppo, per cui si valuta lo sviluppo in relazione al rispetto della dignità umana.
29. Uno sviluppo non soltanto economico si misura e si orienta secondo questa realtà e vocazione dell'uomo visto nella sua globalità, ossia secondo un suo parametro interiore. Egli ha senza dubbio bisogno dei beni creati e dei prodotti dell'industria, arricchita di continuo dal progresso scientifico e tecnologico. E la disponibilità sempre nuova dei beni materiali, mentre viene incontro alle necessità, apre nuovi orizzonti. Il pericolo dell'abuso consumistico e l'apparizione delle necessità artificiali non debbono affatto impedire la stima e l'utilizzazione dei nuovi beni e risorse posti a nostra disposizione; in ciò dobbiamo, anzi, vedere un dono di Dio e una risposta alla vocazione dell'uomo, che si realizza pienamente in Cristo. Ma per conseguire il vero sviluppo e necessario non perder mai di vista detto parametro, che è nella natura specifica dell'uomo, creato da Dio a sua immagine e somiglianza (Gen 1,26). Natura corporale e spirituale, simboleggiata nel secondo racconto della creazione dai due elementi: la terra, con cui Dio plasma il fisico dell'uomo, e l'alito di vita, soffiato nelle sue narici (Gen 2,7). L'uomo così viene ad avere una certa affinità con le altre creature: è chiamato a utilizzarle a occuparsi di esse e sempre secondo la narrazione della Genesi (Gen 2,15) è posto nel giardino col compito di coltivarlo e custodirlo, al di sopra di tutti gli altri esseri collocati da Dio sotto il suo dominio (Gen 1,25). Ma nello stesso tempo l'uomo deve rimanere sottomesso alla volontà di Dio, che gli prescrive limiti nell'uso e nel dominio delle cose (Gen 2,16), così come gli promette l'immortalità (Gen 2,9; Sap 2,23). L'uomo, pertanto, essendo immagine di Dio, ha una vera affinità anche con lui. Sulla base di questo insegnamento, lo sviluppo non può consistere soltanto nell'uso, nel dominio e nel possesso indiscriminato delle cose create e dei prodotti dell'industria umana, ma piuttosto nel subordinare il possesso, il dominio e l'uso alla somiglianza divina dell'uomo e alla sua vocazione all'immortalità. Ecco la realtà trascendente dell'essere umano, la quale appare partecipata fin dall'origine ad una coppia di uomo e donna (Gen 1,27) ed è quindi fondamentalmente sociale.
30. Secondo la Sacra Scrittura, dunque, la nozione di sviluppo non è soltanto «laica» o «profana», ma appare anche, pur con una sua accentuazione socio-economica, come l'espressione moderna di un'essenziale dimensione della vocazione dell'uomo. L'uomo, infatti, non è stato creato, per così dire, immobile e statico. La prima raffigurazione, che di lui offre la Bibbia, lo presenta senz'altro come creatura e immagine, definita nella sua profonda realtà dall'origine e dall'affinità, che lo costituiscono. Ma tutto questo immette nell'essere umano, uomo e donna, il germe e l'esigenza di un compito originario da svolgere, sia ciascuno individualmente sia come coppia. Il compito è di «dominare» sulle altre creature, «coltivare il giardino», ed è da assolvere nel quadro dell'ubbidienza alla legge divina e, quindi, nel rispetto dell'immagine ricevuta, fondamento chiaro del potere di dominio, riconosciutogli in ordine al suo perfezionamento (Gen 1,26); (Gen 2,12); (Sap 9,2). Quando l'uomo disobbedisce a Dio e rifiuta di sottomettersi alla sua potestà, allora la natura gli si ribella e non lo riconosce più come «signore», perché egli ha appannato in sé l'immagine divina. L'appello al possesso e all'uso dei mezzi creati rimane sempre valido, ma dopo il peccato l'esercizio ne diviene arduo e carico di sofferenze (Gen 3,17). Infatti, il successivo capitolo della Genesi ci mostra la discendenza di Caino, la quale costruisce «una città», si dedica alla pastorizia, si dà alle arti (la musica) e alla tecnica (la metallurgia), mentre al tempo stesso si comincia «ad invocare il nome del Signore» (Gen 4,17). La storia del genere umano, delineata dalla Sacra Scrittura, anche dopo la caduta nel peccato è una storia di realizzazioni continue, che, sempre rimesse in questione e in pericolo dal peccato, si ripetono, si arricchiscono e si diffondono come risposta alla vocazione divina, assegnata sin dal principio all'uomo e alla donna (Gen 1,26) e impressa nell'immagine, da loro ricevuta. È logico concludere, almeno da parte di quanti credono nella Parola di Dio, che lo «sviluppo» di oggi deve essere visto come un momento della storia iniziata con la creazione e di continuo messa in pericolo a motivo
dell'infedeltà alla volontà del Creatore, soprattutto per la tentazione dell'idolatria; ma esso corrisponde fondamentalmente alle premesse iniziali. Chi volesse rinunciare al compito, difficile ma esaltante, di elevare la sorte di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, sotto il pretesto del peso della lotta e dello sforzo incessante di superamento, o addirittura per l'esperienza della sconfitta e del ritorno al punto di partenza, verrebbe meno alla volontà di Dio creatore. Sotto questo aspetto nell'Enciclica Laborem exercens ho fatto riferimento alla vocazione dell'uomo al lavoro, per sottolineare il concetto che e sempre lui il protagonista dello sviluppo. Anzi, lo stesso Signore Gesù, nella parabola dei talenti, mette in rilievo il severo trattamento riservato a chi osò nascondere il dono ricevuto: «Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso [...]. Toglietegli, dunque, il talento e datelo a chi ha dieci talenti» (Mt 25,26). A noi, che riceviamo i doni di Dio per farli fruttificare, tocca «seminare» e «raccogliere». Se non lo faremo, ci sarà tolto anche quello che abbiamo. L'approfondimento di queste severe parole potrà spingerci a impegnarci con più decisione nel dovere, oggi per tutti urgente di collaborare allo sviluppo pieno degli altri: «Sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini».
Quello umano è un dominio ministeriale poiché l’unico vero Padrone del Creato è Dio. Mentre l’uomo è semplicemente un amministratore delegato. Lo sviluppo è dunque un proseguimento della creazione.
Paolo VI istituisce la Giornata Mondiale della Pace da celebrarsi il 1 gennaio .
Nel 1990 il messaggio per la GMPace fa emergere il concetto di coscienza ecologica che nasce da un sentimento di precarietà e insicurezza che a sua volta genera egoismo collettivo. In questo contesto non pochi valori etici inerenti la pace sono direttamente collegati con la questione ambientale. Ad esempio, la gestione delle risorse idriche, il cui accaparramento porta a violenti scontri e conflitti in diversi Paesi del mondo.
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE GIOVANNI PAOLO II PER LA CELEBRAZIONE DELLA XXIII GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - 1° GENNAIO 1990 PACE CON DIO CREATORE. PACE CON TUTTO IL CREATO 1. Si avverte ai nostri giorni la crescente consapevolezza che la pace mondiale sia minacciata, oltre che dalla corsa agli armamenti, dai conflitti regionali e dalle ingiustizie tuttora esistenti nei popoli e tra le nazioni, anche dalla mancanza del dovuto rispetto per la natura, dal disordinato sfruttamento delle sue risorse e dal progressivo deterioramento della qualità della vita. Tale situazione genera un senso di precarietà e di insicurezza, che a sua volta favorisce forme di egoismo collettivo, di accaparramento e di prevaricazione. Di fronte al diffuso degrado ambientale l'umanità si rende ormai conto che non si può continuare ad usare i beni della terra come nel passato. L'opinione pubblica ed i responsabili politici ne sono preoccupati, mentre studiosi delle più diverse discipline ne esaminano le cause. Sta così formandosi una coscienza ecologica, che non deve essere mortificata, ma anzi favorita, in modo che si sviluppi e maturi trovando adeguata espressione in programmi ed iniziative concrete.
2. Non pochi valori etici, di fondamentale importanza per lo sviluppo di una società pacifica, hanno una diretta relazione con la questione ambientale. L'interdipendenza delle molte sfide, che il mondo odierno deve affrontare, conferma l'esigenza di soluzioni coordinate, basate su una coerente visione morale del mondo. Per il cristiano una tale visione poggia sulle convinzioni religiose attinte alla Rivelazione. Ecco perché, all'inizio di questo messaggio, desidero richiamare il racconto biblico della creazione, e mi auguro che coloro i quali non condividono le nostre convinzioni di fede possano egualmente trovarvi utili spunti per una comune linea di riflessione e di impegno.
Dio vide che era cosa buona, ma dell’uomo vide che era “molto buona”: basta questa citazione della Genesi per mostrare l’infondatezza della tesi per cui l’uomo sarebbe una minaccia per l’ambiente. Nella resurrezione di Cristo, Dio ha riconciliato a sé tutte le cose (anche il creato!). Non si tratta semplicemente di gestire meglio le risorse.La radice del problema è la crisi morale.
I - «E Dio vide che era cosa buona» 3. Nelle pagine della Genesi, nelle quali è consegnata la prima autorivelazione di Dio alla umanità (1-3), ricorrono come un ritornello le parole: «E Dio vide che era cosa buona». Ma quando, dopo aver creato il cielo e il mare, la terra e tutto ciò che essa contiene, Iddio crea l'uomo e la donna, l'espressione cambia notevolmente: «E Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona» (Gen 1, 31). All'uomo e alla donna Dio affidò tutto il resto della creazione, ed allora come leggiamo - poté riposare «da ogni suo lavoro» (Gen 2, 3). La chiamata di Adamo ed Eva a partecipare all'attuazione del piano di Dio sulla creazione stimolava quelle capacità e quei doni che distinguono la persona umana da ogni altra creatura e, nello stesso tempo, stabiliva un ordinato rapporto tra gli uomini e l'intero creato. Fatti ad immagine e somiglianza di Dio, Adamo ed Eva avrebbero dovuto esercitare il loro dominio sulla terra (cfr. Gen 1, 28) con saggezza e con amore. Essi, invece, con il loro peccato distrussero l'armonia esistente ponendosi deliberatamente contro il disegno del Creatore. Ciò portò non solo all'alienazione dell'uomo da se stesso, alla morte e al fratricidio, ma anche ad una certa ribellione della terra nei suoi confronti (cfr. Gen 3, 17-19; 4,12). Tutto il creato divenne soggetto alla caducità, e da allora attende, in modo misterioso, di esser liberato per entrare nella libertà gloriosa insieme con tutti i figli di Dio (cfr. Rm 8, 20-21). 4. I cristiani professano che nella morte e nella Risurrezione di Cristo si è compiuta l'opera di riconciliazione dell'umanità col Padre, a cui «piacque (…) riconciliare a sé tutte le cose, pacificando col sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli» (Col 1, 19-20). La creazione è stata così rinnovata (cfr. Ap 21, 5), e su di essa, prima sottoposta alla «schiavitù» della morte e della corruzione (cfr. Rm 8, 21), si è effusa una nuova vita, mentre noi «aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra, nei quali avrà stabile dimora la giustizia» (2 Pt 3, 13). Così il Padre «ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi: cioè il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose» (Ef 1, 9-10). 5. Queste considerazioni bibliche illuminano meglio il rapporto tra l'agire umano e l'integrità del creato. Quando si discosta dal disegno di Dio creatore, l'uomo provoca un disordine che inevitabilmente si ripercuote sul resto del creato. Se l'uomo non è in pace con Dio, la terra stessa non è in pace: «Per questo è in lutto il paese e chiunque vi abita langue, insieme con gli animali della terra e con gli uccelli del cielo; perfino i pesci del mare periranno» (Os 4, 3). L'esperienza di questa «sofferenza» della terra è comune anche a coloro che non condividono la nostra fede in Dio. Stanno, infatti, sotto gli occhi di tutti le crescenti devastazioni causate nel mondo della natura dal comportamento di uomini indifferenti alle esigenze recondite, eppure chiaramente avvertibili, dell'ordine e dell'armonia che lo reggono. Ci si chiede, pertanto, con ansia se si possa ancora porre rimedio ai danni provocati. È evidente che un'idonea soluzione non può consistere semplicemente in una migliore gestione, o in un uso meno irrazionale delle risorse della terra. Pur riconoscendo l'utilità pratica di simili misure, sembra necessario risalire alle origini e affrontare nel suo insieme la profonda crisi morale, di cui il degrado ambientale è uno degli aspetti preoccupanti.
II - La crisi ecologica: un problema morale 6. Alcuni elementi della presente crisi ecologica ne rivelano in modo evidente il carattere morale. Tra essi, in primo luogo, è da annoverare l'applicazione indiscriminata dei progressi scientifici e tecnologici. Molte recenti scoperte hanno arrecato innegabili benefici all'umanità; esse, anzi, manifestano quanto sia nobile la vocazione dell'uomo a partecipare responsabilmente all'azione creatrice di Dio nel mondo. Si è, però, constatato che la applicazione di talune scoperte nell'ambito industriale ed agricolo produce, a lungo termine, effetti negativi. Ciò ha messo crudamente in rilievo come ogni intervento in un'area dell'ecosistema non possa prescindere dal considerare le sue conseguenze in altre aree e, in generale, sul benessere delle future generazioni. Il graduale esaurimento dello strato di ozono e l'«effetto serra» hanno ormai raggiunto dimensioni critiche a causa della crescente diffusione delle industrie, delle grandi concentrazioni urbane e dei consumi
energetici. Scarichi industriali, gas prodotti dalla combustione di carburanti fossili, incontrollata deforestazione, uso di alcuni tipi di diserbanti, refrigeranti e propellenti: tutto ciò - com'è noto - nuoce all'atmosfera ed all'ambiente. Ne sono derivati molteplici cambiamenti meteorologici ed atmosferici, i cui effetti vanno dai danni alla salute alla possibile futura sommersione delle terre basse. Mentre in alcuni casi il danno forse è ormai irreversibile, in molti altri esso può ancora essere arrestato. È doveroso, pertanto, che l'intera comunità umana - individui, Stati ed organismi internazionali - assuma seriamente le proprie responsabilità. 7. Ma il segno più profondo e più grave delle implicazioni morali, insite nella questione ecologica, è costituito dalla mancanza di rispetto per la vita, quale si avverte in molti comportamenti inquinanti. Spesso le ragioni della produzione prevalgono sulla dignità del lavoratore e gli interessi economici vengono prima del bene delle singole persone, se non addirittura di quello di intere popolazioni. In questi casi, l'inquinamento o la distruzione riduttiva e innaturale, che talora configura un vero e proprio disprezzo dell'uomo. Parimenti, delicati equilibri ecologici vengono sconvolti per un'incontrollata distruzione delle specie animali e vegetali o per un incauto sfruttamento delle risorse; e tutto ciò - giova ricordare - anche se compiuto nel nome del progresso e del benessere, non torna, in effetti, a vantaggio dell'umanità. Infine, non si può non guardare con profonda inquietudine alle formidabili possibilità della ricerca biologica. Forse non è ancora in grado di misurare i turbamenti indotti in natura da una indiscriminata manipolazione genetica e dallo sviluppo sconsiderato di nuove specie di piante e forme di vita animale, per non parlare di inaccettabili interventi sulle origini della stessa vita umana. A nessuno sfugge come, in un settore così delicato, l'indifferenza o il rifiuto delle norme etiche fondamentali portino l'uomo alla soglia stessa dell'autodistruzione. È il rispetto per la vita e, in primo luogo, per la dignità della persona umana la fondamentale norma ispiratrice di un sano progresso economico, industriale e scientifico . È a tutti evidente la complessità del problema ecologico. Esistono, tuttavia, alcuni principi basilari che, nel rispetto della legittima autonomia e della specifica competenza di quanti sono in esso impegnati, possono indirizzare la ricerca verso idonee e durature soluzioni. Si tratta di principi essenziali per la costruzione di una società pacifica, la quale non può ignorare né il rispetto per la vita, né il senso dell'integrità del creato.
Il problema morale è una specificazione della questione antropologica. Si parla ad esempio di progressi scientifici e tecnologici che vengono applicati indiscriminatamente, ignorando l’ecosistema nel suo insieme; poi si parla di mancanza di rispetto per la vita, anzitutto del lavoratore. E quando la chiesa chiede la chiusura domenicale, ecco che la si accusa di essere retrograda e non attenta alle esigenze lavorative dei singoli. L’unico modo per incidere è il “voto col portafoglio”, cioè iniziare a boicottare ad esempio i supermercati con apertura domenicale. Ancora: le straordinarie possibilità della ricerca biologica giungono fino alla soglia dell’autodistruzione.
III - Alla ricerca di una soluzione 8. Teologia, filosofia e scienza concordano nella visione di un universo armonioso, cioè di un vero «cosmo», dotato di una sua integrità e di un suo interno e dinamico equilibrio. Questo ordine deve essere rispettato: l'umanità è chiamata ad esplorarlo, a scoprirlo con prudente cautela e a fame poi uso salvaguardando la sua integrità. D'altra parte, la terra è essenzialmente un'eredità comune, i cui frutti devono essere a beneficio di tutti. «Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e popoli», ha riaffermato il Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes, 69). Ciò ha dirette implicazioni per il nostro problema. È ingiusto che pochi privilegiati continuino ad accumulare beni superflui dilapidando le risorse disponibili, quando moltitudini di persone vivono in condizioni di miseria, al livello minimo di sostentamento. Ed è ora la stessa drammatica dimensione del dissesto ecologico ad insegnarci quanto la cupidigia e l'egoismo, individuali o collettivi, siano contrari all'ordine del creato, nel quale è inscritta anche la mutua interdipendenza. 9. I concetti di ordine nell'universo e di eredità comune mettono entrambi in rilievo che è necessario un sistema di gestione delle risorse della terra meglio coordinato a livello internazionale. Le dimensioni dei problemi ambientali superano, in molti casi, i confini dei singoli Stati: la loro soluzione, dunque, non può
essere trovata unicamente a livello nazionale. Recentemente sono stati registrati alcuni promettenti passi verso questa auspicata azione internazionale, ma gli strumenti e gli organismi esistenti sono ancora inadeguati allo sviluppo di un piano coordinato di intervento. Ostacoli politici, forme di nazionalismo esagerato ed interessi economici, per non ricordare che alcuni fattori, rallentano, o addirittura impediscono la cooperazione internazionale e l'adozione di efficaci iniziative a lungo termine. L'asserita necessità di un'azione concertata a livello internazionale non comporta certo una diminuzione della responsabilità dei singoli Stati. Questi, infatti, debbono non solo dare applicazione alle norme approvate insieme con le autorità di altri Stati, ma anche favorire, al loro interno, un adeguato assetto socio-economico, con particolare attenzione ai settori più vulnerabili della società. Spetta ad ogni Stato, nell'ambito del proprio territorio, il compito di prevenire il degrado dell'atmosfera e della biosfera, controllando attentamente, tra l'altro, gli effetti delle nuove scoperte tecnologiche o scientifiche, ed offrendo ai propri cittadini la garanzia di non essere esposti ad agenti inquinanti o a rifiuti tossici. Oggi si parla sempre più insistentemente del diritto ad un ambiente sicuro, come di un diritto che dovrà rientrare in un'aggiornata carta dei diritti dell'uomo.
La terra è un’eredità comune e non basta il livello nazionale per risolvere questi problemi. Anzi, nella carta dei diritti universali dell’uomo bisognerebbe inserire il diritto a un ambiente sano. Ad esempio si pensi al disastro di Chernobyl (1986).
IV - L'urgenza di una nuova solidarietà 10. La crisi ecologica pone in evidenza l'urgente necessità morale di una nuova solidarietà, specialmente nei rapporti tra i paesi in via di sviluppo e i paesi altamente industrializzati. Gli Stati debbono mostrarsi sempre più solidali e fra loro complementari nel promuovere lo sviluppo di un ambiente naturale e sociale pacifico e salubre. Ai paesi da poco industrializzati, per esempio, non si può chiedere di applicare alle proprie industrie nascenti certe norme ambientali restrittive, se gli Stati industrializzati non le applicano per primi al loro interno. Da parte loro, i paesi in via di industrializzazione non possono moralmente ripetere gli errori compiuti da altri nel passato, continuando a danneggiare l'ambiente con prodotti inquinanti, deforestazioni eccessive o sfruttamento illimitato di risorse inesauribili. In questo stesso contesto è urgente trovare una soluzione al problema del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti tossici. Nessun piano, nessuna organizzazione, tuttavia, sarà in grado di operare i cambiamenti intravisti, se i responsabili delle nazioni di tutto il mondo non saranno veramente convinti della assoluta necessità di questa nuova solidarietà, che la crisi ecologica richiede e che è essenziale per la pace . Tale esigenza offrirà opportune occasioni per consolidare le pacifiche relazioni tra gli Stati. 11. Occorre anche aggiungere che non si otterrà il giusto equilibrio ecologico, se non saranno affrontate direttamente le forme strutturali di povertà esistenti nel mondo. Ad esempio, la povertà rurale e la distribuzione della terra in molti paesi hanno portato ad un'agricoltura di mera sussistenza e all'impoverimento dei terreni. Quando la terra non produce più, molti contadini si trasferiscono in altre zone, incrementando spesso il processo di deforestazione incontrollata, o si stabiliscono in centri urbani già carenti di strutture e servizi. Inoltre, alcuni paesi fortemente indebitati stanno distruggendo il loro patrimonio naturale con la conseguenza di irrimediabile squilibri ecologici, pur di ottenere nuovi prodotti di esportazione. Di fronte a tali situazioni, tuttavia, mettere sotto accusa soltanto i poveri per gli effetti ambientali negativi da essi provocati, sarebbe un modo inaccettabile di valutare le responsabilità. Occorre, piuttosto, aiutare i poveri, a cui la terra e affidata come a tutti gli altri, a superare la loro povertà, e ciò richiede una coraggiosa riforma delle strutture e nuovi schemi nei rapporti tra gli Stati e i popoli. 12. Ma c'è un'altra pericolosa minaccia che ci sovrasta: la guerra. La scienza moderna dispone già, purtroppo, della capacità di modificare l'ambiente con intenti ostili, e tale manomissione potrebbe avere a lunga scadenza effetti imprevedibili e ancora più gravi. Nonostante che accordi internazionali proibiscano la guerra chimica, batteriologica e biologica, sta di fatto che nei laboratori continua la ricerca per lo sviluppo di nuove armi offensive, capaci di alterare gli equilibri naturali. Oggi qualsiasi forma di guerra su scala mondiale causerebbe incalcolabili danni ecologici. Ma anche le guerre locali o regionali, per limitate che siano, non solo distruggono le vite umane e le strutture della società, ma danneggiano la terra, rovinando i raccolti e la vegetazione e avvelenando i terreni e le acque. I sopravvissuti alla guerra si trovano nella necessità di iniziare una nuova vita in condizioni naturali molto difficili, che creano a loro volta situazioni di grave disagio sociale, con conseguenze negative anche di ordine ambientale.
13. La società odierna non troverà soluzione al problema ecologico, se non rivedrà seriamente il suo stile di vita. In molte parti del mondo essa è incline all'edonismo e al consumismo e resta indifferente ai danni che ne derivano. Come ho già osservato, la gravità della situazione ecologica rivela quanto sia profonda la crisi morale dell'uomo. Se manca il senso del valore della persona e della vita umana, ci si disinteressa degli altri e della terra. L'austerità, la temperanza, la autodisciplina e lo spirito di sacrificio devono informare la vita di ogni giorno affinché non si sia costretti da parte di tutti a subire le conseguenze negative della noncuranza dei pochi. C'è dunque l'urgente bisogno di educare alla responsabilità ecologica: responsabilità verso gli altri; responsabilità verso l'ambiente. E un'educazione che non può essere basata semplicemente sul sentimento o su un indefinito velleitarismo. Il suo fine non può essere né ideologico né politico, e la sua impostazione non può poggiare sul rifiuto del mondo moderno o sul vago desiderio di un ritorno al «paradiso perduto». La vera educazione alla responsabilità comporta un'autentica conversione nel modo di pensare e nel comportamento. Al riguardo, le Chiese e le altre istituzioni religiose, gli organismi governativi, anzi tutti i componenti della società hanno un preciso ruolo da svolgere. Prima educatrice, comunque, rimane la famiglia, nella quale il fanciullo impara a rispettare il prossimo e ad amare la natura. 14. Non si può trascurare, infine, il valore estetico del creato. Il contatto con la natura è di per sé profondamente rigeneratore come la contemplazione del suo splendore dona pace e serenità. La Bibbia parla spesso della bontà e della bellezza della creazione, chiamata a dar gloria a Dio. Forse più difficile, ma non meno intensa, può essere la contemplazione delle opere dell'ingegno umano. Anche le città possono avere una loro particolare bellezza, che deve spingere le persone a tutelare l'ambiente circostante. Una buona pianificazione urbana è un aspetto importante della protezione ambientale, e il rispetto per le caratteristiche morfologiche della terra e un indispensabile requisito per ogni insediamento ecologicamente corretto. Non va trascurata, insomma, la relazione che c'è tra un'adeguata educazione estetica e il mantenimento di un ambiente sano.
Serve una nuova solidarietà. Eppure si accusa l’Occidente di aver disboscato ed estratto indiscriminatamente nel momento dello sviluppo. Ma già GPII invoca una sorta di compromesso: è vero che gli Europei hanno sfruttato l’ambiente, ma nell’Ottocento non c’era la coscienza né la consapevolezza odierna, per cui non si possono ripetere gli errori del passato. Questo non toglie che i primi che debbano mettersi a posto siano proprio i Paesi più sviluppati.Si tratta di rispettare l’ecologia badando però alle esigenze dei paesi poveri. Così pure occorre ridurre l’impiego dei prodotti chimici e inquinanti… Il 2 giugno 1990 un certo Saddam Hussein invade il Kuwait, cui rispondono gli USA a gennaio 1991, scatenando la guerra del Golfo e ritirandosi poco dopo bruciando tutti i pozzi di petrolio, causando un grande inquinamento.Cosa può fare ognuno di noi? Rivedere il proprio stile di vita, improntandolo alla sobrietà. Occorre educarsi alla responsabilità ecologica. Senza ridursi all’indottrinamento verde, bensì con una autentica conversione del pensiero e del comportamento. Individuando nella famiglia la prima fonte di una tale educazione, a partire dal non sprecare il cibo a tavola…Conclude con una indicazione sul rapporto tra educazione estetica e ambiente sano.
Cfr. “Broken windows” – il metodo migliore per bloccare la criminalità è riparare le finestre. Perché se vedo un vetro rotto, mi viene voglia di entrarci e far danni… Ma se io riparo il vetro, nessuno oserà romperlo e non arriverò al quartiere malfamato che farebbe la rovina del posto. Il sindaco di NY, R. Giuliani, farà sua questa tesi con la “tolleranza zero”: non permettere il degrado urbano e sociale abbassa la criminalità. Similmente, Bregantini (già vescovo di Locri), afferma che pulire le spiagge è un aiuto per sconfiggere la mafia. Unum, Verum et Bonum convertuntur V - La questione ecologica: una responsabilità di tutti 15. Oggi la questione ecologica ha assunto tali dimensioni da coinvolgere la responsabilità di tutti. I vari aspetti di essa, che ho illustrato, indicano la necessità di sforzi concordati, al fine di stabilire i rispettivi doveri ed impegni dei singoli, dei popoli, degli Stati e della comunità internazionale. Ciò non solo va di pari passo con i tentativi di costruire la vera pace, ma oggettivamente li conferma e li rafforza. Inserendo la questione ecologica nel più vasto contesto della causa della pace nella società umana , ci si rende meglio
conto di quanto sia importante prestare attenzione a ciò che la terra e l'atmosfera ci rivelano: nell'universo esiste un ordine che deve essere rispettato; la persona umana, dotata della possibilità di libera scelta, ha una grave responsabilità per la conservazione di questo ordine, anche in vista del benessere delle generazioni future. La crisi ecologica - ripeto ancora - è un problema morale. Anche gli uomini e le donne che non hanno particolari convinzioni religiose, per il senso delle proprie responsabilità nei confronti del bene comune, riconoscono il loro dovere di contribuire al risanamento dell'ambiente. A maggior ragione, coloro che credono in Dio creatore e, quindi, sono convinti che nel mondo esiste un ordine ben definito e finalizzato devono sentirsi chiamati ad occuparsi del problema. I cristiani, in particolare, avvertono che i loro compiti all'interno del creato, i loro doveri nei confronti della natura e del Creatore sono parte della loro fede. Essi, pertanto, sono consapevoli del vasto campo di cooperazione ecumenica ed interreligiosa che si apre dinanzi a loro. 16. A conclusione di questo messaggio, desidero rivolgermi direttamente ai miei fratelli e alle mie sorelle della Chiesa cattolica per ricordar loro l'importante obbligo di prendersi cura di tutto il creato. L'impegno del credente per un ambiente sano nasce direttamente dalla sua fede in Dio creatore, dalla valutazione degli effetti del peccato originale e dei peccati personali e dalla certezza di essere stato redento da Cristo. Il rispetto per la vita e per la dignità della persona umana include anche il rispetto e la cura del creato, che è chiamato ad unirsi all'uomo per glorificare Dio. San Francesco d'Assisi, che nel 1979 ho proclamato celeste patrono dei cultori dell'ecologia , offre ai cristiani l'esempio dell'autentico e pieno rispetto per l'integrità del creato. Amico dei poveri, amato dalle creature di Dio, egli invitò tutti - animali, piante, forze naturali, anche fratello sole e sorella luna - ad onorare e lodare il Signore. Dal Poverello di Assisi ci viene la testimonianza che, essendo in pace con Dio, possiamo meglio dedicarci a costruire la pace con tutto il creato, la quale è inseparabile dalla pace tra i popoli. Auspico che la sua ispirazione ci aiuti a conservare sempre vivo il senso della «fraternità» con tutte le cose create buone e belle da Dio onnipotente, e ci ricordi il grave dovere di rispettarle e custodirle con cura, nel quadro della più vasta e più alta fraternità umana. Dal Vaticano, 8 dicembre dell'anno 1989.
Nel creato esiste dunque un ordine e la persona umana, essendo libera, ha la responsabilità di conservare tale ordine.
CENTESIMUS ANNUS, di GPII (1991)
La CA non tratta di ecologia, ma illustra la radice del problema ecologico nella mancanza di una corretta visione antropologica. Infatti l’uomo pensa di poter disporre della terra arbitrariamente, potendo decidere cioè della finalità del creato. Mentre il mondo è stato creato da Dio con una particolare intenzione, con un fine che l’uomo non può stravolgere. Si tratta di scoprire il senso, non in modo passivo, ma ricercandolo attivamente. Quindi: né arbitrario, né passivo.Si tratta di sviluppare in modo attivo il senso scoperto, senza tradirlo. Si tratta di collaborare con Dio, non di mettersi al suo posto.
Giovanni Paolo II Centesimus annus nel centenario della Rerum novarum (1° maggio 1991)
37. Del pari preoccupante, accanto al problema del consumismo e con esso strettamente connessa, è la questione ecologica. L'uomo, preso dal desiderio di avere e di godere, più che di essere e di crescere, consuma in maniera eccessiva e disordinata le risorse della terra e la sua stessa vita. Alla radice dell'insensata distruzione dell'ambiente naturale c'è un errore antropologico, purtroppo diffuso nel nostro tempo. L'uomo, che scopre la sua capacità di trasformare e, in un certo senso, di creare il mondo col proprio lavoro, dimentica che questo si svolge sempre sulla base della prima originaria donazione delle cose da parte di Dio. Egli pensa di poter disporre arbitrariamente della terra, assoggettandola senza riserve alla sua volontà, come se essa non avesse una propria forma ed una destinazione anteriore datale da Dio, che
l'uomo può, sì, sviluppare, ma non deve tradire. Invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell'opera della creazione, l'uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione della natura, piuttosto tiranneggiata che governata da lui. Si avverte in ciò, prima di tutto, una povertà o meschinità dello sguardo dell'uomo, animato dal desiderio di possedere le cose anziché di riferirle alla verità, e privo di quell'atteggiamento disinteressato, gratuito, estetico che nasce dallo stupore per l'essere e per la bellezza, il quale fa leggere nelle cose visibili il messaggio del Dio invisibile che le ha create. Al riguardo, l'umanità di oggi deve essere conscia dei suoi doveri e compiti verso le generazioni future.
Si tratta di costruire anche una ecologia umana, come dice papa Francesco nella LS: Dio ha donato all’uomo il cosmo, ha donato all’uomo se stesso (ci troviamo a vivere). Quello della vita è un dono che come tale non è meritato, ma totalmente gratuito. Questa struttura di dono va rispettata, altrimenti si tradisce la natura dell’uomo e delle cose.In questo contesto si inserisce il riferimento alle strutture di peccato (RP, GPII) che di per sé non sono peccato ma condizione di esso. L’ecologia sociale cerca di creare delle strutture virtuose. La prima delle quali è la famiglia.
38. Oltre all’irrazionale distruzione dell'ambiente naturale è qui da ricordare quella, ancor più grave, dell'ambiente umano, a cui peraltro si è lontani dal prestare la necessaria attenzione. Mentre ci si preoccupa giustamente, anche se molto meno del necessario, di preservare gli «habitat» naturali delle diverse specie animali minacciate di estinzione, perché ci si rende conto che ciascuna di esse apporta un particolare contributo all'equilibrio generale della terra, ci si impegna troppo poco per salvaguardare le condizioni morali di un'autentica «ecologia umana». Non solo la terra è stata data da Dio all'uomo, che deve usarla rispettando l'intenzione originaria di bene, secondo la quale gli è stata donata; ma l'uomo è donato a se stesso da Dio e deve, perciò, rispettare la struttura naturale e morale, di cui è stato dotato. Sono da menzionare, in questo contesto, i gravi problemi della moderna urbanizzazione, la necessità di un urbanesimo preoccupato della vita delle persone, come anche la debita attenzione ad un'«ecologia sociale» del lavoro. L'uomo riceve da Dio la sua essenziale dignità e con essa la capacità di trascendere ogni ordinamento della società verso la verità ed il bene. Egli, tuttavia, è anche condizionato dalla struttura sociale in cui vive, dall'educazione ricevuta e dall'ambiente. Questi elementi possono facilitare oppure ostacolare il suo vivere secondo verità. Le decisioni, grazie alle quali si costituisce un ambiente umano, possono creare specifiche strutture di peccato, impedendo la piena realizzazione di coloro che da esse sono variamente oppressi. Demolire tali strutture e sostituirle con più autentiche forme di convivenza è un compito che esige coraggio e pazienza.
La prima struttura sociale è la famiglia. Altrimenti si ridurrebbe la vita a un insieme di sensazioni da sperimentare. “L’uomo è il suo proprio esperimento” (Jongen, giovane filosofo tedesco).Non è la collezione di esperienze che fa crescere, ma l’inserimento del proprio vissuto personale in un contesto esperienziale. La famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio tra l’uomo e la donna e aperta alla vita (GPII). Garelli (sociologo della religione) parla della tendenza a considerare le scelte di vita – vocazioni professionale, religiosa, matrimoniale – come reversibili e non definitive. Con il risultato che si procrastina una scelta per finire con il non compierla più. A ciò si lega l’innalzamento dell’età di quanti si sposano oggigiorno (non solo per scelta di sperimentazione esistenziale, ma anche per motivi economici, sociali…).La famiglia è santuario della vita e baluardo della cultura della vita (tema ripreso nella Evangelium Vitae del 1995) contro quella cultura della morte che sempre più si diffonde.Non si tratta di un problema solo economico, ma etico-culturale: si ignora la dimensione religiosa e si riduce la società a luogo di produzione di beni e servizi. Ma questo significa confondere il ruolo della libertà umana, di cui quella economica è solo una parte (come Marx riduce l’uomo alla dimensione economica e Freud a quella sessuale). Anche perché ci sono beni collettivi che non possono esser tutelati dal mercato ma devono esser protetti dallo stato.
39. La prima e fondamentale struttura a favore dell'«ecologia umana» è la famiglia, in seno alla quale l'uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità ed al bene, apprende che cosa vuol dire amare ed essere amati e, quindi, che cosa vuol dire in concreto essere una persona. Si intende qui la famiglia fondata sul matrimonio, in cui il dono reciproco di sé da parte dell'uomo e della donna crea un ambiente di vita nel quale il bambino può nascere e sviluppare le sue potenzialità, diventare consapevole della sua dignità e prepararsi ad affrontare il suo unico ed irripetibile destino. Spesso accade, invece, che l'uomo è scoraggiato dal realizzare le condizioni autentiche della riproduzione umana, ed è indotto a considerare se stesso e la propria vita come un insieme di sensazioni da sperimentare anziché come un'opera da compiere. Di qui nasce una mancanza di libertà che fa rinunciare all'impegno di legarsi stabilmente con un'altra persona e di generare dei figli, oppure induce a considerare costoro come una delle tante «cose» che è possibile avere o non avere, secondo i propri gusti, e che entrano in concorrenza con altre possibilità. Occorre tornare a considerare la famiglia come il santuario della vita. Essa, infatti, è sacra: è il luogo in cui la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici attacchi a cui è esposta, e può svilupparsi secondo le esigenze di un'autentica crescita umana. Contro la cosiddetta cultura della morte, la famiglia costituisce la sede della cultura della vita. L'ingegno dell'uomo sembra orientarsi, in questo campo, più a limitare, sopprimere o annullare le fonti della vita ricorrendo perfino all'aborto, purtroppo così diffuso nel mondo, che a difendere e ad aprire le possibilità della vita stessa. Nell'Enciclica Sollicitudo rei socialis sono state denunciate le campagne sistematiche contro la natalità, che, in base ad una concezione distorta del problema demografico e in un clima di «assoluta mancanza di rispetto per la libertà di decisione delle persone interessate», le sottopongono non di rado «a intolleranti pressioni ... per piegarle a questa forma nuova di oppressione». Si tratta di politiche che con nuove tecniche estendono il loro raggio di azione fino ad arrivare, come in una «guerra chimica», ad avvelenare la vita di milioni di esseri umani indifesi. Queste critiche sono rivolte non tanto contro un sistema economico, quanto contro un sistema etico-culturale. L'economia, infatti, è solo un aspetto ed una dimensione della complessa attività umana. Se essa è assolutizzata, se la produzione ed il consumo delle merci finiscono con l'occupare il centro della vita sociale e diventano l'unico valore della società, non subordinato ad alcun altro, la causa va ricercata non solo e non tanto nel sistema economico stesso, quanto nel fatto che l'intero sistema socio-culturale, ignorando la dimensione etica e religiosa, si è indebolito e ormai si limita solo alla produzione dei beni e dei servizi. Tutto ciò si può riassumere affermando ancora una volta che la libertà economica è soltanto un elemento della libertà umana. Quando quella si rende autonoma, quando cioè l'uomo è visto più come un produttore o un consumatore di beni che come un soggetto che produce e consuma per vivere, allora perde la sua necessaria relazione con la persona umana e finisce con l'alienarla ed opprimerla.
L’economia di mercato non può tutelare i beni collettivi. Nel mercato si incontrano domanda e offerta e questo in sé non è male. Il problema è se la logica del mercato giunge a permeare tutti gli ambiti della vita. Il che porta a una ideologia e a una conseguente idolatria. Ecco dove si annida l’errore antropologico di cui parlava GPII: tutta questa premessa spiega perché si inquina e rovina l’ambiente, perché si fraintende il senso del mondo e il rapporto tra uomo e ambiente.
40. È compito dello Stato provvedere alla difesa e alla tutela di quei beni collettivi, come l'ambiente naturale e l'ambiente umano, la cui salvaguardia non può essere assicurata dai semplici meccanismi di mercato. Come ai tempi del vecchio capitalismo lo Stato aveva il dovere di difendere i diritti fondamentali del lavoro, così ora col nuovo capitalismo esso e l'intera società hanno il dovere di difendere i beni collettivi che, tra l'altro, costituiscono la cornice al cui interno soltanto è possibile per ciascuno conseguire legittimamente i suoi fini individuali. Si ritrova qui un nuovo limite del mercato: ci sono bisogni collettivi e qualitativi che non possono essere soddisfatti mediante i suoi meccanismi ; ci sono esigenze umane importanti che sfuggono alla sua logica; ci sono dei beni che, in base alla loro natura, non si possono e non si debbono vendere e comprare. Certo, i meccanismi di mercato offrono sicuri vantaggi: aiutano, tra l'altro, ad utilizzare meglio le risorse; favoriscono lo scambio dei prodotti e, soprattutto, pongono al centro la volontà e le preferenze della persona che nel contratto si incontrano con quelle di un'altra persona. Tuttavia, essi comportano il rischio di un'«idolatria» del mercato, che ignora l'esistenza dei beni che, per loro natura, non sono né possono essere semplici merci.
Beato GIOVANNI PAOLO II - UDIENZA GENERALE Mercoledì, 17 gennaio 2001 Nel periodo in cui commentava i Salmi, giunse al salmo 148: 1 Alleluia. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli. / 2 Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, lodatelo, voi tutte, sue schiere. / 3 Lodatelo, sole e luna, lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. / 4 Lodatelo, cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli. / 5 Lodino tutti il nome del Signore, perché egli disse e furono creati.
GPII parla di un santuario del creato, con i diversi elementi del tempio corrispondenti alle varie realtà create. In questo tempio cosmico che ha per navata il mondo e per abside i cieli, il compito del mondo è governare il create per farne brillare tutte le potenzialità.
L’impegno per scongiurare la catastrofe ecologica (Lettura: Sal 148, 1-5).
1. Nell’inno di lode, or ora proclamato (Sal 148, 1-5), il Salmista convoca, chiamandole per nome, tutte le creature. In alto si affacciano angeli, sole, luna, stelle e cieli; sulla terra si muovono ventidue creature, tante quante sono le lettere dell’alfabeto ebraico, a indicare pienezza e totalità. Il fedele è come "il pastore dell’essere", cioè colui che conduce a Dio tutti gli esseri, invitandoli a intonare un "alleluia" di lode. Il Salmo ci introduce come in un tempio cosmico che ha per abside i cieli e per navate le regioni del mondo e al cui interno canta a Dio il coro delle creature. Questa visione potrebbe essere, per un verso, la rappresentazione di un paradiso perduto e, per un altro, quella del paradiso promesso. Non per nulla l’orizzonte di un universo paradisiaco, che è posto dalla Genesi (c. 2) alle origini stesse del mondo, da Isaia (c. 11) e dall’Apocalisse (cc. 21-22) è collocato alla fine della storia. Si vede così che l’armonia dell’uomo con il suo simile, con il creato e con Dio è il progetto perseguito dal Creatore. Tale progetto è stato ed è continuamente sconvolto dal peccato umano che si ispira a un piano alternativo, raffigurato nel libro stesso della Genesi (cc. 3-11), in cui è descritto l’affermarsi di una progressiva tensione conflittuale con Dio, con il proprio simile e persino con la natura. 2. Il contrasto tra i due progetti emerge nitidamente nella vocazione a cui l’umanità, secondo la Bibbia, è chiamata e nelle conseguenze provocate dalla sua infedeltà a quella chiamata. La creatura umana riceve una missione di governo sul creato per farne brillare tutte le potenzialità . È una delega attribuita dal Re divino alle origini stesse della creazione quando l’uomo e la donna, che sono "immagine di Dio" (Gn 1,27), ricevono l’ordine di essere fecondi, moltiplicarsi, riempire la terra, soggiogarla e dominare sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra (cfr Gn 1,28). San Gregorio di Nissa, uno dei tre grandi Padri cappadoci, commentava: "Dio ha fatto l’uomo in modo tale che potesse svolgere la sua funzione di re della terra… L’uomo è stato creato a immagine di colui che governa l’universo. Tutto dimostra che fin dal principio la sua natura è contrassegnata dalla regalità… Egli è l’immagine viva che partecipa nella sua dignità alla perfezione del divino modello" (De hominis opificio, 4).
La signoria umana è ministeriale, di servizio, non potendo stravolgere l’ordine delle cose ma richiedendo di rispettare la natura del creato secondo il disegno del creatore. Il mondo animale è al servizio del mondo umano. Questa gerarchia non può esser modificata. Ma al tempo stesso bisogna ricordare che l’uomo è amministratore del creato, non padrone assoluto. Guai a parificare tutto, perché tutto si svilisce. Così ad esempio gli animali non dovrebbero entrare in chiesa: possono dar gloria a Dio nel tempio cosmico ma non nel tempio liturgico.
3. Tuttavia la signoria dell’uomo non è "assoluta, ma ministeriale; è riflesso reale della signoria unica e infinita di Dio. Per questo l’uomo deve viverla con sapienza e amore, partecipando alla sapienza e all’amore incommensurabili di Dio" (Evangelium vitae, 52). Nel linguaggio biblico "dare il nome" alle creature (cfr Gn 2,19-20) è il segno di questa missione di conoscenza e di trasformazione della realtà creata. È la missione non di un padrone assoluto e insindacabile, ma di un ministro del Regno di Dio, chiamato a continuare l’opera del Creatore, un’opera di vita e di pace. Il suo compito, definito nel Libro della Sapienza, è quello di governare "il mondo con santità e giustizia" (Sap 9,3).
Purtroppo, se lo sguardo percorre le regioni del nostro pianeta, ci si accorge subito che l’umanità ha deluso l’attesa divina. Soprattutto nel nostro tempo, l’uomo ha devastato senza esitazioni pianure e valli boscose, inquinato le acque, deformato l’habitat della terra, reso irrespirabile l’aria, sconvolto i sistemi idro-geologici e atmosferici, desertificato spazi verdeggianti, compiuto forme di industrializzazione selvaggia, umiliando - per usare un’immagine di Dante Alighieri (Paradiso, XXII, 151) - quell’"aiuola" che è la terra, nostra dimora.
Occorre – dice GPII – una conversione ecologica, ritornando alla consapevolezza che l’uomo non è despota ma servitore del creato.
4. Occorre, perciò, stimolare e sostenere la ‘conversione ecologica’, che in questi ultimi decenni ha reso l’umanità più sensibile nei confronti della catastrofe verso la quale si stava incamminando. L’uomo non più ‘ministro’ del Creatore. Ma autonomo despota, sta comprendendo di doversi finalmente arrestare davanti al baratro. "È, allora, da salutare con favore l’accresciuta attenzione alla qualità della vita e all’ecologia, che si registra soprattutto nelle società a sviluppo avanzato, nelle quali le attese delle persone non sono più concentrate tanto sui problemi della sopravvivenza quanto piuttosto sulla ricerca di un miglioramento globale delle condizioni di vita" (Evangelium vitae, 27). Non è in gioco, quindi, solo un’ecologia ‘fisica’, attenta a tutelare l’habitat dei vari esseri viventi, ma anche un’ecologia ‘umana’ che renda più dignitosa l’esistenza delle creature, proteggendone il bene radicale della vita in tutte le sue manifestazioni e preparando alle future generazioni un ambiente che si avvicini di più al progetto del Creatore.
Il Giubileo biblico consisteva nel riposo dei terreni, nel condono delle colpe e dei debiti… Qualcuno dice che ha solo valenza simbolica, altri dicono che qualcosa di concreto è stato realizzato… Dietro a questa realtà sta il principio di destinazione universale dei beni della terra e l’ipoteca sociale della proprietà privata che è un diritto naturale secondario. Non è dato cioè dallo stato, bensì inerente la persona; inoltre è secondario, cioè non è primario/assoluto. Per cui chi ruba perché spinto dalla fame sarebbe scagionato per aver agito “in stato di necessità” (che ovviamente va verificato dal giudice).La prospettiva del dono che crea fraternità (sviluppato da BXVI in Caritas in veritate) è una strategia argomentativa che permette di allargare il discorso ben oltre il target confessionale, poiché ci si rivolge anche a chi non crede, richiamando l’evidenza che può esser sotto gli occhi di tutti: la vita è un dono, il creato è un dono, quindi posso solo amministrarlo e non disporne!
5. In questa ritrovata armonia con la natura e con se stessi gli uomini e le donne ritornano a passeggiare nel giardino della creazione, cercando di far sì che i beni della terra siano disponibili a tutti e non solo ad alcuni privilegiati, proprio come suggeriva il Giubileo biblico (cfr Lv 25,8-13.23). In mezzo a quelle meraviglie scopriamo la voce del Creatore, trasmessa dal cielo e dalla terra, dal giorno e dalla notte: un linguaggio "senza parole di cui si oda il suono", capace di varcare tutte le frontiere (cfr Sal 19[18], 2-5). Il libro della Sapienza, riecheggiato da Paolo, celebra questa presenza di Dio nell’universo ricordando che "dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si contempla il Creatore" (Sap 13,5; cfr Rm 1,20). È ciò che canta anche la tradizione giudaica dei Chassidim: "Dovunque io vada, Tu! Dovunque io sosti, Tu…, dovunque mi giro, dovunque ammiro, solo Tu, ancora Tu, sempre Tu" (M. Buber, I racconti dei Chassidim, Milano 1979, p. 256).
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE COMPENDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA (2 aprile 2004)
CAPITOLO DECIMO - SALVAGUARDARE L'AMBIENTE
È una sintesi consapevole e articolata della dottrina sociale della Chiesa. Quindi c’è una scelta di temi, struttura e contenuti. Ha poi il limite di essere datato (2004) e quindi non comprende gli interventi magisteriali più recenti.
I. ASPETTI BIBLICI
Il primo dato di fatto è che il mondo è creato da Dio ed è cosa buona (vs gnosi), mentre il suo vertice – l’uomo – è addirittura cosa “molto buona” (pro superiorità dell’uomo sugli animali).
451 L'esperienza viva della presenza divina nella storia è il fondamento della fede del popolo di Dio: «Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente» (Dt 6,21). La riflessione sulla storia permette di riassumere il passato e di scoprire l'opera di Dio fin nelle proprie radici: «Mio padre era un Arameo errante» (Dt 26,5); un Dio che può dire al Suo popolo: «Io presi il padre vostro Abramo da oltre il fiume» (Gs 24,3). È una riflessione che permette di volgersi con fiducia al futuro, grazie alla promessa e all'alleanza che Dio rinnova continuamente. La fede d'Israele vive nel tempo e nello spazio di questo mondo, percepito non come un ambiente ostile o un male da cui liberarsi, ma piuttosto come il dono stesso di Dio, il luogo e il progetto che Egli affida alla responsabile guida e operosità dell'uomo. La natura, opera dell'azione creatrice divina, non è una pericolosa concorrente. Dio, che ha fatto tutte le cose, di ognuna di esse «vide che era cosa buona» (Gen 1,4.10.12. 18.21.25). Al vertice della Sua creazione, come «cosa molto buona» (Gen 1,31), il Creatore pone l'uomo. Solo l'uomo e la donna, tra tutte le creature, sono stati voluti da Dio «a sua immagine» (Gen 1,27): a loro il Signore affida la responsabilità di tutto il creato, il compito di tutelarne l'armonia e lo sviluppo (cfr. Gen 1,26-30). Lo speciale legame con Dio spiega la privilegiata posizione della coppia umana nell'ordine della creazione.
L’uomo nell’ambiente vs l’uomo & l’ambiente: senza ambiente non c’è l’uomo e l’uomo ritrova se stesso nell’ambiente in cui è inserito. Un esempio è il temperamento del nord e del sud, influenzato – non solo nei luoghi comuni – dall’ambiente in cui si vive. L’uomo è quindi plasmato nella sua identità dalla relazione col mondo. Cosa ancor più evidente nei casi di patologie psichiche e psichiatriche influenzate dall’ambiente (claustrofobia, agorafobia…). La relazione col mondo non è dunque accidentale ma essenziale per l’uomo. Se una società distrugge l’ambiente, distrugge se stessa (tradisce la sua natura e vocazione). Se dall’antropologia teologica passiamo alla teologia, possiamo parlare del peccato: che rompe la comunione con Dio e col creato. Ecco perché dunque è peccato anche se nessun altro mi vede o mi scopre! La salvezza è il ristabilirsi di questa armonia, con una “nuova creazione”.
452 La relazione dell'uomo con il mondo è un elemento costitutivo dell'identità umana . Si tratta di una relazione che nasce come frutto del rapporto, ancora più profondo, dell'uomo con Dio. Il Signore ha voluto la persona umana come Sua interlocutrice: solo nel dialogo con Dio la creatura umana trova la propria verità, dalla quale trae ispirazione e norme per progettare il futuro del mondo, un giardino che Dio le ha dato affinché sia coltivato e custodito (cfr. Gen 2,15). Neppure il peccato elimina tale compito, pur gravando di dolore e di sofferenza la nobiltà del lavoro (cfr. Gen 3,1719). La creazione è sempre oggetto della lode nella preghiera di Israele: «Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! Tutto hai fatto con saggezza» (Sal 104,24). La salvezza è compresa come una nuova creazione, che ristabilisce quell'armonia e quella potenzialità di crescita che il peccato ha compromesso: «Io creo nuovi cieli e nuova terra» (Is 65,17) — dice il Signore — «allora il deserto diventerà un giardino... e la giustizia regnerà nel giardino... Il mio popolo abiterà in una dimora di pace» (Is 32,15-18).
453 La salvezza definitiva, che Dio offre a tutta l'umanità mediante il Suo stesso Figlio, non si attua fuori di questo mondo. Pur ferito dal peccato, esso è destinato a conoscere una radicale purificazione (cfr. 2 Pt 3,10) dalla quale uscirà rinnovato (cfr. Is 65,17; 66,22; Ap 21,1), diventando finalmente il luogo nel quale «avrà stabile dimora la giustizia» (2 Pt 3,13). Nel Suo ministero pubblico Gesù valorizza gli elementi naturali. Della natura Egli è non solo sapiente interprete nelle immagini che ama offrirne e nelle parabole, ma anche dominatore (cfr. l'episodio della tempesta sedata in Mt 14,22-33; Mc 6,45-52; Lc 8,22-25; Gv 6,16-21): il Signore la pone al servizio del Suo disegno redentore. Egli chiede ai Suoi discepoli di guardare alle cose, alle stagioni e agli uomini con la fiducia dei figli che sanno di non poter essere abbandonati da un Padre provvidente (cfr. Lc 11,11-13). Lungi dal farsi schiavo delle cose, il discepolo di Cristo deve sapersene servire per creare condivisione e fraternità (cfr. Lc 16,9-13).
La relazione uomo-ambiente non comporta che la Chiesa sia contro il progresso, anzi. I migliori scienziati del medioevo e nell’epoca moderna sono religiosi. I risultati della scienza sono positivi, ma non sono neutri, poiché le scoperte scientifiche vanno rettamente applicate. Così posso usare le radiazioni per fare radioterapia oppure per la bomba atomica. La salvaguardia della persona umana - e in seconda umana delle altre creature (vs parità ontologica, sostenendo la quale si perde un criterio ragionevole per poter privilegiare sempre la vita umana rispetto a quella animale) - è criterio di verifica per l’applicazione delle scoperte scientifiche. Compito umano è intervenire per aiutare lo sviluppo del creato secondo la sua natura e finalità, non stravolgendone lo scopo ultimo. La Laudato si’ parla dell’ambiente come “casa” fin dal sottotitolo, per evitare la riduzione dell’ambiente da casa a risorsa. Ma questo è frutto della riduzione operata dalla visione tecnicistica e scientista del mondo.Quindi: né ecocentrismo né sfruttamento arbitrario e assoluto dell’ambiente.
454 … Attraversando la morte e innestandovi la novità splendente della Risurrezione, Gesù inaugura un mondo nuovo in cui tutto è sottomesso a Lui (cfr. 1 Cor 15,20-28) e ristabilisce quei rapporti di ordine ed armonia che il peccato aveva distrutto. La coscienza degli squilibri tra l'uomo e la natura deve accompagnarsi alla consapevolezza che in Gesù è avvenuta la riconciliazione dell'uomo e del mondo con Dio … La natura, che nel Verbo era stata creata, per mezzo dello stesso Verbo, fattosi carne, viene riconciliata con Dio e rappacificata (cfr. Col 1,15-20).
455 Non solo l'interiorità dell'uomo è risanata, ma tutta la sua corporeità è toccata dalla forza redentrice di Cristo; l'intera creazione prende parte al rinnovamento che scaturisce dalla Pasqua del Signore, pur nei gemiti delle doglie del parto (cfr. Rm 8,19-23), in attesa di dare alla luce «un nuovo cielo e una nuova terra» (Ap 21,1) che sono il dono della fine dei tempi, della salvezza compiuta. …
II. L'UOMO E L'UNIVERSO DELLE COSE 456 La visione biblica ispira gli atteggiamenti dei cristiani in relazione all'uso della terra, nonché allo sviluppo della scienza e della tecnica. ... L'uomo oggi, «specialmente per mezzo della scienza e della tecnica, ha esteso e continuamente estende il suo dominio su quasi tutta la natura». Poiché l'uomo, «creato ad immagine di Dio, ha ricevuto il mandato di governare il mondo nella giustizia e nella santità, sottomettendo a sé la terra con tutto quello che in essa è contenuto, e di rapportare a Dio se stesso e l'universo intero, riconoscendolo Creatore di tutte le cose, perché, nella sottomissione di tutte le cose all'uomo, sia grande il nome di Dio su tutta la terra», il Concilio insegna che «l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, considerato in se stesso corrisponde al progetto di Dio». 457 I risultati della scienza e della tecnica sono, in se stessi, positivi: i cristiani «nemmeno pensano a contrapporre quello che gli uomini hanno prodotto con il proprio ingegno e la propria forza alla potenza di Dio, né che la creatura razionale sia quasi rivale del Creatore; al contrario, sono convinti piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile progetto». I Padri Conciliari sottolineano anche il fatto che «quanto più cresce la potenza degli uomini, tanto più largamente si estende la responsabilità sia degli individui che delle comunità», e che ogni attività umana deve corrispondere, secondo il disegno di Dio e la Sua volontà, al vero bene dell'umanità. In questa prospettiva, il
Magistero ha più volte sottolineato che la Chiesa Cattolica non si oppone in alcun modo al progresso, anzi considera «la scienza e la tecnologia... un prodotto meraviglioso della creatività umana che è un dono di Dio, dal momento che ci hanno fornito possibilità meravigliose, di cui beneficiamo con animo grato». …458 Le considerazioni del Magistero sulla scienza e sulla tecnologia in generale valgono anche per le loro applicazioni all'ambiente naturale e all'agricoltura. … Infatti, «la tecnica potrebbe costituire, con una retta applicazione, un prezioso strumento utile a risolvere gravi problemi, a cominciare da quelli della fame e della malattia, mediante la produzione di varietà di piante più progredite e resistenti e di preziosi medicamenti». È importante, però, ribadire il concetto di «retta applicazione», perché «noi sappiamo che questo potenziale non è neutro: esso può essere usato sia per il progresso dell'uomo, sia per la sua degradazione». Per questa ragione, «è necessario ... mantenere un atteggiamento di prudenza e vagliare con occhio attento natura, finalità e modi delle varie forme di tecnologia applicata». Gli scienziati, dunque, devono «utilizzare veramente la loro ricerca e le loro capacità tecniche per il servizio all'umanità», sapendo subordinarle «ai principi e valori morali che rispettano e realizzano nella sua pienezza la dignità dell'uomo». 459 Punto di riferimento centrale per ogni applicazione scientifica e tecnica è il rispetto dell'uomo, che deve accompagnarsi ad un doveroso atteggiamento di rispetto nei confronti delle altre creature viventi. … In questo senso, le formidabili possibilità della ricerca biologica suscitano profonda inquietudine, in quanto … «si è constatato che l'applicazione di talune scoperte nell'ambito industriale ed agricolo produce, a lungo termine, effetti negativi. Ciò ha messo crudamente in rilievo come ogni intervento in un'area dell'ecosistema non possa prescindere dal considerare le sue conseguenze in altre aree e, in generale, sul benessere delle future generazioni». 460 L'uomo, dunque, non deve dimenticare che «la sua capacità di trasformare e, in un certo senso, di creare il mondo col proprio lavoro ... si svolge sempre sulla base della prima originaria donazione delle cose da parte di Dio». Egli non deve «disporre arbitrariamente della terra, assoggettandola senza riserve alla sua volontà, come se essa non avesse una propria forma ed una destinazione anteriore datale da Dio, che l'uomo può, sì, sviluppare, ma non deve tradire». Quando si comporta in questo modo, «invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell'opera della creazione, l'uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione della natura, piuttosto tiranneggiata che governata da lui». …In fondo, è Dio stesso che offre all'uomo l'onore di cooperare con tutte le forze dell'intelligenza all'opera della creazione.
III. LA CRISI NEL RAPPORTO TRA UOMO E AMBIENTE 461 Il messaggio biblico e il Magistero ecclesiale costituiscono i punti di riferimento essenziali per valutare i problemi che si pongono nei rapporti tra l'uomo e l'ambiente. Alle origini di tali problemi si può ravvisare la pretesa di esercitare un dominio incondizionato sulle cose da parte dell'uomo, un uomo incurante di quelle considerazioni di ordine morale che devono invece contraddistinguere ogni attività umana. La tendenza allo sfruttamento «sconsiderato» delle risorse del creato è il risultato di un lungo processo storico e culturale: «…l'ambiente come “risorsa” rischia di minacciare l'ambiente come “casa”. A causa dei potenti mezzi di trasformazione offerti dalla civiltà tecnologica, sembra talora che l'equilibrio uomo-ambiente abbia raggiunto un punto critico». 462 La natura appare come uno strumento nelle mani dell'uomo, una realtà che egli deve costantemente manipolare, specialmente mediante la tecnologia. A partire dal presupposto, rivelatosi errato, che esiste una quantità illimitata di energia e di risorse da utilizzare, che la loro rigenerazione sia possibile nell'immediato e che gli effetti negativi delle manipolazioni dell'ordine naturale possono essere facilmente assorbiti, si è diffusa una concezione riduttiva che legge il mondo naturale in chiave meccanicistica e lo sviluppo in chiave consumistica; il primato attribuito al fare e all'avere piuttosto che all'essere causa gravi forme di alienazione umana. Un simile atteggiamento non deriva dalla ricerca scientifica e tecnologica, ma da un'ideologia scientista e tecnocratica che tende a condizionarla. La scienza e la tecnica …mentre avanzano nel loro cammino, esse suscitano domande circa il loro senso e fanno crescere la necessità di rispettare la dimensione trascendente della persona umana e della stessa creazione. 463 Una corretta concezione dell'ambiente, mentre da una parte non può ridurre utilitaristicamente la natura a mero oggetto di manipolazione e sfruttamento, dall'altra non deve assolutizzarla e sovrapporla in dignità alla stessa persona umana. In quest'ultimo caso, si arriva al punto di divinizzare la natura o la terra, come si può facilmente riscontrare in alcuni movimenti ecologisti che chiedono di dare un profilo istituzionale internazionalmente garantito alle loro concezioni.
Il Magistero ha motivato la sua contrarietà a una concezione dell'ambiente ispirata all'ecocentrismo e al biocentrismo, perché essa «si propone di eliminare la differenza ontologica e assiologica tra l'uomo e gli altri esseri viventi, considerando la biosfera come un'unità biotica di valore indifferenziato. Si viene così ad eliminare la superiore responsabilità dell'uomo in favore di una considerazione egualitaristica della “dignità” di tutti gli esseri viventi». 464 Una visione dell'uomo e delle cose slegata da ogni riferimento alla trascendenza ha portato a rifiutare il concetto di creazione e ad attribuire all'uomo e alla natura un'esistenza completamente autonoma. Il legame che unisce il mondo a Dio è stato così spezzato: tale rottura ha finito per disancorare dalla terra anche l'uomo e, più radicalmente, ha impoverito la sua stessa identità. L'essere umano si è ritrovato a pensarsi estraneo al contesto ambientale in cui vive. È ben chiara la conseguenza che ne discende: «è il rapporto che l'uomo ha con Dio a determinare il rapporto dell'uomo con i suoi simili e con il suo ambiente . Ecco perché la cultura cristiana ha sempre riconosciuto nelle creature che circondano l'uomo altrettanti doni di Dio da coltivare e custodire con senso di gratitudine verso il Creatore. In particolare, la spiritualità benedettina e francescana hanno testimoniato questa sorta di parentela dell'uomo con l'ambiente creaturale …». Va messa maggiormente in risalto la profonda connessione esistente tra ecologia ambientale ed «ecologia umana». 465 Il Magistero sottolinea la responsabilità umana di preservare un ambiente integro e sano per tutti: «L'umanità di oggi, se riuscirà a congiungere le nuove capacità scientifiche con una forte dimensione etica, sarà certamente in grado di promuovere l'ambiente come casa e come risorsa a favore dell'uomo e di tutti gli uomini, … a condizione che prevalga l'etica del rispetto per la vita e la dignità dell'uomo, per i diritti delle generazioni umane presenti e di quelle che verranno».
Nel considerare l’ambiente come bene collettivo occorre considerare il presente ma anche il futuro, noi e la prossima generazione. Se la logica è quella del dono, avendolo così ricevuto noi stessi, come tale dobbiamo trasmetterlo a chi verrà dopo di noi, come dono ben custodito.Occorrono quindi delle regole giuridiche che permettano di giungere a questo scopo, consapevoli del fatto che le regole sono utili ma non sufficienti. Anzitutto occorre cambiare una mentalità diffusa.Il problema sta nelle informazioni che si possiedono, che sono sovente incomplete e non univoche. Occorre muoversi secondo il principio di precauzione, uno stile e una mentalità che devono ovviamente fondarsi su punti fermi, su alcuni criteri:
1. Se non sono sicuro delle acquisizioni scientifiche ma devo egualmente decidermi, posso assumere una decisione provvisoria e modificabile. (Ad es. potrei aspettare a diffondere OGM se non sono certo della loro bontà)
2. La decisione deve poi essere proporzionata rispetto ad altre decisioni già prese. (Se lascio bere acqua di fonte, posso chiudere una sorgente inquinata ma solo quella, non tutte)
3. Calcolare costi e benefici e scegliere di fermarsi (ma non come immobilismo, bensì come scelta consapevole)
4. Nel processo decisionale ci deve essere trasparenza (chi decide, quali criteri, quali costi)
IV. UNA COMUNE RESPONSABILITÀ a) L'ambiente, un bene collettivo 466 La tutela dell'ambiente costituisce una sfida per l'umanità intera: si tratta del dovere, comune e universale, di rispettare un bene collettivo, destinato a tutti, impedendo che si possa fare «impunemente uso delle diverse categorie di esseri, viventi o inanimati – animali, piante, elementi naturali – come si vuole, a seconda delle proprie esigenze». È una responsabilità che deve maturare in base alla globalità della presente crisi ecologica e alla conseguente necessità di affrontarla globalmente, in quanto tutti gli esseri dipendono gli uni dagli altri nell'ordine universale stabilito dal Creatore…Questa prospettiva riveste una particolare importanza quando si considera, nel contesto degli stretti legami che uniscono tra loro i vari ecosistemi, il valore ambientale della biodiversità, che va trattata con senso di responsabilità e adeguatamente protetta, perché costituisce una straordinaria ricchezza per l'intera umanità. A questo proposito, ognuno può facilmente avvertire, per esempio, l'importanza della regione amazzonica, «uno degli spazi più apprezzati del mondo per la sua diversità biologica, che lo rende vitale per l'equilibrio ambientale di tutto il pianeta». Le foreste contribuiscono a mantenere essenziali equilibri naturali indispensabili alla vita. La loro distruzione, anche tramite sconsiderati incendi dolosi, accelera i processi di
desertificazione con rischiose conseguenze per le riserve di acqua e compromette la vita di molti popoli indigeni e il benessere delle future generazioni. Tutti, individui e soggetti istituzionali, devono sentirsi impegnati a proteggere il patrimonio forestale e, dove necessario, promuovere adeguati programmi di riforestazione. 467 La responsabilità verso l'ambiente, patrimonio comune del genere umano, si estende non solo alle esigenze del presente, ma anche a quelle del futuro: «Eredi delle generazioni passate e beneficiari del lavoro dei nostri contemporanei, noi abbiamo degli obblighi verso tutti, e non possiamo disinteressarci di coloro che verranno dopo di noi ad ingrandire la cerchia della famiglia umana. La solidarietà universale, ch'è un fatto e per noi un beneficio, è altresì un dovere». Si tratta di una responsabilità che le generazioni presenti hanno nei confronti di quelle future, una responsabilità che appartiene anche ai singoli Stati e alla Comunità internazionale. 468 La responsabilità verso l'ambiente deve trovare una traduzione adeguata a livello giuridico. È importante che la Comunità internazionale elabori regole uniformi, affinché tale regolamentazione consenta agli Stati di controllare con maggiore efficacia le diverse attività che determinano effetti negativi sull'ambiente e di preservare gli ecosistemi prevenendo possibili incidenti … Il contenuto giuridico del «diritto ad un ambiente sano e sicuro» sarà il frutto di una graduale elaborazione, sollecitata dalla preoccupazione dell'opinione pubblica di disciplinare l'uso dei beni del creato secondo le esigenze del bene comune e in una comune volontà di introdurre sanzioni per coloro che inquinano. Le norme giuridiche, tuttavia, da sole non bastano; accanto ad esse devono maturare un forte senso di responsabilità nonché un effettivo cambiamento nelle mentalità e negli stili di vita. 469 Le autorità chiamate a prendere decisioni per fronteggiare rischi sanitari ed ambientali talvolta si trovano di fronte a situazioni nelle quali i dati scientifici disponibili sono contradditori oppure quantitativamente scarsi: può essere opportuna allora una valutazione ispirata dal «principio di precauzione», che non comporta una regola da applicare, bensì un orientamento volto a gestire situazioni di incertezza. …La decisione deve essere proporzionata rispetto a provvedimenti già in atto per altri rischi. Le politiche cautelative, basate sul principio di precauzione, richiedono che le decisioni siano basate su un confronto tra rischi e benefici ipotizzabili per ogni possibile scelta alternativa, ivi compresa la decisione di non intervenire. All'approccio precauzionale è connessa l'esigenza di promuovere ogni sforzo per acquisire conoscenze più approfondite, pur nella consapevolezza che la scienza non può raggiungere rapidamente conclusioni circa l'assenza di rischi. Le circostanze di incertezza e provvisorietà rendono particolarmente importante la trasparenza nel processo decisionale.
L’ambiente, essendo un bene collettivo, non può esser lasciato al semplice mercato. E nella programmazione delle attività economiche occorre sempre tenere presente il costo della tutela ambientale (ad esempio i filtri necessari per ridurre l’impatto dei processi industriali).
Rivalità dei beni (se ce l’ho io, non ce l’hai tu: se è la tua moto, non la userò io, non è la mia)Escludibilità (posso decidere chi ce l’ha e chi no, ad es. se non paghi non te lo do)
Beni privati: R ed E (questo gesso è mio)Beni comuni (commons): R ma non E (ad esempio i pascoli demaniali, il posteggio gratuito per strada: se parcheggio io, non puoi tu; ma non escludo te in quanto tale).Beni di club: E ma non R (sono per quanti hanno un certo diritto, ad esempio pagare il pedaggio per l’autostrada, ma se io entro non escludo te)Beni pubblici: né R né E (non comportano rivalità né escludibilità: se c’è un costo, non si rivelano le proprie preferenze per avvalersi comunque del bene… l’economia di mercato non funziona!). Non rivelandosi le intenzioni delle persone, ecco che non vale la legge della domanda e dell’offerta e l’unica soluzione è offrire questi beni e tutelarli dal mercato. Il catechismo li chiama beni collettivi. (Se si dovesse pagare per avere il cielo pulito, ben pochi lo farebbero). Ed è per questo che l’ambiente deve essere tutelato.
La natura non è sacra in sé, per la chiesa, poiché affidata a libertà e responsabilità umane. La Chiesa non è contro l’intervento in sé, ma chiede che se ne valutino i risultati prima di approvare
dal pv morale un qualsiasi interventi. Quindi la chiesa non si oppone al progresso, ma pretende che sia valutato in quanto a liceità morale. Accanto a questa esigenza, bisognerebbe incentivare autonomia e sviluppo dei paesi meno sviluppati. Quindi ok per la ricerca scientifica, purché guidati da una coscienza limpida e onesta. La ricerca potrebbe quindi essere annoverata tra i beni pubblici poiché in vista del bene comune e quindi non può esser lasciata al solo profitto. Al tempo stesso occorre una certa tutela dell’aspetto economico per incentivare la ricerca. La chiesa non è per lo statalismo assoluto, ciò che conta è l’esito: non si può gestirla solo nella logica del profitto. Quello che conta è affermare il primato della politica sulla economia. Non può ricondursi tutto all’economica, ma occorre una politica efficace (senza scadere nel dirigismo sovietico). Ovviamente parliamo di una politica rettamente intesa, al servizio del bene comune.
470 La programmazione dello sviluppo economico deve considerare attentamente «la necessità di rispettare l'integrità e i ritmi della natura», poiché le risorse naturali sono limitate e alcune non sono rinnovabili. L'attuale ritmo di sfruttamento compromette seriamente la disponibilità di alcune risorse naturali per il tempo presente e per il futuro. La soluzione del problema ecologico richiede che l'attività economica rispetti maggiormente l'ambiente, conciliando le esigenze dello sviluppo economico con quelle della protezione ambientale. … In questo contesto vanno considerati i rapporti tra l'attività umana e i cambiamenti climatici … Il clima è un bene che va protetto e richiede che, nei loro comportamenti, i consumatori e gli operatori di attività industriali sviluppino un maggiore senso di responsabilità. Un'economia rispettosa dell'ambiente non perseguirà unicamente l'obiettivo della massimizzazione del profitto, perché la protezione ambientale non può essere assicurata solo sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici. L'ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di difendere o di promuovere adeguatamente. Tutti i Paesi, in particolare quelli sviluppati, devono avvertire come urgente l'obbligo di riconsiderare le modalità d'uso dei beni naturali. …Un'attenzione particolare dovrà essere riservata alle complesse problematiche riguardanti le risorse energetiche. … In una prospettiva morale improntata all'equità e alla solidarietà intergenerazionale, si dovrà, altresì, continuare, tramite il contributo della comunità scientifica, a identificare nuove fonti energetiche, a sviluppare quelle alternative e a elevare i livelli di sicurezza dell'energia nucleare … guidate dalla ricerca continua del bene comune universale. 471 Una speciale attenzione merita la relazione che i popoli indigeni hanno con la loro terra e le sue risorse: si tratta di un'espressione fondamentale della loro identità. Molti popoli hanno già perso o rischiano di perdere, a vantaggio di potenti interessi agro-industriali o in forza di processi di assimilazione e di urbanizzazione, le terre su cui vivono, alle quali è legato il senso stesso della loro esistenza. I diritti dei popoli indigeni devono essere opportunamente tutelati. Questi popoli offrono un esempio di vita in armonia con l'ambiente che essi hanno imparato a conoscere e a preservare …
b) L'uso delle biotecnologie 472 Negli ultimi anni si è imposta con forza la questione dell'uso delle nuove biotecnologie per scopi legati all'agricoltura, alla zootecnia, alla medicina e alla protezione dell'ambiente. Le nuove possibilità offerte dalle attuali tecniche biologiche e biogenetiche suscitano, da una parte, speranze ed entusiasmi e, dall'altra, allarme e ostilità. Le applicazioni delle biotecnologie, la loro liceità dal punto di vista morale, le loro conseguenze per la salute dell'uomo, il loro impatto sull'ambiente e sull'economia, formano oggetto di studio approfondito e di vivace dibattito. Si tratta di questioni controverse che coinvolgono scienziati e ricercatori, politici e legislatori, economisti ed ambientalisti, produttori e consumatori. I cristiani non sono indifferenti a queste problematiche, coscienti dell'importanza dei valori in gioco. 473 La visione cristiana della creazione comporta un giudizio positivo sulla liceità degli interventi dell'uomo sulla natura, ivi inclusi anche gli altri esseri viventi, e, allo stesso tempo, un forte richiamo al senso di responsabilità. La natura non è, in effetti, una realtà sacra o divina, sottratta all'azione umana. È piuttosto un dono offerto dal Creatore alla comunità umana, affidato all'intelligenza e alla responsabilità morale dell'uomo. Per questo egli non compie un atto illecito quando, rispettando l'ordine, la bellezza e l'utilità dei singoli esseri viventi e della loro funzione nell'ecosistema, interviene modificando alcune loro caratteristiche e proprietà. … come per ogni comportamento umano, è necessario valutare accuratamente la loro reale utilità nonché le loro possibili conseguenze anche in termini di rischi. Nell'ambito degli interventi
tecnico-scientifici di forte e ampia incisività sugli organismi viventi, con la possibilità di notevoli ripercussioni a lungo termine, non è lecito agire con leggerezza e irresponsabilità. 474 … Bisogna tener presenti soprattutto i criteri di giustizia e solidarietà, ai quali si devono attenere innanzi tutto gli individui ed i gruppi che operano nella ricerca e nella commercializzazione nel campo delle biotecnologie. Comunque, non si deve cadere nell'errore di credere che la sola diffusione dei benefici legati alle nuove biotecnologie possa risolvere tutti gli urgenti problemi di povertà e di sottosviluppo che assillano ancora tanti Paesi del pianeta. 475 In uno spirito di solidarietà internazionale, diverse misure possono essere attuate in relazione all'uso delle nuove biotecnologie. Va facilitato, in primo luogo, l'interscambio commerciale equo, libero da vincoli ingiusti. La promozione dello sviluppo dei popoli più svantaggiati non sarà però autentica ed efficace se si riduce all'interscambio di prodotti. È indispensabile favorire … gli interscambi di conoscenze scientifiche e tecnologiche e il trasferimento di tecnologie verso i Paesi in via di sviluppo. 476 La solidarietà comporta anche un richiamo alla responsabilità che hanno i Paesi in via di sviluppo e in particolare, le loro autorità politiche, di promuovere una politica commerciale favorevole ai loro popoli e l'interscambio di tecnologie atte a migliorarne le condizioni alimentari e sanitarie . In tali Paesi deve crescere l'investimento nella ricerca …477 Gli scienziati e i tecnici … non devono dimenticare che le loro attività riguardano materiali, viventi e non, appartenenti all'umanità come un patrimonio, destinato anche alle generazioni future; per i credenti si tratta di un dono ricevuto dal Creatore, affidato all'intelligenza e alla libertà umane, anch'esse dono dell'Altissimo. Sappiano gli scienziati impegnare le loro energie e le loro capacità in una ricerca appassionata, guidata da una coscienza limpida e onesta. 478 Gli imprenditori e i responsabili degli enti pubblici che si occupano della ricerca, della produzione e del commercio dei prodotti derivati dalle nuove biotecnologie devono tener conto non solo del legittimo profitto, ma anche del bene comune. Questo principio, valido per ogni tipo di attività economica, diventa particolarmente importante quando si tratta di attività che hanno a che fare con l'alimentazione, la medicina, la custodia della salute e dell'ambiente. … 479 I politici, i legislatori e i pubblici amministratori hanno la responsabilità di valutare le potenzialità, i vantaggi e gli eventuali rischi connessi all'uso delle biotecnologie. Non è auspicabile che le loro decisioni, a livello nazionale o internazionale, vengano dettate da pressioni provenienti da interessi di parte. Le autorità pubbliche devono favorire anche una corretta informazione dell'opinione pubblica e saper prendere comunque le decisioni più convenienti per il bene comune. 480 Anche i responsabili dell'informazione hanno un compito importante, da svolgere con prudenza e obiettività. La società si aspetta da loro un'informazione completa e obiettiva, che aiuti i cittadini a formarsi una corretta opinione sui prodotti biotecnologici, soprattutto perché si tratta di qualcosa che li concerne in prima persona in quanto possibili consumatori. Si deve evitare, pertanto, di cadere nella tentazione di una informazione superficiale, alimentata da facili entusiasmi o da ingiustificati allarmismi.
Anche i mezzi di informazione hanno il loro peso: se sono ben informato, posso ben agire. E non bisogna diffondere falsi allarmismi né menzogne.La destinazione universale dei beni dice che la proprietà privata è un diritto naturale secondario.
c) Ambiente e condivisione dei beni 481 Anche nel campo dell'ecologia la dottrina sociale invita a tener presente che i beni della terra sono stati creati da Dio per essere sapientemente usati da tutti: tali beni vanno equamente condivisi, secondo giustizia e carità. Si tratta essenzialmente di impedire l'ingiustizia di un accaparramento delle risorse: l'avidità, sia essa individuale o collettiva, è contraria all'ordine della creazione. Gli attuali problemi ecologici, di carattere planetario, possono essere affrontati efficacemente solo grazie ad una cooperazione internazionale capace di garantire un maggiore coordinamento sull'uso delle risorse della terra. 482 Il principio della destinazione universale dei beni offre un fondamentale orientamento, morale e culturale, per sciogliere il complesso e drammatico nodo che lega insieme crisi ambientale e povertà. …483 Lo stretto legame che esiste tra lo sviluppo dei Paesi più poveri, mutamenti demografici e un uso sostenibile dell'ambiente, non va utilizzato come pretesto per scelte politiche ed economiche poco conformi alla dignità della persona umana. Nel Nord del pianeta si assiste ad una «caduta del tasso di natalità, con ripercussioni sull'invecchiamento della popolazione, incapace perfino di rinnovarsi biologicamente», mentre nel Sud la situazione è diversa. Se è vero che l'ineguale distribuzione della popolazione e delle risorse disponibili crea ostacoli allo sviluppo e ad un uso sostenibile dell'ambiente, va riconosciuto che la crescita
demografica è pienamente compatibile con uno sviluppo integrale e solidale: «Siamo tutti d'accordo che una politica demografica è soltanto una parte di una strategia di sviluppo globale. Di conseguenza è importante che tutti i dibattiti sulle politiche demografiche prendano in considerazione lo sviluppo attuale e futuro delle nazioni e delle regioni. Allo stesso tempo è impossibile non tener conto dell'autentica natura del significato del termine “sviluppo”. Qualsiasi sviluppo degno di questo nome deve essere completo, ossia rivolto al bene autentico di ogni persona e dell'intera persona».
Il diritto all’acqua è universale e inalienabile, è una base necessaria per vivere. Occorre però una nuova educazione che conduca a nuovi stili di vita, ispirati e sobrietà, temperanza e autodisciplina e solidarietà. L’atteggiamento giusto sarà quello della gratitudine perché il mondo ci appare come dono e come traccia di Dio.
484 Il principio della destinazione universale dei beni si applica naturalmente anche all'acqua, considerata nelle Sacre Scritture come simbolo di purificazione (cfr. Sal 51,4, Gv 13,8) e di vita (cfr. Gv 3,5; Gal 3,27): «In quanto dono di Dio, l'acqua è elemento vitale, imprescindibile per la sopravvivenza e, pertanto, un diritto di tutti». … Un limitato accesso all'acqua potabile incide sul benessere di un numero enorme di persone ed è spesso causa di malattie, sofferenze, conflitti, povertà e addirittura di morte: per essere adeguatamente risolta, tale questione «deve essere inquadrata in modo da stabilire criteri morali basati proprio sul valore della vita e sul rispetto dei diritti e della dignità di tutti gli esseri umani». 485 L'acqua, per la sua stessa natura, non può essere trattata come una mera merce tra le altre e il suo uso deve essere razionale e solidale. La sua distribuzione rientra, tradizionalmente, fra le responsabilità di enti pubblici, perché l'acqua è stata sempre considerata come un bene pubblico, caratteristica che va mantenuta qualora la gestione venga affidata al settore privato. Il diritto all'acqua, come tutti i diritti dell'uomo, si basa sulla dignità umana, e non su valutazioni di tipo meramente quantitativo, che considerano l'acqua solo come un bene economico. Senza acqua la vita è minacciata. Dunque, il diritto all'acqua è un diritto universale e inalienabile.
d) Nuovi stili di vita 486 I gravi problemi ecologici richiedono un effettivo cambiamento di mentalità che induca ad adottare nuovi stili di vita, «nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti». Tali stili di vita devono essere ispirati alla sobrietà, alla temperanza, all'autodisciplina, sul piano personale e sociale. …che rispettino l'ordine della creazione e soddisfino i bisogni primari di tutti. … La questione ecologica non deve essere affrontata solo per le agghiaccianti prospettive che il degrado ambientale profila: essa deve tradursi, soprattutto, in una forte motivazione per un'autentica solidarietà a dimensione mondiale. 487 L'atteggiamento che deve caratterizzare l'uomo di fronte al creato è essenzialmente quello della gratitudine e della riconoscenza: il mondo, infatti, rinvia al mistero di Dio che lo ha creato e lo sostiene. Se si mette tra parentesi la relazione con Dio, si svuota la natura del suo significato profondo, depauperandola. Se invece si arriva a riscoprire la natura nella sua dimensione di creatura, si può stabilire con essa un rapporto comunicativo, cogliere il suo significato evocativo e simbolico, penetrare così nell'orizzonte del mistero, che apre all'uomo il varco verso Dio, Creatore dei cieli e della terra. Il mondo si offre allo sguardo dell'uomo come traccia di Dio, luogo nel quale si disvela la Sua potenza creatrice, provvidente e redentrice.
Proseguiamo con il magistero di Benedetto XVI, con la sua Spe Salvi, che non entra in rapporto diretto con l’ecologia. Ma ci interessa. Perché va alla radice del paradigma tecnocratico contemporaneo. Analizza il pensiero di Francesco Bacone (1561-1626) e i suoi idòla (idoli): idola tribus (pregiudizi radicati nella natura umana), idola fori (del linguaggio), idola teatri (dogmi delle filosofie e religioni tradizionali), idola specus (legati all’educazione). Dietro a questa analisi sta la chiave per intendere il rapporto tra scienza e prassi.La salvezza non la aspetto più dalla fede - che relego nella sfera privata, tra le cose meno rilevanti per il quotidiano – bensì dal rapporto tra scienza e prassi. E quindi la speranza che cos’è? La fede nel progresso. E il progresso è l’idea che il dominio della ragione sia destinato a crescere, vincendo ogni forma di dipendenza dell’uomo, compresa anche quella da Dio.
LETTERA ENCICLICA SPE SALVI DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XVI (2007)
La trasformazione della fede-speranza cristiana nel tempo moderno 16. Come ha potuto svilupparsi l'idea che il messaggio di Gesù sia strettamente individualistico e miri solo al singolo? Come si è arrivati a interpretare la «salvezza dell'anima» come fuga davanti alla responsabilità per l'insieme, e a considerare di conseguenza il programma del cristianesimo come ricerca egoistica della salvezza che si rifiuta al servizio degli altri? Per trovare una risposta all’interrogativo dobbiamo gettare uno sguardo sulle componenti fondamentali del tempo moderno. Esse appaiono con particolare chiarezza in Francesco Bacone. Che un'epoca nuova sia sorta – grazie alla scoperta dell'America e alle nuove conquiste tecniche che hanno consentito questo sviluppo – è cosa indiscutibile. Su che cosa, però, si basa questa svolta epocale? È la nuova correlazione di esperimento e metodo che mette l'uomo in grado di arrivare ad un'interpretazione della natura conforme alle sue leggi e di conseguire così finalmente «la vittoria dell'arte sulla natura». La novità – secondo la visione di Bacone – sta in una nuova correlazione tra scienza e prassi. … teologicamente… significherebbe che il dominio sulla creazione, dato all'uomo da Dio e perso nel peccato originale, verrebbe ristabilito. 17. Chi legge queste affermazioni e vi riflette con attenzione, vi riconosce un passaggio sconcertante: fino a quel momento il ricupero di ciò che l'uomo nella cacciata dal paradiso terrestre aveva perso si attendeva dalla fede in Gesù Cristo, e in questo si vedeva la «redenzione». Ora questa «redenzione», la restaurazione del «paradiso» perduto, non si attende più dalla fede, ma dal collegamento appena scoperto tra scienza e prassi. Non è che la fede, con ciò, venga semplicemente negata; essa viene piuttosto spostata su un altro livello – quello delle cose solamente private ed ultraterrene – e allo stesso tempo diventa in qualche modo irrilevante per il mondo. Questa visione programmatica ha determinato il cammino dei tempi moderni e influenza pure l'attuale crisi della fede che, nel concreto, è soprattutto una crisi della speranza cristiana. Così anche la speranza, in Bacone, riceve una nuova forma. Ora si chiama: fede nel progresso. Per Bacone, infatti, è chiaro che le scoperte e le invenzioni appena avviate sono solo un inizio; che grazie alla sinergia di scienza e prassi seguiranno scoperte totalmente nuove, emergerà un mondo totalmente nuovo, il regno dell'uomo.18. Al contempo, due categorie entrano sempre più al centro dell'idea di progresso: ragione e libertà . Il progresso è soprattutto un progresso nel crescente dominio della ragione e questa ragione viene considerata ovviamente un potere del bene e per il bene. Il progresso è il superamento di tutte le dipendenze – è progresso verso la libertà perfetta. Anche la libertà viene vista solo come promessa, nella quale l'uomo si realizza verso la sua pienezza. In ambedue i concetti – libertà e ragione – è presente un aspetto politico. Il regno della ragione, infatti, è atteso come la nuova condizione dell'umanità diventata totalmente libera. Le condizioni politiche di un tale regno della ragione e della libertà, tuttavia, in un primo momento appaiono poco definite. Ragione e libertà sembrano garantire da sé, in virtù della loro intrinseca bontà, una nuova comunità umana perfetta. In ambedue i concetti-chiave di «ragione» e «libertà», però, il pensiero tacitamente va sempre anche al contrasto con i vincoli della fede e della Chiesa, come pure con i vincoli degli ordinamenti statali di allora. Ambedue i concetti portano quindi in sé un potenziale rivoluzionario di un’enorme forza esplosiva. La radice è tutta nel connubio tra scienza e prassi quale fonte di progresso, come ragione di mancanza di speranza umana. La conseguenza è il consumismo che colpisce i singoli individui…
LETTERA ENCICLICA CARITAS IN VERITATE DI BENEDETTO XVI SULLO SVILUPPO UMANO INTEGRALE NELLA CARITÀ E NELLA VERITÀ - (2009)
Scritta per commemorare la Populorum Progressio di Paolo VI del 1967, ma slittò rispetto al 40mo anniversario a causa della crisi economica che proprio nel 2007 prese avvio e fu pubblicata nel 2009. Vediamo quanto concerne l’orizzonte del nostro corso. Si riaggancia ai temi della Spe Salvi, individuando come primo problema il modo in cui intendo la natura e la persona umana. Se ammetto una evoluzione predeterminata, rischio di ridurre il senso di responsabilità umana verso il creato. Da una parte si può arrivare a considerare “naturale” sinonimo di “intoccabile” o, all’opposto, di “manipolabile” a proprio piacimento.La natura è a disposizione dell’uomo ma come dono da custodire. Però non si può in alcun modo parificare la persona umana ad altro vivente. Non posso neppure dire che la tecnica può fare ciò che vuole, poiché negli esseri è già inscritto un fine ultimo. Che deve essere esplicitato tramite la cultura: l’uomo modella tramite essa l’ambiente naturale, ma la sua cultura attinge alle sue libertà e responsabilità. Occorre quindi legarsi allo sviluppo umano integrale, laddove questo termine dice la preoccupazione per le generazioni future. Occorre dunque investire sull’ambiente sapendo che la sua tutela è via alla pace tra i popoli. L’uso efficiente delle risorse non è assiologicamente neutrale, cioè deve rispondere a una precisa gerarchia di valori. Un principio cardine per la dottrina cristiana è che il fine NON giustifica i mezzi.Efficienza è la capacità di raggiungere l’obiettivo con la minima allocazione possibile di risorse, mentre Efficacia è semplicemente la capacità di raggiungere l’obiettivo.
48. Il tema dello sviluppo è oggi fortemente collegato anche ai doveri che nascono dal rapporto dell'uomo con l'ambiente naturale. Questo è stato donato da Dio a tutti, e il suo uso rappresenta per noi una responsabilità verso i poveri, le generazioni future e l'umanità intera. Se la natura, e per primo l'essere umano, vengono considerati come frutto del caso o del determinismo evolutivo, la consapevolezza della responsabilità si attenua nelle coscienze. Nella natura il credente riconosce il meraviglioso risultato dell'intervento creativo di Dio, che l'uomo può responsabilmente utilizzare per soddisfare i suoi legittimi bisogni — materiali e immateriali — nel rispetto degli intrinseci equilibri del creato stesso. Se tale visione viene meno, l'uomo finisce o per considerare la natura un tabù intoccabile o, al contrario, per abusarne. Ambedue questi atteggiamenti non sono conformi alla visione cristiana della natura, frutto della creazione di Dio. La natura è espressione di un disegno di amore e di verità. Essa ci precede e ci è donata da Dio come ambiente di vita. Ci parla del Creatore (cfr Rm 1, 20) e del suo amore per l'umanità. È destinata ad essere ricapitolata in Cristo alla fine dei tempi (cfr Ef 1, 9-10; Col 1, 19-20). Anch'essa, quindi, è una vocazione. La natura è a nostra disposizione non come «un mucchio di rifiuti sparsi a caso», bensì come un dono del Creatore che ne ha disegnato gli ordinamenti intrinseci, affinché l'uomo ne tragga gli orientamenti doverosi per “custodirla e coltivarla” (Gn 2,15). Ma bisogna anche sottolineare che è contrario al vero sviluppo considerare la natura più importante della stessa persona umana. Questa posizione induce ad atteggiamenti neopagani o di nuovo panteismo: dalla sola natura, intesa in senso puramente naturalistico, non può derivare la salvezza per l'uomo. Peraltro, bisogna anche rifiutare la posizione contraria, che mira alla sua completa tecnicizzazione, perché l'ambiente naturale non è solo materia di cui disporre a nostro piacimento, ma opera mirabile del Creatore, recante in sé una “grammatica” che indica finalità e criteri per un utilizzo sapiente, non strumentale e arbitrario. Oggi molti danni allo sviluppo provengono proprio da queste concezioni distorte. Ridurre completamente la natura ad un insieme di semplici dati di fatto finisce per essere fonte di violenza nei confronti dell'ambiente e addirittura per motivare azioni irrispettose verso la stessa natura dell'uomo. Questa, in quanto costituita non solo di materia ma anche di spirito e, come tale, essendo ricca di significati e di fini trascendenti da raggiungere, ha un carattere normativo anche per la cultura. L'uomo interpreta e modella l'ambiente naturale mediante la cultura, la quale a sua volta viene orientata mediante la libertà responsabile, attenta ai dettami della legge morale. I progetti per uno sviluppo umano integrale non possono pertanto ignorare le generazioni successive, ma devono essere improntati a
solidarietà e a giustizia intergenerazionali, tenendo conto di molteplici ambiti: l'ecologico, il giuridico, l'economico, il politico, il culturale. 49. Le questioni legate alla cura e alla salvaguardia dell'ambiente devono oggi tenere in debita considerazione le problematiche energetiche. L'accaparramento delle risorse energetiche non rinnovabili da parte di alcuni Stati, gruppi di potere e imprese costituisce, infatti, un grave impedimento per lo sviluppo dei Paesi poveri. Questi non hanno i mezzi economici né per accedere alle esistenti fonti energetiche non rinnovabili né per finanziare la ricerca di fonti nuove e alternative. L'incetta delle risorse naturali, che in molti casi si trovano proprio nei Paesi poveri, genera sfruttamento e frequenti conflitti tra le Nazioni e al loro interno. Tali conflitti si combattono spesso proprio sul suolo di quei Paesi, con pesanti bilanci in termini di morte, distruzione e ulteriore degrado. La comunità internazionale ha il compito imprescindibile di trovare le strade istituzionali per disciplinare lo sfruttamento delle risorse non rinnovabili, con la partecipazione anche dei Paesi poveri, in modo da pianificare insieme il futuro. Anche su questo fronte vi è l'urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà, specialmente nei rapporti tra i Paesi in via di sviluppo e i Paesi altamente industrializzati. Le società tecnologicamente avanzate possono e devono diminuire il proprio fabbisogno energetico sia perché le attività manifatturiere evolvono, sia perché tra i loro cittadini si diffonde una sensibilità ecologica maggiore. Si deve inoltre aggiungere che oggi è realizzabile un miglioramento dell'efficienza energetica ed è al tempo stesso possibile far avanzare la ricerca di energie alternative. È però anche necessaria una ridistribuzione planetaria delle risorse energetiche, in modo che anche i Paesi che ne sono privi possano accedervi. Il loro destino non può essere lasciato nelle mani del primo arrivato o alla logica del più forte. Si tratta di problemi rilevanti che, per essere affrontati in modo adeguato, richiedono da parte di tutti la responsabile presa di coscienza delle conseguenze che si riverseranno sulle nuove generazioni, soprattutto sui moltissimi giovani presenti nei popoli poveri, i quali «reclamano la parte attiva che loro spetta nella costruzione d'un mondo migliore». 50. Questa responsabilità è globale, perché non concerne solo l'energia, ma tutto il creato, che non dobbiamo lasciare alle nuove generazioni depauperato delle sue risorse. All'uomo è lecito esercitare un governo responsabile sulla natura per custodirla, metterla a profitto e coltivarla anche in forme nuove e con tecnologie avanzate in modo che essa possa degnamente accogliere e nutrire la popolazione che la abita. C'è spazio per tutti su questa nostra terra: su di essa l'intera famiglia umana deve trovare le risorse necessarie per vivere dignitosamente, con l'aiuto della natura stessa, dono di Dio ai suoi figli, e con l'impegno del proprio lavoro e della propria inventiva. Dobbiamo però avvertire come dovere gravissimo quello di consegnare la terra alle nuove generazioni in uno stato tale che anch'esse possano degnamente abitarla e ulteriormente coltivarla. Ciò implica l'impegno di decidere insieme, «dopo aver ponderato responsabilmente la strada da percorrere, con l'obiettivo di rafforzare quell'alleanza tra essere umano e ambiente che deve essere specchio dell'amore creatore di Dio, dal quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino». È auspicabile che la comunità internazionale e i singoli governi sappiano contrastare in maniera efficace le modalità d'utilizzo dell'ambiente che risultino ad esso dannose. È altresì doveroso che vengano intrapresi, da parte delle autorità competenti, tutti gli sforzi necessari affinché i costi economici e sociali derivanti dall'uso delle risorse ambientali comuni siano riconosciuti in maniera trasparente e siano pienamente supportati da coloro che ne usufruiscono e non da altre popolazioni o dalle generazioni future: la protezione dell'ambiente, delle risorse e del clima richiede che tutti i responsabili internazionali agiscano congiuntamente e dimostrino prontezza ad operare in buona fede, nel rispetto della legge e della solidarietà nei confronti delle regioni più deboli del pianeta. Uno dei maggiori compiti dell'economia è proprio il più efficiente uso delle risorse, non l'abuso, tenendo sempre presente che la nozione di efficienza non è assiologicamente neutrale.
Lo stile di vita è fondamentale, poiché degrado sociale e ambientale si legano tra loro. Il problema di fondo è proprio la complessiva tenuta morale della società. Educazione e leggi dovrebbero favorire la stessa mentalità che lega i doveri verso l’ambiente ai doveri verso sé e gli altri.
51. Le modalità con cui l'uomo tratta l'ambiente influiscono sulle modalità con cui tratta se stesso e, viceversa. Ciò richiama la società odierna a rivedere seriamente il suo stile di vita che, in molte parti del mondo, è incline all'edonismo e al consumismo, restando indifferente ai danni che ne derivano. È necessario un effettivo cambiamento di mentalità che ci induca ad adottare nuovi stili di vita, “nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti”. Ogni lesione della solidarietà e dell'amicizia civica provoca danni ambientali, così come il degrado ambientale, a sua volta, provoca insoddisfazione nelle relazioni sociali. La natura, specialmente nella nostra epoca, è talmente
integrata nelle dinamiche sociali e culturali da non costituire quasi più una variabile indipendente. La desertificazione e l'impoverimento produttivo di alcune aree agricole sono anche frutto dell'impoverimento delle popolazioni che le abitano e della loro arretratezza. Incentivando lo sviluppo economico e culturale di quelle popolazioni, si tutela anche la natura. Inoltre, quante risorse naturali sono devastate dalle guerre! La pace dei popoli e tra i popoli permetterebbe anche una maggiore salvaguardia della natura. L'accaparramento delle risorse, specialmente dell'acqua, può provocare gravi conflitti tra le popolazioni coinvolte. Un pacifico accordo sull'uso delle risorse può salvaguardare la natura e, contemporaneamente, il benessere delle società interessate. La Chiesa ha una responsabilità per il creato e deve far valere questa responsabilità anche in pubblico. E facendolo deve difendere non solo la terra, l'acqua e l'aria come doni della creazione appartenenti a tutti. Deve proteggere soprattutto l'uomo contro la distruzione di se stesso . È necessario che ci sia qualcosa come un'ecologia dell'uomo, intesa in senso giusto. Il degrado della natura è infatti strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana: quando l'«ecologia umana» è rispettata dentro la società, anche l'ecologia ambientale ne trae beneficio. Come le virtù umane sono tra loro comunicanti, tanto che l'indebolimento di una espone a rischio anche le altre, così il sistema ecologico si regge sul rispetto di un progetto che riguarda sia la sana convivenza in società sia il buon rapporto con la natura. Per salvaguardare la natura non è sufficiente intervenire con incentivi o disincentivi economici e nemmeno basta un'istruzione adeguata. Sono, questi, strumenti importanti, ma il problema decisivo è la complessiva tenuta morale della società. Se non si rispetta il diritto alla vita e alla morte naturale, se si rende artificiale il concepimento, la gestazione e la nascita dell'uomo, se si sacrificano embrioni umani alla ricerca, la coscienza comune finisce per perdere il concetto di ecologia umana e, con esso, quello di ecologia ambientale. È una contraddizione chiedere alle nuove generazioni il rispetto dell'ambiente naturale, quando l'educazione e le leggi non le aiutano a rispettare se stesse. Il libro della natura è uno e indivisibile, sul versante dell'ambiente come sul versante della vita, della sessualità, del matrimonio, della famiglia, delle relazioni sociali, in una parola dello sviluppo umano integrale. I doveri che abbiamo verso l'ambiente si collegano con i doveri che abbiamo verso la persona considerata in se stessa e in relazione con gli altri. Non si possono esigere gli uni e conculcare gli altri. Questa è una grave antinomia della mentalità e della prassi odierna, che avvilisce la persona, sconvolge l'ambiente e danneggia la società. 52. La verità e l'amore che essa dischiude non si possono produrre, si possono solo accogliere. La loro fonte ultima non è, né può essere, l'uomo, ma Dio, ossia Colui che è Verità e Amore. Questo principio è assai importante per la società e per lo sviluppo, in quanto né l'una né l'altro possono essere solo prodotti umani; la stessa vocazione allo sviluppo delle persone e dei popoli non si fonda su una semplice deliberazione umana, ma è inscritta in un piano che ci precede e che costituisce per tutti noi un dovere che deve essere liberamente accolto. Ciò che ci precede e che ci costituisce — l'Amore e la Verità sussistenti — ci indica che cosa sia il bene e in che cosa consista la nostra felicità. Ci indica quindi la strada verso il vero sviluppo.
MESSAGGIO DI BENEDETTO XVI PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE (1 gennaio 2010) SE VUOI COLTIVARE LA PACE, CUSTODISCI IL CREATO 1. … Il rispetto del creato riveste grande rilevanza, anche perché «la creazione è l’inizio e il fondamento di tutte le opere di Dio» e la sua salvaguardia diventa oggi essenziale per la pacifica convivenza dell’umanità. Se, infatti, a causa della crudeltà dell’uomo sull’uomo, numerose sono le minacce che incombono sulla pace e sull’autentico sviluppo umano integrale – guerre, conflitti internazionali e regionali, atti terroristici e violazioni dei diritti umani –, non meno preoccupanti sono le minacce originate dalla noncuranza – se non addirittura dall’abuso – nei confronti della terra e dei beni naturali che Dio ha elargito . Per tale motivo è indispensabile che l’umanità rinnovi e rafforzi «quell’alleanza tra essere umano e ambiente, che deve essere specchio dell’amore creatore di Dio, dal quale proveniamo e verso il quale siamo in cammino». 2. Nell’Enciclica Caritas in veritate ho posto in evidenza che lo sviluppo umano integrale è strettamente collegato ai doveri derivanti dal rapporto dell’uomo con l’ambiente naturale, considerato come un dono di Dio a tutti, il cui uso comporta una comune responsabilità verso l’umanità intera, in special modo verso i poveri e le generazioni future. Ho notato, inoltre, che quando la natura e, in primo luogo, l’essere umano
vengono considerati semplicemente frutto del caso o del determinismo evolutivo, rischia di attenuarsi nelle coscienze la consapevolezza della responsabilità. Ritenere, invece, il creato come dono di Dio all’umanità ci aiuta a comprendere la vocazione e il valore dell’uomo. … Contemplare la bellezza del creato è stimolo a riconoscere l’amore del Creatore, quell’Amore che «move il sole e l’altre stelle». 3. Vent’anni or sono, il Papa Giovanni Paolo II, dedicando il Messaggio della Giornata Mondiale della Pace al tema Pace con Dio creatore, pace con tutto il creato, richiamava l’attenzione sulla relazione che noi, in quanto creature di Dio, abbiamo con l’universo che ci circonda. «Si avverte ai nostri giorni – scriveva – la crescente consapevolezza che la pace mondiale sia minacciata... anche dalla mancanza del dovuto rispetto per la natura». E aggiungeva che la coscienza ecologica «non deve essere mortificata, ma anzi favorita, in modo che si sviluppi e maturi, trovando adeguata espressione in programmi ed iniziative concrete». Già altri miei Predecessori avevano fatto riferimento alla relazione esistente tra l’uomo e l’ambiente. Ad esempio, nel 1971, in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, Paolo VI ebbe a sottolineare che «attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura, (l’uomo) rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione». Ed aggiunse che in tal caso «non soltanto l’ambiente materiale diventa una minaccia permanente: inquinamenti e rifiuti, nuove malattie, potere distruttivo totale; ma è il contesto umano, che l’uomo non padroneggia più, creandosi così per il domani un ambiente che potrà essergli intollerabile: problema sociale di vaste dimensioni che riguarda l’intera famiglia umana». 4. Pur evitando di entrare nel merito di specifiche soluzioni tecniche, la Chiesa, «esperta in umanità», si premura di richiamare con forza l’attenzione sulla relazione tra il Creatore, l’essere umano e il creato . Nel 1990, Giovanni Paolo II parlava di «crisi ecologica» e, rilevando come questa avesse un carattere prevalentemente etico, indicava la «urgente necessità morale di una nuova solidarietà» [7]. Questo appello si fa ancora più pressante oggi, di fronte alle crescenti manifestazioni di una crisi che sarebbe irresponsabile non prendere in seria considerazione. Come rimanere indifferenti di fronte alle problematiche che derivano da fenomeni quali i cambiamenti climatici, la desertificazione, il degrado e la perdita di produttività di vaste aree agricole, l’inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere, la perdita della biodiversità, l’aumento di eventi naturali estremi, il disboscamento delle aree equatoriali e tropicali? Come trascurare il crescente fenomeno dei cosiddetti «profughi ambientali»: persone che, a causa del degrado dell’ambiente in cui vivono, lo devono lasciare – spesso insieme ai loro beni – per affrontare i pericoli e le incognite di uno spostamento forzato? Come non reagire di fronte ai conflitti già in atto e a quelli potenziali legati all’accesso alle risorse naturali? Sono tutte questioni che hanno un profondo impatto sull’esercizio dei diritti umani, come ad esempio il diritto alla vita, all’alimentazione, alla salute, allo sviluppo. 5. Va, tuttavia, considerato che la crisi ecologica … fortemente connessa al concetto stesso di sviluppo e alla visione dell’uomo e delle sue relazioni con i suoi simili e con il creato. Saggio è, pertanto, operare una revisione profonda e lungimirante del modello di sviluppo, nonché riflettere sul senso dell’economia e dei suoi fini, per correggerne le disfunzioni e le distorsioni. Lo esige lo stato di salute ecologica del pianeta; lo richiede anche e soprattutto la crisi culturale e morale dell’uomo, i cui sintomi sono da tempo evidenti in ogni parte del mondo. L’umanità ha bisogno di un profondo rinnovamento culturale; ha bisogno di riscoprire quei valori che costituiscono il solido fondamento su cui costruire un futuro migliore per tutti. Le situazioni di crisi, che attualmente sta attraversando – siano esse di carattere economico, alimentare, ambientale o sociale –, sono, in fondo, anche crisi morali collegate tra di loro. …così l’attuale crisi diventa occasione di discernimento e di nuova progettualità. 6. Non è forse vero che all’origine di quella che, in senso cosmico, chiamiamo «natura», vi è «un disegno di amore e di verità»? … Il Libro della Genesi, nelle sue pagine iniziali, ci riporta al progetto sapiente del cosmo, frutto del pensiero di Dio, al cui vertice si collocano l’uomo e la donna, creati ad immagine e somiglianza del Creatore per «riempire la terra» e «dominarla» come «amministratori» di Dio stesso (cfr Gen 1,28). L’armonia tra il Creatore, l’umanità e il creato, che la Sacra Scrittura descrive, è stata infranta dal peccato di Adamo ed Eva, dell’uomo e della donna, che hanno bramato occupare il posto di Dio, rifiutando di riconoscersi come sue creature. La conseguenza è che si è distorto anche il compito di «dominare» la terra, di «coltivarla e custodirla» e tra loro e il resto della creazione è nato un conflitto (cfr Gen 3,17-19). L’essere umano si è lasciato dominare dall’egoismo, perdendo il senso del mandato di Dio, e nella relazione con il creato si è comportato come sfruttatore, volendo esercitare su di esso un dominio assoluto. Ma il vero significato del comando iniziale di Dio, ben evidenziato nel Libro della Genesi, non consisteva in un semplice conferimento di autorità, bensì piuttosto in una chiamata alla responsabilità. …L’uomo, quindi, ha il dovere di esercitare un governo responsabile della creazione, custodendola e coltivandola.
7. … Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha ricordato che «Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli». L’eredità del creato appartiene, pertanto, all’intera umanità. Invece, l’attuale ritmo di sfruttamento mette seriamente in pericolo la disponibilità di alcune risorse naturali non solo per la generazione presente, ma soprattutto per quelle future. Non è difficile allora costatare che il degrado ambientale è spesso il risultato della mancanza di progetti politici lungimiranti o del perseguimento di miopi interessi economici, che si trasformano, purtroppo, in una seria minaccia per il creato. Per contrastare tale fenomeno, sulla base del fatto che «ogni decisione economica ha una conseguenza di carattere morale», è anche necessario che l’attività economica rispetti maggiormente l’ambiente. Quando ci si avvale delle risorse naturali, occorre preoccuparsi della loro salvaguardia, prevedendone anche i costi – in termini ambientali e sociali –, da valutare come una voce essenziale degli stessi costi dell’attività economica. Compete alla comunità internazionale e ai governi nazionali dare i giusti segnali per contrastare in modo efficace quelle modalità d’utilizzo dell’ambiente che risultino ad esso dannose. Per proteggere l’ambiente, per tutelare le risorse e il clima occorre, da una parte, agire nel rispetto di norme ben definite anche dal punto di vista giuridico ed economico, e, dall’altra, tenere conto della solidarietà dovuta a quanti abitano le regioni più povere della terra e alle future generazioni. 8. Sembra infatti urgente la conquista di una leale solidarietà inter-generazionale. I costi derivanti dall’uso delle risorse ambientali comuni non possono essere a carico delle generazioni future: «Eredi delle generazioni passate e beneficiari del lavoro dei nostri contemporanei, noi abbiamo degli obblighi verso tutti e non possiamo disinteressarci di coloro che verranno dopo di noi ad ingrandire la cerchia della famiglia umana. La solidarietà universale, ch’è un fatto e per noi un beneficio, è altresì un dovere. Si tratta di una responsabilità che le generazioni presenti hanno nei confronti di quelle future, una responsabilità che appartiene anche ai singoli Stati e alla Comunità internazionale». L’uso delle risorse naturali dovrebbe essere tale che i vantaggi immediati non comportino conseguenze negative per gli esseri viventi, umani e non umani, presenti e a venire; che la tutela della proprietà privata non ostacoli la destinazione universale dei beni [18]; che l’intervento dell’uomo non comprometta la fecondità della terra, per il bene di oggi e per il bene di domani. Oltre ad una leale solidarietà inter-generazionale, va ribadita l’urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà intra-generazionale, specialmente nei rapporti tra i Paesi in via di sviluppo e quelli altamente industrializzati: «la comunità internazionale ha il compito imprescindibile di trovare le strade istituzionali per disciplinare lo sfruttamento delle risorse non rinnovabili, con la partecipazione anche dei Paesi poveri, in modo da pianificare insieme il futuro». La crisi ecologica mostra l’urgenza di una solidarietà che si proietti nello spazio e nel tempo. È infatti importante riconoscere, fra le cause dell’attuale crisi ecologica, la responsabilità storica dei Paesi industrializzati. I Paesi meno sviluppati e, in particolare, quelli emergenti, non sono tuttavia esonerati dalla propria responsabilità rispetto al creato, perché il dovere di adottare gradualmente misure e politiche ambientali efficaci appartiene a tutti. …9. È indubbio che uno dei principali nodi da affrontare, da parte della comunità internazionale, è quello delle risorse energetiche, individuando strategie condivise e sostenibili per soddisfare i bisogni di energia della presente generazione e di quelle future. … favorire comportamenti improntati alla sobrietà, diminuendo il proprio fabbisogno di energia … promuovere la ricerca e l’applicazione di energie di minore impatto ambientale e la «ridistribuzione planetaria delle risorse energetiche, in modo che anche i Paesi che ne sono privi possano accedervi». La crisi ecologica, dunque, offre una storica opportunità per … uno sviluppo umano integrale, ispirato ai valori propri della carità nella verità. Auspico, pertanto, l’adozione di un modello di sviluppo fondato sulla centralità dell’essere umano, sulla promozione e condivisione del bene comune, sulla responsabilità, sulla consapevolezza del necessario cambiamento degli stili di vita e sulla prudenza, virtù che indica gli atti da compiere oggi, in previsione di ciò che può accadere domani. 10. Per guidare l’umanità verso una gestione complessivamente sostenibile dell’ambiente e delle risorse del pianeta, l’uomo è chiamato a impiegare la sua intelligenza nel campo della ricerca scientifica e tecnologica e nell’applicazione delle scoperte che da questa derivano. La «nuova solidarietà», che Giovanni Paolo II propose nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1990, e la «solidarietà globale», che io stesso ho richiamato nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2009, risultano essere atteggiamenti essenziali per orientare l’impegno di tutela del creato, attraverso un sistema di gestione delle risorse della terra meglio coordinato a livello internazionale …Si tratta di una dinamica imprescindibile, in quanto «lo sviluppo integrale dell’uomo non può aver luogo senza lo sviluppo solidale dell’umanità». Tante sono oggi le opportunità scientifiche … per sfruttare la grande potenzialità dell’energia solare. Altrettanta attenzione va poi rivolta alla questione ormai planetaria dell’acqua ed al sistema idrogeologico globale, il cui ciclo riveste una primaria importanza per la vita sulla terra e la cui stabilità rischia di essere fortemente minacciata dai cambiamenti climatici. … come pure occorre approntare idonee
politiche per la gestione delle foreste, per lo smaltimento dei rifiuti, per la valorizzazione delle sinergie esistenti tra il contrasto ai cambiamenti climatici e la lotta alla povertà. …È necessario, insomma, uscire dalla logica del mero consumo per promuovere forme di produzione agricola e industriale rispettose dell’ordine della creazione e soddisfacenti per i bisogni primari di tutti. La questione ecologica non va affrontata solo per le agghiaccianti prospettive che il degrado ambientale profila all’orizzonte; a motivarla deve essere soprattutto la ricerca di un’autentica solidarietà a dimensione mondiale, ispirata dai valori della carità, della giustizia e del bene comune. … La tecnica, pertanto, si inserisce nel mandato di «coltivare e custodire la terra» (cfr Gen 2,15), che Dio ha affidato all’uomo, e va orientata a rafforzare quell’alleanza tra essere umano e ambiente che deve essere specchio dell’amore creatore di Dio». 11. Appare sempre più chiaramente che il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi, gli stili di vita e i modelli di consumo e di produzione attualmente dominanti, spesso insostenibili dal punto di vista sociale, ambientale e finanche economico. Si rende ormai indispensabile un effettivo cambiamento di mentalità che induca tutti ad adottare nuovi stili di vita «nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti». Sempre più si deve educare a costruire la pace a partire dalle scelte di ampio raggio a livello personale, familiare, comunitario e politico. Tutti siamo responsabili della protezione e della cura del creato. Tale responsabilità non conosce frontiere. Secondo il principio di sussidiarietà, è importante che ciascuno si impegni al livello che gli corrisponde, …le Organizzazioni non-governative, …i media…Non si può rimanere indifferenti a ciò che accade intorno a noi, perché il deterioramento di qualsiasi parte del pianeta ricadrebbe su tutti. Le relazioni tra persone, gruppi sociali e Stati, come quelle tra uomo e ambiente, sono chiamate ad assumere lo stile del rispetto e della «carità nella verità». In tale ampio contesto, è quanto mai auspicabile che trovino efficacia e corrispondenza gli sforzi della comunità internazionale volti ad ottenere un progressivo disarmo ed un mondo privo di armi nucleari, la cui sola presenza minaccia la vita del pianeta e il processo di sviluppo integrale dell’umanità presente e di quella futura. 12. La Chiesa ha una responsabilità per il creato e sente di doverla esercitare, anche in ambito pubblico, per difendere la terra, l’acqua e l’aria, doni di Dio Creatore per tutti, e, anzitutto, per proteggere l’uomo contro il pericolo della distruzione di se stesso. Il degrado della natura è, infatti, strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza umana, per cui «quando la «ecologia umana» è rispettata dentro la società, anche l’ecologia ambientale ne trae beneficio». Non si può domandare ai giovani di rispettare l’ambiente, se non vengono aiutati in famiglia e nella società a rispettare se stessi: il libro della natura è unico, sia sul versante dell’ambiente come su quello dell’etica personale, familiare e sociale. I doveri verso l’ambiente derivano da quelli verso la persona considerata in se stessa e in relazione agli altri. Volentieri, pertanto, incoraggio l’educazione ad una responsabilità ecologica, che, come ho indicato nell’Enciclica Caritas in veritate, salvaguardi un’autentica «ecologia umana» …Occorre salvaguardare il patrimonio umano della società. Questo patrimonio di valori ha la sua origine ed è iscritto nella legge morale naturale, che è fondamento del rispetto della persona umana e del creato. 13. … Vi è pertanto una sorta di reciprocità: nel prenderci cura del creato, noi constatiamo che Dio, tramite il creato, si prende cura di noi. D’altra parte, una corretta concezione del rapporto dell’uomo con l’ambiente non porta ad assolutizzare la natura né a ritenerla più importante della stessa persona. Se il Magistero della Chiesa esprime perplessità dinanzi ad una concezione dell’ambiente ispirata all’ecocentrismo e al biocentrismo, lo fa perché tale concezione elimina la differenza ontologica e assiologica tra la persona umana e gli altri esseri viventi. In tal modo, si viene di fatto ad eliminare l’identità e il ruolo superiore dell’uomo, favorendo una visione egualitaristica della «dignità» di tutti gli esseri viventi. Si dà adito, così, ad un nuovo panteismo con accenti neopagani che fanno derivare dalla sola natura, intesa in senso puramente naturalistico, la salvezza per l’uomo… 14. Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. La ricerca della pace da parte di tutti gli uomini di buona volontà sarà senz’altro facilitata dal comune riconoscimento del rapporto inscindibile che esiste tra Dio, gli esseri umani e l’intero creato. …Proteggere l’ambiente naturale per costruire un mondo di pace è, pertanto, dovere di ogni persona. …la salvaguardia del creato e la realizzazione della pace sono realtà tra loro intimamente connesse …Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato.
DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI AI NUOVI AMBASCIATORI ACCREDITATI PRESSO LA SANTA SEDE Giovedì, 9 giugno 2011 … I primi sei mesi di quest’anno sono stati caratterizzati da innumerevoli tragedie che hanno riguardato la natura, la tecnica e i popoli. L’entità di tali catastrofi ci interpella. È l’uomo che viene per primo, ed è bene ricordarlo. L’uomo, al quale Dio ha affidato la buona gestione della natura, non può essere dominato dalla tecnica e divenirne il soggetto. Una tale presa di coscienza deve portare gli Stati a riflettere insieme sul futuro a breve termine del pianeta, di fronte alle loro responsabilità verso la nostra vita e le tecnologie. L’ecologia umana è una necessità imperativa. Adottare in ogni circostanza un modo di vivere rispettoso dell’ambiente e sostenere la ricerca e lo sfruttamento di energie adeguate che salvaguardino il patrimonio del creato e non comportino pericolo per l’uomo devono essere priorità politiche ed economiche. In questo senso, appare necessario rivedere totalmente il nostro approccio alla natura. Essa non è soltanto uno spazio sfruttabile o ludico. È il luogo in cui nasce l’uomo, la sua «casa», in qualche modo. Essa è fondamentale per noi. Il cambiamento di mentalità in questo ambito, anzi gli obblighi che ciò comporta, deve permettere di giungere rapidamente a un’arte di vivere insieme che rispetti l’alleanza tra l’uomo e la natura, senza la quale la famiglia umana rischia di scomparire. Occorre quindi compiere una riflessione seria e proporre soluzioni precise e sostenibili. Tutti i governanti devono impegnarsi a proteggere la natura e ad aiutarla a svolgere il suo ruolo essenziale per la sopravvivenza dell’umanità. Le Nazioni Unite mi sembrano essere il quadro naturale per una tale riflessione … Occorre inoltre interrogarsi sul giusto posto che deve occupare la tecnica. I prodigi di cui è capace vanno di pari passo con disastri sociali ed ecologici. … Puntare tutto su di essa o credere che sia l’agente esclusivo del progresso o della felicità comporta una reificazione dell’uomo, che sfocia nell’accecamento e nell’infelicità quando quest’ultimo le attribuisce e le delega poteri che essa non ha. Basta constatare i «danni» del progresso e i pericoli che una tecnica onnipotente e in ultimo non controllata fa correre all’umanità. La tecnica che domina l’uomo lo priva della sua umanità. L’orgoglio che essa genera ha fatto sorgere nelle nostre società un economismo intrattabile e un certo edonismo, che determina i comportamenti in modo soggettivo ed egoistico. L’affievolirsi del primato dell’umano comporta uno smarrimento esistenziale e una perdita del senso della vita. Infatti, la visione dell’uomo e delle cose senza riferimento alla trascendenza sradica l’uomo dalla terra e, fondamentalmente, ne impoverisce l’identità stessa. È dunque urgente arrivare a coniugare la tecnica con una forte dimensione etica, poiché la capacità che ha l’uomo di trasformare e, in un certo senso, di creare il mondo per mezzo del suo lavoro, si compie sempre a partire dal primo dono originale delle cose fatto da Dio (CA 37). La tecnica deve aiutare la natura a sbocciare secondo la volontà del Creatore. Lavorando in questo modo, il ricercatore e lo scienziato aderiscono al disegno di Dio, che ha voluto che l’uomo sia il culmine e il gestore della creazione… Consapevoli del rischio che corre l’umanità dinanzi a una tecnica vista come una «risposta» più efficiente del volontarismo politico o dello sforzo paziente educativo per civilizzare i costumi, i Governi devono promuovere un umanesimo rispettoso della dimensione spirituale e religiosa dell’uomo . Infatti, la dignità della persona umana non cambia con il fluttuare delle opinioni. Il rispetto della sua aspirazione alla giustizia e alla pace consente la costruzione di una società che promuove se stessa quando sostiene la famiglia o quando rifiuta, per esempio, il primato esclusivo delle finanze. Un Paese vive della pienezza della vita dei cittadini che lo compongono, essendo ognuno consapevole delle proprie responsabilità e potendo far valere le proprie convinzioni. Inoltre, la tensione naturale verso il vero e verso il bene è fonte di un dinamismo che genera la volontà di collaborare per realizzare il bene comune. Così, la vita sociale può arricchirsi costantemente, integrando la diversità culturale e religiosa attraverso la condivisione di valori, fonte di fraternità e di comunione. Dovendo considerare la vita in società anzitutto come una realtà di ordine spirituale, i responsabili politici hanno la missione di guidare i popoli verso l’armonia umana e verso la saggezza tanto auspicate, che devono culminare nella libertà religiosa, volto autentico della pace.
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIE E DELLA PACEACQUA, UN ELEMENTO ESSENZIALE PER LA VITA. IMPOSTARE SOLUZIONI EFFICACIIl contributo della Santa Sede al Sesto Forum Mondiale dell’Acqua (Marsiglia, marzo 2012)
A. IntroduzioneB. La situazione attualeC. Soluzioni sostenibiliD. Conclusione
A. INTRODUZIONEI. Il contributo della Chiesa Cattolica al dibattito internazionaleIn occasione dei Fora Mondiali dell’Acqua del 2003, del 2006 e del 2009, la Santa Sede ha elaborato alcune riflessioni… di ordine prevalentemente morale … caldeggiando azioni destinate a migliorare la sua fruizione e la sua protezione a livello mondiale.
1. Kyoto 2003In occasione del Forum di Kyoto, il documento Water, an essential element for life della Santa Sede rilevò come l’acqua fosse un fattore comune ai tre pilastri -economico, sociale ed ambientale- dello sviluppo sostenibile. Riguardo alla drammatica situazione in cui vivono le persone che non dispongono di acqua potabile, venne evidenziata la predominanza sia dei problemi di accesso e di gestione delle risorse rispetto a quelli legati alla disponibilità globale, sia dei problemi causati dall’uso eccessivo ed irresponsabile dell’acqua nei Paesi sviluppati rispetto a quelli causati dalla domanda crescente motivata dall’aumento della popolazione.Il documento definisce l’acqua come un triplice bene: bene sociale, collegato alla salute, al cibo, e ai conflitti; bene economico, necessario alla produzione di altri beni e correlato con l’energia, ma che comunque non può essere considerato come qualsiasi altro bene commerciale in quanto è un bene indispensabile alla vita e dono di Dio; bene ambientale, nel senso che esso è connesso alla sostenibilità dell’ambiente e alle catastrofi naturali.Inoltre, la Santa Sede, sempre in occasione del Forum di Kyoto, auspicò il riconoscimento formale del diritto all’acqua potabile quale diritto umano fondamentale e inalienabile, fondato sulla dignità umana. L’acqua, infatti, è una condizione indispensabile per la vita e per la crescita umana integrale. Da ultimo, ne ha evidenziato la valenza religiosa e i molteplici collegamenti con le problematiche della povertà.
2. Mexico 2006…la Santa Sede considerò soprattutto l’acqua come una responsabilità di tutti, essendo un bene fondamentale della creazione di Dio destinato ad ogni persona e popolo. Il suo accesso è un fattore chiave di pace e di sicurezza. … considerarla non una semplice merce, bensì un bene destinato a tutti…
3. Istanbul 2009… analizzare come un’unica ed importante questione l’acqua potabile e i servizi igienici, entrambi fondamentali per determinare i contenuti dello stesso diritto. Riguardo al diritto all’acqua, la Santa Sede …propone un richiamo alla promozione e il riconoscimento esplicito di tale diritto, radicato nella dignità umana.
Necessità di garantire acqua ma anche servizi igienici di standard minimo per salvaguardare la salute pubblica.
II. Il tempo di un bilancio per impostare soluzioni futureNel 1990, il Beato Giovanni Paolo II lanciò un accorato appello sulla «urgente necessità morale di una nuova solidarietà [riguardo alla] crisi ecologica» e sull’uso corretto delle risorse naturali. Due anni dopo, l’ONU organizzò a Rio de Janeiro un Summit su «Ambiente e Sviluppo», evento storico che ebbe un’influenza e ripercussioni a livello mondiale. ...Oggi, dopo l’inizio di una violenta crisi economica, anche collegata allo sfruttamento delle risorse naturali e allo scollamento fra finanza ed economia reale, fra profitto
e sostenibilità, è giunto il momento di fare un bilancio dell’attuale situazione per impostare urgentemente soluzioni efficaci per le problematiche rimaste aperte, in vista della Conferenza di Rio+20 che si terrà a giugno di quest’anno e di ulteriori e necessarie riflessioni sull’acqua considerate in relazione allo sviluppo integrale dei popoli.È motivo di speranza che gli organizzatori del Sesto Forum Mondiale dell’Acqua abbiano scelto di intitolare l’evento Time for solutions. La Santa Sede auspica che nel 2012 siano prese decisioni incisive…
B. LA SITUAZIONE ATTUALE
I. Progressi nell’affermazione del diritto all’acqua e riconoscimento del bisogno di attuarlo1. La Santa Sede e la proposta di diritti relativi ai beni collettivi compresa l’acquaNel 1990, il Beato Giovanni Paolo II parlava del «diritto ad un ambiente sicuro, come di un diritto che sarebbe dovuto rientrare in un'aggiornata carta dei diritti dell'uomo». L’anno seguente, nella sua Enciclica Centesimus annus, esso viene presentato come un diritto che corrisponde ad un «bene collettivo», la cui salvaguardia non può essere assicurata da semplici meccanismi di mercato, bensì tramite la collaborazione di tutti…Nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, pubblicato nel 2004, si specifica che «il diritto all'acqua come tutti i diritti dell'uomo, si basa sulla dignità umana, e non su valutazioni di tipo meramente quantitativo», e si precisa «che è un diritto universale e inalienabile».Nel 2009, Sua Santità Benedetto XVI, evidenziandone la connessione con gli altri diritti, sottolinea che esso riveste un ruolo importante per il loro conseguimento, a cominciare dal diritto primario alla vita.
2. Il cammino delle Nazioni UniteAnche l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, negli ultimi anni, si è più volte interessata al diritto all’acqua …lo si riconosce come diritto fondamentale essenziale al pieno esercizio del diritto alla vita e di tutti i diritti umani. …nel 2011, sulla scia di questo auspicato riconoscimento, basandosi sul suddetto rapporto, il Consiglio per i Diritti Umani ha lanciato un appello agli Stati per la sua effettiva attuazione.
II. C’è ancora molto da fare1. Troppe persone sono senz’acqua potabileAncora oggi, in contesti diversi, molte persone non possono vivere dignitosamente e sono particolarmente esposte a morbilità e mortalità. Manca, infatti, un sufficiente accesso all’acqua potabile in quantità e qualità adeguate. Si tenga, inoltre, presente che le cifre relative a tale accesso comunemente avanzate nelle sedi internazionali non rispecchiano la complessità del fenomeno. La distribuzione geografica delle persone tuttora necessitate di un accesso adeguato, poi, rende ancor più difficile la soluzione dei problemi.
a. Accesso all’acqua potabile in quantità inadeguataAd alcune comunità manca l’acqua in quantità sufficiente per soddisfare i propri bisogni, oppure non dispongono di acqua in prossimità …O, ancora, dipendono da risorse che variano a seconda delle stagioni e delle precipitazioni. A tali restrizioni naturali se ne aggiungono altre di tipo antropico e tecnico, come: la carenza di istituzioni adeguate; l’impossibilità di conservare o di pagare l’acqua potabile; la mancanza improvvisa delle abituali sorgenti o delle strutture di gestione dell’acqua, a causa di conflitti…
È un problema ancora attuale in Italia, ad esempio nel Sud (ma probabilmente è più dovuto alla malavita che alla scarsità di risorse).
b. Accesso all’acqua di qualità potabile inadeguataLa buona qualità dell’acqua potabile non è garantita se non si possiedono efficaci meccanismi di depurazione e adeguati servizi igienici. E nemmeno se manca l’informazione necessaria per distinguere l’acqua veramente potabile dall’acqua apparentemente potabile che, invece, richiede trattamenti per potabilizzarla…
c. Le cifre della sete sottostimateQueste situazioni riguarderebbero circa 800-900 milioni di persone, stando alle statistiche internazionali comunemente diffuse, fra le quali quelle delle Nazioni Unite. Ma, adottando una definizione larga di accesso all’acqua -un accesso regolare e costante ad acqua potabile che sia accessibile economicamente, legalmente e
di fatto, e che sia accettabile dal punto di vista della fruibilità-, la realtà descritta da alcuni studi è ancor più preoccupante: 1,9 miliardi di persone avrebbero a loro disposizione solo acqua insalubre, mentre 3,4 miliardi di persone utilizzerebbero saltuariamente acqua di qualità insicura…
Metà della popolazione mondiale non utilizza acqua verificata nella salubrità e potabilità. Il problema non è la mancanza di acqua ma la mancanza di politiche mirate a far sì che tale risorse non manchino nelle zone meno sviluppate del mondo. È dunque un problema di organizzazione sociale e di investimento di risorse.
d. Una distribuzione geografica complessaLa maggior parte delle persone prive di un regolare accesso all’acqua potabile -84% stando all’Organizzazione Mondiale della Salute-, vive in zone rurali, ovvero in zone in cui le possibilità di fornire acqua potabile sono limitate. In esse, vari fattori -come la lontananza di alcune comunità e il costo delle infrastrutture-, rendono improbabile un rapido e netto miglioramento della situazione. … Inoltre, in alcune zone urbane del mondo, si nota un forte squilibrio fra crescita della popolazione e aumento delle infrastrutture idriche.
2. Il ritardo nei servizi igienici…Oltre un miliardo di persone non avrebbe accesso a nessun tipo di servizio igienico …Questo fenomeno è preoccupante perché i servizi igienici, così come la depurazione, rivestono un ruolo essenziale nei processi di riuso dell’acqua e nel contrasto a possibili pericoli per la salute umana, causati dall’acqua inquinata o stagnante. L’assenza di servizi igienici e di adeguati sistemi di depurazione è una seria minaccia per l’ambiente specie nelle grandi città a forte densità abitativa, in quanto elevate quantità d’acqua inquinata vengono riversate nell’ambiente, in uno spazio limitato.
3. I rischi di una visione mercantileLe regole e i negoziati del commercio internazionale dovrebbero mirare al bene di tutti... L’essenzialità dell’acqua, dono di Dio, per l’esistenza umana obbliga a considerarla non come un bene commerciale qualsiasi.
Non può essere economico il criterio per determinare le politiche sociali in materia di acqua.
Purtroppo, sul piano della prassi, permane talvolta una concezione eccessivamente mercantile dell’acqua …secondo il criterio del profitto per il profitto, senza tener conto della valenza pubblica dell’acqua.Una visione e un comportamento eccessivamente mercantili possono portare a programmare investimenti per infrastrutture solo in zone dove appare redditizio realizzarle, ossia dove appare proficuo, là dove abitano numerose persone. …fornire l’acqua solo a chi è in grado di pagarla. Altro limite dell’approccio mercantile della gestione dell’acqua (e di altre risorse naturali) è quello di curare e salvaguardare l’ambiente assumendosi le proprie responsabilità solo se e quando ciò è economicamente conveniente.
4. Un diritto da tutelare e promuovere
Il diritto all’acqua deve essere giuridicamente azionabile, cioè deve poter valere davanti a un giudice, diversamente non avrebbe adeguata consistenza. Bisogna quindi individuare garanti e responsabili. Raffaele Cantone, responsabile dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione, afferma che sovente il problema è non sapere con qui relazionarsi, chi cioè sia la figura di riferimento.
Un diritto, una volta riconosciuto, va tutelato e promosso con un apposito inquadramento giuridico e con adeguate istituzioni che permettano di definire chiaramente le responsabilità, di stabilire in quali circostanze il diritto non è garantito e che consentano di denunciare e chiedere riparazione in caso di mancato rispetto.…Purtroppo, non tutti gli Stati hanno recepito nel loro ordinamento giuridico nazionale il diritto all’acqua. Alcuni Stati tollerano o pongono in essere nel loro territorio azioni direttamente o indirettamente lesive del diritto delle comunità appartenenti a Stati confinanti, o giungono ad utilizzare l’acqua come strumento di pressione politica o economica.
D’altra parte, a livello internazionale, dopo che è stato riconosciuto un diritto così importante, appare in maniera ancora più eclatante l’inadeguatezza del «complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente» i diritti e sono destinate a garantirli. La necessità di migliorare e rafforzare le istituzioni internazionali esistenti appare del resto evidente, se si pensa …che alcune problematiche non sono più gestibili da un singolo Stato...
III. L’affermarsi di una necessaria visione integrata e multi-livello nella ricerca di soluzioni sorretta da apposite strutture internazionali
1. L’acqua in un approccio globale dello sviluppoNella logica del principio di sussidiarietà bisogna trovare soluzioni nell’ottica di un approccio globale. Cioè non ci si può accontentare di una soluzione o strategia calata dall’alto bensì occorre che dal basso si organizzino le diverse sinergie possibili. Bene che i diversi paesi abbiano riconosciuto il diritto all’acqua, ma si tratta di elaborare delle concrete politiche di intervento.
È oramai noto che non si può analizzare e tentare di risolvere la questione dell’acqua in modo isolato, senza collegarla ad altre tematiche sociali, economiche ed ambientali interconnesse. Essa viene comunemente associata alle questioni della fame e della sottoalimentazione, dell’economia e della finanza, dell’energia, dell’ambiente in senso lato, della produzione e dell’industria, dell’igiene, dell’agricoltura, dell’urbanizzazione, delle catastrofi naturali, delle «siccità devastanti e dell’aumento dei livelli delle acque». Fra queste problematiche esiste un elevato grado di interdipendenza. Esse vanno, quindi, affrontate congiuntamente in vista di un vero sviluppo integrale e sostenibile.
2. I vari livelli di analisi…vanno tenuti debitamente in conto il livello globale e quello locale, la struttura regionale e quella nazionale, come richiede il principio di sussidiarietà.Gli acquiferi internazionali, i fiumi ed i laghi transnazionali, le attività che potenzialmente incidono sulla disponibilità di acqua in un altro Stato costituiscono naturalmente una questione sociale sovranazionale. La prevenzione e la gestione delle crisi in zone di tensione richiedono anch’esse un’analisi a vari livelli… 3. Nuove strutture intergovernative ancora insufficientiLa Santa Sede apprezza la creazione, all’interno delle Nazioni Unite o in strutture intergovernative regionali, di gruppi di consulenza o di organizzazioni di coordinamento specialmente dedicati alle questioni dell’acqua... dimostra l’attenzione crescente prestata al «bene pubblico» che è l’acqua. Ciò nonostante, per la gestione equa dell’acqua a livello internazionale, rimangono da compiere ulteriori progressi istituzionali.
IV. Una richiesta crescente
1. Le ragioniIn futuro ci sarà una richiesta crescente di acqua sul piano mondiale , visto che la popolazione del globo è in aumento. D’altra parte, indipendentemente dall’aumento della popolazione, si innalzano i livelli di vita e di consumo in vari Paesi. Cresce la domanda di acqua e di energia, adoperate anche per scopi non essenziali e nella produzione di beni di consumo non sempre necessari. A tale riguardo, sono particolarmente preoccupanti «lo sperpero di risorse [destinate] ad alimentare un insaziabile consumismo» e la «accumulazione illimitata di beni (...) riservati a un piccolo numero di persone» ...
2. Risorse compromesseAd un’accresciuta domanda di acqua fa, peraltro, riscontro la carenza di un tale bene, e sono manifeste le «preoccupazioni per la crescente diminuita disponibilità di acqua». Infatti le risorse idriche sono compromesse anche da attività direttamente imputabili ad una cattiva gestione, ossia: l’inquinamento che agisce a vari livelli nel ciclo dell’acqua; l’eccessivo pompaggio, che non considera debitamente i tempi di rigenerazione della risorsa acqua. Gravano su di essa anche le perdite negli impianti mal progettati o mal gestiti e gli sprechi dovuti a consumi irresponsabili.Il riscaldamento globale, in alcune zone particolarmente affette da mutamenti climatici, assottiglia le risorse disponibili. …Alcuni Paesi hanno peraltro sovrautilizzato l’acqua disponibile compromettendone le riserve
e oltrepassando i limiti di sostenibilità. La sicurezza e la sostenibilità delle risorse d’acqua rimane, pertanto, una questione di cui bisogna occuparsi urgentemente.
C. SOLUZIONI SOSTENIBILI
Ci troviamo, dunque, in un contesto in cui il diritto all’acqua è stato internazionalmente riconosciuto, ma i progressi nella sua attuazione, nei vari contesti di sviluppo, sono lenti.
I. Il bisogno di soluzioni immediateLa Santa Sede sottolinea l’aspetto «urgente» del problema e si augura che la ricerca di soluzioni in corso nella comunità internazionale non si esprima solo con dichiarazioni di intenti sia pure suffragate da copiosi studi… richiedono una solerte attenzione ed azioni urgenti ed efficaci, miranti a tutelare la dignità umana e la vita di milioni di persone.«Quando è in gioco la vita umana, il tempo si fa sempre breve… Certamente lo sviluppo integrale dei popoli della terra non è meno importante: è un’impresa degna dell’attenzione del mondo».
Ci andrebbe una governance internazionale per dare dei criteri per la gestione della risorsa acqua. Un principio che va senz’altro tenuto presente è quello della destinazione universale dei beni. Lo stato non deve gestire in toto questa risorsa, bensì garantire che ne venga rispettato lo status di merce particolare, oggetto di diritto. È la cosa che accade nell’ambito dei settori energia, alimentari, servizi di trasporto, sanità: vengono garantiti i servizi necessari minimi, controllando i soggetti erogatori o amministratori. Insomma: la chiesa non è per lo statalismo assoluto ma neppure per un libero mercato senza alcuna regola.
II. Strutture e governanceEmerge, con riferimento a varie problematiche sovranazionali, tra cui quelle dell’ambiente e dell’acqua, la necessità di una governance internazionale… come una necessità di coordinamento e di orientamento per una valorizzazione ed uno uso armoniosi e sostenibili dell’ambiente e delle risorse naturali in vista della realizzazione del bene comune mondiale.
1. Il compito della governanceServe, cioè, un assetto di istituzioni che garantisca a tutti e ovunque un accesso all’acqua regolare e adeguato, che risponda ai deficit già segnalati: indicando standard qualitativi e quantitativi; offrendo criteri che aiutino a promuovere legislazioni nazionali compatibili con il diritto all’acqua riconosciuto internazionalmente; monitorando se gli Stati rispettano i loro impegni. Compito importante è quello di favorire varie forme di cooperazione: la cooperazione scientifica e il trasferimento di tecnologie; la cooperazione amministrativa e manageriale. Sono necessarie altresì misure comuni di controllo contro la corruzione e l’inquinamento, nonché per la prevenzione e la gestione dei conflitti. …La governance deve, inoltre, garantire il primato della politica -responsabile del bene comune- sull’economia e la finanza …in considerazione delle loro evidenti responsabilità nei confronti dell’ambiente, del bene pubblico che è l’acqua, e della società, per dare vita a mercati ed istituzioni finanziarie che siano effettivamente a servizio della persona, che siano capaci, cioè, di rispondere alle esigenze del bene comune e della fraternità universale e che non siano motivate dal solo profitto per il profitto.
2. Ragion d’essere della governance: assicurare la destinazione universale dei beniL’umanità ha ricevuto da Dio la missione di curare e di amministrare con saggezza l’ambiente, l’acqua e le altre risorse, che sono «beni comuni» e come tali contribuiscono al «bene comune mondiale» per la cui realizzazione sono indispensabili istituzioni proporzionate. Tali istituzioni devono incaricarsi di garantire a livello globale la destinazione universale dei beni. …Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità. …Il diritto all'uso dei beni terreni, compreso l’uso dell’acqua, è un diritto naturale e inviolabile, di valore universale, in quanto compete ad ogni essere umano. Esso deve essere tutelato e reso effettivo con leggi e istituzioni adeguate.
III. Nuove politiche1. Politiche per l’acquaLa promozione del bene comune -tra le cui condizioni di realizzazione odierna vi è la tutela e la promozione del diritto all’acqua-, è un «dovere delle autorità civili». Occorrono, dunque, politiche che tutelino il suddetto bene…
a. Gli operatori privatiPremesso che l’autorità pubblica mantiene la funzione normativa e di controllo, venendo al caso degli operatori privati nel settore dell’acqua, va detto che è impossibile stabilire regole o norme universali di collaborazione privato-pubblico. Se è comprensibile e logico che gli attori privati tendano a sviluppare attività redditizie, essi non devono dimenticare che l’acqua ha una valenza sociale e deve essere accessibile a tutti. A tal proposito, l’autorità deve garantire, mediante un’adeguata legislazione, che l’acqua mantenga la sua destinazione universale, «con particolare attenzione ai settori più vulnerabili della società». Gli attori privati … non vanno aprioristicamente esclusi. Essi, però, non debbono comportarsi come se l’acqua fosse un bene di tipo meramente mercantile, e non un «bene pubblico» ...
b. Le politiche pubblicheVanno promosse politiche «coraggiose», …rinunciando ad interessi economici immediati o ad ideologie, che finiscono per umiliare la dignità umana. La legge positiva deve fondarsi sui principi della legge morale naturale per garantire il rispetto della dignità e del valore della persona umana che possono essere intaccati qualora il diritto all’acqua non sia garantito e promosso. Servono, pertanto, legislazioni e strutture a servizio del diritto all’acqua. Ma soprattutto servono persone rette, ossia persone con forte sensibilità del bene comune e del «bene pubblico» che è l’acqua.
2. Politiche basate sulla solidarietàLe politiche devono essere espressione della solidarietà, intergenerazionale e infragenerazionale, intesa come amore per il bene comune… La Santa Sede riafferma l’urgente necessità morale di una nuova solidarietà riguardo alle risorse naturali, alla gestione dell’ambiente e in particolare all’acqua, secondo una dimensione internazionale che abbraccia i paesi più poveri e che implica una gestione parsimoniosa delle risorse del pianeta… Se la dignità umana è trascurata, sono vanificate le riforme delle strutture, la stessa governance e l’orientamento morale offerto dai grandi principi.
3. L’impegno della società civileLa Santa Sede in quest’occasione non dimentica che la gestione dell’acqua non è un problema riguardante solo alcuni tecnici, solo alcuni politici o alcuni amministratori. È e deve essere una preoccupazione di tutti, di tutta la società civile. Quest’ultima si avvale in particolare dell’ausilio della comunità politica per raggiungere i suoi fini... La corretta gestione del bene pubblico che è l’acqua si attua secondo solidarietà e sussidiarietà. La società civile conserva la responsabilità ultima per cui, quando la comunità politica non si mostra in grado di svolgere il suo compito, deve mobilitarsi affinché ciò avvenga.
IV. Sobrietà e giustiziaIn una società che persegue l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile ed inclusivo, tutti sono chiamati a vivere con sobrietà e giustizia.
1. Sobrietà nei consumi…Questa diseguaglianza nell’accesso e nel consumo di acqua non può essere approvata. Non possono essere lodate le società che consumano acqua per finalità superflue, in preda a un consumismo sempre più sfrenato, orientate all’accumulazione illimitata di beni, giacché rappresentano pratiche contrarie ad uno sviluppo sostenibile.
Non è condivisibile la motivazione secondo cui il consumo o il risparmio di acqua in un determinato luogo, particolarmente in un Paese avanzato, non avrebbe conseguenze altrove, soprattutto in Paesi in via di sviluppo. L’acqua costituisce un «sistema» su scala mondiale e, se anche non ci fosse un collegamento diretto fra consumo e disponibilità in due luoghi diversi, esistono altri nessi indiretti che vanno tenuti presenti: trasportare, depurare e consumare acqua costa e richiede energia. Orbene, le somme richieste potrebbero essere spese in modo più utile aiutando i più poveri. Non si dimentichi, poi, il fatto che tale
energia viene talora sottratta a regioni che ne hanno maggiormente bisogno. La Santa Sede, pertanto, ribadisce l’importanza della sobrietà nei consumi… Tale sobrietà è sorretta da valori quali l’altruismo, la solidarietà e la giustizia.
2. Principio di giustiziaIl principio della giustizia, articolato negli aspetti commutativi, contributivi, distributivi, ossia come giustizia sociale, deve ispirare le soluzioni della questione dell’acqua.Questo stesso principio deve, ad esempio, orientare la suddivisione equa degli investimenti necessari allo sviluppo e a promuovere l’attuazione del diritto all’acqua. I Paesi in via di sviluppo e le economie emergenti devono contribuire a tali investimenti, in proporzione alle loro possibilità, affiancandosi così ai tradizionali Stati donatori. La comunità internazionale, dal canto suo, è chiamata ad adottare modalità innovative di finanziamento. Tra queste può essere inclusa quella rappresentata dai capitali ricavati da un’eventuale tassazione sulle transazioni finanziarie.Il principio di giustizia deve, inoltre, aiutare a individuare i danni causati al bene dell’acqua e a proporre possibili riparazioni o sanzioni. A tale scopo appaiono funzionali corti di giustizia abilitate alla ricezione di reclami da parte di coloro il cui diritto all’acqua non è garantito.Parimenti, il sopracitato principio orienta l’equa distribuzione dell’acqua… esistono livelli minimi per un’esistenza dignitosa, peraltro non garantiti in molti Paesi in via di sviluppo, che vanno soddisfatti...Inoltre, per la Santa Sede, la giustizia, in armonia con il principio di sussidiarietà, deve operare su tutti i livelli, dal locale al transfrontaliero, dal nazionale al regionale, dal continentale all’internazionale. Come la solidarietà, essa deve essere intergenerazionale e infra-generazionale.…certe politiche forzose di controllo delle nascite imposte a questi ultimi non sono una soluzione equa. Tali politiche costringono, infatti, le comunità più povere a condizionare il loro sviluppo demografico per consentire ad altre società di mantenere i loro livelli eccessivi di consumo.
D. CONCLUSIONEMiliardi di persone sono ancora senz’acqua in quantità o in qualità sufficiente per una vita dignitosa, sicura e confortevole. La Santa Sede, fiduciosa nel senso di responsabilità dei vari attori coinvolti nella gestione dell’acqua, desidera condividere il proprio punto di vista con i Governi e con tutte le persone di buona volontà. Richiamando il dovere di solidarietà, auspica che gli impegni presi vengano rispettati e che siano adottate soluzioni sostenibili con urgenza e con particolare attenzione ai più vulnerabili e alle generazioni future. I prossimi grandi eventi internazionali potranno così proporre tali soluzioni, giuste e sostenibili per l’ambiente, sorrette da meccanismi innovativi che ne garantiscano il rispetto ed una rapida attuazione. Non è da ignorare che nell’attuazione del diritto all’acqua influisce il divario tra i finanziamenti ritenuti necessari e quelli effettivamente mobilitati.L’acqua troppo frequentemente è oggetto di inquinamento, di sprechi e di speculazioni, è sempre più contesa ed è una nota causa di persistenti conflitti. Essa, invece, va custodita come un bene universale che è indispensabile per lo sviluppo integrale dei popoli e per la pace.
UDIENZA DI BENEDETTO XVI AL PONTIF. CONSIGLIO "COR UNUM" (19/01/2013)
“Cor Unum” è un dicastero della Santa Sede che si occupa delle questioni caritative, organizzando, coordinando e promuovendo le organizzazioni internazionali cattoliche. Ad esempio tutte le Caritas del mondo. L’assemblea plenaria riunisce tutti i componenti del pontificio consiglio.
SANTA SEDE Segreteria di Stato – (oggi: Card. Piero Parolin) / Sostituto / RappresentanteCongregazioni (come vari ministeri)Dottrina della fede / Evangelizzazione dei popoli / Clero / Vescovi / Culto divino e liturgia / Istituti di vita apostolica e consacratiPontifici Consigli (di livello inferiore)Varie, guidate da un cardinale prefetto + arcivescovo segretario + monsignore sottosegretario (stabili a Roma)Quindi vi sono un gruppo di membri – vescovi e cardinali – che si riuniscono a Roma solo quando ci sono assemblee plenarie.
Cari amici, … rivolgo il mio saluto cordiale ad ognuno di voi, estendendolo idealmente a tutti quanti operano nel servizio della carità della Chiesa… Così, in quest’Anno della fede il tema «Carità, nuova etica e antropologia cristiana, che voi affrontate, riflette lo stringente nesso tra amore e verità, o, se si preferisce, tra fede e carità. Tutto l’ethos cristiano riceve infatti il suo senso dalla fede come "incontro" con l’amore di Cristo, che offre un nuovo orizzonte e imprime alla vita la direzione decisiva (cfr Enc. Deus caritas est, 1). L’amore cristiano trova fondamento e forma nella fede. Incontrando Dio e sperimentando il suo amore, impariamo «a non vivere più per noi stessi, ma per Lui, e con Lui per gli altri» (ibid., 33). A partire da questo rapporto dinamico tra fede e carità, vorrei riflettere su un punto, che chiamerei la dimensione profetica che la fede instilla nella carità. L’adesione credente al Vangelo imprime infatti alla carità la sua forma tipicamente cristiana e ne costituisce il principio di discernimento. Il cristiano, in particolare chi opera negli organismi di carità, deve lasciarsi orientare dai principi della fede, mediante la quale noi aderiamo al «punto di vista di Dio», al suo progetto su di noi (cfr Enc. Caritas in veritate, 1). Questo nuovo sguardo sul mondo e sull’uomo offerto dalla fede fornisce anche il corretto criterio di valutazione delle espressioni di carità, nel contesto attuale.
Non ogni forma di volontariato è carità cristiana.
In ogni epoca, quando l’uomo non ha cercato tale progetto, è stato vittima di tentazioni culturali che hanno finito col renderlo schiavo. Negli ultimi secoli, le ideologie che inneggiavano al culto della nazione, della razza, della classe sociale si sono rivelate vere e proprie idolatrie (nazismo, fascismo, comunismo); e altrettanto si può dire del capitalismo selvaggio (“selvaggio”, quindi la critica non è rivolta al capitalismo in sé) col suo culto del profitto, da cui sono conseguite crisi, disuguaglianze e miseria. Oggi si condivide sempre più un sentire comune circa l’inalienabile dignità di ogni essere umano e la reciproca e interdipendente responsabilità verso di esso; e ciò a vantaggio della vera civiltà, la civiltà dell’amore (cfr. Paolo VI). D’altro canto, purtroppo, anche il nostro tempo conosce ombre che oscurano il progetto di Dio. Mi riferisco soprattutto ad una tragica riduzione antropologica che ripropone l’antico materialismo edonista, a cui si aggiunge però un "prometeismo tecnologico". Dal connubio tra una visione materialistica dell’uomo e il grande sviluppo della tecnologia emerge un’antropologia nel suo fondo atea. Essa presuppone che l’uomo si riduca a funzioni autonome, la mente al cervello, la storia umana ad un destino di autorealizzazione.
Prometeo è un personaggio della mitologia greca che ha rubato il fuoco agli dei donandolo agli uomini. E per punizione venne incatenato a una roccia mentre un’aquila gli divorava il fegato che continuamente ricresceva, in un supplizio senza fine. L’espressione “prometeismo tecnologico” indica la voglia di sottrarre il posto di Dio con la tecnologia, volendosi fare dio al posto di Dio. Emerge una specifica antropologia…
Tutto ciò prescindendo da Dio, dalla dimensione propriamente spirituale e dall’orizzonte ultraterreno. Nella prospettiva di un uomo privato della sua anima e dunque di una relazione personale con il Creatore, ciò che è tecnicamente possibile diventa moralmente lecito, ogni esperimento risulta accettabile, ogni politica demografica consentita, ogni manipolazione legittimata. L’insidia più temibile di questa corrente di pensiero è di fatto l’assolutizzazione dell’uomo: l’uomo vuole essere ab-solutus, sciolto da ogni legame e da ogni costituzione naturale. Egli pretende di essere indipendente e pensa che nella sola affermazione di sé stia la sua felicità. «L’uomo contesta la propria natura … Esiste ormai solo l’uomo in astratto, che poi sceglie per sé autonomamente qualcosa come sua natura» (Discorso alla Curia romana, 21 dicembre 2012). Si tratta di una radicale negazione della creaturalità e filialità dell’uomo, che finisce in una drammatica solitudine.
Non c’è mai stata tanta connessione e tanta solitudine come oggi!
La fede e il sano discernimento cristiano ci inducono perciò a prestare un’attenzione profetica a questa problematica etica e alla mentalità che vi è sottesa. La giusta collaborazione con istanze internazionali nel campo dello sviluppo e della promozione umana non deve farci chiudere gli occhi di fronte a queste gravi ideologie, e i Pastori della Chiesa – la quale è «colonna e sostegno della verità» (2 Tm 3,15) – hanno il dovere di mettere in guardia da queste derive tanto i fedeli cattolici quanto ogni persona di buona volontà e di retta ragione. Si tratta infatti di una deriva negativa per l’uomo, anche se si traveste di buoni sentimenti all’insegna di un presunto progresso, o di presunti diritti, o di un presunto umanesimo. Di fronte a questa riduzione antropologica, quale compito spetta ad ogni cristiano, e in particolare a voi, impegnati in attività
caritative, e dunque in rapporto diretto con tanti altri attori sociali? Certamente dobbiamo esercitare una vigilanza critica e, a volte, ricusare finanziamenti e collaborazioni che, direttamente o indirettamente, favoriscano azioni o progetti in contrasto con l’antropologia cristiana. Ma positivamente la Chiesa è sempre impegnata a promuovere l’uomo secondo il disegno di Dio, nella sua integrale dignità, nel rispetto della sua duplice dimensione verticale e orizzontale. A questo tende anche l’azione di sviluppo degli organismi ecclesiali. La visione cristiana dell’uomo infatti è un grande sì alla dignità della persona chiamata all’intima comunione con Dio, una comunione filiale, umile e fiduciosa. L’essere umano non è né individuo a sé stante né elemento anonimo nella collettività, bensì persona singolare e irripetibile, intrinsecamente ordinata alla relazione e alla socialità. Perciò la Chiesa ribadisce il suo grande sì alla dignità e bellezza del matrimonio come espressione di fedele e feconda alleanza tra uomo e donna, e il no a filosofie come quella del gender si motiva per il fatto che la reciprocità tra maschile e femminile è espressione della bellezza della natura voluta dal Creatore.
La ideologia del gender sostiene che l’identità di genere non dipende dal sesso bensì dalla percezione di sé, non dalla natura bensì dalla cultura. Buone le motivazioni sul rispetto del diverso, ma menzognero che la scelta individuale possa avanzare pretese giuridiche.
Cari amici, vi ringrazio per il vostro impegno a favore dell’uomo, nella fedeltà alla sua vera dignità. Di fronte a queste sfide epocali, noi sappiamo che la risposta è l’incontro con Cristo. In Lui l’uomo può realizzare pienamente il suo bene personale e il bene comune...
***
Sui testi di papa Francesco le domande all’esame saranno generali, mentre sugli altri documenti saranno chiesti nello specifico (tale testo, tale tema).
La LG indica anche la frequenza di certi richiami come indicatore del peso e della rilevanza magisteriale. Ecco perché proponiamo i diversi passaggi in cui papa Francesco anticipa il tema che ha fatto poi da struttura portante per la “Laudato si’”. Che, come ogni enciclica, non nasce dal nulla ma esprime la sintesi di temi già trattati.
UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO, 05.06.2013 Coltivare e custodire l’ambiente Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi vorrei soffermarmi sulla questione dell’ambiente, come ho avuto già modo di fare in diverse occasioni. Me lo suggerisce anche l’odierna Giornata Mondiale dell’Ambiente, promossa dalle Nazioni Unite, che lancia un forte richiamo alla necessità di eliminare gli sprechi e la distruzione di alimenti. Quando parliamo di ambiente, del creato, il mio pensiero va alle prime pagine della Bibbia, al Libro della Genesi, dove si afferma che Dio pose l’uomo e la donna sulla terra perché la coltivassero e la custodissero (cf 2,15). E mi sorgono le domande: Che cosa vuol dire coltivare e custodire la terra? Noi stiamo veramente coltivando e custodendo il creato? Oppure lo stiamo sfruttando e trascurando? Il verbo “coltivare” mi richiama alla mente la cura che l’agricoltore ha per la sua terra perché dia frutto ed esso sia condiviso: quanta attenzione, passione e dedizione! Coltivare e custodire il creato è un’indicazione di Dio data non solo all’inizio della storia, ma a ciascuno di noi; è parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti. Benedetto XVI ha ricordato più volte che questo compito affidatoci da Dio Creatore richiede di cogliere il ritmo e la logica della creazione. Noi invece siamo spesso guidati dalla superbia del dominare, del possedere, del manipolare, dello sfruttare; non la “custodiamo”, non la rispettiamo, non la consideriamo come un dono gratuito di cui avere cura. Stiamo perdendo l’atteggiamento dello stupore, della contemplazione, dell’ascolto della creazione; e così non riusciamo più a leggervi quello che Benedetto XVI chiama “il ritmo della storia di amore di Dio con
l’uomo”. Perché avviene questo? Perché pensiamo e viviamo in modo orizzontale, ci siamo allontanati da Dio, non leggiamo i suoi segni. Ma il “coltivare e custodire” non comprende solo il rapporto tra noi e l’ambiente, tra l’uomo e il creato, riguarda anche i rapporti umani. I Papi hanno parlato di ecologia umana, strettamente legata all’ecologia ambientale. Noi stiamo vivendo un momento di crisi; lo vediamo nell’ambiente, ma soprattutto lo vediamo nell’uomo. La persona umana è in pericolo: questo è certo, la persona umana oggi è in pericolo, ecco l’urgenza dell’ecologia umana! E il pericolo è grave perché la causa del problema non è superficiale, ma profonda: non è solo una questione di economia, ma di etica e di antropologia. La Chiesa lo ha sottolineato più volte; e molti dicono: sì, è giusto, è vero… ma il sistema continua come prima, perché ciò che domina sono le dinamiche di un’economia e di una finanza carenti di etica. Quello che comanda oggi non è l'uomo, è il denaro, il denaro, i soldi comandano. E Dio nostro Padre ha dato il compito di custodire la terra non ai soldi, ma a noi: agli uomini e alle donne. Noi abbiamo questo compito! Invece uomini e donne vengono sacrificati agli idoli del profitto e del consumo: è la “cultura dello scarto”. Se si rompe un computer è una tragedia, ma la povertà, i bisogni, i drammi di tante persone finiscono per entrare nella normalità. Se una notte di inverno, qui vicino in via Ottaviano, per esempio, muore una persona, quella non è notizia. Se in tante parti del mondo ci sono bambini che non hanno da mangiare, quella non è notizia, sembra normale. Non può essere così! Eppure queste cose entrano nella normalità: che alcune persone senza tetto muoiano di freddo per la strada non fa notizia. Al contrario, un abbassamento di dieci punti nelle borse di alcune città, costituisce una tragedia. Uno che muore non è una notizia, ma se si abbassano di dieci punti le borse è una tragedia! Così le persone vengono scartate, come se fossero rifiuti. Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano. Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione. Una volta i nostri nonni erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri parametri economici. Ricordiamo bene, però, che il cibo che si butta via è come se venisse rubato dalla mensa di chi è povero, di chi ha fame! Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e dello spreco del cibo per individuare vie e modi che, affrontando seriamente tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di condivisione con i più bisognosi. Pochi giorni fa, nella Festa del Corpus Domini, abbiamo letto il racconto del miracolo dei pani: Gesù dà da mangiare alla folla con cinque pani e due pesci. E la conclusione del brano è importante: «Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi avanzati: dodici ceste» (Lc 9,17) . Gesù chiede ai discepoli che nulla vada perduto: niente scarti! E c’è questo fatto delle dodici ceste: perché dodici? Che cosa significa? Dodici è il numero delle tribù d’Israele, rappresenta simbolicamente tutto il popolo. E questo ci dice che quando il cibo viene condiviso in modo equo, con solidarietà, nessuno è privo del necessario, ogni comunità può andare incontro ai bisogni dei più poveri. Ecologia umana ed ecologia ambientale camminano insieme. Vorrei allora che prendessimo tutti il serio impegno di rispettare e custodire il creato, di essere attenti ad ogni persona, di contrastare la cultura dello spreco e dello scarto, per promuovere una cultura della solidarietà e dell’incontro. Grazie.
“Cultura dello scarto” è una espressione specifica di papa Francesco. Il problema non è che questo “accada” ma che divenga una mentalità comune. È come se la mentalità popolare si stesse adattando a questo riduzionismo del valore della persona a “oggetto”.Lo “scarto” intacca l’economia ma altresì i rapporti tra le persone: chi non è immediatamente utile, non lo è ancora o non più, viene scartato.
Il beato Von Galen – il leone di Münster – che seppe resistere negli anni Trenta al progetto di “morte pietosa dei disabili”, strategia fortemente propagandata dal regime nazista. Von Galen dal pulpito tuonava contro un ipotetico disegno di legge che prevedesse la soppressione di malati, invalidi, handicappati… Alle minacce del regime replicò che la sua testa era a loro disposizione, ma non la sua coscienza. È stato un caso di iniziale “cultura dello scarto”. Allora era un orrore del nazismo, mentre oggi le campagne pro eutanasia sarebbero espressione del diritto individuale!
Papa Francesco prende spunto dalla giornata mondiale dell’ambiente, iniziativa laica a cui la Chiesa può aprirsi per offrire il proprio personale e specifico contributo.Cosa “fa notizia”: la borsa, l’economia, ma non la morte del vicino di casa. Emerge l’esigenza di un’etica dell’informazione che sappia ridare il posto giusto agli eventi, restituendo il valore e la dignità a ogni singola vita.Il compito della custodia è vecchio quanto l’uomo – Caino lo respinge, negando di essere il custode di suo fratello Abele.
MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE (1° GENNAIO 2014)
La fraternità aiuta a custodire e a coltivare la natura 9. La famiglia umana ha ricevuto dal Creatore un dono in comune: la natura. La visione cristiana della creazione comporta un giudizio positivo sulla liceità degli interventi sulla natura per trarne beneficio, a patto di agire responsabilmente, cioè riconoscendone quella "grammatica" che è in essa inscritta ed usando saggiamente le risorse a vantaggio di tutti, rispettando la bellezza, la finalità e l’utilità dei singoli esseri viventi e la loro funzione nell’ecosistema. Insomma, la natura è a nostra disposizione, e noi siamo chiamati ad amministrarla responsabilmente. Invece, siamo spesso guidati dall’avidità, dalla superbia del dominare, del possedere, del manipolare, dello sfruttare; non custodiamo la natura, non la rispettiamo, non la consideriamo come un dono gratuito di cui avere cura e da mettere a servizio dei fratelli, comprese le generazioni future. In particolare, il settore agricolo è il settore produttivo primario con la vitale vocazione di coltivare e custodire le risorse naturali per nutrire l’umanità. A tale riguardo, la persistente vergogna della fame nel mondo mi incita a condividere con voi la domanda: in che modo usiamo le risorse della terra? Le società odierne devono riflettere sulla gerarchia delle priorità a cui si destina la produzione. Difatti, è un dovere cogente che si utilizzino le risorse della terra in modo che tutti siano liberi dalla fame. Le iniziative e le soluzioni possibili sono tante e non si limitano all’aumento della produzione. È risaputo che quella attuale è sufficiente, eppure ci sono milioni di persone che soffrono e muoiono di fame e ciò costituisce un vero scandalo. È necessario allora trovare i modi affinché tutti possano beneficiare dei frutti della terra, non soltanto per evitare che si allarghi il divario tra chi più ha e chi deve accontentarsi delle briciole, ma anche e soprattutto per un’esigenza di giustizia e di equità e di rispetto verso ogni essere umano. In tal senso, vorrei richiamare a tutti quella necessaria destinazione universale dei beni che è uno dei principi-cardine della dottrina sociale della Chiesa. Rispettare tale principio è la condizione essenziale per consentire un fattivo ed equo accesso a quei beni essenziali e primari di cui ogni uomo ha bisogno e diritto.
Si parla di amministrare la natura intesa come “dono”. Qualcosa ricevuto gratuitamente e di cui si è responsabili. Legame tra economia e giustizia: non si tratta solo di far funzionare bene l’economia, bensì anche di garantire la giustizia tra contemporanei e anche rispetto alle generazioni future. La fraternità deve essere scoperta, amata, sperimentata, annunciata, testimoniata. Principio cardine: destinazione universale dei beni della terra (& proprietà privata – diritto umano naturale secondario).Sono discorsi legati allo stesso tema della ecologia integrale ma si toccano spunti e accenti diversi.
PAPA FRANCESCO – UDIENZA GENERALE DEL 21.05.2014
3. Tutto questo è motivo di serenità e di pace e fa del cristiano un testimone gioioso di Dio, sulla scia di san Francesco d’Assisi e di tanti santi che hanno saputo lodare e cantare il suo amore attraverso la contemplazione del creato. Allo stesso tempo, però, il dono della scienza ci aiuta a non cadere in alcuni atteggiamenti eccessivi o sbagliati. Il primo è costituito dal rischio di considerarci padroni del creato. Il creato non è una proprietà, di cui possiamo spadroneggiare a nostro piacimento; né, tanto meno, è una
proprietà solo di alcuni, di pochi: il creato è un dono, è un dono meraviglioso che Dio ci ha dato, perché ne abbiamo cura e lo utilizziamo a beneficio di tutti, sempre con grande rispetto e gratitudine. Il secondo atteggiamento sbagliato è rappresentato dalla tentazione di fermarci alle creature, come se queste possano offrire la risposta a tutte le nostre attese. Con il dono della scienza, lo Spirito ci aiuta a non cadere in questo sbaglio. Ma vorrei ritornare sulla prima via sbagliata: spadroneggiare sul creato invece di custodirlo. Dobbiamo custodire il creato poiché è un dono che il Signore ci ha dato, è il regalo di Dio a noi; noi siamo custodi del creato. Quando noi sfruttiamo il creato, distruggiamo il segno dell’amore di Dio. Distruggere il creato è dire a Dio: "non mi piace". E questo non è buono: ecco il peccato. La custodia del creato è proprio la custodia del dono di Dio ed è dire a Dio: "grazie, io sono il custode del creato ma per farlo progredire, mai per distruggere il tuo dono". Questo deve essere il nostro atteggiamento nei confronti del creato: custodirlo perché se noi distruggiamo il creato, il creato ci distruggerà! Non dimenticate questo. Una volta ero in campagna e ho sentito un detto da una persona semplice, alla quale piacevano tanto i fiori e li custodiva. Mi ha detto: "Dobbiamo custodire queste cose belle che Dio ci ha dato; il creato è per noi affinché ne profittiamo bene; non sfruttarlo, ma custodirlo, perché Dio perdona sempre, noi uomini perdoniamo alcune volte, ma il creato non perdona mai e se tu non lo custodisci lui ti distruggerà". Questo deve farci pensare e deve farci chiedere allo Spirito Santo il dono della scienza per capire bene che il creato è il più bel regalo di Dio. Egli ha fatto tante cose buone per la cosa più buona che è la persona umana.
Emergono alcuni elementi nuovi. Anzitutto il dono della scienza che lo Spirito ci dona per comprendere che il creato è un dono di Dio.
7 doni dello Spirito Santo: Sapienza / Intelletto / Consiglio / Fortezza / Scienza / Pietà / Timor di Dio. Sono i doni che competono a chi riceve il sacramento della cresima e ovviamente del battesimo (poiché confermano quanto già c’è).La prudenza è anche una virtù cardinale. La virtù parte dall’uomo, mentre i doni dello Spirito partono da Dio. Ma non sono cose così diverse. Il dono rende più forte, spedita e facilitata l’esecuzione della virtù (la virtù è navigare con la barca a remi, mentre il dono dello Spirito è come il dispiegare le vele ed esser sospinti dal vento).
Ogni dono ha una funzione particolare, collegato a qualche virtù.La SAPIENZA e la SCIENZA si legano alla prudenza e alla fede.La sapienza – sàpere, aver gusto – è il dono che ci fa avere il gusto delle cose di Dio.Mentre la scienza – scire – ci aiuta a leggere la realtà secondo Dio.Quelli dello Spirito sono doni che vanno semplicemente accolti, mentre le virtù si conquistano esercitandole nella pratica ripetuta.
Quindi se il dono della scienza ci aiuta a leggere le cose umane secondo Dio. In questo caso: penetrare la realtà della natura creata secondo il progetto di Dio. Ci fa capire che il creato è un dono di Dio. E quindi ci previene dal rischio di spadroneggiare il creato come se fosse una proprietà privata. Se la natura non si rispetta, essa si ribella (si distrugge).
Altro accento teologico: distruggere il creato è peccato. Come pure esorta a non fermarsi alle creature, ma andare oltre: le creature non rispondono a tutte le nostre attese. Certo, il creato risponde ad alcune attese, ma non a tutte. La creazione deve rimandare al Creatore. È un segno che rimanda alla realtà prima e assoluta.Così come l’amore tra i coniugi non può esser maggiore dell’amore di Dio (“Chi ama suo padre e sua madre più di me, non è degno di me”). Dio è al primo posto.
VISITA PASTORALE DI PAPA FRANCESCO IN MOLISEIncontro con il mondo del lavoro e dell’industria nell’Università degli Studi di Campobasso L’Osservatore Romano, 6 luglio 2014
Signor Rettore, Autorità, studenti… Vi ringrazio soprattutto per aver condiviso con me la realtà che vivete, le fatiche e le speranze. Il Signor Rettore ha ripreso l’espressione che io ho detto una volta: che il nostro Dio è il Dio delle sorprese. È vero, ogni giorno ce ne fa una. È così, il nostro Padre. Ma ha detto un’altra cosa su Dio, che prendo adesso: Dio che rompe gli schemi. E se noi non abbiamo il coraggio di rompere gli schemi, mai andremo avanti perché il nostro Dio ci spinge a questo: a essere creativi sul futuro. La mia visita in Molise comincia da questo incontro con il mondo del lavoro, ma il luogo in cui ci troviamo è l’Università. E questo è significativo: esprime l’importanza della ricerca e della formazione anche per rispondere alle nuove complesse domande che l’attuale crisi economica pone, sul piano locale, nazionale e internazionale. Lo testimoniava poco fa il giovane agricoltore con la sua scelta di fare il corso di laurea in agraria e di lavorare la terra "per vocazione". Il restare del contadino sulla terra non è rimanere fisso, è fare un dialogo, un dialogo fecondo, un dialogo creativo. E’ il dialogo dell’uomo con la sua terra che la fa fiorire, la fa diventare per tutti noi feconda. Questo è importante. Un buon percorso formativo non offre facili soluzioni, ma aiuta ad avere uno sguardo più aperto e più creativo per valorizzare meglio le risorse del territorio. Condivido pienamente ciò che è stato detto sul "custodire" la terra, perché dia frutto senza essere "sfruttata". Questa è una delle più grandi sfide della nostra epoca: convertirci ad uno sviluppo che sappia rispettare il creato. Io vedo l’America – la mia patria, pure: tante foreste, spogliate, che diventano terra che non si può coltivare, che non può dare vita. Questo è il peccato nostro: di sfruttare la terra e non lasciare che lei ci dia quello che ha dentro, con il nostro aiuto della coltivazione. Un’altra sfida è emersa dalla voce di questa brava mamma operaia, che ha parlato anche a nome della sua famiglia: il marito, il bambino piccolo e il bambino in grembo. Il suo è un appello per il lavoro e nello stesso tempo per la famiglia. Grazie di questa testimonianza! In effetti, si tratta di cercare di conciliare i tempi del lavoro con i tempi della famiglia. Ma vi dirò una cosa: quando vado al confessionale e confesso – adesso non tanto come lo facevo nell’altra diocesi –, quando viene una mamma o un papà giovane, domando: "Quanti bambini hai?", e mi dice. E faccio un’altra domanda, sempre: "Dimmi: tu giochi con i tuoi bambini?" La maggioranza risponde: "Come dice Padre?" – "Sì, sì: tu giochi? Perdi tempo con i tuoi bambini?". Stiamo perdendo questa capacità, questa saggezza di giocare con i nostri bambini. La situazione economica ci spinge a questo, a perdere questo. Per favore, perdere il tempo con i nostri bambini! La domenica: lei [si rivolge alla lavoratrice] ha fatto riferimento a questa domenica di famiglia, a perdere il tempo… Questo è un punto "critico", un punto che ci permette di discernere, di valutare la qualità umana del sistema economico in cui ci troviamo. E all’interno di questo ambito si colloca anche la questione della domenica lavorativa, che non interessa solo i credenti, ma interessa tutti, come scelta etica. È questo spazio della gratuità che stiamo perdendo. La domanda è: a che cosa vogliamo dare priorità? La domenica libera dal lavoro – eccettuati i servizi necessari – sta ad affermare che la priorità non è all’economico, ma all’umano, al gratuito, alle relazioni non commerciali ma familiari, amicali, per i credenti alla relazione con Dio e con la comunità. Forse è giunto il momento di domandarci se quella di lavorare alla domenica è una vera libertà. Perché il Dio delle sorprese e il Dio che rompe gli schemi fa sorprese e rompe gli schemi perché noi diventiamo più liberi: è il Dio della libertà.
La custodia della terra diventa un dialogo creativo: saperla osservare, comprendere, accompagnandone lo sviluppo, investendo in creatività, ascoltando quanto la natura dice – ad esempio inserendo nelle coltivazioni a rotazione l’anno di riposo, cogliendo quelli che sono i tempi e i ritmi di sviluppo della terra. Invece di sfruttare la terra, occorre saperne accogliere i frutti.Il tema del tempo: l’umano deve prevalere sulla mentalità economicistica che si infila persino in famiglia, laddove si intende come “sprecato” il tempo passato a giocare coi bambini, poiché non appare produttivo.“Giocare” è una forma di saggezza: significa sapere che cosa conta davvero, che cosa è più importante per la crescita dei figli. E privilegiare la gratuità invece della produttività.Infine il tema della domenica: vale per tutti, come scelta etica, non solo i cristiani.
La santificazione della festa avviene anzitutto con la partecipazione alla messa. Come riferito nella lettera apostolica DIES DOMINI di GPII (1998)
1. Dies Domini – è il giorno in cui il Signore si è riposato e ha dato uno sguardo contemplativo sul creato
2. Dies Christi – è il giorno in cui Cristo è risorto dai morti e ha donato lo Spirito Santo3. Dies Ecclesiae – è il giorno in cui la Chiesa si visibilizza per quanto è, cioè una comunità radunata
(come si vede nella messa domenicale)4. Dies hominis – giorno di gioia, di riposo e di solidarietà: si interrompe il lavoro, si sta nella gioia
con i parenti e gli amici, e si esprime solidarietà nei confronti di chi è bisognoso (chi è solo, chi è vedovo, il parroco… non per forza un mendicante).
5. Dies dierum – il giorno dei giorni, quello che emerge su tutti gli altri, l’ottavo giorno, la domenica senza tramonto. Gli antichi battisteri erano vere e proprie strutture separate dalla chiesa, a pianta ottagonale, a ricordare gli 8 giorni, che culminano nel primo dopo l’ultimo, da domenica a domenica.
La domenica va dunque intesa come spazio della gratuità. È davvero indispensabile lavorare alla domenica? A parte i servizi necessari, forse no. Il problema è la gestione del tempo della settimana: se si passano i momenti dei pasti guardando telefonini e tv, ovviamente mancherà sempre la condivisione in famiglia. Non si può aspettare una soluzione dall’alto ma si tratta di partire da un livello base, dalle famiglie stesse per modificare le abitudini quotidiane che incidono sulla vita personale.Nell’ambito della ecologia umana o ecologia integrale rientra anche l’uso del tempo. È vero che l’ambiente non aiuta, ma sono i genitori che devono saper porre un limite. Anche a Firenze papa Francesco ha ricordato che la civiltà cristiana non c’è più ma sta a ognuno di noi fare le scelte giuste. E l’insegnante di religione dovrebbe essere in grado di proporre queste tematiche da un punto di vista laico, umano, multidisciplinare.
UDIENZA DI PAPA FRANCESCO al Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (MASCI) in occasione del 60° anniversario di fondazione del Movimento (08.11.2014)
Fare strada nel creato. Il nostro tempo non può disattendere la questione ecologica, che è vitale per la sopravvivenza dell’uomo, né ridurla a questione meramente politica: essa infatti ha una dimensione morale che tocca tutti, così che nessuno può disinteressarsene. In quanto discepoli di Cristo, abbiamo un motivo in più per unirci con tutti gli uomini di buona volontà per la tutela e la difesa della natura e dell’ambiente. Il creato, infatti, è un dono affidatoci dalle mani del Creatore. Tutta la natura che ci circonda è creazione come noi, creazione insieme con noi, e nel destino comune tende a trovare in Dio stesso il compimento e la finalità ultima – la Bibbia dice "cieli nuovi e terra nuova" (cfr Is 65,17; 2 Pt 3,13; Ap 21,1). Questa dottrina della nostra fede è per noi uno stimolo ancora più forte per un rapporto responsabile e rispettoso con la creazione: nella natura inanimata, nelle piante e negli animali riconosciamo l’impronta del Creatore, e nei nostri simili la sua stessa immagine. Vivere a più stretto contatto con la natura, come fate voi, implica non solo il rispetto di essa, ma anche l’impegno a contribuire concretamente per eliminare gli sprechi di una società che tende sempre più a scartare beni ancora utilizzabili e che si possono donare a quanti sono nel bisogno. Anzitutto si precisa che la questione ecologica ha una dimensione morale, non solo politica. Morale significa parlare della persona umana in termini di libertà e responsabilità. Emerge un orizzonte escatologico relativo al creato. Inoltre la natura concepita come impronta del Creatore.Infine il richiamo contro gli sprechi del superfluo che può essere dono per i poveri.
INCONTRO DI PAPA FRANCESCO con i Giovani nell’Università Santo Tomas di Manila, 18.01.2015 - Discorso preparato e dato per letto
Diverse volte papa Francesco fa degli incontri pubblici, avendo un discorso ufficiale già pronto (poiché entrano nel Magistero). Ma spesso preferisce parlare a braccio, pur consegnando il discorso preparato al vescovo affinché sia recepito. Nella prassi il papa affida sempre a qualcuno la bozza di quanto vuol dire (discorsi, omelie, Angelus…). Cosa che fanno anche i vescovi chiedendo ai responsabili delle diverse aree un appoggio per intervenire su temi specifici (giovani, scuola, lavoro…). Entra dunque negli atti ufficiali, questo discorso, ma non si ritrova nei filmati e nelle registrazioni dell’occasione.
Un secondo ambito in cui siete chiamati a dare un contributo è nell’avere cura dell’ambiente. Questo non soltanto a causa del fatto che il vostro Paese, più di altri, rischia di essere seriamente colpito dal cambiamento climatico. Siete chiamati a prendervi cura del creato non solo come cittadini responsabili, ma anche come seguaci di Cristo! Il rispetto dell’ambiente richiede di più che semplicemente usare prodotti puliti o riciclarli. Questi sono aspetti importanti ma non sufficienti. Abbiamo bisogno di vedere, con gli occhi della fede, la bellezza del piano di salvezza di Dio, il legame tra l’ambiente naturale e la dignità della persona umana. L’uomo e la donna sono creati ad immagine e somiglianza di Dio e a loro è stato dato il dominio sulla creazione (cfr Gen 1,26-28). Come amministratori della creazione, siamo chiamati a fare della Terra un bellissimo giardino per la famiglia umana. Quando distruggiamo le nostre foreste, devastiamo il suolo e inquiniamo i mari, noi tradiamo quella nobile chiamata. Tre mesi fa, i vostri Vescovi hanno affrontato questi temi in una profetica Lettera Pastorale. Hanno chiesto a ciascuno di riflettere sulla dimensione morale delle nostre attività e dei nostri stili di vita , sui nostri consumi e sull’uso che facciamo delle risorse naturali. Oggi vi chiedo di farlo nel contesto della vostra vita e del vostro impegno per la costruzione del Regno di Cristo. Cari giovani, l’uso corretto e la corretta gestione delle risorse naturali è un compito urgente e voi avete un importante contributo da offrire. Voi siete il futuro delle Filippine. Siate attivamente interessati a quanto avviene nella vostra bellissima terra!
Novità dell’appello ai giovani nella cura del creato, cioè che parlando ai giovani richiami a essi l’impegno per la cura dell’ambiente.Ambiente naturale & dignità della persona umana. Dimensione morale e cristiana delle attività.Si tratta di rispondere alla antica vocazione di essere custodi del creato (“Giardino” o “Paradiso”).
VISITA DI STATO A PAPA FRANCESCO di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana (18.04.2015)
Un altro ambito che richiede oggi particolare attenzione da parte di tutti è la cura dell’ambiente. Per cercare di alleviare i crescenti squilibri ed inquinamenti, che a volte provocano veri e propri disastri ambientali, occorre acquisire piena consapevolezza degli effetti dei nostri comportamenti sul creato, che sono strettamente connessi al modo con cui l’uomo considera e tratta sé stesso (Caritas in veritate, 51). Tra pochi giorni si aprirà a Milano l’Esposizione Universale, che ha come tema: “Nutrire il pianeta. Energie per la vita”. L’evento dell’Expo sarà un’importante occasione in cui verranno presentate le più moderne tecnologie necessarie a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto dell’ambiente. Possa esso contribuire anche ad approfondire la riflessione sulle cause del degrado ambientale, in modo da fornire alle autorità competenti un quadro di conoscenze ed esperienze indispensabile per adottare decisioni efficaci e preservare la salute del pianeta che Dio ha affidato alla cura del genere umano.
Parla dell’Expo di Milano, evento capace di attirare circa 25 milioni di visitatori, ma con organizzazione non all’altezza della grandiosità dell’avvenimento. Avrebbe dovuto offrire
riflessioni sulle occasioni di degrado ambientale per far sì che arrivassero alle autorità un quadro di conoscenze ed esperienze affinché le autorità possano prendere decisioni efficace. Non avrebbe dovuto essere solo una fiera del cibo o evento scenografico…
Più che i doni dello Spirito Santo bisognerebbe parlare del dono dello Spirito Santo, poiché è un dono settiforme. In questa prospettiva forse il dono che aiuta a vedere le cose create secondo Dio è il dono della SCIENZA, mentre il dono della SAPIENZA dà il gusto delle cose divine. E contemplando il creato si possono giocare entrambi i doni, elevandosi dalla contemplazione della bellezza del creato all’amore di Dio.È un percorso crescente, per analogia dalle creatore si risale alla bellezza del Creatore.La “pietà” vale più del “timore”, quanto il rispetto filiale vale più del rispetto reverenziale. Ma tutti i doni dello Spirito si accompagnano agli altri. Quando devo prendere una decisione, ricorrerò al consiglio; alla fortezza, dovendo affrontare una prova o tentazione.
INTERVENTO DI PAPA FRANCESCO al Workshop “Modern Slavery and Climate Change: the Commitment of the Cities” (21.07.2015)
È un discorso “alla buona”, ma afferma anzitutto che l’uomo non è separabile dalla natura e dal cosmo. Anzi: è dentro alla natura. Non è dunque un tema “verde” - quello della LS - ma di dottrina sociale della chiesa, perché la cura dell’ambiente ci “socializza”.Un monito importante nella LS è la tecnocrazia, fonte di malattie rare, causa di inurbamento e origine di megalopoli. Romano Guardini parla di due forme di inculturazione: dobbiamo trasformare il mondo in cultura (1) e quando non si rispetta la terra (2).
Mi permetto di parlare in spagnolo. Buonasera, benvenuti. Vi ringrazio sinceramente di cuore per il lavoro che avete fatto. È vero che tutto girava intorno al tema della cura dell’ambiente, di questa cultura della cura dell’ambiente, però questa cultura della cura dell’ambiente non è un atteggiamento solamente – lo dico nel vero senso della parola – “verde”, non è un atteggiamento “verde”, è molto di più. Prendersi cura dell’ambiente significa avere un atteggiamento di ecologia umana. Non possiamo dire, cioè, che la persona sta qui e il creato, l’ambiente stanno lì. L’ecologia è totale, è umana. E questo è quello che ho voluto esprimere nell’enciclica Laudato si’: che non si può separare l’uomo dal resto; c’è una relazione che incide in maniera reciproca… Per questo di fronte ad una domanda che mi hanno fatto ho risposto: “No, non è un’enciclica “verde”, è un’enciclica sociale”. Perché nella società, nella vita sociale dell’uomo, non possiamo prescindere dalla cura dell’ambiente. In più, la cura dell’ambiente è un atteggiamento sociale, che ci socializza, in un senso o nell’altro – ognuno può dargli il valore che vuole – dall’altro lato, ci fa ricevere – mi piace l’espressione italiana, quando parlano dell’ambiente –, del Creato, di quello che ci è stato dato come dono, ossia l’ambiente. …una delle cose che più si nota quando l’ambiente, la creazione non è curata, è la crescita a dismisura delle città. È un fenomeno mondiale. È come se le teste, le grandi città, si facessero grandi, però ogni volta con cordoni di povertà e di miseria più grandi, dove la gente soffre gli effetti della trascuratezza dell’ambiente. In questo senso è coinvolto il fenomeno migratorio. Perché la gente viene nelle grandi città, nei cordoni delle grandi città, le favelas? Perché fa questo? Semplicemente perché il mondo rurale non dà loro opportunità. E qui un punto che sta nell’Enciclica – e con molto rispetto, però si deve denunciare – è l’idolatria della tecnocrazia. La tecnocrazia porta a distruggere il lavoro, crea disoccupazione. …Non ho le statistiche, però in alcuni Paesi d’Europa, soprattutto i giovani, la disoccupazione giovanile – dai 25 anni in giù – supera il 40 per cento e in alcuni arriva al 50 per cento. …una gioventù disoccupata che, oggi, quale orizzonte e quale futuro può offrire? Che cosa rimane a questa gioventù: o le dipendenze, la noia, il non sapere che cosa fare della propria vita -una vita senza senso, molto dura, il suicidio giovanile …progetti di guerriglia, un ideale di vita. Dall’altro lato, è in gioco la salute. La quantità di “malattie rare”, così si chiamano, che provengono da molti elementi usati per fertilizzare i campi – o chissà, ancora non si sa bene la causa – ma comunque da un eccesso di tecnicizzazione. Tra i problemi più grandi in gioco ci sono quelli dell’ossigeno e dell’acqua. Cioè la desertificazione di grandi zone per la deforestazione…
Che succede quando tutti questi fenomeni di tecnicizzazione eccessiva, senza cura dell’ambiente, oltre ai fenomeni naturali, incidono sulla migrazione? Non avere lavoro e poi la tratta delle persone. Ogni volta è più frequente il lavoro in nero, un lavoro senza contratto, un lavoro “organizzato sotto banco”. Come è cresciuto! II lavoro in nero è molto diffuso, e questo significa che una persona non guadagna sufficientemente per vivere. Questo può provocare reati, tutto quello che succede in una grande città a causa di queste migrazioni provocate dalla tecnicizzazione eccessiva. Soprattutto mi riferisco all’ambiente agricolo ed anche alla tratta delle persone nel lavoro minerario. La schiavitù mineraria è vasta e molto forte. E quello che significa l’uso di certi elementi del trattamento dei minerali – arsenico, cianuro… - che fanno ammalare la popolazione. In questo c’è una responsabilità molto grande. Tutto rimbalza, tutto torna indietro, tutto... È l’effetto rimbalzo contro la stessa persona. Può essere la tratta di esseri umani per il lavoro schiavista, la prostituzione, che sono fonti di lavoro, per poter sopravvivere oggi. Per questo sono contento che voi abbiate riflettuto su questi fenomeni – io ne ho menzionati alcuni, non di più – che colpiscono le grandi città. Alla fine io direi che di questo debbano interessarsi le Nazioni Unite. …Ho ricevuto qualche mese fa una delegazione di donne delle Nazioni Unite, incaricate del problema dello sfruttamento sessuale dei bambini nei Paesi di guerra. I bambini come oggetto di sfruttamento. E’ un altro fenomeno. E le guerre sono anche elemento di squilibrio dell’ambiente. Vorrei infine terminare con una riflessione, che non è mia, ma del teologo e filosofo Romano Guardini, che parla di due forme di “incultura”: l’incultura che Dio ci ha lasciato, perché la trasformassimo in cultura, e per questo ci ha dato il mandato di curare, far crescere e dominare la terra; e la seconda incultura, quando l’uomo non rispetta questa relazione con la terra, non la cura - è molto chiaro nel racconto biblico, che è una letteratura di tipo mistico. Quando non la cura, l’uomo si impadronisce di quella cultura e comincia a deviarla. Ossia l’incultura: la devia, ne perde il controllo e dà origine ad una seconda forma di incultura: l’energia atomica è buona, può aiutare. Fino a qui va bene, ma pensiamo a Hiroshima e a Nagasaki. Si crea cioè il disastro e la distruzione, per fare un vecchio esempio. Oggi, in tutte le forme di incultura, come quelle che avete trattato, questa seconda forma di incultura è quella che distrugge l’uomo. Un rabbino del Medio Evo, più o meno dell’epoca di San Tommaso d’Aquino – forse qualcuno me l’ha sentito dire – spiegava in un “midrash” il problema della Torre di Babele ai suoi “parrocchiani” nella Sinagoga e diceva che per costruire la Torre di Babele c’era voluto molto tempo e molto lavoro, soprattutto nel fare i mattoni… Quando cadeva un mattone era un problema molto grave e il colpevole, quello che aveva trascurato il lavoro e aveva lasciato cadere il mattone, era punito. Quando cadeva un operaio, di quelli che lavoravano nella costruzione, non succedeva niente. Questo è il dramma della seconda forma di incultura: l’uomo creatore di incultura, perché non ha cura dell’ambiente. …La Santa Sede, o quel Paese o quell’altro, potrà fare un bel discorso alle Nazioni Unite, ma se il lavoro non parte dalle periferie verso il centro non ha effetto. Da qui la responsabilità dei Sindaci delle città. Per questo vi ringrazio moltissimo che vi siate riuniti come periferie che prendono molto sul serio questo problema…
LETTERA DI PAPA FRANCESCO per l’istituzione della “Giornata Mondiale di Preghiera per la CURA DEL CREATO” (1° settembre) - (10.08.2015)
Bartolomeo – residente a Istanbul – è primus inter pares tra gli Ortodossi in un paese islamico dove ci sono pochi cristiani, mentre il Patriarca di Mosca, di istituzione ben più recente, è primus su 300 mln di cristiani.
Condividendo con l’amato fratello il Patriarca Ecumenico Bartolomeo le preoccupazioni per il futuro del creato (LS 7-9) … desidero comunicarvi che ho deciso di istituire anche nella Chiesa Cattolica la “Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato”, che, a partire dall’anno corrente, sarà celebrata il 1° settembre, così come già da tempo avviene nella Chiesa Ortodossa. Come cristiani vogliamo offrire il nostro contributo al superamento della crisi ecologica che l’umanità sta vivendo. Per questo dobbiamo prima di tutto attingere dal nostro ricco patrimonio spirituale le motivazioni che alimentano la passione per la cura del creato, ricordando sempre che per i credenti in Gesù Cristo, Verbo di Dio fattosi uomo per noi, «la spiritualità non è disgiunta dal proprio corpo, né dalla natura o dalle realtà di questo mondo, ma piuttosto vive con esse e in esse, in comunione con tutto ciò che li
circonda» (ibid., 216). La crisi ecologica ci chiama dunque ad una profonda conversione spirituale: i cristiani sono chiamati ad una «conversione ecologica che comporta il lasciare emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda» (ibid., 217). Infatti, «vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana» (ibid). L’annuale Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato offrirà ai singoli credenti ed alle comunità la preziosa opportunità di rinnovare la personale adesione alla propria vocazione di custodi del creato , elevando a Dio il ringraziamento per l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura, invocando il suo aiuto per la protezione del creato e la sua misericordia per i peccati commessi contro il mondo in cui viviamo. La celebrazione della Giornata, nella stessa data, con la Chiesa Ortodossa sarà un’occasione proficua per testimoniare la nostra crescente comunione con i fratelli ortodossi. Viviamo in un tempo in cui tutti i cristiani affrontano identiche ed importanti sfide, alle quali, per risultare più credibili ed efficaci, dobbiamo dare risposte comuni. Per questo, è mio auspicio che tale Giornata possa coinvolgere, in qualche modo, anche altre Chiese e Comunità ecclesiali ed essere celebrata in sintonia con le iniziative che il Consiglio Ecumenico delle Chiese promuove su questo tema. …in armonia con le esigenze e le situazioni locali, la celebrazione sia debitamente curata con la partecipazione dell’intero Popolo di Dio: sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli laici. …tale Giornata Mondiale possa diventare segno di un cammino percorso insieme da tutti i credenti in Cristo. Sarà premura inoltre di codesto Dicastero curare il coordinamento con iniziative simili intraprese dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. Mentre auspico la più ampia collaborazione per il migliore avvio e sviluppo della Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, invoco l’intercessione della Madre di Dio Maria Santissima e di san Francesco d’Assisi, il cui Cantico delle Creature ispira tanti uomini e donne di buona volontà a vivere nella lode del Creatore e nel rispetto del creato...
UDIENZA DI PAPA FRANCESCO ai partecipanti al Meeting Internazionale promosso dalla “Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile” su “Giustizia ambientale e cambiamenti climatici”, (11.09.2015)
I cambiamenti climatici hanno gravi implicazioni sociali, perché chi più patisce sono i poveri, quindi la questione del clima è di rilievo per la giustizia.Non si tratta solo di responsabilità dei governanti, ma anche delle singole persone, a seconda del ruolo e del contributo. La discussione deve essere integrale, includendo tutte le parti in causa, comprese quelle che sono tra gli esclusi, tra cui dobbiamo comprendere anche la terra che ben pochi ascoltano. Rispettare l’ambiente come bene COLLETTIVO in base a tre principi…
Illustri Signori e Signore, buongiorno e benvenuti! …ringrazio tutti voi per aver collaborato a questo Meeting internazionale, dedicato a un tema la cui importanza e urgenza non possono essere esagerate. Il clima è un bene comune, oggi gravemente minacciato: lo indicano fenomeni come i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale e l’aumento degli eventi meteorologici estremi. Sono temi oggetto di grande attenzione da parte dei media e dell’opinione pubblica, e attorno ai quali sono in corso accesi dibattiti scientifici e politici, da cui è andato emergendo un consenso diffuso, anche se non unanime. Perché e come occuparcene? Non possiamo dimenticare le gravi implicazioni sociali dei cambiamenti climatici: sono i più poveri a patirne con maggiore durezza le conseguenze! Per questo – come giustamente evidenzia il titolo di questo Meeting – la questione del clima è una questione di giustizia; e anche di solidarietà, che dalla giustizia non va mai separata. È in gioco la dignità di ognuno, come popoli, come comunità, come donne e uomini. La scienza e la tecnologia mettono nelle nostre mani un potere senza precedenti: è nostro dovere, verso l’umanità intera e in particolare verso i più poveri e le generazioni future, utilizzarlo per il bene comune. Riuscirà la nostra generazione a «essere ricordata per aver assunto con generosità le proprie responsabilità»? (LS 165). Pur tra le molte contraddizioni del nostro tempo, abbiamo ragioni sufficienti per alimentare la speranza di riuscire a farlo. E da questa speranza dobbiamo lasciarci guidare. Nell’adempiere questo
impegno, auguro a ciascuno di voi di sperimentare il gusto di partecipare ad azioni che trasmettono vita. La gioia del Vangelo dimora anche qui. In che modo possiamo esercitare la nostra responsabilità, la nostra solidarietà, la nostra dignità di persone e cittadini del mondo? Ognuno è chiamato a rispondere personalmente, nella misura che gli compete in base al ruolo che occupa nella famiglia, nel mondo del lavoro, dell’economia e della ricerca, nella società civile e nelle istituzioni. Non sfoderando improbabili ricette: nessuno le ha! Piuttosto offrendo quanto ha capito al dialogo e accettando che il proprio apporto sia messo in discussione: a tutti è richiesto un contributo in vista di un risultato che non può essere che frutto di un lavoro comune. Il grande nemico qui, è l’ipocrisia. A buon diritto il vostro Meeting rappresenta un esempio della pratica di questo dialogo, che nell’Enciclica Laudato si’ ho proposto come unica via per affrontare i problemi del nostro mondo e cercare soluzioni davvero efficaci. Mi sembra un segno di grande importanza, persino provvidenziale, che a questo Meeting partecipino esponenti di rilievo di “mondi” diversi: la religione e la politica, l’attività economica e la ricerca scientifica in molteplici settori, le organizzazioni internazionali e quelle impegnate nella lotta alla povertà. Per portare frutto, questo dialogo ha bisogno di essere ispirato da una visione tanto trasparente quanto ampia, e di procedere secondo un approccio integrale, ma soprattutto partecipativo, includendo tutte le parti in causa, anche quelle che più facilmente restano ai margini dei processi istituzionali. Rivolgo a tutti un pressante invito a compiere ogni sforzo perché ai tavoli in cui si cerca il modo per risolvere l’unica e complessa crisi socio-ambientale possano far udire la propria voce i più poveri, tra i Paesi e tra gli esseri umani: è anche questo un dovere di giustizia ambientale. Di fronte all’emergenza dei cambiamenti climatici e con lo sguardo rivolto ai cruciali appuntamenti che nei prossimi mesi li affronteranno – l’approvazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile da parte delle Nazioni Unite alla fine di questo mese e soprattutto la COP 21 di Parigi a inizio dicembre –, mi sento di proporre che questo dialogo diventi un’autentica alleanza per arrivare ad accordi ambientali globali realmente significativi. In questo percorso potete contare sul sostegno mio personale e di tutta la Chiesa, a partire da quello, indispensabile, della preghiera. Fin da ora offro al Signore il nostro comune sforzo, chiedendogli di benedirlo perché l’umanità sappia finalmente dare ascolto al grido della terra – oggi la nostra madre terra è tra i tanti esclusi che gridano al Cielo per un aiuto! La nostra madre terra è un’esclusa! –, anche al grido della terra, nostra madre e sorella, e dei più poveri tra coloro che la abitano, e prendersene cura. In questo modo la creazione si avvicinerà sempre di più alla casa comune che l’unico Padre ha immaginato come dono per la famiglia universale delle sue creature.
UDIENZA DI PAPA FRANCESCO ai Ministri dell’Ambiente di Paesi Membri dell’Unione Europea (16.09.2015)
Signore e signori, buongiorno! Saluto cordialmente tutti voi Signori ministri dell’Ambiente dell’Unione Europea, il cui incarico negli ultimi anni ha assunto sempre maggiore importanza per la cura della casa comune. Infatti, l’ambiente è un bene collettivo, patrimonio dell’intera umanità, e responsabilità di ognuno di noi. Una responsabilità che non può che essere trasversale e richiede una efficace collaborazione all’interno dell’intera comunità internazionale… anche in vista degli importanti avvenimenti internazionali dei prossimi mesi: l’adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile alla fine di questo mese e la Cop 21 di Parigi. Vorrei soffermarmi su tre principi. In primo luogo, il principio di solidarietà, parola talvolta dimenticata, altre volte abusata in maniera sterile. Sappiamo che le persone più vulnerabili dal degrado ambientale sono i poveri, che ne patiscono le conseguenze più gravi. Solidarietà vuol dire allora mettere in atto strumenti efficaci, capaci di unire la lotta al degrado ambientale con quella alla povertà. Esistono numerose esperienze positive in tale direzione. Si tratta, ad esempio, di sviluppo e trasferimento di tecnologie appropriate, capaci di utilizzare al meglio risorse umane, naturali, socioeconomiche, maggiormente accessibili a livello locale, in modo da garantire una loro sostenibilità anche nel lungo periodo. In secondo luogo, il principio di giustizia. Nell’enciclica “Laudato si’” ho parlato di “debito ecologico”, soprattutto tra Nord e Sud, connesso a squilibri commerciali con conseguenze in ambito ecologico, come pure all’uso sproporzionato delle risorse naturali compiuto storicamente da alcuni Paesi. Dobbiamo onorare
questo debito. Questi ultimi sono chiamati a contribuire, a risolvere questo debito dando il buon esempio, limitando in modo importante il consumo di energia non rinnovabile, apportando risorse ai Paesi più bisognosi per promuovere politiche e programmi di sviluppo sostenibile, adottando sistemi di gestione adeguata delle foreste, del trasporto, dei rifiuti, affrontando seriamente il grave problema dello spreco del cibo, favorendo un modello circolare dell’economia, incoraggiando nuovi atteggiamenti e stili di vita. In terzo luogo, il principio di partecipazione, che richiede il coinvolgimento di tutte le parti in causa, anche quelle che spesso rimangono al margine dei processi decisionali. Viviamo infatti in un momento storico molto interessante: da una parte la scienza e la tecnologia mettono nelle nostre mani un potere senza precedenti; dall’altra, il corretto uso di tale potere presuppone l’adozione di una visione più integrale e integrante. Ciò richiede di aprire le porte ad un dialogo, dialogo ispirato da tale visione radicata in quella ecologia integrale, che è oggetto dell’enciclica “Laudato si’”. Si tratta ovviamente di una grande sfida culturale, spirituale ed educativa. Solidarietà, giustizia e partecipazione per rispetto della nostra dignità e per rispetto del creato. …Da parte mia e della Santa Sede non mancherà il sostegno per rispondere adeguatamente tanto al grido della Terra quanto al grido dei poveri. Grazie.
INCONTRO DI PAPA FRANCESCO CON I MEMBRI DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU - New York, 25 settembre 2015
Il compito delle Nazioni Unite, a partire dai postulati del Preambolo e dei primi articoli della sua Carta costituzionale, può essere visto come lo sviluppo e la promozione della sovranità del diritto, sapendo che la giustizia è requisito indispensabile per realizzare l’ideale della fraternità universale. In questo contesto, è opportuno ricordare che la limitazione del potere è un’idea implicita nel concetto di diritto. Dare a ciascuno il suo, secondo la definizione classica di giustizia, significa che nessun individuo o gruppo umano si può considerare onnipotente, autorizzato a calpestare la dignità e i diritti delle altre persone singole o dei gruppi sociali. La distribuzione di fatto del potere (politico, economico, militare, tecnologico, ecc.) tra una pluralità di soggetti e la creazione di un sistema giuridico di regolamentazione delle rivendicazioni e degli interessi, realizza la limitazione del potere. Oggi il panorama mondiale ci presenta, tuttavia, molti falsi diritti, e – nello stesso tempo – ampi settori senza protezione, vittime piuttosto di un cattivo esercizio del potere: l’ambiente naturale e il vasto mondo di donne e uomini esclusi. Due settori intimamente uniti tra loro, che le relazioni politiche ed economiche preponderanti hanno trasformato in parti fragili della realtà. Per questo è necessario affermare con forza i loro diritti, consolidando la protezione dell’ambiente e ponendo termine all’esclusione. Anzitutto occorre affermare che esiste un vero “diritto dell’ambiente” per una duplice ragione. In primo luogo perché come esseri umani facciamo parte dell’ambiente. Viviamo in comunione con esso, perché l’ambiente stesso comporta limiti etici che l’azione umana deve riconoscere e rispettare. L’uomo, anche quando è dotato di «capacità senza precedenti» che «mostrano una singolarità che trascende l’ambito fisico e biologico» (LS 81), è al tempo stesso una porzione di tale ambiente. Possiede un corpo formato da elementi fisici, chimici e biologici, e può sopravvivere e svilupparsi solamente se l’ambiente ecologico gli è favorevole. Qualsiasi danno all’ambiente, pertanto, è un danno all’umanità. In secondo luogo, perché ciascuna creatura, specialmente gli esseri viventi, ha un valore in sé stessa, di esistenza, di vita, di bellezza e di interdipendenza con le altre creature. Noi cristiani, insieme alle altre religioni monoteiste, crediamo che l’universo proviene da una decisione d’amore del Creatore, che permette all’uomo di servirsi rispettosamente della creazione per il bene dei suoi simili e per la gloria del Creatore, senza però abusarne e tanto meno essendo autorizzato a distruggerla. Per tutte le credenze religiose l’ambiente è un bene fondamentale (cfr ibid., 81). L’abuso e la distruzione dell’ambiente, allo stesso tempo, sono associati ad un inarrestabile processo di esclusione. In effetti, una brama egoistica e illimitata di potere e di benessere materiale, conduce tanto ad abusare dei mezzi materiali disponibili quanto ad escludere i deboli e i meno abili, sia per il fatto di avere abilità diverse (portatori di handicap), sia perché sono privi delle conoscenze e degli strumenti tecnici adeguati o possiedono un’insufficiente capacità di decisione politica. L’esclusione economica e sociale è una negazione totale della fraternità umana e un gravissimo attentato ai diritti umani e all’ambiente . I più poveri sono quelli che soffrono maggiormente questi attentati per un triplice, grave motivo: sono scartati dalla società, sono nel medesimo tempo obbligati a vivere di scarti e devono ingiustamente
soffrire le conseguenze dell’abuso dell’ambiente. Questi fenomeni costituiscono oggi la tanto diffusa e incoscientemente consolidata “cultura dello scarto”. La drammaticità di tutta questa situazione di esclusione e di in-equità, con le sue chiare conseguenze, mi porta, insieme a tutto il popolo cristiano e a tanti altri, a prendere coscienza anche della mia grave responsabilità al riguardo, per cui alzo la mia voce, insieme a quella di tutti coloro che aspirano a soluzioni urgenti ed efficaci. L’adozione della “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” durante il Vertice mondiale che inizierà oggi stesso, è un importante segno di speranza. Confido anche che la Conferenza di Parigi sul cambiamento climatico raggiunga accordi fondamentali ed effettivi. Non sono sufficienti, tuttavia, gli impegni assunti solennemente, benché costituiscano certamente un passo necessario verso la soluzione dei problemi. La definizione classica di giustizia alla quale ho fatto riferimento anteriormente contiene come elemento essenziale una volontà costante e perpetua: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Il mondo chiede con forza a tutti i governanti una volontà effettiva, pratica, costante, fatta di passi concreti e di misure immediate, per preservare e migliorare l’ambiente naturale e vincere quanto prima il fenomeno dell’esclusione sociale ed economica, con le sue tristi conseguenze di tratta degli esseri umani, commercio di organi e tessuti umani, sfruttamento sessuale di bambini e bambine, lavoro schiavizzato, compresa la prostituzione, traffico di droghe e di armi, terrorismo e crimine internazionale organizzato. …La crisi ecologica, insieme alla distruzione di buona parte della biodiversità, può mettere in pericolo l’esistenza stessa della specie umana. Le nefaste conseguenze di un irresponsabile malgoverno dell’economia mondiale, guidato unicamente dall’ambizione di guadagno e di potere, devono costituire un appello a una severa riflessione sull’uomo: «L’uomo non si crea da solo. È spirito e volontà, però anche natura» (Benedetto XVI, 2011; citato in LS 6). …Perciò, la difesa dell’ambiente e la lotta contro l’esclusione esigono il riconoscimento di una legge morale inscritta nella stessa natura umana, che comprende la distinzione naturale tra uomo e donna (LS 155) e il rispetto assoluto della vita in tutte le sue fasi e dimensioni (LS 123; 136). …La guerra è la negazione di tutti i diritti e una drammatica aggressione all’ambiente. Se si vuole un autentico sviluppo umano integrale per tutti, occorre proseguire senza stancarsi nell’impegno di evitare la guerra tra le nazioni e tra i popoli. A tal fine bisogna assicurare il dominio incontrastato del diritto e l’infaticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici e all’arbitrato, come proposto dalla Carta delle Nazioni Unite, vera norma giuridica fondamentale. L’esperienza dei 70 anni di esistenza delle Nazioni Unite, in generale, e in particolare l’esperienza dei primi 15 anni del terzo millennio, mostrano tanto l’efficacia della piena applicazione delle norme internazionali come l’inefficacia del loro mancato adempimento. Se si rispetta e si applica la Carta delle Nazioni Unite con trasparenza e sincerità, senza secondi fini, come un punto di riferimento obbligatorio di giustizia e non come uno strumento per mascherare intenzioni ambigue, si ottengono risultati di pace. Quando, al contrario, si confonde la norma con un semplice strumento da utilizzare quando risulta favorevole e da eludere quando non lo è, si apre un vero vaso di Pandora di forze incontrollabili, che danneggiano gravemente le popolazioni inermi, l’ambiente culturale, e anche l’ambiente biologico. …La casa comune di tutti gli uomini deve continuare a sorgere su una retta comprensione della fraternità universale e sul rispetto della sacralità di ciascuna vita umana, di ciascun uomo e di ciascuna donna; dei poveri, degli anziani, dei bambini, degli ammalati, dei non nati, dei disoccupati, degli abbandonati, di quelli che vengono giudicati scartabili perché li si considera nient’altro che numeri di questa o quella statistica. La casa comune di tutti gli uomini deve edificarsi anche sulla comprensione di una certa sacralità della natura creata.
APPENDICE
Cantico delle creature di san Francesco d’Assisi
Altissimu, onnipotente bon Signore, Tue so’ le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione. Ad Te solo, Altissimo, se konfano, et nullu homo ène dignu te mentovare. Laudato sie, mi’ Signore cum tucte le Tue creature, spetialmente messor lo frate Sole, lo qual è iorna, et allumeni noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: de Te, Altissimo, porta significatione. Laudato si’, mi Signore, per sora Luna e le stelle: in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle. Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento. Laudato si’, mi’ Signore, per sor Aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. Laudato si’, mi Signore, per frate Focu, per lo quale ennallumini la nocte: ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. Laudato si’, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore et sostengono infirmitate et tribulatione. Beati quelli ke ’l sosterranno in pace, ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. Laudato si’ mi Signore, per sora nostra Morte corporale, da la quale nullu homo vivente po’ skappare: guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati, ka la morte secunda no ’l farrà male. Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate e serviateli cum grande humilitate
Consigli dell’ENI per il risparmio energetico (cf http://www.30percento.it/consigli/24/index.htm)
IN CASA: PICCOLI GESTI QUOTIDIANI 1. Non lasciare gli elettrodomestici in stand-by 2. Usare lampadine a basso consumo 3. Installare i riduttori di flusso dell’acqua 4. Installare valvole termostatiche sui termosifoni 5. Usare la lavatrice a temperature basse (40/60ºC) 6. Usare la lavastoviglie solo a pieno carico 7. Isolare il cassonetto degli avvolgibili 8. Non utilizzare l’asciugatura ad aria calda nella lavastoviglie RISPARMIARE ACQUISTANDO APPARECCHI EFFICIENTI 9. Sostituire il vecchio frigorifero con uno nuovo più efficiente 10. Sostituire la vecchia lavatrice con una nuova più efficiente 11. Sostituire lo scaldabagno elettrico con uno a gas 12. Scegliere una caldaia più efficiente LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA 13. D’inverno tenere in casa una temperatura di 20º C 14. D’estate ridurre l’uso del condizionatore in casa 15. Usare correttamente l’aria condizionata in auto ALLA GUIDA 16. Mantenere una velocità moderata in autostrada 17. Mantenere un’andatura regolare in città 18. Utilizzare le marce alte 19. Evitare di riscaldare il motore a veicolo fermo PICCOLA MANUTENZIONE DELL’AUTO 20. Controllare la pressione dei pneumatici almeno una volta al mese 21. Scegliere gomme "Fuel Saver" 22. Scegliere lubrificanti "Fuel Economy" 23. Non usare accessori che penalizzino l’aerodinamica dell’auto 24. Evitare carichi superflui in auto
R. CANTALAMESSA, «Il primo talento», Omelia per la prima Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato - (1/09/2015)
Dio li benedisse e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra» (Gen 1,28). Queste parole hanno suscitato in tempi recenti una forte critica. Esse, ha scritto qualcuno, attribuendo all’uomo un dominio indiscriminato sul resto della natura, sono all’origine dell’attuale crisi ecologica. Viene rovesciato il rapporto del mondo antico, soprattutto dei greci, che vedeva l’uomo in funzione del cosmo, e non il cosmo in funzione dell’uomo. Io credo che questa critica, come tante analoghe mosse al testo biblico, parta dal fatto che si interpretano le parole della Bibbia alla luce di categorie secolari ad essa estranee. “Dominate”, non ha qui il significato che la parola ha fuori della Bibbia. Per la Bibbia, il modello ultimo del dominus, del signore, non è il sovrano politico che sfrutta i suoi sudditi, ma è Dio
stesso, Signore e padre. Il dominio di Dio sulle creature non è certo finalizzato al proprio interesse, ma a quello delle creature che egli crea e custodisce. C’è un parallelismo evidente: come Dio è il dominus dell’uomo, così l’uomo deve essere il dominus del resto del creato, cioè responsabile di esso e suo custode. L’uomo è creato perché sia «ad immagine e somiglianza di Dio», non di padroni umani. Il senso del dominio dell’uomo è esplicitato da ciò che segue poco dopo nel testo: «Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gen 2,15). …La fede in un Dio creatore e nell’uomo fatto a immagine di Dio, non è dunque una minaccia, ma piuttosto una garanzia per il creato, e la più forte di tutte. Dice che l’uomo non è padrone assoluto delle altre creature; deve rendere conto di quello che ha ricevuto. La parabola dei talenti ha qui la sua applicazione primordiale: la terra è il talento che tutti insieme abbiamo ricevuto e di cui dobbiamo rendere conto. L’idea di un rapporto idillico tra l’uomo e il cosmo, fuori della Bibbia, oltre tutto, è una invenzione letteraria. L’opinione dominante tra i filosofi pagani del tempo tendeva a fare del mondo materiale, sulla scia di Platone, il prodotto di un dio di secondo rango (il Deuteros theos, o Demiurgo), o addirittura, come dirà Marcione, opera di un dio cattivo, diverso dal Dio rivelato da Gesù Cristo. L’anelito era liberarsi dalla materia, non liberare la materia. Una visione, questa, che al tempo di Francesco d’Assisi riviveva nell’eresia dei catari. …Accanto alla grande affermazione che uomini e cose provengono da un unico principio, il racconto biblico mette in luce, questo sì, una gerarchia di importanza che è la gerarchia stessa della vita e che vediamo inscritta in tutta la natura. Il minerale serve al vegetale che di esso si nutre, il vegetale serve all’animale (è il bue che mangia l’erba non il contrario!), e tutti tre servono alla creatura razionale che è l’uomo. Questa gerarchia è per la vita, non contro di essa. Essa viene violata, per esempio, quando si fanno spese pazze per degli animali (e non certo per quelli in pericolo di estinzione!), mentre si lasciano morire di fame e di malattie milioni di bambini sotto i propri occhi. Qualcuno vorrebbe abolire del tutto la gerarchia tra gli esseri, posta dalla Bibbia e insita nella natura. Ci si è spinti addirittura a ipotizzare e auspicare un universo futuro senza più la presenza in esso della specie umana, ritenuta dannosa per il resto del creato. La si chiama “ecologia profonda” (è il caso del sito internet VHEMT - Voluntary human extinction movement). Ma questo è chiaramente un nonsenso. …Come è rasserenante, in questo contesto, riascoltare le parole del salmo 8 che vogliamo far nostre in questa veglia di preghiera: «Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi? Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi: tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!». Passiamo ora al brano evangelico che abbiamo ascoltato: «Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo... Osservate come crescono i gigli del campo. Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?” ... Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena» (Mt 6,25-34). Qui le obiezioni umane diventano un coro di protesta. Non preoccuparsi del domani? Ma non è proprio quello che si propone l’ecologismo e che Papa Francesco fa in tutta la sua enciclica Laudato si’? …quelle parole di Gesù oggi parlano anche a tutti noi. Dicono: non preoccupatevi del vostro domani, ma preoccupatevi del domani di quelli che verranno dopo di voi! Non chiedetevi: «Che mangeremo? Che berremo? Che vestiremo?». Chiedetevi piuttosto: «Che mangeranno? Che berranno? Che vestiranno i nostri figli, i futuri abitatori di questo pianeta?». …Purtroppo questa massima del “vivere e lasciar morire” è quella che nessuno pronuncia, ma molti praticano nella realtà. Gesù, in più occasioni, si preoccupa di dare lui stesso da mangiare alla gente, moltiplicando il pane e i pesci, e alla fine dice di raccogliere i pezzi avanzati «perché nulla vada disperso» (Gv 6,12). Una parola che bisognerebbe adottare come motto contro lo spreco, soprattutto in campo alimentare. In realtà, il brano evangelico mette la scure alla radice — la stessa scure alla stessa radice a cui la mette Papa Francesco nella sua enciclica. Lo fa quando dice all’inizio del brano: «Non potete servire Dio e la ricchezza». Nessuno può servire seriamente la causa della salvaguardia del creato se non ha il coraggio di puntare il dito contro l’accumulo di ricchezze esagerate nelle mani di pochi e contro il denaro che ne è la misura. Sia chiaro: Gesù non ha mai condannato la ricchezza per se stessa. …Quella che Gesù condanna è «la ricchezza disonesta» (Lc 16,9), la ricchezza accumulata a spese del prossimo… Francesco d’Assisi …Il suo amore per le creature è una conseguenza diretta della sua fede nella paternità universale di Dio. …Il suo è un ecologismo puro dagli scopi utilitaristici, per quanto legittimi, che abbiamo noi oggi. …Le parole del santo che definisce bello il sole, bello fratello fuoco, chiarite e belle le
stelle, sono l’eco di quel «E Dio vide che tutto era bello», del racconto della creazione. …La Chiesa ci mette sulle labbra le parole per farlo quando, nel Gloria della Messa, ci fa dire: «Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa». «I cieli e la terra — dice spesso la Scrittura — sono pieni della sua gloria». …Quanto ha dovuto attendere l’universo, quale lunga rincorsa ha dovuto prendere, per giungere a questo punto! Milioni e miliardi di anni, durante i quali la materia, attraverso la sua opacità, avanzava faticosamente verso la luce della coscienza, come la linfa che dal sottosuolo sale verso la cima dell’albero per espandersi in fiore e frutto. Questa coscienza fu finalmente raggiunta, quando comparve nell’universo «il fenomeno umano». Ma ora che l’universo ha raggiunto il suo traguardo, esige che l’uomo compia il suo dovere, che assuma, per così dire, la direzione del coro e intoni per tutti il «Gloria a Dio nell’alto dei cieli!». Francesco ci addita la strada per un cambiamento radicale nel nostro rapporto con il creato: essa consiste nel sostituire al possesso la contemplazione. Egli ha scoperto un modo diverso di godere delle cose che è quello di contemplarle, anziché possederle. Può gioire di tutte le cose, perché ha rinunciato a possederne alcuna. …Francesco canta la bellezza delle creature quando non è più in grado di vedere nessuna di esse e anzi la semplice luce del sole o del fuoco gli procura atroci dolori! Il possesso esclude, la contemplazione include; il possesso divide, la contemplazione moltiplica. Uno solo può possedere un lago, un parco, e così tutti gli altri ne sono esclusi; migliaia possono contemplare quello stesso lago o parco, e tutti ne godono senza sottrarlo ad alcuno. Si tratta di un possesso più vero e profondo, un possedere dentro, non fuori, con l’anima, non solo con il corpo. …L’esempio di Francesco d’Assisi dimostra che l’atteggiamento religioso e dossologico nei confronti del creato non è senza conseguenze pratiche e operative …Raccoglie perfino dalla strada i piccoli vermi, perché non siano calpestati …Anche noi dovremmo proporci: non voglio essere ladro di risorse, usandone più del dovuto e sottraendole così a chi verrà dopo di me. Certo, Francesco non aveva la visione globale e planetaria del problema ecologico, ma una visione locale, immediata. Pensava a quello che poteva fare lui ed eventualmente i suoi frati. Anche in questo però egli ci insegna qualcosa. Uno slogan oggi molto di moda dice: Think globally, act locally, pensa globalmente, ma agisci localmente. …La salvaguardia del creato, come la pace, si fa, direbbe il nostro Santo Padre Francesco, “artigianalmente”, cominciando subito da se stessi. La pace incomincia da te, …Penso che se (San Francesco) vivesse oggi egli aggiungerebbe un’altra strofa ancora al suo cantico: Laudato sii, mi Signore, per tutti quelli che lavorano per proteggere nostra sorella madre Terra…
ECOLOGIA Integrale
È un corso monografico, cioè di approfondimento tematico. Quindi non c’è un vincolo di programma così stretto, bensì una certa elasticità. Corso monografico di Teologia Morale. L’argomento prescelto è l’ecologia (oikos = casa, ambiente; logos = discorso, studio), in riferimento all’enciclica di papa Francesco, Laudato sii. “Integrale” perché ci sono tanti modelli di ecologia che affondano le loro radici in altrettanti modelli antropologici. Un conto è pensare che l’uomo sia un intralcio allo sviluppo ambientale, altro è pensare che l’uomo sia il vertice della natura e dunque tutti sia in funzione sua.
LAUDATO SI’Lettera enciclica del santo padre Francesco sulla cura della casa comune (24 maggio 2015)
Introduzione (1-16)Capitolo PRIMO - QUELLO CHE STA ACCADENDO ALLA NOSTRA CASA (17-61)Capitolo SECONDO - IL VANGELO DELLA CREAZIONE (62-100)Capitolo TERZO - LA RADICE UMANA DELLA CRISI ECOLOGICA (101-136)Capitolo QUARTO - UN’ECOLOGIA INTEGRALE (137-162)Capitolo QUINTO - ALCUNE LINEE DI ORIENTAMENTO E DI AZIONE (163-201)Capitolo SESTO - EDUCAZIONE E SPIRITUALITÀ ECOLOGICA (202-246)
Introduzione“Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra” (1)Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori (2)
La continuità con i precedenti pontificati:- Giovanni XXIII si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà (Pacem in Terris)- Paolo VI parla di “sfruttamento sconsiderato della natura”- Giovanni Paolo II richiama più volte a una “autentica ecologia umana”- Benedetto XVI ha messo in guardia dal considerare la natura “semplicemente proprietà
nostra”
Il Patriarca Ecumenico Bartolomeo: un crimine contro la natura è un crimine contro noi stessi e un peccato contro Dio (8)
Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. (…) l’ecologia integrale richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano con l’essenza dell’umano. (…) ci propone di riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà (10-12)
La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale (13)
Il percorso della LSIn primo luogo, farò un breve percorso attraverso vari aspetti dell’attuale crisi ecologica (…). A partire da questa panoramica, riprenderò alcune argomentazioni che scaturiscono dalla tradizione giudeo-cristiana, al fine di dare maggiore coerenza al nostro impegno per l’ambiente. Poi proverò ad arrivare alle radici della situazione attuale, in modo da coglierne non solo i sintomi ma anche le cause più profonde. Così potremo proporre un’ecologia che (…) integri il posto specifico che l’essere umano occupa in questo mondo (…), alcune ampie linee di dialogo e di azione (…).
Infine, un cammino educativo, (…) alcune linee di maturazione umana ispirate al tesoro dell’esperienza spirituale cristiana (15)
I temi principali della LS…alcuni assi portanti (…) attraversano tutta l’Enciclica. Per esempio: l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta; la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso; la critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia; l’invito a cercare altri modi di intendere l’economia e il progresso; il valore proprio di ogni creatura; il senso umano dell’ecologia; la necessità di dibattiti sinceri e onesti; la grave responsabilità della politica internazionale e locale; la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita. Questi temi non vengono mai chiusi o abbandonati, ma anzi costantemente ripresi e arricchiti (16)
LAUDATO SII – Enciclica di papa Francesco
1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella… 2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che «geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora.
Niente di questo mondo ci risulta indifferente 3. Più di cinquant’anni fa, mentre il mondo vacillava sull’orlo di una crisi nucleare, il santo Papa Giovanni XXIII …diresse il suo messaggio Pacem in terris a tutto il “mondo cattolico”, ma aggiungeva «nonché a tutti gli uomini di buona volontà». Adesso, di fronte al deterioramento globale dell’ambiente, voglio rivolgermi a ogni persona che abita questo pianeta. …In questa Enciclica, mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune. 4. …nel 1971, il beato Papa Paolo VI si riferì alla problematica ecologica, presentandola come una crisi che è «una conseguenza drammatica» dell’attività incontrollata dell’essere umano: «Attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura, egli rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione». Parlò anche alla FAO della possibilità, «sotto l’effetto di contraccolpi della civiltà industriale, di […] una vera catastrofe ecologica», sottolineando «l’urgenza e la necessità di un mutamento radicale nella condotta dell’umanità», perché «i progressi scientifici più straordinari, le prodezze tecniche più strabilianti, la crescita economica più prodigiosa, se non sono congiunte ad un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono, in definitiva, contro l’uomo». 5. San Giovanni Paolo II si è occupato di questo tema con un interesse crescente. Nella sua prima Enciclica, osservò che l’essere umano sembra «non percepire altri significati del suo ambiente naturale, ma solamente quelli che servono ai fini di un immediato uso e consumo». Successivamente invitò ad una conversione ecologica globale. Ma nello stesso tempo fece notare che si mette poco impegno per «salvaguardare le condizioni morali di un’autentica ecologia umana».La distruzione dell’ambiente umano è qualcosa di molto serio, non solo perché Dio ha affidato il mondo all’essere umano, bensì perché la vita umana stessa è un dono che deve essere protetto da diverse forme di degrado. …L’autentico sviluppo umano possiede un carattere morale e presuppone il pieno rispetto della persona umana, ma deve prestare attenzione anche al mondo naturale e «tener conto della natura di ciascun essere e della sua mutua connessione in un sistema ordinato». Pertanto, la capacità dell’essere umano di trasformare la realtà deve svilupparsi sulla base della prima originaria donazione delle cose da parte di Dio.6. Il mio predecessore Benedetto XVI ha rinnovato l’invito a «eliminare le cause strutturali delle disfunzioni dell’economia mondiale e [...] correggere i modelli di crescita che sembrano incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente». Ha ricordato che il mondo non può essere analizzato solo isolando uno dei suoi aspetti, perché «il libro della natura è uno e indivisibile» e include l’ambiente, la vita, la sessualità, la famiglia, le relazioni sociali, e altri aspetti. …Anche l’ambiente sociale ha le sue ferite. Ma tutte sono causate in fondo dal medesimo male, cioè dall’idea che non esistano verità indiscutibili che guidino la nostra vita, per cui la libertà umana non ha limiti. Si dimentica che «l’uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé. L’uomo non crea se stesso. Egli è spirito e volontà, ma è anche natura» ...
Uniti da una stessa preoccupazione 7. Questi contributi dei Papi raccolgono la riflessione di innumerevoli scienziati, filosofi, teologi e organizzazioni sociali che hanno arricchito il pensiero della Chiesa su tali questioni. Non possiamo però ignorare che anche al di fuori
della Chiesa Cattolica, altre Chiese e Comunità cristiane – come pure altre religioni – hanno sviluppato una profonda preoccupazione e una preziosa riflessione su questi temi che stanno a cuore a tutti noi. Per citare solo un esempio particolarmente significativo, voglio riprendere brevemente parte del contributo del caro Patriarca Ecumenico Bartolomeo, con il quale condividiamo la speranza della piena comunione ecclesiale. 8. Il Patriarca Bartolomeo si è riferito particolarmente alla necessità che ognuno si penta del proprio modo di maltrattare il pianeta, perché «nella misura in cui tutti noi causiamo piccoli danni ecologici», siamo chiamati a riconoscere «il nostro apporto, piccolo o grande, allo stravolgimento e alla distruzione dell’ambiente». Su questo punto, egli si è espresso ripetutamente in maniera ferma e stimolante, invitandoci a riconoscere i peccati contro la creazione… Perché «un crimine contro la natura è un crimine contro noi stessi e un peccato contro Dio».9. Allo stesso tempo Bartolomeo ha richiamato l’attenzione sulle radici etiche e spirituali dei problemi ambientali, che ci invitano a cercare soluzioni non solo nella tecnica, ma anche in un cambiamento dell’essere umano, perché altrimenti affronteremmo soltanto i sintomi. Ci ha proposto di passare dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di condividere, in un’ascesi che «significa imparare a dare, e non semplicemente a rinunciare. È un modo di amare, di passare gradualmente da ciò che io voglio a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio. È liberazione dalla paura, dall’avidità e dalla dipendenza… È nostra umile convinzione che il divino e l’umano si incontrino nel più piccolo dettaglio della veste senza cuciture della creazione di Dio, persino nell’ultimo granello di polvere del nostro pianeta».
San Francesco d’Assisi 10. …Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. È il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell’ecologia, amato anche da molti che non sono cristiani. …In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore. 11. La sua testimonianza ci mostra anche che l’ecologia integrale richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano con l’essenza dell’umano. Così come succede quando ci innamoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature. Egli entrava in comunicazione con tutto il creato… Il suo discepolo san Bonaventura narrava che lui, «considerando che tutte le cose hanno un’origine comune, si sentiva ricolmo di pietà ancora maggiore e chiamava le creature, per quanto piccole, con il nome di fratello o sorella». …Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera spontanea. La povertà e l’austerità di san Francesco non erano un ascetismo solamente esteriore, ma qualcosa di più radicale: una rinuncia a fare della realtà un mero oggetto di uso e di dominio. 12. D’altra parte, san Francesco, fedele alla Scrittura, ci propone di riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà: «Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si contempla il loro autore» (Sap 13,5) …Il mondo è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode.
Il mio appello 13. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. …I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi. 14. Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. Il movimento ecologico mondiale ha già percorso un lungo e ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che hanno favorito una presa di coscienza. Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. …Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità. 15. Spero che questa Lettera enciclica, che si aggiunge al Magistero sociale della Chiesa, ci aiuti a riconoscere la grandezza, l’urgenza e la bellezza della sfida che ci si presenta. In primo luogo, farò un breve percorso attraverso vari aspetti dell’attuale crisi ecologica allo scopo di …dare una base di concretezza al percorso etico e spirituale che segue. A partire da questa panoramica, riprenderò alcune argomentazioni che scaturiscono dalla tradizione giudeo-cristiana, al fine di dare maggiore coerenza al nostro impegno per l’ambiente. Poi proverò ad arrivare alle radici della situazione attuale, in modo da coglierne non solo i sintomi ma anche le cause più profonde. Così potremo proporre un’ecologia
che, nelle sue diverse dimensioni, integri il posto specifico che l’essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo circonda. Alla luce di tale riflessione vorrei fare un passo avanti in alcune ampie linee di dialogo e di azione che coinvolgano sia ognuno di noi, sia la politica internazionale. Infine, poiché sono convinto che ogni cambiamento ha bisogno di motivazioni e di un cammino educativo, proporrò alcune linee di maturazione umana ispirate al tesoro dell’esperienza spirituale cristiana. 16. Ogni capitolo, sebbene abbia una sua tematica propria e una metodologia specifica, riprende a sua volta, da una nuova prospettiva, questioni importanti affrontate nei capitoli precedenti. Questo riguarda specialmente alcuni assi portanti che attraversano tutta l’Enciclica. Per esempio: l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta; la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso; la critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia; l’invito a cercare altri modi di intendere l’economia e il progresso; il valore proprio di ogni creatura; il senso umano dell’ecologia; la necessità di dibattiti sinceri e onesti; la grave responsabilità della politica internazionale e locale; la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita. Questi temi non vengono mai chiusi o abbandonati, ma anzi costantemente ripresi e arricchiti.
CAPITOLO PRIMO - QUELLO CHE STA ACCADENDO ALLA NOSTRA CASA
I. INQUINAMENTO E CAMBIAMENTI CLIMATICIII. LA QUESTIONE DELL’ACQUAIII. PERDITA DI BIODIVERSITÀIV. DETERIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA UMANA E DEGRADAZIONE SOCIALEV. INEQUITÀ PLANETARIAVI. LA DEBOLEZZA DELLE REAZIONIVII. DIVERSITÀ DI OPINIONI
Metodo e premesseLe riflessioni teologiche o filosofiche sulla situazione dell’umanità e del mondo possono suonare come un messaggio ripetitivo e vuoto, se non si presentano nuovamente a partire da un confronto con il contesto attuale (17)Gli obiettivi di questo cambiamento veloce e costante non necessariamente sono orientati al bene comune e a uno sviluppo umano, sostenibile e integrale (18) (…) matura una sincera e dolorosa preoccupazione per ciò che sta accadendo al nostro pianeta. (…) L’obiettivo non è di raccogliere informazioni o saziare la nostra curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza (…) e così riconoscere qual è il contributo che ciascuno può portare (19)
I. INQUINAMENTO E CAMBIAMENTI CLIMATICI
Esistono forme di inquinamento che colpiscono quotidianamente le persone (20) inquinando aria, terra, acqua. La terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizia” (21). Questi problemi sono intimamente legati alla cultura dello scarto, che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura. (…) il funzionamento degli ecosistemi naturali è esemplare (…). Al contrario, il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie (22).
Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. (…) siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. (…) L’umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità di cambiamenti di stili di vita, di produzione e di consumo, per combattere questo riscaldamento o, almeno, le cause umane che lo producono o lo accentuano (23) Se la tendenza attuale continua, questo secolo potrebbe essere testimone di cambiamenti climatici inauditi e di una distruzione senza precedenti degli ecosistemi, con gravi conseguenze per tutti noi (24).Molti di coloro che detengono più risorse e potere economico o politico sembrano concentrarsi soprattutto nel mascherare i problemi o nasconderne i sintomi, cercando solo di ridurre alcuni impatti negativi di cambiamenti climatici (26).
II. LA QUESTIONE DELL’ACQUA
L’acqua potabile e pulita rappresenta una questione di primaria importanza, perché è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici (28)Un problema particolarmente serio è quello della qualità dell’acqua disponibile per i poveri, che provoca molte morti ogni giorno. Fra i poveri sono frequenti le malattie legate all’acqua, incluse quelle causate da microorganismi e da sostanze chimiche (29)(…) in alcuni luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato. In realtà, l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale. (…) è prevedibile che il controllo dell’acqua da parte di grandi imprese mondiali si trasformi in una delle principali fonti di conflitto di questo secolo (30-31)
III. PERDITA DI BIODIVERSITÀ
Ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali e animali (…). La stragrande maggioranza si estingue per ragioni che hanno a che fare con qualche attività umana (33)Quando si analizza l’impatto ambientale di qualche iniziativa economica (…) non sempre si include uno studio attento dell’impatto sulla biodiversità, come se la perdita di alcune specie o di gruppi animali o vegetali fosse qualcosa di poco rilevante (35)
La cura degli ecosistemi richiede uno sguardo che vada aldilà dell’immediato, perché quando si cerca solo un profitto economico rapido e facile, a nessuno interessa veramente la loro preservazione (36)Ci sono luoghi che richiedono una cura particolare a motivo della loro enorme importanza per l’ecosistema mondiale (…). Ricordiamo, per esempio, quei polmoni del pianeta colmi di biodiversità che sono l’Amazzonia e il bacino fluviale del Congo, o le grandi falde acquifere e i ghiacciai. (…) la vita nei fiumi, nei laghi, nei mari e negli oceani, che nutre gran parte della popolazione mondiale, si vede colpita dal prelievo incontrollato delle risorse ittiche, che provoca diminuzioni drastiche di alcune specie (37-38.40-41)Poiché tutte le creature sono connesse tra loro, di ognuna dev’essere riconosciuto il valore con affetto e ammirazione, e tutti noi esseri creati abbiamo bisogno gli uni degli altri (42)
IV. DETERIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA UMANA E DEGRADAZIONE SOCIALE
(…) non possiamo tralasciare di considerare gli effetti del degrado ambientale, dell’attuale modello di sviluppo e della cultura dello scarto sulla vita delle persone (43)Tra le componenti sociali del cambiamento globale si includono gli effetti occupazionali di alcune innovazioni tecnologiche, l’esclusione sociale, la disuguaglianza nella disponibilità e nel consumo dell’energia e di altri servizi, la frammentazione sociale, l’aumento della violenza e il sorgere di nuove forme di aggressività sociale, il narcotraffico e il consumo crescente di droghe fra i più giovani, la perdita di identità (46) (…) le relazioni reali con gli altri, con tutte le sfide che implicano, tendono ad essere sostituite da un tipo di comunicazione mediata da internet. (…) e così si genera spesso un nuovo tipo di emozioni artificiali, che hanno a che vedere più con dispositivi e schermi che con le persone e la natura (47)
V. INEQUITÀ PLANETARIA
L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme (48)(…) un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri (49)Invece di risolvere i problemi dei poveri e pensare a un mondo diverso, alcuni si limitano a proporre una riduzione della natalità. Non mancano pressioni internazionali sui Paesi in via di sviluppo che condizionano gli aiuti economici a determinate politiche di “salute riproduttiva”. (…) la crescita demografica è pienamente compatibile con uno sviluppo integrale e solidale (50)
L’inequità (…) obbliga a pensare ad un’etica delle relazioni internazionali. C’è infatti un vero “debito ecologico”, soprattutto tra il Nord e il Sud, connesso a squilibri commerciali con conseguenze in ambito ecologico, come pure all’uso sproporzionato delle risorse naturali compiuto storicamente da alcuni Paesi (51)
È necessario che i Paesi sviluppati contribuiscano a risolvere questo debito limitando in modo importante il consumo di energia non rinnovabile, e apportando risorse ai Paesi più bisognosi per promuovere politiche e programmi di sviluppo sostenibile. (…) Bisogna rafforzare la consapevolezza che siamo una sola famiglia umana (52)
VI. LA DEBOLEZZA DELLE REAZIONI
Queste situazioni provocano i gemiti di sorella terra, che si uniscono ai gemiti degli abbandonati del mondo, con un lamento che reclama da noi un’altra rotta (53)Degna di nota è la debolezza della reazione politica internazionale. (…) L’alleanza tra economia e tecnologia finisce per lasciare fuori tutto ciò che non fa parte dei loro interessi immediati (54)È prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni (57)
VII. DIVERSITÀ DI OPINIONI
Da un estremo, alcuni sostengono ad ogni costo il mito del progresso (…). Dall’altro estremo, altri ritengono che la specie umana, con qualunque suo intervento, può essere solo una minaccia e compromettere l’ecosistema mondiale (60) Su molte questioni concrete la Chiesa non ha motivo di proporre una parola definitiva e capisce che deve ascoltare e promuovere il dibattito onesto fra gli scienziati, rispettando le diversità di opinione. Basta però guardare la realtà con sincerità per vedere che c’è un grande deterioramento della nostra casa comune. (…) aldilà di qualunque previsione catastrofica, è certo che l’attuale sistema mondiale è insostenibile da diversi punti di vista (…): l’umanità ha deluso l’attesa divina (61)
CAPITOLO PRIMO QUELLO CHE STA ACCADENDO ALLA NOSTRA CASA17. Le riflessioni teologiche o filosofiche sulla situazione dell’umanità e del mondo possono suonare come un messaggio ripetitivo e vuoto, se non si presentano nuovamente a partire da un confronto con il contesto attuale, …quello che sta accadendo alla nostra casa comune. 18. La continua accelerazione dei cambiamenti dell’umanità e del pianeta si unisce oggi all’intensificazione dei ritmi di vita e di lavoro, in quella che in spagnolo alcuni chiamano “rapidación” (rapidizzazione). Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei sistemi complessi, la velocità che le azioni umane gli impongono oggi contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica. A ciò si aggiunge il problema che gli obiettivi di questo cambiamento veloce e costante non necessariamente sono orientati al bene comune e a uno sviluppo umano, sostenibile e integrale… 19. Dopo un tempo di fiducia irrazionale nel progresso e nelle capacità umane, una parte della società sta entrando in una fase di maggiore consapevolezza. Si avverte una crescente sensibilità riguardo all’ambiente e alla cura della natura, e matura una sincera e dolorosa preoccupazione per ciò che sta accadendo al nostro pianeta. Facciamo un percorso… L’obiettivo non è di raccogliere informazioni o saziare la nostra curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo, e così riconoscere qual è il contributo che ciascuno può portare.
Inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto 20. Esistono forme di inquinamento che colpiscono quotidianamente le persone. L’esposizione agli inquinanti atmosferici produce un ampio spettro di effetti sulla salute, in particolare dei più poveri, e provocano milioni di morti premature. …A questo si aggiunge l’inquinamento che colpisce tutti, causato dal trasporto, dai fumi dell’industria, dalle discariche di sostanze che contribuiscono all’acidificazione del suolo e dell’acqua, da fertilizzanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti e pesticidi tossici in generale. La tecnologia …a volte risolve un problema creandone altri. 21. C’è da considerare anche l’inquinamento prodotto dai rifiuti, compresi quelli pericolosi presenti in diversi ambienti. Si producono centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti l’anno, molti dei quali non biodegradabili: rifiuti domestici e commerciali, detriti di demolizioni, rifiuti clinici, elettronici o industriali, rifiuti altamente tossici e radioattivi. La terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizia. …Tanto i rifiuti industriali quanto i prodotti chimici utilizzati nelle città e nei campi, possono produrre un effetto di bio-accumulazione negli organismi degli abitanti delle zone limitrofe… Molte volte si prendono misure solo quando si sono prodotti effetti irreversibili per la salute delle persone.
22. Questi problemi sono intimamente legati alla cultura dello scarto, che colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura. Rendiamoci conto, per esempio, che la maggior parte della carta che si produce viene gettata e non riciclata. Stentiamo a riconoscere che il funzionamento degli ecosistemi naturali è esemplare: le piante sintetizzano sostanze nutritive che alimentano gli erbivori; questi a loro volta alimentano i carnivori, che forniscono importanti quantità di rifiuti organici, i quali danno luogo a una nuova generazione di vegetali. Al contrario, il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare…
Il clima come bene comune 23. Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. Esso, a livello globale, è un sistema complesso in relazione con molte condizioni essenziali per la vita umana. Esiste un consenso scientifico molto consistente che indica che siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Negli ultimi decenni, tale riscaldamento è stato accompagnato dal costante innalzamento del livello del mare, e inoltre è difficile non metterlo in relazione con l’aumento degli eventi meteorologici estremi, a prescindere dal fatto che non si possa attribuire una causa scientificamente determinabile ad ogni fenomeno particolare. L’umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità di cambiamenti di stili di vita, di produzione e di consumo, per combattere questo riscaldamento o, almeno, le cause umane che lo producono o lo accentuano. È vero che ci sono altri fattori (quali il vulcanismo, le variazioni dell’orbita e dell’asse terrestre, il ciclo solare), ma numerosi studi scientifici indicano che la maggior parte del riscaldamento globale degli ultimi decenni è dovuta alla grande concentrazione di gas serra (biossido di carbonio, metano, ossido di azoto ed altri) emessi soprattutto a causa dell’attività umana…24. A sua volta, il riscaldamento ha effetti sul ciclo del carbonio. Crea un circolo vizioso che aggrava ancora di più la situazione e che inciderà sulla disponibilità di risorse essenziali come l’acqua potabile, l’energia e la produzione agricola delle zone più calde, e provocherà l’estinzione di parte della biodiversità del pianeta. Lo scioglimento dei ghiacci polari e di quelli d’alta quota minaccia la fuoriuscita ad alto rischio di gas metano, e la decomposizione della materia organica congelata potrebbe accentuare ancora di più l’emissione di biossido di carbonio. A sua volta, la perdita di foreste tropicali peggiora le cose, giacché esse aiutano a mitigare il cambiamento climatico. L’inquinamento prodotto dal biossido di carbonio aumenta l’acidità degli oceani e compromette la catena alimentare marina. Se la tendenza attuale continua, questo secolo potrebbe essere testimone di cambiamenti climatici inauditi e di una distruzione senza precedenti degli ecosistemi, con gravi conseguenze per tutti noi… 25. I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali per l’umanità. Gli impatti più pesanti probabilmente ricadranno nei prossimi decenni sui Paesi in via di sviluppo. Molti poveri vivono in luoghi particolarmente colpiti da fenomeni connessi al riscaldamento, e i loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente dalle riserve naturali e dai cosiddetti servizi dell’ecosistema, come l’agricoltura, la pesca e le risorse forestali. Non hanno altre disponibilità economiche e altre risorse che permettano loro di adattarsi agli impatti climatici o di far fronte a situazioni catastrofiche, e hanno poco accesso a servizi sociali e di tutela. …È tragico l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa. Purtroppo c’è una generale indifferenza di fronte a queste tragedie, che accadono tuttora in diverse parti del mondo… 26. Molti di coloro che detengono più risorse e potere economico o politico sembrano concentrarsi soprattutto nel mascherare i problemi o nasconderne i sintomi, cercando solo di ridurre alcuni impatti negativi di cambiamenti climatici. Ma molti sintomi indicano che questi effetti potranno essere sempre peggiori se continuiamo con gli attuali modelli di produzione e di consumo. Perciò è diventato urgente e impellente lo sviluppo di politiche affinché nei prossimi anni l’emissione di biossido di carbonio e di altri gas altamente inquinanti si riduca drasticamente, ad esempio, sostituendo i combustibili fossili e sviluppando fonti di energia rinnovabile. …Ma queste buone pratiche sono lontane dal diventare generali.
La questione dell’acqua 27. Altri indicatori della situazione attuale sono legati all’esaurimento delle risorse naturali. Conosciamo bene l’impossibilità di sostenere l’attuale livello di consumo dei Paesi più sviluppati e dei settori più ricchi delle società, dove l’abitudine di sprecare e buttare via raggiunge livelli inauditi. Già si sono superati certi limiti massimi di sfruttamento del pianeta, senza che sia stato risolto il problema della povertà. 28. L’acqua potabile e pulita rappresenta una questione di primaria importanza, perché è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici. Le fonti di acqua dolce riforniscono i settori sanitari, agropastorali e industriali. La disponibilità di acqua è rimasta relativamente costante per lungo tempo, ma ora in molti luoghi la domanda supera l’offerta sostenibile, con gravi conseguenze a breve e lungo termine. Grandi città, dipendenti da importanti riserve idriche, soffrono periodi di carenza della risorsa, che nei momenti critici non viene amministrata sempre con una adeguata gestione e con imparzialità. La povertà di acqua pubblica si ha specialmente in Africa, dove grandi settori della popolazione non accedono all’acqua potabile sicura, o subiscono siccità che rendono difficile la
produzione di cibo. In alcuni Paesi ci sono regioni con abbondanza di acqua, mentre altre patiscono una grave carenza. 29. Un problema particolarmente serio è quello della qualità dell’acqua disponibile per i poveri, che provoca molte morti ogni giorno. Fra i poveri sono frequenti le malattie legate all’acqua, incluse quelle causate da microorganismi e da sostanze chimiche. La dissenteria e il colera, dovuti a servizi igienici e riserve di acqua inadeguati, sono un fattore significativo di sofferenza e di mortalità infantile. Le falde acquifere in molti luoghi sono minacciate dall’inquinamento che producono alcune attività estrattive, agricole e industriali...30. Mentre la qualità dell’acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato. In realtà, l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani. Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non hanno accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita radicato nella loro inalienabile dignità. …il problema dell’acqua è in parte una questione educativa e culturale, perché non vi è consapevolezza della gravità di tali comportamenti in un contesto di grande in-equità. 31. Una maggiore scarsità di acqua provocherà l’aumento del costo degli alimenti e di vari prodotti che dipendono dal suo uso. …Gli impatti ambientali potrebbero colpire miliardi di persone, e d’altra parte è prevedibile che il controllo dell’acqua da parte di grandi imprese mondiali si trasformi in una delle principali fonti di conflitto di questo secolo.
Perdita di biodiversità 32. Anche le risorse della terra vengono depredate a causa di modi di intendere l’economia e l’attività commerciale e produttiva troppo legati al risultato immediato. La perdita di foreste e boschi implica allo stesso tempo la perdita di specie che potrebbero costituire nel futuro risorse estremamente importanti, non solo per l’alimentazione, ma anche per la cura di malattie e per molteplici servizi. Le diverse specie contengono geni che possono essere risorse-chiave per rispondere in futuro a qualche necessità umana o per risolvere qualche problema ambientale. 33. …Ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali e animali che non potremo più conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, perse per sempre. La stragrande maggioranza si estingue per ragioni che hanno a che fare con qualche attività umana... 34. Probabilmente ci turba venire a conoscenza dell’estinzione di un mammifero o di un volatile, per la loro maggiore visibilità. Ma per il buon funzionamento degli ecosistemi sono necessari anche i funghi, le alghe, i vermi, i piccoli insetti, i rettili e l’innumerevole varietà di microorganismi. Alcune specie poco numerose, che di solito passano inosservate, giocano un ruolo critico fondamentale per stabilizzare l’equilibrio di un luogo. …Per esempio, molti uccelli e insetti che si estinguono a motivo dei pesticidi tossici creati dalla tecnologia, sono utili alla stessa agricoltura, e la loro scomparsa dovrà essere compensata con un altro intervento tecnologico che probabilmente porterà nuovi effetti nocivi… 35. Quando si analizza l’impatto ambientale di qualche iniziativa economica, si è soliti considerare gli effetti sul suolo, sull’acqua e sull’aria, ma non sempre si include uno studio attento dell’impatto sulla biodiversità, come se la perdita di alcune specie o di gruppi animali o vegetali fosse qualcosa di poco rilevante. …Quando si sfruttano commercialmente alcune specie, non sempre si studia la loro modalità di crescita, per evitare la loro eccessiva diminuzione con il conseguente squilibrio dell’ecosistema. 36. La cura degli ecosistemi richiede uno sguardo che vada aldilà dell’immediato, perché quando si cerca solo un profitto economico rapido e facile, a nessuno interessa veramente la loro preservazione. …Per questo, possiamo essere testimoni muti di gravissime in-equità quando si pretende di ottenere importanti benefici facendo pagare al resto dell’umanità, presente e futura, gli altissimi costi del degrado ambientale.37. …Nella cura della biodiversità, gli specialisti insistono sulla necessità di porre una speciale attenzione alle zone più ricche di varietà di specie, di specie endemiche, poco frequenti o con minor grado di protezione efficace. Ci sono luoghi che richiedono una cura particolare a motivo della loro enorme importanza per l’ecosistema mondiale, o che costituiscono significative riserve di acqua e così assicurano altre forme di vita. 38. Ricordiamo, per esempio, quei polmoni del pianeta colmi di biodiversità che sono l’Amazzonia e il bacino fluviale del Congo, o le grandi falde acquifere e i ghiacciai. È ben nota l’importanza di questi luoghi per l’insieme del pianeta e per il futuro dell’umanità. …È lodevole l’impegno di organismi internazionali e di organizzazioni della società civile che sensibilizzano le popolazioni e cooperano in modo critico, anche utilizzando legittimi meccanismi di pressione, affinché ogni governo adempia il proprio e non delegabile dovere di preservare l’ambiente e le risorse naturali del proprio Paese, senza vendersi a ambigui interessi locali o internazionali. 39. Neppure la sostituzione della flora selvatica con aree piantate a bosco, che generalmente sono monocolture, è solitamente oggetto di un’adeguata analisi...40. Gli oceani non solo contengono la maggior parte dell’acqua del pianeta, ma anche la maggior parte della vasta varietà di esseri viventi, molti dei quali ancora a noi sconosciuti e minacciati da diverse cause. D’altra parte, la vita nei fiumi, nei laghi, nei mari e negli oceani, che nutre gran parte della popolazione mondiale, si vede colpita dal prelievo incontrollato delle risorse ittiche, che provoca diminuzioni drastiche di alcune specie. Ancora si continua a sviluppare modalità selettive di pesca che scartano gran parte delle specie raccolte… 41. Addentrandoci nei mari tropicali e subtropicali, incontriamo le barriere coralline, che corrispondono alle grandi foreste della terraferma, perché ospitano approssimativamente un milione di specie, compresi pesci, granchi, molluschi,
spugne, alghe. Molte delle barriere coralline del mondo oggi sono sterili o sono in continuo declino: «Chi ha trasformato il meraviglioso mondo marino in cimiteri subacquei spogliati di vita e di colore?». Questo fenomeno è dovuto in gran parte all’inquinamento… È aggravato dall’aumento della temperatura degli oceani. Tutto questo ci aiuta a capire come qualunque azione sulla natura può avere conseguenze che non avvertiamo a prima vista, e che certe forme di sfruttamento delle risorse si ottengono a costo di un degrado che alla fine giunge fino in fondo agli oceani. 42. È necessario investire molto di più nella ricerca, per comprendere meglio il comportamento degli ecosistemi e analizzare adeguatamente le diverse variabili di impatto di qualsiasi modifica importante dell’ambiente. Poiché tutte le creature sono connesse tra loro, di ognuna dev’essere riconosciuto il valore con affetto e ammirazione, e tutti noi esseri creati abbiamo bisogno gli uni degli altri…
Deterioramento della qualità della vita umana e degradazione sociale 43. Se teniamo conto del fatto che anche l’essere umano è una creatura di questo mondo, che ha diritto a vivere e ad essere felice, e inoltre ha una speciale dignità, non possiamo tralasciare di considerare gli effetti del degrado ambientale, dell’attuale modello di sviluppo e della cultura dello scarto sulla vita delle persone. 44. Oggi riscontriamo, per esempio, la smisurata e disordinata crescita di molte città che sono diventate invivibili dal punto di vista della salute, non solo per l’inquinamento originato dalle emissioni tossiche, ma anche per il caos urbano, i problemi di trasporto e l’inquinamento visivo e acustico. Molte città sono grandi strutture inefficienti che consumano in eccesso acqua ed energia. Ci sono quartieri che, sebbene siano stati costruiti di recente, sono congestionati e disordinati, senza spazi verdi sufficienti. Non si addice ad abitanti di questo pianeta vivere sempre più sommersi da cemento, asfalto, vetro e metalli, privati del contatto fisico con la natura. 45. In alcuni luoghi, rurali e urbani, la privatizzazione degli spazi ha reso difficile l’accesso dei cittadini a zone di particolare bellezza; altrove si sono creati quartieri residenziali “ecologici” solo a disposizione di pochi...46. Tra le componenti sociali del cambiamento globale si includono gli effetti occupazionali di alcune innovazioni tecnologiche, l’esclusione sociale, la disuguaglianza nella disponibilità e nel consumo dell’energia e di altri servizi, la frammentazione sociale, l’aumento della violenza e il sorgere di nuove forme di aggressività sociale, il narcotraffico e il consumo crescente di droghe fra i più giovani, la perdita di identità. …Alcuni di questi segni sono allo stesso tempo sintomi di un vero degrado sociale, di una silenziosa rottura dei legami di integrazione e di comunione sociale. 47. A questo si aggiungono le dinamiche dei media e del mondo digitale, che, quando diventano onnipresenti, non favoriscono lo sviluppo di una capacità di vivere con sapienza, di pensare in profondità, di amare con generosità. …Questo ci richiede uno sforzo affinché tali mezzi si traducano in un nuovo sviluppo culturale dell’umanità e non in un deterioramento della sua ricchezza più profonda. La vera sapienza, frutto della riflessione, del dialogo e dell’incontro generoso fra le persone, non si acquisisce con una mera accumulazione di dati che finisce per saturare e confondere, in una specie di inquinamento mentale. Nello stesso tempo, le relazioni reali con gli altri, con tutte le sfide che implicano, tendono ad essere sostituite da un tipo di comunicazione mediata da internet. …Per questo non dovrebbe stupire il fatto che, insieme all’opprimente offerta di questi prodotti, vada crescendo una profonda e malinconica insoddisfazione nelle relazioni interpersonali, o un dannoso isolamento.
Inequità planetaria 48. L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme, e non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale, se non prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale. Di fatto, il deterioramento dell’ambiente e quello della società colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta… Per esempio, l’esaurimento delle riserve ittiche penalizza specialmente coloro che vivono della pesca artigianale e non hanno come sostituirla, l’inquinamento dell’acqua colpisce in particolare i più poveri che non hanno la possibilità di comprare acqua imbottigliata, e l’innalzamento del livello del mare colpisce principalmente le popolazioni costiere impoverite che non hanno dove trasferirsi… 49. Vorrei osservare che spesso non si ha chiara consapevolezza dei problemi che colpiscono particolarmente gli esclusi. Essi sono la maggior parte del pianeta, miliardi di persone. Oggi sono menzionati nei dibattiti politici ed economici internazionali, ma per lo più …al momento dell’attuazione concreta, rimangono frequentemente all’ultimo posto. Questo si deve in parte al fatto che tanti professionisti, opinionisti, mezzi di comunicazione e centri di potere sono ubicati lontani da loro, in aree urbane isolate, senza contatto diretto con i loro problemi. …Questa mancanza di contatto fisico e di incontro, a volte favorita dalla frammentazione delle nostre città, aiuta a cauterizzare la coscienza e a ignorare parte della realtà in analisi parziali. Ciò a volte convive con un discorso “verde”. Ma oggi non possiamo fare a meno di …ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri.50. Invece di risolvere i problemi dei poveri e pensare a un mondo diverso, alcuni si limitano a proporre una riduzione della natalità. Non mancano pressioni internazionali sui Paesi in via di sviluppo che condizionano gli aiuti economici a determinate politiche di “salute riproduttiva”. Però, «se è vero che l’ineguale distribuzione della popolazione e delle risorse disponibili crea ostacoli allo sviluppo e ad un uso sostenibile dell’ambiente, va riconosciuto che la crescita demografica è pienamente compatibile con uno sviluppo integrale e solidale». Incolpare l’incremento demografico e non il consumismo estremo e selettivo di alcuni, è un modo per non affrontare i problemi. …Inoltre, sappiamo che si spreca approssimativamente un terzo degli alimenti che si producono, e «il cibo che si butta via è come se lo si rubasse dalla mensa del povero». Ad ogni modo, è certo che bisogna prestare attenzione allo squilibrio nella distribuzione della
popolazione sul territorio, sia a livello nazionale sia a livello globale, perché l’aumento del consumo porterebbe a situazioni regionali complesse... 51. L’in-equità non colpisce solo gli individui, ma Paesi interi, e obbliga a pensare ad un’etica delle relazioni internazionali. C’è infatti un vero “debito ecologico”, soprattutto tra il Nord e il Sud, connesso a squilibri commerciali con conseguenze in ambito ecologico, come pure all’uso sproporzionato delle risorse naturali compiuto storicamente da alcuni Paesi. …Il riscaldamento causato dall’enorme consumo di alcuni Paesi ricchi ha ripercussioni nei luoghi più poveri della terra, specialmente in Africa, dove l’aumento della temperatura unito alla siccità ha effetti disastrosi sul rendimento delle coltivazioni. A questo si uniscono i danni causati dall’esportazione verso i Paesi in via di sviluppo di rifiuti solidi e liquidi tossici e dall’attività inquinante di imprese che fanno nei Paesi meno sviluppati ciò che non possono fare nei Paesi che apportano loro capitale…52. Il debito estero dei Paesi poveri si è trasformato in uno strumento di controllo, ma non accade la stessa cosa con il debito ecologico. In diversi modi, i popoli in via di sviluppo, dove si trovano le riserve più importanti della biosfera, continuano ad alimentare lo sviluppo dei Paesi più ricchi a prezzo del loro presente e del loro futuro. La terra dei poveri del Sud è ricca e poco inquinata, ma l’accesso alla proprietà dei beni e delle risorse per soddisfare le proprie necessità vitali è loro vietato da un sistema di rapporti commerciali e di proprietà strutturalmente perverso. È necessario che i Paesi sviluppati contribuiscano a risolvere questo debito limitando in modo importante il consumo di energia non rinnovabile, e apportando risorse ai Paesi più bisognosi per promuovere politiche e programmi di sviluppo sostenibile. …è opportuno puntare «specialmente sulle necessità dei poveri, deboli e vulnerabili, in un dibattito spesso dominato dagli interessi più potenti». Bisogna rafforzare la consapevolezza che siamo una sola famiglia umana… La debolezza delle reazioni 53. Queste situazioni provocano i gemiti di sorella terra, che si uniscono ai gemiti degli abbandonati del mondo, con un lamento che reclama da noi un’altra rotta. Mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune come negli ultimi due secoli. …Si rende indispensabile creare un sistema normativo che includa limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che le nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico finiscano per distruggere non solo la politica ma anche la libertà e la giustizia. 54. Degna di nota è la debolezza della reazione politica internazionale. La sottomissione della politica alla tecnologia e alla finanza si dimostra nel fallimento dei Vertici mondiali sull’ambiente. Ci sono troppi interessi particolari e molto facilmente l’interesse economico arriva a prevalere sul bene comune e a manipolare l’informazione per non vedere colpiti i suoi progetti. In questa linea il Documento di Aparecida chiede che «negli interventi sulle risorse naturali non prevalgano gli interessi di gruppi economici che distruggono irrazionalmente le fonti di vita». L’alleanza tra economia e tecnologia finisce per lasciare fuori tutto ciò che non fa parte dei loro interessi immediati… 55. A poco a poco alcuni Paesi possono mostrare progressi importanti, lo sviluppo di controlli più efficienti e una lotta più sincera contro la corruzione. È cresciuta la sensibilità ecologica delle popolazioni, anche se non basta per modificare le abitudini nocive di consumo, che non sembrano recedere, bensì estendersi e svilupparsi. …Se qualcuno osservasse dall’esterno la società planetaria, si stupirebbe di fronte a un simile comportamento che a volte sembra suicida. 56. Nel frattempo i poteri economici continuano a giustificare l’attuale sistema mondiale, in cui prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che tendono ad ignorare ogni contesto e gli effetti sulla dignità umana e sull’ambiente. Così si manifesta che il degrado ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi… 57. È prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno scenario favorevole per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni. La guerra causa sempre gravi danni all’ambiente e alla ricchezza culturale dei popoli, e i rischi diventano enormi quando si pensa alle armi nucleari e a quelle biologiche. …Si richiede dalla politica una maggiore attenzione per prevenire e risolvere le cause che possono dare origine a nuovi conflitti. Ma il potere collegato con la finanza è quello che più resiste a tale sforzo, e i disegni politici spesso non hanno ampiezza di vedute… 58. In alcuni Paesi ci sono esempi positivi di risultati nel migliorare l’ambiente… Queste azioni non risolvono i problemi globali, ma confermano che l’essere umano è ancora capace di intervenire positivamente... 59. Nello stesso tempo, cresce un’ecologia superficiale o apparente che consolida un certo intorpidimento e una spensierata irresponsabilità. Come spesso accade in epoche di profonde crisi, che richiedono decisioni coraggiose, siamo tentati di pensare che quanto sta succedendo non è certo. Se guardiamo in modo superficiale, al di là di alcuni segni visibili di inquinamento e di degrado, sembra che le cose non siano tanto gravi e che il pianeta potrebbe rimanere per molto tempo nelle condizioni attuali. Questo comportamento evasivo ci serve per mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di consumo. È il modo in cui l’essere umano si arrangia per alimentare tutti i vizi autodistruttivi: cercando di non vederli, lottando per non riconoscerli, rimandando le decisioni importanti, facendo come se nulla fosse.
Diversità di opinioni 60. Infine, riconosciamo che si sono sviluppate diverse visioni e linee di pensiero in merito alla situazione e alle possibili soluzioni. Da un estremo, alcuni sostengono ad ogni costo il mito del progresso …senza considerazioni etiche né cambiamenti di fondo. Dall’altro estremo, altri ritengono che la specie umana, con qualunque suo intervento, può essere solo una minaccia e compromettere l’ecosistema mondiale, per cui conviene ridurre la sua presenza sul pianeta e
impedirle ogni tipo di intervento. Fra questi estremi, la riflessione dovrebbe identificare possibili scenari futuri …che potrebbero entrare in dialogo in vista di risposte integrali. 61. Su molte questioni concrete la Chiesa non ha motivo di proporre una parola definitiva e capisce che deve ascoltare e promuovere il dibattito onesto fra gli scienziati, rispettando le diversità di opinione. Basta però guardare la realtà con sincerità per vedere che c’è un grande deterioramento della nostra casa comune. … «Se lo sguardo percorre le regioni del nostro pianeta, ci si accorge subito che l’umanità ha deluso l’attesa divina».
Capitolo SECONDO - IL VANGELO DELLA CREAZIONE (62-100)
Un capitolo sulle convinzioni della fede dopo aver detto che la LS si rivolge a tutti gli uomini. Ma è opportuno sottolineare che Scienza e Fede possono dialogare.Anzitutto si illumina la questione ambientale con la luce della fede; poi alcuni riferimenti a passi ed episodi biblici legati alla questione ambientale. Per riparare il danno fin qui prodotto sull’ambiente, non si può scartare alcun approccio, neppure quello della fede. Che i cristiani sentano i doveri nei confronti del creato come parte della loro fede.
Alcuni passi biblici offrono spunti di teologia del creato. In Gen 1 Dio vede che l’uomo e la donna sono cosa “molto buona”, quindi non possono essere dannosi per l’ambiente, anzi è fondamento della dignità della persona umana voluta per se stessa. Uomo – Dio / Uomo – uomo / Uomo – terra sono le tre relazioni fondamentali che, dopo il peccato originale, perdono equilibrio e coerenza: l’uomo è cacciato dall’Eden, entra in conflitto con la donna e coi fratelli (Caino), con l’ambiente (fatica del lavoro, dolore del parto, dramma della morte).“Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data”. “Soggiogare” la terra è il compito dell’uomo: non si intende “dominio sfrenato”, poiché la stessa Genesi offre un contesto di interpretazione in cui emerge il compito di custodire e coltivare il giardino.La legge sul riposo del settimo giorno interessa anche gli animali, contro ogni dispotismo antropocentrico. Ma si ribadisce la priorità dell’essere umano che sovrasta in dignità ogni altra creatura. Dalla crisi delle relazioni deriva la crisi del rapporto con l’ambiente.Tutto è in relazione: il diluvio universale mostra come, nonostante la malvagità degli uomini, Dio apre una nuova via di salvezza in nome del solo uomo giusto, Noè, con cui si riscopre la legge del riposo, l’anno sabbatico ogni sette anni, etc. per riconoscere che i doni della terra sono di tutti, non di uno solo ( principio di destinazione universale dei beni). Quando il popolo è messo alla prova, i profeti lo rincuorano mostrando la forza del Creatore di ogni essere vivente.
Il mistero dell’universo si apre definendo che la creazione dice “natura” in modo specifico: il mondo non deriva dal caso o dalla natura stessa, bensì dall’amore di Dio, ragione fondamentale di tutto il creato. Demitizzare la natura significa non attribuirle caratteristiche divine e difendere il primato del creatore, esaltando però ancor più la responsabilità di ogni uomo dinanzi all’ambiente.La Chiesa deve dunque ricordare all’uomo l’impegno di tutela dell’ambiente. Ma soprattutto ammonirlo sul rischio di autodistruzione. L’uomo è persona, soggetto: ogni uomo va considerato un fine in sé, dunque non può essere oggetto di alcun uso strumentale.
L’universo materiale rispecchia l’amore di Dio, come se ogni creatura fosse una lettera di un grandioso libro scritto dalla creazione divina. Solo una visione d’insieme può spingere alla lode che san Francesco ha elevato al creato. Il mondo è luogo della presenza di Dio, in cui le creature si scoprono interconnesse in una grande famiglia universale, in cui ovviamente spicca la famiglia umana come oggetto di particolare vocazione da parte di Dio (divina figliolanza). Questa posizione di primato ci induce a una forte responsabilità nei confronti dell’ambiente e in particolare dei più poveri e dei più emarginati.
La terra è un’eredità comune i cui frutti devono andare a tutti: destinazione universale dei beni della terra. A questo principio si subordina la proprietà privata come principio di diritto naturale secondario. La terra è infatti un dono che Dio ha fatto a tutti gli uomini. La Chiesa difende la proprietà privata, ma su di essa grava una ipoteca sociale, poiché ogni bene deve servire anzitutto ai bisognosi. L’ambiente è dunque un bene collettivo, patrimonio dell’umanità.
Infine si guarda a Gesù come a Colui che riconosce che Dio è Padre. Vive in mezzo alla gente, svolge un lavoro manuale, restituendo dignità al lavoro e santificandolo.Attraverso Cristo, presente fin dall’origine del mondo, passa il mistero della creazione. Il Verbo è presente alla creazione, è Logos che si incarna nel Cristo. Si inserisce nel cosmo condividendo la condizione umana in tutto fuorché il peccato, ma poi si presenta risorto e glorioso, con una signoria universale, chiamato a ricapitolare in sé tutte le cose e a presentarle al Padre. Le creature sono chiamate, nel risorto, a un destino di vera pienezza.
CAPITOLO SECONDO IL VANGELO DELLA CREAZIONE62. Perché inserire in questo documento, rivolto a tutte le persone di buona volontà, un capitolo riferito alle convinzioni di fede? Sono consapevole che, nel campo della politica e del pensiero, alcuni rifiutano con forza l’idea di un Creatore, o la ritengono irrilevante, al punto da relegare all’ambito dell’irrazionale la ricchezza che le religioni possono offrire per un’ecologia integrale e per il pieno sviluppo del genere umano… Tuttavia, la scienza e la religione, che forniscono approcci diversi alla realtà, possono entrare in un dialogo intenso e produttivo per entrambe.
La luce che la fede offre 63. Se teniamo conto della complessità della crisi ecologica e delle sue molteplici cause, dovremmo riconoscere che le soluzioni non possono venire da un unico modo di interpretare e trasformare la realtà. È necessario ricorrere anche alle diverse ricchezze culturali dei popoli, all’arte e alla poesia, alla vita interiore e alla spiritualità. …la Chiesa Cattolica è aperta al dialogo con il pensiero filosofico, e ciò le permette di produrre varie sintesi tra fede e ragione. Per quanto riguarda le questioni sociali, questo lo si può constatare nello sviluppo della dottrina sociale della Chiesa…64. D’altra parte, anche se questa Enciclica si apre a un dialogo con tutti per cercare insieme cammini di liberazione, voglio mostrare fin dall’inizio come le convinzioni di fede offrano ai cristiani, e in parte anche ad altri credenti, motivazioni alte per prendersi cura della natura e dei fratelli e sorelle più fragili. Se il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi cura dell’ambiente del quale sono parte, «i cristiani, in particolare, avvertono che i loro compiti all’interno del creato, i loro doveri nei confronti della natura e del Creatore sono parte della loro fede». Pertanto, è un bene per l’umanità e per il mondo che noi credenti riconosciamo meglio gli impegni ecologici che scaturiscono dalle nostre convinzioni.
La sapienza dei racconti biblici 65. …Nel primo racconto dell’opera creatrice nel libro della Genesi, il piano di Dio include la creazione dell’umanità. Dopo la creazione dell’uomo e della donna, si dice che «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona» (Gen 1,31). La Bibbia insegna che ogni essere umano è creato per amore, fatto ad immagine e somiglianza di Dio (Gen 1,26). Questa affermazione ci mostra l’immensa dignità di ogni persona umana, che «non è soltanto qualche cosa, ma qualcuno. È capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare in comunione con altre persone». … Coloro che s’impegnano nella difesa della dignità delle persone possono trovare nella fede cristiana le ragioni più profonde per tale impegno. …Il Creatore può dire a ciascuno di noi: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto» (Ger 1,5). Siamo stati concepiti nel cuore di Dio e quindi «ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno è amato, ciascuno è necessario». 66. I racconti della creazione nel libro della Genesi …suggeriscono che l’esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse: la relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. Secondo la Bibbia, queste tre relazioni vitali sono rotte, non solo fuori, ma anche dentro di noi. Questa rottura è il peccato. …per avere noi preteso di prendere il posto di Dio, rifiutando di riconoscerci come creature limitate. Questo fatto ha distorto anche la natura del mandato di soggiogare la terra (Gen 1,28) e di coltivarla e custodirla (Gen 2,15). Come risultato, la relazione originariamente armonica tra essere umano e natura si è trasformato in un conflitto (Gen 3,17-19). …oggi il peccato si manifesta con tutta la sua forza di distruzione nelle guerre, nelle diverse forme di violenza e maltrattamento, nell’abbandono dei più fragili, negli attacchi contro la natura. 67. Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. Ciò consente di rispondere a un’accusa lanciata contro il pensiero ebraico-cristiano: è stato detto che, a partire dal racconto della Genesi che invita a soggiogare la terra (Gen 1,28), verrebbe favorito lo sfruttamento selvaggio della natura presentando un’immagine dell’essere umano come dominatore e distruttore. Questa non è una corretta interpretazione della Bibbia come la intende la Chiesa. …È importante leggere i testi biblici nel loro contesto, con una giusta ermeneutica, e ricordare che essi ci invitano a «coltivare e custodire» il giardino del mondo (Gen 2,15). Mentre «coltivare» significa arare o lavorare un terreno, «custodire» vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura. Ogni comunità può prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla e garantire la continuità della sua fertilità per le generazioni future. In definitiva, «del Signore è la terra» (Sal 24,1), a Lui appartiene «la terra e quanto essa contiene» (Dt 10,14). Perciò Dio nega ogni pretesa di proprietà assoluta…
68. Questa responsabilità di fronte ad una terra che è di Dio, implica che l’essere umano, dotato di intelligenza, rispetti le leggi della natura e i delicati equilibri tra gli esseri di questo mondo… Ne consegue il fatto che la legislazione biblica si soffermi a proporre all’essere umano diverse norme, non solo in relazione agli altri esseri umani, ma anche in relazione agli altri esseri viventi: «Se vedi l’asino di tuo fratello o il suo bue caduto lungo la strada, non fingerai di non averli scorti [...]. Quando, cammin facendo, troverai sopra un albero o per terra un nido d’uccelli con uccellini o uova e la madre che sta covando gli uccellini o le uova, non prenderai la madre che è con i figli» (Dt 22,4.6). In questa linea, il riposo del settimo giorno non è proposto solo per l’essere umano, ma anche «perché possano godere quiete il tuo bue e il tuo asino» (Es 23,12). Così ci rendiamo conto che la Bibbia non dà adito ad un antropocentrismo dispotico che non si interessi delle altre creature. 69. Mentre possiamo fare un uso responsabile delle cose, siamo chiamati a riconoscere che gli altri esseri viventi hanno un valore proprio di fronte a Dio …Il Catechismo pone in discussione in modo molto diretto e insistito quello che sarebbe un antropocentrismo deviato: «Ogni creatura ha la sua propria bontà e la sua propria perfezione [...] Le varie creature, volute nel loro proprio essere, riflettono, ognuna a suo modo, un raggio dell’infinita sapienza e bontà di Dio. Per questo l’uomo deve rispettare la bontà propria di ogni creatura, per evitare un uso disordinato delle cose». 70. Nel racconto di Caino e Abele, vediamo che la gelosia ha spinto Caino a compiere l’estrema ingiustizia contro suo fratello. Ciò a sua volta ha causato una rottura della relazione tra Caino e Dio e tra Caino e la terra, dalla quale fu esiliato. …Dio insiste: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto, lontano da [questo] suolo» (Gen 4,9-11). Trascurare l’impegno di coltivare e mantenere una relazione corretta con il prossimo, verso il quale ho il dovere della cura e della custodia, distrugge la mia relazione interiore con me stesso, con gli altri, con Dio e con la terra. …Questo è ciò che ci insegna il racconto di Noè, quando Dio minaccia di spazzare via l’umanità per la sua persistente incapacità di vivere all’altezza delle esigenze della giustizia e della pace… In questi racconti così antichi, ricchi di profondo simbolismo, era già contenuta una convinzione oggi sentita: che tutto è in relazione, e che la cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri. 71. …Dio «si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra» (Gen 6,6), tuttavia, attraverso Noè, che si conservava ancora integro e giusto, Dio ha deciso di aprire una via di salvezza. In tal modo ha dato all’umanità la possibilità di un nuovo inizio. …questa riabilitazione comporta la riscoperta e il rispetto dei ritmi inscritti nella natura dalla mano del Creatore. Ciò si vede, per esempio, nella legge dello Shabbat. Il settimo giorno, Dio si riposò da tutte le sue opere. Dio ordinò a Israele che ogni settimo giorno doveva essere celebrato come giorno di riposo, uno Shabbat (Gen 2,2-3; Es 16,23; 20,10). D’altra parte, fu stabilito anche un anno sabbatico per Israele e la sua terra, ogni sette anni (Lv 25,1-4), durante il quale si concedeva un completo riposo alla terra, non si seminava e si raccoglieva soltanto l’indispensabile per sopravvivere e offrire ospitalità (Lv 25,4-6). Infine, trascorse sette settimane di anni, cioè quarantanove anni, si celebrava il giubileo, anno del perdono universale e della «liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti» (Lv 25,10). Lo sviluppo di questa legislazione ha cercato di assicurare l’equilibrio e l’equità nelle relazioni dell’essere umano con gli altri e con la terra dove viveva e lavorava. Ma, allo stesso tempo, era un riconoscimento del fatto che il dono della terra con i suoi frutti appartiene a tutto il popolo… 72. I Salmi invitano con frequenza l’essere umano a lodare Dio creatore, Colui che «ha disteso la terra sulle acque, perché il suo amore è per sempre» (Sal 136,6). Ma invitano anche le altre creature alla lode: «Lodatelo, sole e luna, lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. Lodatelo, cieli dei cieli, voi, acque al di sopra dei cieli. Lodino il nome del Signore, perché al suo comando sono stati creati» (Sal 148,3-5) … 73. Gli scritti dei profeti invitano a ritrovare la forza nei momenti difficili contemplando il Dio potente che ha creato l’universo. …Nella Bibbia, il Dio che libera e salva è lo stesso che ha creato l’universo, e questi due modi di agire divini sono intimamente e indissolubilmente legati: «Ah, Signore Dio, con la tua grande potenza e la tua forza hai fatto il cielo e la terra; nulla ti è impossibile [...]. Tu hai fatto uscire dall’Egitto il tuo popolo Israele con segni e con miracoli» (Ger 32,17.21)… 74. L’esperienza della schiavitù in Babilonia generò una crisi spirituale che ha portato ad un approfondimento della fede in Dio, esplicitando la sua onnipotenza creatrice, per esortare il popolo a ritrovare la speranza in mezzo alla sua infelice situazione. …Se Dio ha potuto creare l’universo dal nulla, può anche intervenire in questo mondo e vincere ogni forma di male. Dunque, l’ingiustizia non è invincibile. 75. Non possiamo sostenere una spiritualità che dimentichi Dio onnipotente e creatore. In questo modo, finiremmo per adorare altre potenze del mondo, o ci collocheremmo al posto del Signore, fino a pretendere di calpestare la realtà creata da Lui senza conoscere limite. …ritornare a proporre la figura di un Padre creatore e unico padrone del mondo, perché altrimenti l’essere umano tenderà sempre a voler imporre alla realtà le proprie leggi e i propri interessi.
Il mistero dell’universo 76. Per la tradizione giudeo-cristiana, dire “creazione” è più che dire natura, perché ha a che vedere con un progetto dell’amore di Dio, dove ogni creatura ha un valore e un significato. …un dono che scaturisce dalla mano aperta del Padre di tutti, come una realtà illuminata dall’amore che ci convoca ad una comunione universale. 77. «Dalla parola del Signore furono fatti i cieli» (Sal 33,6). Così ci viene indicato che il mondo proviene da una decisione, non dal caos o dalla casualità, e questo lo innalza ancora di più. Vi è una scelta libera espressa nella parola creatrice. …La creazione appartiene all’ordine dell’amore. L’amore di Dio è la ragione fondamentale di tutto il creato:
«Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata» (Sap 11,24) … 78. Allo stesso tempo, il pensiero ebraico-cristiano ha demitizzato la natura. Senza smettere di ammirarla per il suo splendore e la sua immensità, non le ha più attribuito un carattere divino. In questo modo viene sottolineato ulteriormente il nostro impegno nei suoi confronti. …Se riconosciamo il valore e la fragilità della natura, e allo stesso tempo le capacità che il Creatore ci ha dato, questo ci permette oggi di porre fine al mito moderno del progresso materiale illimitato. Un mondo fragile, con un essere umano al quale Dio ne affida la cura, interpella la nostra intelligenza per riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e limitare il nostro potere. 79. In questo universo, composto da sistemi aperti che entrano in comunicazione gli uni con gli altri, possiamo scoprire innumerevoli forme di relazione e partecipazione. Questo ci porta anche a pensare l’insieme come aperto alla trascendenza di Dio, all’interno della quale si sviluppa. La fede ci permette di interpretare il significato e la bellezza misteriosa di ciò che accade. La libertà umana può offrire il suo intelligente contributo verso un’evoluzione positiva, ma può anche aggiungere nuovi mali, nuove cause di sofferenza e momenti di vero arretramento. Questo dà luogo all’appassionante e drammatica storia umana, capace di trasformarsi in un fiorire di liberazione, crescita, salvezza e amore, oppure in un percorso di decadenza e di distruzione reciproca. Pertanto, l’azione della Chiesa non solo cerca di ricordare il dovere di prendersi cura della natura, ma al tempo stesso «deve proteggere soprattutto l’uomo contro la distruzione di sé stesso».80. Ciononostante, Dio, che vuole agire con noi e contare sulla nostra collaborazione, …ha voluto limitare sé stesso creando un mondo bisognoso di sviluppo, dove molte cose che noi consideriamo mali, pericoli o fonti di sofferenza, fanno parte in realtà dei dolori del parto, che ci stimolano a collaborare con il Creatore. Egli è presente nel più intimo di ogni cosa senza condizionare l’autonomia della sua creatura, e anche questo dà luogo alla legittima autonomia delle realtà terrene. Questa presenza divina, che assicura la permanenza e lo sviluppo di ogni essere, «è la continuazione dell’azione creatrice» ...81. L’essere umano, benché supponga anche processi evolutivi, comporta una novità non pienamente spiegabile dall’evoluzione di altri sistemi aperti. Ognuno di noi dispone in sé di un’identità personale in grado di entrare in dialogo con gli altri e con Dio stesso. La capacità di riflessione, il ragionamento, la creatività, l’interpretazione, l’elaborazione artistica ed altre capacità originali mostrano una singolarità che trascende l’ambito fisico e biologico. La novità qualitativa implicata dal sorgere di un essere personale all’interno dell’universo materiale presuppone un’azione diretta di Dio, una peculiare chiamata alla vita e alla relazione di un Tu a un altro tu. A partire dai testi biblici, consideriamo la persona come soggetto, che non può mai essere ridotto alla categoria di oggetto. 82. Sarebbe però anche sbagliato pensare che gli altri esseri viventi debbano essere considerati come meri oggetti sottoposti all’arbitrario dominio dell’essere umano. Quando si propone una visione della natura unicamente come oggetto di profitto e di interesse, ciò comporta anche gravi conseguenze per la società. …L’ideale di armonia, di giustizia, di fraternità e di pace che Gesù propone è agli antipodi di tale modello... 83. Il traguardo del cammino dell’universo è nella pienezza di Dio, che è stata già raggiunta da Cristo risorto, fulcro della maturazione universale. In tal modo aggiungiamo un ulteriore argomento per rifiutare qualsiasi dominio dispotico e irresponsabile dell’essere umano sulle altre creature. Lo scopo finale delle altre creature non siamo noi. Invece tutte avanzano, insieme a noi e attraverso di noi, verso la meta comune, che è Dio, in una pienezza trascendente dove Cristo risorto abbraccia e illumina tutto. L’essere umano, infatti, dotato di intelligenza e di amore, e attratto dalla pienezza di Cristo, è chiamato a ricondurre tutte le creature al loro Creatore.
Il messaggio di ogni creatura nell’armonia di tutto il Creato 84. Insistere nel dire che l’essere umano è immagine di Dio non dovrebbe farci dimenticare che ogni creatura ha una funzione e nessuna è superflua. Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio... 85. Dio ha scritto un libro stupendo, «le cui lettere sono la moltitudine di creature presenti nell’universo». I Vescovi del Canada hanno espresso bene che nessuna creatura resta fuori da questa manifestazione di Dio: «Dai più ampi panorami alle più esili forme di vita, la natura è una continua sorgente di meraviglia e di reverenza. Essa è, inoltre, una rivelazione continua del divino». …Possiamo dire che «accanto alla rivelazione propriamente detta contenuta nelle Sacre Scritture c’è, quindi, una manifestazione divina nello sfolgorare del sole e nel calare della notte». Prestando attenzione a questa manifestazione, l’essere umano impara a riconoscere sé stesso in relazione alle altre creature…86. L’insieme dell’universo, con le sue molteplici relazioni, mostra al meglio la ricchezza inesauribile di Dio. …Per questo, abbiamo bisogno di cogliere la varietà delle cose nelle loro molteplici relazioni. Dunque, si capisce meglio l’importanza e il significato di qualsiasi creatura, se la si contempla nell’insieme del piano di Dio. Questo insegna il Catechismo: «L’interdipendenza delle creature è voluta da Dio. Il sole e la luna, il cedro e il piccolo fiore, l’aquila e il passero: le innumerevoli diversità e disuguaglianze stanno a significare che nessuna creatura basta a se stessa, che esse esistono solo in dipendenza le une dalle altre, per completarsi vicendevolmente, al servizio le une delle altre».87. Quando ci si rende conto del riflesso di Dio in tutto ciò che esiste, il cuore sperimenta il desiderio di adorare il Signore per tutte le sue creature e insieme ad esse, come appare nel bellissimo cantico di san Francesco d’Assisi: «Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature…».
88. I Vescovi del Brasile hanno messo in rilievo che tutta la natura, oltre a manifestare Dio, è luogo della sua presenza. In ogni creatura abita il suo Spirito vivificante che ci chiama a una relazione con Lui. La scoperta di questa presenza stimola in noi lo sviluppo delle «virtù ecologiche». Ma quando diciamo questo, non dimentichiamo che esiste anche una distanza infinita, che le cose di questo mondo non possiedono la pienezza di Dio…
Una comunione universale 89. Le creature di questo mondo non possono essere considerate un bene senza proprietario: «Sono tue, Signore, amante della vita» (Sap 11,26). Questo induce alla convinzione che, essendo stati creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile… 90. Questo non significa equiparare tutti gli esseri viventi e togliere all’essere umano quel valore peculiare che implica allo stesso tempo una tremenda responsabilità. E nemmeno comporta una divinizzazione della terra, che ci priverebbe della chiamata a collaborare con essa e a proteggere la sua fragilità. Queste concezioni finirebbero per creare nuovi squilibri nel tentativo di fuggire dalla realtà che ci interpella. Si avverte a volte l’ossessione di negare alla persona umana qualsiasi preminenza, e si porta avanti una lotta per le altre specie che non mettiamo in atto per difendere la pari dignità tra gli esseri umani. Certamente ci deve preoccupare che gli altri esseri viventi non siano trattati in modo irresponsabile, ma ci dovrebbero indignare soprattutto le enormi disuguaglianze che esistono tra di noi, perché continuiamo a tollerare che alcuni si considerino più degni di altri. …Continuiamo nei fatti ad ammettere che alcuni si sentano più umani di altri, come se fossero nati con maggiori diritti. 91. Non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura, se nello stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani. È evidente l’incoerenza di chi lotta contro il traffico di animali a rischio di estinzione, ma rimane del tutto indifferente davanti alla tratta di persone, si disinteressa dei poveri, o è determinato a distruggere un altro essere umano che non gli è gradito... 92. D’altra parte, quando il cuore è veramente aperto a una comunione universale, niente e nessuno è escluso da tale fraternità. Di conseguenza, è vero anche che l’indifferenza o la crudeltà verso le altre creature di questo mondo finiscono sempre per trasferirsi in qualche modo al trattamento che riserviamo agli altri esseri umani. Il cuore è uno solo e la stessa miseria che porta a maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le altre persone. Ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura «è contrario alla dignità umana». Non possiamo considerarci persone che amano veramente se escludiamo dai nostri interessi una parte della realtà: «Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse, che non si potranno separare in modo da essere trattate singolarmente, a pena di ricadere nuovamente nel riduzionismo» ...
La destinazione comune dei beni 93. Oggi, credenti e non credenti sono d’accordo sul fatto che la terra è essenzialmente una eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di tutti. Per i credenti questo diventa una questione di fedeltà al Creatore, perché Dio ha creato il mondo per tutti. Di conseguenza, ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più svantaggiati. Il principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni e, perciò, il diritto universale al loro uso, è una “regola d’oro” del comportamento sociale, e il «primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale». La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata, e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata. San Giovanni Paolo II ha ricordato con molta enfasi questa dottrina, dicendo che «Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno». …Con grande chiarezza ha spiegato che «la Chiesa difende sì il legittimo diritto alla proprietà privata, ma insegna anche con non minor chiarezza che su ogni proprietà privata grava sempre un’ipoteca sociale, perché i beni servano alla destinazione generale che Dio ha loro dato». …Questo mette seriamente in discussione le abitudini ingiuste di una parte dell’umanità.94. Il ricco e il povero hanno uguale dignità, perché «il Signore ha creato l’uno e l’altro» (Pr 22,2) … Questo ha conseguenze pratiche, come quelle enunciate dai Vescovi del Paraguay: «Ogni contadino ha diritto naturale a possedere un appezzamento ragionevole di terra, dove possa stabilire la sua casa, lavorare per il sostentamento della sua famiglia e avere sicurezza per la propria esistenza…». 95. L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti. Chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti. Se non lo facciamo, ci carichiamo sulla coscienza il peso di negare l’esistenza degli altri…
Lo sguardo di Gesù 96. Gesù fa propria la fede biblica nel Dio creatore e mette in risalto un dato fondamentale: Dio è Padre (cfr Mt 11,25). Nei dialoghi con i suoi discepoli, Gesù li invitava a riconoscere la relazione paterna che Dio ha con tutte le creature, e ricordava loro con una commovente tenerezza come ciascuna di esse è importante ai suoi occhi: «Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio» (Lc 12,6) … 98. Gesù viveva una piena armonia con la creazione, e gli altri ne rimanevano stupiti: «Chi è mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» (Mt 8,27). Non appariva come un asceta separato dal mondo o nemico delle cose
piacevoli della vita. Riferendosi a sé stesso affermava: «È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un mangione e un beone”» (Mt 11,19). Era distante dalle filosofie che disprezzavano il corpo, la materia e le realtà di questo mondo. …ha santificato il lavoro e gli ha conferito un peculiare valore per la nostra maturazione. San Giovanni Paolo II insegnava che «sopportando la fatica del lavoro in unione con Cristo crocifisso per noi, l’uomo collabora in qualche modo col Figlio di Dio alla redenzione dell’umanità».99. Secondo la comprensione cristiana della realtà, il destino dell’intera creazione passa attraverso il mistero di Cristo, che è presente fin dall’origine: «Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui» (Col 1,16). … «si fece carne» (Gv 1,14). Una Persona della Trinità si è inserita nel cosmo creato, condividendone il destino fino alla croce… 100. Il Nuovo Testamento non solo ci parla del Gesù terreno e della sua relazione tanto concreta e amorevole con il mondo. Lo mostra anche risorto e glorioso, presente in tutto il creato con la sua signoria universale… Questo ci proietta alla fine dei tempi, quando il Figlio consegnerà al Padre tutte le cose, così che «Dio sia tutto in tutti» (1 Cor 15,28)…
Capitolo TERZO - LA RADICE UMANA DELLA CRISI ECOLOGICA (101-136)
Si entra nel ruolo umano della questione ecologica, dovuta a un modo deviato di intendere la vita e l’azione dell’uomo.
I progressi scientifici degli ultimi due secoli hanno migliorato le condizioni di vita dell’uomo: trasporti, comunicazioni, social network hanno rivoluzionato tempo e spazio della vita umana. D’altro canto non sempre l’uomo ha usato bene la tecnologia: tecniche di sterminio di massa, energia nucleare per bombe atomiche… Ogni acquisto di potenza esige che l’uomo ne disponga un retto uso. All’uomo di oggi mancano una solida etica, una cultura aperta, una spiritualità profonda.
Il paradigma tecnocratico è andato globalizzandosi: la realtà è vista come modificabile secondo il gusto dell’uomo, che mira a sfruttarne radicalmente ogni bene e risorsa. Gli sviluppi non sono mai neutri. Dipende dall’uso. Oggi tutte le applicazioni tecniche sono soggette alla logica del mercato e del profitto. Ma questa logica non è integrale, non considera le persone più svantaggiate, non offrendo programmi sociali che permettano a tutti di accedere egualmente alle risorse. Questo è anche il frutto della specializzazione del sapere e della sua parcellizzazione. Un’etica sociale dovrebbe contrastare l’individualismo contemporaneo.
Occorre una cultura ecologica. Che non consiste nei rimedi pratici ai problemi ambientali, bensì a uno sguardo più ampio e profondo capace di cogliere la complessità del problema.Ci sono però segnali di speranza: piccoli produttori del biologico, tecniche scientifiche di nuova generazione per la cura delle malattie.
La gente non crede più a un futuro felice nel nome del progresso tecnologico ma esige qualcos’altro. Pur non dichiarandosi disposta a rinunciare a qualcosa in termini di comodità e ricchezza.Papa Francesco indica la via: una rivoluzione culturale che vada oltre il mero tecnicismo e miri a uno sviluppo umano, integrale e sostenibile.Critica le megalopoli che non sostengono la necessità dell’uomo di non appiattirsi a masse indifferenziate bensì restare unico e irripetibile.
L’antropocentrismo deviato di oggi ci porta a non vedere più la natura come norma e rifugio bensì bene da sfruttare. Occorre recuperare il valore e la dignità della cura della natura sapendo che non è affatto sintomo di debolezza. Se non si tutela un embrione, come si può pretendere di aver un corretto rapporto con la vita della natura?Tutela ambientale e difesa della vita vanno insieme. Se non si rifiuta l’aborto, si mette da parte un embrione che non sia utile, e così pure le persone che non sono produttive. Si parla di relativismo pratico: l’altro è mezzo per soddisfare i miei interessi (sfruttamento sessuale dei minori, commercio di organi, prostituzione…).
Il lavoro ha un grande valore come assolvimento del mandato di custodia del creato che Dio ha affidato all’uomo. E si lega alla contemplazione e alla considerazione spirituale del lavoro (ora et lavora). Occorre favorire le politiche di accesso al lavoro per permettere a ciascuno di vivere un rapporto più autentico con il mondo e l’ambiente.
Infine, l’innovazione biologica: sperimentazione sugli animali (lecita se utile all’uomo), OGM (questione aperta: alcuni effetti positivi ci sono, ma ancora non assoluti).Conclude con l’invito a diffidare dei movimenti ecologisti che difendono l’ambiente ma non la vita umana, non opponendosi a uso degli embrioni con fine di ricerca. La tecnica separata dall’etica difficilmente sarà capace di autoregolamentarsi.
La radice della crisi ambientale è antropologica e sociale: il paradigma tecnocratico (la chiesa non è contro la scienza ma contro il potere assoluto della tecnica).
CAPITOLO TERZO LA RADICE UMANA DELLA CRISI ECOLOGICA101. A nulla ci servirà descrivere i sintomi, se non riconosciamo la radice umana della crisi ecologica. Vi è un modo di comprendere la vita e l’azione umana che è deviato e che contraddice la realtà fino al punto di rovinarla. Perché non possiamo fermarci a riflettere su questo? Propongo pertanto di concentrarci sul paradigma tecnocratico dominante e sul posto che vi occupano l’essere umano e la sua azione nel mondo.
La tecnologia: creatività e potere 102. L’umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnologia ci pone di fronte ad un bivio. Siamo gli eredi di due secoli di enormi ondate di cambiamento: la macchina a vapore, la ferrovia, il telegrafo, l’elettricità, l’automobile, l’aereo, le industrie chimiche, la medicina moderna, l’informatica e, più recentemente, la rivoluzione digitale, la robotica, le biotecnologie e le nanotecnologie. È giusto rallegrarsi per questi progressi …perché «la scienza e la tecnologia sono un prodotto meraviglioso della creatività umana che è un dono di Dio». La trasformazione della natura a fini di utilità è una caratteristica del genere umano fin dai suoi inizi, e in tal modo la tecnica «esprime la tensione dell’animo umano verso il graduale superamento di certi condizionamenti materiali». La tecnologia ha posto rimedio a innumerevoli mali che affliggevano e limitavano l’essere umano…103. La tecno-scienza, ben orientata, è in grado non solo di produrre cose realmente preziose per migliorare la qualità della vita dell’essere umano… È anche capace di produrre il bello e di far compiere all’essere umano, immerso nel mondo materiale, il “salto” nell’ambito della bellezza. Si può negare la bellezza di un aereo, o di alcuni grattacieli? …104. Tuttavia non possiamo ignorare che l’energia nucleare, la biotecnologia, l’informatica, la conoscenza del nostro stesso DNA e altre potenzialità che abbiamo acquisito ci offrono un tremendo potere. Anzi, danno a coloro che detengono la conoscenza e soprattutto il potere economico per sfruttarla un dominio impressionante sull’insieme del genere umano e del mondo intero. Mai l’umanità ha avuto tanto potere su sé stessa e niente garantisce che lo utilizzerà bene, soprattutto se si considera il modo in cui se ne sta servendo. Basta ricordare le bombe atomiche lanciate in pieno XX secolo, come il grande spiegamento di tecnologia ostentato dal nazismo, dal comunismo e da altri regimi totalitari al servizio dello sterminio di milioni di persone, senza dimenticare che oggi la guerra dispone di strumenti sempre più micidiali. In quali mani sta e in quali può giungere tanto potere? È terribilmente rischioso che esso risieda in una piccola parte dell’umanità. 105. Si tende a credere che «ogni acquisto di potenza sia semplicemente progresso, accrescimento di sicurezza, di utilità, di benessere, di forza vitale, di pienezza di valori», come se la realtà, il bene e la verità sbocciassero spontaneamente dal potere stesso della tecnologia e dell’economia. Il fatto è che «l’uomo moderno non è stato educato al retto uso della potenza», perché l’immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell’essere umano per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza. …è possibile che oggi l’umanità non avverta la serietà delle sfide che le si presentano, e «la possibilità dell’uomo di usare male della sua potenza è in continuo aumento» quando «non esistono norme di libertà, ma solo pretese necessità di utilità e di sicurezza». L’essere umano non è pienamente autonomo. La sua libertà si ammala quando si consegna alle forze cieche dell’inconscio, dei bisogni immediati, dell’egoismo, della violenza brutale. …possiamo affermare che gli mancano un’etica adeguatamente solida, una cultura e una spiritualità che realmente gli diano un limite e lo contengano entro un lucido dominio di sé.
La globalizzazione del paradigma tecnocratico 106. Il problema fondamentale è un altro, ancora più profondo: il modo in cui di fatto l’umanità ha assunto la tecnologia e il suo sviluppo insieme ad un paradigma omogeneo e unidimensionale. In tale paradigma risalta una concezione del soggetto che progressivamente, nel processo logico-razionale, comprende e in tal modo possiede l’oggetto che si trova all’esterno. Tale soggetto si esplica nello stabilire il metodo scientifico con la sua sperimentazione, che è già esplicitamente una tecnica di possesso, dominio e trasformazione. È come se il soggetto si trovasse di fronte alla realtà informe totalmente disponibile alla sua manipolazione. L’intervento dell’essere umano sulla natura si è sempre verificato, ma per molto tempo ha avuto la caratteristica di accompagnare, di assecondare le possibilità offerte dalle cose stesse. Si trattava di ricevere quello che la realtà naturale da sé permette, come tendendo la mano. Viceversa, ora ciò che interessa è estrarre tutto quanto è possibile dalle cose attraverso l’imposizione della mano umana, che tende ad ignorare o a dimenticare la realtà stessa di ciò che ha dinanzi. …Da qui si passa facilmente all’idea di una crescita
infinita o illimitata, che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della tecnologia. Ciò suppone la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta, che conduce a “spremerlo” fino al limite e oltre il limite... 107. …Gli effetti dell’applicazione di questo modello a tutta la realtà, umana e sociale, si constatano nel degrado dell’ambiente, ma questo è solo un segno del riduzionismo che colpisce la vita umana e la società in tutte le loro dimensioni. Occorre riconoscere che i prodotti della tecnica non sono neutri, perché creano una trama che finisce per condizionare gli stili di vita e orientano le possibilità sociali nella direzione degli interessi di determinati gruppi di potere. Certe scelte che sembrano puramente strumentali, in realtà sono scelte attinenti al tipo di vita sociale che si intende sviluppare. 108. Non si può pensare di sostenere un altro paradigma culturale e servirsi della tecnica come di un mero strumento, perché oggi il paradigma tecnocratico è diventato così dominante, che è molto difficile prescindere dalle sue risorse, e ancora più difficile è utilizzare le sue risorse senza essere dominati dalla sua logica. È diventato contro-culturale scegliere uno stile di vita con obiettivi che almeno in parte possano essere indipendenti dalla tecnica, dai suoi costi e dal suo potere globalizzante e massificante. Di fatto la tecnica ha una tendenza a far sì che nulla rimanga fuori dalla sua ferrea logica, e «l’uomo che ne è il protagonista sa che, in ultima analisi, non si tratta né di utilità, né di benessere, ma di dominio; dominio nel senso estremo della parola» …109. Il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il proprio dominio anche sull’economia e sulla politica. L’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza prestare attenzione a eventuali conseguenze negative per l’essere umano. La finanza soffoca l’economia reale. Non si è imparata la lezione della crisi finanziaria mondiale e con molta lentezza si impara quella del deterioramento ambientale. In alcuni circoli si sostiene che l’economia attuale e la tecnologia risolveranno tutti i problemi ambientali, allo stesso modo in cui si afferma, con un linguaggio non accademico, che i problemi della fame e della miseria nel mondo si risolveranno semplicemente con la crescita del mercato. …affermano che l’obiettivo della massimizzazione dei profitti è sufficiente. Il mercato da solo però non garantisce lo sviluppo umano integrale e l’inclusione sociale. Nel frattempo, abbiamo una «sorta di supersviluppo dissipatore e consumistico che contrasta in modo inaccettabile con perduranti situazioni di miseria disumanizzante», mentre non si mettono a punto con sufficiente celerità istituzioni economiche e programmi sociali che permettano ai più poveri di accedere in modo regolare alle risorse di base. Non ci si rende conto a sufficienza di quali sono le radici più profonde degli squilibri attuali, che hanno a che vedere con l’orientamento, i fini, il senso e il contesto sociale della crescita tecnologica ed economica.110. La specializzazione propria della tecnologia implica una notevole difficoltà ad avere uno sguardo d’insieme. La frammentazione del sapere assolve la propria funzione nel momento di ottenere applicazioni concrete, ma spesso conduce a perdere il senso della totalità, delle relazioni che esistono tra le cose, dell’orizzonte ampio, senso che diventa irrilevante. …Una scienza che pretenda di offrire soluzioni alle grandi questioni, dovrebbe necessariamente tener conto di tutto ciò che la conoscenza ha prodotto nelle altre aree del sapere, comprese la filosofia e l’etica sociale. Ma questo è un modo di agire difficile da portare avanti oggi. Perciò non si possono nemmeno riconoscere dei veri orizzonti etici di riferimento. La vita diventa un abbandonarsi alle circostanze condizionate dalla tecnica, intesa come la principale risorsa per interpretare l’esistenza. Nella realtà concreta che ci interpella, appaiono diversi sintomi che mostrano l’errore, come il degrado ambientale, l’ansia, la perdita del senso della vita e del vivere insieme. Si dimostra così ancora una volta che «la realtà è superiore all’idea». 111. La cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano riguardo al degrado ambientale, all’esaurimento delle riserve naturali e all’inquinamento. Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico…112. È possibile, tuttavia, allargare nuovamente lo sguardo, e la libertà umana è capace di limitare la tecnica, di orientarla, e di metterla al servizio di un altro tipo di progresso, più sano, più umano, più sociale e più integrale. La liberazione dal paradigma tecnocratico imperante avviene di fatto in alcune occasioni. Per esempio, quando comunità di piccoli produttori optano per sistemi di produzione meno inquinanti, sostenendo un modello di vita, di felicità e di convivialità non consumistico. O quando la tecnica si orienta prioritariamente a risolvere i problemi concreti degli altri, con l’impegno di aiutarli a vivere con più dignità e meno sofferenze... 113. D’altronde, la gente ormai non sembra credere in un futuro felice, non confida ciecamente in un domani migliore a partire dalle attuali condizioni del mondo e dalle capacità tecniche. Prende coscienza che il progresso della scienza e della tecnica non equivale al progresso dell’umanità e della storia, e intravede che sono altre le strade fondamentali per un futuro felice. …Diventa difficile fermarci per recuperare la profondità della vita. …Non rassegniamoci a questo e non rinunciamo a farci domande sui fini e sul senso di ogni cosa. Diversamente, legittimeremo soltanto lo stato di fatto e avremo bisogno di più surrogati per sopportare il vuoto. 114. Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza di procedere in una coraggiosa rivoluzione culturale. La scienza e la tecnologia non sono neutrali, ma possono implicare dall’inizio alla fine di un processo diverse intenzioni e possibilità, e possono configurarsi in vari modi. Nessuno vuole tornare all’epoca delle caverne, però è indispensabile rallentare la marcia per guardare la realtà in un altro modo, raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibili, e al tempo stesso recuperare i valori e i grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane.
Crisi e conseguenze dell’antropocentrismo moderno
115. L’antropocentrismo moderno, paradossalmente, ha finito per collocare la ragione tecnica al di sopra della realtà… In tal modo, si sminuisce il valore intrinseco del mondo. Ma se l’essere umano non riscopre il suo vero posto, non comprende in maniera adeguata sé stesso e finisce per contraddire la propria realtà. «Non solo la terra è stata data da Dio all’uomo, che deve usarla rispettando l’intenzione originaria di bene, secondo la quale gli è stata donata; ma l’uomo è donato a sé stesso da Dio e deve, perciò, rispettare la struttura naturale e morale, di cui è stato dotato». 116. Nella modernità si è verificato un notevole eccesso antropocentrico che, sotto altra veste, oggi continua a minare ogni riferimento a qualcosa di comune e ogni tentativo di rafforzare i legami sociali. Per questo è giunto il momento di prestare nuovamente attenzione alla realtà con i limiti che essa impone, i quali a loro volta costituiscono la possibilità di uno sviluppo umano e sociale più sano e fecondo. Una presentazione inadeguata dell’antropologia cristiana ha finito per promuovere una concezione errata della relazione dell’essere umano con il mondo. Molte volte è stato trasmesso un sogno prometeico di dominio sul mondo che ha provocato l’impressione che la cura della natura sia cosa da deboli. Invece l’interpretazione corretta del concetto dell’essere umano come signore dell’universo è quella di intenderlo come amministratore responsabile.117. …Quando non si riconosce nella realtà stessa l’importanza di un povero, di un embrione umano, di una persona con disabilità – per fare solo alcuni esempi –, difficilmente si sapranno ascoltare le grida della natura stessa. Tutto è connesso. Se l’essere umano si dichiara autonomo dalla realtà e si costituisce dominatore assoluto, la stessa base della sua esistenza si sgretola, perché «invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera della creazione, l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione della natura».118. Questa situazione ci conduce ad una schizofrenia permanente, che va dall’esaltazione tecnocratica che non riconosce agli altri esseri un valore proprio, fino alla reazione di negare ogni peculiare valore all’essere umano. Ma non si può prescindere dall’umanità. Non ci sarà una nuova relazione con la natura senza un essere umano nuovo. Non c’è ecologia senza un’adeguata antropologia. …Un antropocentrismo deviato non deve necessariamente cedere il passo a un “biocentrismo”, perché ciò implicherebbe introdurre un nuovo squilibrio, che non solo non risolverà i problemi, bensì ne aggiungerà altri. Non si può esigere da parte dell’essere umano un impegno verso il mondo, se non si riconoscono e non si valorizzano al tempo stesso le sue peculiari capacità di conoscenza, volontà, libertà e responsabilità. 119. La critica all’antropocentrismo deviato non dovrebbe nemmeno collocare in secondo piano il valore delle relazioni tra le persone. Se la crisi ecologica è un emergere o una manifestazione esterna della crisi etica, culturale e spirituale della modernità, non possiamo illuderci di risanare la nostra relazione con la natura e l’ambiente senza risanare tutte le relazioni umane fondamentali. Quando il pensiero cristiano rivendica per l’essere umano un peculiare valore al di sopra delle altre creature, dà spazio alla valorizzazione di ogni persona umana, e così stimola il riconoscimento dell’altro. L’apertura ad un “tu” in grado di conoscere, amare e dialogare continua ad essere la grande nobiltà della persona umana. …non si può proporre una relazione con l’ambiente a prescindere da quella con le altre persone e con Dio. Sarebbe un individualismo romantico travestito da bellezza ecologica e un asfissiante rinchiudersi nell’immanenza.120. Dal momento che tutto è in relazione, non è neppure compatibile la difesa della natura con la giustificazione dell’aborto. … «Se si perde la sensibilità personale e sociale verso l’accoglienza di una nuova vita, anche altre forme di accoglienza utili alla vita sociale si inaridiscono». 121. Si attende ancora lo sviluppo di una nuova sintesi che superi le false dialettiche degli ultimi secoli. Lo stesso cristianesimo… sempre si ripensa e si ri-esprime nel dialogo con le nuove situazioni storiche, lasciando sbocciare così la sua perenne novità.
Il relativismo pratico 122. Un antropocentrismo deviato dà luogo a uno stile di vita deviato. Nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho fatto riferimento al relativismo pratico che caratterizza la nostra epoca, e che è «ancora più pericoloso di quello dottrinale». Quando l’essere umano pone sé stesso al centro, finisce per dare priorità assoluta ai suoi interessi contingenti, e tutto il resto diventa relativo. Perciò non dovrebbe meravigliare il fatto che, insieme all’onnipresenza del paradigma tecnocratico e all’adorazione del potere umano senza limiti, si sviluppi nei soggetti questo relativismo, …atteggiamenti che provocano al tempo stesso il degrado ambientale e il degrado sociale. 123. La cultura del relativismo è la stessa patologia che spinge una persona ad approfittare di un’altra e a trattarla come un mero oggetto, obbligandola a lavori forzati, o riducendola in schiavitù a causa di un debito. È la stessa logica che porta a sfruttare sessualmente i bambini, o ad abbandonare gli anziani che non servono ai propri interessi. È anche la logica interna di chi afferma: lasciamo che le forze invisibili del mercato regolino l’economia, perché i loro effetti sulla società e sulla natura sono danni inevitabili. Se non ci sono verità oggettive né princìpi stabili, al di fuori della soddisfazione delle proprie aspirazioni e delle necessità immediate, che limiti possono avere la tratta degli esseri umani, la criminalità organizzata, il narcotraffico, il commercio di diamanti insanguinati e di pelli di animali in via di estinzione? …quando è la cultura che si corrompe e non si riconosce più alcuna verità oggettiva o princìpi universalmente validi, le leggi verranno intese solo come imposizioni arbitrarie e come ostacoli da evitare.
La necessità di difendere il lavoro 124. In qualunque impostazione di ecologia integrale, che non escluda l’essere umano, è indispensabile integrare il valore del lavoro, tanto sapientemente sviluppato da san Giovanni Paolo II nella Laborem exercens. Ricordiamo che,
secondo il racconto biblico della creazione, Dio pose l’essere umano nel giardino appena creato (cfr Gen 2,15) non solo per prendersi cura dell’esistente (custodire), ma per lavorarvi affinché producesse frutti (coltivare)… 125. Se cerchiamo di pensare quali siano le relazioni adeguate dell’essere umano con il mondo che lo circonda, emerge la necessità di una corretta concezione del lavoro, perché, se parliamo della relazione dell’essere umano con le cose, si pone l’interrogativo circa il senso e la finalità dell’azione umana sulla realtà. Non parliamo solo del lavoro manuale o del lavoro della terra, bensì di qualsiasi attività che implichi qualche trasformazione dell’esistente, dall’elaborazione di un studio sociale fino al progetto di uno sviluppo tecnologico…126. Raccogliamo anche qualcosa dalla lunga tradizione monastica. All’inizio essa favorì in un certo modo la fuga dal mondo, tentando di allontanarsi dalla decadenza urbana. Per questo i monaci cercavano il deserto, convinti che fosse il luogo adatto per riconoscere la presenza di Dio. Successivamente, san Benedetto da Norcia volle che i suoi monaci vivessero in comunità, unendo la preghiera e lo studio con il lavoro manuale (Ora et labora). Questa introduzione del lavoro manuale intriso di senso spirituale si rivelò rivoluzionaria. Si imparò a cercare la maturazione e la santificazione nell’intreccio tra il raccoglimento e il lavoro. Tale maniera di vivere il lavoro ci rende più capaci di cura e di rispetto verso l’ambiente, impregna di sana sobrietà la nostra relazione con il mondo.127. Affermiamo che «l’uomo è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale». Ciononostante, quando nell’essere umano si perde la capacità di contemplare e di rispettare, si creano le condizioni perché il senso del lavoro venga stravolto. Conviene ricordare sempre che l’essere umano è nello stesso tempo «capace di divenire lui stesso attore responsabile del suo miglioramento materiale, del suo progresso morale, dello svolgimento pieno del suo destino spirituale». Il lavoro dovrebbe essere l’ambito di questo multiforme sviluppo personale, dove si mettono in gioco molte dimensioni della vita: la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo delle capacità, l’esercizio dei valori, la comunicazione con gli altri, un atteggiamento di adorazione…128. Siamo chiamati al lavoro fin dalla nostra creazione. Non si deve cercare di sostituire sempre più il lavoro umano con il progresso tecnologico: così facendo l’umanità danneggerebbe sé stessa. Il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale. …Il vero obiettivo dovrebbe sempre essere di consentire loro una vita degna mediante il lavoro. Tuttavia l’orientamento dell’economia ha favorito un tipo di progresso tecnologico finalizzato a ridurre i costi di produzione in ragione della diminuzione dei posti di lavoro, che vengono sostituiti dalle macchine. È un ulteriore modo in cui l’azione dell’essere umano può volgersi contro sé stesso. …Rinunciare ad investire sulle persone per ottenere un maggior profitto immediato è un pessimo affare per la società. 129. Perché continui ad essere possibile offrire occupazione, è indispensabile promuovere un’economia che favorisca la diversificazione produttiva e la creatività imprenditoriale. Per esempio, vi è una grande varietà di sistemi alimentari agricoli e di piccola scala che continua a nutrire la maggior parte della popolazione mondiale, utilizzando una porzione ridotta del territorio e dell’acqua e producendo meno rifiuti, sia in piccoli appezzamenti agricoli e orti, sia nella caccia e nella raccolta di prodotti boschivi, sia nella pesca artigianale. …Le autorità hanno il diritto e la responsabilità di adottare misure di chiaro e fermo appoggio ai piccoli produttori e alla diversificazione della produzione. Perché vi sia una libertà economica della quale tutti effettivamente beneficino, a volte può essere necessario porre limiti a coloro che detengono più grandi risorse e potere finanziario. La semplice proclamazione della libertà economica, quando però le condizioni reali impediscono che molti possano accedervi realmente, e quando si riduce l’accesso al lavoro, diventa un discorso contraddittorio che disonora la politica. …la creazione di posti di lavoro è parte imprescindibile del servizio al bene comune.
L’innovazione biologica a partire dalla ricerca130. Nella visione filosofica e teologica dell’essere umano e della creazione, che ho cercato di proporre, risulta chiaro che la persona umana, con la peculiarità della sua ragione e della sua scienza, non è un fattore esterno che debba essere totalmente escluso. Tuttavia, benché l’essere umano possa intervenire nel mondo vegetale e anima le e servirsene quando è necessario alla sua vita, il Catechismo insegna che le sperimentazioni sugli animali sono legittime solo se «si mantengono in limiti ragionevoli e contribuiscono a curare o a salvare vite umane». Ricorda con fermezza che il potere umano ha dei limiti e che «è contrario alla dignità umana far soffrire inutilmente gli animali e disporre indiscriminatamente della loro vita». Qualsiasi uso e sperimentazione «esige un religioso rispetto dell’integrità della creazione».131. …Giovanni Paolo II …ricordava «come ogni intervento in un’area dell’ecosistema non possa prescindere dal considerare le sue conseguenze in altre aree». Affermava che la Chiesa apprezza l’apporto «dello studio e delle applicazioni della biologia molecolare, completata dalle altre discipline come la genetica e la sua applicazione tecnologica nell’agricoltura e nell’industria». Benché dicesse anche che questo non deve dar luogo ad una «indiscriminata manipolazione genetica» che ignori gli effetti negativi di questi interventi. …non si può fare a meno di riconsiderare gli obiettivi, gli effetti, il contesto e i limiti etici di tale attività umana che è una forma di potere con grandi rischi. 132. In questo quadro dovrebbe situarsi qualsiasi riflessione circa l’intervento umano sul mondo vegetale e animale, che implica oggi mutazioni genetiche prodotte dalla biotecnologia, allo scopo di sfruttare le possibilità presenti nella realtà materiale. …In ogni caso, è legittimo l’intervento che agisce sulla natura «per aiutarla a svilupparsi secondo la sua essenza, quella della creazione, quella voluta da Dio».
133. È difficile emettere un giudizio generale sullo sviluppo di organismi geneticamente modificati (OGM), vegetali o animali, per fini medici o in agricoltura, dal momento che possono essere molto diversi tra loro e richiedere distinte considerazioni...134. Sebbene non disponiamo di prove definitive circa il danno che potrebbero causare i cereali transgenici agli esseri umani, e in alcune regioni il loro utilizzo ha prodotto una crescita economica che ha contribuito a risolvere alcuni problemi, si riscontrano significative difficoltà che non devono essere minimizzate. In molte zone, in seguito all’introduzione di queste coltivazioni, si constata una concentrazione di terre produttive nelle mani di pochi, dovuta alla «progressiva scomparsa dei piccoli produttori, che, in conseguenza della perdita delle terre coltivate, si sono visti obbligati a ritirarsi dalla produzione diretta». I più fragili tra questi diventano lavoratori precari e molti salariati agricoli finiscono per migrare in miserabili insediamenti urbani. L’estendersi di queste coltivazioni distrugge la complessa trama degli ecosistemi, diminuisce la diversità nella produzione e colpisce il presente o il futuro delle economie regionali...135. Senza dubbio c’è bisogno di un’attenzione costante, che porti a considerare tutti gli aspetti etici implicati. A tal fine occorre assicurare un dibattito scientifico e sociale che sia responsabile e ampio, in grado di considerare tutta l’informazione disponibile e di chiamare le cose con il loro nome. A volte non si mette sul tavolo l’informazione completa, ma la si seleziona secondo i propri interessi, siano essi politici, economici o ideologici. …Quella degli OGM è una questione di carattere complesso, che esige di essere affrontata con uno sguardo comprensivo di tutti i suoi aspetti, e questo richiederebbe almeno un maggiore sforzo per finanziare diverse linee di ricerca autonoma e interdisciplinare che possano apportare nuova luce.136. D’altro canto, è preoccupante il fatto che alcuni movimenti ecologisti difendano l’integrità dell’ambiente, e con ragione reclamino dei limiti alla ricerca scientifica, mentre a volte non applicano questi medesimi princìpi alla vita umana. Spesso si giustifica che si oltrepassino tutti i limiti quando si fanno esperimenti con embrioni umani vivi. Si dimentica che il valore inalienabile di un essere umano va molto oltre il grado del suo sviluppo. Ugualmente, quando la tecnica non riconosce i grandi princìpi etici, finisce per considerare legittima qualsiasi pratica. Come abbiamo visto in questo capitolo, la tecnica separata dall’etica difficilmente sarà capace di autolimitare il proprio potere.
Capitolo QUARTO - UN’ECOLOGIA INTEGRALE (137-162)
(137) Si propone una ecologia integrale che comprenda le diverse dimensioni: ambientale, economica, sociale, della vita quotidiana, culturale, umana, istituzionale, urbanistica, del corpo.(139) L’EI è nuovo paradigma di giustizia: garantisce che l’uomo sia collocato nel giusto posto all’interno dell’ambiente e del mondo
L’ecologia può esser il punto di partenza per rimettere in dubbio e ripensare i modelli di produzione, consumo e sviluppo. Data la profonda connessione tra gli elementi dell’ambiente, non si possono separare le crisi ma anzi affrontarle insieme per risolverle insieme. Si tratta di una sola crisi sociale-ambientale. Ecco perché l’ecologia non può tralasciare il problema povertà. Migliorare l’ambiente naturale per migliorare l’ambiente umano.
Ecologia economica: la protezione dell’ambiente è parte dei programmi di sviluppoEcologia sociale: dalla famiglia alle relazioni internazionali, deve avere una ricaduta istituzionaleEcologia istituzionale: la salute delle istituzioni ha ricadute e influenza sull’ambiente e sulle relazioni umane (142)Ecologia culturale: si tratta di rilevare gli elementi culturali che, dalle tradizioni aborigene alle più moderne espressioni, rischiano di essere spazzati via dalle logiche di consumo che appiattiscono queste espressioni dell’animo umano (145-146). La terra è un dono di Dio e tale idea è parte di alcune culture originarie che, se scomparissero, significherebbero un pericoloso impoverimento della cultura umana.
Ecologia umana: nel degrado di certe situazioni ambientali critiche, anche in presenza di negatività, si deve credere che la solidarietà, l’appartenenza alla famiglia umana e l’amore cristiano sono più forti. Segnala l’importanza di avere una casa e una abitazione per la famiglia, restituendo l’urbanizzazione a criteri più umani e solidali. Esalta l’idea della partecipazione attiva degli abitanti, della integrazione dei quartieri poveri nell’alveo della città tutta. Altro problema: i trasporti, criticità delle megalopoli. Un trattamento indegno della persona a causa di affollamento, trasporti, concentrazioni urbane va combattuto: emerge la concretezza dello sguardo del papa che è uso servirsi di mezzi pubblici e ben conosce le situazioni di cui parla…Si parla di ecologia dell’uomo (155): anche l’uomo possiede una natura che non può manipolare, a partire dal proprio corpo che va accolto e accettato come dono, aprendosi all’altro e la mondo intero come doni.
Critica il rifiuto della differenza sessuale da parte di chi non sanno più confrontarsi con essa.Apertura progressiva: l’io diventa un noi che si integra nel tutti, dalla stanza alla casa, dal quartiere alla città, fino al mondo.L’ecologia integrale è inseparabile dal principio del bene comune, cioè quelle condizioni di vita sociale che permettono ai singoli e ai gruppi di raggiungere la propria perfezione più speditamente e più perfettamente (157) Insiste sulla famiglia come orizzonte in cui si afferma quel “Noi” che inserisce “io” nel “tutti”.
La giustizia tra le generazioni: il dono della terra implica la responsabilità della custodia tra generazioni diverse.Tutto questo si apre a interrogativi esistenziali: perché siamo sulla terra? Non “che dobbiamo fare?”, bensì: “chi siamo noi?”. E impegna a uno sforzo più grande verso i poveri e gli ultimi (così papa Francesco integra con l’opzione dei poveri la prospettiva “verde” del patriarca Bartolomeo).
CAPITOLO QUARTO UN’ECOLOGIA INTEGRALE137. Dal momento che tutto è intimamente relazionato e che gli attuali problemi richiedono uno sguardo che tenga conto di tutti gli aspetti della crisi mondiale, propongo di soffermarci adesso a riflettere sui diversi elementi di una ecologia integrale, che comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali.
Ecologia ambientale, economica e sociale 138. L’ecologia studia le relazioni tra gli organismi viventi e l’ambiente in cui si sviluppano. Essa esige anche di fermarsi a pensare e a discutere sulle condizioni di vita e di sopravvivenza di una società, con l’onestà di mettere in dubbio modelli di sviluppo, produzione e consumo. …Come i diversi componenti del pianeta – fisici, chimici e biologici – sono relazionati tra loro, così anche le specie viventi formano una rete che non finiamo mai di riconoscere e comprendere. Buona parte della nostra informazione genetica è condivisa con molti esseri viventi. Per tale ragione, le conoscenze frammentarie e isolate possono diventare una forma d’ignoranza se fanno resistenza ad integrarsi in una visione più ampia della realtà.139. Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una particolare relazione: quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. …È fondamentale cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura. 140. A causa della quantità e varietà degli elementi di cui tenere conto, al momento di determinare l’impatto ambientale di una concreta attività d’impresa diventa indispensabile dare ai ricercatori un ruolo preminente e facilitare la loro interazione, con ampia libertà accademica. Questa ricerca costante dovrebbe permettere di riconoscere anche come le diverse creature si relazionano, formando quelle unità più grandi che oggi chiamiamo “ecosistemi”. Non li prendiamo in considerazione solo per determinare quale sia il loro uso ragionevole, ma perché possiedono un valore intrinseco indipendente da tale uso. Come ogni organismo è buono e mirabile in sé stesso per il fatto di essere una creatura di Dio, lo stesso accade con l’insieme armonico di organismi in uno spazio determinato, che funziona come un sistema. Anche se non ne abbiamo coscienza, dipendiamo da tale insieme per la nostra stessa esistenza. …viviamo e agiamo a partire da una realtà che ci è stata previamente donata, che è anteriore alle nostre capacità e alla nostra esistenza. Perciò, quando si parla di “uso sostenibile” bisogna sempre introdurre una considerazione sulla capacità di rigenerazione di ogni ecosistema nei suoi diversi settori e aspetti. 141. D’altra parte, la crescita economica tende a produrre automatismi e ad omogeneizzare, al fine di semplificare i processi e ridurre i costi. Per questo è necessaria un’ecologia economica, capace di indurre a considerare la realtà in maniera più ampia. Infatti, «la protezione dell’ambiente dovrà costituire parte integrante del processo di sviluppo e non potrà considerarsi in maniera isolata». Ma nello stesso tempo diventa attuale la necessità impellente dell’umanesimo, che fa appello ai diversi saperi, anche quello economico, per una visione più integrale e integrante. …C’è una interazione tra gli ecosistemi e tra i diversi mondi di riferimento sociale, e così si dimostra ancora una volta che «il tutto è superiore alla parte».142. Se tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle istituzioni di una società comporta conseguenze per l’ambiente e per la qualità della vita umana: «Ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica provoca danni ambientali». In tal senso, l’ecologia sociale è necessariamente istituzionale e raggiunge progressivamente le diverse dimensioni che vanno dal gruppo sociale primario, la famiglia, fino alla vita internazionale, passando per la comunità locale e la Nazione. All’interno di ciascun livello sociale e tra di essi, si sviluppano le istituzioni che regolano le relazioni umane. Tutto ciò che le danneggia comporta effetti nocivi, come la perdita della libertà, l’ingiustizia e la violenza. Diversi Paesi sono governati da un sistema istituzionale precario, a costo delle sofferenze della popolazione e a beneficio di coloro che lucrano su questo stato di cose. Tanto all’interno dell’amministrazione dello Stato, quanto nelle diverse espressioni della società civile, o nelle relazioni degli abitanti tra loro, si registrano con eccessiva frequenza comportamenti illegali…
Ecologia culturale 143. Insieme al patrimonio naturale, vi è un patrimonio storico, artistico e culturale, ugualmente minacciato. È parte dell’identità comune di un luogo e base per costruire una città abitabile. Non si tratta di distruggere e di creare nuove città ipoteticamente più ecologiche, dove non sempre risulta desiderabile vivere. Bisogna integrare la storia, la cultura e l’architettura di un determinato luogo, salvaguardandone l’identità originale. Perciò l’ecologia richiede anche la cura delle ricchezze culturali dell’umanità nel loro significato più ampio...144. La visione consumistica dell’essere umano, favorita dagli ingranaggi dell’attuale economia globalizzata, tende a rendere omogenee le culture e a indebolire l’immensa varietà culturale, che è un tesoro dell’umanità. Per tale ragione, pretendere di risolvere tutte le difficoltà mediante normative uniformi o con interventi tecnici, porta a trascurare la complessità delle problematiche locali, che richiedono la partecipazione attiva degli abitanti. I nuovi processi in gestazione non possono sempre essere integrati entro modelli stabiliti dall’esterno ma provenienti dalla stessa cultura locale. Così come la vita e il mondo sono dinamici, la cura del mondo dev’essere flessibile e dinamica. Le soluzioni meramente tecniche corrono il rischio di prendere in considerazione sintomi che non corrispondono alle problematiche più profonde. È necessario assumere la prospettiva dei diritti dei popoli e delle culture, e in tal modo comprendere che lo sviluppo di un gruppo sociale suppone un processo storico all’interno di un contesto culturale e richiede il costante protagonismo degli attori sociali locali a partire dalla loro propria cultura. Neppure la nozione di qualità della vita si può imporre, ma dev’essere compresa all’interno del mondo di simboli e consuetudini propri di ciascun gruppo umano. 145. …La scomparsa di una cultura può essere grave come o più della scomparsa di una specie animale o vegetale. L’imposizione di uno stile egemonico di vita legato a un modo di produzione può essere tanto nocivo quanto l’alterazione degli ecosistemi. 146. In questo senso, è indispensabile prestare speciale attenzione alle comunità aborigene con le loro tradizioni culturali. …Quando rimangono nei loro territori, sono quelli che meglio se ne prendono cura. Tuttavia, in diverse parti del mondo, sono oggetto di pressioni affinché abbandonino le loro terre e le lascino libere per progetti estrattivi, agricoli o di allevamento che non prestano attenzione al degrado della natura e della cultura.
Ecologia della vita quotidiana 147. Per poter parlare di autentico sviluppo, occorrerà verificare che si produca un miglioramento integrale nella qualità della vita umana, e questo implica analizzare lo spazio in cui si svolge l’esistenza delle persone. Gli ambienti in cui viviamo influiscono sul nostro modo di vedere la vita, di sentire e di agire... 148. È ammirevole la creatività e la generosità di persone e gruppi che sono capaci di ribaltare i limiti dell’ambiente, modificando gli effetti avversi dei condizionamenti, e imparando ad orientare la loro esistenza in mezzo al disordine e alla precarietà. Per esempio, in alcuni luoghi, dove le facciate degli edifici sono molto deteriorate, vi sono persone che curano con molta dignità l’interno delle loro abitazioni, o si sentono a loro agio per la cordialità e l’amicizia della gente. La vita sociale positiva e benefica degli abitanti diffonde luce in un ambiente a prima vista invivibile. …In tal modo, qualsiasi luogo smette di essere un inferno e diventa il contesto di una vita degna. 149. È provato inoltre che l’estrema penuria che si vive in alcuni ambienti privi di armonia, ampiezza e possibilità d’integrazione, facilita il sorgere di comportamenti disumani e la manipolazione delle persone da parte di organizzazioni criminali. …Tuttavia mi preme ribadire che l’amore è più forte. Tante persone, in queste condizioni, sono capaci di tessere legami di appartenenza e di convivenza che trasformano l’affollamento in un’esperienza comunitaria in cui si infrangono le pareti dell’io e si superano le barriere dell’egoismo. Questa esperienza di salvezza comunitaria è ciò che spesso suscita reazioni creative per migliorare un edificio o un quartiere.150. Data l’interrelazione tra gli spazi urbani e il comportamento umano, coloro che progettano edifici, quartieri, spazi pubblici e città, hanno bisogno del contributo di diverse discipline che permettano di comprendere i processi, il simbolismo e i comportamenti delle persone …è tanto importante che il punto di vista degli abitanti del luogo contribuisca sempre all’analisi della pianificazione urbanistica.151. È necessario curare gli spazi pubblici, i quadri prospettici e i punti di riferimento urbani che accrescono il nostro senso di appartenenza, la nostra sensazione di radicamento, il nostro “sentirci a casa” all’interno della città che ci contiene e ci unisce. …come parte di un “noi” che costruiamo insieme. Per questa stessa ragione, sia nell’ambiente urbano sia in quello rurale, è opportuno preservare alcuni spazi nei quali si evitino interventi umani che li modifichino continuamente. 152. La mancanza di alloggi è grave in molte parti del mondo, tanto nelle zone rurali quanto nelle grandi città, anche perché i bilanci statali di solito coprono solo una piccola parte della domanda. Non soltanto i poveri, ma una gran parte della società incontra serie difficoltà ad avere una casa propria. La proprietà della casa ha molta importanza per la dignità delle persone e per lo sviluppo delle famiglie. Si tratta di una questione centrale dell’ecologia umana…153. La qualità della vita nelle città è legata in larga parte ai trasporti, che sono spesso causa di grandi sofferenze per gli abitanti. Nelle città circolano molte automobili utilizzate da una o due persone, per cui il traffico diventa intenso, si alza il livello d’inquinamento, si consumano enormi quantità di energia non rinnovabile e diventa necessaria la costruzione di più strade e parcheggi, che danneggiano il tessuto urbano. Molti specialisti concordano sulla necessità di dare priorità ai trasporti pubblici. Tuttavia alcune misure necessarie difficilmente saranno accettate in modo pacifico dalla società
senza un miglioramento sostanziale di tali trasporti, che in molte città comporta un trattamento indegno delle persone a causa dell’affollamento, della scomodità o della scarsa frequenza dei servizi e dell’insicurezza.154. Il riconoscimento della peculiare dignità dell’essere umano molte volte contrasta con la vita caotica che devono condurre le persone nelle nostre città...155. L’ecologia umana implica anche qualcosa di molto profondo: la necessaria relazione della vita dell’essere umano con la legge morale inscritta nella sua propria natura, relazione indispensabile per poter creare un ambiente più dignitoso. Affermava Benedetto XVI che esiste una «ecologia dell’uomo» perché «anche l’uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere». In questa linea, bisogna riconoscere che il nostro corpo ci pone in una relazione diretta con l’ambiente e con gli altri esseri viventi. L’accettazione del proprio corpo come dono di Dio è necessaria per accogliere e accettare il mondo intero come dono del Padre e casa comune; invece una logica di dominio sul proprio corpo si trasforma in una logica a volte sottile di dominio sul creato. Imparare ad accogliere il proprio corpo, ad averne cura e a rispettare i suoi significati è essenziale per una vera ecologia umana. Anche apprezzare il proprio corpo nella sua femminilità o mascolinità è necessario per poter riconoscere sé stessi nell’incontro con l’altro diverso da sé. In tal modo è possibile accettare con gioia il dono specifico dell’altro o dell’altra, opera di Dio creatore, e arricchirsi reciprocamente. Pertanto, non è sano un atteggiamento che pretenda di «cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa».
Il principio del bene Comune 156. L’ecologia integrale è inseparabile dalla nozione di bene comune, un principio che svolge un ruolo centrale e unificante nell’etica sociale. È «l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente». 157. Il bene comune presuppone il rispetto della persona umana in quanto tale, con diritti fondamentali e inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale. Esige anche i dispositivi di benessere e sicurezza sociale e lo sviluppo dei diversi gruppi intermedi, applicando il principio di sussidiarietà. Tra questi risalta specialmente la famiglia, come cellula primaria della società. Infine, il bene comune richiede la pace sociale, vale a dire la stabilità e la sicurezza di un determinato ordine, che non si realizza senza un’attenzione particolare alla giustizia distributiva, la cui violazione genera sempre violenza. Tutta la società – e in essa specialmente lo Stato – ha l’obbligo di difendere e promuovere il bene comune. 158. Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove si riscontrano tante in-equità e sono sempre più numerose le persone che vengono scartate, private dei diritti umani fondamentali, il principio del bene comune si trasforma immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, in un appello alla solidarietà e in una opzione preferenziale per i più poveri. Questa opzione richiede di trarre le conseguenze della destinazione comune dei beni della terra, ma, come ho cercato di mostrare nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, esige di contemplare prima di tutto l’immensa dignità del povero alla luce delle più profonde convinzioni di fede. Basta osservare la realtà per comprendere che oggi questa opzione è un’esigenza etica fondamentale per l’effettiva realizzazione del bene comune.
La giustizia tra le generazioni 159. La nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. Le crisi economiche internazionali hanno mostrato con crudezza gli effetti nocivi che porta con sé il disconoscimento di un destino comune, dal quale non possono essere esclusi coloro che verranno dopo di noi. Ormai non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra le generazioni. Quando pensiamo alla situazione in cui si lascia il pianeta alle future generazioni, entriamo in un’altra logica, quella del dono gratuito che riceviamo e comunichiamo. Se la terra ci è donata, non possiamo più pensare soltanto a partire da un criterio utilitarista di efficienza e produttività per il profitto individuale. …una questione essenziale di giustizia, dal momento che la terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno...160. Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo? …ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti. …A che scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c’è in gioco è la dignità di noi stessi…161. Le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia. Potremmo lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizia. Il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione dell’ambiente ha superato le possibilità del pianeta, in maniera tale che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente in catastrofi, come di fatto sta già avvenendo periodicamente in diverse regioni…162. La difficoltà a prendere sul serio questa sfida è legata ad un deterioramento etico e culturale, che accompagna quello ecologico. L’uomo e la donna del mondo postmoderno corrono il rischio permanente di diventare profondamente individualisti, e molti problemi sociali attuali sono da porre in relazione con la ricerca egoistica della soddisfazione immediata, con le crisi dei legami familiari e sociali, con le difficoltà a riconoscere l’altro. …Perciò, «oltre alla leale solidarietà intergenerazionale, occorre reiterare l’urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà intragenerazionale».
Capitolo QUINTO - ALCUNE LINEE DI ORIENTAMENTO E DI AZIONE (163-201)
Il papa avanza una proposta per uscire dalla spirale di autodistruzione in cui stiamo affondando (163).
Propone 5 piste di dialogo1 – nella politica internazionale2 – per nuove politiche nazionali e locali3 – per la trasparenza nei processi decisionali4 - tra politica ed economia5 – tra scienza e religione
1--Se abitiamo una casa comune, dobbiamo condividere un progetto comune (164), sulla base del lavoro svolto dal movimento ecologico mondiale attraverso vari incontri di vertice, fino alla dichiarazione dell’ONU sullo Sviluppo Sostenibile (2012).Manca una presa di coscienza globale e occorrono cambiamenti radicali (170), come pure accordi internazionali per la tutela dei beni comuni globali (174). Auspica una autorità politica mondiale che tuteli il bene complessivo dell’umanità.
2--A livello nazionale e locale non mancano importanti risorse il cui uso va regolamentato dalla legge che deve ridurre gli effetti inquinanti della produzione (177), incoraggiando i comportamenti virtuosi a livello locale (179) laddove più si colgono l’amore per la terra e l’ambiente. Occorre tempo e lungimiranza per valorizzare le risorse e cogliere gli obiettivi.
3—I processi decisionali della politica relativi all’ambiente devono essere trasparenti. Solo così si può mettere in atto una reale tutela dell’ambiente, opponendosi alla logica dell’utile che, anche tramite la corruzione, nasconde spesso i reali rischi di determinate scelte (182). Occorre valutare l’impatto ambientale (partecipazione, informazione, controllo).Occorre interrogarsi sul vero sviluppo implicito in una scelta di politica imprenditoriale. Emerge la necessità di rispettare sempre il principio di precauzione (187) per fermare o modificare il proprio agire a fronte di un rischio possibile (cfr. COMPENDIO DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA)
4—Fondamentale è il dialogo tra politica ed economia, che devono essere al servizio della vita, non del risultato. La logica della rendita ha portato a un tale degrado ambientale che ormai bisogna trovare delle soluzioni, in una ottica di ecologia integrale che sappia coniugare economia ed etica. Lo sviluppo sostenibile comporta anche una attenzione alle popolazioni più povere, per rispetto alle quali può esser chiesto un rallentamento del ritmo di crescita delle popolazioni più sviluppate. Alcuni obiettano che questo sarebbe un rallentamento del progresso, ma il papa dice che progresso è solo quello in cui l’avanzamento tecnologico non è svincolato dal rispetto della qualità della vita umana. Etico sarebbe dunque un comportamento in cui l’investimento economico ricade su chi è attore (cioè i popoli più sviluppati non fanno “pagare” i propri investimenti a quelli più poveri…).Principio di sussidiarietà e lotta alla corruzione per rendere efficace l’azione politica.È necessaria una “certa” decrescita (teoria di Latouche, cui si oppone ad esempio Zamagni), non una decrescita a tutti i costi.
5—La scienza deve riconoscere i propri limiti: non risponde alle domande di senso. Il ruolo della fede è supportato da un forte richiamo alla coerenza dei credenti. Se la maggior parte degli uomini si dichiarano credenti, allora le diverse religioni dovrebbero entrare in dialogo tra loro per collaborare alla tutela ambientale. Così pure le diverse scienze dovrebbero collaborare tra loro.
CAPITOLO QUINTO ALCUNE LINEE DI ORIENTAMENTO E DI AZIONE163. Ho cercato di prendere in esame la situazione attuale dell’umanità, tanto nelle crepe del pianeta che abitiamo, quanto nelle cause più profondamente umane del degrado ambientale. …proviamo ora a delineare dei grandi percorsi di dialogo che ci aiutino ad uscire dalla spirale di autodistruzione in cui stiamo affondando.
Il dialogo sull’ambiente nella politica internazionale 164. Dalla metà del secolo scorso, superando molte difficoltà, si è andata affermando la tendenza a concepire il pianeta come patria e l’umanità come popolo che abita una casa comune. …L’interdipendenza ci obbliga a pensare a un solo mondo, ad un progetto comune. Ma lo stesso ingegno utilizzato per un enorme sviluppo tecnologico, non riesce a trovare forme efficaci di gestione internazionale in ordine a risolvere le gravi difficoltà ambientali e sociali. Per affrontare i problemi di fondo, che non possono essere risolti da azioni di singoli Paesi, si rende indispensabile un consenso mondiale che porti, ad esempio, a programmare un’agricoltura sostenibile e diversificata, a sviluppare forme rinnovabili e poco inquinanti di energia, a incentivare una maggiore efficienza energetica, a promuovere una gestione più adeguata delle risorse forestali e marine, ad assicurare a tutti l’accesso all’acqua potabile. 165. …In attesa di un ampio sviluppo delle energie rinnovabili, che dovrebbe già essere cominciato, è legittimo optare per l’alternativa meno dannosa o ricorrere a soluzioni transitorie. Tuttavia, nella comunità internazionale non si raggiungono accordi adeguati circa la responsabilità di coloro che devono sopportare i costi maggiori della transizione energetica. Negli ultimi decenni le questioni ambientali hanno dato origine a un ampio dibattito pubblico, che ha fatto crescere nella società civile spazi di notevole impegno e di generosa dedizione. La politica e l’industria rispondono con lentezza, lontane dall’essere all’altezza delle sfide mondiali. In questo senso si può dire che, mentre l’umanità del periodo post-industriale sarà forse ricordata come una delle più irresponsabili della storia, c’è da augurarsi che l’umanità degli inizi del XXI secolo possa essere ricordata per aver assunto con generosità le proprie gravi responsabilità. 166. Il movimento ecologico mondiale ha già fatto un lungo percorso, arricchito dallo sforzo di molte organizzazioni della società civile. …Ciononostante, i Vertici mondiali sull’ambiente degli ultimi anni non hanno risposto alle aspettative perché, per mancanza di decisione politica, non hanno raggiunto accordi ambientali globali realmente significativi ed efficaci. 167. Va ricordato il Vertice della Terra celebrato nel 1992 a Rio de Janeiro. In quella sede è stato dichiarato che «gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile». Riprendendo alcuni contenuti della Dichiarazione di Stoccolma (1972), ha sancito, tra l’altro, la cooperazione internazionale per la cura dell’ecosistema di tutta la terra, l’obbligo da parte di chi inquina di farsene carico economicamente, il dovere di valutare l’impatto ambientale di ogni opera o progetto. Ha proposto l’obiettivo di stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera per invertire la tendenza al riscaldamento globale. Ha elaborato anche un’agenda con un programma di azione e una convenzione sulla diversità biologica, ha dichiarato principi in materia forestale. Benché quel vertice sia stato veramente innovativo e profetico per la sua epoca, gli accordi hanno avuto un basso livello di attuazione perché non si sono stabiliti adeguati meccanismi di controllo, di verifica periodica e di sanzione delle inadempienze. I principi enunciati continuano a richiedere vie efficaci e agili di realizzazione pratica. 168. Tra le esperienze positive si può menzionare, per esempio, la Convenzione di Basilea sui rifiuti pericolosi, con un sistema di notificazione, di livelli stabiliti e di controlli… Grazie alla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e la sua attuazione mediante il Protocollo di Montreal e i suoi emendamenti, il problema dell’assottigliamento di questo strato sembra essere entrato in una fase di soluzione. 169. Riguardo alla cura per la diversità biologica e la desertificazione, i progressi sono stati molto meno significativi. Per quanto attiene ai cambiamenti climatici, i progressi sono deplorevolmente molto scarsi. La riduzione dei gas serra richiede onestà, coraggio e responsabilità, soprattutto da parte dei Paesi più potenti e più inquinanti. La Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile denominata Rio+20 (Rio de Janeiro 2012), ha emesso un’ampia quanto inefficace Dichiarazione finale. I negoziati internazionali non possono avanzare in maniera significativa a causa delle posizioni dei Paesi che privilegiano i propri interessi nazionali rispetto al bene comune globale. …Noi credenti non possiamo non pregare Dio per gli sviluppi positivi delle attuali discussioni, in modo che le generazioni future non soffrano le conseguenze di imprudenti indugi. 170. Alcune delle strategie per la bassa emissione di gas inquinanti puntano alla internazionalizzazione dei costi ambientali, con il pericolo di imporre ai Paesi con minori risorse pesanti impegni sulle riduzioni di emissioni, simili a quelli dei Paesi più industrializzati. L’imposizione di queste misure penalizza i Paesi più bisognosi di sviluppo. In questo modo si aggiunge una nuova ingiustizia sotto il rivestimento della cura per l’ambiente...171. La strategia di compravendita di “crediti di emissione” può dar luogo a una nuova forma di speculazione e non servirebbe a ridurre l’emissione globale di gas inquinanti. Questo sistema sembra essere una soluzione rapida e facile, con l’apparenza di un certo impegno per l’ambiente, che però non implica affatto un cambiamento radicale all’altezza delle circostanze. Anzi, può diventare un espediente che consente di sostenere il super-consumo di alcuni Paesi e settori.172. Per i Paesi poveri le priorità devono essere lo sradicamento della miseria e lo sviluppo sociale dei loro abitanti; al tempo stesso devono prendere in esame il livello scandaloso di consumo di alcuni settori privilegiati della loro popolazione e contrastare meglio la corruzione. …Lo sfruttamento diretto dell’abbondante energia solare richiede che si stabiliscano meccanismi e sussidi in modo che i Paesi in via di sviluppo possano avere accesso al trasferimento di tecnologie, ad assistenza tecnica e a risorse finanziarie, ma sempre prestando attenzione alle condizioni concrete, giacché «non sempre viene adeguatamente valutata la compatibilità degli impianti con il contesto per il quale sono progettati». I costi sarebbero bassi se raffrontati al rischio dei cambiamenti climatici. In ogni modo, è anzitutto una decisione etica, fondata sulla solidarietà di tutti i popoli.
173. Urgono accordi internazionali che si realizzino, considerata la scarsa capacità delle istanze locali di intervenire in modo efficace. Le relazioni tra Stati devono salvaguardare la sovranità di ciascuno, ma anche stabilire percorsi concordati per evitare catastrofi locali che finirebbero per danneggiare tutti…174. Menzioniamo anche il sistema di governance degli oceani. Infatti, benché vi siano state diverse convenzioni internazionali e regionali, la frammentazione e l’assenza di severi meccanismi di regolamentazione, controllo e sanzione finiscono con il minare tutti gli sforzi. …In definitiva, abbiamo bisogno di un accordo sui regimi di governance per tutta la gamma dei cosiddetti beni comuni globali. 175. …Abbiamo bisogno di una reazione globale più responsabile, che implica affrontare contemporaneamente la riduzione dell’inquinamento e lo sviluppo dei Paesi e delle regioni povere …diventa indispensabile lo sviluppo di istituzioni internazionali più forti ed efficacemente organizzate, con autorità designate in maniera imparziale mediante accordi tra i governi nazionali e dotate del potere di sanzionare. Come ha affermato Benedetto XVI nella linea già sviluppata dalla dottrina sociale della Chiesa, «per il governo dell’economia mondiale; per risanare le economie colpite dalla crisi, per prevenire peggioramenti della stessa e conseguenti maggiori squilibri; per realizzare un opportuno disarmo integrale, la sicurezza alimentare e la pace; per garantire la salvaguardia dell’ambiente e per regolamentare i flussi migratori, urge la presenza di una vera Autorità politica mondiale, quale è stata già tratteggiata dal mio Predecessore, [san] Giovanni XXIII». In tale prospettiva, la diplomazia acquista un’importanza inedita, in ordine a promuovere strategie internazionali per prevenire i problemi più gravi che finiscono per colpire tutti.
Il dialogo verso nuove politiche nazionali e locali 176. Non solo ci sono vincitori e vinti tra i Paesi, ma anche all’interno dei Paesi poveri, in cui si devono identificare diverse responsabilità. Perciò, le questioni relative all’ambiente e allo sviluppo economico non si possono più impostare solo a partire dalle differenze tra i Paesi, ma chiedono di porre attenzione alle politiche nazionali e locali. 177. Dinanzi alla possibilità di un utilizzo irresponsabile delle capacità umane, sono funzioni improrogabili di ogni Stato quelle di pianificare, coordinare, vigilare e sanzionare all’interno del proprio territorio. La società, in che modo ordina e custodisce il proprio divenire in un contesto di costanti innovazioni tecnologiche? Un fattore che agisce come moderatore effettivo è il diritto, che stabilisce le regole per le condotte consentite alla luce del bene comune. I limiti che deve imporre una società sana, matura e sovrana sono attinenti a previsione e precauzione, regolamenti adeguati, vigilanza sull’applicazione delle norme, contrasto della corruzione, azioni di controllo operativo sull’emergere di effetti non desiderati dei processi produttivi, e intervento opportuno di fronte a rischi indeterminati o potenziali… 178. Il dramma di una politica focalizzata sui risultati immediati, sostenuta anche da popolazioni consumiste, rende necessario produrre crescita a breve termine. Rispondendo a interessi elettorali, i governi non si azzardano facilmente a irritare la popolazione con misure che possano intaccare il livello di consumo o mettere a rischio investimenti esteri. La miope costruzione del potere frena l’inserimento dell’agenda ambientale lungimirante all’interno dell’agenda pubblica dei governi. Si dimentica così che «il tempo è superiore allo spazio», che siamo sempre più fecondi quando ci preoccupiamo di generare processi, piuttosto che di dominare spazi di potere. La grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base di grandi princìpi e pensando al bene comune a lungo termine. Il potere politico fa molta fatica ad accogliere questo dovere in un progetto di Nazione. 179. In alcuni luoghi, si stanno sviluppando cooperative per lo sfruttamento delle energie rinnovabili che consentono l’autosufficienza locale e persino la vendita della produzione in eccesso. Questo semplice esempio indica che, mentre l’ordine mondiale esistente si mostra impotente ad assumere responsabilità, l’istanza locale può fare la differenza. …La società, attraverso organismi non governativi e associazioni intermedie, deve obbligare i governi a sviluppare normative, procedure e controlli più rigorosi. Se i cittadini non controllano il potere politico – nazionale, regionale e municipale – neppure è possibile un contrasto dei danni ambientali. D’altra parte, le legislazioni municipali possono essere più efficaci se ci sono accordi tra popolazioni vicine per sostenere le medesime politiche ambientali. 180. Non si può pensare a ricette uniformi, perché vi sono problemi e limiti specifici di ogni Paese e regione. È vero anche che il realismo politico può richiedere misure e tecnologie di transizione, sempre che siano accompagnate dal disegno e dall’accettazione di impegni graduali vincolanti. Allo stesso tempo, però, in ambito nazionale e locale c’è sempre molto da fare, ad esempio promuovere forme di risparmio energetico. …Si possono facilitare forme di cooperazione o di organizzazione comunitaria che difendano gli interessi dei piccoli produttori e preservino gli ecosistemi locali dalla depredazione. È molto quello che si può fare! 181. È indispensabile la continuità, giacché non si possono modificare le politiche relative ai cambiamenti climatici e alla protezione dell’ambiente ogni volta che cambia un governo. I risultati richiedono molto tempo e comportano costi immediati con effetti che non potranno essere esibiti nel periodo di vita di un governo. Per questo, senza la pressione della popolazione e delle istituzioni, ci saranno sempre resistenze ad intervenire, ancor più quando ci siano urgenze da risolvere. Che un politico assuma queste responsabilità con i costi che implicano, non risponde alla logica efficientista e “immediatista” dell’economia e della politica attuali, ma se avrà il coraggio di farlo, potrà nuovamente riconoscere la dignità che Dio gli ha dato come persona e lascerà, dopo il suo passaggio in questa storia, una testimonianza di generosa responsabilità...
Dialogo e trasparenza nei processi decisionali
182. La previsione dell’impatto ambientale delle iniziative imprenditoriali e dei progetti richiede processi politici trasparenti e sottoposti al dialogo, mentre la corruzione che nasconde il vero impatto ambientale di un progetto in cambio di favori spesso porta ad accordi ambigui che sfuggono al dovere di informare ed a un dibattito approfondito.183. Uno studio di impatto ambientale non dovrebbe essere successivo all’elaborazione di un progetto produttivo o di qualsiasi politica, piano o programma. Va inserito fin dall’inizio e dev’essere elaborato in modo interdisciplinare, trasparente e indipendente da ogni pressione economica o politica. Dev’essere connesso con l’analisi delle condizioni di lavoro e dei possibili effetti sulla salute fisica e mentale delle persone, sull’economia locale, sulla sicurezza. I risultati economici si potranno così prevedere in modo più realistico, tenendo conto degli scenari possibili ed eventualmente anticipando la necessità di un investimento maggiore per risolvere effetti indesiderati che possano essere corretti. …La partecipazione richiede che tutti siano adeguatamente informati sui diversi aspetti e sui vari rischi e possibilità, e non si riduce alla decisione iniziale su un progetto, ma implica anche azioni di controllo o monitoraggio costante. C’è bisogno di sincerità e verità nelle discussioni scientifiche e politiche, senza limitarsi a considerare che cosa sia permesso o meno dalla legislazione. 184. Quando compaiono eventuali rischi per l’ambiente che interessano il bene comune presente e futuro, questa situazione richiede «che le decisioni siano basate su un confronto tra rischi e benefici ipotizzabili per ogni possibile scelta alternativa». …Alcuni progetti, non supportati da un’analisi accurata, possono intaccare profondamente la qualità della vita di un luogo per questioni molto diverse tra loro come, ad esempio, un inquinamento acustico non previsto, la riduzione dell’ampiezza visuale, la perdita di valori culturali, gli effetti dell’uso dell’energia nucleare. La cultura consumistica, che dà priorità al breve termine e all’interesse privato, può favorire pratiche troppo rapide o consentire l’occultamento dell’informazione. 185. In ogni discussione riguardante un’iniziativa imprenditoriale si dovrebbe porre una serie di domande, per poter discernere se porterà ad un vero sviluppo integrale: Per quale scopo? Per quale motivo? Dove? Quando? In che modo? A chi è diretto? Quali sono i rischi? A quale costo? Chi paga le spese e come lo farà? In questo esame ci sono questioni che devono avere la priorità…186. Nella Dichiarazione di Rio del 1992, si sostiene che «laddove vi sono minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di piene certezze scientifiche non potrà costituire un motivo per ritardare l’adozione di misure efficaci» che impediscano il degrado dell’ambiente. Questo principio di precauzione permette la protezione dei più deboli, che dispongono di pochi mezzi per difendersi e per procurare prove irrefutabili. Se l’informazione oggettiva porta a prevedere un danno grave e irreversibile, anche se non ci fosse una dimostrazione indiscutibile, qualunque progetto dovrebbe essere fermato o modificato...187. Questo non significa opporsi a qualsiasi innovazione tecnologica che consenta di migliorare la qualità della vita di una popolazione. Ma in ogni caso deve rimanere fermo che la redditività non può essere l’unico criterio da tener presente …Il risultato della discussione potrà essere la decisione di non proseguire in un progetto, ma potrebbe anche essere la sua modifica o l’elaborazione di proposte alternative. 188. Ci sono discussioni, su questioni relative all’ambiente, nelle quali è difficile raggiungere un consenso. Ancora una volta ribadisco che la Chiesa non pretende di definire le questioni scientifiche, né di sostituirsi alla politica, ma invito ad un dibattito onesto e trasparente, perché le necessità particolari o le ideologie non ledano il bene comune.
Politica ed economia in dialogo per la pienezza umana 189. La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia. Oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno in modo ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si pongano decisamente al servizio della vita, specialmente della vita umana. …La crisi finanziaria del 2007-2008 era l’occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici, e per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale. Ma non c’è stata una reazione che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti che continuano a governare il mondo...190. In questo contesto bisogna sempre ricordare che «la protezione ambientale non può essere assicurata solo sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici. L’ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di difendere o di promuovere adeguatamente». Ancora una volta, conviene evitare una concezione magica del mercato, che tende a pensare che i problemi si risolvano solo con la crescita dei profitti delle imprese o degli individui. È realistico aspettarsi che chi è ossessionato dalla massimizzazione dei profitti si fermi a pensare agli effetti ambientali che lascerà alle prossime generazioni? ...191. Quando si pongono tali questioni, alcuni reagiscono accusando gli altri di pretendere di fermare irrazionalmente il progresso e lo sviluppo umano. Ma dobbiamo convincerci che rallentare un determinato ritmo di produzione e di consumo può dare luogo a un’altra modalità di progresso e di sviluppo. Gli sforzi per un uso sostenibile delle risorse naturali non sono una spesa inutile, bensì un investimento che potrà offrire altri benefici economici a medio termine. Se non abbiamo ristrettezze di vedute, possiamo scoprire che la diversificazione di una produzione più innovativa e con minore impatto ambientale, può essere molto redditizia. Si tratta di aprire la strada a opportunità differenti, che non implicano di fermare la creatività umana e il suo sogno di progresso, ma piuttosto di incanalare tale energia in modo nuovo. 192. …La diversificazione produttiva offre larghissime possibilità all’intelligenza umana per creare e innovare, mentre protegge l’ambiente e crea più opportunità di lavoro...
193. In ogni modo, se in alcuni casi lo sviluppo sostenibile comporterà nuove modalità per crescere, in altri casi, di fronte alla crescita avida e irresponsabile che si è prodotta per molti decenni, occorre pensare pure a rallentare un po’ il passo, a porre alcuni limiti ragionevoli e anche a ritornare indietro prima che sia tardi. Sappiamo che è insostenibile il comportamento di coloro che consumano e distruggono sempre più, mentre altri ancora non riescono a vivere in conformità alla propria dignità umana. Per questo è arrivata l’ora di accettare una certa decrescita in alcune parti del mondo procurando risorse perché si possa crescere in modo sano in altre parti. Diceva Benedetto XVI che «è necessario che le società tecnologicamente avanzate siano disposte a favorire comportamenti caratterizzati dalla sobrietà, diminuendo il proprio consumo di energia e migliorando le condizioni del suo uso». 194. Affinché sorgano nuovi modelli di progresso abbiamo bisogno di «cambiare il modello di sviluppo globale», la qual cosa implica riflettere responsabilmente «sul senso dell’economia e sulla sua finalità, per correggere le sue disfunzioni e distorsioni». …Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore, non può considerarsi progresso. …In questo quadro, il discorso della crescita sostenibile diventa spesso un diversivo e un mezzo di giustificazione che assorbe valori del discorso ecologista all’interno della logica della finanza e della tecnocrazia, e la responsabilità sociale e ambientale delle imprese si riduce per lo più a una serie di azioni di marketing e di immagine. 195. Il principio della massimizzazione del profitto, che tende ad isolarsi da qualsiasi altra considerazione, è una distorsione concettuale dell’economia: se aumenta la produzione, interessa poco che si produca a spese delle risorse future o della salute dell’ambiente; se il taglio di una foresta aumenta la produzione, nessuno misura in questo calcolo la perdita che implica desertificare un territorio, distruggere la biodiversità o aumentare l’inquinamento. Vale a dire che le imprese ottengono profitti calcolando e pagando una parte infima dei costi. Si potrebbe considerare etico solo un comportamento in cui «i costi economici e sociali derivanti dall’uso delle risorse ambientali comuni siano riconosciuti in maniera trasparente e siano pienamente supportati da coloro che ne usufruiscono e non da altre popolazioni o dalle generazioni future». La razionalità strumentale, che apporta solo un’analisi statica della realtà in funzione delle necessità del momento, è presente sia quando ad assegnare le risorse è il mercato, sia quando lo fa uno Stato pianificatore. 196. Qual è il posto della politica? Ricordiamo il principio di sussidiarietà, che conferisce libertà per lo sviluppo delle capacità presenti a tutti i livelli, ma al tempo stesso esige più responsabilità verso il bene comune da parte di chi detiene più potere...197. Abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione ampia, e che porti avanti un nuovo approccio integrale, includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi. Molte volte la stessa politica è responsabile del proprio discredito, a causa della corruzione e della mancanza di buone politiche pubbliche. …Una strategia di cambiamento reale esige di ripensare la totalità dei processi, poiché non basta inserire considerazioni ecologiche superficiali mentre non si mette in discussione la logica soggiacente alla cultura attuale. Una politica sana dovrebbe essere capace di assumere questa sfida. 198. La politica e l’economia tendono a incolparsi reciprocamente per quanto riguarda la povertà e il degrado ambientale. Ma quello che ci si attende è che riconoscano i propri errori e trovino forme di interazione orientate al bene comune. Mentre gli uni si affannano solo per l’utile economico e gli altri sono ossessionati solo dal conservare o accrescere il potere, quello che ci resta sono guerre o accordi ambigui dove ciò che meno interessa alle due parti è preservare l’ambiente e avere cura dei più deboli. Anche qui vale il principio che «l’unità è superiore al conflitto».
Le religioni nel dialogo con le scienze 199. Non si può sostenere che le scienze empiriche spieghino completamente la vita, l’intima essenza di tutte le creature e l’insieme della realtà. Questo vorrebbe dire superare indebitamente i loro limitati confini metodologici. Se si riflette con questo quadro ristretto, spariscono la sensibilità estetica, la poesia, e persino la capacità della ragione di cogliere il senso e la finalità delle cose. …I princìpi etici che la ragione è capace di percepire possono riapparire sempre sotto diverse vesti e venire espressi con linguaggi differenti, anche religiosi. 200. D’altra parte, qualunque soluzione tecnica che le scienze pretendano di apportare sarà impotente a risolvere i gravi problemi del mondo se l’umanità perde la sua rotta, se si dimenticano le grandi motivazioni che rendono possibile il vivere insieme, il sacrificio, la bontà. In ogni caso, occorrerà fare appello ai credenti affinché siano coerenti con la propria fede e non la contraddicano con le loro azioni, bisognerà insistere perché si aprano nuovamente alla grazia di Dio e attingano in profondità dalle proprie convinzioni sull’amore, sulla giustizia e sulla pace… 201. La maggior parte degli abitanti del pianeta si dichiarano credenti, e questo dovrebbe spingere le religioni ad entrare in un dialogo tra loro orientato alla cura della natura, alla difesa dei poveri, alla costruzione di una rete di rispetto e di fraternità. È indispensabile anche un dialogo tra le stesse scienze, dato che ognuna è solita chiudersi nei limiti del proprio linguaggio, e la specializzazione tende a diventare isolamento e assolutizzazione del proprio sapere. Questo impedisce di affrontare in modo adeguato i problemi dell’ambiente. …andare avanti sulla via del dialogo che richiede pazienza, ascesi e generosità, ricordando sempre che «la realtà è superiore all’idea».
Capitolo SESTO - EDUCAZIONE E SPIRITUALITÀ ECOLOGICA (202-246)
1--Si tratta di puntare su un altro stile di vita, sapendo che dobbiamo operare per il bene comune.Il consumo ossessivo è riflesso del paradigma tecno-economico: è un paradigma assai concreto, che ricade singolarmente nelle decisioni di consumo ossessivo, incidendo nel tessuto del quotidiano.Paura ed egoismo collettivoGli esseri umani sono capaci di ri-orientarsi al beneAbitudini sociali e influenza sulle imprese (occorre esserne consapevoli per correggersi)La Carta della Terra (si tratta di sviluppare una coscienza universale e auto-trascendere la propria individualità, per aprirsi a una mentalità alternativa)Superare l’autoreferenzialità
2--Occorre educare a una alleanza tra umanità & ambiente (Puntare tutto sull’educazione ecologica, contemplativa e del bello).C’è una crisi culturale ed ecologia: bisogna puntare sui giovani che devono essere rieducati a una libertà dagli oggetti materiali.Necessità di una educazione ambientale: dobbiamo essere educati per fare un salto verso il mistero.Creare cittadinanza ecologica: coprirsi di più e accendere meno il riscaldamento, in modo da esprimere con piccoli gesti la consapevolezza del proprio contributo alla causa globale. Piccoli passi che esprimono la grande forza di “cambiare il mondo”.Agenzie educative: la famiglia, la scuola, la parrocchia. Questi soggetti educano a contemplare il creato e a coglierne la bellezza. Educare alla bellezza
3—La conversione ecologica: un impegno culturale che coinvolge tutta la persona umana, per cui l’uomo deve riprendere coscienza che il mondo e le strutture sociali e relazionali sono caratterizzate dallo stile del dono e della gratuità.Spiritualità cristiana ed ecologia: occorre coniugare la spiritualità con le esigenze dell’ecologia, ponendo in dialogo il creato e la naturaDeserti interiori ed esteriori / Conversione della persona e riconciliazione con il creato / La necessità di fare rete / Gratuità e tenerezza / Il dinamismo di Dio: è un processo in corso, in divenire…
4—Gioia e pace: vivere umiltà, sobrietà e gratitudine per contribuire all’integrità della persona umana nel personale e nel sociale, secondo lo stile dell’uomo biblico.Spiritualità cristiana e qualità della vita / La via della sobrietà / La via dell’umiltà / La pace del cuore / Essere presenti a se stessi e agli altriRendere grazie: in modo semplice, prima del pasto e dopo, per far memoria della nostra dipendenza da Dio che ci dona quanto occorre per vivere ogni giorno
5—Amore civile e politico: lo stile della gratuità e del dono diviene capacità di costruire un tessuto sociale di vera relazionalitàFraternità universale / Contro la superficialità morale / La pratica della gentilezza / Il valore dei piccoli gestiLiberarsi dall’indifferenza consumistica
6—I segni sacramentali e il riposo celebrativo: l’Eucaristia è il centro vitale dell’universo, mentre il riposo settimanale diviene lo spazio per Dio e gli altri, a natura e i poveri.Dall’esteriorità all’interiorità / Un legame mistico con tutte le cose / La materia sacramentale / Eucaristia e creato: la domenica è il tempo della nuova creazione / Il tempo del riposo contro il vuoto attivismo
7—La Trinità e la relazione con tutte le creature: più si vive in comunione con Dio, più si approfondisce la comunione con il creatoIl Padre creatoreTrinità e natura: ogni creatura ha in sé struttura trinitaria (memoria, intelligenza, volontà – s. Agostino)La crescita spirituale
8—La Regina di tutto il creato: Maria e Giuseppe insegnano a custodire e ad amare il creatoMaria, Regina del Creato: tenerezza e amore di donna e di madreGiuseppe, uomo della cura: custodisce la sacra famiglia, come pure la Chiesa.
9—Aldilà del sole: la rilevanza escatologica della cura ecologicaIl mistero dell’universo / La cura della casa comune
-Preghiere conclusive (per la nostra terra e con il creato)
CAPITOLO SESTO - EDUCAZIONE E SPIRITUALITÀ ECOLOGICA202. Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l’umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale e educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione.
Puntare su un altro stile di vita 203. Dal momento che il mercato tende a creare un meccanismo consumistico compulsivo per piazzare i suoi prodotti, le persone finiscono con l’essere travolte dal vortice degli acquisti e delle spese superflue. Il consumismo ossessivo è il riflesso soggettivo del paradigma tecno-economico. Accade ciò che già segnalava Romano Guardini: l’essere umano «accetta gli oggetti ordinari e le forme consuete della vita così come gli sono imposte dai piani razionali e dalle macchine normalizzate e, nel complesso, lo fa con l’impressione che tutto questo sia ragionevole e giusto». Tale paradigma fa credere a tutti che sono liberi finché conservano una pretesa libertà di consumare, quando in realtà coloro che possiedono la libertà sono quelli che fanno parte della minoranza che detiene il potere economico e finanziario. In questa confusione, l’umanità postmoderna non ha trovato una nuova comprensione di sé stessa che possa orientarla, e questa mancanza di identità si vive con angoscia. Abbiamo troppi mezzi per scarsi e rachitici fini. 204. La situazione attuale del mondo «provoca un senso di precarietà e di insicurezza, che a sua volta favorisce forme di egoismo collettivo». Quando le persone diventano autoreferenziali e si isolano nella loro coscienza, accrescono la propria avidità. …In questo orizzonte non esiste nemmeno un vero bene comune… 205. Eppure, non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi condizionamento psicologico e sociale che venga loro imposto. Sono capaci di guardare a sé stessi con onestà, di far emergere il proprio disgusto e di intraprendere nuove strade verso la vera libertà... 206. Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. È ciò che accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per modificare il comportamento delle imprese, forzandole a considerare l’impatto ambientale e i modelli di produzione. …«Acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico». Per questo oggi «il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi». 207. La Carta della Terra ci chiamava tutti a lasciarci alle spalle una fase di autodistruzione e a cominciare di nuovo, ma non abbiamo ancora sviluppato una coscienza universale che lo renda possibile. Per questo oso proporre nuovamente quella preziosa sfida: «Come mai prima d’ora nella storia, il destino comune ci obbliga a cercare un nuovo inizio […].per la risolutezza nel raggiungere la sostenibilità, per l’accelerazione della lotta per la giustizia e la pace, e per la gioiosa celebrazione della vita». 208. È sempre possibile sviluppare una nuova capacità di uscire da sé stessi verso l’altro. Senza di essa non si riconoscono le altre creature nel loro valore proprio, non interessa prendersi cura di qualcosa a vantaggio degli altri, manca la capacità di porsi dei limiti per evitare la sofferenza o il degrado di ciò che ci circonda. L’atteggiamento fondamentale di auto-trascendersi, infrangendo la coscienza isolata e l’autoreferenzialità, è la radice che rende possibile ogni cura per gli altri e per l’ambiente...
Educare all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente 209. La coscienza della gravità della crisi culturale ed ecologica deve tradursi in nuove abitudini. Molti sanno che il progresso attuale e il semplice accumulo di oggetti o piaceri non bastano per dare senso e gioia al cuore umano, ma non si sentono capaci di rinunciare a quanto il mercato offre loro. …Per questo ci troviamo davanti ad una sfida educativa.210. L’educazione ambientale è andata allargando i suoi obiettivi. Se all’inizio era molto centrata sull’informazione scientifica e sulla presa di coscienza e prevenzione dei rischi ambientali, ora tende a includere una critica dei “miti” della modernità basati sulla ragione strumentale (individualismo, progresso indefinito, concorrenza, consumismo, mercato senza regole) e anche a recuperare i diversi livelli dell’equilibrio ecologico: quello interiore con sé stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio. L’educazione ambientale dovrebbe disporci a fare quel salto verso il Mistero, da cui un’etica ecologica trae il suo senso più profondo. D’altra parte ci sono educatori capaci di reimpostare gli itinerari pedagogici di un’etica ecologica, in modo che aiutino effettivamente a crescere nella solidarietà, nella responsabilità e nella cura basata sulla compassione. 211. Tuttavia, questa educazione, chiamata a creare una “cittadinanza ecologica”, a volte si limita a informare e non riesce a far maturare delle abitudini. L’esistenza di leggi e norme non è sufficiente a lungo termine per limitare i cattivi comportamenti, anche quando esista un valido controllo. Affinché la norma giuridica produca effetti rilevanti e duraturi è necessario che la maggior parte dei membri della società l’abbia accettata a partire da motivazioni adeguate, e reagisca
secondo una trasformazione personale. Solamente partendo dal coltivare solide virtù è possibile la donazione di sé in un impegno ecologico…212. Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali azioni diffondono un bene nella società che sempre produce frutti al di là di quanto si possa constatare, perché provocano in seno a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente. Inoltre, l’esercizio di questi comportamenti ci restituisce il senso della nostra dignità, ci conduce ad una maggiore profondità esistenziale, ci permette di sperimentare che vale la pena passare per questo mondo. 213. Gli ambiti educativi sono vari: la scuola, la famiglia, i mezzi di comunicazione, la catechesi, e altri. Una buona educazione scolastica nell’infanzia e nell’adolescenza pone semi che possono produrre effetti lungo tutta la vita. Ma desidero sottolineare l’importanza centrale della famiglia… Nella famiglia si coltivano le prime abitudini di amore e cura per la vita, come per esempio l’uso corretto delle cose, l’ordine e la pulizia, il rispetto per l’ecosistema locale e la protezione di tutte le creature. La famiglia è il luogo della formazione integrale, dove si dispiegano i diversi aspetti, intimamente relazionati tra loro, della maturazione personale. Nella famiglia si impara a chiedere permesso senza prepotenza, a dire “grazie” come espressione di sentito apprezzamento per le cose che riceviamo, a dominare l’aggressività o l’avidità, e a chiedere scusa quando facciamo qualcosa di male. Questi piccoli gesti di sincera cortesia aiutano a costruire una cultura della vita condivisa e del rispetto per quanto ci circonda. 214. Alla politica e alle varie associazioni compete uno sforzo di formazione delle coscienze. Compete anche alla Chiesa. Tutte le comunità cristiane hanno un ruolo importante da compiere in questa educazione...215. In questo contesto, «non va trascurata […] la relazione che c’è tra un’adeguata educazione estetica e il mantenimento di un ambiente sano». Prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad uscire dal pragmatismo utilitaristico. Quando non si impara a fermarsi ad ammirare ed apprezzare il bello, non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli. …Altrimenti continuerà ad andare avanti il modello consumistico trasmesso dai mezzi di comunicazione e attraverso gli efficaci meccanismi del mercato.
La Conversione ecologica 216. La grande ricchezza della spiritualità cristiana, generata da venti secoli di esperienze personali e comunitarie, costituisce un magnifico contributo da offrire allo sforzo di rinnovare l’umanità. Desidero proporre ai cristiani alcune linee di spiritualità ecologica che nascono dalle convinzioni della nostra fede, perché ciò che il Vangelo ci insegna ha conseguenze sul nostro modo di pensare, di sentire e di vivere...217. Se «i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i deserti interiori sono diventati così ampi», la crisi ecologica è un appello a una profonda conversione interiore. Tuttavia dobbiamo anche riconoscere che alcuni cristiani impegnati e dediti alla preghiera, con il pretesto del realismo e della pragmaticità, spesso si fanno beffe delle preoccupazioni per l’ambiente. Altri sono passivi, non si decidono a cambiare le proprie abitudini e diventano incoerenti. Manca loro dunque una conversione ecologica, che comporta il lasciar emergere tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda. Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana. 218. Ricordiamo il modello di san Francesco d’Assisi, per proporre una sana relazione col creato come una dimensione della conversione integrale della persona…219. Tuttavia, non basta che ognuno sia migliore per risolvere una situazione tanto complessa come quella che affronta il mondo attuale. I singoli individui possono perdere la capacità e la libertà di vincere la logica della ragione strumentale e finiscono per soccombere a un consumismo senza etica e senza senso sociale e ambientale. Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la mera somma di beni individuali: «Le esigenze di quest’opera saranno così immense che le possibilità delle iniziative individuali e la cooperazione dei singoli, individualisticamente formati, non saranno in grado di rispondervi. Sarà necessaria una unione di forze e una unità di contribuzioni». La conversione ecologica che si richiede per creare un dinamismo di cambiamento duraturo è anche una conversione comunitaria. 220. Tale conversione comporta vari atteggiamenti che si coniugano per attivare una cura generosa e piena di tenerezza. In primo luogo implica gratitudine e gratuità, vale a dire un riconoscimento del mondo come dono ricevuto dall’amore del Padre… Implica pure l’amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri dell’universo una stupenda comunione universale. Per il credente, il mondo non si contempla dal di fuori ma dal di dentro, riconoscendo i legami con i quali il Padre ci ha unito a tutti gli esseri... 221. Diverse convinzioni della nostra fede, sviluppate all’inizio di questa Enciclica, aiutano ad arricchire il senso di tale conversione, come la consapevolezza che ogni creatura riflette qualcosa di Dio e ha un messaggio da trasmetterci, o la certezza che Cristo ha assunto in sé questo mondo materiale e ora, risorto, dimora nell’intimo di ogni essere, circondandolo con il suo affetto e penetrandolo con la sua luce...
Gioia e Pace 222. La spiritualità cristiana propone un modo alternativo di intendere la qualità della vita, e incoraggia uno stile di vita profetico e contemplativo, capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal consumo. È importante accogliere un antico insegnamento, presente in diverse tradizioni religiose, e anche nella Bibbia. Si tratta della convinzione che “meno è di più”. Infatti il costante cumulo di possibilità di consumare distrae il cuore e impedisce di
apprezzare ogni cosa e ogni momento. …È un ritorno alla semplicità che ci permette di fermarci a gustare le piccole cose, di ringraziare delle possibilità che offre la vita senza attaccarci a ciò che abbiamo né rattristarci per ciò che non possediamo. Questo richiede di evitare la dinamica del dominio e della mera accumulazione di piaceri. 223. La sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario. …Si può aver bisogno di poco e vivere molto, soprattutto quando si è capaci di dare spazio ad altri piaceri e si trova soddisfazione negli incontri fraterni, nel servizio, nel mettere a frutto i propri carismi, nella musica e nell’arte, nel contatto con la natura, nella preghiera. La felicità richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono, restando così disponibili per le molteplici possibilità che offre la vita. 224. La sobrietà e l’umiltà non hanno goduto nell’ultimo secolo di una positiva considerazione. Quando però si indebolisce in modo generalizzato l’esercizio di qualche virtù nella vita personale e sociale, ciò finisce col provocare molteplici squilibri, anche ambientali. Per questo non basta più parlare solo dell’integrità degli ecosistemi. Bisogna avere il coraggio di parlare dell’integrità della vita umana, della necessità di promuovere e di coniugare tutti i grandi valori. La scomparsa dell’umiltà, in un essere umano eccessivamente entusiasmato dalla possibilità di dominare tutto senza alcun limite, può solo finire col nuocere alla società e all’ambiente... 225. D’altra parte, nessuna persona può maturare in una felice sobrietà se non è in pace con sé stessa. …La pace interiore delle persone è molto legata alla cura dell’ecologia e al bene comune, perché, autenticamente vissuta, si riflette in uno stile di vita equilibrato unito a una capacità di stupore che conduce alla profondità della vita. …Un’ecologia integrale richiede di dedicare un po’ di tempo per recuperare la serena armonia con il creato, per riflettere sul nostro stile di vita e i nostri idea- li, per contemplare il Creatore, che vive tra di noi e in ciò che ci circonda, e la cui presenza «non deve essere costruita, ma scoperta e svelata».226. Stiamo parlando di un atteggiamento del cuore, che vive tutto con serena attenzione, che sa rimanere pienamente presente davanti a qualcuno senza stare a pensare a ciò che viene dopo, che si consegna ad ogni momento come dono divino da vivere in pienezza. Gesù ci insegnava questo atteggiamento quando ci invitava a guardare i gigli del campo e gli uccelli del cielo, o quando, alla presenza di un uomo in ricerca, «fissò lo sguardo su di lui» e «lo amò» (Mc 10,21). Lui sì che sapeva stare pienamente presente davanti ad ogni essere umano e davanti ad ogni creatura, e così ci ha mostrato una via per superare l’ansietà malata che ci rende superficiali, aggressivi e consumisti sfrenati. 227. Un’espressione di questo atteggiamento è fermarsi a ringraziare Dio prima e dopo i pasti...
Amore civile e politico 228. La cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica capacità di vivere insieme e di comunione. Gesù ci ha ricordato che abbiamo Dio come nostro Padre comune e che questo ci rende fratelli. L’amore fraterno può solo essere gratuito, non può mai essere un compenso per ciò che un altro realizza, né un anticipo per quanto speriamo che faccia. Per questo è possibile amare i nemici. Questa stessa gratuità ci porta ad amare e accettare il vento, il sole o le nubi, benché non si sottomettano al nostro controllo. Per questo possiamo parlare di una fraternità universale. 229. Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pena di essere buoni e onesti. Già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della fede, dell’onestà, ed è arrivato il momento di riconoscere che questa allegra superficialità ci è servita a poco. Tale distruzione di ogni fondamento della vita sociale finisce col metterci l’uno contro l’altro per difendere i propri interessi, provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo di una vera cultura della cura dell’ambiente. 230. L’esempio di santa Teresa di Lisieux ci invita alla pratica della piccola via dell’amore, a non perdere l’opportunità di una parola gentile, di un sorriso, di qualsiasi piccolo gesto che semini pace e amicizia. Un’ecologia integrale è fatta anche di semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo. Viceversa, il mondo del consumo esasperato è al tempo stesso il mondo del maltrattamento della vita in ogni sua forma.231. L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche civile e politico, e si manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo migliore. L’amore per la società e l’impegno per il bene comune sono una forma eminente di carità, che riguarda non solo le relazioni tra gli individui, ma anche «macro-relazioni, rapporti sociali, economici, politici». Per questo la Chiesa ha proposto al mondo l’ideale di una «civiltà dell’amore». L’amore sociale è la chiave di un autentico sviluppo...232. Non tutti sono chiamati a lavorare in maniera diretta nella politica, ma in seno alla società fiorisce una innumerevole varietà di associazioni che intervengono a favore del bene comune, difendendo l’ambiente naturale e urbano. …Queste azioni comunitarie, quando esprimono un amore che si dona, possono trasformarsi in intense esperienze spirituali.
I segni sacramentali del riposo celebrativo 233. L’universo si sviluppa in Dio, che lo riempie tutto. …come insegnava san Bonaventura: «La contemplazione è tanto più elevata quanto più l’uomo sente in sé l’effetto della grazia divina o quanto più sa riconoscere Dio nelle altre creature».234. San Giovanni della Croce insegnava che tutto quanto c’è di buono nelle cose e nelle esperienze del mondo «si trova eminentemente in Dio in maniera infinita o, per dire meglio, Egli è ognuna di queste grandezze che si predicano».
…Se ammira la grandezza di una montagna, non può separare questo da Dio, e percepisce che tale ammirazione interiore che egli vive deve depositarsi nel Signore…235. I Sacramenti sono un modo privilegiato in cui la natura viene assunta da Dio e trasformata in mediazione della vita soprannaturale. Attraverso il culto siamo invitati ad abbracciare il mondo su un piano diverso. L’acqua, l’olio, il fuoco e i colori sono assunti con tutta la loro forza simbolica e si incorporano nella lode. La mano che benedice è strumento dell’amore di Dio e riflesso della vicinanza di Cristo che è venuto ad accompagnarci nel cammino della vita. L’acqua che si versa sul corpo del bambino che viene battezzato è segno di vita nuova. Non fuggiamo dal mondo né neghiamo la natura quando vogliamo incontrarci con Dio…236. Nell’Eucaristia il creato trova la sua maggiore elevazione. La grazia, che tende a manifestarsi in modo sensibile, raggiunge un’espressione meravigliosa quando Dio stesso, fatto uomo, arriva a farsi mangiare dalla sua creatura. Il Signore, al culmine del mistero dell’Incarnazione, volle raggiungere la nostra intimità attraverso un frammento di materia. Non dall’alto, ma da dentro, affinché nel nostro stesso mondo potessimo incontrare Lui. Nell’Eucaristia è già realizzata la pienezza, ed è il centro vitale dell’universo, il centro traboccante di amore e di vita inesauribile. Unito al Figlio incarnato, presente nell’Eucaristia, tutto il cosmo rende grazie a Dio. In effetti l’Eucaristia è di per sé un atto di amore cosmico… L’Eucaristia unisce il cielo e la terra, abbraccia e penetra tutto il creato. Il mondo, che è uscito dalle mani di Dio, ritorna a Lui in gioiosa e piena adorazione: nel Pane eucaristico «la creazione è protesa verso la divinizzazione, verso le sante nozze, verso l’unificazione con il Creatore stesso». Perciò l’Eucaristia è anche fonte di luce e di motivazione per le nostre preoccupazioni per l’ambiente, e ci orienta ad essere custodi di tutto il creato. 237. La domenica, la partecipazione all’Eucaristia ha un’importanza particolare. Questo giorno, così come il sabato ebraico, si offre quale giorno del risanamento delle relazioni dell’essere umano con Dio, con sé stessi, con gli altri e con il mondo. La domenica è il giorno della Risurrezione, il “primo giorno” della nuova creazione, la cui primizia è l’umanità risorta del Signore, garanzia della trasfigurazione finale di tutta la realtà creata. Inoltre, questo giorno annuncia «il riposo eterno dell’uomo in Dio». In tal modo, la spiritualità cristiana integra il valore del riposo e della festa. …Siamo chiamati a includere nel nostro operare una dimensione ricettiva e gratuita, che è diversa da una semplice inattività. Si tratta di un’altra maniera di agire che fa parte della nostra essenza. In questo modo l’azione umana è preservata non solo da un vuoto attivismo, ma anche dalla sfrenata voracità e dall’isolamento della coscienza che porta a inseguire l’esclusivo beneficio personale. La legge del riposo settimanale imponeva di astenersi dal lavoro nel settimo giorno, «perché possano godere quiete il tuo bue e il tuo asino e possano respirare i figli della tua schiava e il forestiero» (Es 23,12). Il riposo è un ampliamento dello sguardo che permette di tornare a riconoscere i diritti degli altri. Così, il giorno di riposo, il cui centro è l’Eucaristia, diffonde la sua luce sull’intera settimana e ci incoraggia a fare nostra la cura della natura e dei poveri.
La Trinità e la relazione tra le creature 238. Il Padre è la fonte ultima di tutto, fondamento amoroso e comunicativo di quanto esiste. Il Figlio, che lo riflette, e per mezzo del quale tutto è stato creato, si unì a questa terra quando prese forma nel seno di Maria. Lo Spirito, vincolo infinito d’amore, è intimamente presente nel cuore dell’universo animando e suscitando nuovi cammini. Il mondo è stato creato dalle tre Persone come unico principio divino, ma ognuna di loro realizza questa opera comune secondo la propria identità personale. Per questo, «quando contempliamo con ammirazione l’universo nella sua grandezza e bellezza, dobbiamo lodare tutta la Trinità».239. Per i cristiani, credere in un Dio unico che è comunione trinitaria porta a pensare che tutta la realtà contiene in sé un’impronta propriamente trinitaria...240. Le Persone divine sono relazioni sussistenti, e il mondo, creato secondo il modello divino, è una trama di relazioni. Le creature tendono verso Dio, e a sua volta è proprio di ogni essere vivente tendere verso un’altra cosa, in modo tale che in seno all’universo possiamo incontrare innumerevoli relazioni costanti che si intrecciano segretamente. Questo non solo ci invita ad ammirare i molteplici legami che esistono tra le creature, ma ci porta anche a scoprire una chiave della nostra propria realizzazione. Infatti la persona umana tanto più cresce, matura e si santifica quanto più entra in relazione, quando esce da sé stessa per vivere in comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. Così assume nella propria esistenza quel dinamismo trinitario che Dio ha impresso in lei fin dalla sua creazione. Tutto è collegato, e questo ci invita a maturare una spiritualità della solidarietà globale che sgorga dal mistero della Trinità.
La regina di tutto il Creato 241. Maria, la madre che ebbe cura di Gesù, ora si prende cura con affetto e dolore materno di questo mondo ferito. Così come pianse con il cuore trafitto la morte di Gesù, ora ha compassione della sofferenza dei poveri crocifissi e delle creature di questo mondo sterminate dal potere umano. Ella vive con Gesù completamente trasfigurata, e tutte le creature cantano la sua bellezza. È la Donna «vestita di sole, con la luna sotto i piedi e una corona di dodici stelle sul suo capo» (Ap 12,1). Elevata al cielo, è Madre e Regina di tutto il creato. …Perciò possiamo chiederle che ci aiuti a guardare questo mondo con occhi più sapienti. 242. Insieme a lei, nella santa famiglia di Nazaret, risalta la figura di san Giuseppe. Egli ebbe cura e difese Maria e Gesù con il suo lavoro e la sua presenza generosa, e li liberò dalla violenza degli ingiusti portandoli in Egitto. Nel Vangelo appare come un uomo giusto, lavoratore, forte. Ma dalla sua figura emerge anche una grande tenerezza, che non è propria di chi è debole ma di chi è veramente forte, attento alla realtà per amare e servire umilmente. Per questo è
stato dichiarato custode della Chiesa universale. Anche lui può insegnarci ad aver cura, può motivarci a lavorare con generosità e tenerezza per proteggere questo mondo che Dio ci ha affidato.
Aldilà del sole 243. Alla fine ci incontreremo faccia a faccia con l’infinita bellezza di Dio (1 Cor 13,12) e potremo leggere con gioiosa ammirazione il mistero dell’universo, che parteciperà insieme a noi della pienezza senza fine. Sì, stiamo viaggiando verso il sabato dell’eternità, verso la nuova Gerusalemme, verso la casa comune del cielo. Gesù ci dice: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). La vita eterna sarà una meraviglia condivisa, dove ogni creatura, luminosamente trasformata, occuperà il suo posto e avrà qualcosa da offrire ai poveri definitivamente liberati. …Camminiamo cantando! Che le nostre lotte e la nostra preoccupazione per questo pianeta non ci tolgano la gioia della speranza. 245. Dio, che ci chiama alla dedizione generosa e a dare tutto, ci offre le forze e la luce di cui abbiamo bisogno per andare avanti. Nel cuore di questo mondo rimane sempre presente il Signore della vita che ci ama tanto. Egli non ci abbandona, non ci lascia soli, perché si è unito definitivamente con la nostra terra, e il suo amore ci conduce sempre a trovare nuove strade. A Lui sia lode!
* * *
246. Dopo questa prolungata riflessione, gioiosa e drammatica insieme, propongo due preghiere, una che possiamo condividere tutti quanti crediamo in un Dio creatore onnipotente, e un’altra affinché noi cristiani sappiamo assumere gli impegni verso il creato che il Vangelo di Gesù ci propone.
Preghiera per la nostra terra - Dio onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella più piccola delle tue creature, Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace.
Preghiera cristiana con il creato - Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che sono uscite dalla tua mano potente. Sono tue, e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza. Laudato si’! Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose. Hai preso forma nel seno materno di Maria, ti sei fatto parte di questa terra, e hai guardato questo mondo con occhi umani. Oggi sei vivo in ogni creatura con la tua gloria di risorto. Laudato si’! Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l’amore del Padre e accompagni il gemito della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori per spingerci al bene. Laudato si’! Signore Dio, Uno e Trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a contemplarti nella bellezza dell’universo, dove tutto ci parla di te. Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato. Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, amino il bene comune, promuovano i deboli, e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. I poveri e la terra stanno gridando: Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo Regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. Laudato si’! Amen.
Conferenza sul clima di Parigi (30 novembre – 11 dicembre 2015)
“Il futuro del pianeta”La rassegna stampa relativa alla conferenza sul clima riporta spesso un logo: la foglia verde sullo sfondo della tour Eiffel.La COP21 (Conferenza sui cambiamenti climatici) concerne una azione mondiale per i popoli e il pianeta.“Il clima sta cambiando. La scienza ha parlato”: già il sottotitolo dice l’orizzonte pratico della conferenza che si rivolge ai diversi Paesi chiedendo di intervenire sulla base di quanto ormai la scienza ha già denunciato in merito al degrado ambientale e ai cambiamenti climatici.Si apre con una marcia silenziosa, cioè delle scarpe lasciate sulla strada in luogo di una prevista sfilata che non si è tenuta per motivi di sicurezza.“Standing march” – una installazione di due autori contemporanei (JR e Darren Aronofsky) composta di circa 500 volti che si voltano all’unisono per scorgere il cambiamento in atto… Volti seri, concentrati, apparentemente inespressivi, che mirano a suscitare una reazione nei passanti.
COP = conferenza delle parti. Nascono dagli accordi quadro sul cambiamento climatico dell’ONU formato al summit di Rio nel 1992. Allora le parti sottoscriventi erano 154. Oggi è la 21ma edizione.Quello di KYOTO è un protocollo fondamentale per i successivi accordi. Sottoscritto l’11 dicembre 1997, di natura volontaria, entra in vigore solo nel 2005 proprio perché non vincolante e destinato a entrare in vigore con almeno 55 nazioni produttrici del 55% almeno delle emissioni. Ma non riesce a coinvolgere gli USA. Emissione “antropica” significa prodotta dall’uomo. Entro il 2012 si prevedeva la riduzione del 5% delle emissioni mondiali rispetto al 1990, indicando obiettivi precisi per ogni Paese. Alcuni paesi in via di sviluppo – tra cui Cina, Messico, Corea del Sud – non hanno obiettivi segnalati per cui non intraprendono una reale prospettiva di sviluppo.A Montreal (2007) si precisano le regole di esecuzione del protocollo di Kyoto, in vista del primo periodo di adempimenti (2008-2012).
Oggi a Parigi ci sono 196 parti coinvolte, ma solo 146 hanno fornito piani di riduzione delle emissioni per elaborare il rapporto del 30 ottobre 2015.Le indicazioni di temperatura sono in gradi C per l’Europa, in Farenheit per gli USA.Sono 13 giorni, su 180.000 metri quadrati, 40.000 presenze + giornalisti accreditati.Obiettivi:
(1) Raggiungere un nuovo accordo internazionale inclusivo e vincolante per un aumento massimo della temperature di +2°C entro il 2100, con un periodo di applicazione 2021-2025.
(2) Tagliare le emissioni di gas serra dal 40% al 70% entro il 2050, arrivando fino a emissioni zero entro il 2100. Non sono solo le emissioni di CO2, ma di tipi diversi legati a trasformazioni industriali e producono un effetto serra che impedisce la fuoriuscita dei raggi solari e provoca un conseguente innalzamento della temperatura globale. L’effetto serra è positivo perché permette di trattenere con uno strato di anidrite carbonica i raggi solari, favorendo il riscaldamento dell’atmosfera, necessario per la vita umana. Ma un eccessivo ispessimento dello strato di anidrite carbonica provoca un eccessivo trattenimento dei raggi solari, innalzando eccessivamente la temperatura. A questo si collega il problema del “buco nell’ozono”, cioè delle falde che si aprono a causa delle emissioni inquinanti nello strato di ozono che filtra i raggi ultravioletti e dunque impedisce un eccessivo surriscaldamento della temperatura.
(3) Controllo e revisione delle quote di emissioni dal 2020 con controllo ogni 5 anni
(4) Assegnazione di obiettivi di riduzione di emissione e di costi a seconda dei diversi Paesi (sviluppati o meno)
Il 35% dei gas serra arriva dall’energia, il 24% dai trasporti…La strada prevede MITIGAZIONE (ridurre l’aumento della temperatura) e ADATTAMENTO (ridurre le vulnerabilità agli impatti attesi).
Occorre l’impegno di tutti: degli USA (16% emissioni globali), CINA (29%), UE (11%), Russia (8%), India (6%). Gli obiettivi di riduzione “rispetto al 1990” non sono granché se paragonati ai dati (ben peggiori) del 2010, ad esempio… E non si tratta di cercare solo dati di lungo periodo, bensì di escogitare strategie per ridurre gli obiettivi realmente necessari…
Il Card. Parolin ha tenuto un discorso per l’occasione.(1) Agire contro i problemi legati al riscaldamento globale(2) Avviare nuovi modelli di sviluppo(3) Incidere sugli stili di vita(4) Attenzione agli stati più vulnerabili e le generazioni future(5) Trovare un accordo giusto(6) Educare alla responsabilità ambientale.
Nelle relazioni diplomatiche lo Stato della Città del Vaticano intrattiene rapporti con diversi stati. Alla COP21 aderiscono nazioni che sono membri dell’ONU. La SANTA SEDE ha un osservatore permanente…
La Santa Sede è composta dal Romano Pontefice e dagli uffici che provvedono, su suo mandato, al governo della chiesa universale. Lo Stato della Città del Vaticano, creato nel 1929, svolge invece la funzione strumentale di essere il mezzo per garantire alla Santa Sede la libertà e indipendenza necessarie per la missione religiosa. Per cui è la Santa Sede e non lo SCV il soggetto di diritto sovrano che agisce in ambito internazionale con diritto di legazione attiva e passiva (mandare e ricevere ambasciatori).
Accordo globale trasformativo fondato – ha detto Parolin nel discorso del 1/12/15 – su tre pilastri:
(1) Un chiaro orientamento etico (vs povertà, pro dignità umana, alleviando impatto ambientale)(2) Con segnali che orientino tutti gli attori (economia con basso contenuto di carbonio,
sviluppo umano integrale)(3) Visione del futuro consapevole e responsabile (controllo, educazione, nuovi modelli di
sviluppo)La base sta nella de-carbonizzazione del ciclo industriale e nella piena disponibilità di acqua e risorse necessarie per i Paesi più poveri
L’Angelus di domenica 6/12/2015 vede l’attenzione del papa all’evento della COP21. Riprende la LS ribadendo l’importanza della riduzione degli impatti climatici, contrastando la povertà e salvaguardando la dignità umana. Criterio di scelta: il maggior bene per l’intera famiglia umana.Questo è il centro del messaggio cristiano in questa conferenza sul clima: contrastare la povertà e salvaguardare la dignità umana integrale (tutto l’uomo e tutti gli uomini) – il che significa che non si possono ridurre le emissioni “a ogni costo” ma occorre tenere presenti le esigenze di sostentamento e sviluppo dell’uomo.
www.cop21.gouv.fr
Libertà e sviluppo
Il libro del prof. Casazza verrà presentato dagli studenti nel corso delle lezioni, previa lettura del capitolo relativo da parte di tutti gli allievi. Così che si possa interagire nella discussione che segue.
La LS cita una “certa decrescita”. I seguenti articoli aiutano a puntualizzare il tema.
STEFANO ZAMAGNI Il mercato non va demonizzato, va umanizzato. La tesi della “Decrescita” di S. Latouche e la Dottrina sociale della Chiesa. Due paradigmi a confronto - 05-04-2011 http://www.vanthuanobservatory.org/notizie-dsc/notizia-dsc.php?lang=it&id=1153 [accesso: 22.03.2013]
La proposta della decrescita felice ha un precedente illustre: la teoria dello stato stazionario per primo elaborata dal grande filosofo ed economista inglese J. S. Mill a metà Ottocento. Mill ha parlato di stato stazionario per significare una situazione in cui il tasso di crescita netto dell’economia è uguale a zero. In seguito, altri economisti e pensatori hanno formulato ipotesi analoghe. Ricordo, tra questi, Nicholas Georgescu Roegen ed il suo programma di “bioeconomia” avanzato negli anni Settanta del secolo scorso. Non ci si deve dunque meravigliare se, di tanto in tanto, la preoccupazione per la sostenibilità e la paura del futuro spingono studiosi di diversa estrazione culturale (ad es., J.S. Mill era un grande liberale) ad avanzare proposte come quella della decrescita felice. La posizione della Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) si distacca e si differenzia da quest’ultima non tanto sul piano della diagnosi – molti punti della quale sono condivisibili e ormai da tutti accettati – quanto piuttosto su quello della terapia. Per rimanere nella metafora medica, sarebbe come dire: esiste il male serio, ma anziché cercare di curarlo alla radice – come è certamente possibile, anche se difficile – ci si rassegni alla (più o meno lenta) eutanasia del paziente.
Latouche afferma che “per scongiurare l’implosione del sistema è indispensabile un’autolimitazione dei modi di produzione e di consumo dominanti”. L’economia è un mezzo. O si decresce o si rischia una catastrofe planetaria. Occorrono otto cambiamenti fondamentali: rivalutare / riconcettualizzare / ristrutturare / redistribuire / rilocalizzare / ridurre / riutilizzare / riciclare.
Perché la Dottrina sociale della Chiesa non accetta la tesi della Decrescita. La DSC non accetta – né potrebbe farlo – una tale prospettiva di discorso. Vediamo perché. Primo, va precisato che il concetto di sviluppo ha ben poco da spartire con quello di crescita. Etimologicamente, sviluppo significa “liberazione dai viluppi, cioè dai vincoli” che limitano la libertà della persona e delle aggregazioni sociali in cui essa si esprime. Questa nozione di sviluppo viene pienamente formulata all’epoca dell’Umanesimo civile (XV secolo) e decisivo, a tale riguardo, è stato il contributo della Scuola di pensiero francescana: ricercare le vie dello sviluppo significa amare la libertà. Tre sono le dimensioni dello sviluppo umano, tante quante sono le dimensioni della libertà: la dimensione quantitativo-materiale, cui corrisponde la libertà da; quella socio-relazionale, cui corrisponde la libertà di; quella spirituale, cui corrisponde la libertà per. PRIMA OBIEZIONE - Non è detto che eliminando la crescita (quantitativa) si abbia più sviluppo (qualitativo). Nelle condizioni attuali, è bensì vero che la dimensione quantitativo-materiale fa aggio sulle altre due, ma ciò non legittima affatto la conclusione che riducendo (o annullando) la crescita – che riguarda appunto la dimensione quantitativo-materiale – si favorisca l’avanzamento delle altre due dimensioni. Anzi, si può dimostrare – ma non è questa la sede – che è vero il contrario. Ecco perché la DSC (e in special modo la Caritas in Veritate, CV) parla di sviluppo umano integrale, di uno sviluppo, cioè, che deve tenere in armonico e mutuo bilanciamento le tre dimensioni di cui sopra. Ciò si realizza attraverso un mutamento della composizione – e non già del livello – del paniere dei beni di consumo: meno beni materiali, più beni relazionali e più beni immateriali.
Beni relazionali: sono i beni che hanno come primo valore quello della messa in comune cioè della relazione. Che un economista consideri questa categoria non è scontato.
È possibile ciò? Certo che lo è, come il filone di studi dell’economia civile da tempo va dimostrando.
Non la Decrescita ma l’Economia civile. L’antidoto dunque all’attuale modello consumistico – da sempre condannato dalla DSC – non è la decrescita, quanto piuttosto l’economia civile – un programma di ricerca e di pensiero tipicamente italiano che è stato dominante in Europa fino alla metà del Settecento, e da allora è stato obnubilato dal programma di ricerca dell’economia politica. Si notino le differenze: mentre l’economia civile è finalizzata al bene comune, l’economia politica mira piuttosto al bene totale. Laddove quest’ultima ritiene di poter risolvere i problemi della sfera economico-sociale appoggiandosi sui principi dello scambio di equivalenti e di redistribuzione ad opera dello Stato, l’economia civile aggiunge a questi due principi quello di reciprocità, che è il precipitato pratico della fraternità. La grande novità della CV è nell’avere restituito alla fraternità (cfr. il cap. III) quel ruolo centrale nella sfera dell’economico che la Rivoluzione francese e l’utilitarismo di Bentham avevano completamente cancellato. È per questo che la CV sta ricevendo attenzioni e consensi mai registrati in precedenza da una enciclica un po’ ovunque, a partire dal Nord America.
I principi fondamentali della dottrina sociale sono (1) dignità della persona, (2) solidarietà, (3) sussidiarietà, (4) bene comune = insieme delle condizioni che permettono lo sviluppo integrale umane. Per passare al bene comune – dal bene totale – occorre ricollocare la redistribuzione all’inizio del processo (anche tenendo conto dei principi di solidarietà e sussidiarietà).Il bene comune promuove lo sviluppo integrale dell’uomo, cioè di tutto l’uomo e di ogni uomo. Mentre il bene totale guarda solo alla quantità totale, alla somma complessiva.
SECONDA OBIEZIONE - Il mercato non va demonizzato, va umanizzato. Per paradossale che ciò possa apparire, la tesi della decrescita si limita a porre il segno meno al paradigma dell’economia politica, ma non ne costituisce il superamento: è per questo motivo che non la si può ritenere risolutiva dei tanti e gravi problemi che affliggono le nostre società. Se si continua a demonizzare il mercato, questo diventerà davvero un inferno. La sfida invece è quella della sua umanizzazione. La DSC mai potrà accettare regressioni di sorta: chi coltiva la concezione del tempo come kairos, e non già come chronos, sa che le difficoltà si superano mutando la prospettiva di sguardo sulla realtà – come ci ricorda la celebre frase di San Francesco – e non con operazioni che riporterebbero indietro le lancette della storia. Se si può capire la tentazione del ritorno “all’antico”, non la può certo giustificare chi – come la DSC – accoglie in pieno un’antropologia personalista che, mentre rifiuta l’individualismo, non può abbracciare la sponda opposta, quella del comunitarismo. In entrambi i casi, l’esito finale sarebbe infatti il nichilismo. C’è da augurarsi che coloro che, in buona fede, si battono per la decrescita felice arrivino a comprendere il punto qui delucidato, sia pur in breve.
PIL = Prodotto Interno Lordo – la somma totale dei beni e dei servizi prodotti in un Paese in un certo periodo (normalmente un anno). Andare a cena fuori aumenta senz’altro il PIL, ma non è detto che questo accresca anche il bene relazionale dello stare insieme (anzi). Per cui il PIL non misura il benessere di un Paese. Si può allora parlare di BES = Benessere Equo Solidale. Per misurare lo sviluppo. Ma è difficile da misurare e quantificare. Mentre il PIL è una misura oggettivabile e raffrontabile con altri Paesi. Insomma, è facile dire quando guadagno più dell’anno scorso, ma non è facile dire quanto più felice sono rispetto allo scorso anno.
Decrescita, un’illusione romantica LA STAMPA, 22/08/2012, P. 1 ON. IRENE TINAGLI Laureata in economia, giornalista, membro del parlamento sotto il governo Monti e anche sotto il governo Renzi.
Molti governi europei oggi cercano ricette per stimolare la crescita: ma è davvero necessario tornare a crescere? Secondo alcuni no. Le teorie anti-crescita, che affondano le loro radici nei movimenti anti-industriali dell’Ottocento e che sono state riportate in auge dall’economista francese Serge Latouche, stanno ispirando molte persone ad invocare una sana decrescita. I sostenitori di queste tesi affermano che
ripensando il nostro sistema dei consumi sia possibile vivere felici senza che aumenti il Pil. Quello che dovremmo fare, come ci ricorda anche Guido Ceronetti nel suo articolo su La Stampa di domenica scorsa, è separare i bisogni essenziali da quelli che non lo sono e i beni prodotti per soddisfare bisogni reali da quelli fatti solo per generare profitto, ovvero i «commerci». Se le persone, per esempio, anziché produrre beni inutili volti al commercio e al profitto fine a se stesso, producessero semplicemente quello che serve loro per sostentarsi, sarebbero meno dipendenti dai cicli economici, dai debiti e dall’ansia di accumulare ricchezza. E i Paesi starebbero in piedi senza bisogno di far crescere il Pil a tutti i costi. Questa prospettiva è molto affascinante e per certi versi romantica, se non fosse che la distinzione tra beni volti alla soddisfazione di bisogni cosiddetti essenziali e beni commerciali non è così netta come si possa pensare (senza contare l’inquietante scenario in cui qualcuno decide cosa è essenziale per la gente e cosa non lo è). A meno di ridurre i beni essenziali al mero consumo alimentare, molti bisogni fondamentali non si soddisfano solo con l’autosussistenza. Se per beni essenziali si considerano infatti anche l’istruzione, le scuole e la sanità pubblica, i vaccini e le medicine, i trasporti e così via, allora tutto cambia. Perché tutti questi beni e servizi non si mantengono con l’economia di sussistenza, soprattutto in Paesi, come l’Italia, che non hanno materie prime da esportare. Si costruiscono invece con i proventi delle attività commerciali e industriali e le relative entrate fiscali; risorse che consentono, appunto, di finanziare servizi pubblici e di supportare ricerca scientifica, innovazione e progresso. Deve essere chiaro, quindi, che decrescere non significa solo diminuire le ricchezze individuali e fare a meno di qualche accessorio come il cellulare o l’iPad, ma significa allo stesso tempo diminuire le risorse che lo Stato ha a disposizione per tutte le azioni di redistribuzione, assistenza e investimento per il futuro. È chiaro: la decrescita non danneggia tutti nello stesso modo e quindi non spaventa tutti nello stesso modo. La scarsa crescita non è mai stata un gran danno per l’aristocrazia terriera o quelle classi che possono contare su rendite fisse e sostituire i servizi pubblici con servizi privati, ma è un disastro per gli operai, i commercianti e la classe media, che più delle altre hanno bisogno di servizi pubblici. Certo: possiamo dire a tutte queste persone che tornino a coltivare la terra e a badare da soli ai propri figli, insegnandogli a leggere a casa e curando le loro malattie con le erbe del giardino. In fondo era così fino a non molto tempo fa, prima dell’industrializzazione e delle rivoluzioni tecnologiche dell’ultimo secolo e mezzo. Ma erano altri tempi, difficilmente invidiabili: tempi in cui davvero c’era poco altro a cui ambire al di là della sussistenza , in cui il bisogno di crescere, studiare e viaggiare era privilegio di pochi, e in cui i progressi della medicina e della scienza erano scarsi e lenti. Basta pensare che l’aspettativa di vita è rimasta quasi invariata dai tempi dei Romani fino agli inizi del Novecento. È stato con l’aumento dei commerci, dei grandi progressi economici, industriali e scientifici dell’ultimo secolo, che si è più che raddoppiata. Anche la storia recente ci offre numerosi esempi del ruolo della crescita. È stato grazie all’apertura e alla crescita economica che la Cina ha potuto, nei soli vent’anni tra il 1981 e il 2001, dimezzare la povertà nel Paese . È stato con la crescita economica che il Brasile si è potuto permettere programmi sociali che hanno strappato all’emarginazione milioni di famiglie. E persino nel miracolo cubano degli Anni Sessanta l’alfabetizzazione e le infrastrutture sanitarie furono sostenute da alti tassi di crescita. Una crescita fittizia, pompata dagli aiuti della Russia, e che infatti crollò miseramente alla fine degli Anni Ottanta. Tra il 1989 e il 1993 il Pil subì una contrazione del 35%. Ma la decrescita non fu affatto felice. La crisi di fame e povertà che colpì la popolazione cubana fu atroce. Solo con l’apertura al turismo, ai capitali esteri e ad alcune forme di commercio e di piccole iniziative imprenditoriali (e con una forte repressione del dissenso che nel frattempo andava aumentando), Cuba è riuscita a resistere finché non è arrivata la cooperazione con il Venezuela di Chavez e poi con la Cina. Perché pure i Paesi d’ispirazione socialista, forse anche più degli altri, si sono accorti dell’importanza della crescita economica. Come disse Deng Xiaoping: «La povertà non è socialismo». Quello su cui molti Paesi dovrebbero riflettere oggi, e la vera sfida che hanno davanti, non è tanto come eliminare o ridurre la crescita, ma su quali basi costruirla e con quali criteri utilizzarla e ridistribuirla. Perché non tutte le crescite sono egualmente sostenibili nel tempo, e non tutte sono gestite e distribuite nello stesso modo. Questo è il vero nodo attorno al quale si gioca il nostro futuro.
ZAMAGNI e TINAGLI sono contro la decrescita. Ma possiamo diversificare e confrontare le posizioni.Sulla decrescita la Tinagli dice che essa danneggia in modo diverso le persone, e prende posizione da liberale. Anche Zamagni critica la decrescita, dicendo che non equivale necessariamente a sviluppo e insiste troppo sulla quantità. Mentre il modello di Tinagli è liberale, dunque si riferisce
all’obiettivo della crescita della libertà. Invece Zamagni punta alla crescita del bene comune (ma anche Zamagni parla della libertà da/di/per). Tinagli sostiene che l’aumento della crescita è anche positivo. Mentre Zamagni si concentra sul richiamo all’economia civile.
COP 21 e la ricezione mediatica.
Approvazione accordo di Parigi 12/12/201529 articoliEntrata in vigore nel 2020, con la accettazione / approvazione di almeno 55 Paese purché equivalenti ad almeno il 55% delle emissioni prodotte nel 2015.--Contenere la soglia dell’innalzamento della temperatura entro +2°C (si punta a +1,5°C)--Consenso globale: EU, Cina, India, USA – i quattro grandi “inquinatori” – hanno aderito insieme a moltissimi altri Paesi--Consenso ogni 5 anni (primo nel 2013)--Fondi per l’energia pulita: 100 miliardi di dollari / anno (dal 2020)--Rimborsi ai Paesi più esposti ai cambiamenti climatici
Art. 4 / Art. 7
LUCI E OMBRE SULLA COP 21, “Civiltà Cattolica”.
C. Carraro & A. Mazzai, Il clima che cambia – Il Mulino (consiglio di lettura)
SVILUPPO E LIBERTÀ IN AMARTYA SEN. Provocazioni per la teologia morale
INTRODUZIONEAffrontare un tema di attualità presenta il rischio di una materia in evoluzione, con forte coinvolgimento nella discussione e abbondante materiale da selezionare. Affrontare le teorie del Nobel per l’Economia 1998, Amartya Sen (AS), ha lo scopo di raccogliere provocazioni utili per la teologia morale a partire dai concetti di sviluppo (come accrescimento delle possibilità delle persone di scegliere il tipo di vita che preferiscono) e libertà (come qualità essenziale per maturare scelte autentiche e personali nel contesto della vita associata). I due concetti sono poi inseriti nel paradigma di convivenza “Ulisse/Sen” che guarda all’altro come a un fratello, non un nemico, aprendosi nell’orizzonte teologico al concetto di fraternità fondato sulla comune esperienza dell’a/Amore accolto e donato.La prima parte esamina la riflessione di AS sulla povertà (cap. I), legata al concetto di sviluppo della persona (cap. II), fondato su un clima di fiducia democratica (cap. III) che coniuga il benessere del singolo e della comunità (cap. IV).La seconda parte sviluppa il pensiero di AS in orizzonte teologico, cogliendo i capisaldi antropologici di un corretto rapporto individuo/società (cap. V), estendendo il paradigma di convivenza fraterna con l’altro all’Altro (cap. VI) nel contesto civile libero dal “compromesso accondiscendente” (cap. VII).Nell’ottica della ecologia integrale, l’opera intende analizzare il volto di una possibile società in cui applicare e incarnare i principi emersi dalla lettura dei testi del magistero e della enciclica LS sul rapporto uomo-ambiente.
PARTE PRIMA. SVILUPPO E LIBERTÀ IN AMARTYA SEN
CAPITOLO I – SVILUPPO E POVERTÀ
1. Che cos’è la povertà?La povertà come fenomeno sociale è facilmente rilevabile da qualsiasi osservatore, e lo stesso AS ne ha visto la tragedia in occasione della carestia che ha colpito lo stato indiano del Bengala nel 1943, causando 3 milioni di morti. Una carestia non causata da assenza di risorse alimentari ma dalla difficoltà di accedere ad esse: più che le risorse in sé contano i titoli necessari per accedere ai diversi beni necessari. Insomma: si muore di fame non (solo) quando manca il cibo, ma anzitutto quando non si hanno le risorse per acquistarlo. Per cui per definire la povertà occorre prestare attenzione anche alle dinamiche di reddito e al potere d’acquisto dei salari. Fattori che incidono sulla scarsità di risorse acquisibili ma anche sulle nuove povertà sociali (un disoccupato è anche impoverito in termini di relazioni, autostima, etc…).In questo contesto di emergenza, ruolo determinante spetta alle autorità politiche che possono intervenire a basso costo (sulle poche persone interessate) ma con grandi benefici (evitare epidemie, profughi, criminalità…). Esempio del New Deal negli USA post crisi del 1929.L’impegno della comunità internazionale per debellare la fame – che causa danni diretti per 30 mld $ / anno e indiretti per 500 mld $ / anno – avrebbe anche una positiva ricaduta economica.La Corea del Sud è un positivo esempio di intervento pubblico a sostegno dell’economia (riforma agraria), il Brasile un caso negativo (si arricchisce chi già è ricco).
DIVERSI TIPI DI BENIRivalità dei beni (se ce l’ho io, non ce l’hai tu: se è la tua moto, non la userò io, non è la mia)Escludibilità (posso decidere chi ce l’ha e chi no, ad es. se non paghi non te lo do)
Beni privati : R ed E (questo gesso è mio)Beni comuni (commons): R ma non E (ad esempio i pascoli demaniali, il posteggio gratuito per strada: se parcheggio io, non puoi tu; ma non escludo te in quanto tale).Beni di club : E ma non R (sono per quanti hanno un certo diritto, ad esempio pagare il pedaggio per l’autostrada, ma se io entro non escludo te)Beni pubblici : né R né E (non comportano rivalità né escludibilità: se c’è un costo, non si rivelano le proprie preferenze per avvalersi comunque del bene… l’economia di mercato non funziona!). Non rivelandosi le intenzioni delle persone, ecco che non vale la legge della domanda e dell’offerta e l’unica soluzione è offrire questi beni e tutelarli dal mercato. Il catechismo li chiama beni collettivi. (Se si dovesse pagare per avere il cielo pulito, ben pochi lo farebbero). Ed è per questo che l’ambiente deve essere tutelato.
La povertà non può ridursi a una linea arbitraria (ad esempio la Banca Mondiale definisce “povertà assoluta” un reddito pro capite inferiore ai 2 $ al giorno), ma va relazionata alla possibilità della persona di migliorare la sua situazione: nesso tra povertà & crescita (e possibile circolo vizioso: più si è poveri, meno si può crescere). AS suggerisce di considerare dunque 5 fonti di variazioni parametriche: le diversità personali (età, struttura corporea, sesso, handicap, talenti), le diversità ambientali (riscaldarsi in Congo o in Alaska non è uguale), le diversità di clima sociale (quali standard di igiene, istruzione, sicurezza?), le diversità del tenore di vita medio (la povertà relativa è il 50% del reddito medio pro capite; un conto è vivere a Milano, altro vivere a Calcutta), le diverse distribuzioni di reddito in seno alla famiglia (chi decide e come?).In rapporto al “tenore di vita medio”, giova ricordare che Adam Smith nella Ricchezza delle Nazioni (1776) annoverava tra i beni indispensabili il poter apparire in pubblico senza vergogna (all’epoca, con una camicia di tela, poi con le scarpe di cuoio, cose non necessarie per gli antichi Romani…) e partecipare alla vita della comunità. Insomma, la valutazione delle risorse disponibili non può esser disgiunta dalla cultura, poiché gli “stati di essere e di fare” individuali riflettono la libertà personale nello scegliere e attuare un certo tipo di vita. Per AS più che di scarsità di risorse bisognerebbe parlare di inadeguatezza. Si tratta di povertà relativa, intesa come mancanza di capacità (capability) che permettono all’individuo di dispiegare le proprie potenzialità (sviluppo). Tale concetto si lega al bene comune (vs bene totale: mera somma di redditi).
Lo sviluppo viene dunque inteso come crescita delle opportunità offerte realmente agli individui per realizzare le loro scelte. Ma quali sono le caratteristiche da eguagliare per garantire un equo sviluppo a tutti? John Rawls parla di eguaglianza di beni primari (opportunità, libertà, reddito, ricchezza, rispetto di sé), ma Sen ribatte che un elenco rigido di tali beni trascura la reali e differenti capacità degli individui; Robert Nozick parla invece di uguaglianza di diritti (lo Stato minimo tutela in primis quelli di proprietà); Ronald Dworkin parla di eguali risorse (relative alle capacità individuali da sviluppare); Ralf Dahrendorf parla invece di eguali chances di vita, cioè di concrete possibilità di sviluppare la propria libertà.
2. Problemi demografici e povertàLa povertà non è solo scarsità di reddito dunque. E ben si lega all’andamento demografico, a partire dalle analisi di Thomas Malthus, pastore anglicano, che in Saggio sul principio di popolazione
(1798) osserva che la popolazione cresce in progressione geometrica (2, 4, 8, 16…), mentre le risorse in progressione aritmetica (2, 4, 6, 8…), fino a un certo limite, quando si scatenano gli “ostacoli repressivi” (epidemie, guerre, carestie) che riportano l’equilibrio. Malthus propone di non sostenere i poveri, cosicché la povertà funga da naturale contenimento demografico.La corrente neomalthusiana – a partire dal Club di Roma nato nel 1968 – parla di “bomba demografica” (Paul Ehrlich), cui si legherebbero alterazioni climatiche e ondate migratorie in grado di minacciare il futuro del mondo. Per cui gli USA decisero di condizionare gli aiuti economici ai paesi sottosviluppati in virtù di politiche di sterilizzazione (come pure fecero altri governi africani e la Cina). Di fatto, gli studi mostrano che la produzione di cibo è cresciuta più rapidamente della popolazione, al punto che la Banca Mondiale prevede il dimezzamento delle persone che vivono in miseria (meno di 1 $ al giorno) entro il 2030.La popolazione cresce anzitutto perché diminuisce la mortalità infantile (progressi medici); la popolazione mondiale è raddoppiata negli ultimi 50 anni, ma la natalità infantile è diminuita perché anche popolazioni più povere investono di più nell’istruzione di meno figli. Per cui oggi si potrebbe parlare di “inverno demografico” (invecchiamento della popolazione mondiale).
3. Il ruolo della donna e della famigliaEffetti negativi del problema demografico ricadono anche sulle donne, penalizzate nella distribuzione di cibo durante le carestie, dagli aborti selettivi e dagli infanticidi, dai carichi di lavoro domestici e dalla mancanza di istruzione. Invece di guardare al benessere del nucleo famigliare, bisognerebbe cogliere le sperequazioni interne. Proprio sulle pari opportunità tra i sessi si svolsero le battaglie femministe degli anni ’60-’70 e si scontrano oggi Occidente e Islam. Maggior reddito e maggior istruzione alle donne (cfr. India, Kerala vs Cina: a lungo sterilizzazione forzata, ma oggi permessi 2 figli, e si insiste sulla istruzione alle donne) porta a un decremento della natalità.Sostegno alle donne viene anche dal micro-credito: il caso della Grameen Bank del Bangladesh che ha favorito, dalla fondazione nel 1977, l’uscita dalla povertà di 12 mln di persone, con piccoli prestiti, preziosa occasione di mini-imprenditoria ma anche opportunità per la banca (rientrati al 93%). Analoghi esperimenti si stanno avviando anche in Italia, accanto a micro-risparmio, micro-assicurazione, micro-pensioni. Critiche possibili: è un circuito finanziario parallelo e poco incisivo, inoltre esposto al controllo delle banche commerciali.AS nota che l’economia non dovrebbe parlare di individui e imprese, ma famiglie. Si potrebbe considerare la famiglia come una unità coesa, misconoscendo però così il ruolo dei singoli; oppure parlarne come di una impresa di due coniugi, enfatizzando però lo scambio a discapito della gratuità; ancora, si potrebbe intendere la famiglia paternalistica, riassunta cioè nelle scelte del (solo!) paterfamilias. AS preferisce intendere il benessere familiare come funzione delle libertà positive di cui possono godere i singoli membri della famiglia.
CAPITOLO II - SVILUPPO E PERSONA
1. Il soggetto e le sue affiliazioni pluraliLa riflessione sulla donna e sulla famiglia ci portano a interrogarci sulla persona e sul suo ruolo nel processo di sviluppo. In quest’ottica, AS esamina la posizione di Rawls nella prospettiva di un contrattualismo (1) universalista e (2) particolarista-nazionale.
Si parla di (1) universalismo quando ci si riferisce alla totalità delle persone, tentando – invano, perché inattuabile – di applicare al pianeta intero la “posizione originaria”, cioè una immaginaria condizione di equità primordiale garantita dal “velo d’ignoranza” dietro a cui le parti contraenti non sono in grado di prevedere le posizioni esistenziali che andrebbero ad occupare e dunque decidono secondo equità, raggiungendo un accordo ipotetico e astorico (limite: è dunque un puro esperimento mentale, come nota Rawls in Justice as Fairness, 2001) su due principi: di uguaglianza (ogni persona ha diritto al più ampio sistema di libertà fondamentali, compatibilmente con un simile sistema di libertà per tutti) e di differenza o maximin (le ineguaglianze economiche e sociali devono essere per il più grande beneficio dei meno avvantaggiati e collegate a cariche e posizioni aperte a tutti, secondo il maximum minimorum). Il primo principio è necessario per applicare il secondo. Sono norme procedurali contenutisticamente neutrali, accettabili per “consenso per sovrapposizione” da ogni persona, a prescindere dalle visioni filosofiche, morali e religiose della vita. Un consenso che non è un mero modus vivendi e tuttavia risulta un accordo che funziona solo se il consenso è già operativo (dunque è più descrittivo che normativo!).Si parla poi di particolarismo nazionale immaginando che simile contratto possa sussistere tra stati diversi. Ma AS è critico: ogni soggetto ha molteplici appartenenze e difficilmente si potrebbe arbitrariamente selezionarne una sola (la cittadinanza?). Pare assurdo immaginare di essere osservatori imparziali. Piuttosto, come suggerisce Adam Smith, dobbiamo diventare spettatori imparziali di noi stessi, sforzandoci di considerarci con gli occhi degli altri, escludendo dall’agone politico chi deve formulare una valutazione (“imparzialità aperta”, AS): si tratta cioè di un arbitrato (con giudice esterno) piuttosto che una negoziazione (i partecipanti sono tutti coinvolti, come la posizione originaria di Rawls), sapendo che non si può raggiungere a view from nowhere (come invece Rawls vorrebbe).Domanda: chi negozia il contratto? Di quale soggetto parliamo?
Dopo la II guerra mondiale, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (ONU, 1948) ha riconosciuto la dignità di ogni essere umano. Dignità che oggigiorno, dietro al dominio della tecnica, pare dimenticata, pensando che poter (lecitamente) fare tutto ciò che (scientificamente) si riesce a fare. Se l’antropologia liberale di John Locke riconosce come persona chi è in grado di decidere di sé liberamente come agente morale, l’utilitarismo di Jeremy Bentham e John Stuart Mill parla di utilità in termini di conseguenze positive per la persona intesa come soggetto capace di provare sensazioni (dunque non embrioni, soggetti in coma, handicappati, moribondi?); ancora: il contrattualismo di Thomas Hobbes e di Jean Jacques Rousseau sostiene che persona (sociale) è quella dotata di capacità contrattuale.Nell’ottica di visioni antropologiche così diverse, come pure di molteplici appartenenze, una posizione originaria universale che ignorasse le frammentarie e poliedriche identità di ciascuno appare impraticabile.
Altro fattore: la globalizzazione. Positivamente contestata (a partire dal World Trade Organization, Seattle, 1999) da chi non usa la violenza e più che slogan offre interrogativi, sapendo che la stessa diffusione mondiale delle tematiche no-global è sintomo della globalizzazione (rapido trasferimento mondiale di persone, cose, notizie). Uno scambio culturale che già segnò il pluri-culturalismo greco-latino-arabo in vista della moderna rivoluzione scientifica, ma che oggi si ripete con
differenze quantitative e qualitative. Demonizzare la globalizzazione sarebbe assurdo: non è la leva dell’imperialismo economico occidentale! (Cfr. critiche di Serge Latouche).Ma è pur vero che i benefici andrebbero divisi (tra Paesi ricchi e non, ceti ricchi e non). Non basta pensare che accedendo al commercio mondiale i Paesi più poveri possano svilupparsi. La globalizzazione, nota AS, ha un volto ambivalente.
Ma offre stimoli critici. Anzitutto mette in crisi la teoria comunitarista (M. Sandel, C. Taylor, A. MacIntyre) per la quale l’individuo costruirebbe la propria identità a partire dalla comunità di appartenenza: in realtà, la globalizzazione mostra che ognuno è coinvolto in una pluralità di identità e deve scegliere quale sia prioritaria e come siano connesse tra loro. Non che AS neghi l’influsso della comunità in cui si vive, ma ne vuol ridurre il peso “identitario”, evitando di dare per scontata la superiorità dell’appartenenza comunitaria, col rischio di ridurre le possibilità di dialogo con culture diverse e limitare la libertà di scelta del singolo (Gandhi scelse di stare con chi si opponeva alla madrepatria inglese, invece che con quanti ne servivano le leggi).
AS distingue la funzione definitoria dell’identità (circoscrive il gruppo di persone) e la funzione percettiva (indica il modo in cui si concepisce la realtà). I cui riflessi si vedono nei tragici conflitti tra gruppi etnici opposti in Ruanda, Ex-Jugoslavia, Indonesia (evitabili se si fossero riviste le priorità di appartenenza?).Connesso all’identità è poi il cosiddetto “scontro di civiltà” teorizzato da Samuel Huntington: crollati i regimi totalitari del XX secolo, si sarebbero scontrate non più le ideologie politiche ma quelle culturali e religiose. All’opposto Francis Fukuyama, per il quale la “fine della storia” sarebbe giunta col trionfo della democrazia liberale che avrebbe aperto le porte a un futuro “post-umano” dominato dalle tecno-scienze che avrebbero assegnato più diritti a chi avesse avuto maggior accesso a manipolazione genetica e neo-medicine, fino al rischio - paventato da alcuni - della schedatura di massa con microchip sottocutanei che mettono le persone permanentemente in rete, inneggiando alla “mistica del DNA”… Scenari opposti tra loro, ma che portano a riflettere sul rapporto tra soggetto e ambiente.
2. Ecologia: ambiente e personaIl nesso tra economia ed ecologia risale a Ernst Haeckel che a metà Ottocento conia il termine “ecologia” quale “economia della natura”. Dall’orizzonte naturalistico, il termine è poi passato a designare il rapporto uomo/risorse a metà del Novecento, legandosi ai timori sulle conseguenze negative dell’azione umana sull’ambiente che hanno fatto nascere associazioni ambientaliste (WWF), corsi universitari, iniziative cinematografiche (The Day After Tomorrow, 2004) e filosofiche (il concetto greco di “Gaia”, il pianeta che vive, di James Lovelock).Il terreno di tali riflessioni fu l’Inghilterra di Adam Smith, teatro della prima rivoluzione industriale di fine Settecento, all’insegna di macchine, materie prime (carbone minerale), crescita demografica per diminuita mortalità, sviluppo della comunicazione e dell’istruzione. Uno sviluppo, dunque, ma non accessibile a tutti. Da qui i movimenti di protesta (luddismo inglese di inizio Ottocento) e i timori per lo sfruttamento eccessivo e il possibile esaurimento delle risorse.
In merito gli studiosi divergono: da chi afferma il pericolo del surriscaldamento globale a chi dice che gli idrocarburi sono ben lontani dall’esaurirsi, da chi prevede scenari terroristici per il monopolio petrolifero a chi denuncia la deforestazione massiccia.
In questo quadro complesso e articolato si colloca il concetto di “sviluppo sostenibile” che cioè “soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”. AS è perplesso dinanzi a teorie di sviluppo sostenibile che considerino le persone come “oggetti” passivi di tutela esterna e non agenti liberi e protagonisti. Problemi aperti: come tutelare l’esigenza di tutela ambientale con la competitività internazionale? Le politiche governative paiono poco organiche, dirette all’emergenza (buco dell’ozono, agenti inquinanti, smaltimento rifiuti, tutela della biodiversità) e non lungimiranti (cfr. COP 21) né capaci di integrare aspetti ambientali ed economici, collocando le persone al centro dello sviluppo.
Ecco il nodo del problema: mettere la persona al centro della questione ecologica (cfr. idea di “ecologia integrale”). Come si è tentato di fare già parlando di “ambiente” e non più solo “natura” (mentre “creato” resta termine religioso). Il problema ecologico è insomma una questione di ethos pubblico, tocca i valori che ispirano la convivenza umana: non più solo ambientalismo (tecniche) ma ecologismo (cultura), nell’ottica di una promozione di stili di vita e iniziative educative favorevoli alla interazione uomo-ambiente ma centrate sul soggetto.
3. Valori della persona, istituzioni e crescita economicaNel contesto dello sviluppo come libertà, occorre definire il rapporto tra persone e istituzioni, sapendo che la sola azione di queste ultime indebolisce il coinvolgimento popolare, mentre la sola iniziativa dei singoli renderebbe meno necessarie le riforme governative.Ancora: si tratta di promuovere una cultura etica diffusa, riconoscendo che il problema non è il controllo della natalità per diminuire l’inquinamento, ma l’aumento dello sviluppo e della ricchezza dei paesi poveri (e più inquinati).
Max Weber ha studiato il rapporto tra etica protestante e spirito del capitalismo, sostenendo non l’identità tra i due elementi ma una certa affinità (la ricerca di segni della predestinazione divina avrebbe accompagnato in area protestante un migliore sviluppo dell’iniziativa capitalistica: il calvinismo ha accompagnato, non generato lo sviluppo del capitalismo). Ma a Weber si oppongono quanti riconoscono altrettanto validi stimoli al progresso e allo sviluppo nel confucianesimo. Tanto basta per dire che spirito e morale influenzano lo sviluppo materiale.
CAPITOLO III – LA LIBERTÀ, CONDIZIONE PER LO SVILUPPO
1. Persona e agireAffinché la persona possa svilupparsi occorre un clima di fiducia in un contesto democratico.Solo di recente – abbiamo visto parlando di Weber – si è recuperata l’idea che i valori sono importanti per i risultati economici. Prima ci si fermava alla tesi attribuita ad Adam Smith, padre della scienza economica moderna, secondo cui per ottenere successo sarebbe sufficiente la ricerca dei guadagni individuali, unica o massima motivazione dell’agire umano.AS critica questa lettura di Adam Smith, rilevando che nella sua Teoria dei sentimenti morali (1759) si afferma che l’interesse individuale si connette a una “simpatia” che rende attenti alle vicende altrui, aiutando a mantenere relazioni equilibrate con gli altri, ottenendo riconoscimento sociale e reputazione. Ben lontani dalla Favola delle api (1705-1729) di Bernard Mandeville che
sostiene invece il motto “vizi privati, pubblici benefici”, cioè che la ricerca delle comodità individuali (vizi privati) favorisce l’economia complessiva (pubblici benefici).Lo stesso Smith nella Ricchezza delle nazioni (1776) afferma pure che andiamo dal macellaio, dal birraio o dal fornaio rivolgendoci non alla loro umanità ma al loro egoismo, intendendo però che lo scambio avviene sulla base dei propri interessi e non della gratuità. Ma questo significa affermare il ruolo del self-love, senza arrivare a dire che il puro interesse egoistico (selfishness) da solo possa far funzionare lo scambio. Ma tanto basta per dire, ad AS, che non esiste uno Smith moralista (della simpatia) e uno Smith economista (del self-love) inconciliabili tra loro.
Alla “simpatia” di Adam Smith possiamo collegare un altro fattore decisivo per lo sviluppo, cioè la fiducia. Proprio fiducia e lealtà avrebbero creato il clima per cui, a detta di Jeremy Rifkin, al declino di prestigio degli USA farebbe da contraltare l’ascesa dell’Unione Europea, oggi regolata dal Trattato di Lisbona (2009). Alla fiducia ha fatto appello il Presidente della Repubblica Ciampi nel suo discorso di fine anno 2003.In questo orizzonte, si comprende come sia possibile il buon funzionamento del mercato, in cui si incontrano interessi diversi (noi vogliamo sfamarci, il fornaio guadagnare). Quando questi interessi siano addirittura conflittuali, Adam Smith si limita a immaginare una “mano invisibile” (La ricchezza delle nazioni, 1776, anno dell’indipendenza USA) che raccorda i diversi interessi per cui perseguendo il suo interesse, l’individuo fa quello della società (in chiave simpatetica, non solo casuale).
AS critica però il fatto che il soggetto sia però passivo. Il punto non è che certe conseguenze non siano intenzionali, bensì che si possano prevedere certi effetti. Una conseguenza non voluta non è necessariamente non-prevedibile! Tra le variabili da prevedere, c’è l’influenza del fattore fiducia che costituisce il vincolo tra economia capitalistica e democrazia liberale. Ma AS appare un po’ ingenuo nel credere che il successo economico coinciderebbe con il successo morale. Invece, oltre a più mercato occorre andare “oltre” il mercato.
2. Il valore dell’agire: utilità e conseguenzePer cogliere il nesso tra soggetto e comportamento dobbiamo parlare di razionalità. In prima istanza la intendiamo come rapporto tra scelta e preferenze. Ma sarebbe equivoco affermare che l’attore agisce sempre e solo per il proprio interesse personale (basti pensare ai sacrifici scelti da un genitore per i figli o dai soldati per la madrepatria). Bisogna riconoscere che non si vota solo col portafoglio, ma anche per ideali e senso d’identità sociale. Ora, nota AS, negare che si agisca sempre e solo per egoismo puro non significa affermare, all’opposto, che si sia sempre motivati da altruismo. Altro conetto di razionalità è quello legato alla coerenza interna tra preferenze, per cui l’attore sceglie in base alle priorità. Limite di dal concezione è confondere l’ottimizzazione (la scelta del meglio in assoluto) con la massimizzazione (la scelta dell’opzione ora più valida).Comunque sia, AS sente l’esigenza di una analisi decisionale del soggetto più approfondita, che non riduca ogni scelta alla razionalità (massimizzazione), ma contempli altresì il ruolo di valori ed emozioni (anima della pubblicità, secondo il nipote di Freud, Edward Bernays).
La prospettiva tradizionale è quella dell’ottimo paretiano. Vilfredo Pareto, economista, nel suo Manuale di economia politica (1906) distingue le azioni umane in campo economico (di tipo logico) e in campo sociale (di tipo non logico, ispirate ai valori). Da qui la netta distinzione tra economia e sociologia. In ambito di politica economica sono giustificati gli interventi che non consentono di migliorare una condizione individuale senza peggiorare quella di un altro soggetto. Il merito dell’ottimo paretiano è di andare aldilà delle somme di utilità, benché rimanga un criterio di efficienza più che di equità (non potrei migliorare le condizioni del povero se queste peggiorassero quelle di un ricco!). Questo criterio, nota AS, è quello più usato nella odierna economia del benessere, ma è paradossale: per rispettare l’ottima paretiano potrei dover rinunciare a minimali richieste di libertà individuali!
A monte dell’ottimo paretiano sta l’impostazione utilitaristica che coniuga welfarismo, ordinamento per somma, consequenzialismo. La bontà di un’azione dipende dalla somma totale di utilità e benessere (welfare). Ma bisognerebbe distinguere l’utilitarismo dell’atto (valuto caso per caso) da quello della regola (analisi delle regole generali). Comunque, l’utilitarismo è una dottrina teleologica (il bene è prioritario rispetto al giusto e giusto è ciò che massimizza il bene), non deontologica (rispetto di valori di fondo, non negoziabili). Il fascino di questa teoria è che pare considerare molto i desideri individuali, ma fatica a rintracciare una funzione di “utilità collettiva” che consideri i singoli soggetti e non solo la somma totale delle loro felicità.
La teoria dei giochi mostra la divergenza tra razionalità individuale e ottimo sociale col dilemma del prigioniero: se uno confessa per entrambi, si beccano 10 anni; se l’altro solo confessa, quello è scarcerato ma l’uno si becca 20 anni; se nessuno confessa, si beccano solo 2 anni (per crimini minori, in mancanza di prove). Individualmente è meglio confessare (e beccarsi 10 anni), ma nella strategia di gruppo meglio non confessare affatto (facendosi solo 2 anni in carcere). Insomma, agendo in modo altruistico si ottiene un risultato per sé migliore, rispetto al seguire solo i propri interessi.Bernard Williams accusa poi l’utilitarismo di fondarsi su riduzione (ogni interesse è sullo stesso piano degli altri), idealizzazione (scelte in situazioni ideali, di informazione perfetta), astrazione (presunta asetticità da circostanze concrete).
Il benessere in chiave utilitaristica è esclusivamente misurato in riferimento al vantaggio personale, mentre AS si rifà alla persona in quanto agente e non mero “contenitore di utilità”. Anche perché un conto è parlare di casa, lavoro, reddito e cibo – quantità misurabili e confrontabili – e altro è invece parlare di “somme di felicità”; ancora: si può essere agiati senza stare bene, oppure felici senza molta libertà, o vivere la vita cercata ma non essere felici… Infine: se l’individuo è il miglior giudice di se stesso, come giustificare politiche di intervento e correzione “dall’alto”? Insomma, l’utilitarismo ha gravi carenze a livello psicologico e politico.
AS, invece, parte da un approccio aristotelico, vedendo l’uomo come “animale socievole”, traendo dalla dynamis aristotelica il proprio concetto di capacità. Anche se rifiuta di darne un elenco preciso ed esaustivo, come invece fa Martha Nussbaum (riducendole di fatto ai diritti fondamentali della persona: vita, salute, integrità fisica, libertà di coscienza e interazione sociale, proprietà…). Ma favorendo comunque un recupero della dimensione etica nell’ambito dell’economia.
3. Il contesto dell’agire: democrazia e partecipazioneIl clima di fiducia che consente al singolo di fare scelte libere e responsabili ha nella democrazia il contesto più propizio. Dopo l’attentato alle Torri Gemelle di New York (11/09/01) si è aperto il dibattito intorno alla libertà e alla democrazia, il cui trionfo pareva certo dopo gli avvenimenti del 1989-1991 (crollo del comunismo, di cui tratta diffusamente la Centesimus Annus). Aveva ragione G.W. Bush nel ritenere gli USA investiti della missione di esportare nel mondo la democrazia? O ha ragione chi accusa l’azione militare USA di interessi e ambiguità?
AS colloca la nascita della democrazia ai tempi dell’antica Grecia, partendo dalla riflessione politica di Aristotele che presenta tre forme di buon governo (monarchia, aristocrazia, politéia quale buona democrazia) e altrettante degenerazioni (tirannide, oligarchia, democrazia). Ma bisognerebbe riconoscere che a quel tempo la libertà della polis veniva prima di quella dei cittadini. Diversamente dalla attuale liberal-democrazia che considera le libertà del singole meritevoli di tutela prima dell’interesse dello stato).Precedenti “democratici” sono la Magna Carta Libertatum (1215, Inghilterra, benevola concessione del re Giovanni Senza Terra ai baroni inglesi), la costituzione americana (1776) e la rivoluzione francese (1789). Benché oggi siano democratici 117 stati su 191 circa 2,5 mld di persone (40% della popolazione) sottostanno a regimi autoritari. Quindi la democrazia è ancora una aspirazione più che un fatto.
A chi sostiene che la democrazia sia un ostacolo allo sviluppo economico (citando l’esempio del primo ministro di Singapore dal 1959 al 1990, Lee Kuan Yew, artefice di grande sviluppo con metodi autoritari), AS ribatte mostrando gli errori politici di queste “tesi di Lee”: la democrazia sottopone i governanti al controllo del popolo e dunque devono agire al meglio; inoltre la libertà e la fiducia democratiche favoriscono la solidarietà nel bisogno e l’aiuto delle istituzioni per non perdere consensi…; ancora: errore antropologico è la mancata valorizzazione della libertà politica come bene intrinseco, per cui la democrazia diviene semplice contrattazione tra libertà individuale e non tutela del bene della libertà.La democrazia non è un fatto acquisito ma un ideale da perseguire. C’era infatti la democrazia nella Germania in cui ascese al potere Hitler negli anni Trenta. La democrazia è più metodo che governo. E per AS non consiste solo nelle libere elezioni (come vorrebbe Huntington) bensì nella discussione pubblica. Essendo un metodo, è come un sacco vuoto da riempire di contenuti. Indicando il rapporto tra la democrazia come metodo e la democrazia come valore. Sapendo che se ne percepisce il bisogno laddove essa manca…
La democrazia non sta nella regola della maggioranza - che potrebbe anche rovesciarsi nella dittatura della maggioranza – ma sta o cade coi valori che essa promuove (Centesimus Annus).Essa ha una ricaduta positiva per lo sviluppo, come mostrarono la trasparenza (Glasnost) e la riforma economica (Perestrojka) dell’URSS di Gorbaciov. Alla democrazia si legano inoltre una cultura della legalità che favorisca il clima di fiducia a essa proprio nonché la possibilità, in ambito internazionale, di interazioni economiche tra Stati che favoriscano lo sviluppo e combattano la povertà (la libertà manca nell’84% dei Paesi più poveri: un semplice caso?). Ancora: la democrazia favorisce l’istruzione pubblica che incide sulla crescita economica (vedi i casi dell’India prima e della Cina adesso, dove l’alfabetizzazione degli strati inferiori della società unita a una certa liberalizzazione economica aiuta la crescita sociale).
4. Le condizioni dell’agire: giustizia e diritti umaniLa democrazia è aperta, non deve tradire le promesse di eguaglianza e libertà (“governo del popolo, attraverso il popolo, per il popolo”, disse Lincoln nel 1863). Per ovviare alle (fisiologiche) crisi della democrazia, occorre adottare un concetto di giustizia non riduttivo: AS critica Rawls, per la sua incapacità di considerare le molteplici appartenenze identitarie del singolo, come pure il comunitarismo che vorrebbe riconoscere una sola appartenenza comune, favorendo il disprezzo (e poi l’intolleranza) verso gruppi diversi o minoritari. Per favorire la libertà e il clima di fiducia, occorre tutelare la libera stampa, sapendo che gli uomini non solo usano, m vivono il linguaggio. E prendere parte alla discussione pubblica è essenziale per la democrazia (come non avvenne nei regimi totalitari del ‘900 e ancora non avviene in Cina o Corea del Nord), a dispetto delle lobbies occulte che potrebbero controllare il sistema dei media (vs una reale etica dell’informazione).Alla base della democrazia sta l’unica forma di giustizia trasversale e condivisibile: i diritti umani, garantiti da ogni costituzione democratica. Ma oggetto di critica: come parlarne, se non sono tradotti in legge? E poi: esistono prima di essere legalmente riconosciuti? Ancora: hanno consistenza, se non si specifica chi sia deputato a farli rispettare? Ad esempio GPII affermava che la compassione non poteva ridursi a mero sentimentalismo ma doveva tradursi in iniziative operative in favore dei più deboli (Enc. Sollicitudo Rei Socialis, 1987). Alla luce di queste critiche, AS preferisce distinguere tra le libertà dell’individuo (di cui è dotato in quanto uomo) e diritti (la loro traduzione legale). Ma resta un’ombra, relativamente alla difficoltà di definire e fondare i diritti umani: è infatti più facile tutelarli che impegnarsi ad analizzare la natura dei soggetti che ne sono portatori, alla ricerca dell’origine dei diritti stessi.
CAPITOLO IV – LA LIBERTÀ, META PER LO SVILUPPO
1. I protagonisti dell’agire: tra individuo e StatoLa critica rivolta alla praticabilità della tutela effettiva dei diritti umani sta nel dichiarare impossibile il definire gli enti deputati alla difesa di ogni singolo diritto o classe di diritti. Per superare questa critica occorre indagare il rapporto tra individuo e Stato.La libertà umana non è assoluta, ma limitata e situata. Affinché possa ben esercitarsi occorrono determinate condizioni che coordinano le varie libertà, dette da AS “libertà strumentali”: le libertà politiche, le infrastrutture economiche, le occasioni sociali, il clima di fiducia, la rete di sicurezza sociale. Queste raccordano le libertà del singolo con quelle sociali.
È possibile un ideale di sviluppo che promuova le libertà individuali in armonia con gli interessi di tutti? AS esamina il caso del comunismo sovietico e indica come maggior sconfitta storica la proprietà statale dei mezzi di produzione (fondamentalismo istituzionale); diverso è l’atteggiamento rispetto al fondamentalismo dei risultati (eguaglianza economica) e dei processi (processo cooperativo per la decisione), AS non è così critico, riconoscendo l’importanza della eguaglianza e della partecipazione collettiva. Ma si distacca dal marxismo perché il protagonista non è, a suo dire, la classe operaia bensì l’individuo.
Come il marxismo non tutela la persona singola dinanzi alle richieste dello stato (cfr. stalinismo), così la pura economia di mercato, sul fronte opposto, rischia di ridurre tutto a oggetto di transazione. Mentre occorre tutelare quei beni pubblici che non generano rivalità né escludibilità.
A questo proposito si collega il discorso sul Welfare State, cioè una pubblica amministrazione che fornisca ai cittadini un reddito minimo e garanzia per malattia, vecchiaia, disoccupazione. Se il Medioevo vive della carità di enti religiosi, nel Sei-Settecento prevale la filosofia del laissez-faire (il governo non deve interferire, vs pianificazione socialista). Welfare State indica nello specifico la politica di protezione sociale realizzata nel secondo dopo guerra in Inghilterra (con inversione di tendenza con Margaret Thatcher che invece taglia le tasse ai ricchi per favorire investimenti produttivi).Oggi il quadro è critico: bassa natalità, invecchiamento della popolazione, disoccupazione, rallentamento economico non danno le risorse necessarie per mantenere il sistema sorto negli anni ’80-’90. Realisticamente, lo stato sociale è da rivedere, cercando un equilibrio tra esigenze di stabilità economica e intervento sociale. Occorrono decisioni condivise, a cui si può arrivare con la “terapia del consenso” vs decisioni prese per decreto. Il rischio è non convergere sui reali bisogni (ad es. il Trattato di Maastricht che nel 1992 ha sancito la nascita della CEE, puntando sui vincoli finanziari e trascurando povertà e disoccupazione ad essi legate).
2. Esito dell’agire: benessere e capacitàNell’interazione individuo-società entra in gioco il concetto di “capitale umano”: dalla prospettiva fisica (risorse, macchine) si passa a quella antropologica (talenti umani). Il rischio è però, anche qui, di ridurre l’uomo a mezzo di produzione e non a obiettivo del processo di sviluppo.Il capitale sociale non è la semplice somma delle potenzialità dei singoli, bensì il frutto dello sforzo e della cooperazione solidale posto in connessione con i rapporti interpersonali di ogni individuo. Quindi riguarda non solo capacità produttive, ma relazioni sociali e norme di reciprocità, in orizzonte non di pura economia bensì di vita di comunità.
In merito, AS distingue benessere e capacità, cioè il possesso di un bene e le occasioni e opportunità da questo dischiuse. Definisce funzionamenti (functionings) i comportamenti e modi d’essere che costituiscono gli obiettivi in vista dei quali le risorse disponibili servono come mezzi. I funzionamenti non sono merci/risorse, ma stati di vita. Mentre le risorse sono i mezzi per conseguire un certo funzionamento. La combinazione dei vari funzionamenti – intesi come stati d’essere e di fare – è costituita dalle capacità. Mentre l’entitlement è un insieme di panieri alternativi di merci (commodities) la capability è insieme di panieri di funzionamenti (functionings) e tra di essi esiste bi-direzionalità (+ risorse danno + capacità, e viceversa). AS afferma che un funzionamento è un conseguimento (condizione di vita) mentre la capacità è l’abilità di conseguire (nozione di libertà).Cioè: Beni/risorse/benesserecapacità (possibilità)funzionamenti (condizione/assetto di vita)
Occorre verificare però la reale capacità di acquisire funzionamenti (oltre la mera e data fattualità) perché tali capacità rappresentano la libertà individuale di acquisire lo star bene (anche in futuro, oltre a quanto oggi è dato).
Il positivo di questo approccio è che si è passati dal welfare (insieme di cose materiale disponibili) al well-being (complesso di opportunità). Il rischio è però una lettura riduttiva: se ho + scelte, ho per forza + benessere. Non è così. Né AS spiega oltre la natura della scelta: quando e fin dove è libera? Parlare di “qualità” di libertà è bene (non dipenda solo dalla quantità di alternative disponibili) ma AS non chiarisce di che “qualità si tratti”. Ma è indubbio un merito nella sua concezione: aver posto al centro non le risorse/merci, bensì la libertà generata dal loro possesso (capacità). Non si devono poi confondere benessere e tenore di vita (il primo riguarda i funzionamenti, il secondo solo le risorse): non basta il portafoglio pieno per star bene. Il benessere è infatti tale se non c’è esclusione sociale (la disoccupazione porta decremento di risorse, ma anche depressione, solitudine, meno autostima).
3. Oltre l’agire: antropologia e cultureIl contesto più adatto in cui i singoli possono confrontarsi e scegliere per il bene comune secondo le aspirazioni individuali è la democrazia. Che si può esportare nel nome della universalità dei diritti umani da essa promossi e tutelati. Occorre chiedersi se questi diritti siano un patrimonio dell’umanità o del mondo occidentale. Come pure se la tutela della democrazia, ad esempio nella guerra al terrorismo, ammetta la revisione di alcuni diritti (vedi le torture per i prigionieri di guerra).Se Max Weber ha illustrato il rapporto tra credo religioso protestante e capitalismo moderno, potremmo rintracciare lo stesso rapporto tra la dottrina di Confucio (VI-V sec. aC.) improntata a rispetto, benevolenza, fedeltà, bontà (ren) e l’economia asiatica? Certo, il confucianesimo non è l’unica religione asiatica (area che conta quasi 4 mld di abitanti!), ma coesiste accanto a buddismo, induismo, taoismo, islam… Non c’è dunque una sola religione, né questa coincide con la cultura nel suo complesso, per cui bisognerebbe parlare piuttosto di “civiltà”. A fondamento della quale sta la tolleranza, praticata dall’imperatore Ashoka nell’India del III sec. a.C., come pure dal principe buddista Shotoku nel Giappone del VII sec. d.C. e infine dall’imperatore islamico Akbar nell’India del XVI sec. Questa trasversalità della tolleranza alla cultura asiatica, pur in religioni diverse, per AS è un buon argomento contro lo “scontro di civiltà” (religiose) teorizzato da Huntington nel 1993, poiché dire Arabia non significa dire Islam, come dire India non significa dire Induismo. Anzi: all’interno dello stesso paese spesso di registrano scontri tra gruppi religiosi diversi. Quindi non si può parlare di valori occidentali, ma bisogna riconoscerne una certa paternità anche all’Oriente. Fino a giungere a una base comune di dialogo che siano i diritti umani, la cui promozione è facilitata dalla democrazia. Contro AS, bisogna riconoscere che non basta parlare però di diritti umani o tolleranza per dire “democrazia”, visto che storicamente solo in USA ed Europa gli stessi valori hanno avuto effettiva realizzazione (un conto è il diritto alla tolleranza, altro è la sua benevola concessione in un regime orientale).
4. Per un nuovo agire: diritti, libertà, responsabilitàNon esiste conflitto, per AS, tra libertà fondamentali della persona (tradotti nei diritti umani) e i fini collettivi: il punto di connessione è dato dal concetto di capacità. L’incontro tra libertà del singolo e vita sociale porta a riflettere sul concetto di libertà. Distinguiamo freedom (essere liberi ma uniti agli altri popoli, quindi connessi) da liberty (sciolti da schiavitù e sottomissione, quindi separati). AS riprende la distinzione del 1958 di Isaiah Berlin tra libertà negativa (“da” – liberalismo di destra) e positiva (“di” – socialismo di sinistra).
I 4 principi ordinatori della società secondo la dottrina sociale della chiesa – cioè dignità della persona umana, solidarietà, sussidiarietà, bene comune – le contemplano entrambe.La libertà negativa riguarda l’assenza di interferenze, mentre quella positiva la possibilità di prendere decisioni autonome e responsabili. Alla prima AS collega la libertà-di-agire, alla seconda la libertà-di-conseguire. Non sembra un grande passo avanti rispetto a Berlin, ma evidenzia che per AS la libertà non è solo mezzo bensì parte integrante della vita buona del singolo.
La responsabilità richiede la libertà, tenendo conto di diritti e doveri (John Donne: “Nessun uomo è un’isola”, XVI sec.). Per AS la libertà è dunque mezzo e fine dello sviluppo, uno sviluppo inteso come GALA (getting by, with a little assistance) – farcela con un po’ di aiuti pubblici – vs BLAST (Blood, Sweat and Tears – cfr. Churchill), cioè sperequazione sociale e autoritarismo come rischi collaterali per accumulo di ricchezza.
A questo punto si tratta di scegliere tra il modello assimilazionista di cui parla Erodoto (i Persiani sono ostili ai lontani, perché l’altro è un nemico) o quello di Ulisse/Sen (l’altro è un fratello, occasione positiva di confronto con la diversità).
PARTE SECONDA – PROVOCAZIONI PER LA TEOLOGIA MORALE
CAPITOLO V – LA RAZIONALITÀ E L’AGIRE
1. La divaricazione tra persona e societàL’Ulisse dantesco (Inferno, XXVI) è sospeso tra hybris/tracotanza e missione di esplorare il mondo per l’umanità. Ma non sono letture incompatibili tra loro. Ulisse/Sen pone in rilievo l’attitudine sociale dell’uomo che dal confronto con l’altro trae occasione di crescita. Cosa vera per i singoli e per i popoli.
Oggigiorno il duplice e simmetrico rischio è però che l’individuo sia assorbito dalla società o, all’opposto, che questa sia assorbita nell’individuo. Il primo caso è proprio dei totalitarismi di destra a sinistra, in cui l’individuo è sottoposto alla causa dello stato (nazismo, comunismo, kamikaze giapponesi). Nel secondo caso invece razionale è ciò che è oggetto di desiderio e lo stato è semplice strumento di tutela delle proprie libertà, in un contesto che vede l’altro come nemico delle proprie ambizioni. A questo schema fa riferimento il motto “la mia libertà finisce dove inizia la tua”, da cui deriva che l’altro è ostacolo alla mia libertà! AS nota che ciascuno vive molteplici appartenenze (sesso, sangue, preferenze, contesto sociale…) che si intrecciano e ordinano in ognuno in modo diverso (interazione tra natura e culturaidentità).
Se la mia libertà viene prima di tutto, allora si scatena una selvaggia lotta per la sopravvivenza. Un esempio è il dipinto di Eugène Delacroix (XIX sec.), “La libertà guida il popolo”, in cui una giovane donna, col berretto giacobino, marcia vittoriosa alla testa del popolo. Ma marcia su uno stuolo di cadaveri. Insomma: per il bene dell’umanità, si perde di vista il valore della singola persona. Che viene spazzata via, come nel Terrore francese.
2. L’incrocio tra persona e societàDopo la guerra fredda, oggi la paura viene dal terrorismo internazionale. La persona si vuol difendere, le autorità devono prevenire e reprimere. Nei sistemi liberali tentati dal radicalismo individualista, pare prevalere il “compromesso accondiscendente”: rinuncio alle posizioni forti per non creare conflitto, ad esempio rinunciando al progetto di discarica appena annunciato di fronte a chi occupa i binari del treno… Sindrome NIMBY (Not In My Nack Yard) e BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything) o LULU (Locally Unwanted Land Use). Forme di opposizione cui le istituzioni replicano con un compromesso che mira al quieto vivere. Se l’altro è un nemico, l’autorità accondiscende ai gruppi numerosi e rumorosi, o al singolo se minaccia cattiva pubblicità sui media.Diverso è l’approccio aristotelico: valorizzare l’unicità dell’individuo per una unità armoniosa che non si riduca a rigida uniformità. Cosa che vale per un rispetto dei singoli ma anche dei popoli, a partire dal riconoscimento della comune umanità. Ma tutto dipende, appunto, dalla visione antropologica sostenuta: l’altro è un nemico o un fratello?
3. Per una positiva interazione tra persona e società: capisaldi antropologiciIl pensiero cristiano offre alcuni capisaldi irrinunciabili per una visione antropologica favorevole a una buona relazione individuo-società.Anzitutto (1) la centralità della persona umana che va trattata come fine e mai come mezzo, in quanto l’uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio e voluto per se stesso, chiamato alla divina figliolanza per adozione in Gesù Cristo (GS 22: “figli nel Figlio”).Poi, (2) la persona è dotata di intrinseca socialità, superiore agli animali (cui Adamo dà il nome), benché l’uccisione di Abele da parte di Caino riveli che il fratello può esser visto anche come un nemico. Ma il paradigma Ulisse/Sen porta il singolo ad aprirsi a una rete di relazioni contrassegnate dalla carità, specchio della comunione intra-trinitaria. Quindi, (3) la solidarietà che nel racconto della torre di Babele si percepisce minacciata dal tentativo di imporre il proprio mondo sugli altri, invece che costruisce con gli altri un mondo migliore. Il recupero della filantropia della Grecia classica e della humanitas romana potrebbe esser un buon punto di partenza per riedificare una società fraterna e solidale. Laddove la solidarietà sarebbe l’aspetto sociale della carità.
La Chiesa non motiva la solidarietà solo in quanto membri della famiglia umana ma perché creati da Dio e a Lui destinati. Esiste una solidarietà buona tra i battezzati (la comunione dei santi) e una negativa (il peccato sociale: ogni peccato danneggia il singolo ma anche l’intera chiesa). Ecco perché la Chiesa chiede di confessare le proprie colpe quando si comincia la Messa e così pure nel Padre Nostro (“rimetti a noi i nostri debiti…”). La chiamata a una vita buona non si traduce per il cristiano nel richiamo a una astratta morale bensì all’aderire a una persona, Gesù. Per accedere allo status di figli adottivi basta il battesimo, poi ogni comportamento conseguente non è sforzo del singolo ma risposta a un dono di grazia già ricevuto, recuperando in pieno il senso della fraternità umana a partire dal senso della paternità divina (cfr. il padre misericordioso e i due figli, Lc 15).
Per superare il contrasto tra libertà del singolo e quella della comunità, occorre rifarsi al principio della sussidiarietà (di cui pure parla il titolo V della Costituzione Italiana riformato nel 2001), di cui tratta la Quadragesimo Anno di Pio XI (1931: non si deve far svolgere dalle società superiori quanto possono fare quelle inferiori o il singolo stesso) e che è ribadita dalla Centesimus Annus di GPII (1991): lo stato assistenzialista rallenta lo sviluppo e solo chi è davvero prossimo al bisognoso può portare aiuto e conforto efficaci. Sussidiarietà orizzontale (tra stato/articolazioni periferiche e società/individui) e verticale (tra stato ed enti locali).Analogamente, centrale tra individuo e società risulta la famiglia come luogo primario di umanizzazione (Christifideles Laici 40).
4. Un compromesso al meglioI capisaldi cristiani permettono di superare il compromesso accondiscendente, valorizzando centralità e dignità della persona. Bisogna guardarsi dai rischi del nichilismo e del relativismo contemporanei. E neppure pensare che l’oggettività sia qualcosa di asettico e indipendente dallo spettatore (come una partita di calcio o un’opera d’arte impressionista non sono!). Anche la verità morale è oggettiva nel senso di interpellare libertà e responsabilità del soggetto. Ma occorre evitare il rischio di cadere da una morale degli atti (oggettiva) a una morale dell’intenzione (soggettiva).
AS suggerisce una mediazione tra soggettività e oggettività con l’espressione “oggettività posizionale”: esser consapevoli che l’oggetto è visto da un certo punto di vista soggettivo. Occorre assumere il punto di vista altrui per verificarne la plausibilità. La svolta “empatica” in teologia morale potrebbe guardare a Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) che parlava di Einfuehlung/Empatia: l’oggetto si attinge attraverso la soggettività.Ciò che salda i fatti agli ideali è l’intenzionalità. La Chiesa dice che la moralità di un atto è legata all’oggetto nella prospettiva del soggetto che agisce (Veritatis Splendor 101). Per il cristiano si tratta di assumere lo sguardo di Cristo, diventando per “empatia divina” come Lui (theosis/divinizzazione). Questa posizione di “oggettività soggettiva” vede la Chiesa protagonista non come al servizio della verità ma come diaconia alla verità, per guidare al maggior bene possibile concretamente (date le circostanze presenti).Un conto è to take a decision (spostarsi sa un punto a un altro), altro è to make a decision (costruire una scelta mescolando istanze diverse): non la soluzione più comoda, ma la migliore in quelle circostanze.Resta ora da chiedersi se il modello Ulisse/Sia valga, oltre che per il rapporto con l’altro, anche per la relazione con l’Altro…
CAPITOLO VI – PERSONA CON LA SOCIETÀ
1. Le categorie della decisioneNel cap. V si è visto come una positiva articolazione individuo/società possa emergere considerando l’altro come fratello, in un modello di apertura e fiducia negli altri. Tale approccio oltre che per l’orizzonte interpersonale vale anche per quello intrapersonale? Per rispondere, dobbiamo concepire l’uomo come un individuo alla ricerca del costante miglioramento di sé. Caratteristica che, a suo modo, anche Charles Darwin espone nel suo L’origine della specie (1859) esponendo il concetto di evoluzione naturale quale selezione delle mutazioni
insorte per cause genetiche o contingenti nella specie e selezionate dall’ambiente nell’ambito della lotta per la sopravvivenza. L’uomo sarebbe, in questa ottica, l’apice di un fortuito processo evolutivo. Il creazionismo di matrice protestante americana ha rigettato in toto l’evoluzionismo, mentre la Chiesa lo accoglie con dei correttivi: non è un processo senza guida, accidentale, né le singole scienze naturali potranno mai rendere conto del significato globale dell’esistenza umana. La Chiesa oggi accetta dunque l’evoluzionismo biologico, purché esso ammetta una discontinuità ontologica che permetta di rendere conto dell’anima spirituale che differenzia l’uomo da ogni altro essere vivente.
Secondo AS, Darwin pone troppa enfasi sulla necessita di adattarsi all’ambiente piuttosto che svilupparsi/trasformarsi. Così blocca lo sviluppo del singolo e lo deresponsabilizza, riconducendo la sua storia al patrimonio genetico originario. Ora, per quanto si possa spiegare persino l’innamoramento in orizzonte di interazione “chimica” tra individui, questa non può che essere una dimensione dell’affettività umana. Mentre lo scientismo afferma che l’uomo è solo corpo, che la scienza è neutra e che l’etica umana è trasformazione evolutiva dell’altruismo animale.Senza negare la base biologica di partenza, occorre evidenziare anche l’influenza ambientale (Cfr. E. Zola e il ciclo dei Rougon Macquart, 1868-1893) che si intreccia con la libertà umana. L’evoluzionismo in ottica neo-malthusiana lascia invece più spazio alle decisioni del singolo impegnato nella lotta per la sopravvivenza. In pratica: libertà sì, ma situata.
In ambito cristiano la possibilità di cambiamento sempre presente – vera esaltazione della libertà del singolo – trova riscontro nel concetto di conversione, intesa come: (1) passaggio da una religione a un’altra (Clodoveo re dei Franchi, 496; Enrico di Navarra, 1593; il rabbino capo di Roma, Israel Zolli, + 1956); (2) passaggio da una vita dissoluta a una vita buona (l’innominato manzoniano; il poeta francese Paul Claudel, 1886; Leonardo Mondadori e Alessandra Borghese); (3) permanente stile di vita, tipico del credente che si scopre peccatore e si accosta pentito alla riconciliazione sacramentale. La Bibbia è ricca di racconti di conversione (sociale: Zaccheo; personale: adultera), aiutando a non sottovalutare neppure quei peccati veniali che invece creano “strutture di peccato” (Sollicitudo Rei Socialis 36) in cui la rilassatezza morale porta a schiavitù di peccato. E neppure si può dire che il singolo peccato non muti l’opzione fondamentale, come spiega la Veritatis Splendor (nn 65-70).
Cambiar vita per tutti è una chiamata a lasciar un segno positivo nella storia dell’umanità; per un cristiano c’è l’ulteriore (e prima) motivazione di rispondere alla vocazione dell’Eden, in cui il Creatore chiama l’uomo a lavorare come custode prima della caduta e della cacciata. Anche Gesù ha lavorato. Perché il lavoro è il prolungamento della creazione. Ogni singolo uomo ha la vocazione di trasformare il creato, cioè è chiamato (vocare).Chi è chiamato? I pubblicani e i peccatori, cioè tutti gli uomini.A che cosa si è chiamati? Alla salvezza, cioè alla vita di comunione col Signore, poiché l’uomo è “capax Dei” e l’uomo si ritrova solo nel dono sincero di sé (GS 24). In questo orizzonte le classiche filantropia e humanitas ricevono impulso nuovo di fraternità. Il cristiano si sente pienamente coinvolto nelle vicende concrete del mondo e vuol trasformare in meglio la società. Ogni lavoro può essere via di santità (S. Agostino, S. Caterina, S. Francesco di Sales, S. Josemarìa Escrivà).La risposta dell’uomo entra nel disegno salvifico universale di Dio (1Tim 2,4) ed è o sì o no, tertium non datur (anche il differire la risposta è un no). Rispondere da “respondeo” potrebbe essere
res-pondere cioè portare il peso di una azione (chiamata) cui si corrisponde. La responsabilità umana dipende da una libertà situata (spazio e tempo), senza però accontentarsi di rispondere impulsivamente alle circostanze né scegliendo in base al mero tornaconto personale. Il tutto in un paradigma dell’altro-come-fratello. Lasciando spazio alla speranza (compimento pieno delle attese) che è specifica virtù della Chiesa.La speranza non toglie però che la vita sia una battaglia. Già Seneca diceva “vivere militare est” e san Paolo parla della buona battaglia della fede (1Tim 6,12). Anche S. Agostino e S. Ignazio di Loyola usano la terminologia militare, come pure il CVII parla della vita umana come lotta spirituale (GS 37). Nella prospettiva cristiana, la riposta/responsabilità apre all’Altro, con la sempre soggiacente tentazione di voler essere dio al posto di Dio (Cfr. Gen 3). Se si sceglie il proprio tornaconto, l’Altro diventa l’avversario per eccellenza, il rivale assoluto da placare al più con ritualità religiose. Ma se così fosse avrebbe ragione Marx nel definire la religione “oppio dei popoli”! Il punto discriminante è rigettare ogni forma di idolatria, rifuggendo la “simia Dei” che è il demonio che porta a vedere Dio come antagonista, fino ad accusarlo (Satana è l’accusatore).Invece la persona responsabile risponde alla vocazione all’impegno nel mondo con la speranza nell’aiuto di Dio e alimentando tale speranza con la preghiera. Pregare come se tutto dipendesse da Dio, agire come se tutto dipendesse da noi, consigliava S. Ignazio di Loyola. In questo atteggiamento, l’uomo si apre a una relazione filiale con Dio secondo il paradigma vissuto nella carne di Gesù, la cui prima caratteristica è stata l’obbedienza come libera e responsabile adesione al progetto salvifico del Padre, fino alla croce. Diametralmente opposto il rapporto con Dio di scribi e farisei che dietro ai gesti religiosi non hanno vera fiducia in Dio-Padre. Tomas Spidlìk nota che l’obbedienza in greco si esprime come sottomissione (hypotagé) e come ascolto (hypakoé) a uno che parla: in questo senso Dio dice al popolo: “Ascolta Israele” (Dt).
2. I presupposti della decisioneIl nostro futuro non dipende dal nostro DNA ma dalle scelte che facciamo: siamo padri di noi stessi. Non solo l’agire segue l’essere, ma lo costituisce. Sapendo che il demonio, come cane legato alla catena, morde solo chi si avvicina troppo.Se il male resta un mistero, è vero però che educare il senso del peccato aiuta. Come pure ricordarsi che non è vero che il fine giustifichi i mezzi (CCC 1759), poiché la dignità della persona non va mai sacrificata. È un percorso graduale di educazione come contesto di bene, così come la Bibbia è il libro della pazienza di Dio che educa il popolo eletto. Una educazione che richiede il recupero del concetto di formazione enciclopedica, cioè conclusa e circolare, non ridotta alle tecniche utili a “fare”, ma allargata a ogni scienza che illumini il mondo e l’essere dell’uomo stesso.L’utilitarismo fa dell’educazione un semplice addestramento, per imparare a produrre e guadagnare, senza consegnare una vera speranza per il futuro (ecco perché oggi i giovani rifuggono la politica e l’impegno sociale, vivono al presente, nella provvisorietà, rifugiandosi nel proprio piccolo mondo).
Nessuno nasce cristiano ma la fede si “apprende” nella comunità in cui si cresce e si è educati. La teologia morale ha il compito di mostrare il nesso tra ciò che si crede e ciò che si è chiamati a fare, sapendo che la coscienza della propria divina figliolanza conduce a un certo stile di vita. “Sapendo”: cioè occorre una ferma consapevolezza, non un semplice e passeggero coinvolgimento emotivo.
3. I luoghi della decisioneSenza educazione, l’uomo è menomato nelle sue possibilità per cui educare significa guidare alla libertà, suscitando senso critico, andando oltre un mero elenco di nozioni o regole, arrivando a uno sguardo positivo sull’esistenza, con un progetto retto da speranza e fiducia, fondato sulla umana capacità di trascendersi (tipica di ogni sport agonistico) e sulla positiva apertura all’altro come fratello. Non è ingenua speranza, ma fiducia cristiana, per cui si allontana la tristezza come insidia diabolica (S. Francesco di Sales) e si integrano fede e ragione come due ali dello spirito umano che si innalza a contemplare la verità (Fides et Ratio, prologo). La fede non va contro ma oltre l’intelligenza, come la teologia va oltre la parziale prospettiva delle scienze naturali e umane. Come diceva Karl Rahner, l’uomo deve sperimentarsi come persona (un tutto) e come soggetto (libero di orientare la propria esistenza nel reale).
Il luogo in cui educare gli altri allo sguardo positivo verso i fratelli è la famiglia, in cui l’educazione si rivela il complesso degli atti con cui i genitori rendono ragione al figlio della promessa che essi gli hanno fatto mettendolo al mondo (G. Angelini). Nella famiglia si intrecciano l’orizzonte affettivo (rassicurante) e normativo (orientante), educando il figlio alla risposta libera e responsabile al progetto di Dio su di lui.Nella famiglia si forma alla decisione, quindi si forma non solo l’uomo ma altresì il cittadino. Tanto è rilevante l’educazione familiare, che la Bibbia esorta: “onora tuo padre e tua madre” (Dt 5, 16), come raccordo tra i doveri di religione e i restanti comandamenti. Onora, cioè ripaga il tuo debito di gratitudine.Essere padre o madre non si riduce all’atto generativo, ma ricade nell’arco di una intera esistenza e non solo nel tempo libero (positivi i micro-nidi aziendali, che permettono alle mamme di coniugare lavoro e maternità). Lavoro e famiglia devono poter coesistere, sapendo che la famiglia è di fondamentale importanza per la società, poiché educa i figli alle prime decisioni morali.La famiglia è anche luogo di tensioni e contraddizioni (Caino docet) e i genitori devono esser disposti a rimettersi in gioco, suscitando nei figli la voglia di imparare ad imparare, nell’ottica di costruire se stessi e la propria autonomia.
Nell’ottica di decidere di sé, occorre trattare del principio del bene comune, costituito dall’insieme di condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente (GS 26). È la dimensione sociale e comunitaria del bene morale (poiché ogni azione morale individuale ha ricaduta collettiva, secondo la teoria del butterfly effect).
CAPITOLO VII – PERSONA NELLA SOCIETÀ
1. Autonomia e trascendente: fusioni e confusioniIl pensiero di AS e la teologia morale si intrecciano in tre aree. Il primo dei quali riguarda i rapporti persona/società. Soggetti a letture ambivalenti: o la persona è assorbita nella società, o la seconda ridotta a mero aggregato di individui. Oppure il paradigma di Ulisse/Sen apre la prospettiva di una relazione di reciproco sostegno e mutua integrazione, secondo i principi del pensiero sociale cristiano.
Il secondo ambito riguarda la persona stessa, che rende concretamente perseguibile il paradigma della fraternità solo se concepita secondo i principi di centralità, solidarietà, sussidiarietà, bene comune. Terzo ambito è quello che ora affrontiamo: come costruire un “compromesso al meglio” che permetta di armonizzare le varie sensibilità del vivere comunitario? Quale apporto può venire dalla teologia morale?
Anzitutto è da notare che la mera applicazione delle leggi non può condurre ipso facto a pacifica convivenza. Perseguire il quieto vivere, inoltre, non garantisce la qualità etica della vita comunitaria. Occorre un compromesso al meglio: che garantisca pacifica convivenza + un impegno di ciascuno volto a superare egoistici particolarismi. La persona fin dalla nascita è egocentrica (più che egoistica, che ha connotazione morale), sviluppandosi poi tramite decentramento e auto-trascendenza. Tale inclinazione è accentuata dalla ferita del peccato originale che, sebbene non sia peccato personale, tuttavia inclina al peccato il singolo. Oltre a produrre effetti sul “peccato del mondo” (Piet Schoonenberg).
In questo contesto, la prospettiva di separarsi è più forte di quella a coltivare l’unità. Però. Però la storia che registra 3600 anni sugli ultimi 4000 segnati dalla guerra, annovera anche esempi di eroico altruismo (Cuore sta di fronte al De Bello Gallico).In parallelo, si può vedere la vita della Chiesa come se il mondo fosse sempre in balìa di Satana, un assedio che mai diventa però conquista (Imitazione di Cristo); oppure una Chiesa chiamata al dialogo aperto e sincero col mondo (CVII).
Le tentazioni ricorrenti sono di annullare l’altro (perché diverso da me) tramite annientamento o assorbimento. Così fa ad esempio l’ateismo (teorico o pratico) che nega ciò con cui rifiuta di confrontarsi. La Gaudium et Spes esamina le diverse anime dell’ateismo: filosofica, agnostica, positivista, immanentista, marxista.Dinanzi agli atei si può fare un primo passo col paradigma Ulisse/Sen, guardando all’altro come un fratello, non un nemico; poi, come insegna la Pacem In Terris (1963), senza confondere errore ed errante; in questo orizzonte, la teologia morale si pone come scienza che continuamente si interroga.Se l’ateismo nega per annullamento, il panteismo annulla per assorbimento: il divino è immanente, ridotto alle creature; e queste stesse sono private di dignità, ridotte a semplici manifestazioni del divino. Il CVII risponde distinguendo una autonomia delle cose terrene positiva (hanno leggi proprie) e una negativa (le creature non dipenderebbero dal Creatore) – cfr. GS 36. Il compito del cristiano non sta nel trasformare il profano in sacro, ma nel santificare il profano.Diversamente si cade in uno dei 3 approcci errati al rapporto Chiesa/Mondo: il mondo in balia di satana va fuggito; il mondo deve essere edificato come regno di Dio sulla terra; lo spazio umano è sganciato dalla trascendenza. Invece deve rintracciarsi il rapporto di distinzione senza separazione.
Nella pluralità di approcci della teologia morale, resta valido il criterio specificato dalle parole di GPII conclusive del Giubileo del 2000: “Non una formula ci salverà, ma una Persona e la certezza che essa ci infonde: Io sono con voi!”. Come pure BXVI afferma che all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una idea, ma l’incontro con un avvenimento, una Persona (Deus Caritas Est 1). In questo orizzonte, l’incontro con la Persona di Cristo che suscita la risposta persona e responsabile del soggetto riecheggia la prospettiva della oggettività soggettiva di Sen
(“oggettività posizionale”). Laddove la fede si esprime nella forma della traditio (fedeltà oggettiva) – redditio (creatività soggettiva). La grandezza della fede cristiana sta in questo: nell’aver saputo declinare la traditio nelle diverse epoche e culture, trovando conferma nella santità di tanti uomini e donne che hanno fatto dell’ordinario qualcosa di quotidianamente eroico (ecco perché tante canonizzazioni sotto il pontificato di GPII!)
2. La fede come forma del vivereSe la convivenza civile è ridotta a “compromesso accondiscendente”, non c’è più spazio per la verità la sola certezza è il giudizio dell’io, per cui la verità viene ridotta ad autenticità (cfr. Lumen fidei), cioè le scelte sono considerate buone in quanto scaturiscono dalla volontà del singolo, in modo spontaneo, seguendo l’emozione. Secondo il relativismo assoluto soggiacente a tale impostazione, l’uomo è il suo proprio esperimento, è auto-poietico.Di contro, la vita quotidiana mostra la rilevanza della credenza (fin dal primo caffè che si beve al bar senza invocare un test chimico che dimostri che non è avvelenato!). L’uomo quotidianamente vive di credenza. E proprio nell’era delle tecno-scienze impazza il ricorso a maghi e la ricerca del paranormale. La fiducia investe così il quotidiano, ma anche il mono degli affari.Bisognerebbe richiamare la gravità dei peccati che ledono il clima di fiducia verso l’altro, cioè le calunnie e le maldicenze, rispetto a cui vige l’obbligo di riparazione (S. Filippo Neri e la gallina spennata dalla donna come penitenza per aver confessato un peccato di calunnia).
Se il rapporto con l’altro vede la verità ridotta a spontaneità/autenticità, analogamente nel rapporto con l’Altro la fede si riduce a “etica del buon vivere”, mentre dovrebbe essere una autentica connessione tra fatti e ragioni, tra l’individuo e il Signore. Non si aderisce infatti a una dottrina, ma al Signore. Così la catechesi dovrebbe avvenire non in vista dei sacramenti ma attraverso i sacramenti, in modo da evitare uno scontato abbandono dopo la Cresima. La catechesi dovrebbe abbandonare l’aspetto di gelido insegnamento dottrinale e divenire gioiosa testimonianza dell’esperienza della fede, cosicché il cristianesimo potesse diffondersi come per positivo contagio, raccordando la fides quae (oggettiva) e la fides qua (soggettiva), cosicché lo stesso amore divenga conoscenza (S. Gregorio Magno).
3. La democrazia alla provaPer vivere un modello di relazione con l’altro-visto-come-un-fratello per coniugare sviluppo e libertà, occorre una società imperniata sui principi della dottrina sociale della Chiesa. Bisogna vedere se il modello democratico può ispirare una tale società.Anzitutto bisognerebbe distinguere tra laicità e laicismo. Un conto è che le istituzioni rivendichino legittima autonomia nel darsi leggi e ordinamenti, senza separare politica (secondo la Costituzione) e morale individuale (secondo il Vangelo), pur distinguendo le guide della polis dai capi della ekklesìa. Evitando però altresì che lo stato sostenga ateismo o agnosticismo in modo preferenziale.Che è proprio ciò che invece fa il laicismo, relegando il credo religioso alla sfera privata o manifestando ostilità pubblica. Altro possibile equivoco è tra la tolleranza come rispetto delle posizioni e appartenenze altrui, e la tolleranza come indifferenza alla sorte altrui da parte di chi ritiene, a dispetto della dichiarata neutralità, di essere in posizione predominante. Come ogni componente identitaria concorre a indirizzare le scelte individuali, così deve poter accadere per le identità religiose.
Infine, la citata neutralità etica condurrebbe a una democrazia come “guscio vuoto” (Veritatis Splendor 101), di fatto abitata dal relativismo etico che si imporrebbe come pensiero unico attraverso i principi del politically correct. La tolleranza si tradurrebbe nella irrilevanza delle scelte, poiché ogni opzione etica o visione culturale sarebbe equipollente, trasformando così il relativismo in nuovo dogmatismo che non riconosce nulla di definitivo e che lascia come ultima misura solo l’io e le proprie voglie (BXVI).
Questa posizione investe la religione e si traduce in una sorta di “relativismo religioso” per cui Gesù sarebbe solo una delle diverse manifestazioni del divino. In merito alla salvezza dei non cristiani, il CVII ha risposto che si salvano coloro che senza colpa ignorano il Vangelo ma cercano sinceramente Dio, sforzandosi di compierne la volontà, nel modo in cui la conoscono attraverso la loro coscienza (LG 16). Più complesso è il tema delle altre religioni come mediazioni salvifiche (Il cristianesimo e le religioni, CTI, 1997).Ancora, occorre riconoscere che alla estromissione pubblica della fede religiosa concorre la paura per il fondamentalismo religioso (islamico).
Per rimediare a tutto questo, si dovrebbe forse auspicare che anche in ambito religioso trovasse spazio la “oggettività soggettiva” di cui già si è detto, evitando le secche del relativismo che tutto riduce all’io, rifuggendo il disimpegno e la critica a ogni costo tipicamente adolescenziali, per inserire invece la persona in un percorso autentico di sviluppo e libertà.
4. Cultura e diritti umaniIl limite del relativismo è che toglie ogni fiducia e valorizzazione nella posizione altrui, guardando all’altro più come a un nemico che a un fratello. Di fronte al relativismo sta oggi la questione dei diritti umani: sono propri della cultura occidentale, oppure possono vantare pretesa di valore universale?Oggi proprio i diritti umani paiono il terreno di migliore incontro per le diverse culture, identità e sensibilità. E il miglior contesto in cui tale incontro può avvenire pare la democrazia (moderna, non quella greca della libertà della polis, bensì delle libertà individuali). La storia del riconoscimento dei diritti individuali non conosce un percorso lineare, passando attraverso 4 generazioni: (1) i diritti di prima generazione, politici e civili (rivoluzione americana, 1776, e francese, 1789); (2) diritti di seconda generazione, economici, sociali e culturali (Dichiarazione universale, 1948); (3) diritti di terza generazione, quelli di solidarietà degli anni ’60-’70: autodeterminazione dei popoli, pace, sviluppo; (4) diritti di quarta generazione, relativi al campo della bioetica, delle manipolazioni genetiche, del nuovi strumenti di comunicazione (con il rischio di millantare come diritto di salute riproduttiva l’aborto che è un vero e proprio delitto!).
Nell’orizzonte di un panorama multiculturale, segnato da forti movimenti migratori, pare saliente adottare una prospettiva cristiana di accoglienza (poiché la terra è solo del Signore, di cui tutti sono servi; Lev 25), avendo la tolleranza come forma mentis (tolerance) e pratica di accoglienza (toleration). Alla luce della quale ribadiamo l’impraticabilità della posizione originaria di Rawls che tutte queste differenze di cultura e identità penserebbe di poter ignorare.
Dalla presa di coscienza del comune destino dell’umanità può scaturire una rinnovata consapevolezza dei riverberi della tematica ecologia sulla teologia morale. Già AS faceva della questione ecologica un problema culturale. Alla luce del pensiero cristiano, non si può che rifiutare un approccio economicistico, paventando un Prometeo scatenato (Hans Jonas, Principio responsabilità). Per scegliere invece un modello di vita in linea con quello del Maestro che si segue. Decidendo di impegnarsi per salvaguardare non solo la natura ma l’ambiente, come base per un’autentica ecologia umana (Centesimus Annus 38), ottica alla quale il pensiero cristiano offre il contributo della persona come parte di un progetto, chiamata liberamente allo sviluppo di sé e del mondo interpersonale circostante, sapendo che i beni creati da Dio (secondo il principio della loro destinazione universale) sono per tutti. Nella prospettiva di una solidarietà universale nutrita dal paradigma del veder l’a/Altro non come nemico ma come fratello.
CONCLUSIONELe due idee portanti del lavoro sono: (1) che lo sviluppo non dipende dal mero aumento di reddito ma dal poter efficacemente dispiegare le potenzialità di individui e popoli; (2) che una società è moralmente giusta ed economicamente efficiente nella misura in cui realizza un clima di fiducia, che incoraggia la persona a vedere nell’altro non un nemico ma un fratello. L’habitat migliore perché questo avvenga pare essere la democrazia, in cui gli ideali dello sviluppo, della libertà, della fiducia e della fraternità stimolano la teologia morale ad approfondire questi stessi valori e principi per sostanziarli maggiormente.Nel cammino verso questo traguardo, il credente è sostenuto dal pane dell’eucaristia, sacramento di sviluppo e libertà.