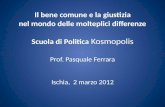B.sordi Nodi Cruciali
-
Upload
marco-storonimazzolani-di-maio -
Category
Documents
-
view
13 -
download
0
description
Transcript of B.sordi Nodi Cruciali

Bernardo Sordi
Nodi cruciali nel processo evolutivo della scienza amministrativa*
Se volessimo arrischiare una raffigurazione semplificata e schematica dei grandi periodi della storia
della scienza del diritto amministrativo nei 150 anni che ci separano dall’Unità, potremmo, con
qualche fondamento, individuare cinque grandi scansioni, insieme cronologiche e tematiche.
Cinque grandi scansioni che altrettanto schematicamente è possibile intitolare con questa
successione, di tempi e di contenuti:
1. Il tempo dell’esegesi: dall’Unità alle riforme crispine. 2. Il tempo delle cattedrali: il tornante di
fine Ottocento e l’età giolittiana. 3. Il formalismo difensivo: il periodo tra le due guerre. 4. Le nuove
frontiere tra diritto pubblico e diritto privato: il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta. 5. Il lento
disgelo costituzionale: il trentennio tra il 1960 ed il 1990, un momento disteso quindi su di un arco
più ampio della stretta cronologia di storia costituzionale.
Proviamo a passare molto rapidamente in rassegna questi cinque momenti.
1. Il tempo dell’esegesi
Non si tratta di una genesi in senso assoluto. Più semplicemente di una ripartenza.
Amministrazione e codici, sin dall’inizio del secolo, sin dall’età napoleonica, incarnano la stabilità
ottocentesca. Il diritto amministrativo è una solida eredità del mondo pre-unitario. Ed è pure,
ormai, una presenza indiscussa e caratterizzante dello Stato di diritto europeo-continentale.
Un linguaggio istituzionale acquisito, ma ancora all’inizio del suo radicamento accademico, si
adegua alla nuova dimensione unitaria.
Non solo. La ‘questione amministrativa’ assorbe grandi attenzioni e grandi energie; possiede una
evidente, strategica, centralità nella costruzione del nuovo Stato unitario.
E’ un momento contrassegnato, anche per questo, da forti intersezioni disciplinari. La letteratura
amministrativa sarebbe poca cosa se sottraessimo gli atti parlamentari, la pubblicistica politica, le
riviste non giuridiche, dalla Nuova Antologia alla Rassegna settimanale.
* Si pubblica qui anticipatamente sugli Atti la relazione tenuta alla Seconda Università degli Studi di Napoli, il 6 dicembre 2011, nell’ambito del Convegno Il contributo del diritto amministrativo in 150 anni di Unità d’Italia. Si è deliberatamente conservata l’originaria forma colloquiale.
1

Con l’abolizione del contenzioso manca, del resto, un grand corps in grado di porsi come primaria
sorgente giurisprudenziale nel mondo amministrativo.
Non stupisce quindi che ad occupare la scena siano personaggi che amministrativisti certo non
possono dirsi, da Pasquale Stanislao Mancini a Filippo Cordova, da Marco Minghetti a Silvio
Spaventa. Se si esclude il fortunato manuale di Lorenzo Meucci, la formalizzazione giuridica
scivola ad inventariazione dei nuovi materiali normativi fissati nelle grandi leggi di unificazione
amministrativa del Regno.
Benché già il regolamento Natoli del 1865 individui nel diritto amministrativo una materia
obbligatoria del corso di laurea in giurisprudenza, le relative cattedre sono - è proprio Minghetti a
ricordarlo - “quasi accessorie e di complemento”1. Il primato romanistico-pandettistico è quasi
inscalfibile. Per dirla con Lorenz von Stein, “mentre le cose del modo corrono veloci, nelle facoltà
di diritto impera l’antiquariato”. Persino nella Germania che approda all’unificazione, le scienze
dello Stato sono ancora delle Nebensachen rispetto alle Pandette2.
2. Il tempo delle cattedrali 3
Alla fine degli anni Ottanta, le riforme crispine garantiscono una inedita stabilità istituzionale. Il
decollo amministrativo è alle porte.
L’istituzione della IV Sezione fa da levatrice delle prime riviste di settore: La giustizia
amministrativa (1890-1923), ma anche le grandi ‘riviste-progetto’. Su tutte, l’orlandiano Archivio di
diritto pubblico (1891-1896), ripreso nel 1902 ed infine nel 1909 con il titolo di Rivista di diritto
pubblico e dell’amministrazione italiana. E’ facile verificare la perfetta contemporaneità con il
percorso continentale: l’Archiv für öffentliches Recht viene fondato nel 1885; assumerà la
denominazione di Archiv des öffentlichen Rechts nel 1911; la Revue du droit public inizia le sue
pubblicazioni nel 1894.
Anche sul piano scientifico assistiamo ad un marcato, significativo, cambio di passo. Si dispiega un
deciso momento progettuale, scandito da celebri prolusioni, da una ricca produzione manualistica,
1 M.MINGHETTI, I partiti politici e l’ingerenza loro nella giustizia e nell’amministrazione, Bologna, 1881, p.2, ora in ID., Scritti politici, a cura di Raffaella Gherardi, Roma, 1986, p.749.2 L.von STEIN, Handbuch der Verwaltungslehre und des Verwaltungsrechts, Stuttgart, 1870, pp.V-VII.3 Riprendiamo, con voluta simmetria, il titolo di un capitolo del volume di F.BURDEAU, Histoire du droit administratif (de la Révolution au début des années 1970), Paris, 1995, pp.323 e ss, dedicato alla Terza Repubblica di Maurice Hauriou e Léon Duguit.
2

dal varo delle prime, grandi, opere collettive, dalle riviste, appunto, sino al Trattato di diritto
amministrativo4, progettato e diretto da Vittorio Emanuele Orlando, il cui primo volume esce nel
1897.
Anche in Italia, come in Francia, come in Germania, sono i giuristi gli artefici delle cattedrali. Se gli
anni Settanta ed Ottanta sono stati anni di recezioni, di innamoramenti culturali, di eclettismo, di
progressivo spostamento dell’asse di influenza culturale, dalla Francia alla Germania, la fine del
secolo è all’insegna di un forte impegno sistematico: la parte generale è ormai alla portata degli
stessi giuristi di diritto pubblico.
Colpisce - tenuto conto del modesto punto di partenza al 1861 - il rapido allineamento della
giuspubblicistica italiana al mainstream europeo. Partita in ritardo, la scienza giuridica italiana
partecipa a pieno titolo alla definitiva impalcatura sistematica del modello amministrativo
ottocentesco. E vi partecipa in perfetta contemporaneità, se si considera che i Précis di Maurice
Hauriou vengono pubblicati nel 1892; il Deutsches Verwaltungsrecht di Otto Mayer, nel 1895.
Difficile negare - malgrado un certo eccesso di attenzione storiografica - il ruolo pioniere e
demiurgico di Orlando. E’ comunque un momento di forti individualità. Lo ricordava anni fa
Massimo Severo Giannini, aprendo un volume monografico dei Quaderni fiorentini, con un titolo
dal forte potere evocativo: Federico Cammeo il grande5.
Grandi individualità che dialogano e si affrontano in un grande lavoro corale. Quella almeno
apparente omogeneità metodologica, venata di un germanismo condiviso e diffuso, nasconde una
ricca pluralità di posizioni e di indirizzi. Lo dimostra il difficile campo della giustizia amministrativa,
spinto certo dal problematico completamento legislativo - tutto italiano - del sistema di
giurisdizione unica, ma anche passaggio ineludibile verso la sistematica dell’atto e delle situazioni
soggettive: in una parola, verso i principi. Ed ancora, i campi della patrimonialità pubblica, della
contrattualità amministrativa, dell’organizzazione, dell’autarchia, dell’amministrazione sociale,
della responsabilità pubblicistica.
Nel 1901, un piccolo volumetto in carta riso, ma di inequivocabile statura europea, i Principii di
diritto amministrativo italiano di Santi Romano, in nove teorie, dalla Teoria generale dei rapporti di
diritto amministrativo alla Teoria amministrativa dei rapporti di diritto privato degli enti pubblici ,
getta il solco di una traccia sistematica indelebile.
4 Il cui titolo - Primo Trattato completo di diritto amministrativo italiano - conferma la coralità di un’iniziativa vissuta e realizzata come grande opera prima.5 Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 22(1993), pp.7-18.
3

3. Il formalismo difensivo
Il quadro che si apre nel primo dopoguerra è meno eroico. Il ‘pacato’ nitore zanobiniano è
indiscutibile. Ma non è dal versante del diritto amministrativo che s’intuisce il nuovo spirito dei
tempi. La forbice con i percorsi continentali, che nel primo decennio del secolo si era
notevolmente ristretta, tende di nuovo ad aprirsi.
La rapida chiusura totalitaria non consente di dare ingresso alle novità weimariane ed austriache;
non penetra in Italia quella Methodenstreit che arriva ad investire i nessi tra costituzione e
amministrazione, tra giustizia e amministrazione, tra amministrazione ed economia, tra politica e
burocrazia, scoprendo così nuove realtà (il procedimento, il diritto amministrativo economico, la
disaggregazione amministrativa) ed inediti problemi di democrazia dell’amministrazione.
Pure al geniale antistatualismo di Duguit si è posto argini invalicabili. Il mondo nuovo del service
public resta in Italia una terra incognita, difficilmente avvicinabile anche dalla teoria romaniana
delle prestazioni degli enti amministrativi, troppo chiusa all’interno dello schema del rapporto
giuridico, di derivazione civilistica, per costruire una teoria giuridica di quell’amministrazione
sociale che pure, sulle orme di Hermann Roesler e di Lorenz von Stein, sui due fronti del diritto
amministrativo e della scienza dell’amministrazione (per intendersi, Vittorio Emanuele Orlando e
Carlo Francesco Ferraris) si era scoperta per tempo.
Pesa, anche un certo conservatorismo difensivo nei confronti delle novità del regime.
Si tratta, sotto molti aspetti, di un conservatorismo provvido. La legalità zanobiniana, fissata nella
celebre prolusione pisana del 19246, è povera di contenuti costituzionali, ha mero valore ordinante
e prevalente taglio sistematico, ma garantisce una piena continuità con la tradizione disciplinare
precedente. E quella tradizione s’impone, impedendo anche negli anni a venire qualsiasi deriva
verso quella Deutsche Verwaltung, di marca nazionalsocialista, con cui in Germania, si pretenderà
di negare, insieme alla forma giuridica, anche la stessa possibilità di intitolare al diritto
amministrativo i corsi sull’amministrazione tedesca degli anni Trenta. Al contrario, il diritto
amministrativo italiano, anche durante il ventennio, affina istituti e teoria generale in perfetta
continuità con l’età liberale.
6 G.ZANOBINI, L’attività amministrativa e la legge, in Riv.dir.pubbl., 1924, ora in ID., Scritti vari di diritto pubblico, Milano 1955, pp.205 e ss.
4

Anche verso il corporativismo, l’amministrazione si confermerà cittadella inespugnabile. Proprio
Zanobini, nel Corso di diritto corporativo del 1935, fisserà una celebre summa divisio, che
interpretava la prudente politica del regime di limitare l’inquadramento sindacale della galassia
pubblicistica: il regime corporativo è il regime del contratto e degli organi indiretti dello Stato, le
corporazioni; il regime amministrativo è il regime dell’atto amministrativo e degli organi diretti
dello Stato, le amministrazioni7.
Steccati provvidi, ma che finivano pure per rendere immobile e diafano il campo del diritto
amministrativo. Escluso il diritto corporativo, che nelle sue contraddizioni era pur sempre un
rivelatore di complessità, il diritto amministrativo espunse dal suo raggio d’interesse anche il
crescente strumentario del governo dell’economia. Fermo nel suo tradizionalismo, non riuscirà a
svelare la profonda trasformazione della statualità tra le due guerre. Lo stesso corpus legislativo
degli ultimi anni del fascismo, dalla legge bancaria, alla legge sulla tutela delle cose di interesse
storico ed artistico, alla legge urbanistica, così come la maggior parte della legislazione di settore,
nasceva lontano dalle cattedre degli amministrativisti, che non di rado derubricavano quelle fonti
ad interventi di natura strettamente congiunturale e contingente, privi di rilievo sistematico.
Solo sul finire degli anni Trenta, Il potere discrezionale di Massimo Severo Giannini ed Il
procedimento di Aldo Sandulli avvieranno - come è ben noto - un primo, significativo,
rinnovamento.
4. Le nuove frontiere tra diritto pubblico e diritto privato
Una pagina celebre, Umanesimo giuridico di Giovanni Miele, testimonia nel 1945 l’amarezza del
bilancio ed insieme l’ansia palingenetica del nuovo8. Il dopoguerra è all’insegna di un
7 G. ZANOBINI, Corso di diritto corporativo, Milano, 1935, p.49; p.53; pp.71-72.8 G.MIELE, Umanesimo giuridico, in Rivista di diritto commerciale, 1945, ora in ID., Scritti giuridici, Milano 1987, vol.II, p.445: si è circondato lo Stato di “tutti gli attributi della divinità, enfiato, pletorico, ma terribilmente vuoto entro le sue colossali dimensioni, perché scisso senza rimedio dalla massa dei suoi cittadini”, sino a ridurre l’ordinamento giuridico “a pura espressione del volere statale”. “Le scienze sociali e quelle giuridiche in particolare, dovran perdere quel carattere astratto e formale che così bene ha favorito le varie tirannidi, e porre in essere i procedimenti atti a dare incremento a tutto quanto v’ha di nobile e di perenne nell’animo umano, la libertà, la giustizia, la solidarietà, la carità del prossimo, lo spirito di fraternità. E’ alla luce di questo criterio che oggi s’impone e deve essere iniziata una radicale revisione di quei concetti che possono esercitare un’influenza decisiva in tale campo: per il giurista si tratterà di riesaminare la complessa realtà dello Stato, la natura dei suoi compiti, la distribuzione dei suoi organi e delle sue funzioni, i suoi rapporti con l’individuo, i rapporti di questo con i suoi simili, l’autonomia del singolo e dei gruppi …”.
5

rinnovamento profondo dei principi, all’insegna di nuove aperture, di nuovi allargamenti
problematici. E’ acuto il senso delle trasformazioni.
Non ha dubbi Giannini quando recensisce l’ultima edizione (1952) dei Principii di Orlando:
“Orlando ritiene che il diritto amministrativo sia (anche dopo la costituzione) ricostruibile in chiave di teoria
del liberalismo. E’ sostenibile questa sua presa di posizione? Io ritengo di no…; nel 1891 la comunità statale
si componeva di poche migliaia di cittadini-elettori ed oggi coincide con l’intero popolo”9.
Eppure, il diritto amministrativo dei primi anni dell’Italia repubblicana (Lezioni gianniniane del
1950, comprese) non diventa immediatamente konkretisiertes Verfassungsrecht. A prima lettura,
la costituzione sembra ora disattenta nei confronti dell’amministrazione, ora meramente
confermativa degli assetti ereditati dal passato dello Stato liberale e fascista.
La scienza giuridica, deve per di più, rimettersi al passo con una realtà amministrativa che il
formalismo difensivo degli anni Trenta ha fatto solo intravedere. Da un lato, occorre fare i conti
con la tradizione, ‘sublimare’ il sistema, offrendo un’architettura definitiva ad invarianti e
concettuologie stabilizzate; dall’altro, scoprire il pianeta nebuloso delle intersezioni tra diritto ed
economia, che hanno slabbrato la cittadella amministrativa, facendo esplodere tipologie
organizzative e moduli di attività.
Il percorso gianniniano è emblematico, ricchissimo. Ma è tutta una generazione che lavora ora
dentro, ora fuori la ‘Fortezza Bastiani’. E’ come se il diritto amministrativo assumesse la forma di
un’ellisse, collocando, sui due fuochi, ora, l’imperatività del provvedimento, ora, il diritto comune
a pubblici e privati operatori.
Le raffigurazioni unitarie, strenuamente inseguite e quindi pure strenuamente difese, non reggono
più. Occorre tornare, di nuovo, ad intercettare le orbite europee, che dalla distinzione kelseniana
tra amministrazione diretta e indiretta, a quella di Ernst Forsthoff, tra Eingriffs- e
Leistungsverwaltung, incorniciano il volto ancipite dell’amministrazione novecentesca.
La specialità amministrativa, lo stesso rapporto pubblico-privato, attendono una radicale
rifondazione. E basterebbe avere il tempo di ripercorrere il bellissimo dibattito che nella Francia
della Quarta Repubblica oppone privatisti e pubblicisti (Georges Ripert e René Savatier, da un lato;
9 M.S.GIANNINI, Recensione a V.E.ORLANDO, Principi di diritto amministrativo, in Riv.trim.dir.pubbl., 1953, p.149.
6

Charles Eisenmann e Jean Rivero, dall’altro10), per capire che la scienza giuridica italiana è riuscita,
tempestivamente, a riallinearsi sulla rotta europea.
5. Il lento disgelo costituzionale
Il diritto pubblico dell’economia, che il tradizionalismo degli amministrativisti aveva strozzato sul
nascere, tra le due guerre, conoscerà una vera e propria esplosione, tra gli anni Cinquanta e
Sessanta, sull’onda della ripresa del ciclo interventista, della proliferazione degli enti pubblici
economici, degli entusiasmi suscitati dal piano Vanoni del 1954 e dal contrastato varo della
programmazione economica: una letteratura che il diffondersi del verbo concorrenziale ha oggi
irreversibilmente ingiallito, ma che aveva il pregio di sottoporre ad indagine giuridica, tra tante
contingenze, anche alcuni nodi strutturali - tutt’altro che risolti - della costituzione economica.
Sul fronte sistematico il diritto amministrativo continua a scriversi in un dialogo serrato con la
tradizione. Si pensi a Miele che nel 1960 ripubblica, con note di aggiornamento, il Corso di
Cammeo; si pensi soprattutto al modo con il quale Giannini costruisce nel 1963 il suo Discorso
generale sulla giustizia amministrativa o Benvenuti traccia nel 1969 l’Exkursus ancora sulla
Giustizia amministrativa; od, infine, Nigro struttura, nel 1976, i primi capitoli della sua Giustizia
amministrativa.
La tradizione, beninteso, non è solo dottrinale: pesa il silenzio del legislatore sulla disciplina
dell’attività; pesa l’inconciliabilità di linguaggi e di modelli, impiegati nelle grandi scelte che hanno
fondato il sistema di giustizia amministrativa. Su alcuni snodi qualificanti della parte generale, è la
giurisprudenza11 a colmare l’afasia legislativa, dalla imperatività all’autotutela, dal riparto
all’eccesso di potere, dall’ottemperanza all’effetto conformativo del giudicato.
Ed il colloquio con la tradizione ha un duplice segno.
Ora, è autenticamente storicista, quando indaga il paradigma disciplinare, ricostruendo i profili
della scienza del diritto amministrativo, ma soprattutto quando scolpisce tappe e contenuti del
processo di costruzione dello Stato unitario: dall’amministrazione centrale alle relazioni centro-
10 G.RIPERT, Le déclin du droit, Paris, 1949; R.SAVATIER, Du droit civil au droit public à travers les personnes, les biens et la responsabilité civile, Paris, 19502; C.EISENMANN, Droit public, droit privé (en marge d’un livre sur l’évolution du droit civil français du XIXe au XXe siècle, in Revue du droit public, 1952, pp.903 e ss. ; J.RIVERO, Droit public et droit privé : conquête ou statu quo ?, in Chronique Dalloz, 1947, pp.69 e ss. 11 Attentamente esaminata, nel corso del Convegno, da Franco Scoca con riferimento alla Corte costituzionale e da Giuseppe Morbidelli per il giudice amministrativo.
7

periferia, dalla giustizia amministrativa alle imprese pubbliche. Non dimentichiamo che 50 anni fa
è la disciplina intera a contribuire in prima persona e con grande impegno al rigoglio di studi di
storia istituzionale che accompagna il primo centenario dell’unificazione politica e soprattutto il
primo centenario delle leggi di unificazione amministrativa.
Ora invece, quel colloquio serve semplicemente a rendere leggibile il formante giurisprudenziale e
ad offrire razionalità sistematica al contenuto normativo che la tradizione esprime: il ‘para
sistema’, faticosamente, si fa sistema giuridico.
Ma anche sul fronte sistematico, il fermento è grande. Ed alla razionalizzazione della tradizione
inizia ad affiancarsi, progressivamente, una rivisitazione sempre più incisiva. Il disgelo
costituzionale inizia a far breccia anche nel diritto amministrativo e le letture che valorizzano le
novità della costituzione iniziano a reclamare un superamento radicale del modello ottocentesco.
Lo si fa sul terreno dell’organizzazione, dove con l’imporsi delle “ragioni delle regioni”12 è il nuovo
ordinamento comunitario delle autonomie a disegnare un modello alternativo di unità politica,
opposto al monismo statuale dell’autarchia.
Lo si fa sul terreno dell’attività, dove finalmente confluiscono i temi della legalità, della funzione,
delle situazioni soggettive, del procedimento, della partecipazione, dei servizi pubblici, con
l’effetto di ridimensionare “la forte statalità culturale”13 che aveva contraddistinto a fine Ottocento
i processi di pubblicizzazione ed insieme di restituire una visione meno stereotipata e monolitica
delle tipologie di azione amministrativa.
Si annuncia il crepuscolo della specialità che, a partire dagli inizi degli anni Novanta, inizia a far
breccia anche sul versante legislativo: una specialità non più monolitica, ma aperta e multiforme,
pronta a recepire le nuove ibridazioni tra pubblico e privato, che si iniziano a delineare nel transito
dall’interventismo alla regolazione. Le invarianti gianniniane cominciano ad uscire di scena,
sospinte da progressive decostruzioni concettuali. Pesano i nuovi spazi politici ed il deciso
allargamento dell’orbita; l’ordine giuridico europeo, prima; il diritto globale, dopo.
Sono ancora una volta le trasformazioni a spingere il corso delle cose, in questo caso ad avviare un
primo distacco dalla tradizione. Ma non si tratta di un distacco indolore. La difficile convivenza tra
nuovo ed antico, tra livelli normativi e giurisprudenziali divenuti plurali, tra la residua specialità e la
12 F.BENVENUTI, Ragioni delle regioni, Conversazione al Collegio Augustinianum dell’Università Cattolica di Milano, 29 gennaio 1960, ora in ID., Amministrazione pubblica. Autonomie locali. Scritti degli anni dell’Isap, a cura di Ettore Rotelli, Milano, 2010, pp.163-171.13 S.CASSESE, “Fare l’Italia per costituirla poi”: le continuità dello Stato, in Riv.trim.dir.pubbl., 2011, p.327.
8

confluenza, ancor prima concettuale che normativa, verso il diritto comune, generano disagio,
eccesso esegetico, accentuano il senso di vuoto sistematico.
Colloquio con la tradizione e distacco dalla tradizione continuano a procedere strettamente
affiancati.
* * *
Quale colpo d’occhio si può trattenere di questo lungo percorso?
Il diritto amministrativo, allo stesso tempo, regola e linguaggio delle istituzioni, ne ha seguito,
nell’arco dei 150 anni di vita dello Stato unitario, le evoluzioni e gli arretramenti, le continuità e le
fratture. Il diritto amministrativo, come ogni fenomeno giuridico, non ha nulla di statico; è
dinamica; segue la linea, si immette in un alveo lungo e profondo di scorrimento.
Mimeticamente, in controluce, il diritto amministrativo riflette, in particolare, la storia dello Stato;
dello Stato nella sua dimensione ordinamentale, nelle sue imbricazioni con il sociale. La storia del
diritto amministrativo è parte essenziale di una autentica Verfassungsgeschichte: una storia dello
Stato nazionale, certo, nei suoi tempi, nelle sue trasformazioni tipologiche, nei suoi passaggi
costituzionali e legislativi, nei grands arrêts dei suoi corpi giudiziari, nella prassi dei suoi apparati.
Ma il diritto amministrativo, figlio primogenito di uno Stato di diritto che, all’inizio dell’Ottocento,
tiene a battesimo il codice e l’amministrazione moderna, è pure inseparabile dalla storia della
forma Stato europea.
Ed in questo senso, la storia della scienza italiana del diritto amministrativo, nelle sue irripetibili
individualità, resta - a pieno titolo - un capitolo indefettibile di una storia europea eminentemente
plurale.
9