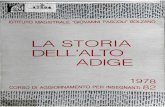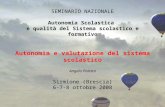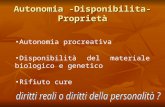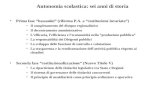Autonomia
-
Upload
ale-sandro -
Category
Documents
-
view
8.137 -
download
0
description
Transcript of Autonomia
- 1. Lautonomia delle ii.ss. prima della riforma introdotta dalla
L. n.59/97
- Prima della riforma introdotta dalla L.59/97, le istituzioni scolastiche erano organi dello Stato, con limitata autonomia amministrativa riconosciuta dai decreti delegati.
- Tuttavia, gi prima dei decreti delegati del 1974, gli istituti di istruzione tecnica e professionale, di istruzione artistica, i convitti nazionali e gli educandati femminili erano dotati di unautonomia amministrativa.
2. Lautonomia delle ii.ss. prima della riforma introdotta dalla L. n.59/97
- Con lart. 2 del D.P.R. n.416 del 1974 veniva riconosciuta a tutti gli istituti una limitata autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, ma non anche la personalit giuridica.
- La relativa disciplina viene recepita dagli artt. 26-30 del d.lgs. n.297 del 1994.
3. L.59/97
- Snodi fondamentali dello scenario delineato alla L.59/97:
- la centralit delle scuole;
- La riorganizzazione centrale e periferica della P.I. secondo due poli di governo, uno centrale, con funzioni di indirizzo, programmazione e valutazione, e uno periferico, con funzioni di coordinamento, supporto alle scuole e di interfaccia con regioni ed enti locali;
- Il rafforzamento delle regioni e degli enti locali rispetto alle amministrazioni centrali dello Stato e la conseguente ricerca di unintegrazione diretta fra scuola e istituzioni locali.
4. La riforma dellautonomia scolastica
- Lart. 21 della l. 59/97attribuisce personalit giuridica alle scuole pubbliche, introducendo cos lautonomia.
- Con questa norma, le scuole non sono pi organi dello Stato, ma autonomi soggetti di diritto.
5. La riforma dellautonomia scolastica
- Lart. 21 della L.59/97 non d una definizione di autonomia, ma subordina lattribuzione della stessa alle ii.ss. man mano che esse raggiungono i requisiti dimensionali ottimali, individuati in rapporto alle esigenze e alla variet delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nellistituzione scolastica.
6. La riforma dellautonomia scolastica
- In ogni casola personalit giuridica e lautonomia sono attribuite alle ii.ss. non oltreil 31 dicembre 2000contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per la loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni stesse.
7. Lautonomia giuridica delle II.SS.
- Le istituzioni scolastiche sonosoggetti dellordinamento giuridiconel quale operano.
- Per soggetto dellordinamento si intende un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e passive(diritti, interessi, potest, obblighi, oneri).
8. Lautonomia giuridica delle II.SS.
- Alle II.SS. attribuitala personalit giuridica , comportante la totale autonomia patrimoniale di tali organismi.
- Pertanto, come soggetti dotati di personalit giuridica, godono di autonomia di gestione, in quanto strutture che hanno per lo svolgimento dellattivit cui sono preposte un bilancio separato, una propria dotazione di personale, un patrimonio, nonch lamministrazione diretta delle disponibilit finanziarie.
9. Lautonomia giuridica delle II.SS.
- Lattribuzione della personalit giuridica alle II.SS. anche espressione di autonomia funzionale, atteso il riconoscimento dello specifico ruolo assegnato a tali istituzioni, nettamente distinto dalle funzioni proprie delle autonomie locali (province, comuni) che attengono invece a compiti di governo del territorio.
- funzione delle scuole lerogazione del servizio scolastico
10. ORGANIZZAZIONE: La riforma dellautonomia scolastica
- Alla luce dei principi introdotti nella 59/97, lautonomia stata attuata mediante successive norme:
-
- Il D.P.R. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
11. D.P.R. 275/99
- Art. 1 Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
- Le istituzioni scolastiche sono espressioni diautonomia funzionalee provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- A tal fine interagiscono tra loro e con gli Enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialit individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.
12. Che vuol dire Autonomia Funzionale?
- che le scuole sono titolari di
-
- Vari spazi di libert, che servono per erogare, al meglio, il servizio di istruzione (questa la funzione della scuole)
-
- In tale compito, le scuole interagiscono con tutti gli altri soggetti della comunit di riferimento (per questo le scuole sono enti locali).
- Le scuole pubbliche sono dunque enti locali funzionali
13. Come si manifesta, in concreto, la libert delle scuole?
- Sotto forma di autonomia :
-
- Didattica : le scuole hanno piena libert di scelta di metodi, strumenti, organizzazione e tempi dinsegnamento. Tale forma di autonomia si manifesta nel P.O.F.(art.4);
-
- Organizzativa : le scuole possono organizzarsi come meglio credono; il responsabile un dirigente scolastico che, al pari degli altri dirigenti pubblici, ha pieni poteri di gestione e distribuzione delle risorse umane e strumentali (art.5);
-
- Di ricerca, sperimentazione e sviluppo : le scuole possono sviluppare, singolarmente o in associazioni con altre scuole, innovazioni metodologiche e disciplinari (art.6);
-
- Finanziaria : le scuole hanno proprie risorse finanziarie, che possono aumentare mediante mutui, donazioni,sponsorizzazioni, ecc.
14. D.P.R. 275/99: Autonomia didattica
- Le scuole possono scegliere liberamente
-
- metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento da adottare nel rispetto della pluralit delle opzioni metodologiche ed in ogni altra iniziativa che sia espressione di libert progettuale (compresa lofferta di insegnamenti opzionali, facoltativi, ecc.)
- Perch ?
- Per realizzare, nel rispetto della libert dell insegnamento, di scelta educativa delle famiglie e delle finalit generali del sistema,percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto di apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni .
- Migliore scuola = Migliore societ
15. D.P.R. 275/99 lautonomia didattica libert di decidere
- 1) CHE COSA INSEGNARE
- 2) COME INSEGNARE
- 3) QUANTO INSEGNARE
16. D.P.R. 275/99: Cosa insegnare
- Lart. 8 del D.P.R. 275/99, prevede che il ministro dellistruzione definisce:
- gli obiettivi generali del processo formativo, gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni,
- le discipline e le attivit costituenti la quota nazionale dei curricoli
- e il relativo monte ore annuale.
- Questo significa che il programma delle scuole , in gran parte, obbligatorio
17. D.P.R. 275/99 per
- le istituzioni scolastichepossono , con il piano dellofferta formativa, integrare la quota definita a livello nazionale con la quota riservata che comprende le discipline e le attivit da esse liberamente scelte.
- Esiste, dunque, una quota oraria e disciplinare (curricolo obbligatorio) strutturata a livello ministerialeche le istituzioni scolastiche devono osservare, e che, pertanto,rappresenta un limite non valicabile dellautonomia didattica .
- Esiste altres una quota oraria e disciplinare per la quale le scuole esercitano una certa discrezionalit.
18. D.P.R. 275/99: Come insegnare
- Lart. 4 del D.P.R. 275/99 prevede che nellesercizio dellautonomia didattica, le ii.ss. regolano itempidellinsegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attivit nel modo pi adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le ii.ss. possono adottare tutte le forme diflessibilitche ritengono opportune.
- Questo significa che
19. D.P.R. 275/99
- nel rispetto della libert di insegnamento del singolo docente
- Le scuole debbono insegnare in modo da garantire larealizzazione del diritto di apprendere e
- la crescita educativa degli alunni , dei quali sono riconosciute e valorizzante le diversit e promosse le potenzialit, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
- insomma, la scuola deve essere funzionale alla crescita dellalunno
20. D.P.R. 275/99: Quanto insegnare?
- Le scuole possono ridurre la durata dellunit oraria.
- In tal caso, per, la quota oraria dovr essere recuperata sia in relazione al monte ore annuale da dedicare alle discipline obbligatorie, sia in relazione allobbligo di servizio dei docenti.
21. in ogni caso
- pur riducendo la durata oraria, le scuole debbono comunque rispettare
- Il monte orario annuo complessivo previsto per ciascuna delle discipline e attivit indicate come fondamentali per ciascun indirizzo di studio;
- La distribuzione dellattivit didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto degli obblighi di servizio annuali dei docenti previsti dai contratti collettivi.
22. Lautonomia organizzativa delle ii.ss.
- LO SCOPO
- Lautonomia organizzativa finalizzata alla :
- Realizzazione della flessibilit, della diversificazione, dellefficienza/efficacia del servizio scolastico;
- Al miglioramento delle risorse/strutture;
- Allintroduzione di tecnologie introduttive;
- Al coordinamento con il contesto territoriale.
23. Lautonomia didattica delle ii.ss.
- LE MODALITA DI ATTUAZIONE
- Lautonomia organizzativa si esplica attraverso:
- La possibilit di modificare la tradizionale suddivisione in ore dellorario scolastico e della settimana di lavoro;
- Leventuale superamento del concetto di classe;
- Modalit autonome di impiego e distribuzione dei docenti;
- Lottimizzazione del tempo scuola e lintroduzione di tecnologie innovative;
- Il coordinamento con il contesto territoriale.
24. anche in questo caso, per, le scuole debbono rispettare
- Il numero di ore di attivit didattica annuale, previsto a livello nazionale;
- La distribuzione dellattivit didattica in non meno di cinque giorni settimanali;
- Gli obblighi di servizio annuali dei docenti previsti dai contratti collettivi.
25. Lautonomia di ricerca
- Le scuole possono
- Arricchire e ampliarelofferta formativa;
- Attivare processi dintegrazionefra sistemi distruzione e formazione;
- Integrareil curricolo nazionale con altre discipline;
- Costituireretidi scuole consorziate, per presentare unofferta formativa forte e organizzata sul territorio.
26. Qual lo strumento di attuazione dellautonomia? ? ?
- IL POF, Piano dellOfferta Formativa
- Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, ilpiano dellofferta formativa ,documento fondamentale dellidentit culturale e progettuale dellistituzione scolastica,che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nellambito della loro autonomia.
27. Chi elabora il POF?
- Il collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi generali per le attivit della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, dagli studenti.
28. Il P.O.F.
- In altri termini, sebbene il piano sia elaborato dal collegio dei docenti, alla sua predisposizione devono partecipare tutte le componenti della comunit scolastica:
- Il POF quindi espressione di uguaglianza sostanziale (art. 3 comma 2 cost.)
- e del principio per cui la scuola si conforma allo spirito democratico della repubblica:
- Il POF coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di scuola, determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realt locale.
29. Il P.O.F.
- In esso trova applicazione:
- A) larticolazione del monte ore annuale per ciascuna disciplina;
- B) lorganizzazione delle lezioni su moduli diversi dellunit oraria e lutilizzo di eventuali tempi residui;
- C) lattivazione modulare di gruppo di alunni;
- D) laggregazione disciplinare;
- E) lattivazione di percorsi didattici individualizzati.
30. Sono dunque cos libere le scuole?
- No, a parte i limiti gi visti, mancano alla scuolail potere di
-
- formare le graduatorie;
-
- reclutare direttamente personale (a tempo indeterminato), e gestire autonomamente il personale esistente,
-
- Inoltre, gran parte delle risorse finanziarie della scuola pubblica dipende dalle assegnazioni statali.
31. e infatti
- IlD.P.R. 347 del 2000 ( Regolamento di organizzazione del MIUR)istituisce in ogni regione gli USR, che si occupano di
- Formazione delle graduatorie permanenti;
- Reclutamento del personale docente, educativo ed A.T.A.;
- Autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri, comandi e collocamenti fuori ruolo;
- Riconoscimento di titoli di studio esteri.
32. Lautonomia finanziaria:Il D.M. 44/2001
- Con Decreto Ministeriale n.44 del 1 febbraio 2001 stato adottato il regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche.
33. Il D.M. 44/2001
- Si conclude cosliter normativo di riorganizzazione dellintero sistema in materia di istruzione disposto dallarticolo 21 della L.59/97 ed attuato con appositi regolamenti indipendenti.
34. Il D.M. 44/2001
- Il regolamento 44/2001 conferma il principio di annualit del bilancio, disponendo che lesercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- Per anno finanziario si intende lunit temporale della gestione, coincidente o meno con lanno solare.
35. Il D.M. 44/2001
- Il complesso delle operazioni di entrata e di spesa e le relative variazioni patrimoniali prende il nome di esercizio finanziario.
36. Il D.M. 44/2001
- Il bilancio delle ii.ss. rappresenta un esempio di ulteriore evoluzione dei principi in materia di bilancio delle PP.AA.
- La gestione finanziaria delle ii.ss. espressa in termini di competenza (art. 2 comma 2) e tale previsione rappresenta uninnovazione introdotta dal nuovo regolamento contabile.
37. Il D.M. 44/2001
- I principi, cui il bilancio di previsione che sar denominatoprogrammain ossequio alla denominazione adottata dal Regolamento, sono gli stessi cui si ispira il bilancio dello Stato: oltre al principio diannualit , rilevano i principi ditrasparenza, universalit, integrit , unit e veridicit .
- La gestione finanziaria , inoltre, improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicit.
38. Il D.M. 44/2001
- Ilprincipio di trasparenzacomporta la pubblicit e laccesso agli atti della P.A. nonch la predeterminazione dei criteri e delle modalit dellazione amministrativa. Tale principio si considera di diretta derivazione dal principio costituzionale dimparzialit (art.97 Cost.).
39. Il D.M. 44/2001
- In ossequio alprincipio di universalit , nel bilancio devono trovare esposizione integrale tutte le entrate e le spese. Pertanto, le gestioni fuori bilancio sono vietate.
- Specificazione delluniversalit ilprincipio di integrit , in base al quale nel bilancio liscrizione delle entrate e delle spese deve avvenire senza decurtazioni per oneri afferenti alle modalit di riscossione o di pagamento.
40. Il D.M. 44/2001
- La rappresentazione integrale delle risorse acquisite e utilizzate per le finalit istituzionali si ispira alprincipio dellunit .
- In ossequio al principio di veridicit occorre improntare la redazione del bilancio alla maggiore rispondenza possibile tra le previsioni e le reali esigenze da perseguire nel corso dellesercizio di riferimento, evitando sopravvalutazioni o svalutazioni.
41. Il D.M. 44/2001
- Il documento contabile, denominato programma, viene predisposto in coerenza con le previsioni del POF. Tale programma corredato di unapposita relazione illustrativa nella quale vengono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, oltre che i risultati della gestione in corso e del precedente esercizio finanziario.
42. Il dirigente scolastico
- Il concetto di autonomia non pu prescindere da un punto di riferimento, dotato dipoteri di impulso, vigilanza, coordinamentoed anche, talvolta, di gerarchia: il dirigente scolastico con funzione di capo distituto nellambito dellamministrazione scolastica periferica.
43. Il dirigente scolastico
- Lattribuzione della qualifica dirigenziale per i capi di istituto ( d.lgs. 6 marzo 1998 n.59 ) comporta che il loro operato sia soggetto a valutazione, effettuata da un apposito nucleo di verifica inserito nel quadro dellamministrazione scolastica regionale connessa al raggiungimento dei risultati.
44. Il dirigente scolastico
- affidata al dirigente scolastico la gestione unitaria dellistituzione, la legale rappresentanza della stessa, la responsabilit della gestione delle risorse finanziarie e strumentali. Il medesimo ha, altres, la cura dellottimale raggiungimento dei risultati di servizio, ottenuta con lo strumento della direzione, del coordinamento e dellimpulso delle risorse umane e culturali.
45. Il dirigente scolastico
- Se il dirigente scolastico si presenta come figura motrice del processo di gestione dellautonomia, tale ruolo si compendia in accresciute competenze a doveri decisionali, con correlata assunzione di responsabilit: ci si specifica nella definizione di modelli di azione di razionalit decisionale, di valorizzazione delle risorse umane, di assunzione di responsabilit da risultato secondo i parametri dellefficienza, dellefficacia, di instaurazione di corrette e positive relazioni e di momenti comunicativi tra i soggetti dellautonomia. Ad esso vanno applicati, quindi, i principi di responsabilit che fanno capo alla generale figura del dirigente nella P.A.