Atti Moked Autunnale 5769moked.it/dec/files/2009/11/atti-moked-parma.pdf · Ed aggiunge il Sefer...
Transcript of Atti Moked Autunnale 5769moked.it/dec/files/2009/11/atti-moked-parma.pdf · Ed aggiunge il Sefer...
2
INDICE
Presentazione Roberto Della Rocca
Programma
Giosuè e Calev, due percorsi differenti e paralleli nel rapporto con Eretz
Israel
Roberto Della Rocca
Lo Stato di Israele: la redenzione germoglia?
Michael Ascoli
Terra-madre o terra-sposa? Sion e l’avvenire della storia ebraica
Donatella Ester Di Cesare
Il sionismo chaluzista
Anselmo Calò L'inseguimento della "normalità"
David Meghnagi L’importance stratégique d’une idéologie en crise
Shmuel Trigano
Messianisme et orthodoxie
David Banon
L’ evoluzione della Medicina in Israele
L’evoluzione del Servizio Sanitario in Israele
Germano Salvatorelli ( AME Italia)
Tsad Kadima “Un passo avanti”
Alessandro Viterbo
Conclusioni
Un assillo, una sfida: lo stacco generazionale Victor Magiar
Dossier / Interviste a cura di Lucilla Efrati, Daniela Gross, Valerio Mieli, Guido Vitale
3 4 6 10 17 25 31 47 51 59 59 63 66 68
3
Il Dipartimento Educazione e Cultura
dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
presenta
ISRAELE, 60 ANNI DI STORIA
E UN FUTURO DA COSTRUIRE
Mokèd autunnale 5769 Parma 5 - 8 dicembre 2008 / 8 -11 kislev 5769 - Hotel Palace Maria Luigia
La nascita dello Stato di Israele avvenuta 60 anni fa ha radicalmente cambiato
la coscienza e la percezione che gli ebrei hanno avuto di sé e della relazione
con il resto del mondo per molti secoli.
Lo Stato ebraico è stato il prodotto di un movimento di pensiero ebraico,
minoritario e spesso contrastato, che costituisce ancora una grande sfida
intellettuale, sociale e religiosa per l’intero ebraismo sviluppatosi nel corso dei
secoli come realtà diasporica.
L’esistenza di uno Stato ebraico non costituisce una sfida solo per la Diaspora,
costretta a ridefinire ogni giorno la propria ragione d’essere. Il fatto di avere
uno Stato costringe gli ebrei, in particolare quelli israeliani, a confrontarsi con
l’intera vicenda storica e identitaria dell'ebraismo. Queste nuove prospettive
indicano che il programma sionistico non significa la fine, ma l’inizio di nuove
sfide e interrogativi per il pensiero ebraico.
In che modo è vissuto oggi lo Stato dalle diverse correnti di pensiero? La
fondazione dello Stato costituisce per tutti l’inizio della Redenzione? Quale sarà
il destino di Israele?
Rav Roberto Della Rocca
Direttore Dipartimento Educazione e Cultura Ucei
55
4
PROGRAMMA
Venerdì 5 dicembre Ore 14 - 16 Arrivo e sistemazione Ore 16, 15 Kabbalàt Shabbàt in Hotel Ore 17,30 - 19 Apertura del Mokèd Roberto Della Rocca - Direttore Dec-Ucei Lo Stato di Israele: la redenzione inizia a germogliare? Michael Ascoli - Ufficio Rabbinico Comunità di Roma Ore 19 Cena e Oneg Shabbàt Ore 20,30 Attività a cura di Daniel Segre - Gerusalemme Sabato 6 dicembre Ore 9 - 13 Tefillà, Kiddùsh, Parashàt Ha Shavua e Minchà: Sinagoga, Vicolo Cervi 4 Ore 13,15 Pranzo Ore 16 - 17.15 Amore e conflitti con Israele (Spunti da una pagina del Talmùd) Rav Roberto Della Rocca - Direttore Dec-Ucei Ore 17, 30 Arvìt e Avdalà in hotel Ore 18,30 L’ evoluzione della Medicina in Israele Dott. Salvatorelli e Dott.ssa Silvera - AME Italia (Associazione Medica Ebraica) Ore 20 Cena Ore 21 - 23 Proiezione del film-documentario Yotvatà Segue dibattito con il regista Corso Salani
Domenica 7 dicembre
Ore 7,45 Shachrìt in hotel Ore 9 - 13 Convegno Saluti di Renzo Gattegna - Presidente Ucei Alexander Manea - Presidente Comunità di Parma
5
Luciano Meir Caro – Rabbino Capo della Comunità di Ferrara e Parma Correnti spirituali e filosofiche del sionismo Roberto Arbib - Direttore Centro Studi Ebraici Iyun Tel -Aviv Messianesimo e ortodossia David Banon - Università Ginevra Terra-madre o terra-sposa? Sion e l'avvenire della storia ebraica Donatella Di Cesare - Università La Sapienza Roma Il sionismo : l’importanza strategica dell’ideologia in crisi Shmuel Triganò – Università di Parigi Coordina Victor Magiar - Consigliere Ucei delegato al Dec Ore 13 Pranzo e Minchà Ore 15 - 19 Convegno Israele anno 100 Vittorio Dan Segre - Università di Lugano Il sionismo chalutzista Anselmo Calò - Consigliere Ucei Il sionismo e l'inseguimento della "normalità" David Meghnagi - Università Roma Tre Coordina Roberto Della Rocca - Direttore Dec - Ucei Ore 19,30 Cena e Arvìt Ore 21 “Via da Freedonia” . Cosa rappresenta Israele per un ebreo italiano? Spettacolo teatrale a cura di Enrico Fink Presso la sala contigua alla Biblioteca Civica, Vicolo Santa Maria 5. Lunedì 8 dicembre Ore 7,45 Shachrìt in hotel Ore 9 - 13 Gita a Soragna: visita alla Sinagoga, al Museo Ebraico e alla Rocca di Meli Lupi. Ore 13 Pranzo e chiusura del Mokèd
6
Roberto della Rocca
“Giosuè e Calev, due percorsi differenti e paralleli nel rapporto con Eretz Israel”
La mia riflessione prende spunto da a una delle più conosciute, ma anche delle più tragiche pagine della storia del popolo ebraico. Si tratta dell’ episodio della delegazione che Moshè manda in Eretz Israel per una missione esplorativa. La rappresentanza dei 12 Principi delle Tribù di Israele oltre a riferire sulla fertilità della Terra lamenta però l’impossibilità dell'impresa della conquista, data la superiorità della popolazione che già è insediata nella terra di Kenaan. La conseguenza di questo comportamento di sfiducia sarà più grave di quelle del peccato di idolatria del "vitello d'oro", in quanto il popolo ebraico dovrà permanere nel deserto per altri 38 anni (per un totale di 40 anni). Da questo episodio infatti scaturiranno la distruzione del Tempio e l'esilio. La Torà (Numeri; 14, 1) riferisce che ascoltando il resoconto degli esploratori: "…e pianse il
popolo in quella notte". Il Midrash afferma che D-o disse: "Voi avete pianto per niente,
io stabilisco che questa notte sarà per voi una notte di pianto". Quella notte infatti era il 9 del mese di Av. Quindi il pianto isterico e gratuito del popolo ebraico che rifiuta di andare in Eretz Israel diviene la causa della notte della distruzione del Tempio e dell’oscurità dell’esilio. Con un significativo paradosso, che non si armonizza molto con le categorie della storia, i Maestri stanno affermando che la data dell’esilio è stabilita ancor prima dell’ingresso in Eretz Israel! La Parashà di Shelach Lechà si conclude con il precetto relativo allo tzitzit :"E sarà per voi come tzitzit, e lo vedrete e ricorderete
tutte le mizvot del Signore e le eseguirete; e non esplorerete appresso ai vostri cuori ed
appresso ai vostri occhi, appresso ai quali voi vi prostituite." (Numeri 15, 39). Rashi’ in loco interpreta cosi’: "e non esplorerete appresso ai vostri cuori: come: dall’esplorare
la Terra (13, 25). Il cuore e gli occhi sono esploratori per il corpo e gli propongono le
trasgressioni, l’occhio vede ed il cuore desidera, ed il corpo compie la trasgressione". Che significa ‘non esplorare appresso ai pensieri del cuore ed alla vista degli occhi’? Il Sefer HaChinuch dice testualmente che: "Il senso di questo divieto è che dobbiamo
evitare di pensare idee che sono l’opposto dell’idea sulla quale la Torà è costruita, dal
momento che è possibile da qui passare all’eresia; ed allo stesso modo che l’uomo non
insegua la vista dei suoi occhi ed in questo contesto che non insegua appresso ai
desideri di questo modo poiché la loro fine è cattiva ….". Ed aggiunge il Sefer
HaChinuch quanto dice il Sifrì in loco, ossia che ‘appresso ai vostri cuori’ indica
l’eresia, ed ‘appresso ai vostri occhi’ indica la prostituzione. Ci troviamo eccezionalmente di fronte una mitzwà che ci impone di controllare la nostra mente e di rinunciare volontariamente a pensieri ed idee che sono contrarie alla Torà. A questo proposito sempre Rashì nota come la stessa radice verbale alla base del divieto, l’esplorare, il latur, sia anche la radice chiave dell’episodio raccontato all’inizio della Parashà, la tragica esplorazione della Terra d’Israele. "e non esplorerete appresso ai
vostri cuori: come: dall’esplorare la Terra (13, 25). Il cuore e gli occhi sono
esploratori per il corpo e gli propongono le trasgressioni, l’occhio vede ed il cuore
desidera, ed il corpo compie la trasgressione". Rashi’ sta affermando che gli occhi ed
7
il cuore sono strumenti che D-o ci ha dato per servirLo e per relazionarci con il mondo. Siamo però noi che dobbiamo indirizzare questi e non viceversa. Il motivo per il quale noi mettiamo i Tefillin alla radice della nostra testa, e non come è scritto “in mezzo ai
tuoi occhi”, và forse ricercata nel fatto che dobbiamo guardare l’altro e affrontare le situazioni con la “testa” e non viceversa facendoci portare “in giro” dagli occhi. Per questo motivo la mitzwà dei Tefillin può essere eseguita soltanto dal momento in cui uno riconosce “l’altro” ad almeno 2 metri di distanza. E’ proprio nella volontà di anteporre gli occhi e il cuore e di verificare quello che D-o dice, che si fonda il fallimento della missione degli esploratori: la causa pertanto è il sentimento di sfiducia. Alcuni commenti tentano tuttavia di capire in profondità le reticenze degli esploratori che, ricordiamolo, non erano persone qualunque, erano persone di vaglia, erano i rappresentanti del popolo. Alcune riserve erano di natura etico- morale: che diritto abbiamo noi su questa terra? Questa terra è gia abitata! Un’altra riserva era di tipo spirituale-religioso. Gli esploratori si sono detti: “..ma chi ce lo fa fare...!, ci nutriamo
della manna, un cibo che viene direttamente dal cielo, possiamo occuparci di Torà e del
suo studio tutto il giorno, perché dovremmo rinunciare a tutto questo per iniziare una
vita dura piena di incognite, con un lavoro che ci impedirebbe di dedicare tempo ed
energie allo studio della Torà?”. Ma è veramente questo lo scopo dell’ebraismo? Distaccarsi dalla vita quotidiana per dedicarsi interamente allo spirito? Certamente no. Il nostro obbiettivo è quello, piuttosto, di portare la kedushà nella vita materiale di tutti i giorni. Affermano i Maestri che Eretz Israel è una di quelle tre cose che come la Torà
e l’Holam Abbà si acquista con issurim, con sofferenza. Il Maharal di Praga nel suo testo Netzach Israel ci fa notare che il testo che leggiamo a Tishà Beav è il libro di Ekhà, che ha le stesse lettere della parola Ajeka quella domanda retorica che D-o pone al primo uomo chiedendogli “dove sei?” , per insegnarci che l’esilio non è una questione esclusivamente geografica. Il libro di Ekhà è scritto tra l’altro in forma acrostica ( il primo verso inizia con la alef, il secondo con la bet e cosi’ via..). C’è tuttavia un’eccezione: il verso che inizia con la lettera “pe” precede quello che inizia con lettera “ain” (nell’alfabeto ebraico invece la ain viene prima della pe). Sappiamo che la parola “pe” significa bocca e che la parola ain vuol dire occhio. Ciò significa che la causa del primo Tishà beav della storia ebraica è rappresentata dal fatto che gli esploratori hanno fatto precedere la bocca agli occhi, hanno denigrato Eretz Israel ancora prima di averla vista, e questo è l’origine di ogni pregiudizio e di ogni posizione precostituita. L’esegesi rabbinica stigmatizza molto questo aspetto sottolineando come gli esploratori si sono recati in Eretz Israel già ideologicamente prevenuti, “…ci andrò ma prima devo vedere
se mi piace….!”. In fondo gli esploratori hanno solo riportato la verità dei fatti e di ciò che hanno visto.Quale è allora la loro vera colpa? Il fatto che alla loro relazione oggettiva hanno aggiunto un “però”….! E’ non è forse cio’ che esprimiamo ogni giorno nei nostri giudizi politici, morali, sociali e religiosi su Eretz Israel? “Si Israele è bella…
..però…!”. Per la Torà vivere in Eretz Israel, amare Eretz Israel, è una mitzwà, che come per tutte le altre mitzwot, và vissuta senza “ma” e senza “però”… ! Ma il giudizio più severo che Maestri del Talmud esprimono sugli esploratori è quello che si riferisce alla valutazione che i delegati esploratori fanno di loro stessi: “Eravamo come
8
cavallette ai nostri occhi e tali eravamo ai nostri occhi…”. Quando un individuo si considera ai propri occhi una nullità appare tale anche agli occhi degli altri. E’ pericoloso sottovalutarsi! Il problema degli esploratori è stato proprio quello di farsi un “tour” (incredibile coincidenza omofonica tra l’ebraico e l’inglese!) in Israele. A
Rehov Dizzengoff ci sono dei bei negozi e dei bei caffè ma forse è meglio….. Via del
Corso…! Oppure confrontare il mare di Eilat con quello della Sardegna! A livello individuale due sono gli esploratori che si distinguono perché, come noto, non si associano al resoconto negativo degli altri dieci: si tratta di Hoshea figlio di Nun della tribù di Efraim e di Calev figlio di Jefunnè della tribù di Jeudà. Solo Jehoshua e Calev capiscono che non è questo il modo giusto di rapportarsi a Eretz Israel. Questi due approcci, diversi nella forma ma simili nell'intenzione, garantiscono l'incolumità dei nostri due personaggi. La Torà dice che Moshè cambiò il nome di Hoshea in Jeoshua. Egli voleva che la protezione Divina (simboleggiata dalle prime due lettere del nome di D-o) facesse scudo ad Hoshea affinché non divenisse complice del complotto degli esploratori. Si tratta delle due lettere del Nome di D-o che compaiono nel giuramento che il Signore fa al termine della battaglia contro Amalek guidata dallo stesso Jeoshua. Hoshea diviene quindi Jeoshua. Prende le iniziali del Nome di D-o, viene chiamato con il Nome di D-o. Il Midrash afferma che la lettera jod aggiunta è la stessa che è stata tolta a Saraj quando è divenuta Sarà, come se qualcosa appartenente alla prima ebrea per la quale viene acquistata Eretz Israel (Abramo acquista il terreno di Chevron per
seppellire Sarà) viene restituito a colui, Giosuè, che per primo entrerà in Eretz Israel. Questo cambiamento del nome rappresenta quindi un segno esteriore di un percorso interiore ben più profondo. Jeoshua costituisce il paradigma del "shimush chachamim", il servizio dei Maestri. Jeoshua è colui che non si distanzia mai dalla Tenda dello studio della Torà. Prima di partire per la difficile missione, Moshè concretizza questa dimensione spirituale rendendo Jeoshua, il suo discepolo per eccellenza, portatore del Nome Divino. Se Jeoshua è colui che tiene saldo il legame Maestro-Discepolo , colui che non si stacca mai dalla tenda dove si studia Torà, Calev è invece colui che ristabilisce il rapporto con la catena della Tradizione. Il testo della Torà dice 'E salirono
nel Neghev e giunse a Chevron'. Il passaggio del verso dal plurale al singolare viene interpretato dal Midrash come indicatore del fatto che solo Calev andò a Chevron ricongiungendosi con le radici storiche e religiose. Calev voleva pregare sulla tomba dei patriarchi per invocare il loro merito come antitodo contro la possibile seduzione ideologica degli altri dieci esploratori (il primo “ minian” della storia ebraica). Calev è colui che tiene saldo il rapporto con gli antenati andando a Chevron sulla tomba dei Patriarchi, perché se non ci si ricorda da dove si viene non si può sapere dove si va. Rabbi Nachman di Breslav diceva: "in ogni luogo in cui vado sto andando verso Erez
Israel." Questa consapevolezza del rapporto atavico con la Terra è necessaria per santificare questa Terra altrimenti si rischia un rapporto di tipo feticistico .Se i dieci esploratori portano i frutti di Eretz Israel, Jeoshua e Calev tornano a mani vuote. Jeoshua è colui che viene chiamato con il Nome di D-o e chiamato a succedere a Moshè. Calev sarà invece l'unico ebreo a vedersi chiamato proprietario di un pezzo specifico di Eretz Israel. Abbiamo visto come questa storia evidenzi un significativo
9
parallelismo tra il divieto di pensare contro la Torà ed il precetto di farsi degli tzizziot
con il quale si chiude la Parashà degli esploratori. Se è vero che lo tzizzit costituisce
l’antitodo al vagare appresso al desiderio degli occhi e al desiderio del cuore, perchè vedendo lo tzizzit che ho indosso mi ricordo della Torà, questa storia ci insegna che verso Eretz Israel si può andare solo se si impara ad ammantarsi con il Nome di D-o.
10
Michael Ascoli
Lo Stato di Israele: la redenzione germoglia?
Desidero ringraziare rav Roberto Della Rocca per avermi invitato a prender parte attiva a questo convegno. Ho accettato volentieri, ricordando però che le considerazioni che andrò ad esporre non sono, né potrebbero essere, il frutto di uno studio sistematico o di un esperto della materia, ma più modestamente riflessioni che propongo e che desidero condividere con chi ascolta. Ho scelto di partire dalla “tefillà li-shalom medinat Israel” perché per molti aspetti è emblematica dell’ideologia sionista religiosa e dei contrasti insiti sia al suo interno sia fra questa e il resto della popolazione ebraica. Questa estate Yoel Rappel ha pubblicato un articolo1 nel quale si attribuisce definitivamente la paternità di questa preghiera, nella formulazione che noi conosciamo, a rav Herzog z’’l, rabbino capo di Israele all’epoca dell’indipendenza dello stato ebraico e negli anni successivi, riducendo di molto il ruolo dello scrittore S. I. Agnon z”l nella stesura del testo. In un recente seminario rabbinico2 rav Arussi, nel corso di un intervento molto critico sulla politica dello Stato di Israele nei confronti del rabbinato, ha sostenuto che la scelta del momento in cui iniziare a recitare la preghiera per lo stato di Israele non fu casuale: sarebbe stata piuttosto una reazione al mancato consulto dei rabbini-capo Herzog e Uziel3 per la nomina dei giudici del neonato Stato, il quale così facendo dimostrava di misconoscere il ruolo dei dayanim e delle regole della Torà. Rav Herzog e rav Uziel pertanto non parteciparono all’assemblea inaugurale del bet ha-mishpat ha-elion e circa una settimana dopo si iniziò a recitare la preghiera. Siamo al 20, 21 settembre 1948. Prima di allora, comunque, vi erano state molte altre proposte. In ogni caso l’idea di una tefillà per lo stato in cui si vive è una tradizione antica, valida in ogni nazione. Ed in effetti alcune formulazioni alternative a quella che noi oggi utilizziamo riprendono direttamente anche nella formula questa tradizione (in alcune sinagoghe sono usate tutt’oggi). La novità fondamentale, direi, è racchiusa nella formula reshit tzemikhat gheulatenu
(“inizio del germoglio della nostra redenzione”) utilizzata qui per la prima volta. A lungo si è ritenuto che fosse di rav Kook, ma questa ipotesi non ha trovato riscontro. E’ una definizione sofferta, forse esitante –inizio del germogliare della nostra redenzione- che probabilmente riprende l’espressione et tzemakh david avdekhà
meherà tazmiakh” (“il germoglio di David Tuo servo fai germogliare presto”), che recitiamo nella ‘amidà4; sicuramente richiama la definizione classica di atkhaltà de-
geullà (“inizio della redenzione”). יואל רפל 1 ," תפילה מיוחסת בת שישים " , מקור ראשון 19.9.08. 2 Gerusalemme, 4 kislew 5769 (1.12.08). 3 Rabbino capo sefardita all’epoca. 4 Inizio della 15° berakhà della ‘amidà.
11
Insomma, ciò che è chiaro è che questa tefillà sancisce il fatto che siamo in era messianica. Fermiamoci a riflettere: perché lo stato di Israele implica necessariamente l’epoca (l’inizio dell’epoca) messianica? Si apre a questo punto un problema enorme a cui possiamo solo accennare e per il quale esiste un testo di riferimento essenziale per nostra fortuna tradotto in italiano, che presumo molti di voi conoscano bene: Aviezer Raviztky La fine svelata e lo stato degli
ebrei. Raviztky si sofferma a considerare quattro diversi approcci fondamentali nei confronti dello Stato di Israele: una parte dei charedim, assai minoritaria in numero ma molto estremista e militante, oppositori oltranzisti dello Stato; i sionisti religiosi; il resto dei charedim e i chabad. Occorre fare attenzione che il libro è del 1993 e che quindi per alcuni aspetti è datato. Non nel senso che le analisi fatte fossero sbagliate, quanto piuttosto nel senso che le cose sono purtroppo peggiorate da allora. Tanto per fare un esempio eclatante nel ’93 il Rebbe dei Lubavitch era ancora vivo. Bisognerebbe allora piuttosto fare riferimento a D. Berger - The Rebbe, the Messiah and the Scandal of
Orthodox Indifference) o ai rapporti che ogni tanto cura D. Grosser. Quanto agli estremisti del sionismo religioso, ci tornerò più tardi. Ciò che ora è fondamentale sottolineare è che anche laddove il riferimento messianico non era inizialmente maggioritario o fondamentale - come per esempio nel caso della maggior parte dei charedim che ha una reazione di indifferenza nei confronti dello stato- questo riferimento invece è diventato via via più importante, se non altro per il fatto di dovervisi misurare, a fronte degli attacchi sempre più pressanti degli “estremisti”. In brevissima sintesi: i sionisti affermano “siamo in epoca messianica”, gli antisionisti, ad esempio i Satmar, sostengono che “lo Stato di Israele allontana il Messia”; il grosso dei charedim rimane ugualmente in “golà” ma deve sempre più confrontarsi con questa entità arrivata ormai a sessant’anni. Sessanta’anni per la storia sono pochissimi ma la maggior parte delle persone ha meno di 60 anni, cioè non ha mai conosciuto una realtà senza lo stato di Israele! Ma perché è così fondamentale dare una giustificazione teologica all’esistenza dello Stato? Cosa ci impedisce di considerarlo niente più che il compimento del nostro
dovere, la realizzazione delle nostre tefilloth non appena ci è stato finalmente possibile? La filosofia della storia nel mondo ebraico ha subito enormi evoluzioni nei secoli: i tosafisti discutevano su quale fosse “l’esenzione” dall’andare in Israele: cioè “perché non ci andiamo?” Una delle risposte fu “perché la strada per arrivarci è pericolosa”. Non era una domanda teorica. Ed infatti, 300 di loro decisero invece di trasferirsi! Si tratta di una giustificazione dettata dalle circostanze, “la strada è pericolosa”, non di una obiezione di principio. E’ noto che Ramban vi andò e così tanti altri nel corso della storia. L’atteggiamento era piuttosto quello di trovare una giustificazione, magari a posteriori, per chi non vi andasse o non vi fosse andato. In tempi più recenti però si era consolidata l’idea per la quale dall’esilio si sarebbe usciti solo con il Messia. Un atteggiamento passivo nei riguardi degli avvenimenti e della storia, non era quindi una debolezza, bensì l’unico comportamento religiosamente accettabile, quello che esprimeva la fede completa nella venuta del Messia, quel Messia
12
che lui, e soltanto lui, ci avrebbe portato nella terra d’Israele. Ravitzky dedica un intero capitolo ai tre giuramenti
5. Il Talmud insegna che D-o fece giurare al popolo ebraico che 1) non sarebbero saliti compatti (“come un muro”) e che 2) non si sarebbero ribellati alle nazioni e alle nazioni del Mondo che 3) non avrebbero asservito Israele eccessivamente. L’elaborazione di questa fonte è ciò che ha verosimilmente portato al consolidarsi di quella passività di cui abbiamo parlato. Un’altra idea importante è una giustificazione –questa sì di principio e non dettata dalle circostanze- di uno dei tosafisti: la kedushà che la terra d’Israele richiede non è alla portata di tutti, ma solo di pochi eletti. Se non si è in grado di vivere “da santi” meglio non andare: “non assomiglia chi vìola la volontà del Re per strada a chi la vìola all’interno del suo palazzo!”. Perfino i chovevè tzion, gli “anelanti a Sion” della prima alyah erano spesso persone “scelte” . Quegli stessi maestri che invitarono loro ad andare, invitarono altri a non andare, perché non all’altezza. Date queste premesse è chiaro che si va in Israele solo se ci porta il Messia o perché invece ci si sta ribellando alla volontà del Signore. E siccome, per altro, la maggior parte dei sionisti sono laici ribelli è chiaro a cosa tenda il sionismo. Ci volle tutto il carisma e la carica innovativa di rav Kook per stravolgere questo ragionamento, parlare dell’inizio della redenzione che viene dal basso, di Herzel come del masciach ben Yosef (!)6, dei sionisti laici come di una fase necessaria, di scorger in loro una scintilla di divino, ecc. ecc. Qui voglio introdurre un altro elemento: il primo movimento religioso sionista, il Mizrachi, non aveva nessuna tendenza messianica. Vedeva nello stato di Israele la salvezza del popolo. Questa è un’idea ben precedente alla shoà –anche se non abbiamo tempo di affrontare questo argomento voglio solo sottolinearlo- e che incredibilmente accomunava Herzel a rav Reines (fondatore del Mizrachi) al punto che entrambi erano favorevoli all’opzione Uganda!! E non è escluso che rav Reines intendesse con ciò proprio evitare qualsiasi implicazione messianica. Riflettiamo sulla conclusione alla quale siamo arrivati: il ritorno a Sion non è l’esaudimento delle nostre preghiere, né l’adempimento di un nostro dovere. In realtà non ci sarebbe neanche bisogno di tornare a Sion, basta un angolo del mondo in cui ci lascino in pace. Quando infine si decide di tornare a Sion bisogna trovare una giustificazione teologica a questo ritorno. Non solo, bisogna spiegare religiosamente la necessità e la positività di un movimento sionista assolutamente a-religioso anzi spesso anti-religioso. Evidenziamo a questo punto un altro elemento del pensiero di rav Kook che a me sembra sia stato gravido di conseguenze: rav Kook parla di nevuà, di profezia e di ruakh
ha-qodesh (“spirito santo” o “ispirazione divina”). In estrema sintesi direi che qui troviamo i due germi alla luce dei quali –esprimo umilmente un tentativo di spiegazione che va approfondito, confermato dagli studiosi- si 5 TB Ketubboth, 111. In passi paralleli si trovano varianti anche significative, v. Ravitzky. 6 Secondo una tradizione rabbinica, prima del Messia di stirpe davidica ne apparirà uno discendente da Yosef, che sarà destinato a morire.
13
può spiegare la deriva dell’ebraismo religioso che si ritiene continuatore dell’insegnamento di rav Kook e che rappresenta ahimè la maggior parte dell’ebraismo religioso sionista: l’era messianica e la profezia. Infatti, l’inizio dell’era messianica non può essere troppo lungo -e 60 anni sono troppi per troppa gente- e una profezia non può fallire!” Tutti sanno che rav Zvì Yehudà Kook z”l, il figlio di rav Kook, è colui che ha trasformato l’insegnamento del padre portandolo dalle aspirazioni di riscatto dell’umanità intera, aspirazioni figlie dei tempi di Rav Kook padre, all’aspirazione nazionalista-territorialista.7 “Dov’è Hevron? Dov’è Scechem?” tuonava rav Zvi Yehuda dicendo di non poter gioire di yom ha-atzmaut perché la conquista non era completa. Fu lui a ispirare il movimento Gush Emunim, e fu lui a spingere i suoi alunni a insediarsi in Yehudà e Shomron. Ma fu lui anche a semplificare la dialettica del padre portandola a un livello molto più piano, dogmatico. La guerra dei 6 giorni accrebbe ancor di più questa sua tensione messianica, fino al punto che Y. Leibowitz z”l -sempre radicale nei suoi giudizi- lo definisce senza mezzi termini “fascista idolatra”. Ma poi venne lo schiaffo della guerra del Kippur. Qui mi permetto di riportare un’esperienza personale: forse saprete che ho vissuto tre anni in Israele. Per me, abituato a contare le guerre che Israele ha combattuto nella sua breve storia, è stato un trauma enorme scoprire come la guerra del Kippur venne recepita sostanzialmente come una sconfitta. All’inizio stentavo a capire il tono degli articoli dei supplementi dei giornali israeliani (avete presente gli interminabili “musaf shabbat”?), perché si parlasse di crollo di un mito, di sconfitta. Forse alcuni conoscono la canzone “noi siamo i figli dell’inverno del ‘73” che è uno dei colpi allo stomaco più forti che possono riceversi in Israele. Bene, se fino al ’67 il fervore messianico non fece che crescere, dal ’73 in poi iniziarono i problemi. Si cominciò a parlare di restituzione dei territori; si fece sempre più forte l’idea di una sorta di santità intrinseca alla terra, per cui non si poteva rinunciare neanche a un metro quadrato di essa. Ora: di chi è la colpa? Perché le profezie non si avverano? Rav Kook era capace di abbracciare il pioniere che gli urlava in faccia “non abbiamo bisogno di rabbini qua” . I suoi sedicenti alunni sono capaci di fare altrettanto? In genere no. Nei casi peggiori, è cronaca dell’altro ieri, sono capaci di dire al poliziotto etiope “un negro non caccia via gli ebrei”. Ora, alcuni che pure si considerano alunni di Rav Kook, per esempio rav Amital, si discostano dagli insegnamenti e dalle interpretazioni di Rav Zvì Yehudà. Ma la corrente maggioritaria lo segue. Non solo lo segue, ma nega la possibilità di contestarlo. Siccome l’argomento è doloroso, troppo in contrasto con l’atmosfera sabbatica, faccio un solo esempio, eclatante: la soffertissima hitnatqut, (“separazione” da Gaza). Un giorno appare su uno dei pochi giornali moderati che si trovano di shabbat al tempio, una pubblicità che riporta un’affermazione di rav Liechtenstein: “Un compromesso che 7 Segnalo a questo proposito un articolo del dayan Gad Eldad apparso su Shalom di qualche tempo fa a seguito dell’attentato nel quale furono assassinati alcuni studenti della yeshivà “merkaz ha-rav” di Gerusalemme, dove per rav si intende appunto rav Kook.
14
ci consenta di conservare la nostra casa, seppure più ristretta, costituisce una soluzione ebraica, conforme alla Torà, spirituale e morale”. Al di là del fatto che il movimento Meimad si troverà costretto a rettificare, specificando che la citazione era presa da un altro contesto, nel numero successivo, rav Sharlo (è uno dei più carismatici del movimento Tzohar se qualcuno ne ha sentito parlare, persona aperta e moderata), si è sentito in obbligo di difendere il diritto di rav Lichtenstein ad esprimere un’opinione del genere, e della redazione di pubblicarlo!, nonostante vi vedesse un problema etico (!). Per apprezzare pienamente la gravità dell’episodio, bisogna tener presente la caratura di rav Liechtenstein, uno dei più grandi talmidè khachamim viventi, ultraottantenne, allievo di rav Soloveitchik e co-fondatore della yeshivà di Har Etzion! Purtroppo debbo aggiungere che se leggete sia Ravitzky, sia la recentissima biografia di rav Kook curata da Avinoam Rosenak, entrambe evidenziano un problema di censura (sic) operata sugli scritti di rav Kook da parte dei suoi allievi. Tornando al sionismo religioso, vorrei sottolineare come il festeggiare/non festeggiare yom ha-atzmaut e yom yerushalaim sia determinante. Spiega rav Amital che “Dov’è
Hevron, dov’è Shechem?” trasforma la festa dell’indipendenza –che ha un valore in sé come egli si dilunga ad illustrare– in festa di conquista territoriale. E allora ecco che Yom Yerushalaim diviene più importante di Yom ha-atzmaut. Faccio notare che la rabbanut ha-rashìt inizialmente decretò che venisse recitato l’hallel con berachà a yom yerushalaim e senza berachà per yom ha-atzmaut! E’ questa anche l’occasione per citare il nostro rav Artom z’’l che pure era fortemente contrario a qualsiasi restituzione territoriale e che mi sembra ammettesse pienamente il principio di reshit tzemikhat
geulatenu:
“[…] l’aspetto più grave è questo: i gruppi ‘religiosi’ vogliono sminuire l’importanza del 5 di yiar (yom ha-atzmaut), poiché questo è un giorno di festa e di gioia per tutto il popolo, senza distinzione di fede e di partito; il 28 di yiar (yom yerushalaim), invece, destinato ad essere principalmente la festa dei ‘religiosi’, destinato ad essere un ulteriore elemento dell’auto-isolamento religioso, merita di esser maggiormente rimarcato! Alla luce di ciò, meglio destinare yom ha-atzmaut anche per celebrare la liberazione di Yerushalaim […]”. Dunque io penso che in Italia dovremmo ri-analizzare la nostra posizione riguardo a queste due feste tenendo conto dell’opinione di rav Artom. Insomma il divario tra religiosi e non religiosi aumenta. E l’odio, o almeno il pregiudizio, è reciproco. Un esempio letterario delicato: “Gerome diventa un genio”. Ora, fate caso: da una parte una popolazione religiosa sempre più indissolubilmente legata alla terra; dall’altra una popolazione che vi si stacca sempre di più. Per un giovane laico a Gerusalemme, ammesso che ve ne siano rimasti ancora, andare al Kotel non è significativo, semplicemente non ci si va, mai. Recentemente si è parlato del film “Qualcuno con cui correre” tratto dall’omonimo libro di Grossman. Bellissimo. Però fate caso come quasi invariabilmente la critica sottolinei l’ambientazione in scenari non “classici” di Gerusalemme. Mi sembra che da parte della popolazione laica ci sia un costante desiderio di dimostrare l’esistenza di una cultura israeliana non legata
15
all’ebraismo, del quale pertanto rimuove ogni simbolo. Sarà mica un caso che A. B. Yehoshua identifica nella lingua l’unico retaggio autentico dell’ebraismo! E se lui , come Amos Oz, Grossman, ecc. fanno volenti o nolenti uso abbondante di espressioni tolte ai khachamim, è nata una generazione successiva di scrittori che non ha più neanche quello. Ma non sono solo i laici a non fare la tefillà per lo stato di Israele. Loro, da questo punto di vista, semplicemente non fanno tefillà, ma sono generalmente vicini ai sionisti religiosi perché fanno tutti il militare. La “tzavà” è un collante enorme, come tutti sapete; è quello, lo accenno soltanto, che consente il “ghiur sociologico”: si scannino pure i rabbini a stabilire se i ghiurim del tribunale speciale di rav Druchman sono validi o no (discussione in sé gravissima!). Il fatto assai più significativo è che la maggior parte non fa neanche richiesta. Non ne ha nessun bisogno, nessuna esigenza. Si integra nella società israeliana senza bisogno di conoscere alcun rabbino e il servizio militare ne suggella l’ingresso in società laddove non fosse già avvenuto prima. C’è una fetta importante della popolazione israeliana, segnatamente quella che viene dall’ex-URSS che non ha nessun legame con l’ebraismo, e in questo caso neppure con la cultura israeliana. Ma torniamo a noi. Chi non prega per lo stato di Israele sono i kharedim, che allo stato di Israele si rapportano come a qualsiasi altro stato: con gli “shtadlanim”: quanto posso
ottenere dallo stato? Però ora sono stabilmente alla Kneset, influenzano tutto: dalla politica agli scavi archeologici, ai lavori per la metropolitana, alla rabbanut ha-rashìt ai suoi tribunali, ovviamente! Sono una presenza sempre più cospicua e nonostante le dichiarazioni ideologiche, sempre più coinvolta, ma che, a differenza dell’ebraismo sionista non prende responsabilità per gli altri: la grandezza , lo splendore di rav Kook sta nel farsi carico dell’intera popolazione. Il kharedì è ancorato all’interpretazione ‘ammecha=im ‘osè ma’asè ‘ammecha
8, cioè “la solidarietà esiste solo con chi si
comporta secondo il modo che si addice al tuo popolo”, ossia osservando le mitzwot ( e osservandole come dicono loro!) La tefillà li-shalom medinat Israel è emblematica anche per il fatto che ci sono frange sempre più importanti proprio della tradizione datit che ne cambiano la formula o non la recitano più affatto: auspicano che vengano scelti alla guida dello Stato uomini “valorosi, tementi del Signore, uomini onesti che detestano il lucro iniquo”9 implicando con ciò che chi ne è oggi alla guida non ha questi requisiti, oppure recitano sheteè reshit
tzemikhat geulatenu, sicché lo Stato di Israele ad oggi non è l’inizio del germoglio della redenzione ma si auspica che possa diventarlo, e tante altre ancora. Qualcuno si è divertito a contare le varianti proposte, circa 60. Infine, la tefillà li-shalom medinat Israel è significativa per la sua seconda parte: “we-et
akhenu col bet Israel peqod na micol artzot pizureem…” – “E i nostri fratelli della casa 8 Quando la Torà parla del tuo popolo (ammecha) si riferisce a chi si comporta in modo degno del tuo popolo (‘osè ma’asè
‘ammecha). 9 Cfr. Esodo 18:21.
16
di Israele ricorda, orsù, in tutte le terre in cui sono dispersi…” perché ci mette ineluttabilmente di fronte alla questione di quale senso abbia recitare una tale tefillà in diaspora, come pure siamo abituati a fare nelle comunità italiane. Assai concisamente dirò che la definizione più calzante per molti di noi ebrei italiani è quella di “sionista vigliacco”, che non ha il coraggio di dare seguito coerente alle sue idee, come si legge nel libro “Melagrana” di L. Tagliacozzo. Ancor più lapidario è Vittorio Dan Segre: “Cosa tiene lontano gli ebrei da Israele? La paura e la mentalità diasporica”10. Anche qui l’interrogativo si farà sempre più pressante, visto che se già oggi la maggior parte del popolo ebraico si stima viva in Israele, nel giro di 10-15 anni il rapporto Israele-diaspora potrebbe divenire 70% - 30%, marcando così come decisamente minoritario l’ebraismo diasporico. Nonostante tutte le cose, anche molto dure che ho detto, lo Stato di Israele si distingue dalle altre nazioni del mondo per la sua capacità e la sua volontà di risolvere i problemi, per il suo ottimismo, che recentemente rav Riccardo Di Segni ha sottolineato come l’unica cosa “non normale” nel succitato romanzo di Grossman, ma che è vera, meravigliosamente vera in generale. Vorrei pertanto concludere invitando tutti a recitare domani con devozione la tefillà per lo stato di Israele avendo la cawanà di mettere in pratica personalmente la sua seconda parte, andando “a testa alta alla tua città, Sion!”.
10 Intervista a Shalom di gennaio ’09. Questa aggiunta evidentemente successiva al moqèd è un’autorevole conferma a quanto esposto. L’intervista è molto interessante anche perché evidenzia la crescente marginalità dell’ebraismo diasporico occidentale.
17
Donatella Ester Di Cesare ∗
Terra-madre o terra-sposa? Sion e l’avvenire della storia ebraica
1. “Normalizzazione degli ebrei”?
In una lettera a Walter Benjamin della primavera del 1931 Gershom Scholem, già emigrato in Palestina, scrive all’amico rimasto in Europa: Non credo che ci possa essere una ‘soluzione della questione ebraica’ nel senso di una normalizzazione degli ebrei, e non credo certo che in tal senso questa questione possa essere risolta in Palestina – mi era e mi è sempre stato chiaro che la Palestina è necessaria”11. È come se qui Scholem volesse dire che la Palestina è necessaria, ma non sufficiente, necessaria per la questione ebraica, nei termini drammatici in cui si va ponendo nel Novecento, ma non sufficiente. Perché quella fascia di terra ristretta non può essere assunta come il confine ultimo, come il fine del popolo ebraico. La terra rinvia oltre sé alla promessa. 2. Israele: uno stato-paria
Nell’era degli stati-nazione è oggi l’esistenza del popolo ebraico nella sua forma statale che sembra cristallizzare la sua illegittimità. Quel che nei secoli passati era l’ebreo singolo, è ora lo stato di Israele. La questione ebraica è divenuta una questione planetaria. Dopo Oslo, e soprattutto dopo la conferenza di Durban del 2001, l’esclusione mondiale di Israele ne ha fatto lo stato-paria per eccellenza. Unico stato le cui frontiere non sono riconosciute, è il bersaglio in tutte le arene internazionali. Basterebbero poche cifre. Tra il 1948 e il 1991 il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha emesso 175 risoluzioni sul conflitto mediorientale di cui 97 contro Israele, 4 contro i paesi arabi; l’Assemblea generale ha emesso 322 risoluzioni che condannano Israele, nessuna contro i paesi arabi. Ma non si tratta solo di cifre. E la situazione è non solo complessa; ha uno spessore tale da richiedere una riflessione pacata e approfondita che spesso la frettolosa applicazione di categorie dell’attualità finisce per oscurare e anzi per impedire. ∗ Questo è il testo, rivisto e corredato di note, della conferenza tenuta al Moked autunnale 5769, tenutosi a Parma nei giorni 5 - 8 dicembre 2008/8 -11 kislev 5769 organizzato dal DEC-UCEI (Rav Roberto Della Rocca).
18
È noto l’argomento che conduce a ritenere illegittimo lo stato di Israele: l’esistenza di uno stato ebraico sarebbe segnata da un peccato originale, cioè dall’ingiustizia commessa verso il popolo presunto autoctono, quello palestinese, che sarebbe stato scalzato da un “popolo straniero”, quello ebraico. L’argomento si fonda dunque sull’estraneità del popolo ebraico rispetto al paese contestato. Già straniero fra gli altri popoli, viene considerato straniero anche in quel che considera il suo essere presso di sé. Al popolo ebraico non spetterebbe dunque nessun posto nel mondo. Il che equivale a un verdetto sulla sua esistenza, se esistere vuol dire essere in un luogo. Ma se il popolo ebraico è sopravvissuto a venti anni di esilio, è perché è rimasto legato a Sion, rivolto con la sua speranza a Gerusalemme. Negare la sua storia è come negare la sua esistenza. 3. Quale sionismo?
Alla fine della modernità, e dunque anche della modernità ebraica, occorre meditare sugli esiti dell’emancipazione, ma anche sulla filosofia che la sottende. Nel mondo illuminato ed emancipato sono stati gli individui, astratti e generici, per così dire depurati dal loro ebraismo, ad essere stati accettati. Il popolo ebraico, appunto in quanto popolo, è rimasto del tutto al di fuori. Il sionismo politico è stato l’unico movimento – a parte il Bund, la lega dei lavoratori ebrei – a chiederne il riconoscimento. Il merito del sionismo è stato di aver creato una cittadinanza ebraica nell’età degli stati-nazione; senza uno Stato di Israele l’emancipazione si sarebbe pericolosamente arrestata, dato che la modernità politica si basa su due pilastri: il cittadino e lo stato-nazione. C’è tuttavia una dimensione tragica del sionismo che occorre mettere allo scoperto. Accettando la dialettica dei Lumi e dell’emancipazione, Theodor Herzl e i fondatori del sionismo non hanno riconosciuto la natura della modernità politica che rifiuta la differenza del popolo ebraico12. È proprio l’ebraismo del popolo ebraico che resta fuori dalla modernità degli stati-nazione. Sta qui la tragicità del progetto sionista teso a iscrivere il popolo ebraico nell’emancipazione che volgeva al termine. Così ha risuscitato il ricordo del popolo assente, senza tuttavia renderlo presente nella sua storicità. Ma già Buber scrive nel 1944: Finché si interpreti il concetto di Sion semplicemente come una delle tante idee nazionali, non si può arrivare a comprenderne il vero significato13. 11 G. Scholem, Walter Benjamin – die Geschichte einer Freundschaft, Suhrkamp, Frankfurt 1975, p. 211 [questa lettera non è tradotta nell’edizione italiana]. 12 Su questo mi permetto d rinviare a D.E. Di Cesare, La “differenza” dell’ebraismo. Riflessioni tra
Rosenzweig, Sholem, Derrida, Levinas, in “La rassegna mensile di Israel”, 73, 2007, pp. 1-17 13 M. Buber, Sion. Storia di un’idea [1944], trad. it. di P. Gonnelli, intr. di A. Poma, Marietti, Genova 1987, p. 5.
19
“Essere come gli altri” – questo è stato sempre il desiderio degli ebrei moderni, il motore dell’assimilazione. Ciò che oggi è in questione è proprio il desiderio di normalizzazione degli ebrei che si è tradotto nella volontà che lo Stato di Israele sia uno stato come tutti gli altri, assolutamente normale. Non per caso il progetto sionista si è avvalso di due mezzi che sono anche i criteri della normalità: la terra e l’identità. Questa territolizzazione identitaria implica una definizione negativa non tanto della vita diasporica, quanto più profondamente dell’esilio. Ma così il sionismo politico finisce per concepire negativamente la stessa ebraicità che non è una tecnica di sopravvivenza nell’esilio, ma un modo altro di esistere. 4. Estraneità. Sulla vocazione di Israele
Questo modo altro di esistere, che è il modo di essere ebrei, non è la condizione del paria, bensì la condizione dello straniero. Rispetto all’autoctono, a chi crede di essere radicato dall’origine, lo straniero, pur essendo residente, ha un rapporto del tutto diverso con la terra, con l’altro, con se stesso. Questa estraneità, che Israele è stato chiamato a testimoniare nella storia del mondo, questo esilio dell’esistenza, che a ben guardare è tutt’uno con l’esistenza, segna la condizione umana, cancellata e rimossa nei secoli. La normalizzazione degli ebrei ha voluto sopprimere questa estraneità. Svuotata e banalizzata, l’estraneità è stata ridotta al suo opposto, all’identità identitaria. Ma così si è finito per non comprendere che l’estraneità è una identità che apre all’alterità dell’altro. È nell’estraneità che si compendia il concetto di “popolo ebraico”. Ed è l’estraneità che ha costituito lo specifico della sua presenza-assenza nella storia. In tal senso non si può parlare né di una assenza dalla storia del “popolo eterno”, né perciò del suo ingresso nella storia14. La storia ebraica è una storia dell’estraneità che, pur interagendo, non può essere allineata, come ha preteso il sionismo, alla storia dell’autoctonia dei popoli. Si è consumata qui la conflittualità tra il principio illusorio dell’autoctonia e l’estraneità di cui si è fatto carico il popolo ebraico non solo individualmente, ma come comunità, e vivendola non solo in termini esistenziali, ma anche in termini politici. Perciò l’ebraismo, malgrado il contrasto che lo oppone allo “stato”, è strettamente connesso alla dimensione politica. Certo non alla politica della modernità, né tanto meno a quella dello stato-nazione. Va da sé che sotto il governo dello stato-nazione, che è solo una delle possibili forme di articolazione dell’umanità, è non senza dubbio quella 14 Di una assenza del “popolo eterno” dalla storia parla Rosenzweig. Cfr. F. Rosenzweig, La stella della
redenzione, trad. it. di G. Bonola, Marietti, Genova 1985, pp. 324-326.
20
definitiva, non ci sono più popoli, ma una “nazione”. È lo stato che istituisce la nazione. Il popolo ebraico, disperso fra gli altri, appare irriducibile a un solo territorio e a una sola nazione. Questa irriducibilità, che paradossalmente si ripropone anche quando gli ebrei creano il proprio stato-nazione, questa irriducibile estraneità è lì per denunciare la nazione inchiodata all’immanenza del potere e del territorio, per smascherare l’autoctonia che genera i falsi sentimenti di sicurezza, continuità, forza, per indicare i pericoli del radicamento e dell’identità territoriale. Ma soprattutto l’estraneità di Israele è la spina nel fianco dello “stato” che nella sua immanenza idolatrica, nella sua sovranità demiurgica, così tellurica e così radicata, nel suo asfittico paganesimo nega ogni possibilità di un oltre, nega l’oltre dell’altro, l’Alterità della trascendenza. Senza stato, Israele ha vissuto oltre lo stato, nell’al di là anarchico che ha segnato il suo profetismo, senza venir meno alla necessità dell’ora, ma senza neppure smettere di guardare, nell’ora, all’oltre messianico di ciò che è a venire. È la Presenza divina, che non si incarna nel corpo del popolo, ma è sempre anche assente, a rendere impossibile la pienezza dell’autoctonia, a iscrivere la separazione nel cuore stesso dell’identità. Così Israele testimonia l’estraneità che è il principio costitutivo di tutta l’umanità, iscritto nell’identità di ogni individuo. Questo non significa per nulla subire passivamente la condizione di paria; piuttosto e ben di più vuol dire fare dell’estraneità il principio di una nuova azione nella storia, di una nuova strategia esistenziale, etica, politica – di un’altra politica. Quel che l’umanità sperimenta attraverso Israele è il limite dello stato-nazione fondato sulla territorializzazione dell’identità collettiva e sull’esclusione dello straniero. Se tutti nello scenario attuale lo vivono, è Israele a porlo al mondo come questione.
5. La Terra e la questione del ritorno
Finché è in esilio, è Israele a portare l’estraneità nel mondo. Ma che cosa accade alla fine dell’esilio? La fine dell’esilio è segnato dal ritorno alla Terra. L’importanza della Terra è fondamentale; sta nel cuore del dramma dell’esilio. Ma nell’ebraismo il ritorno degli ebrei a Sion non può essere preso per un semplice ritorno al luogo d’origine. La questione che si pone è quella del ritorno. Se il momento del ritorno è tra i più difficili, è perché si può rischiare di prendere il ritorno per un semplice radicamento. La Terra di Israele non è una terra ancestrale, non è rivendicata come “terra-madre”. Quando si dice Sion, la città del “Gran Re” (Sal 47,3) si rinvia a una terra promessa, una terra-sposa, si rinvia allo “sposalizio” – come scrive Buber – di un popolo santo con una Terra santa. La promessa della terra è la condizione perché possa nascere la comunità di
21
un popolo “santo”15. Ma in nessuna epoca della storia di Israele questa terra è stata semplicemente possesso del popolo. Perché sposandola il popolo deve dall’unione santa dare vita a qualcosa di nuovo – a venire. La terra non è un oggetto passivo, ma è attiva e vivente. Come la terra ha bisogno del popolo, così il popolo ha bisogno della terra – ciò che avverrà sarà perciò opera della storia e della natura. La terra a sé stante e il popolo a sé stante potrebbero essere considerati normali, ma nella loro relazione reciproca sono un unicum senza paragoni. Sottrarsi a questa unione vuol dire far crollare tutto ciò che è stato costruito; realizzarlo è l’inizio di una nuova convivenza umana. A guidare questa impresa è una fede storica nel D-o di Israele che conduce nella Terra prima i padri e poi il popolo per fini storici. Come i padri fondatori, come il popolo che esce dall’Egitto, così gli israeliani di oggi: il popolo ebraico viene da altrove ed è promesso a quella terra, come quella terra gli è promessa. Il che vuol dire che il popolo ebraico non è il prodotto della terra, del territorio. Il suo rapporto con la terra non è quello dell’autoctono, non può rivendicare e non rivendica una autoctonia. Il suo rapporto con la terra è retto da una esteriorità, da una estraneità, da una separazione che vanno lette non in termini di negazione, ma positivamente. In questa separazione si iscrive la terra “santa”, che non è sacra e non va sacralizzata. La sacralizzazione significherebbe un rapporto idolatrico con la terra, una identificazione (per ottenere anche una identità), un radicamento, una fusione. Al contrario – come insegna la Torah – la terra è santa, perché è separata: anzitutto dalla naturalità degli altri territori, ma anche per il rapporto che il popolo ebraico intrattiene con questa terra. La terra è “santa” perché il popolo ebraico mentre vi si insedia, non si radica, ma se ne separa. Abita questa terra in modo diverso dal consueto, normale abitare degli altri popoli; abita come uno straniero residente, un ospite che sa di essere ospite. L’accettazione di questa condizione è per la Torah la condizione della permanenza dell’abitare nella Terra promessa.
Mia è la terra, perché voi siete forestieri e residenti provvisori presso di Me (Lev 20, 23). D’altronde, chi sono gli abitanti originari, i primi occupanti, gli autoctoni, di questa terra – ma di ogni terra? L’eco di questa estraneità originaria c’è già nella Torah; Israele si dirige verso la terra promessa dall’esterno. E ogni volta che Israele compare su questa terra, si pone la questione dell’estraneità. Il che poi vuol dire che ogni popolo è invasore di una terra che non gli appartiene e che può abitare solo salvaguardando il ricordo della sua originaria estraneità. Ma così Israele ricorda a tutti i popoli della terra che non sono autoctoni, ma solo ospiti. Il grande insegnamento della Torah è proprio questo: l’uomo 15 Cfr. M. Buber, Sion. Storia di un’idea, cit. pp. 8-9.
22
non è mai autoctono sulla terra; la sua condizione è sempre quella dello straniero-residente, dell’ospite su una terra che non gli appartiene. Il ritorno di Israele nella Palestina è allora la possibilità aperta di un nuovo abitare. In discussione non è la delimitazione della terra, ma il rapporto con la terra e con i suoi abitanti. È qui che si gioca la promessa di un nuovo abitare. Non si tratta di essere dominati, perché si può mantenere il principio dell’autonomia senza abdicare alla politica aperta all’estraneità. Piuttosto si tratta di abitare altrimenti. È in tal senso che il sorgere di Eretz Israel nel cuore della Palestina rappresenta uno scandalo intollerabile per tutte le nazioni, la minaccia di un superamento dello stato-nazione, l’apertura dunque di un nuovo ordine mondiale. Ma a ben guardare nell’assunzione dell’estraneità e nella possibilità di rilanciarla in una strategia dell’estraneità si decide la questione stessa dell’essere-ebrei oggi. 6. Che cos’è la “terra promessa”?
In ebraico la parola per “straniero” gher è connessa con il verbo “abitare” ghar. Abitare vuol dire allora restare pur sempre stranieri. Ma come si può abitare restando pur sempre stranieri? In altri termini: che cosa vuol dire, dopo l’esilio, il ritorno? Quale sarà il luogo elettivo del ritorno? E che cos’è la terra promessa? A questa domanda molto attuale si può tentare di rispondere risalendo alla Torah. Abramo lascia la sua città nativa non per errare nel deserto, ma per ritornare alla terra promessa, una terra ben più ampia di quella della sua origine, la terra elettiva sopravvenuta nell’appello all’esilio. L’esilio marca qui un risveglio della coscienza e Abramo sa dove viene e sa dove va, perché accetta il comando di andare in esilio – lech,
lechah! – per far ritorno. Il suo ritorno è una sorta di riparazione, la matrice di una ri-nascita di sé attraverso l’altro, e dell’altro da sé. Un’altra parola per ritorno può essere teshuvàh. Così l’esilio, mentre pratica l’accoglienza dell’estraneità in sé, forza l’altro ad accogliere lo straniero. In tal senso è già esperienza di ospitalità. Dopo l’esilio il ritorno non può essere un semplice rimpatrio, un ritorno a casa. L’esiliato ha scoperto infatti che il luogo di partenza era già un luogo d’esilio. Nel lasciarsi alle spalle l’origine si volge allora non verso il luogo di un radicato essere-presso-di-sé, ma a quello di un elettivo essere-presso-l’altro. Il ritornare a sé si rivela un andare verso l’altro. Il luogo non-luogo dell’origine che non c’è, che non c’è più, viene reinterpretato come luogo che non c’è ancora, ma che ci sarà, luogo che è oltre e altro, luogo a venire dell’altro, promessa che viene dall’altro16. Il luogo del ritorno è dunque
quello della promessa. 16 Cfr. D.E. Di Cesare, Esilio e globalizzazione, in “Iride” (54), 2008, pp. 273-286.
23
Ma non si tratta di una terra da possedere. La terra verso cui Abramo ritorna è la “terra promessa”, cioè una terra fatta di parole – se la promessa è anzitutto parola. Promessa non è allora la terra; promessa è la parola. Il che vuol dire che la terra nella sua mera fisicità non può essere il luogo elettivo del ritorno. Si dovrebbe riflettere qui su due espressioni importanti: adamàh, la terra nella sua fisicità, e aretz, quando diciamo appunto: Eretz Israel. Questo non significa per nulla che la terra del ritorno sia una terra immaginaria. La terra del ritorno è una terra concreta. Ma ciò che è nuovo è il rapporto con la terra che, in quanto è “promessa”, non è più appropriabile; è anzi inappropriabile. La promessa resta a interdire l’appropriazione della terra. Il momento del ritorno è sempre quello più difficile. Può indurre Israele a definire il futuro, a chiuderlo, limitarlo. E può spingerlo a regredire all’immanenza spaziale. In questa sorta di incipiente vita sedentaria Israele potrebbe essere portato a credere che la terra, quella terra dell’elezione, gli appartenga, che sia terminata la sua condizione di straniero, che la sua estraneità possa essere revocata da una nuova radicata identità. Perciò potrebbe non esibire disposizione all’ospitalità. Ed è certo in questo momento che potrebbe celarsi ogni violenza. Ma il popolo ebraico non può dimenticare di esser solo un ospite sulla terra, non può dimenticare la sua condizione di “straniero-residente”. È la Torah a ricordarglielo. A questo proposito Shmuel Trigano richiama alla memoria la levitizzazione della terra17. All’indomani dell’uscita dall’Egitto le tribù di Israele si dividono la terra promessa, ad esclusione della tribù di Levi che, dispersa tra le altre tribù, viene sostentata dalle altre e abita solo in alcune città chiamate città-rifugio. Il che vuol dire non solo che la terra promessa non può essere totalmente divisa. Di più: quando il popolo ebraico si insedia, preserva in sé, attraverso i leviti, la condizione dello straniero, mantiene quel principio di estraneità che impronta tutte le sue strutture politiche, economiche, religiose. Ai leviti spetta infatti la responsabilità dell’Arca dell’Alleanza e dunque della “tenda della radunanza” in cui dimora la Shekhinah, quella Presenza che non può mai essere presente e rinviando ad una Assenza impedisce il radicamento e ingiunge ogni volta il congedo. Lo statuto di “straniero-residente” non può non avere effetti sulla “città”, cioè sulla forma in cui dimora la comunità. Perché mettendo in questione il “proprio” e la “proprietà”, chiede una volta per tutte diritto di cittadinanza per l’estraneità. 7. Il resto di Israele
Israele rimane nel sistema internazionale della mondializzazione un resto inassimilabile che, come scriveva già Emmanuel Lévinas, ha irritato e irrita la sovrana autocoscienza 17 S. Trigano, Il terremoto di Israele. Filosofia della storia ebraica, trad. it. di A. Lissa, Guida, Napoli 2007, pp. 243-250.
24
delle nazioni stabilmente sostenute dalla incrollabile esperienza della terra nella loro salda affermazione di sé18. Come se, nel processo inarrestabile della mondializzazione ci fosse un resto che, nella sua estraneità, fa resistenza e si sottrae alla fusione. Ed è interessante che ciò avvenga grazie alla fondazione e dopo la fondazione dello Stato di Israele. A riprova però che lo stato applicato al popolo ebraico non può avere come risultato l’eliminazione dell’estraneità. Israele nella sua estraneità che trascende la storia dei popoli resta più che mai a testimoniare la necessità di un oltre della storia, la fedeltà alla sua attesa messianica, il ricordo del futuro, la rievocazione del mondo a venire, l’impellenza del ritorno a Sion. Ostacolo a qualsiasi tentazione totalitaria, Israele resta nella sua dissidenza originaria, resiste nella sua esigenza irriducibile di giustizia fatta valere nella storia del mondo. Ben più di ogni altro confine, è il suo bordo escatologico che Israele deve preservare. Più che mai la terra santa appare nella sua separazione una frontiera in cui, grazie a Israele, può dischiudersi l’a venire di un nuovo ordine del mondo. È questa responsabilità della sua elezione che attende Israele sull’ultima trincea della terra data per promessa. 18 E. Lévinas, Politica in subordine!, in id., L’aldilà del versetto. Letture e discorsi talmudici, trad. it. di G. Lissa, Guida, Napoli 1986, pp. 277-284, p. 279.
25
Anselmo Calò
Il sionismo chaluzista
Cosa intendiamo per Sionismo Chaluzzista? Haluzt in ebraico significa pioniere. Il Pioniere è colui che apre una via, l’esploratore di una nuova strada. Il Sionismo chaluzzista è quindi il sionismo delle avanguardie, di coloro che per primi giunsero in Erez Israel non appena si fece concreta la possibilità di ricominciare a reinsediarvisi. Naturalmente questi, per lo più giovani ebrei, donne e uomini, che decisero di emigrare dai loro abituali luoghi di residenza per una terra inospitale, ridotta arida dal lungo abbandono, basarono la loro determinazione su alcuni ideali. Nella seconda metà dell’ottocento, l’esperienza essenzialmente tedesca dell’Haskalà – l’illuminismo ebraico, cominciò ad affacciarsi anche nei territori zaristi, dove, fortemente concentrati nella fascia più occidentale dell’Impero, vivevano oltre cinque milioni di ebrei. I maskilim tedeschi, avevano annegato la propria identità ebraica nell’illusione che l’emancipazione avrebbe fatto di loro dei cittadini di fede mosaica. In realtà questo, nella maggior parte dei casi, significò una lenta ma inesorabile assimilazione. Nell’impero zarista, dove il sentimento etnico delle popolazioni era più fervido, alcuni pensatori ebrei esplorarono, alla luce dell’Haskalà, la possibilità di una moderna identità ebraica, dai contenuti popolari e nazionali, collegati non solo ai riti religiosi e all’osservanza delle mizvot, ma anche alla lingua, alla storia, e alla condizione sociale del popolo ebraico. Durante la Pasqua del 1881, dopo l’assasinio dello Zar Alessando II, furono scatenati a numerosi pogroms che continuarono fino al 1883. Queste violenze condussero coloro che già avevano cominciato a pensare in termini di nazione ebraica ad ipotizzare la creazione di un territorio autonomo per gli ebrei. Da questa necessità nacquero i circoli dei hoveve zion, degli amanti di sion, dei sionisti in poche parole. I primi haluzim che giunsero in Erez Israel all’indomani dei progrom del 1882 erano i frequentatori di questi circoli, che avevano trovato in Leo Pinsker il loro infaticabile leader, ma anche il loro principale ideologo. Pinsker aveva appena pubblicato un opuscolo intitolato Autoemancipazione Ebraica, con il quale prendeva atto che l’emancipazione che i governi, e non certo quello zarista, erano propensi a concedere agli ebrei, era in realta una via all’assimilazione, gli ebrei divenendo solo seguaci delle fede mosaica si de-nazionalizzavano, e perdevano tutte le caratteristiche di popolo che avevano conservato per quasi duemila anni.
26
L’alia del 1882 è definita nella storia del Sionismo prima alia, come è evidente essa precede di almeno un decennio l’iniziativa Herzliana, e ne possiamo sostenere che sia la prima esperienza assoluta del moderno ritorno ebraico verso la biblica Canaan.
Il Processo di indipendenza dei coloni delle Americhe dapprima gli Stati Uniti e poi nel sud America, avevano rilanciato all’inzio dell’800 la funzione strategica del medio oriente come ponte verso l’oriente, che diveniva la nuova frontiera del colonialismo europeo. In questa cornice va vista la napoleonica spedizione in Egitto, e l’interesse degli europei ad instaurare proficui rapporti con gli ottomani. Nel 1857, un diplomatico francese, Ernest Laharanne, aveva proposto a Napoleone III di favorire l’immigrazione ebraica in Palestina al fine di creare in quel terrirorio uno stato amico della Francia. Di li a poco cominceranno i lavori per il canale di Suez, che apriva una nuova via verso l’oriente. Negli stessi anni l’organizzazione ebraica francese Alliance Israelite, creava una scuola agricola a Miqve Israel, vera istituzione pionieristica per il reinsediamento ebraico in Palestina. Dante Lattes, descrive i Choveve Zion come “l’embrione di un movimento nazionale verso la Palestina”. Il 30 luglio del 1882 un gruppo di studenti universitari russi fondò non lontano dall’antica città di Jaffa, Rishon leZion, il primo yshuv . “Erano le anime – prosegue Lattes – conquistate già dalla propaganda Smolenski, Gordon, Liliemblum”. I giovani russi che fuggivano dai pogroms non andavano in Erez Israel, solo per salvarsi la vita, ma cercavano la strada per la creazione di una propria vita ebraica autonoma, volevano ripristinare l’uso della lingua ebraica, abbandonando l’yddisch,
intendevano creare una società ebraica, fin dalle fondamenta e pensavano che la ritualità religiosa, che pure aveva conservato il popolo ebraico attaccato alle proprie tardizioni non era più il valore centrale del loro essere ebrei, Il popolo ebraico avrebbe dovuto costruire la propria nazione e infine un proprio Stato. Il primo elemento di questa rinascita era la terra, disporre della terra, per creare quelle imprese che avrebbero costuito l’ossatura della società. Ancora prima dell’infaticabile azione poltica di Theodor Herzl, il movimento dei Biluim (dal motto biblico “Bet
Yaacov lechu venelechà”) cercarono un contatto con gli Ottomani, sostenuti dal governo francese ed inglese, volevano ottenere il beneplacito turco per le loro iniziative economiche, strinsero un alleanza con il Barone De Rothschild che lì forni non solo di capitali, ma anche di personale specializzato ad impiantare aziende agricole modello. L’organizzazione era tuttavia carente, la forza politica praticamente inesistente, le colonie erano isolate, e soprattutto il numero degli immigrati era esiguo. Per quanti olim arrivavano quasi altrettanti abbandonavano. Gli studenti russi, figli di quei pochi ebrei che avevano tentato l’uscita dall’ambiente ebraico verso la società circostante non avevano la forza fisica ne morale, per dedicarsi al duro lavoro agricolo. I pochi che restarono e riuscirono ad impiantare le prime attività economiche si avvalsero della popolazione locale. La loro impresa riproduceva le caratteristiche del colonialismo, che gli Stati europei conducevano in quegli anni in Africa ed Asia.
27
Gli ebrei dell’impero zarista nei successivi venti anni, continuarono a cercare di emanciparsi, lasciavano gli shtetl e la vita di sussistenza che questi potevano garantire, per dirigersi verso le città. La popolazione ebraica subiva l’evoluzione della società circostante, lo sviluppo industriale costituiva il miraggio di una vita migliore, gran parte degli ebrei appartenevano alla classe proletaria e pativano anche loro i limiti sociali e lo sfruttamento del capitalismo selvaggio di quegli anni. Le dottrine socialiste e progressiste attraevano i giovani ebrei, proporzionalmente dippiù dei gentili, anche i poveri ebrei avevano la solida cultura del heder, essi ritrovavano nelle enunciazioni di eguaglianza alcuni dei precetti biblici perciò ne venivano attratti. Gli ebrei costituirono perciò un loro partito operaio: il Bund che in quanto ebraico affianca alle istanze socialiste, una forte identità nazionale. Anche la seconda ondata di immigrazione ebraica in Palestina, si deve a fatti esterni: all’inizio del novecento l’impero zarista opprime tutta la sua popolazione e la pressione rivoluzionaria in Russia si fa via via, più forte. Molti giovani ebrei sono attivisti del movimento operaio e per questo sono tenuti sotto sorveglianza dalla polizia, per alcuni la fuga è la sola via d’uscita. Quando nel 1905 fallisce la prima rivoluzione, i giovani ebrei fuggono a migliaia. In realtà i militanti del Bund, all'inizio, sono tutt’altro che sionisti, la loro partecipazione alla vita politica russa denota una scelta, essi vogliono migliorare la società in cui vivono e pretendono che la nuova società socialista riconosca i diritti nazionali del popolo ebraico in Russia. Tuttavia alcuni militanti del Bund già hanno cominciato a sintetizzare le teorie socialiste con quelle sioniste, Nel 1900 nasce a Minsk il partito dei Poale Zion, il loro ideologo e Dov Ber Borochov, che effettua una rigorosa analisi marxista della condizione ebraica, concludendo che privi della disponibilità dei mezzi di produzione gli ebrei in Russia non potranno mai essere padroni del loro destino, e che quindi è gioco-forza che debbano crearsi un loro Stato ebraico in Palestina. La via dell’emigrazione rappresenta così una vera via d’uscita, questi giovani si sono formati una solida identità nazionale ebraica, la loro adesione ai movimenti progressisti ha affievolito il loro rispetto per l’osservanza rituale, ma non il loro sentimento d’appartenenza al popolo ebraico, e comprendono che la via sionista risponde appieno a tutti loro ideali, anzi la possibilità che hanno di creare una società dalle fondamenta li convince che potranno creare una società socialista. Intanto Thedor Herzl era riuscito ad interessare alla impresa sionista tutti i potenti della Terra, dopo francesi ed inglesi anche il Kaiser tedesco, che stava stringendo rapporti sempre più stretti coi turchi, appoggia l’immigrazione ebraica, l’idea sionista non seduce più solo gli ebrei russi, ma anche quelli più facoltosi e organizzati dell’occidente europeo. L’alia che comincia negli anni 1904-1905 può perciò contare su un quadro più sviluppato sia per la maggiore consapevolezza degli immigrati, sia del complessivo quadro politico.
28
Tra gli immigrati dei primi anni del novecento e quelli che li hanno preceduti, corre molto di più di una generazione biologica, in quei vent’anni che li separano c’è tutto un mondo di istanze e aspirazioni. Gli immigrati del 1882 vengono considerati borghesi dai nuovi arrivati, perché costituiscono una borghesia ebraica che domina su un proletariato arabo. E’ una situazione inacettabile per gli immigrati socialisti, essi vogliono creare una società ebraica egualitaria, appropriasi della terra per lavorarla direttamente, perché la terra appartiene a chi la lavora. Il lavoro fisico diviene quasi un dogma religioso la rinascita ebraica passa attravero la creazione di una classe di contadini ebrei. La teoria di Borochov è che la società ebraica diasporica è una piramide rovesciata priva della base di contadini e con un vasto ceto borghese; in queste condizioni, lo Stato ebraico potrà dare asilo a tutto il popolo solo se costituirà una società socialista I valori del sionismo per gli immigrati in Palestina, non sono più quelli dei seguaci di Herzl che aspirano alla creazione di uno Stato per gli ebrei, ma vanno oltre: In Erez Israel, si dovrà creare una società ebraica, laica e moderna, che fondi la sua legittimità sulla storia e le tradizioni del popolo ebraico, ma soprattutto che sia in grado di creare un nuovo tipo di ebreo completamente emancipato dai retaggi diasporici; che sia padrone del proprio destino e della propria esistenza; che faccia dello Stato ebraico una luce per le nazioni, forte del messaggio sociale millenario dei profeti di Israele e che perciò sia in grado di formare una società egualitaria basata sul lavoro. La popolazione ebraica in Palestina è tuttavia ancora fortemente minoritaria, l’acquisizione di terreeni che viene condotta dalle organizzazioni ebraiche sioniste è lenta e per certi aspetti inconcludente, la malaria che infesta le zone non aride limita fortemente il lavoro e i terreni più fertili sono di proprietà dei latifondisti di Damasco, Beirut e Istanbul. Gli anni che conducono alla prima guerra mondiale sono però gli anni in cui l' ebraico diviene la lingua parlata degli ebrei in Palestina, le organizzazioni sioniste sostengono economicamente gli immigrati, e la convivenza con la popolazione araba, eccetto alcuni casi specifici, risulta possibile. Le colonie agricole più vecchie si consolidano e alcune di nuove ne nascono. La prima Guerra Mondiale, come è noto, vede il dissolvimento dell’Impero ottomano e la spartizione dei territori periferici dell’Impero tra Francia e Regno Unito. Nel 1917 alla vigilia dell’ingresso delle truppe inglesi a Gerusalemme il governo di Sua Maestà Britannica ha rilasciato la famosa dichiarazione Balfour, che ha il duplice intento di creare un clima favorevole all’occupazione britannica della Palestina e di far esercitare da parte delle comunità ebraiche una pressione sulle potenze vincitrici affinchè venga affidato alla Gran Bretagna il mandato sulla Palestina (Come è noto una analoga dichiarazione fu rilasciata dal Governo Britannico a favore della dinastia Hashemita con le medesime intenzioni di facilitare l’ingresso britannico nel territorio)
29
La rivoluzione d’ottobre e il periodo controrivoluzionario che la segui, portò verso la Palestina altri immigrati ebrei, come quelli del decennio precedente, si trattava soprattutto di giovani ideologizzati, che intendevano creare in Erez Israel lo Stato ebraico socialista. Gli anni che vanno dal 1917 ai primi anni venti, coincidono con il consolidarsi dell’occupazione britannica della Palestina sono quelli che vedono la nascita delle prime organizzazioni ebraiche locali. Gli immigrati debbono ancora essere supportati dalle organizzazioni ebraiche internazionali, ma iniziano anche a creare le loro strutture un sistema scolastico e(col tempo sorgeranno diversi sistemi scolastici ebraici) con una connotazione politica molto netta. Cominciano anche a crearsi le prime comuni sociali ovvero i Kibutzim. i. partiti politici, e l’Histadruth l’organizzazione sindacale dei lavoratori ebrei. La parola d’ordine degli immigrati ebrei dei primi anni fu il kibusc adama cioè disporre della terra. Con la terra si poteva finalmente creare quel rapporto tra l’individuo e la natura, cioè il possesso del territorio, inoltre la terra è la risorsa produttiva primaria, il più importante mezzo di produzione come sostenevano i marxisti. Senza il possesso e il lavoro della terra non ci sarebbe mai potuto essere uno Stato ebraico degno di questo nome A partire degli anni venti un nuovo motto si diffonde tra gli olim il kibusc avodà,ovvero la disponibilità del lavoro. Tra gli olim della prima alià e quelli della seconda c’erà gia stato lo scontro per l’utilizzazione della mano d’opera ebraica, i padroni delle aziende preferivano la mano d’opera araba, meno politicizzata e quindi più buon mercato. La nascita del Kibutz fu una prima risposta, ma man mano che la popolazione ebraica cresceva, il problema del lavoro diventava più stringente. La creazione dell’Histadrut fu perciò la soluzione naturale a questa situazione. Così come la creazione delle leghe dei Kibutzim servì a pianificare le produzioni agricole e l’azione delle società d’acquisto della terra a programmare l’estensione del territorio disponibile, (cioè davano la risposta al Kibusc Adama) l’Histadrut serviva a dare la risposta al kibusc avodà.
Negli anni venti cominciano ad arrivare in Palestina immigrati ebrei da Paesi diversi degli ex-.territori zaristi, l’idea sionista era ormai consolidata, dal punto di vista politico, organizzativo e ideologico. Un embrione di società ebraica si profila in Erez Israel, e la creazione del Vaad Leumì cioè l’assemblea nazionale e l’agenzia ebraica costituiranno i pilastri dell’organizzazione statale quando nel 1948 nascerà lo Stato. Chi sono perciò i Haluzim ? Sono tutti coloro, che sfidando le peggiori condizioni climatiche e di lavoro che il reinsediamento in Erez Israel comportava, si stabilirono tra il 1882 e la fine degli anni ’30 in Palestina, furono coloro che dissodarono la terra, coloro che vollero creare una società ebraica, prima ancora dello Stato, che abbandonarono l’idea iniziale di uno Stato per gli ebrei e posero le basi per uno Stato ebraico. Sono coloro che cercarono di costruire una società egualitaria sono coloro che aprirono la strada al medinat Israel quando nel 1948 nacque.
30
Shlomo Avineri, ha ricordato nel suo discorso celebrativo a Basilea per il centenario del primo Congresso sionistico, che lo Stato d’Israele pote nascere perché l’abitudine degli ebrei ad organizzarsi in comunità nella diaspora aveva permesso loro di organizzare in Erez Israel strutture sociali già molto prima della creazione dello stato Lo Stato pote nascere perché i halutzim ne avevano creato tutte le strutture.
31
David Meghnagi
L’inseguimento della “normalità”
“So che tutti voi in Israele, o almeno molti di voi, prendete questo con calma, qualcosa di questa calma, tu lo sai, si è anche trasmessa a me, ma devi sapere- ciò che certo sai già- che il mio pensare a Israele è un temere per Israele”
P. Celan a I. Shmueli, Lettera del 4 novembre 1969.
Prologo
Nell’affrontare la questione ebraica, il sionismo ha avuto il merito di porre la questione ebraica in termini politici. Il problema ebraico era per i padri fondatori del movimento sionista in primo luogo politico. Il guaio è che anche il conflitto d’aspirazioni con i popoli arabi, che nei primi decenni del secolo, che si è chiuso, prendevano coscienza della loro identità nazionale, era politico.
Parafrasando le parole che Babel mette in bocca al figlio del rabbino né L’Armata a
cavallo, per evitare che il conflitto d’aspirazioni nazionali arabe ed ebraiche assuma valenze tragiche occorreva che gli Stati che si contendono le spoglie dell’impero ottomano, avessero a cuore realmente il bene degli ebrei e degli arabi, e non fossero invece spinti da una logica di spartizione e di dominio. Occorreva che tutti si comportassero da “persone per bene”: che ogni essere umano vegliasse sui destini del suo prossimo, ogni popolo avesse a cuore le sorti dell’altro. In un mondo del genere gli ebrei di Europa non avrebbero dovuto far fronte alle persecuzioni, non sarebbero stati costretti a emigrare per evitare lo sterminio.
In un mondo di gente per bene il sogno del ritorno sarebbe forse rimasto appannaggio della memoria religiosa, affidato alle speranze future del genere umano. Questo mondo esiste purtroppo soltanto nella fantasia dei poeti, nelle aspirazioni profonde dell’umanità a una vita pacificata, non nella dura realtà delle relazioni fra i popoli e gli Stati. Gli israeliani della vecchia generazione, amano ancora soffermarsi sugli scopi originari del sionismo. L'idea maggioritaria era di andare dove non ci fossero arabi, luoghi desertici in cui creare un'esistenza nuova, per rinnovare la vita ebraica e non entrare negli spazi degli arabi19. E’ stata questa la ragione prima della scommessa sionista. Senza questa scelta il movimento non avrebbe potuto creare le basi di una società ebraica. 19 Cfr. D. Meghnagi, Dialoghi con A. Yehoshua, cit.; Meghnagi/ Yehoshua, Gerusalemme, la scrittura e la guerra…”, in “La primavera di MicroMega”, n 4, febbraio 2001, pp. 45-52.
32
Il conflitto con le aspirazioni del nazionalismo arabo potevano essere attenuate, ma non eliminate. Si trattava di un conflitto politico, non di una questione di buon vicinato. Il sionismo rappresentava una pagina nuova, un voltare pagina, un cambiare alle radici alimentato dall’incontro col deserto. Vivere nel deserto era una terapia dell’anima contro la vita sedentaria della diaspora e le sue nevrosi. Il deserto era un ritorno ai grandi spazi di libertà contro i luoghi bui e angusti delle zone di residenza coatta dell’impero zarista. Scopo del sionismo era dare una patria agli ebrei, non di opprimere gli arabi, o di occupare le loro terre. Su quei territori disabitati c’era spazio per entrambi, almeno è così nei sogni di chi emigra, sacrificando ogni comodità alla dura vita delle paludi. Il movimento sionista si afferma in aperto conflitto con l’ortodossia religiosa. Nella diaspora, come a Gerusalemme, si trattava di una frattura con il mondo della tradizione, ma il rapporto con la dimensione religiosa e simbolica della città prima o poi sarebbe tornato a galla, il rapporto con la tradizione religiosa, parzialmente rimosso, irrompeva con forza nella scena politica. Il sionismo aspirava a fare degli ebrei un popolo “come gli altri”, a edificare uno Stato ebraico “come gli altri”. Lo Stato degli ebrei serviva a normalizzare le condizioni di vita ebraica, superare “la malattia” della vita diasporica, come se fosse esistita per davvero “una malattia ebraica” da curare e non fosse invece il mondo a essere divenuto ad un certo punto folle oltremisura. L’esito solo in apparenza paradossale di questa impresa è stato di avere uno Stato “diverso” dagli altri, giudicato secondo parametri che non si applicano a nessun altro Stato. L’accusa di anormalità si è trasferita sull’unico Stato che deve la sua nascita a una decisione delle Nazioni Unite. Unico fra gli Stati, Israele è chiamato a giustificarsi non per quel che realmente compie, ma per quello che è. Lo Stato degli Ebrei è diventato l’Ebreo degli Stati e gli ebrei i suoi ambasciatori, non solo agli occhi degli antisemiti vecchi e nuovi, dichiarati o camuffati, ma anche degli amici sinceri. Lo Stato che doveva renderne l’esistenza più sicura, il che è accaduto, è oggi la fonte della preoccupazione di ogni ebreo. È il suo roveto ardente, il richiamo del Sinai che lo insegue, quanto più ne fugge. Un richiamo che prima o poi arriva, anche per i più tiepidi e lontani, che sono costretti a riscoprirsi ebrei per evitare il collasso morale.
L’inseguimento della “normalità”
Ricordare agli israeliani la scelta di De Gaulle è un topos che inchioda gli israeliani in uno stereotipo che per gli europei è tranquillizzante. Soprattutto per le sinistre che possono guardare al conflitto con gli occhi del passato coloniale europeo. In questa logica tutto appare semplice. Se gli israeliani si ritirano, come i francesi hanno fatto prima in Algeria, “si salvano” l’anima e ritrovano la sicurezza e le amicizie perdute. L’accostamento è in realtà fuorviante.
33
In realtà i francesi poterono illudersi di poter chiudere definitivamente i conti con l’Algeria perché c’era il mare a separarli. Il mare, almeno così speravano, rendeva possibile la chiusura di una pagina storica intrisa di sangue: dieci anni di guerra con un milione di algerini morti e un milione di francesi rientrati in patria. Se avessero avuto il mare come la Francia a separarli dai “territori”, gli israeliani non avrebbero atteso come i francesi a separarsi dagli arabi. L’accostamento dei dilemmi di Israele con quelli sperimentati dalla Francia al tempo della guerra d’Algeria, è fuorviante. Più che chiarire confonde. È parte di un pregiudizio che guarda a Israele con le lenti del colonialismo europeo e della lotta anticoloniale afroasiatica. Ma anche prendendo per buono il parallelo, non vi è nulla che giustifichi l’accostamento. A differenze che per la Francia in Algeria, gli israeliani non hanno un mare che li separi dai vicini. A nord come a est e a sud gli israeliani sono circondati da un universo ostile. Gli israeliani non hanno un territorio profondo in cui ritirarsi, né un mare che li separi. Vivono per oltre la metà in una striscia di terra che può essere facilmente colpita. Il territorio è piccolo e per metà desertico. A separare gli israeliani dagli arabi non c’è né un mare, né un fiume, né una montagna. Il mare alle spalle non li riporta a casa, è solo una via di fuga verso un mondo da cui i padri fondatori sono fuggiti per ricostruirsi una vita, l’unica a disposizione nel caso di una nuova catastrofe. Dopo ogni vittoria il loro nemico è più numeroso e agguerrito. La prima sconfitta rischia di essere l’ultima. Il Giordano separa i palestinesi dai Giordani e non dagli israeliani. Il Golan è un altopiano da cui i siriani controllavano sino al ’67 la Galilea, costringendo i bambini dei kibbutz della valle a vivere dentro i rifugi. Da nord e da est il territorio plana verso il mare. A ovest, Tel Aviv è nel punto più basso rispetto a chi viene da oriente. Il deserto del Negev, situato a sud, al quale Ben Gurion aveva guardato come a una nuova frontiera, è situato in una zona arida e desertica. Oltre il mare vi è l’occidente da cui i padri fondatori sono fuggiti, avendo come unica loro ricchezza i loro sogni di una vita diversa. Singolarmente presi, gli israeliani avrebbero in Occidente grandi possibilità di farsi strada e avere successo. Ora che è più facile spostarsi, avendo un parente oltremare, contando sulla solidarietà degli ebrei della diaspora, o semplicemente sulle proprie capacità, basterebbe partire per ricominciare una nuova vita altrove. Ma la soluzione individuale, se seguita in grandi numeri, potrebbe rivelarsi letale per la sopravvivenza del loro paese. Contando sulla “propensione diasporica” degli ebrei, il terrorismo vuole rendere la vita ebraica talmente insopportabile in Israele da spingere una parte consistente dei suoi abitanti a cercare altrove una condizione di vita migliore e più accettabile, a cercare una soluzione individuale ai problemi che nel lungo periodo si tradurrebbe nella vittoria di chi vorrebbe la fine di Israele. Mezzo milione di israeliani vivono fuori dal loro paese. Una nuova diaspora ebraica con caratteristiche proprie, si è aggiunta a quella più antica, al punto che il Dipartimento dell’Agenzia ebraica preposto all’immigrazione, ha creato un apposito distaccamento per “i rientri”.
34
La diaspora israeliana è composta di cittadini che vivono e lavorano all’estero, ma votano come gli altri cittadini israeliani e sono chiamati a compiere il servizio militare. Sono cittadini americani o europei, ma anche israeliani. Fintanto che la bilancia migratoria pende a favore degli arrivi, queste partenze possono essere messe in conto come parte di un processo di “normalizzazione” della vita di un paese. Il discorso cambierebbe se le partenze dovessero cominciare a superare gli arrivi e se i turisti ebrei dovessero diventare riluttanti a portare i figli in vacanza per paura degli attentati, come è accaduto in parte con l seconda Intifada. Ed è a questo che principalmente puntano gli attentati indiscriminati contro i civili. Non potendo piegare Israele militarmente, si cerca di renderne la vita impossibile. Contando sulla propensione “diasporica”, si rendono meno appetibili gli arrivi e individualmente più desiderabili le “partenze”. Il resto arriverebbe come esito di una “guerra biologica” apertamente dichiarata. Nell’inseguimento della normalità, il premier Barak non trova di meglio che portare con sé durante le fallimentari trattative di Camp David, il libro di Alistair Horne sulla guerra d’Algeria. Ben Amì, che lo accompagna, il libro di Kissinger sul congresso di Vienna20. In realtà l’anomalia ebraica, che il sionismo voleva superare, sta diventando un tratto caratterizzante delle società odierne più avanzate dove gli immigrati s’integrano nelle nuove società conservando legami profondi con le società d’origine. I francesi algerini non hanno fatto in tempo a rientrare nei loro confini, che le loro città si “sono riempite” di tunisini, marocchini e algerini e cittadini provenienti dai territori francesi di oltremare. Quaranta anni dopo la guerra di Algeria il rapporto demografico fra “metropoli” e “periferia” si è rovesciato: un decimo della popolazione francese è oggi composto di cittadini immigrati o figli d’immaginati da quei paesi che il colonialismo francese ha abbandonato per motivi giusti e sacrosanti. L’Algeria rispedì a casa un milione di coloni francesi, cui seguirono gli ebrei che coloni non erano, e avrebbero avuto diritto di ben altro trattamento da parte di un paese in cui vivevano prima delle invasioni arabe. Ma insieme e dopo partirono in cerca di una vita diversa, in numero oltremodo superiore i mussulmani. Lo scontro che prima si svolgeva nelle periferie dell’impero, si è trasferito nelle periferie delle metropoli europee. Per uno dei tanti paradossi della storia, la separazione vagheggiata da De Gaulle è stata solo temporanea. A cambiare è stato il vettore e la direzione. Non era più l’Europa a scaricare sulle colonie la sua manodopera in eccesso, ma al contrario le ex colonie, divenute indipendenti, a riempire le periferie delle metropoli europee con la sua popolazione più giovane. La sinistra europea che per decenni ha creduto di dare agli israeliani lezioni di convivenza, scopre con smarrimento che l’Europa è per molti versi indietro in fatto di tolleranza e rispetto a un paese di appena ventuno mila chilometri quadrati, dove i confini attraversano la capitale e lambiscono la periferia della più grande città. Il nord 20 Alistair Horne (1979), Storia della guerra d’Algeria. 1954-1962, Milano, Rizzoli, 1980. Penguin Books, New York; A World Restored: The Politics Of Consarvatorism in a Revolutionary Age di Kisisnger. Cfr. Sh. Ben Amì, (2005), Palestina, la storia incompiuta (la tragedia arabo israeliana), Roma, Il Corbaccio, 2007, p. 10.
35
del paese è n Israele per il quaranta per cento abitato da arabi. Il sud è desertico e di fatto inabitabile.
Il conflitto mediorientale verso cui gli europei hanno guardato per lungo tempo da spettatori, indifferenti o schierati con una delle parti, si è di fatto trasferito nel cuore dell’Europa. Uno sguardo alle principali città centro europee dimostra che la “questione mediorientale”, in quanto problema di convivenza e di rapporti fra identità diverse, è ormai una questione europea. Se la convivenza fra culture e religioni dovesse fallire in Europa, e ci sono buone ragioni per cominciare a temere, non si vede come possa essere declinato nella regione mediorientale un futuro di pace21
Quanto a Israele, per un gioco di paradossi, il paese che avrebbe dovuto radunare gli ebrei che fuggivano, ha cominciato col radunare anche i figli di chi li aveva espulsi dall’Europa. I nonni erano emigrati dai loro paesi di origine nei pesi dell’est Europa per sfuggire ai pogrom. Emigravano sognando di lasciarsi per sempre il mondo i cui erano nati e di cui portavano la nostalgia nei canti e nella musica. I nipoti dei contadini che erano aizzati contro i loro avi, li raggiungono oggi dopo il tracollo del comunismo andando a riempire i vuoti lasciato dai lavoratori arabi dei territori.
Cinquanta anni fa i lavoratori salariati e le domestiche nelle case della borghesia e dell’intellighenzia israeliana, nella quasi totalità di origine hashkenazita, erano ebrei di origine afroasiatica. I pacifisti e gli illuminati occupavano la parte più alta della società mentre “i guerrafondai” erano quelli che occupavano la scala sociale più bassa. La sinistra israeliana di matrice europea poteva dirottare sulla tragedia dei profughi palestinesi, il senso di colpa verso gli ebrei meno fortunati dell’oriente arabo destinati ai lavori più umili. Il lamento per i diritti negati alla minoranza araba delle fasce progressiste della popolazione, si coniugava col diniego dell’amaro destino delle centinaia di migliaia d’immigrati dai paesi arabi, senza le quali lo Stato sarebbe collassato per mancanza di una popolazione ebraica sufficiente. Anche per questo forse alla polemica araba sui profughi, gli israeliani non seppero, o non vollero contrapporre il racconto degli ebrei fuggiti dai paesi arabi. Eppure la questione degli ebrei dei paesi arabi, era la chiave per riportare la discussione politica sul Vicino Oriente ad un minimo di razionalità nel conflitto che oppose mussulmani e induisti milioni di persone sono passate dal Pakistan all’India e viceversa. A nessuna persona seria di mente verrebbe oggi di chiedere il ritorno alla situazione precedente, di far tornare i profughi indù nelle terre divenute pakistane e i profughi mussulmani in quella che è poi diventata l’India. Eppure è ciò che accade nel Vicino Oriente, contro ogni ragionevole considerazione umana e politica.
21 Francia, Inghilterra e Germania, ma anche Italia, Spagna e altri paesi industrializzati sono oggi la meta di chi emigra o fugge per disperazione al tracollo di ogni speranza di vita nel proprio paese. La popolazione del Nord Africa e del Medio Oriente oggi attorno ai 338 milioni, salirà a 537 milioni nel 2025. Da quest’area del mondo giungeranno nell’Unione Europea nei prossimi venti anni dai seicentomila al milione di immigrati per anno. La popolazione di origine islamica oggi attorno ai venti milioni salirà a quaranta nei prossimi due decenni e con essa il tasso di provenienza dall’Africa del Nord e dal Vicino Oriente. Cfr. M. Massari, “L’Europa alla ricerca di un ruolo”, in Aspenia, rivista di Aspen Institute Italia, A, 12, n. 37, 1007, pp. 184-192.
36
La Diaspora come “nemesi”
Come altri scrittori israeliani della sua generazione il rapporto di Yehoshua con la scrittura è molto intriso di passioni etiche e politiche, né potrebbe essere diverso in un paese dove la lotta per la sopravvivenza è un elemento costitutivo dell’identità. La posizione più volte ripresa nei suoi scritti è tipo militante e lascia poco a una lettura diversa e più articolata della storia ebraica. A poco serve ricordare la semplificazione di un processo storico, il soggettivismo estremo dell’argomentazione che porta a sottovalutare il fatto che lo stesso ritorno evocato dal sionismo, con il progetto “impossibile” di ricreare una vita nazionale indipendente nella terra dei padri, nel contesto di un’ostilità generalizzata e di un tragico conflitto d’aspirazioni nazionali, non poteva che essere di pochi idealisti. Si trattò all’inizio di poche centinaia di persone, disposte a un sacrificio estremo, che hanno cambiato il corso della storia ebraica. L’arrivo di grandi masse di popolazione come minimo avrebbe richiesto la creazione delle infrastrutture necessarie per accogliere gli immigrati e fornire loro le condizioni minime d’esistenza. A poco serve notare l’unilateralità di una visione puramente negativa della Diaspora e della sua storia millenaria, con le sue creazioni durature. L’unilateralità della rappresentazione è parte di una visione ideologica, storicamente datata, propria di una fase del dibattito all’interno del movimento ebraico di emancipazione che identificava negativamente la diaspora col vuoto dell’esilio e della dispersione. A poco serve ricordare che tale rappresentazione negativa ha non pochi elementi in comune con le ideologie del rifiuto antiebraico e i miti che la fondano. Analogamente a quanto è avvenuto in altri processi di riscatto e di rinascita contro le oppressioni subite, l’unilateralità con cui si negava il valore della diaspora, si nutriva degli ingredienti dell’ideologia che ha per secoli oppresso ed escluso gli ebrei. Il desiderio di Yehoshua di riscrivere all’infinito il suo elogio della normalità22, lo porta a fantasticare un impossibile ritorno a ritroso verso un passato premonoteista che fa tabula rasa dell’intera storia del Giudaismo e che nei fatti rovescia in negativo i valori più duraturi dell’Ebraismo: la rottura con l’idolatria e coi culti della terra e dello Stato23. Il profeta Moshe avrebbe dovuto farsi costruire una grande tomba che lo ricordasse, rendendo così più difficile ai suoi seguaci abbandonare il proprio paese e lasciare incustodito il suo sepolcro. Rabbì Yochanan che dopo la catastrofe del Secondo Tempio, salvò il Giudaismo dall’estinzione costruendo una scuola a Yavneh, avrebbe dovuto fissare il minian, il numero degli ebrei necessari alla preghiera, “a mille o a duemila, anziché dieci, per evitare una facile dispersione”, Moshe bar Maimon (Maimonide), avrebbe dovuto supplicare “il Saladino, che non nomina nelle sue opere”, ma di cui era il medico personale, “di permettere agli ebrei di stabilirsi nella terra dei loro padri da lui appena conquistata”, oppure “vi si sarebbe dovuto trasferire egli
22 Cfr. Yehoshua , Elogio della normalità. Saggi sulla diaspora e Israele, cit. 23 Cfr. A. Yehoshua, Antisemitismo e sionismo. Una discussione, Torino, Einaudi, 2004, pp. 59-61.
37
stesso”. Quanto ai persecutori di Shabbatai Zwi, il falso messia di Smirne, forse avrebbero rivisto la loro posizione, mentre Rabbi Nachman di Breslav, avrebbe superato le sue paure e non sarebbe fuggito da Israele dopo esservi giunto24.
Se c’è una descrizione irreale della condizione umana, è questa rappresentazione estrema di soggettivismo applicato all’intera cultura della Diaspora, colpevole di restare nel guado sospesa tra attaccamento alle origini nazionali, il cui nocciolo duro sarebbe stato conservato dalla tradizione religiosa, e una vocazione diasporica che il sionismo non è riuscito a estirpare e che alla lunga potrebbe minare i risultati conseguiti. Identificata come “anomalia” e “malattia” da curare, la Diaspora assume il significato di una nemesi potenzialmente distruttiva. Israele, scrive Grossman, sta “riproducendo e ricostruendo” nel rapporto con gli arabi, una delle “più tenaci anomalie che hanno caratterizzato il popolo ebraico nella diaspora, e la tragedia della sua esistenza negli ultimi due mila anni”.25 A parte l’inapplicabilità del paragone, le equazioni false che veicola, il confine che dovrebbe “separare” non esiste purtroppo per cause storiche e politiche ben più profonde, e non per la propensione diasporica degli israeliani che “mescolandosi con gli arabi”, come erroneamente affermano Grossman e Yehoshua, riprodurrebbero le loro più antiche “anomalie”. Il soggettivismo necessario e vitale per affrontare le terribili sfide cui è andato incontro il paese, può incontrarsi con il pregiudizio di chi amplifica il potere degli ebrei di influenzare le sorti del mondo. Sfortunatamente per Israele e per gli ebrei, non è così ed è Grossman a riconoscerlo quando fa sua l’invocazione che si recita nella preghiera di Musaf di Sabato (“Oh Signore, che tu possa piantarci entro i nostri confini”)26. In realtà la mancanza di radicamento degli israeliani non nasce dalla volontà di espandersi o dall’incapacità di liberarsi da una cultura diasporica contrassegnata dall’assenza di confini. Nasce da un’impossibilità strutturale dal sapore kafkiano che ha come sfondo il rifiuto dell’esistenza di uno Stato ebraico nella regione. Le spinte annessioniste che si sono determinate dopo la guerra del giugno 1967, con la conseguenza rottura della cultura dei limiti che la leadership sionista si era saggiamente imposta nei primi decenni del movimento, non sono state la conseguenza di una conservazione dello spirito diasporico, come in modi diversi e contradditori sembrano avallare Yehoshua e Grossmann. Non sono nemmeno il risultato dell’essere diventati stato, come ritiene chi oppone al sionismo lo spirito di una condizione diasporica idealizzata. Di là degli errori di scelta e di condotta politica, giudicabili sul terreno della politica come arte del possibile, sono il risultato delle impossibilità regionali e internazionali che si sono moltiplicate e aggravate nei decenni. La mescolanza di arroganza e di paura di cui sono accusati gli israeliani, è il frutto di una situazione in cui gli errori di prospettiva si mescolano con l’impossibilità di soluzioni realmente praticabili.
24 Ibid., pp. 59-61 25 D. Grossman, Israele, la Shoah e il futuro, in “la Repubblica”, 2 marzo 2007, pp. 1 e 53.
26 Ibid.
38
Unico stato al mondo che deve la sua nascita a una votazione dell’Assemblea delle Nazioni Unite, Israele è lo stato che ne ha subito il numero più alto di condanne. Che a votare le condanne siano in maggioranza delle dittature e degli Stati di polizia, che possono a turno rappresentare le proprie aree regionali può essere una magra consolazione dal sapore masochistico.
Il processo di rinascita e di costruzione di una vita nazionale indipendente, non è avvenuto nel vuoto, ma nel cuore delle temperie storiche di cui si è nutrito. La terra promessa non era purtroppo disabitata e il ritorno ebraico non poteva che accelerare il processo di coagulo nazionale arabo in chiave antiebraica, ponendo le basi per la nascita di una nazione araba palestinese. Consapevole delle implicazioni di talune sue affermazioni che ricalcano, anche se con obiettivi opposti non pochi luoghi comuni dell’antisemitismo europeo, Yehoshua si guarda bene dal giustificare la patologia dell’antisemitismo con le nevrosi della diaspora. Il suo obiettivo è di togliere gli ebrei dalla loro posizione pericolosa. Le ricostruzioni specifiche delle diverse manifestazioni dell’antisemitismo non rientrano nella sua analisi e non la contraddicono. Sono gli aspetti di una vicenda che affonda le sue cause in un vizio di origine dovuto all’incapacità di sciogliere la religione dalla nazione. Per spiegare gli esiti cui è andato incontro il progetto sionista, Yehoshua è costretto a spostare l’aspirazione alla normalità ebraica a un’epoca precedente su cui si è invece fondata la retorica del sionismo1. Secondo questa contorta logica, per tornare normali gli ebrei dovrebbero annullare non solo gli ultimi due mila anni della loro storia, ma anche i secoli che precedono la distruzione del Secondo tempio. La sospirata normalità andrebbe ricercata nel superamento dell’operazione condotta da Esdra nell’esilio babilonese e che rese possibile la sopravvivenza degli ebrei come gruppo anche senza uno Stato proprio. Ciò che l’autore non riesce però a dirci, è per quale motivo gli ebrei dovrebbero farsi Stato e nazione, se l’obiettivo è l’assimilazione come gruppo. Non sarebbe più semplice assimilarsi come singoli, perdere la propria identità e cancellarsi come gruppo? Non era poi questo che era loro richiesto contraddittoriamente da chi ne stigmatizzava la diversità? Se l’obiettivo del sionismo era di fare degli ebrei un popolo come gli altri, non era più semplice e salutare rinunciare a ogni progetto e aspirazione nazionale? Non sarebbe più onesto affermare che la nascita di Israele, è stata una tragica necessità, ben più profonda e necessaria delle rappresentazioni che vi hanno fatto da sfondo e che i problemi posti dalla secolarizzazione, che prima gli ebrei hanno dovuto all’interno di una cornice comunitaria, si propongano ora all’interno di una cornice statale con tutto ciò che questo comporta? La crisi che investe la società israeliana ha qui uno dei suoi nuclei di origine profondi. A parte la tragedia del conflitto col mondo arabo e islamico, la vera grande sfida sta nella capacità di far convivere senza eccessive tensioni le diverse anime del Giudaismo. Nonostante lo sforzo dei padri fondatori, la società israeliana somiglia a un coagulo di comunità, che a una realtà omogenea e indifferenziata. È questa una delle sue ricchezze.
39
Accanto a quel che resta sul piano mitologico dell’ebreo nuovo, le vecchie polarità non indicano un fallimento. Sono piuttosto un’anticipazione di molti dei problemi con cui l’Europa apprende solo ora a confrontarsi, con la crisi dello Stato nazionale, il riemergere dei vecchi particolarismi e il cambiamento demografico indotto dai flussi migratori e dalla crescita esponenziale delle minoranze arabe e islamiche in Europa. La società israeliana ha anticipato molti aspetti della società post moderna. Le tradizioni comunitarie un tempo svalutate in nome dell’ebreo nuovo, si sono riprese una rivincita e la possibilità di vincere un’elezione si misura ormai con la capacità di rispondere ai richiami e alle rivendicazioni dei singoli gruppi comunitari (sefarditi e hashkenaziti, ebrei di origine russa e di origine marocchina ecc). Più che una società “anormale” che dovrebbe adattare i propri standard a quelli europei, somiglia a un laboratorio postmoderno che ha sperimentato in profondità e con molto anticipo molti dei problemi che assillano oggi l’Europa.
A non accorgersene sono gli europei che dopo avere lungamente preteso di impartire lezioni agli israeliani sulla convivenza tra popoli diversi, scoprono con angoscia di non essere per niente avanti in fatto di tolleranza, e che molti dei problemi che pensavano di essersi lasciati per sempre alle spalle si sono violentemente riaffacciati, mostrando quanto fragili siano le costruzioni umane.
Consapevole delle implicazioni potenzialmente pericolose del suo discorso per l’esistenza di Israele, Yehoshua non intende però mettere direttamente in pratica il suo programma. La sua è un’indicazione per il lungo periodo, che toccherà alle generazioni future affrontare. “Lo scioglimento del vincolo tra religione e nazionalità, si legge nella pagina conclusiva, è un processo complesso, che comporta un’analisi interiore articolata e difficile, che incontrerà un’opposizione feroce e dovrà essere condotto con lentezza e cautela per non sgretolare l’essenza stessa della nostra identità. Tuttavia questo processo potrebbe portare gradi benefici e aprire nuovi orizzonti, così com’è successo duecento anni orsono allorché fu riconosciuta la legittimità dell’ateismo degli ebrei. Quindi anche se dovesse protrarsi per moltissimi anni, vale la pena di iniziarlo a più presto e, per lo meno, di cominciare a pensarci”.27
La strada da percorrere appare quella dell’assimilazione come gruppo, anziché come singoli. In prospettiva la soluzione del problema starebbe nella riduzione dell’ebraismo diasporico a una minoranza religiosa, fra le tante (era del resto questa una delle prospettive aperte dalla riforma), e in Israele nella scelta ebraica (‘ivri) contro quella giudaica (yehudi’.)28 In entrambi i casi, gli ebrei cesserebbero di esistere e con loro anche la “questione ebraica”. Nella Diaspora tutto ciò avverrebbe mediante l’assimilazione dei singoli. In Israele attraverso ad un processo di assimilazione gruppale in cui la dimensione religiosa del Giudaismo sarebbe sostituita da quella nazionale (ma l’Ebraismo non si è
27 Yehoshua, Antisemitismo e sionismo, cit., pp. 89-90. 28 La distinzione manca nella lingua italiana, il che è all’origine di molti equivoci.
40
mai religiosamente declinato come nazione nel senso classico del termine)29. Gli ebrei cesserebbero di essere giudei per diventare solo ebrei svincolando con ciò la condizione di appartenenza nazionale da quella religiosa, un po’ come avveniva nel regno di Israele in contrasto con quello di Giuda. L’aspetto bizzarro di quest’argomentazione è che gli ebrei del Regno di Israele sparirono come nazione con la sua caduta, molti secoli prima delle distruzioni operate dalle legioni romani, alimentando nel corso dei secoli il mito delle tribù perdute. Al contrario gli ebrei del regno di Giuda furono gli unici a conservarsi perché ebrei, nonostante le distruzioni e le persecuzioni. Per vie opposte il sionismo militante di Yehoshua, con i suoi tratti “cananei” alla Ratosh30, s’incontra nei fatti con quello delle frange antisioniste estreme e dei movimenti d’ispirazione comunista, che ha dato vita negli anni Sessanta al gruppo del Matzpen e alle sue diramazioni di matrice trockista31. Yehoshua non si chiede se in nome del suo elogio della normalità, non fosse più coerente, come normalmente facevano, gli assimilazionisti più conseguenti, chiedere all’Ebraismo di annullarsi come tale nella Diaspora, e non come egli auspica facendosi prima nazione con un proprio Stato. Non si capisce, infatti, per quale ragione gli ebrei della Diaspora avrebbero dovuto conservare la loro identità lungo i secoli se la prospettiva era un’assimilazione collettiva al posto di un’individuale.
Coloro che nel passato avevano fatto la scelta che Yehoshua sostiene oggi, custodire i sepolcri e adorare le divinità locali, hanno cessato per primi di esistere come ebrei. Accettando di far parte delle “maggioranze compatte” si sono unite alle maggioranze che opprimevano le loro minoranze. In ogni generazioni gli ebrei si sono dovuti confrontare con questa tentazione32. Se doveva essere questo l’esito del sionismo, e non è escluso che ciò possa accadere, vi sarebbe un che di grottesco. Verrebbe da chiedere a Yehoshua perché condannare alla gogna chi ha scelto di restare nella Diaspora? Non sarebbe meglio lasciarli in pace, non inseguirli culturalmente come ha poi fatto Israele per costruire un anello più ampio di appartenenze e solidarietà che la proteggesse dalla deriva del conflitto col mondo arabo? Perché riportare in vita, le paludi, dissodare il deserto se l’obiettivo era la fine del popolo ebraico? Per complicare ulteriormente la vita agli ebrei e a palestinesi, che il sionismo delle origini immaginare di poter integrare nella nuova nazione ebraica, salvo poi escluderli nella realtà drammatica in cui si è svolto il processo di costruzione di una presenza ebraica in Palestina? Dovremmo forse concludere, e c’è purtroppo chi lo sostiene, che il sionismo è responsabile di una nuova
29 Cfr. la rivisitazione che ne fa da una prospettiva opposta e problematica M. Susman (1946), Il libro di Giobbe e
il desino del popolo ebraico, a cura di G. Bonola, Firenze, Giuntina, 1999. 30 Jonathan Ratosh, pseudonimo di Uriel Halperin, nato in Russia nel 1908, morì nel 1941. Elaborò l’idea di un
distacco dal giudaismo a favore di una prospettiva Cananea. Da una matrice cananea parte la riflessione di Uri Avneri per il superamento della natura sionista dello Stato di Israele Cfr. Uri Avneri, fondatore del periodico Ha’olam Hazeh, autore Israele senza sionisti, Torino, Einaudi, 1974.
31 Formazione di estrema sinistra israeliana. Sulla storia del Matzpen cfr. D. Meghnagi, La sinistra in Israele
(storia ideologia prospettive), Milano, Feltrinelli, 1980 32 Cfr. S. Freud (1924), Le resistenze alla psicoanalisi, in OSF, vol. X, pp. 45-58. Col riferimento a questo
aspetto, tratto da un lavoro di Ibsen, Freud definirà uno dei tratti della sua identificazione ebraica.
41
forma di antisemitismo dovuta all’attrazione esercitata sugli ebrei della Diaspora? Non era meglio assimilarsi come singoli nella diaspora, trasformarsi in una delle tante chiese locali, come avevano cercato di fare agli inizi i più conseguenti dei tedeschi di “confessione mosaica”, convertirsi alla fede della maggioranza che aveva per secoli oppresso gli ebrei.
Gli ebrei che fuggivano dall’Europa infestata dall’antisemitismo, erano di fatto gli unici europei di un’Europa che non ha ancora scoperto come suo valore fondante il superamento delle chiusure che per secoli l’avevano insanguinata.
Come scrive con amaro umorismo Amos Oz, gli altri popoli erano o si dichiaravano panslavi, pangermanici, o semplicemente patrioti lituani, bulgari, irlandesi, slovacchi. In Cecoslovacchia “vivevano tre nazionalità: cechi, slovacchi e cecoslovacchi, cioè gli ebrei”. In Iugoslavia c’erano i serbi, i croati, gli sloveni e i montenegrini, ma anche lì vi era una manciata di iugoslavi smaccati, e persino con Stalin, c’erano russi e ucraini e uzbechi e ceceni e tatari, ma fra tutti vi erano dei suoi parenti che erano “membri del popolo sovietico”33.
Coscienti di avere come patria spirituale le lingue e le culture europee, la stragrande maggioranza degli ebrei non si rassegna all’idea di fare ritorno alla loro patria più antica solo per fare un piacere agli antisemiti. Sino a che l’Europa non diventa una grande prigione e anche dopo, sono in molti a considerare assurda l’idea di ritagliarsi un piccolo spazio territoriale in cui farsi Stato fra gli altri per sopravvivere ed esistere. Spariti gli ebrei, le due nazioni di cui si compone la Cecoslovacchia, quasi a voler simboleggiare l’assenza dell’elemento comune che li rende europei, si sono separate prima di poter fare il loro comune ingresso nell’Europa nata dalle ceneri di Auschwitz. Nei Balcani, i popoli raggruppati nella ex Iugoslavia devono combattersi e decimare per annullare “ogni mescolanza”, prima di fare il loro ingresso separato nell’Unione europea. “Oggigiorno, scrive Oz, l’Europa è completamente diversa, oggi è piena di europei, da un muro all’altro. Fra parentesi, anche le scritte, sui muri, sono cambiate completamente: quando mio papà era ragazzo a Vilna, stava scritto su ogni muro d’Europa: “Giudei, andatevene a casa, in Palestina”. Passarono cinquanta anni e mio padre tornò per un viaggio in Europa, dove i muri gli urlavano addosso: “Ebrei, uscite dalla Palestina”34.
Tra i rimproveri che Yehoshua muove al profetismo ebraico, è di avere inoculato nelle viscere della vita ebraica richieste impossibili con un conseguente senso di colpa che fa dell’odio di sé un elemento costitutivo dell’identità35. Le accuse mosse al profetismo sono in realtà simmetriche alle accuse che lo scrittore da sempre rivolge agli ebrei della Diaspora per il fatto di non trasferirsi in massa in Israele.
33 A. Oz (2002), Una storia di amore e di tenebra, Milano, Feltrinelli, 2003, pp. 86-87. 34 Ibid. 35 Cfr. W. Goldkhorn, “La profezia di Yehoshua”, colloquio con Abraham B. Yehoshua, “L’espresso”, 12 luglio
2007, pp. 96-99.
42
Al contrario di Yehoshua, Grossman non nasconde il fascino per la cultura ebraica della Diaspora. Il suo auspicio è che una volta conseguita la pace e la sicurezza, il popolo israeliano potrà finalmente “decidere se essere un popolo dello spazio o un popolo del tempo”. La risposta su che cosa sia meglio essere sarà data dopo, quando “il popolo di Israele” potrà sentirsi per la prima volta a casa propria. La scelta delle parole, sicuramente sfuggita ai diplomatici che lo ascoltano, non lascia dubbi. Dire “popolo di Israele” è cosa ben diversa che dire “popolo israeliano”. I due termini non sono sovrapponibili. Nel primo caso vi è qualcosa che oltrepassa l’esperienza del sionismo e dello stato. Nel secondo siamo dentro la logica degli stati. Le antinomie ebraiche non vengono meno col fatto di essere diventati nazione. Al contrario possono acuirsi perché pongono l’Ebraismo di fronte alle sue impossibilità che sono però anche le sue fonti di vitalità interiore, di cui solo l’umorismo può fornire la cornice adeguata per esprimersi. Risolti i problemi con i suoi vicini, Israele potrà secondo Grossman cominciare a curare i propri mali, a curare “quel senso di non accettazione degli israeliani e degli ebrei”, a riconquistare “una normalità politica universale” da cui per secoli l’ebraismo è stato precluso, a “superare il senso di “estraneità profonda rispetto al mondo” da cui è stato storicamente segnato. Quasi ci fosse da una parte un popolo traumatizzato prigioniero delle sue paure più antiche e dall’altra un mondo normale, più in grado di trovare le soluzioni giuste, e non invece un paese che in una situazione di difficoltà impensabili appare comunque in grado di scavare nelle sue ferite e di interrogarsi attraverso i suoi scrittori sul proprio futuro.
Diaspora e Israele
Gli ebrei sono l’unico popolo al mondo che simbolicamente conta la storia a partire dalla genesi. il natale ebraico è il natale del mondo. Non racconta un inizio che riduce ciò che vi era prima ad una colpa originaria o all’ignoranza assoluta come avviene nella visione paolina o in quella islamica per la quale il periodo precedente alla rivelazione islamica è il mondo della yahilia.
Nella Bibbia, la storia non comincia con gli ebrei, né si deve contare a partire da loro. La data simbolica con cui viene segnato l’inizio, serve a sottolineare l’unità del genere umano affinché nessuno possa dire: “Mio padre è meglio del tuo”. La solitudine di Israele, è questo il grande fardello che Israele sostiene per la sua elezione, è a garanzia di unità per l’intera umanità. In “settanta persone” Israele discese nell’Egitto per fare poi ritorno dopo la dura schiavitù per ricevere nel Sinai le tavole della libertà36. Settanta sono per la Bibbia i confini che separano le nazioni37.
La rivelazione che fa del popolo ebraico “un popolo di sacerdoti” (‘am kohanim) al servizio di Dio e dell’umanità, non annulla quella noachide, né la impone al resto del
36 Il Pirkei Avoth invita a leggere la parola heruth (tavole) come “libertà”. 37 “Quando l’Altissimo spartiva l’eredità delle nazioni, quando egli divideva i figli di Adam, Egli fissò i confini
dei popoli secondo il numero di dei figli di Israele” (Devarim/Deuteronomio, 32,8).
43
genere umano38. L’appello di Abramo ad abbandonare la sua terra per dare ascolto all’anima e al cuore39, segna un passaggio che non annulla le differenze, ma le assume facendo di Israele un simbolo che le garantisce.
Contare l’inizio, ha per il Giudaismo un valore simbolico. Significa che nell’universo ebraico l’altro non ha il ruolo di comparsa, esiste indipendentemente dalla nostra esistenza e non è riducibile alle nostre proiezioni.
Il comandamento biblico di amare per il prossimo ciò che vorremmo per noi, ha qui il suo preciso significato. Poiché Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, nello sguardo dell’altro, è la Divinità che ci viene incontro. È per l’amore verso Dio, padre e madre di ogni vivente che dobbiamo estendere al prossimo il sentimento della compassione e di una comune appartenenza. Nel Libro di Devarim, il Dio della vita si rivela come Colui che libera gli schiavi e protegge lo straniero. Sviluppando questa idea, la psicoanalisi afferma che siamo stranieri a noi stessi.
Sei mila anni di “calendario” sono il simbolo di un inizio in cui il prima è rappresentato da un’origine comune,e dove la patria è il mondo della natura e dei viventi. Una patria che non ha bisogno di un territorio delimitato per declinarsi, in cui la terra appartiene al Signore che l’ha data all’uomo per curarla e proteggerla, dove è lontano ma è di casa ovunque lo si faccia entrare.
A fondarsi come inizio sono i regime totalitari e le religioni assolutiste, per le quali ciò che esiste prima non ha valore, o ha un valore secondario e subalterno. L’inizio cui si richiama l’Ebraismo per celebrare il nuovo anno, è l’inizio da cui ha preso corpo il tutto. È impegnativo anche nei rapporti con la natura ed ha un valore ecologico.
Le benedizioni che Dio rivolge a Israele non sono contro gli altri popoli, che per estensione e dominio sono anche esse benedette. Il patriarca Abraham è capostipite di popoli e nazioni, che in lui sono benedette. Ismaele, suo primogenito, è nella tradizione ebraica il capostipite dei popoli arabi e islamici. Esaù, primogenito di Isacco, il secondo dei patriarchi, è il capostipite dei popoli cristiani.40
La he di Abraham, quinta lettera dell’alfabeto è il segno di una presenza divina che avvolge l’intero mondo. Trasferitasi dalla moglie Sarai (che diventa Sarah) al marito, dopo la terribile prova cui entrambi hanno dovuto fronte, la duplice he di Abraham e di Sarah è il segno di un rinnovamento che appartiene al mondo, di cui Jacob, divenuto Israel dopo avere lottato con l’Angelo, per averne la benedizione, è testimone41.
38 E. Benamozeg, Il noachismo, Genova, Marietti, 2006. 39 Come insegna un midrash, il verso biblico Lekkh Lekhà mearzekhà, “Vai via dalla tua terra” , può significare
in ebraico “Vai verso di te” (Bereshith/Genesi, 12.1). 40“E tu non sarai più nominato Abramo; anzi il tuo nome sarà Abraham. Perché io ti ho costituito padre di una
moltitudine di nazioni”(Bereshith/Genesi, 17.5). 41 La yud e la he sono due dele lettere di cui si compone il tetragramma santo e impronunciabile del Nome divino.
La yud corrisponde al numero 10. La he al numero 5. Secondo un midrash la yud di cui si compone in origine il nome Sarai è stato scomposto in due he, ciascuna delle quali è stata incorporata nel nome dei due patriarchi divenuti Sarah e Abrahama a testimonianza della presenza della Shekhinah al loro interno.
44
Ismaele ed Esaù che nel Midrash simboleggiano l’Islam e il Cristianesimo, sono rappresentati come fratelli con le loro specifiche benedizioni, anche se nella storia reale il rapporto per Israele non è stato facile e talvolta tragico. Anche nella tragedia più grande, l’Ebraismo non ha mai negato ai suoi due fratelli simbolici la loro umanità. Non era stato Abraham a mettere in discussione il diritto divino a distruggere Sodoma se vi erano dieci giusti?42 Le vittime non vorrebbero mai essere come i loro persecutori. I loro antesignani sono Giobbe che non cessa di chiamare Dio alle sue responsabilità verso il mondo; Abraham che mettendo in discussione l’idea di una colpa collettiva, chiama in causa il diritto di Dio a distruggere un’intera città; Moshe che si interpone per interrompere l’ira divina contro il suo popolo, colto dallo smarrimento e dall’angoscia per una lunga assenza.
Sin dalla loro apparizione sulla scena storica, gli ebrei sono in cammino. La terra è una promessa che si trasfigura nella nostalgia di un ritorno al futuro in cui realizzare le speranze mancate e le delusioni del passato più antico e recente. Nell’umorismo ebraico la patria può essere un violino, più facile da portare in caso di abbandono forzato. Per parafrasare Heine, il violino è come la Torah, “una patria portatile”.
Gli ebrei che dallo Yemen lasciano ogni loro avere e attraversano il deserto per raggiungere la terra degli avi, portano con sé i libri della Torah, il Talmud e lo Zohar
43. Coloro che li hanno preceduti dalla Galizia tre decenni prima per fondare i primi kibbutz hanno con sé come “unico capitale”, una copia di Das Kapital e una dell’Interpretazione dei sogni
44. Il sogno messianico di redenzione si era trasfigurato in quello secolare.
Diaspora e Israele appaiono molti secoli prima della distruzione del Secondo Tempio come poli distinti e correlati dell’esistenza ebraica. I momenti più alti e quelli più dolorosi e tragici della storia ebraica si sono svolti largamente nella diaspora. Il regno di David non ha fatto in tempo a passare dal figlio prediletto ai nipoti, che era già sdoppiato in due regni fragili ed esposti alle invasioni da Nord e da Sud.
L’immagine del ritorno conservata nella liturgia è stata caricata dopo ogni generazione di significati nuovi che hanno reso possibile il rinnovamento dell’esistenza. Nella visione messianica il ritorno a Gerusalemme è un ritorno al futuro. Nella mistica chassidica sono i persecutori e gli oppressori a non essere liberi perché si sono staccati dalla fonte primaria dell’Essere. Il più oppresso dei popoli ha sempre saputo di essere internamente più libero dei suoi oppressori. Nel canto gioioso di Lekha Dodì si può sperimentare come certezza un frammento del futuro che contiene le speranze non realizzate del passato più antico.
Combinando le immagini di un ritorno a un passato immaginato come glorioso nella fantasia, con la speranza in un futuro diverso per l’umanità intera, l’Ebraismo si è 42 Faresti tu perire anche il giusto con l’empio?” (Bereshith/Genesi, 18.23). 43 Il Sefer (pl Sefarim) Torah, sono i cinque libri del pentateuco scritti secondo una particolare e complessa procedura per l’utilizzazione nel servizio religioso. Lo Zohar
44 Ch. Weizman a E. Jones, 7 dicembre 1920, in E. Jones, Vita e opera di Freud, Milano, Garzanti, 1977, vol. III, p. 46.
45
rinnovato nei secoli, conservando i legami col passato più antico. Il posto della patria è stato preso da un Libro rinnovato nei suoi significati di generazione in generazione.
La saggezza dell’umorista va oltre le aspirazioni giovanili e insegue, non conosce le unilateralità forzate, sa anzi che la forza e la debolezza di un pensiero e di una condizione esistenziale sono strettamente intrecciate, i meriti e i demeriti, gli aspetti buoni e quelli criticati. Come insegnava Freud, perdendo l’uno si rischia di perdere l’altra45. Dubito che ci sia un che d’interessante all’idea che l’intera impresa del sionismo avesse avuto come obiettivo di diventare una nuova nazione cananea, come invece avrebbe desiderato uno dei grandi poeti del Risorgimento ebraico? Ma era proprio quello che sognava, o invece vi era dell’altro che spiega più di ogni altra cosa la capacità di incidere sulla storia ebraica e di darvi una svolta? Decidere se essere popolo dello spazio o del tempo, della contingenza o dell’eternità, non è una questione che appartiene agli Stati, né può essere rimandata al giorno in cui gli ebrei potranno vivere al sicuro e in pace con i loro vicini. È un dilemma permanente della vita ebraica, indipendente dal fatto che si viva in Israele o nella Diaspora.
Non ci sono un prima e un dopo per declinare la propria vocazione. Gli israeliani come gli ebrei della Diaspora possono rinunciare a questo dilemma a un solo prezzo: cessare di essere ebrei. Nella Diaspora lo possono fare perdendo ogni contatto con le fonti sorgive di una tradizione millenaria, in Israele diventando una nazione come le altre. Al posto di un’assimilazione individuale si tratterebbe di un’assimilazione collettiva. La Diaspora non è stata solo una valle di lacrime. Diaspora ed esilio non sono sinonimi e l’immagine della Sukkah, la capanna in cui dimorarono gli ebrei nel deserto, non è un’immagine di perdita, ma di una presenza di vita che nessuna comunità statale potrebbe mai surrogare. Il sionismo, paga oggi il prezzo delle sue parole d’ordine. Si voleva che qualcosa nella vita ebraica cambiasse, ma questo non era al prezzo della perdita dell’identità. Insieme al cambiamento si voleva garantire la continuità senza mutazione né dispersione. Di questo rischio, i suoi critici all’interno della tradizione ebraica, apparivano più consapevoli, anche se a loro volta, non erano in grado di dare una risposta alternativa. L’esistenza di una Diaspora culturalmente viva, è oggi vitale per Israele, è il sale della sua democrazia, la garanzia che il paese non si chiuda in se stesso facendo del nazionalismo laico o religioso, e dello Stato un culto “idolatrico”. Le sfide che attendono il popolo israeliano sono enormi. Uscire dall’incubo della guerra, ritrovare la normalità dell’esistenza, costruire un futuro di pace e di coesistenza coi vicini. Sono domande attuali alle quali si aggiungono quelle della costruzione di una società pluralista in cui le diverse anime del Giudaismo siano in grado di convivere. Per i padri fondatori, il sionismo voleva dire recupero di un più antico passato nazionale che riportava gli ebrei dentro la storia. La valorizzazione della Bibbia rispetto al Talmud rientra in questo quadro. La Bibbia racconta una teodicea dentro la storia. Il Talmud colloca i personaggi biblici fuori dalla storia, le trasforma in figure archetipiche,
45 D. Meghnagi, “Jewish humour on psychoanalysis Jewish humour on psychoanalysis”, in “International Review of Psychoanalysis”, Published in conjunction with The International Journal of Psychoanalysis, Vol. 18, 1991, pp. 223-228.
46
metafora di un discorso situato fuori dal tempo storico, valido per ogni epoca. Che l’evento raccontato nel Midrash, si svolga mille o due anni fa, ha poca importanza per chi lo ascolta nella sinagoga. Obiettivo del Midrash è l’attualizzazione dell’insegnamento religioso, la drammatizzazione delle ansie della comunità, la gestione delle angosce e delle paure collettive, la loro sublimazione nell’ambito di una visione religiosa ebraica della vita. In opposizione alla tradizione religiosa, i sionisti restituivano un valore centrale alla Bibbia alla sua interezza. Da qui anche la scelta dei nomi a tutto campo e non nell’ambito di una cerchia ristretta delle figure bibliche. Una Bibbia ridotta allo stato dell’Eneide o dell’Odissea era in ogni caso, anche per i modernisti più conseguenti, incontrava dei limiti, oltrepassati i quali la visione dell’ebraismo rischiava di sfaldarsi. “Ho sempre considerato, scrive uno dei padri del sionismo culturale, il sionismo laico come una via legittima, ma io rigetto –scrive Scholem- la proposizione stupida secondo la quale gli ebrei dovrebbero diventare <un popolo come gli altri>. Se ciò dovesse avvenire sarebbe la fine del popolo ebraico. Io condivido l’opinione tradizionale secondo cui, quanto più noi vorremmo diventare un popolo come gli altri, non esisteremmo più. Se ci riuscissimo, sarebbe come essere finiti”.46 L’esistenza di Israele, la sua sicurezza, è una garanzia di vitalità per la Diaspora. Israele non è solo la promessa di un rifugio sicuro contro nuove e più terribili persecuzioni, è anche un richiamo per ebrei e non ebrei a ripensare i rapporti che intercorrono fra le molteplici forme di appartenenza cui il mondo moderno ci obbliga. Senza Israele, la Diaspora tornerebbe a essere fragile com’è accaduto per due millenni. Senza la Diaspora Israele perderebbe uno degli elementi costitutivi della sua identità. Senza la Diaspora Israele non sarebbe più Israele. Due centri e due periferie, una molteplicità di centri convergenti, secondo l’angolo di visuale e di osservazione.
L’anomalia è rappresentata in questa dialettica dall’eventuale sparizione di uno dei due centri. Ciò che, infatti, è accaduto dopo la distruzione del Secondo Tempio, non fu l’inizio della diaspora. La diaspora esisteva già da secoli e aveva dato grandi contributi allo sviluppo della cultura ebraica. Ciò che accadde con la distruzione del Secondo Tempio, fu la perdita di uno dei centri in cui si era sostanziata la vita ebraica con lo sviluppo della comunità ebraica in Babilonia e di altri centri di vita ebraica nell’antichità. Nella storia della civiltà ebraica e nella strutturazione dei suoi spazi culturali e mentali, l’anomalia non è rappresentata dall’esistenza della Diaspora, ma in una diaspora che non possa più riflettersi e guardare dialetticamente a uno dei suoi centri più antichi.
46 G. Scholem, Entretien avec Gershom Scholem, in Fidelité et Utopie, Essais sur le Judaisme Contemporain
Paris, Calmann Levy, 1978, pp. 15-22. Intervista realizzata da Muki Tsur, pp. 15-22.
47
Shmuel Trigano
L’importance stratégique d’une idéologie en crise
Devant l’égarement contemporain et la diabolisation ambiante dont il est l’objet, il est important de clarifier la signification du sionisme politique. S’il est la réalisation de l’idée immémoriale du retour à Sion, il n’en est pas moins une idéologie moderne spécifique. Trois objectifs la caractérisent, dans son propre regard : 1)Mettre un terme à la condition diasporique des Juifs, interprétée comme la source du malheur juif 2)Conquérir une autonomie sous la forme de la souveraineté étatique. 3)Normaliser les Juifs, c’est à dire rompre avec le judaïsme, identifié à la diaspora. L’idéologie sioniste entreprend de faire des Juifs une nation, définie par l’autochtonie. Peut-être pourrait-on avancer que l’autonomie, c’est à dire la constitution du Souverain, a toujours été plus importante que la spécificité et l’identité. A l’origine, ces dernières sont restée plutôt impensées. Le contrat fondant l’association pollitique était plus important que l’identité, comme pour le Rousseau du Contrat Social. Ainsi, la judéïté dans le sionisme s’est, la plupart du temps et dans son courant dominant, manifesté comme le retour d’un refoulé originel, sous la forme d’une crise, d’une fatalité ou d’une catastrophe, si bien que l’on peut affirmer que l’idéologie sioniste ne dispose pas du cadre intellectuel qui lui permettrait d’intégrer l’historicité du judaïsme, comme force de l’histoire. C’est ce qui explique pourquoi la question du judaïsme (inséparable de la question du peuple juif) a constitué le problème central de l’Etat d’Israël, à la façon de la question lancinante de la religion et de l’Etat ou des sépharades dans la nation israélienne ... Ce jugement ne signifie pas pour autant que la clef du destin du sionisme serait dans la pensée du judaïsme rabbinique. En n’enfantant pas le sionisme et, pire, en s’opposant à lui à sa naissance et en continuant de le faire un siècle après dans le milieu ultra-orthodoxe, celui-ci pourrait avoir râté le coche de l’histoire. Ce n’est qu’après coup, en effet, que le judaïsme rabbinique est devenu sioniste. Il n’a pas été le moteur du retour à Sion comme le fut le courant laïque et a-religieux ou anti-religieux qui , après l’émancipation, a seul elevé le défi du destin juif confronté à une nouvelle condition dans laquelle, devenant des citoyens individuels et abstraits, les Juifs cessaient d’être un peuple. Le fameux mot du Comte de Clermont Tonnerre, un acteur de la Révolution française, résonne encore : « Tout pour les Juifs en tant qu’individus, rien pour les Juifs en tant que peuple ». Or, 40 ans après l’émancipation, apparaissait en Europe un
48
nouveau phénomène, l’antisémitisme, ciblant dans les Juifs un peuple secret secret, appréhendé sous le signe du mythe du complot juif ... Le sionisme fut le seul courant idéologique à avoir construit une stratégie sur la base du peuple juif. Le Bund, stratégie diasporiste, ne pouvaat y prétendre car il avait renoncé au peuple juif pour ne prendre en considération que les Juifs polonais non religieux, et évidemment pas le reste des communautés juives du monde. Cette dimension du destin collectif et de la souveraineté constitue la donnée stratégique la plus importante du sionisme, à partir de laquelle tout doit se penser. C’est ce qui explique pourquoi, il est resté l’unique conception politique juive à survivre à la deuxième guerre mondiale et pourquoi toutes les communautés juives du monde se sont ralliées à lui peu à peu. Les causes en sont concrètes. En effet d’un point de vue morphologique, la Shoa avait montré que le destin juif était collectif, parce que les Juifs, qui étaient à titre individuel les nationaux de chaque Etat européen, avaient été retranchés en bloc de la citoyenneté de leurs pays respectifs et détruits en masse comme s’ils étaient un peuple étranger en Europe. Un peuple qui n’avait jamais été reconnu, dont le destin politique n’avait jamais été organisé et que ses membres eux mêmes avaient déserté. Au sortir de la Shoah, le sionisme prend objectivement un sens nouveau : il devient le seul vecteur qui a fait du destin collectif des Juifs un facteur positif et constructif, certes dramatique, plutôt qu’une tragédie. C’est ce qui explique que toutes les communautés de la diaspora sont devenues sionistes. La création de l’Etat par Ben Gourion va accentuer cette nouvelle donne, avec la résurrection d’une souveraineté du peuple d’Israël, la première depuis l’État des Macchabées. Cette souveraineté, quoique laïque, constitue de facto un phénomène religieux considérable qui laisse loin, là aussi, derrière lui le judaïsme rabbinique. Le destin de l’Israël éternel échappe objectivement alors à l’Autorité rabbinique. Ce décalage ouvre un no man’s land normatif et provoque un égarement des consciences. C’est un tournant gigantesque quise produit et nous replonge dans les temps bibliques (auxquels la guerre de 1967 va donner du contenu : le retour en masse de la « terre promise » refoulée et du judaïsme dans le sionisme. Il n’y a alors pas de valeurs ni de concepts pour penser le phénomène. La Halakha est incompétente car son investissement dans le droit civil et constitutionnel (le domaine du Hoshen Mishpat) s’est tari depuis le Moyen âge. Les laïques sont désorientés car les Juifs, peuple intelligent s’il en est - sont profondément défaillants sur le plan du sens politique. Un champ existentiel nouveau s’est alors ouvert qui attend encore sa pensée, une pensée politique émergeant de la Tora.
49
Cependant, la boite de Pandore est ouverte. Les laïques du sionisme, les fils ignorants en judaïsme des pères fondateurs qui, bien que laïques, avaient étudié le judaïsme, suivent la pente de la « négation de la Galout » et du rêve de l’autochtonie. Ils vont jusqu’au bout de cette logique dans les courants du post-sionisme, du post-modernisme et des « nouveaux historiens ». Ces courants sont animés d’une hostilité profonde envers le judaïsme et le peuple juif, la même que dans les années 1920 du Yishouv. Ils ne veulent plus du peuple juif mais d’une nation israélienne, d’un État qui serait « l’État de tous ses citoyens » et dont les symboles ne seraient plus juifs. Les sionistes religieux qui se trouvaient au centre de l’échiquier idéologique et qui avaient pris en marche le train du sionisme, se laissent attirer par le désir d’autochtonie originellement propre au sionisme laïque (comme l’idéologie des Canaanéens l’avaient illustré) mais en le sacralisant cette fois ci voire presque en le divinisant. A l’autre extrême, l’ultra-orthodoxie revient en force. Elle est toujours antisioniste mais vit désormais aux crochets de l’Etat et se comporte comme elle se comportait dans le ghetto qu’elle a choisi au mileu du XIX° siècle quand elle s’est constituée et maglré le terrible échec de sa stratégie que fut pour elle la Shoah. Entre temps, dans la diaspora, avec l’institution de la Mémoire de la Shoah, le destin collectif des Juifs dans la Shoah a été sacralisé et spiritualisé, « universalisé », engageant les Juifs sur la voie d’une identité victimaire, c’est à dire d’un renoncement à la condition politique, et donc à la souveraineté politique. Cette évolution, propre aux Juifs déjudaïsés, très inquiétante pour l’avenir, va dans le même sens que celle de l’ultra-orthodoxie qui a toujours été hostile à l’assomption par les Juifs de leur destin politique et à l’idée même de souveraineté. Mais elle rencontre aussi l’évolution des post –sionistes qui critiquent non seulement le caractère juif de la souveraineté de l’État d’Israël mais aussi toute souveraineté propre à l’Etat nation . Quant aux sionistes religieux, toujours écartés de la responsabilité politique, ils n’ont pas le sens et la pratique politiques nécessaires pour faire face aux défis de la situation. Leur messianisme eschatologique est un terrible handicap à la vision et à l’action politiques. Ce tableau est inquiétant car nous pouvons constater que dans tous ces courants contemporains, il y a une prédisposition à renoncer à la souveraineté qu’elle soit étatique et nationale, pour les uns, juive pour les autres, comme si le sionisme n’avait pas eu lieu. C’est comme si il y avait une fuite devant l’adversité. Cette évolution est d’ailleurs le signe d’une situation dangereuse qui s’annonce pour le peuple juif. Le danger se profile sur deux plans : dans le monde islamique et en Occident. Dans ces deux arènes, c’est la légitimité d’abord, puis la survie du peuple juif qui sont en question. Il est sans doute dûr d’accepter l’idée que l’on a face à soi un ennemi résolu qui recherche votre destruction. C’est le cas de l amajeure partie du monde arabo-islamique et en premier lieu des Palestiniens, nonspas ceux qu’exalte la presse
50
occidentale mais ceux que nous révèlent la TV, les médias, les livres d’école de l’Autorité palestinienne. Les choses sont très claires mais personne ne veut les entendre. Il y a dans la mystique de la paix partagée par de nombreux milieux juifs, une prophétie auto-réalisatrice qui méconnait qu’on ne peut faire la paix qu’avec quelqu’un qui veut la paix. L’hostilité immense du monde arabo-islamique envers les Juifs prend une tournure dramatique avec la bombe atomique iranienne. En fait et en principe, l’islam ne peut accepter l’idée d’une souveraineté juive car il assigne les non musulmans à une condition de dhimmi, de soummis, dont ils ne peuvent s’échapper sans encourir la guerre sainte ? La deuxième arène du problème est celle de l’opinion publique occidentale qui, depuis la deuxième intifada, avec le poids de l’anti-américanisme, met de plus en plus en question la légitimité d’un État juif, courramment qualifié de raciste, , fondé sur une injustice, nazi... Une grande partie de l’intelligentsia eurpéenne et américaine le pense, tandis que le malaise vis à vis d’Israël est grand dans l’opinion, du fait des nombreuses manipulations médiatiques auxquelles nous avons assisté et qui ont été démontées depuis les années 2000. Le mot de sionisme est devenu une injure et l’antisionisme se comporte objectivement comme une déclianison nouvelle de l’antisémitisme. On nie aux Juifs la moralité de leur droit à l’autodétermination ,que l’on reconnait aux Palestiniens, un peuple qui n’existait pas il y a 50 ans. Cet alliage monstrueux entre antisionisme et philosémitisme a été rendu possible par la mémoire victimaire de la Shoa. Si on reconnait les Juifs morts comme un peuple dans les camps, on ne reconnait pas le peuple juif vivant et souverain... A ce concert, se joignent les voix nihilistes et accusatrices deune partie de l’intelligentsia juive diasporique et israélienne qui récusent le principe même d’un État juif et d’une souveraineté juive au nom d’une éthique désincarnée qui a sombré corps et biens dans la Shoah. Dans cette perspective stratégique, le sionisme politique – quelles que soient ses défaillances intrinsèques – prend un sens nouveau. Il devient l’emblême de l’existence d’un peuple juif sujet de l’histoire, et c’est ce qu’il faut défendre à tous prix et avec une ferme résolution dans toutes les arènes où il est remis en question intellectuellement et pratiquement. Pour une raison pratique tout d’abord, en deçà de toute option idéologique, car chaque fois que les Juifs ont renoncé à leur statut collectif, ils ont été détruits dans leur condition individuelle. Faire un compromis sur celà, c’est le premier pas vers la fin. Pour une raison spirituelle et morale, ensuite, le peuple juif est la poutre maîtresse du judaïsme. Nous sommes l’unique religion au monde dans laquelle la révélation a été faite à un peuple et non à un individu. C’est le coeur du judaïsme et c’est ce que ses ennemis ont voulu détruire depuis toujours, idéologiquement ou politiquement.
51
David Banon
Messianisme et orthodoxie
Prenant le pouls de l’histoire la plus contemporaine et la plus brûlante, celle à oscillations brèves, rapides et nerveuses tout en essayant d’en dégager les lignes de force, Aviézer Ravitsky déploie une ample réflexion en nous offrant une belle fresque du messianisme, du sionisme et du radicalisme religieux en Israël. Tel est le sous-titre de son ouvrage intitulé L’avènement dévoilé et l’Etat des Juifs
47. Ouvrage qui tente
d’analyser l’idéologie du messianisme orthodoxe et celle du sionisme laïc à partir de leurs confrontations dans le cadre de l’Etat d’Israël. Confrontations qui ont provoqué tensions et conflits puisque les tenants de l’un et l’autre courants ont voulu donner corps à leurs aspirations dans ce cadre-là. L’objectif de ce livre, clairement défini par son auteur, est de « mettre à jour les fondements théologiques du débat qui s’est engagé en Israël autour des questions de la religion, du peuple et de l’Etat, d’examiner les racines idéologiques des diverses positions orthodoxes tout en tentant de les subsumer sous un modèle conceptuel général. » (p.19) Pour l’établir, Ravitsky a choisi comme critère le rapport à l’idée messianique. Ce rapport lui permet de distinguer différents courants dans l’orthodoxie qu’il répartit entre adversaires et partisans du sionisme pour ensuite décrire les nuances au sein de chacun de ces courants. Son intention est aussi de « suivre à la trace les processus de radicalisation qui se sont produits dans la conception du monde de ces différents courants en rapport avec le sionisme et le messianisme. » (p.19) C’est dire que ce livre se présente comme une analyse détaillée et une description rigoureuse des types de pensée religieuse dans leur relation à la modernité. (Rappelons que l’orthodoxie48 s’est constituée en tant que réaction à la modernité. Réaction complexe et diversifiée qui va du rejet absolu au consentement partiel.) Avant de passer au contenu de l’ouvrage, il convient de signaler que l’examen du rapport du messianisme au sionisme s’élabore à partir de notions-clés qui se présentent par paires : l’exil et la rédemption d’une part, de l’autre, la sainteté du pays d’Israël et sa profanation. Ces notions-clés drainent dans leur sillage des questions halakhiques, mystiques et émotionnelles d’une intensité considérable. 47 Haqets hamégoulé oumédinat hayéhoudim. Méshih’iyout, tsionout véradiqalism dati béyisrael, ‘Am ‘Oved publishers, Tel-Aviv, 1993, collection “Sifriat Ofaqim”, 399 p., en hébreu. 48 Qu’on peut diviser en trois groupes, tous trois soucieux de respecter la halakha, et en ce sens, ils sont tous également orthodoxes. Toutefois, la relation plus ou moins exclusive qu’ils entretiennent à l’égard et du code religieux juif et de la modernité permet de distinguer l’ultra-orthodoxie, la néo-orthodoxie et l’orthodoxie que l’on pourrait qualifier de « réformatrice »
52
Dans le premier chapitre, Ravitsky plante le décor. Le décor, c’est le contexte historique et conceptuel de la question sioniste dans son rapport au messianisme, telle qu’elle est apparue aux juifs croyants au tournant du 20è siècle. C’est d’ailleurs ce chapitre qui permet de donner au lecteur les outils conceptuels à l’aide desquels il pourra s’ouvrir un chemin dans les méandres du débat actuel puisque les questions brûlantes qui l’alimentent sont reconduites à leur source. L’on constate ainsi qu’à côté de quelques dirigeants hassidiques qui défendaient avec enthousiasme l’idée sioniste, nombreux étaient ceux qui s’abstenaient d’identifier sionisme et messianisme, de peur que l’idée sioniste n’entachât l’utopie messianique. Plus encore, ils ont réussi à élever « des barrières entre la réalité historique et l’espérance de la rédemption. » (p.38) Sionisme et ultra-orthodoxie Le second chapitre se focalise sur les positions ultra-orthodoxes de deux maîtres du hassidisme hongrois : Rabbi Haïm Elazar Shapira (1872-1937) et Rabbi Yoël Moshé Teitelbaum (1888-1982) pour lesquels il était hors de question de remettre en cause le quiétisme messianique qui dominait la tradition rabbinique depuis l’échec de Bar Kokhba. La neutralisation49 de l’aspect dynamique du messianisme le dota d’un triple caractère : passif (la rédemption s’opérera de manière miraculeuse), utopique (elle instaurera une ère radicalement nouvelle) et apocalyptique (elle interviendra après l’irruption de catastrophes inouïes). L’auteur décrit, dans un langage fleuri, les réflexions et déclarations de ces personnalités éminentes qui voient dans l’entreprise sioniste en particulier et dans le nouvel Israël entrain de se construire en général, l’œuvre du Satan (p.71-74 ; 80-81 et 103). Ravitsky éclaire ainsi la très vive hostilité régnant entre l’ultra-orthodoxie et le sionisme, lequel éradique la rationalité de l’existence juive. Son objectif étant de « conduire l’ensemble du peuple à une double trahison de sa vocation : par une entrée fracassante sur la scène de l’histoire profane et un rejet du joug de la Torah et des cieux. » (p.87) Plus encore, l’auteur perçoit l’essence de cette répulsion entre ces deux mondes dans l’interprétation de la Shoah comme « châtiment collectif consécutif à une révolte collective du peuple juif contre le royaume des cieux. » (p.89) Là aussi se situe la frontière entre le monde de l’orthodoxie et celui de l’ultra-orthodoxie. Le premier était attentif aux soubresauts de l’histoire et tentait de s’accommoder à ces effets. La foi des orthodoxes était fondée sur la réalité de la providence divine conduisant le monde. Par conséquent, l’histoire, qui atteste cette providence, ne peut qu’avoir des « effets bénéfiques » ou à tout le moins « positifs ». C’est pourquoi les orthodoxes consentent à vivre dans l’Etat d’Israël tel qu’il est. (p.93-94) En revanche, les ultra-orthodoxes 49Conformément aux « trois serments » dont deux interdisent au peuple juif « de ne pas monter [en Israël] en masse » et « de ne pas entrer en rébellion contre les nations ». Le troisième, lui, enjoint aux nations de « ne pas opprimer outre mesure le peuple juif ». Ces trois serments découlent de l’interprétation talmudique (Ketoubot 111 a) du verset du Chant des Chants : « Je vous conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles ou par les biches des champs, n’éveillez pas, ne réveillez pas l’amour, jusqu’à ce qu’il le veuille. » qui apparaît à trois reprises (2, 7. 3, 5 et 8, 4).
53
abordent la réalité comme étant l’œuvre du Satan lequel peut se déguiser et apparaitre sous les traits « du juste, disciple de sage » (p.94). Selon Ravitsky, tant que l’Etat se renforçait « la réalité extérieure était considérée comme l’ennemi du principe essentiel : la réalité ou l’œuvre du Satan s’opposait à l’essence ou la parole de Dieu. » (p.95) De là découle le paradoxe de l’ultra-orthodoxie assuré que l’Etat n’a aucun avenir mais qu’il convient malgré tout de le contester et de manifester contre lui. C’est ainsi qu’elle déclare « urbi et orbi qu’elle n’est aucunement responsable des agissements des sionistes et qu’elle s’en écarte. » (p.102) Ou bien « qu’elle prie pour la destruction de l’Etat mais simultanément aussi pour qu’aucun juif ne soit touché par cet événement », livrant par là le sort de l’Etat aux mains de Dieu. L’ultra-orthodoxie – celle des Nétouré
Qarta (les Gardiens de la Cité) et celle des hassidim de Satu-mare50 - contestent et dénient l’entreprise sioniste. Contestation et dénégation qui vont jusqu’à la diabolisation du sionisme et la démonisation de l’Etat d’Israël. Les sionistes-religieux et le messianisme Le troisième chapitre traite du « sionisme religieux messianique ». Là, l’auteur montre que l’on n’invoque pas les interdits des « trois serments » comme obstacles ou menaces. Déjà Rabbi Yéhouda Haï Alkalaï (Serbie, 1795-1878) et Rabbi Tsvi Hirsch Kalisher (Prusse, 1798-1874), deux précurseurs du sionisme, distinguaient deux phases dans la rédemption. La première, naturelle, correspond au retour physique des Juifs dans le pays d’Israël et la seconde, miraculeuse, verra le retour spirituel des Juifs vers Dieu et l’instauration de Sa royauté. La rédemption n’est donc pas un événement cataclysmique qui instituerait soudainement une ère sainte, en rupture avec l’ordre profane antérieur, il s’agit d’un processus graduel qui se réalisera « petit à petit comme l’aurore qui pointe à l’horizon51. » Si Alkalaï et Kalisher avaient pensé que leur époque était messianique, ils auraient pu interpréter le midrach des trois serments à la manière du Rav Tsvi Yéhouda Kook (1891-1981) : « Lo, lo anah’nou doh’aqim et haqetz, haqetz doh’eq otanou. Non, ce n’est pas nous qui précipitons le dénouement, mais le dénouement qui se hâte, se précipite, nous contraint. » (p.111). Le messianisme, ici, ne prends pas le visage d’un messie personnel, c’est un « messianisme sans messie » (p.113) découlant nécessairement du processus de la rédemption. Ce qui était pour le Rav Avraham Itshaq 50 Pour une présentation de la conception de ce mouvement, voir Roland Goetschel, « La diabolisation du sionisme dans les écrits de R. Joël Teitelbaum, maître des hassidim de Satmar » in Les Retours aux Ecritures. Fondamentalismes présents et
passés, édité par E. Patlagean et A Le Boulluec, Bibliothèque des Hautes Etudes, Section des Sciences Religieuses, vol. XCIX, Peeters, Louvain-Paris, 1994, p. 133-155. Alors que Goetschel ne fait que rendre compte du livre de Teitelbaum, Vayoël Moshé/Moïse consentit, selon Ex 2, 21 [Rachi ad loc. signale que le Midrach rapproche le verbe vayoël de ala : serment. Il commente. Moïse a fait serment à Jetro qu’il ne quittera pas Midian sans son autorisation], Ravitsky pointe l’influence décisive du rabbi de Munkacz, Hayim Elazar Shapira sur cette œuvre. C’est d’abord chez Shapira qu’on trouve le concept de diabolisation du sionisme et de « la Terre Sainte comme territoire où sont enfouies des puissances ténébreuses constituant une menace pour quiconque s’y aventure. » (p.62). 51 Yérushalmi, Berakhot 1, 1 et Cant. des Cant. Rabba 6,16.
54
Hacohen Kook (1865-1935), père de Tsvi Yéhouda, de l’ordre de l’utopie : « un Etat qui est, dans son fondement, idéal et dont les aspirations consistaient au fait que Dieu soit Un et Son nom Un » devenait chez son fils « une existence historico-politique de fait, hic et nunc » (p.115) Mais peut-on établir un lien entre la pensée du père et celle du fils ? A l’évidence le Rav Kook (père) a posé les bases d’une nouvelle réflexion sur la question messianique déjà à l’époque des précurseurs du sionisme lesquels avaient cantonné la renaissance nationale à l’ordre politique et factuel. Cette attention portée à la dimension matérielle, par un judaïsme inscrit dans l’histoire, se manifeste à travers toute une série de réajustements à laquelle va procéder une fraction du judaïsme orthodoxe, notamment Shmuel Rabinovitch et Ytshaq Yaacov Reines (1839-1915) en fondant en 1902, à Vilna, le mouvement Mizrahi. Le Rav Kook ira plus loin. Il ne se contente pas de cette thèse. Il en élabore une, plus audacieuse. Il inscrit la construction du pays d’Israël dans la progression de l’idée divine dans l’histoire. Cette thèse qui se nourrit de la doctrine kabbalistique devait cependant surmonter le fait que les « impies » sont bien les accoucheurs du monde messianique alors que les Justes semblaient tout désignés pour remplir cette tâche. Le Rav Kook fait alors des sionistes laïcs, à leurs corps défendant, des agents de la providence qui puisent à la source de la sainteté. Il affirme que le profane n’existe pas. Que seule une erreur de perspective et de perspicacité nous fait attribuer une réalité intrinsèque à ce qui n’est qu’une enveloppe extérieure. Le profane, c’est une perfection à venir, une sainteté qui se dévoilera peu à peu52. Ainsi, il donne un sens théologique au sionisme. La conception du Rav Kook, comprise comme une tentative de nier aux individus la capacité à exercer un choix en leur âme et conscience et à le doter d’un sens, était loin d’être partagée par tous. Le fait d’imposer à leurs actes une signification qu’ils rejettent a provoqué la colère de ses contradicteurs dans le camp des laïcs. Les orthodoxes, eux, refusaient de considérer cette entreprise comme s’inscrivant dans un projet divin ou pouvant revêtir une intention religieuse dissimulée. Ravitsky prend la défense du Rav Kook et assure que cette interprétation n’est pas le fruit d’un rejet ou d’un mépris mais provient d’une adhésion totale à l’entreprise sioniste. Ravitsky découvre dans les écrits du Rav Kook « le désir et l’élan vers l’harmonie, l’aspiration et la foi de la révélation à venir de l’unité des contraires. » (p.161) C’est la dure réalité qui l’a empêché de maintenir cette tension. En effet, lorsqu’il fut nommé à la tête du rabbinat d’Israël, il s’est vu contraint et forcé de condamner outre les nombreuses profanations de la loi religieuse, l’arrogance des antireligieux. Preuve, si besoin était, qu’un fossé se creuse entre « l’historiosophie messianique et l’histoire réelle. » (p.163) 52 Inutile de souligner que cette conception n’a pas emporté l’adhésion, notamment celle des orthodoxes radicaux qui voyaient dans l’Etat un produit de l’impiété « conçu et engendré dans l’impureté » alors que pour le camp des sionistes-messianistes l’Etat est « conçu et engendré dans la sainteté » (p.191)
55
Ravitsky qui montre comment la pensée radicale du Rav Kook est devenue une doctrine populaire actuelle, soutient fort justement qu’il a fallu attendre une génération pour que cette pensée se fraie un chemin vers les couches populaires et revêt l’expression d’un programme politique (p.170-171). C’est d’ailleurs, le fils, Tsvi Yéhouda Kook qui a transplanté la vision de son père du monde des idées au monde des faits. Ce passage a été rendu possible par la guerre des Six Jours laquelle a fait germer les conditions de l’assimilation de l’espérance messianique. « La foi messianique du Rav Kook et l’espoir d’un avenir optimiste ont revêtu une dimension solide faite de certitude messianique et d’une connaissance indubitable de l’avenir. » (p.172) Ravitsky prétend que, malgré la similitude de pensée entre le Rav Kook et son fils, ce furent la Shoah et son empreinte qui ont conféré à la conception messianique du fils son efficacité et sa crédibilité. La Shoah n’avait pas trouvé son insertion dans la vision optimiste du père entièrement fondée sur la notion, héritée des Lumières, de progrès universel. (p.174-175) Le Rav Tsvi Yéhouda Kook « expliquait la Shoah comme une destruction et une éradication de la culture chancelante de la diaspora » (p.176) Il est intéressant de noter que les deux camps de l’orthodoxie radicale : les antisionistes et les sionistes messianiques ont sais la Shoah comme un événement qui renforce et affermit leur conception. Les premiers y percevant un châtiment collectif pour la précipitation du dénouement/déh’iqat haqets par les sionistes alors que ces derniers attribuaient le châtiment collectif au non-discernement du dénouement. Aveuglement qui a provoqué « une intervention cruelle de Dieu de rupture avec la diaspora motivée par “le mépris [affiché] du pays délicieux” (Ps 106, 24) » et perçu, dès lors, comme une trahison envers le pays et envers…Dieu. Si bien que pour les partisans de ce camp, la rédemption ne dépendait plus des actions du peuple juif mais suivait son cours propre inscrit dans le programme de l’univers, processus qui devait nécessairement aboutir - indépendamment des actions du peuple. L’orthodoxie non-messianique Le chapitre IV « L’exil d’Israël en terre sainte : le dilemme du judaïsme orthodoxe » craignant Dieu ou h’arédi examine la position de l’orthodoxie non messianique-fondamentaliste. Les partisans de ce camp évaluent l’Etat « selon sa capacité à épauler et soutenir effectivement les adeptes de la Torah et ceux qui se consacrent à son étude et, selon le rapport de ses dirigeants et de ses citoyens aux exigences de la halakha. » (p.201) Ravitsky distingue entre les différents groupes qui entrent dans la composition du camp de l’orthodoxie fondamentaliste. Le critère de distinction est soit ethnique soit en rapport avec la modernité. L’Etat est perçu comme une réalité diasporique non seulement au niveau théologique mais aussi au niveau existentiel suite au sentiment d’étrangeté et d’aliénation qu’ils éprouvent devant les événements qui s’y déroulent. Ce sentiment est d’ailleurs commun aux Hassidim et aux Lituaniens qui constituent l’essentiel des effectifs de ce groupe. (p.205) Ravitsky souligne que des trois arguments opposés aux sionistes par les h’aredim : précipitation du dénouement, création d’un Etat
56
illusoire et irréel, mû par un nationalisme laïc qui met en danger la nation juive, le dernier est celui qui perdure. C’est autour de lui que s’est condensé l’opposition des h’aredim Selon eux, l’Etat n’a aucune signification religieuse et le rapport qu’il s’agit d’instaurer avec l’institution étatique est purement instrumental. Sa fonction étant d’assurer des services, il sera jugé à la manière dont il sert les tenants de la Torah et ceux qui se consacrent à son étude, mais comme l’Etat n’a aucune signification religieuse, on ne saurait lui appliquer des critères de jugement religieux (p.210 et 214) Malgré le rapport des h’arédim à l’Etat comme institution neutre du point de vue religieux, ces groupes restent attentifs à l’histoire telle qu’elle est saisie et comprise par la majorité. Comme ils sont sûrs que le processus historique est providentiel, tout ce qui est considéré comme réussite sur ce plan est justifié religieusement, par exemple : la déclaration Balfour, la création de l’Etat ou la guerre des Six Jours (p.217-223). C’est ainsi que même si la conception de la rédemption dominante dans ce camp exige une passivité absolue, il reste que, selon eux, « la rédemption divine surviendra en un clin d’œil ». Toutefois, à cause de l’hérésie et du reniement de la foi53, l’on se trouve immanquablement dans l’étape des signes avant-coureurs du messie/ ‘iqvéta
démeshih’a. Cependant, seuls la Torah et la repentance peuvent sauver Israël des souffrances de la gestation du messie (p.235) « C’est une conception paradoxale de la rédemption, car les pas du messie et l’avènement du messie ne se situent pas dans une continuité historique mais se présentent comme une chose et son contraire : que la lumière vienne et dissipe l’obscurité ! Les pas du messie éveillent l’espoir que la rédemption interviendra comme une irruption, à partir du bas de l’échelle » (p.237), c’est-à-dire à partir de la situation la plus désespérée. Car le camp des h’arédim a le sentiment que dans l’Etat d’Israël se fomente une « rébellion collective contre le royaume des cieux » (p.248) Habad, du conservatisme au messianisme
Le chapitre V consacré au mouvement Habad (Loubavitch) s’intitule : « Du conservatisme au messianisme. » C’est une radiographie de ce mouvement h’assidique tel qu’il se présente « aujourd’hui54 ». Ce qui suppose une dynamique, une « évolution » dans les conceptions antérieures qui ont présidé à sa naissance. Ravitsky y distingue un tournant idéologique : du conservatisme de Rabbi Shalom Douber (1840 ?-1908) qui déclara et livra la « guerre » à la modernité et aux sionistes, jusqu’à l’agitation messianique de Rabbi Menahem Mendel (1902-1994). Du point de vue théologique, Habad n’établit pas aujourd’hui de distinction entre le saint et le profane ni dans l’espace, ni dans le temps. La présence de Dieu est 53 « Dire de Rabbi Itsh’aq :“Le fils de David ne viendra que lorsque la royauté sera hérétique”. » (Sanhédrin 97 a) 54 C’est-a-dire avant la mort du dernier rabbi de Loubavitch, R Menahem Mendel Schneerson, le dernier rabbi de la « dynastie ». Depuis, il n’y en a plus.
57
perceptible dans chaque acte et chaque pensée, dans chaque lieu et à chaque moment, c’est-à-dire dans chaque parcelle de la réalité. « Le h’assid de Habad est appelé à devancer cette réalité (où l’on ne distingue plus entre le saint et le profane) et à l’anticiper dans l’existence actuelle. Il est invité, selon la terminologie habadique, à “goûter, dès à présent, le goût de la rédemption future”. » (p.254) C’est ainsi aussi que Ravitsky explique le rapport positif de Habad à la technologie moderne et à la science contrairement aux autres courants de l’orthodoxie fondamentaliste. C’est une approche « d’extension de la sphère religieuse » à tous les aspects de la vie y compris les techniques modernes, à distinguer de l’approche « limitative » ou de « rejet total de la modernité » (p.257) Ravitsky constate, de ce fait, une proximité entre le monde de Habad et celui du Rav Kook tant sur le plan de l’approche métaphysique du séculier que de l’aspiration à la rédemption universelle (p.260-262). A ce sujet les quelques divergences qui subsistent autour de la modalité messianique de l’Etat d’Israël s’estompent. En revanche, l’agitation messianique55 qui s’est emparée de Habad au début des années 1990 et jusqu’à 1995 risque d’ébranler cette proximité de vues sur la rédemption. Les trois serments L’annexe traite du premier des trois serments : « qu’ils ne montent pas en masse » ou en employant les armes et de leur impact dans l’histoire juive. Ravitsky passe en revue les sources halakhiques et théoriques instrumentalisées par ceux qui hésitaient de se lancer dans le courant messianique. Un autre chercheur, Mordékhaï Breuer qui avait traité ce sujet avait conclu que ces serments n’ont joué aucun rôle dans la décision des Juifs de monter ou non en Israël pour s’y installer. Ils concernaient, disait-il, la situation diasporique. Ravitsky conteste cette conclusion et soutient que les serments ont joué un rôle crucial dans les débats concernant l’installation en terre d’Israël au cours des générations. L’utilisation qu’en fait l’orthodoxie antisioniste ne se confine pas seulement au niveau de l’argumentation. Elle a force de loi. « La crainte de l’installation en masse tire sa source dans la prestation de serments prononcés par Israël, selon le Talmud et le Midrach, d’accepter le joug de l’exil » (p.277-278) Les trois serments ont servi véritablement à repousser et à dissuader tout candidat à l’installation en Israël. En conclusion, Ravitsky présente des courants religieux non-radicaux et non-messianiques qui considèrent l’Etat comme « un modèle historique intermédiaire » et vivent en paix avec la réalité qui n’est ni exil, ni rédemption (p.308). Ils soutiennent la renaissance nationale fût-elle détachée de la rédemption religieuse. Ils trouvent un sens dans la construction d’un monde « pré-messianique » et s’arriment au principe de l’alliance entre Dieu et son peuple. C’est pourquoi l’Etat sera jugé à l’aune de ses 55 Sur ce point précis, nous nous permettons de renvoyer à notre Le messianisme, PUF, Paris, 1998, collection « Que sais-je ? » n° 3377, p.118-124
58
actions effectives et non pas à l’aune d’un principe a priori. Ils se contentent de son caractère incomplet car « la promesse prophétique de l’avenir est absolue, fixée et prévue mais sa concrétisation en une génération déterminée sera, à jamais, incertaine. » (p.310) On sent que Ravitsky expose là sa conception personnelle qui est somme toute modérée et qui donne à cette fresque magistrale56 une touche de réalisme qui reconduit à l’histoire et à ses aléas. 56 Il est regrettable que Ravitsky n’ait pas consacré un chapitre à « l’orthodoxie sépharade » dont un des épiphénomènes est le parti Shass, même si les Sépharades ont été soumis à un phénomène d’acculturation sans précédent dans leur rapport à la Torah et à la religion juive de la part de l’orthodoxie lituanienne et/ou hassidique. A ce sujet, voir Yaacov Lupo, Métamorphose ultra-orthodoxe chez les Juifs du Maroc.(comment les sépharades sont devenus ashkénazes), Préface de Shmuel Trigano, Editions L’Harmattan, Paris, 2007
59
A cura dell’ AME Italia (Associazione Medica Ebraica) L’ evoluzione della Medicina in Israele
A Parma, a questo Moked, AME Italia partecipa con piacere per voce di Germano
Salvatorelli, ordinario di Istologia all’ Università di Ferrara e mia, Maria Silvera,
psicologa, di Milano, ricordando che la prima assemblea, da cui era emerso il primo
Consiglio dell’ Associazione del quale siamo membri, si è svolta proprio in seno a un
Moked, nel 2003.
Coerentemente con il tema che si dibatte qui, in questi giorni, faccio notare che una
delle linee costituenti dell’ AME Italia è la relazione con Israele e, in particolare, con i
medici israeliani. Questa relazione fa parte della rete internazionale formatasi molti
anni fa, che raccoglie rappresentanti delle diverse associazioni mediche ebraiche e che
è sempre stata coordinata da medici israeliani appartenenti all’ Israel Medical
Association.
E’ questa la fonte prevalente delle informazioni che riceverete e dei posters che vedete
affissi.
Da essi, in particolare, si evince come l’ attività dei colleghi non si limiti alla cura dei
loro connazionali, da ogni dove viene apprezzato l’ operato di professionisti la cui
competenza è stata notevolmente arricchita dall’ esperienza dovuta, purtroppo, alle ben
note situazioni. Medici israeliani ebrei curano pazienti palestinesi, volano in Africa
piuttosto che in Canada, in casi di emergenze naturali e non.
Ascoltiamo, ora, la relazione del prof. Salvatorelli che darà una precisa immagine del
panorama medico israeliano.
Maria Silvera
Germano Salvatorelli
L’evoluzione del Servizio Sanitario in Israele
All’inizio del XIX secolo malattie come la dissenteria, la malaria, il tifo e il tracoma erano endemiche nella Terra d’Israele, una regione periferica e di scarsa considerazione da parte del governo dell’Impero Ottomano. Al fine di fornire servizi sanitari per la popolazione ebraica di Gerusalemme un certo numero di cliniche create dalle comunità ebraiche europee avevano fornito servizi medici gratuiti per chi era incapace di pagare tali servizi. Queste cliniche si erano successivamente espanse per diventare ospedali capaci di offrire servizi utilizzando tecnologie mediche avanzate per l’epoca (Bikur Holim 1843, Misgav Ladach 1888, Shaare Zedek 1902) . L’Hadassah Medical Center di Gerusalemme, con scuole di medicina, infermieristica e due moderni ospedali, fu istituito nel 1913 dall’Hadassah Women’s Zionist Organization statunitense.
60
Il sistema sanitario, che includeva una rete di servizi medici per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie, continua anche durante il periodo del mandato inglese (1918-1948). Alla nascita dello Stato di Israele funzionava quindi una infrastruttura medica ben sviluppata capace di ulteriori evoluzioni. Attualmente Israele possiede un servizio sanitario di alta qualità per quanto riguarda le risorse e la ricerca, moderne strutture ospedaliere e un buon rapporto di medici e specialisti rispetto alla popolazione. Questa situazione ottimale si riflette nella bassa mortalità infantile (4,6 ogni 1000 nascite) e una lunga aspettativa di vita (82,3 anni per le donne e 78,3 per gli uomini). Le cure mediche sono estese per legge a tutti dall’infanzia alla vecchiaia e, le spese per la salute (8,2% del bilancio dello stato), sono comparabili a quelle degli altri stati più sviluppati. La popolazione può quindi contare su ospedali, ambulatori e centri per la medicina preventiva e la riabilitazione. I servizi ospedalieri includono procedure e tecniche avanzate quali la fecondazione in vitro, chirurgia cerebrale, trapianto di midollo osseo e di organi. Sono inoltre presenti centri per le donne durante la gravidanza e per i bambini dalla nascita alla prima infanzia, che offrono anche servizi di esami prenatali, diagnosi precoce di malattie mentali e fisiche, vaccinazioni, visite di controllo pediatrico ed educazione sanitaria. La responsabilità per tutti i servizi è del Ministero della Salute che prepara la legislazione e sovraintende al suo adempimento. Esso controlla anche lo standard medico nazionale, mantiene standard per la qualità del cibo e delle medicine, promuove la ricerca medica, valuta i servizi sanitari e sovraintende alla pianificazione e alla costruzione di ospedali. Il Ministero agisce anche come un’agenzia di sanità pubblica anche per quanto riguarda l’ambiente e la medicina preventiva . In Israele circa 27000 medici esercitano la loro professione come membri di staff ospedaliero e degli ambulatori, o come liberi professionisti. Esistono 4 Facoltà di Medicina, 2 di Odontoiatria, 1 di Farmacologia e circa 20 scuole per infermiere 4 delle quali rilasciano un titolo accademico. Sono inoltre disponibili Corsi per Fisioterapisti, Terapisti delle Malattie Professionali, Nutrizionisti, Tecnici di Radiologia e Tecnici di Laboratorio. Precedentemente al 1995 l’assicurazione malattia era volontaria, circa il 95% della popolazione era assicurata con una delle Health Maintenance Organizations (Clalit 54,3%, Maccabi 23,1%, Meuhedet 12,5% e Leumit 9,8%) e il “paniere” dei servizi non era chiaramente definito. Dal 1995, data di emissione della Legge di Assicurazione Nazionale per la Salute (NHI), il Sistema Sanitario Israeliano, che è stato esteso al 100% della popolazione si basa su 3 livelli di assicurazione sanitaria, la così detta piramide (fig.1).
61
National Health
Insurance 100%
1
Supplemental Health
Services 72%
2
Private Health
Insurance 34%3
Figure 1: The Israeli Health Insurance Model 2006
Percentage of coverage
La base della piramide è gestita dallo Stato e copre praticamente il 100% della popolazione. Il Governo finanzia i servizi sanitari attraverso una quota capitaria basata sull’età e i fornitori dei servizi sono le quattro HMO (Health Maintenance Organizations) più il Ministero della Salute che inoltre supervisiona e fornisce assistenza geriatrica, psichiatrica e servizi di prevenzione. Viene assicurato a tutti gli israeliani un Basic Basket of Service che include: visite mediche, servizi diagnostici e di laboratorio, servizi paramedici quali terapia fisica e logopedia, servizi di riabilitazione, l’ospedalizzazione incluso il parto e la prescrizione di farmaci. La maggior parte dei servizi richiede un co-pagamento che varia da 7NIS per il medico di famiglia a 23NIS per visite ambulatoriali in ospedale. Il secondo livello è assicurato dalle quattro HMO non profit che forniscono i servizi direttamente o attraverso privati che hanno contratti con queste organizzazioni. Le HMO forniscono differenti contratti assicurativi di servizi supplementari quali visite specialistiche, consulti con liberi professionisti, servizi odontoiatrici, interventi chirurgici all’estero e medicina alternativa (chiroteapia, omeopatia, ecc). La punta della piramide è coperta da assicurazioni private e anche i servizi sono forniti da privati. L’assicurazione sanitaria privata copre operazioni costose, trapianti, trattamenti salva-vita in Israele e all’estero, gravi malattie e terapie a lungo termine. Estende anche la propria attività per persone incapaci delle normali attività quotidiane (compreso l’Alzheimer) e che necessitano di assistenza in servizi residenziali o a domicilio. In Israele sono presenti:
• 29 ospedali per complessivi 14200 letti • 21 ospedali psichiatrici per complessivi 3150 letti • 272 ospedali per malati cronici per complessivi 18200 letti
La politica generale è quella di diminuire i ricoveri ospedalieri e di aumentare l’efficienza degli ambulatori. Ne consegue un basso rapporto tra numero dei letti e popolazione (2,2 letti per 1000 persone), una bassissima media annua di degenze (4,1 giorni a persona) e un’alta percentuale di letti occupati (99%).
62
Per quanto riguarda la salute mentale è stato sancito il diritto legale alla terapia e una migliore integrazione fra cure fisiche e mentali. Viene inoltre favorito lo “shift” dall’ospedale ai servizi di comunità psichiatriche. Nel caso dei servizi geriatrici, sono stati sviluppati appositi centri con personale specializzato. Si intende migliorare le cure geriatriche incrementando la qualità dei servizi medici e realizzando un servizio di outsercing nel settore privato, aggiungendo l’assicurazione per il ricovero da parte delle HMO. Il Servizio Sanitario Israeliano prevede anche tre approcci col paziente del tutto innovativi. 1. Servizio infermiere/medico On Call Questo servizio offre l’accesso telefonico immediato 24 ore dei pazienti verso infermieri / medici comprendenti:
� Consigli di emergenza medica. � Invio di mezzi di emergenza medica. � Informazione medica non di emergenza. � Counseling medico non di emergenza. � Consigli medici generali non di emergenza.
2. Servizio Web Il servizio web è un servizio integrato per i pazienti che permette l’accesso alla cartella clinica personale ed informazioni mediche riguardanti:
� Recupero di risultati di laboratorio � Situazione sanitaria personale � Fattori di rischio cardiaco � Dieta & nutrizione � Lista personale di farmaci
Offre inoltre un knowledge base con servizi di applicazione amministrativa come: � Programmazione, Contabilizzazione & Assicurazione
Il Servio Web offre inoltre gestione di appuntamenti e offerta di informazioni quali: � Web e SMS per la gestione di appuntamenti � Management di programmi di lavoro di medici e ambulatori � Software per la programmazione rapida CSR � SMS di promemoria per ridurre i “No Show” � Creazione di “Knowledge Base”
3. Servizio di Tele-medicina Permette l’implementazione e l’integrazione di informazione della di Cartella Clinica per pazienti con altri sistemi sanitari ed è atto a migliorare:
� Qualità dell’assistenza � Riduzione degli errori � Riduzione dei costi amministrativi � Migliore uso del tempo dei professionisti � Riduzione della ripetizione dei test � Riduzione dei ricoveri ospedalieri
63
� Riduzione della durata del ricovero � Migliore efficacia e qualità delle cure � Migliore qualità di vita
Nel campo delle cardiopatie coronariche, ad esempio, sulla totalità dei pazienti che si presentano in pronto soccorso per dolore toracico, il 60% viene ricoverato ma solo il 20% di questi pazienti ha realmente subito un infarto del miocardio. È tuttavia possibile, utilizzando appositi dispositivi di costo relativamente basso e di facile utilizzo, eseguire a domicilio, da parte dei pazienti in caso di sospetto infarto, un ECG e un esame ematico di markers di danno miocardico(troponina-I e mioglobina). Questi esami possono essere trasmessi via telefono o web ad un centro capace di fare rapidamente diagnosi di infarto e provvedere tempestivamente all’invio di un’ambulanza. In caso di infarto è da ricordare che dopo 4 ore i danni al miocardio divengono irreversibili e quindi la velocità di intervento gioca un ruolo fondamentale sulla prognosi. Se gli esami risultano negativi il centro ha il compito di rassicurare il paziente. Questa rete di servizi di tele-medicina è attualmente in uso negli USA, in Germania ed in Israele e ciò a si che anche in questo campo la medicina israeliana si ponga all’avanguardia per quanto riguarda una medicina di tipo innovativo e quindi di maggior efficacia. Riprendo, ora, la parola per portare la testimonianza di Alessandro Viterbo che da
Israele, attraverso una lettera che sintetizzerò, ci fa conoscere un’ associazione molto
interessante sia dal punto di vista medico sia da quello sociale.
Alessandro Viterbo
Tsad Kadima “Un passo avanti”
Alessandro Viterbo, originario di Padova, vivo da 31 anni in Israele, sposato, ho due figli, Adina di 19 anni, ora soldatessa, e Yoel di 14, cerebroleso dalla nascita.
Ringrazio l'Associazione Medica Ebraica per avermi dato la possibilità di presentarvi "Tsad Kadima".
La storia di "Tsad Kadima " è l'esempio di come un’ idea, un’ innovazione importata da fuori, sia stata sviluppata e perfezionata in Israele tanto da essere presa come modello e da essere corteggiata da enti esterni.
(Vorrei ricordare a questo proposito anche il metodo Feuerstein che viene scelto nell’
ambito dell’ aggiornamento degli operatori di diversi Servizi di Neuropsichiatria
Infantile in Italia per adottarlo come metodo terapeutico innovativo. Ciò dimostra
ulteriormente l’ esistenza di una proficua interazione fra Israele e altre Nazioni, tra le
quali l’ Italia.).
"Tsad Kadima" è un associazione di genitori che si occupa di organizzare e aiutare il
64
percorso formativo dei bambini che soffrono di lesione cerebrale in Israele, a prescindere dalla religione, dal credo o dall'appartenenza etnica. "Tsad Kadima" vede come scopo principale l’integrazione dei bambini e ragazzi cerebrolesi nella società normale e si adopera per rendere la cosa possibile nonostante le gravi limitazioni fisiche delle quali soffrono.
Essa nasce da alcuni genitori israeliani che prendono l'iniziativa di cercare qualcosa di più per i loro figli cerebrolesi dalla nascita. Durante l'estate del 1987, infatti, prendono i loro figli, tutti dell’ età di circa 4-6 anni, e li portano a Budapest rincorrendo un’ idea proposta da un servizio televisivo: un metodo diverso per riabilitare i bambini cerebrolesi. Si tratta del metodo dell'educazione conduttiva che mette la figura del bambino e la sua personalità al centro dell'attenzione. Ritornati in Israele questi genitori si organizzano e in breve inviano 10 studenti a imparare il metodo direttamente all' Istituto di Budapest.
Nel giro di alcuni anni e una volta diventati gli studenti "conduttori di programmi ", gli stessi genitori aprono il Centro di Rishon Lezion. Siamo nel 1992 e abbiamo 2 classi e 12 bambini.
Tsad Kadima è attiva oggi in molte città israeliane e svolge attività e progetti per più di 320 bambini e ragazzi dai primi anni di vita fino a oltre i 21 anni.
• Asili nido riabilitativi a Rishon Lezion(centro principale), Beer-sheva ed Eilat. • Asili (2-6 anni) a Rishon Lezion, Hasharon, Natania, Beer-Sheva. • Classi di integrazione a Rishon Lezion e Carmiel. • Attivita' rieducative completative (pomeriggio) a Gerusaleme e Haifa. • Appartamenti di apprendimento a Gerusalemme e Rishon Lezion. • Appartamento di abitazione fissa a Gerusalemme. • Gruppo adulti a Kiriat –Haim (Haifa). • Campeggio estivo per 35 ragazzi.
Il metodo che "Tsad Kadima " applica è, in sostanza, un metodo educativo psicologico che mette la personalità del bambino al centro del lavoro riabilitativo. Scopo del metodo quindi è quello di aiutare il bambino cerebroleso ad apprendere vie alternative per superare le limitazioni fisiche. Il processo di riabilitazione, perciò, implica l'apprendimento e l'applicazione di tecniche e metodologie che incoraggiano il bambino ad attivare le proprie capacità.
Il successo di "Tsad Kadima " consiste nell’ aver costruito un sistema aperto a ogni innovazione, dove è continuo il lavoro di ricerca, con progetti pilota nei vari Centri e perfezionamenti dei programmi esistenti, che mette in armonia gli aspetti educativi con quelli medico riabilitativi ( tra gli aspetti riabilitativi funzionali: l'idroterapia, la logopedia, la fisioterapia applicata) presentando a bambini e a genitori un quadro
65
completo. Si tratta, in definitiva, anche di un modo di vedere la vita del giovane cerebroleso dall'età più giovane fino all'età adulta.
Alcuni dei ragazzi cresciuti nei centri di "Tsad Kadima" studiano oggi all’Università, sono soldati nell’esercito,vivono da soli in appartamenti adattati alle loro esigenze, lavorano a seconda delle proprie possibilità.
Per sottolineare e festeggiare i 20 anni di attività " Tsad Kadima" ha organizzato un congresso internazionale che si è tenuto nel mese di dicembre 2007 a Tel Aviv, durante il quale sono stati discussi i temi professionali dell'educazione e riabilitazione dei giovani cerebrolesi e a cui hanno partecipato esperti provenienti da più di 10 Paesi diversi tra i quali Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Spagna, Ungheria, India, dimostrando, così, di rappresentare un forte punto di riferimento sia sul piano interno israeliano sia su quello internazionale. I suoi rappresentanti, infatti, sono spesso chiamati a portare la loro esperienza nel quadro di congressi, incontri e tavole rotonde. Il congresso e' stato organizzato in stretta e attiva cooperazione con il Dipartimento di Neurologia Infantile dell'Ospedale Shaare Zedek di Gerusalemme, la Scuola di Riabilitazione Funzionale dell'Università e dell’ Ospedale Hadassah di Monte Scopus e l'Associazione Istruttrici "Bobat " di Fisioterapia.
In questi ultimi anni si sono sviluppati legami professionali anche con molte istituzioni simili in Italia: al congresso ha partecipato una delegazione italiana e molte sono le richieste di informazioni.
A testimonianza dell’ evoluzione, nel corso degli anni, dell’ Associazione da metodo sperimentale a modello riconosciuto faccio presente, per esempio, che sta prendendo corpo un accordo di cooperazione con un istituto lombardo della provincia di Como che porterà presto personale medico ed educativo a venire a studiare i nostri metodi e le nostre applicazioni. (Forse mentre ne stiamo parlando è già passata la delibera
relativa)
La precaria situazione di questi anni porta la nostra Associazione a compiere un continuo sforzo per assicurare un regolare e continuo svolgimento dei programmi. Una parte delle attività, specialmente quelle extra scolastiche, non ricevono alcun appoggio governativo e si reggono sulla possibilità di trovare un finanziamento adatto. Alcuni dei nostri programmi sono stati in passato sostenuti da aiuti pervenuti da privati e associazioni italiani, a tutti loro invio il nostro più sentito ringraziamento.
A disposizione per qualsiasi domanda, vi ringrazio per l'attenzione e vi mando a nome della famiglia “Tsad Kadima” un cordiale e affettuoso Shalom.
Alessandro Viterbo, Alroy 5-B, Gerusalemme, Tel. 00972- 2-5667871- 508801450 Fax 026540069 - e.mail [email protected] - www.tsadkadima.org.il
66
Conclusioni
Victor Magiar
Un assillo, una sfida: lo stacco generazionale
Quello di Parma è stato senz’altro un bel Moked che, ricco di discussioni importanti e di ottimo livello, è riuscito a fornire punti di vista molto diversificati non solo sui sessant’anni dello Stato d’Israele e sul sionismo ma anche sul tema della trasmissione dei valori. È emerso con forza un tema che a me sta molto a cuore, e che è diventato il mio principale “assillo”: lo stacco generazionale che ha messo in crisi quella trasmissione d’idee e ideali che per decenni avevano tenuto insieme il mondo ebraico. E’ da qui che si deve partire per restituire nuove prospettive di riflessione. Negli ultimi due anni, grazie anche al contributo del mio predecessore Dario Calimani, abbiamo innovato in modo profondo il modo di lavorare, attivando sulle tematiche culturali una stretta sinergia che, accanto al Dipartimento educazione e cultura diretto da Rav Roberto Della Rocca, coinvolge tutte le altre strutture Ucei, in particolare quella dei giovani. I risultati sono molteplici. Mentre proseguono le attività volte alla comunicazione con l’esterno, quali il Giorno della Memoria o la Giornata della Cultura Ebraica, stiamo portando avanti un’attività di formazione che coinvolge tutte le Comunità. E’ stata avviata infatti una serie d’incontri con i presidenti e i rabbini per discutere le prospettive del mondo ebraico italiano. Il numero degli iscritti sta calando in modo drammatico e per i giovani le nostre istituzioni mancano di appeal. I pilastri ideologici di altre generazioni ebraiche sono da loro vissuti in modo meno coinvolgente, più intellettuale. Israele, il sionismo e la memoria della Shoah, appunto i pilastri ideologici d’intere generazioni di ebrei italiani ed europei. I quarantenni di oggi hanno introiettato nel profondo queste tematiche, ma per i giovani sono ormai questioni di valenza molto diversa, vissute in termini più intellettuali e con minore coinvolgimento valoriale. In una battuta: per chi oggi ha vent’anni Israele non è il miracolo che fu per noi, ma un fatto scontato. Anche la memoria ha un impatto diverso: senza implicazioni dirette sul quotidiano, è qualcosa vissuto dai nonni e dai bisnonni, e a volte non ci accorgiamo che lo stesso lessico usato un tempo per trasmettere questi valori è cambiato. Per capire come si può trasmettere ai giovani l’esperienza ebraica è necessario un lavoro di recupero dei nostri valori più profondi. Studiando nuovi linguaggi e nuove tecniche per farlo e valorizzando i tanti strumenti che rimangono validi. E’ la preoccupazione principale che ci accompagna nella nostra programmazione culturale e che ci assilla
67
ogni qualvolta ci apprestiamo a programmare la Giornata della memoria o la Giornata della cultura ebraica. C’è senz’altro una preoccupazione sul modo in cui si affrontano, nella società italiana e nelle nostre comunità, la Giornata della memoria o la Giornata della cultura ebraica. In una società che offre migliaia di sollecitazioni e che attraversa una profonda crisi morale ed economica non possiamo infatti dare risposte di maniera o scontate. Sappiamo che gli aspetti cerimoniali, soprattutto del giorno dedicato alla memoria, sono deleteri. Dobbiamo dunque evitare la ripetitività e i momenti di circostanza. Per questo chiediamo alle Comunità e a quanti promuovono le iniziative di puntare sulla cultura e sull’istruzione: meglio una cerimonia di meno e una borsa di studio in più. Entrambe le manifestazioni rimangono comunque ottime occasioni di comunicazione che sortiscono ottimi riscontri. Ma anche i risultati positivi possono avere un “rovescio della medaglia”. Un tema che mi angoscia è proprio l’iperattivismo ebraico, che tanto spesso ha anticipato o è coinciso con gravi crisi storiche. Stiamo vivendo una stagione difficile dal punto di vista economico mentre risorgono nazionalismi e razzismi. Come è accaduto altre volte, la nostra grande tensione d’attività potrebbe distoglierci dal vedere la catastrofe che incombe. Una società in crisi diventa infatti pericolosa per le minoranze. Basti pensare alle pulsioni di fastidio e intolleranza già manifestatesi nei confronti dei rom. Se non saremo capaci di tenere gli occhi bene aperti potremmo non capire quanto sta accadendo e non essere in grado di porvi riparo. Tornando agli aspetti pratici del Moked, che hanno ovviamente impatto sulla qualità dell’evento e sulla sua “ricaduta” nelle nostre comunità, registro un unico vero neo: un’esperienza di riflessione così importante dovrebbe coinvolgere un numero maggiore di persone. Ritengo quindi che debbano essere nostri precisi obiettivi per il futuro l’ampliamento e il ringiovanimento dei partecipanti. È vero che la partecipazione al Moked invernale è più difficile per le famiglie sia per gli impegni lavorativi che per l’avvicinarsi delle vacanze scolastiche. Sappiamo però che un serio ostacolo è la quota economica di partecipazione che per molti può risultare elevata. Abbiamo approfittato del Consiglio Ucei svoltosi l’ultimo giorno del Moked, e a cui hanno preso parte i presidenti di Comunità, per discutere proprio di queste difficoltà. Abbiamo individuato alcune possibili soluzioni: innovazioni tecniche per abbassare le quote e ricorso ai fondi dell’otto per mille per aiutare le Comunità a “regalare” a una famiglia la partecipazione all’incontro. Per tutto questo stiamo ipotizzando nuove formule organizzative per i prossimi Moked che vorremmo più lievi, attraenti e innovativi: un contributo alla crescita di comunità vive e consapevoli.
68
A cura di Lucilla Efrati, Daniela Gross,Valerio Mieli, Guido Vitale
Dossier Moked autunnale 5769 / Interviste
Israele, le culture minoritarie, la crisi dei numeri e le nuove sfide degli ebrei italiani. Il Moked autunnale 5769 in un dossier che raccoglie il lavoro della redazione del Portale
dell’ebraismo italiano.
Portare vita nelle piccole comunità
“Inizia questa sera, con l’entrata dello Shabbat, il Mokèd autunnale 5769 che durerà fino a lunedì 8 dicembre. Siamo a Parma dove ci incontreremo con i pochi ebrei rimasti della locale Comunità e dei dintorni con i quali domattina faremo la Tefillà e la lettura del Sefer Torà nel Bet Ha-Keneset di Vicolo Cervi. Più si riducono i numeri del nostro ebraismo più abbiamo bisogno di trovarci e mantenere vivi i contatti. Per questo il DEC organizza i suoi Mokèd in Comunità piccole e decentrate, dove porta ebrei da ogni altra Comunità a vivere insieme vita e cultura ebraica, e si fa Shabbàt con chi non ne ha mai la possibilità”. Rav Roberto Della Rocca, direttore del Dipartimento Educazione e Cultura dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Il grande incontro degli ebrei italiani
Sarà la riapertura della Sinagoga di Parma a suggellare, sabato mattina, la nuova edizione del Moked, l’ormai tradizionale incontro dell’ebraismo italiano, dedicato quest’anno ai 60 anni dello Stato d’Israele, in corso nella cittadina emiliana. La Tefillà del mattino, la lettura del Sefer Torah e poi il kiddush. Per qualche ora, grazie alla partecipazione degli iscritti al Moked, la piccolissima Comunità parmense - meno di cinquanta persone - rivivrà così attimi d’intensa vita ebraica. Non a caso, d’altronde, il Moked - la convention organizzata dal Dipartimento educazione e cultura (Dec) dell’Ucei - fin dagli esordi privilegia come sede le piccole Comunità. “Queste occasioni -spiega infatti il direttore del Dec rav Roberto Della Rocca - hanno un duplice obiettivo. All’approfondimento di tematiche culturali di particolare rilevanza si accompagna infatti un forte impegno di socializzazione”. “L’ebraismo italiano - prosegue - è fortemente penalizzato dalle distanze geografiche che rendono molto difficili gli incontri e gli scambi tra gli iscritti alle diverse Comunità. Eventi come il Moked sono dunque una scommessa di relazione”. E accanto alla socialità, la cultura. Al centro dell’edizione in corso, che si conclude lunedì, i 60 anni d’Israele e il sionismo. “Vi sono due argomenti - dice rav Della Rocca - che oggi nell’ebraismo sono trattati con grande retorica ed emotività: il sionismo e la Shoah. Intorno a queste due tematiche, in realtà molto poco elaborate e conosciute si
69
sono costruiti simbolismi e una sorta di religione”. Uno degli obiettivi del Moked è invece proprio quello di ragionare e discutere. Per questo fino a lunedì a Parma intellettuali, studiosi e storici si confronteranno su contenuti e prospettive del sionismo, analizzandone i tantissimi risvolti culturali, religiosi e filosofici. “La speranza - dice rav Della Rocca - è di riuscire ad andare oltre le semplificazioni, le etichette preconfezionate e le sterili contrapposizioni restituendo invece alla sua complessità un tema di stringente attualità”.
“Nel 1948 si è aperta un’epoca di nuove sfide e opportunità”
“Se ci soffermiamo a paragonare la nostra condizione di ebrei negli ultimi 60 anni, con quella che ha caratterizzato la vita dei nostri genitori, dei nostri nonni e, risalendo indietro nel tempo, dei nostri antenati, abbiamo l’impressione di essere entrati in una nuova epoca nella quale l’ebreo come individuo e gli ebrei come collettività hanno assunto una connotazione e un ruolo molto diverso rispetto al passato. Mi pongo spesso la domanda: stiamo vivendo un periodo eccezionale o per caso appare a noi un fatto eccezionale iniziare a rientrare nella normalità? (godimento dei diritti civili, rispetto, integrazione nella società). Per gli ebrei italiani l’anno 1948, durante il quale è stata promulgata la Costituzione Repubblicana ed è nato lo Stato d’Israele, ha assunto il valore simbolico di un momento di svolta che ha investito tutti gli aspetti della nostra vita, su piani diversi ma convergenti:istituzionale e giuridico culturale e religioso personale e psicologico. Da quel momento è iniziato anche un graduale e progressivo cambiamento sia dell’immagine che gli ebrei proiettano all’esterno, sia del ruolo che essi sono chiamati a svolgere nella società di cui sono parte integrante. In questi ultimi anni è capitato spesso a noi stessi di rimanere stupiti dall’importanza che è stata attribuita, sia nel mondo della politica, che in quello della cultura, alle nostre opinioni, alle nostre adesioni o ai nostri rifiuti, alla nostra partecipazione o meno agli eventi più disparati. Il nostro peso specifico nella società è fortemente aumentato e tende ancora a crescere tanto che a volte sentiamo la necessità di regolare e contenere questa tendenza per evitare una sovraesposizione che, alla lunga, potrebbe apparire sproporzionata e diventare controproducente. Ma quali sono le cause e quali saranno gli effetti di tutto ciò? Certamente ha contribuito la crisi di tutte le ideologie, che a lasciato molti, soprattutto i giovani, senza punti di riferimento stabili. Hanno certamente contribuito anche le due terribili e grandi vicende storiche del secolo scorso: la Shoà e la nascita dello Stato d’Israele. Entrambe hanno imposto all’attenzione del mondo la particolarità della nostra plurimillenaria esistenza, la nostra cultura, la nostra religione. Per arrivare al tema centrale di questo Mokèd, è interessante, giusto ed opportuno che venga da noi nuovamente approfondito l’argomento del Sionismo e della nascita e sviluppo dello Stato d’Israele, anche nell’ottica della vasta gamma di effetti che ha
70
prodotto e che potrà produrre in futuro. Leggendo i titoli delle diverse relazioni vedo che certamente tutti questi aspetti saranno approfonditi. Renzo Gattegna, Presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche Italiane
“Diamo ossigeno alle piccole Comunità”
Un patrimonio umano e culturale prezioso che nel giro di pochi anni rischia però di essere vanificato dal calo demografico. Il futuro delle piccole Comunità ebraiche, che costituiscono tanta parte dell’ebraismo italiano, si gioca su queste due opposte polarità, tra la vitalità dell’oggi e la minaccia di un prossimo declino. Ma se nulla si può fare per contrastare il decremento delle nascite e il parallelo invecchiamento degli iscritti, molto invece è possibile sul fronte delle relazioni e dell’organizzazione comune. Questo il messaggio lanciato oggi dal presidente dell’Ucei Renzo Gattegna in occasione del Moked, l’incontro dell’ebraismo italiano in corso in questi giorni a Parma. Una Comunità minuscola, una cinquantina scarsa di ebrei, location ideale per capire i modi e gli strumenti per restituire ossigeno ed energia alle tante microrealtà ebraiche italiane oggi in affanno. Presidente Gattegna, qual è oggi la situazione delle piccole Comunità ebraiche? Sono accomunate da un dato che continua a stupirci. Esprimono infatti tutte vitalità e capacità notevoli. Ma troppo spesso queste caratteristiche sono fondate su singoli individui che assommano su di sé tutte le competenze. E’ un aspetto ammirevole che allo stesso tempo è però motivo di forti preoccupazioni per il futuro. Il rischio è che venga a mancare il ricambio generazionale. Il problema centrale è di tipo demografico. Nei piccoli centri vi sono Comunità che oggi combattono per la sopravvivenza, in cui gli iscritti invecchiano e passano anni senza che vi sia un matrimonio o nasca un bambino mentre i pochi giovani si allontanano verso situazioni che offrono migliori opportunità di vita ebraica o di lavoro. Sembra un processo irreversibile. E’ un aspetto su cui non si può certo intervenire. Vi sono però altre prospettive da cui la questione può essere affrontata. Per questo due anni fa l’Ucei per la prima volta ha affidato a tre consiglieri – Federico Steinhaus, Gadi Polacco e Fabio Norsa – l’incarico di mantenere i contatti con le piccole Comunità così da recepirne le istanze e risolvere eventuali problemi di funzionamento. E’ una decisione che di per sé non può risolvere situazioni di crisi. Ma può contribuire ad evitare che si disperda l’immenso patrimonio culturale rappresentato dalla piccole realtà. Cos’è stato fatto in questi due anni? C’è stato uno scambio molto più intenso del passato, attraverso contatti, viaggi, incontri. Personalmente ho visitato quasi tutte le piccole Comunità conoscendone i dirigenti. Questo ci ha permesso di conoscere in modo più diretto e partecipato le diverse situazioni. Da questi scambi sono emerse nuove prospettive? Una via per evitare dispersioni di risorse, sia umane sia economiche, potrebbe passare attraverso una razionalizzazione della struttura. Un articolo dello statuto Ucei prevede,
71
da oltre dieci anni, che le Comunità possano consorziarsi così da mantenere servizi culturali e amministrativi che soddisfino un ambito più ampio, ad esempio regionale. Si tratta di una decisione che va assunta dalle stesse Comunità e che non può certo partire dall’Ucei. In ogni caso, per facilitare eventuali processi aggregativi, in vista del prossimo Congresso stiamo preparando una commissione per la riforma dello statuto. E in attesa di possibili consorzi su base regionale? Da tempo siamo impegnati nella costruzione di una rete di scambi capace di andare al di là della dimensione comunale in cui vivevano tante piccole Comunità. Per questo è stato messo a punto un progetto informativo che mantiene uno stretto dialogo con le diverse realtà attraverso la newsletter e la rassegna stampa spedite ogni giorno agli iscritti e il portale moked. Quest’ultimo non è uno strumento d’informazione a senso unico. Ma prevede la partecipazione in forma diretta delle diverse Comunità che possono gestire il loro sito in prima persona e in forma autonoma, contribuendo anche all’informazione nazionale. E’ un modo di combattere la solitudine delle realtà più piccole e di costruire insieme nuovi contributi. Intanto avanza il progetto per mettere in comunicazione in tempo reale tutte le Comunità italiane attraverso una rete informatica che oggi consente di mettere on line le lezioni del Collegio rabbinico e domani permetterà videoconferenze, riunioni a distanza ed esperienze didattiche tra le diverse scuole ebraiche. Il futuro potrebbe dunque vedere nell’ebraismo italiano una minore frammentazione della vita e delle relazioni. La speranza è questa. Ma al tempo stesso dobbiamo puntare alla sprovincializzazione e all’allargamento dei nostri confini. L’ebraismo italiano è una realtà molto ridotta dal punto di vista numerico che deve coltivare collegamenti e scambi, oggi ancora scarsi dal punto di vista istituzionali, con le Comunità ebraiche europee e statunitensi e con Israele. Credo sia questa una delle vie principali per rivitalizzare il nostro tessuto e proiettarci davvero nel futuro.
Faccia a faccia sul sionismo
“Israele è una parte di me”. “Io non potrei mai viverci, lo farei soltanto se ritenessi in pericolo la mia vita qui…”. Parte da queste due opinioni contrapposte il dialogo che, nella prima serata del Moked, ha visto i partecipanti confrontarsi con Daniel Segre, sul loro rapporto con Israele e sui significati del sionismo oggi. Segre, organisational coaching israeliano che svolge la propria attività a Gerusalemme, apre con una domanda un po’ provocatoria “Che cosa è Israele per te?”. Dapprima qualche timido intervento poi a poco a poco quasi tutti intervengono con il desiderio di far sentire il proprio parere di dar voce ai propri ricordi, alle proprie esperienze, al proprio vissuto. “L’intenzione che avevo - dice Dan Segre - era tirare fuori la percezione che ciascuno ha di Israele prima delle conferenze dei prossimi giorni, il mio lavoro inizia sempre così: faccio una domanda e parlo di me stesso, in questo modo le persone si sentono a proprio agio, quando racconti qualche cosa di te anche gli altri sono più disposti ad
72
esprimersi “. Daniel che cosa è Israele per te? Io a 19 anni ho deciso esattamente che cosa dovesse essere Israele per me, ho preparato le valige e sono partito. La mia vita è divisa in due parti: i primi 18 anni li ho vissuti in Italia e gli altri 38 anni in Israele, ho trascorso dei periodi all’estero per lavoro, ho viaggiato molto, ma la mia casa, la mia vita è in Israele. Hai un modello preordinato nello svolgere un’attività? Per me è sempre un’incognita, la mia aspettativa è quella di sentir raccontare. Devo essere attento a quello che le persone dicono, mostrare loro interesse, e non perdere ma non sempre è necessario che io intervenga, sono le persone che via via iniziano a parlare, il mio compito è di fare in modo che non si disperdano, che la conversazione non prenda direzioni sbagliate, in questo caso devo intervenire per riprendere i fili del discorso. A volte si creano situazioni di antagonismo, anche nei miei confronti, l’importante è non mettersi sulla difensiva, ma saper ascoltare anche le critiche sono necessarie… Quale dote ci vuole per svolgere questo lavoro? Ci vuole molta trasparenza, bisogna essere in grado di mettersi in gioco, alcune volte è stancante perché richiede un alto grado di concentrazione, ma le soddisfazioni sono molte. Quali aspettative hai quando svolgi una delle tue attività? Io non ho altra aspettativa se non quella che la gente venga con la propria storia. Un’altra considerazione interessate da fare è il fatto che non ci sono molte opportunità di scambiarsi delle idee in una forma ordinata, quindi se c’è uno spazio ordinato in cui parlarsi con delle regole le persone tendono ad aprirsi.
Dal mito di Israele alla nostra realtà
“Tredici lezioni per diventare ebrei. S’intitolava così uno dei libri più venduti lo scorso anno in Cina dove, nello stesso periodo, andava a ruba un manuale di galateo per comportarsi a dovere con nuove conoscenze di religione ebraica. Le ragioni di tanto interesse con ogni probabilità affondano le loro radici in questioni d’affari più che di cultura. Ma il boom degli ebrei nel paese del Sol levante è un’ulteriore conferma di una costante sovraesposizione mediatica dell’ebraismo a livello internazionale. “Una pubblicità ottima”, chiosa con un sorriso Vittorio Dan Segre che proprio con il caso cinese ha concluso il suo intervento al Moked di Parma. Classe 1923, Segre ha contribuito alla nascita dello Stato d’Israele. Ex-diplomatico, ex-militare, docente di Relazioni internazionali in università prestigiose – da Oxford alla Bocconi al Mit di Boston – fondatore a Lugano dell’l’Istituto di studi mediterranei, giornalista e scrittore (sua l’autobiografica «Storia di un Ebreo fortunato»), collaboratore apprezzatissimo di www.moked.it e del notiziario quotidiano l’Unione informa, Vittorio Dan Segre rifugge da ogni previsione apocalittica sia sull’ebraismo sia su Israele. E professa invece un convinto ottimismo che di questi tempi sembra diventato merce rara.
73
Professor Segre, perché gli ebrei sono oggi così di moda? Perché siamo al tempo stesso il simbolo dell’altro e la speranza della sua soluzione. Israele ha infatti realizzato un sistema d’integrazione, non solo nei confronti degli ebrei, che gli ha consentito di assorbire nel paese immigrati dal terzo e dal quarto mondo facendo dell’immigrazione una forza e non un peso. Da questo punto di vista siamo un modello. Eppure l’immagine di Israele all’estero non è così positiva. Invece di proporre gli aspetti post moderni dell’esperienza israeliana, quale ad esempio la questione dell’integrazione o lo sviluppo tecnologico e scientifico, la rappresentazione mediatica preferisce soffermarsi sull’elemento dell’ortodossia ebraica e dunque su quell’aspetto dell’ebraismo che è stato oggetto di distruzione con la Shoah e che oggi rappresenta un anacronismo. I motivi di questa focalizzazione? E’ molto più comodo mettere in secondo piano i successi e la modernità che fanno d’Israele un modello e puntare invece su una tradizione immobile. Diciamo poi che nel caso del mondo arabo o palestinese entra in gioco anche l’invidia per i risultati che siamo riusciti a raggiungere partendo dal nulla. Anche da parte ebraica c’è però una sorta di ritrosia a lodare troppo Israele. E’ un atteggiamento di falsa umiltà per cui si cerca di sminuire il dato positivo e si mettono in luce gli errori. La realtà è che l’evoluzione d’Israele è portentosa al punto che noi che l’abbiamo visto nascere non riusciamo davvero a rendercene conto. Accade per Israele come per la Shoah: è una storia troppo grande per essere compresa da una sola generazione. Si deve lasciar decantare con il tempo l’epopea dello Stato e la tragedia dell’Olocausto. Solo allora si potrà cercare di capire. Quanti hanno assistito alla nascita dello Stato d’Israele oggi spesso stigmatizzano il suo essere divenuto uno stato come tutti gli altri. Non riescono più a riconoscersi in Israele perché il loro Israele era il paese di un’epopea messianica che non poteva però essere realizzata nel giro di poche generazioni. Uno dei motivi di critica sta nella presunta caduta di valori della società israeliana. E’ un tema di cui si dibatte molto anche in Israele. Va però sottolineato che quella israeliana è una società di straordinaria forza che oggi non è affatto rappresentata dalla sua dirigenza. Che funzione ha l’ebraismo diasporico nei confronti d’Israele? Ha uno straordinario senso storico, ideale, religioso e morale perché porta un messaggio di grande rilievo di cui Israele è uno degli elementi importanti. In questo senso la Diaspora ha una responsabilità notevole nei confronti di se stessa e dell’umanità. Come vede il futuro dell’area mediorientale? Non dobbiamo mai dimenticare cosa comporta l’emergere di una nuova sovranità in una zona politico strategico così compatta come il Medio oriente. Fatti di questo tipo creano sconvolgimenti di portata molto profonda nell’ecologia politica di qualsiasi zona. Basti pensare alle ripercussioni della nascita dello Stato italiano. L’epopea israeliana non poteva risolversi in tempi ridotti. E la pace?
74
La pace già esiste con un numero notevole di vicini. La pace però si conclude con un altro stato. Ora il problema è lo scontro in atto tra un popolo e uno stato. Si tratta di una situazione che contiene in sé elementi rivoluzionari e distruttivi. L’esistenza di uno Stato palestinese è dunque una necessità: non un pericolo.
Quel pensionato che vola in alto
Credo che nessuno possa risentirsi se affermo che con l’intervento del “pensionato” Vittorio Dan Segre, ascoltato in “religioso silenzio” e pur non mancando certamente molti spunti di dibattito anche in quanti lo hanno preceduto, si e’ “volato alto” con un mix di realistica analisi unito pero’ ad un messaggio di ottimismo concreto e quindi assolutamente non “d’ufficio”. Iniezione assai utile per riportare il percorso di questo Moked,ancora una volta di grande interesse, proiettato in avanti e, per mutuare un concetto anglosassone,orientato a vedere le difficoltà più come opportunità che mancate occasioni (mi riferisco ad accenni intervenuti nella giornata denotati da un pessimismo che sembra avere origini essenzialmente nella delusione derivante dal naufragio di esperienze alle quali si e’ guardato con speranza). Hazak quindi,ancora una volta, agli organizzatori ed uno spunto,magari per future occasioni, affinché si approfondisca maggiormente il contributo millenario del “sionismo religioso” ma anche il concetto di “laicità” molto spesso accennato anche in questo Moked ma sempre nell’accezione,non certo esaustiva, di “areligioso” od “antireligioso”. Gadi Polacco, Consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Educazione e cultura contro la dispersione
“L’educazione e la cultura. E’ su queste due direttrici principali, le uniche capaci di contrastare la dispersione e l’assimilazione dell’ebraismo italiano, che si giocano le progettualità dei prossimi anni”. Anselmo Calò, assessore al Bilancio Ucei, sintetizza così il mandato che guida la sua attività. Attività complessa, alla ricerca costante di un equilibrio tra esigenze diverse, che in questi ultimi anni vede tra le poste in gioco la stessa sopravvivenza delle piccole Comunità ebraiche, un tema a cui il Moked di Parma ha dedicato un’attenzione particolare. Qual è la prima difficoltà con cui si trova a fare i conti l’assessore al Bilancio? Il problema principale è riuscire ad accontentare le diverse richieste di finanziamento. Si tratta di iniziative meritevoli, che non sempre possono però trovare sostegno da parte dell’Ucei. Dobbiamo dunque porre una scala di priorità e calibrare le nostre scelte puntando sulle progettualità più meritevoli d’attenzione così da evitare di disperdere risorse a pioggia. Quali sono i criteri della scelta? Quelli definiti dall’ultimo Congresso Ucei, l’educazione e la cultura. Sono le sole strade per combattere l’assimilazione. Non a caso una quota molto rilevante del nostro
75
bilancio, circa 800 mila euro, è destinata all’istruzione superiore: il Collegio rabbinico, il corso di laurea e il Dipartimento educazione e cultura Ucei. Un altro problema, di cui si è parlato molto al Moked, riguarda il tramonto delle piccole Comunità. L’ebraismo italiano si confronta con un drammatico calo demografico fin dal secondo dopoguerra. Il censimento fascista del ’38 rilevava circa 70 mila presenze. Oggi, secondo gli ultimi dati, la realtà ebraica si attesta sulle 25 mila persone. Sono numeri inesorabili – frutto della Shoah e del generale decremento delle nascita che caratterizza il mondo occidentale - che assumono caratteristiche di particolare preoccupazione nei centri più piccoli dove il ricambio generazionale è molto ridotto e i pochi giovani tendono a spostarsi verso le grandi città. Cosa comporta in termini concreti questa diminuzione degli iscritti? Innanzi tutto diventa sempre più difficile continuare a garantire quel minimo di servizi indispensabile alla vita ebraica. Poi si pone il problema del patrimonio, anche immobiliare, che con il venire meno della popolazione ebraica rischia di andare disperso o degradato. Una delle questioni da anni all’attenzione dell’ebraismo italiano riguarda proprio
la conservazione dei beni storici, sinagoghe, cimiteri o musei. Al momento il problema principale riguarda il rifinanziamento per il triennio 2010 – 2012 della legge 175 finalizzata al loro recupero. Per l’anno prossimo questi fondi sono stati ridotti del 25 per cento e ciò ci preoccupa. Tagli di questo tipo (cui peraltro aveva fatto ricorso anche il governo precedente) non consentono infatti la certezza di riuscire a portare a termine i progetti. Per fortuna possiamo però contare su uno schieramento bipartisan a sostegno del patrimonio ebraico: è una ricchezza immensa in termini affettivi e culturali per l’intero Paese che non può andare perduta.
“Insieme possiamo riuscire”, la lezione dell’incontro di Parma
Il Moked autunnale, il tradizionale incontro dell’ebraismo italiano, che quest’anno si è svolto a Parma, volge al termine. Tre giorni di incontri, con storici, filosofi, scrittori e psicologi per riflettere sui 60 anni dello Stato di Israele, per capire chi siamo ed in che direzione stiamo andando, una riflessione cui il pubblico presente ha preso parte attiva. Abbiamo chiesto un bilancio conclusivo su questi giorni a Rav Roberto Della Rocca, direttore del dipartimento educazione e cultura UCEI. Rav Della Rocca, tiriamo le somme di questi giorni sei soddisfatto? “Per quanto riguarda il pubblico intervenuto, il bilancio è soddisfacente sotto il piano della partecipazione impegnata, la gente è stata presente a tutte le attività, la sala era sempre piena, ed anche il livello culturale delle conferenze è stato alto e stimolante. Sono molto contento anche per la partecipazione attiva dei membri della piccola Comunità di Parma, che ha condiviso con noi le giornate di studio e che ci ha aperto con entusiasmo il tempio per la tefillà di sabato mattina. Sotto il profilo interno devo dire che il valore aggiunto di questo Moked è il lavoro corale dei Dipartimenti Ucei: il Moked non è più un evento del Dec ma dell’Ucei, che
76
ha visto il coinvolgimento qualificato ed armonico del personale dei vari dipartimenti ed è stato un esempio di come si stia superando la settorialità” A proposito di personale, mi sembra che il tuo staff abbia avuto delle modifiche Sì, al prezioso lavoro di Ruth Steindler che continuerà a coordinare l’organizzazione del Moked, si sono aggiunte due persone, Alan Naccache che coordina l’Ufficio Giovani Nazionale e Ilana Bahbout nell’assistenza alla direzione per la parte culturale, entrambi hanno dato un grande impulso alle attività del Dec. A parte la stanchezza accumulata, c’è qualche elemento negativo che vuoi evidenziare? Un elemento su cui penso si debba riflettere è la scarsa presenza dei 40enni ai Moked, indubbiamente in questo momento c’è anche un problema di natura economica, spostarsi spesso con due tre bambini è costoso. Abbiamo studiato delle alternative, ma abbiamo delle esigenze per cui non ci si può discostare molto da un certo target di albergo: occorrono strutture con due tre sale per le riunioni, molte stanze, impianti di cucina che consentano di rispettare la casherut. C’è poi da dire che venire al Moked è una scelta identitaria, culturale, educativa, è certamente diverso che organizzarsi una vacanza in un villaggio turistico. Quale soluzione suggerisci? Per quanto riguarda i costi penso che forse le Comunità potrebbero supportare una famiglia alla volta con un viaggio premio, questo potrebbe avere una ricaduta positiva su tutta la Comunità perché al ritorno dal Moked queste persone potrebbero portare nuova linfa vitale nelle loro Comunità. Poi penso che si dovrebbero studiare delle formule per non circoscrivere gli argomenti trattati nel Moked a 1-2 giorni, ma “spalmarli” su tutto il territorio nazionale organizzando incontri di approfondimento nelle varie Comunità durante il corso dell’anno. A proposito dell’argomento affrontato durante questo Moked: i 60 anni dello Stato di Israele, ti sembra che ci siano ancora delle cose che debbano venir fuori? C’erano molte perplessità nella scelta di questo tema, alla luce dei fatti penso che sia stata una scelta vincente, perché non è stato dato un taglio celebrativo, retorico. Ovviamente tre giorni non possono essere esaustivi sull’argomento, ma penso che il tema sia stato trattato con una certa completezza e serietà: Israele è la nostra identità e come tale richiama interrogativi continui a cui non ci sono risposte compiute e questo ha dato nuovi spunti, anche inquietanti, ma questo è il bello, bisogna evitare le etichette preconfezionate.
Freedonia o Israele?
Che cosa rappresenta Israele? Un sogno di salvezza, il luogo dove la sua famiglia avrebbe potuto salvarsi? Il mostro dell’occupazione, raccontato tutti i giorni dai giornali? Il futuro, un modo nuovo di intendere l’essere ebreo? Uno stato come tanti altri? Riccardo, il protagonista dello spettacolo messo in scena da Enrico Fink, e rappresentato in teatro in occasione del Moked di Parma, racconta Israele attraverso i propri occhi, e attraverso un dialogo fitto – anche se immaginato - con i compagni con
77
cui ha condiviso la passione politica, il pacifismo – e nei confronti dei quali Israele ha sempre rappresentato un discrimine, un motivo di differenza. Via da Freedonia, quale è il significato del titolo del tuo spettacolo? Via da Freedonia è un monologo teatrale con musica il punto da cui parto, come dico all’inizio dello spettacolo, è questo: sono cresciuto in Italia, dopo la guerra gli ebrei della generazione di mio padre si spaccarono in due chi andò in Israele, chi invece andò a Freedonia, a sognare la libertà. A Freedonia non c’era niente da ricostruire, niente era reale, niente provocava sofferenze: perfino la guerra non era vera, era la guerra lampo dei Fratelli Marx. Freedonia rappresenta come ti dicevo un luogo ideale, libero e per alcuni ebrei della generazione di mio padre ha rappresentato il simbolo di un luogo ideale dove andare a vivere. Per alcuni il luogo ideale è stato lo Stato di Israele, per altri c’è stata soltanto una realtà immaginaria. E tu dove ti collochi a Freedonia, nello Stato di Israele o dove altro? Io sono cresciuto in una realtà piuttosto lontana dal mondo ebraico, dove i riferimenti non erano lo Stato di Israele, ma trovare il proprio spazio in un mondo a volte ostile, nel diventare adulto penso ci sia un momento nella vita di ciascuno di noi in cui si ha il bisogno di confrontarsi con la realtà dello Stato di Israele. A questo punto ho capito che Israele rappresenta un modo di essere ed anche se ero molto impegnato politicamente ho sentito il bisogno di difenderlo. Per fare questo ho dovuto studiare. Quello che racconto in questo spettacolo è il bisogno di raccontare non soltanto le cose belle, ma anche le ombre. Quale è il pubblico che viene ad ascoltarti? Lo spettacolo è indirizzato a chi non sa cosa significa amare Israele, cosa significa essere un ebreo italiano, per questo uso anche le parole di Grossman che oltre ad essere molto belle sono anche molto significative, credo che egli abbia dato un’immagine di Israele bellissima, persino quando ha pronunciato il suo discorso in occasione della cerimonia in memoria di Rabin, ed egli aveva perso suo figlio in guerra pochi giorni prima, è riuscito a parlare in un modo che per un essere umano è difficilissimo e la domanda che io faccio è questa: noi ce la faremmo? Riusciremmo a metterci in quella realtà prima di esprimere giudizi?
“L’inizio di nuove sfide e di perenni interrogativi”
“Si è concluso ieri a Parma il Mokèd autunnale organizzato dal Dipartimento Educazione e Cultura dell’Ucei che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone provenienti da molte Comunità italiane. Durante l’incontro si è svolto un convegno che ha affrontato con autorevoli studiosi e intellettuali, non solo italiani, il tema del nostro rapporto con lo Stato di Israele a 60 anni dalla sua fondazione. Il tema è stato finalmente affrontato sotto una prospettiva inedita. I relatori hanno evidenziato come lo Stato di Israele è stato il prodotto di un movimento di pensiero ebraico, minoritario e spesso contrastato, che costituisce ancora una grande sfida intellettuale, sociale e religiosa per l’intero ebraismo sviluppatosi nel corso dei secoli come realtà diasporica. Queste considerazioni ci indicano come il programma sionistico non
78
significa la fine, ma l’inizio di nuove sfide e perenni interrogativi per il pensiero ebraico. Israele ci ripropone incessantemente la sfida di rilegare cielo e terra mediante quella scala sognata dal nostro padre Jaakov.”
Rav Roberto Della Rocca, direttore del Dipartimento Educazione e Cultura dell’Unione delle Comunità ebraiche Italiane




















































































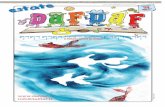










![001 La gestione e l esecuzione dei contratti rancati parma 29 06 … Rancati Parma.pdf · /> EhKsK K / / KEdZ dd/ Wh >/ / } } ] o } } ] À } ~ X> P X í õ ] o î ì í ó U v X ñ](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5c67c01a09d3f226188c308b/001-la-gestione-e-l-esecuzione-dei-contratti-rancati-parma-29-06-rancati-parmapdf.jpg)

