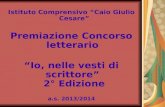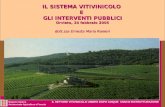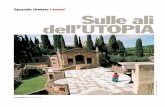ANTONIO RIMPATTA G - Bollettino d'Arte · vesti e nella distribuzione degli alberi nel fondo, il...
Transcript of ANTONIO RIMPATTA G - Bollettino d'Arte · vesti e nella distribuzione degli alberi nel fondo, il...

FEDERICO ZERI
ANTONIO
G RAZIE all'amichevole cortesia di Luisa Mortari, che l'aveva rinvenuto nei locali dell'Abbazia di Farfa in Sabina, ho potuto studiare
tempo fa un dipinto che per !'inconsueta mescolanza di accenti regionali, piuttosto che per il grado di qualità,
RIMPATTA
centro della cultura figurativa dell' epoca. Un accento emiliano, anzi, delle Romagne occidentali, è quello denunciato da11.'aspetto plU propriamente tecnico dell' opera; ed è lo stesso, precisantesi nel ricordo di Marco Palmezzano, che traligna nella figura dell'An
gelo, a cominciare dal suo tipo fisico. Altrove, e soprattutto nelle pieghe delle vesti e nella distribuzione degli alberi nel fondo, il precedente umbro, di zona peruginesca, spicca con altrettanta evidenza; uno sfocato ricordo di qualcosa non distante da Francesco Francia circola nel volto della Madonna, mentre nel modulo compositivo del Bambino par di avvertire un riflesso vagamente senese, in direzione di Gerolamo di Benvenuto.
Un piccolo gruppo di dipinti, evidentemente legati a quello di Farfa da qualcosa di più che non una generica affinità di cultura, conferma la mescolanza grammaticale del pittore, rivelando ci che la sua fu una vicenda peregrinatoria, e indicando il suo nome di battesimo: Antonio Rimpatta da Bologna.
invita a ricercare a quale territorio artistico dell'Italia del primo Cinquecento possa aver appartenuto l'autore (fig. I). Sostenuta da una solida tecnica di buon artigianato, che passa dalla minuta descrizione di ricami e di capelli al liscio smalto degli incarnati, e a quello, vivacemente policromo, delle vesti, la figurazione è accordata secondo modi che si amerebbe definire eclettici, se questo termine, troppo spesso abusato, non avesse già da tempo perduto ogni effettivo significato critico ed ogni validità icastica. Rigidamente "in posa", le tre figure paiono accostate più per casuali ragioni di economia spaziale che per reale esigenza di stile; e la mancanza di un intimo legame, accentuata dalla rigidità espressiva, conferisce e al gruppo della Vergine col Bambino, e all'Angelo che sostiene il cartiglio mariologico (" Pulchra es et decora Filia
FIG. I - FARFA, ABBAZIA - A. RIMPATTA: MADONNA COL BAMBINO (DOPO IL RESTAURO)
All'inesauribile miniera di curiosità e di problemi, costituita dai depositi della Walters Art Gallery di Bal
Hierusalem,,) uno sconcertante sapore, non già, come avrebbe voluto l'artista, di efficacia iconica, ma piuttosto, almeno agli occhi odierni, di oggetti di una natura morta, di cose cioè perennemente immote. Si ignora se il dipinto sia stato eseguito per l'Abbazia di Farfa, il cui stemma fu molto più tardi aggiunto al di sotto dell' Angelo; ma, riferitane la nascita in Sabina, o altrove, è tuttavia evidente che la combinazione di varie lingue locali, quale appare da una sommana lettura, presuppone la frequenza di più di un
timora, appartiene questo pannello, dove la figura del San Sebastiano, individuato con tutti i più marcati caratteri del "plague saint", campeggia contro un paese collinoso, mentre in basso, secondo una simbolica riduzione di scala, è la donatrice, inginocchiata accanto ai suoi tre figliuoli (fig. 2) . Il momento di stile del conservatissimo dipinto è quanto di più" primo Cinquecento " si possa reperire; il drappello dei soldati, che si intravede in marcia fra due prominenze alla destra, suggerisce trattarsi di un ex-voto la cui
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. 2 - BALTIMORA, WALTERS ART GALLERY - A. RIMPATTA : SAN SEBASTIANO E DONATORI
nascita fu sollecitata dal disastroso diffondersi di gravi epidemie (fra cui la comparsa del "mal francese,,) conseguente alla discesa di Carlo VIII, alle guerre del Valentino, e alle altre iatture politiche di cui è contrassegnato l'inizio del "secolo d'oro" nell'Italia centromeridionale. Anche qui la tecnica, impeccabilmente compatta e smaltata, con cui è disteso il pigmento cromatico, ubbidisce a spunti formali di varia estrazione, di marca 1azia1e, umbra ed emiliana. Di Antoniazzo Romano sono ovviamente il tipo del paesaggio (anche se arricchito di una flora umbreggiante) e il modulo della figura del Santo martire, che par alludere alla conoscenza del celebre pannello nella Galleria Nazionale di Roma (il cui monumenta1e respiro risulta qui del tutto travisato, per l'alterato rapporto tra figura e fondo); le pieghe del perizoma si svolgono con tipici grafismi alla Pietro Perugino; e, di nuovo, un sapore bolognese e romagno10 condiziona il fogliame degli alberelli e le figurine dei devoti, dove si sfiora un caratterismo grafico prossimo ad Antonio Pirri ed alle primizie degli Zaganelli da Cotignola.
Circa dieci anni fa passò sul commercio parigino un tondo (che poi mi si disse entrato in Italia) esprimente, contro un'apertura di lontano paese, la mezza figura della Vergine col Bambino (fig. 5). I limiti della capacità fantastica e del repertorio del pittore sono, mi
FIG. 3 - BRIGHTON, COLLo CHAMBERLAIN - A. RIMPATTA: MADONNA COL BAMBINO
sembra, bene misurati da questo terzo numero del suo breve catalogo. A parte la consueta combinazione dei soliti elementi grammaticali, realizzata con la sospesa atonia di sentimento che fu già notata nel pannello di Farfa, è ben sintomatico che la fisionomia della Vergine sia 1'esatta controparte, per 1'altro sesso, di quella del San Sebastiano di Baltimora: stesso ovale di regolarità un po' forzata e accentuata dalla esattissima scriminatura nelle chiome, stessa flessione di patetismo psicologico, che da sp1enetico sta diventando svogliato. Così pa1mari e molteplici sono i 1egam{ di questo piccolo gruppo con la tavola che ci rivela il nome e l'origine del pittore, fornendo anche una indicazione precisa sul tempo della sua operosità e sulla parabola del suo percorso geografico, che non so proprio da quale incominciare. È la grande pala già sull' altar maggiore della Chiesa di San Pietro ad Aram a Napoli, poi, sin dal 1821, nella locale Pinacoteca (fig. 4) · Riferita tradizionalmente, e sino dal secolo XVII, ad Antonio da Solario detto 10 Zingaro, tale battesimo venne accettato anche dalla più informata critica ottocentesca; I) sino a che le ricerche di G . Fi-1angieri di Satriano non scoprirono due documenti, l'uno concernente l'allogazione, 1'a1tro la stima del dipinto, dai quali il pittore risultò essere "Maestro Antonio Rimpacta da Bologna" , cui la pala venne
47
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. 4 - NAPOLI, GALLERIA NAZIONALE - A. RIMPATTA : MADONNA COL BAMBINO
E SANTI (Fot. Brogi)
Agostino, dietro il quale una figura di laico rappresenta con ogni probabilità il pittore stesso, in età non molto avanzata e forse ancora entro il terzo decennio, suggerendo così che la sua nascita va situata fra il I480 e il I490. L'opera torna dunque a riproporre il ruolo di artista girovago sortito dal suo autore, bolognese di nascita ma operoso a Napoli ; lo stesso curricolo cioè che la lettura delle sue opere aveva già posto in rilievo. È sintomatico che, giusta il documento riesumato dal Filangieri, fra gli estimatori dell'opera appaia un altro bolognese viaggiante per l'Italia centro-meridionale, " Maestro Antonio Pirro di Manfreda da Bologna", il ben noto Antonio Pirri. Del resto il tessuto figurativo della pala non manca di accenni a conoscenze emiliane, sia nel gruppo principale, evidentemente desunto da modelli del Costa e del Francia, sia nei due rosari di globi di vetro o di pietre colorate ornanti la conchiglia del trono, che rammentano il motivo pubblicato da Francesco del Cossa negli scomparti principali del bolognese altare Griffoni (Galleria di Londra e Brera); a meno che non vadano riferiti ad Antonio da Crevalcore, anche perchè il tema dei due festoni di frutta sembra riprendere, caricandone la portata, quello del ' Ritratto Sacrati' nella Pinacoteca di Monaco e della ' Sacra Famiglia' già Spiridon a Parigi.
commessa nel I509, per essere collaudata nel I5 I l. 2)
L'artista vi si è impegnato a spiegare la misura delle sue possibilità tutte intere, e le più che cospicue dimensioni della superficie da riempire (cm. 38I X 280) non gli hanno impedito di esercitare la sua meccanica pazienza nell' eseguire sottili ricami di vesti, fregi scolpiti, capitelli, grottesche, festoni; tutto con l'infaticabile applicazione di un artigiano che, per le figure, mette in mostra al completo il suo repertorio. Ai lati del trono della Vergine (e non sto a sottolinearne la precisa identità con gli esemplari già esaminati) i due gruppi di Santi si compongono con l'immobilità senza respiro di chi è costretto a star fermo per un tempo eccessivo: alla destra Sebastiano (con l'aguzzino che lo sta slegando), Pietro e Candida seniore (la Santa contitolare della Chiesa) ; alla sinistra Paolo, Monica e
Singolarmente staccati dal contesto sono infine i due putti sul baldacchino, che accennano allo studio di cose del primo tempo di Raffaello a Roma, specie della volta della prima Stanza, suggerendo che a Napoli il Rimpatta si sia recato poco prima di ricevere la commissione di questo suo caposaldo.
Il carattere regionalmente composito, leggibile nei numeri da cui prende avvio la ricerca, viene così a svolgersi senza ostacoli nei termini impliciti nella pala napoletana : perchè il Rimpatta, esordiente in Emilia, dovette necessariamente passare per l'Umbria e per Roma prima di giungere nella capitale del Regno. A Roma, non so se egli debba annoverarsi, almeno per un certo tempo, fra i molteplici " lavoranti" della bottega di Antoniazzo; ma che questi abbia fatto presa su di lui, si è visto nel ' San Sebastiano ' di
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

Baltimora, e meglio lo si osserva in un piccolo pannello, molti anni fa nella Collezione Chamberlain di Brighton (fig. 3). Le dimensioni ridott~ vi favoriscono il grado di qualità; ma, nonostante l'accoglienza di dati antoniazzeschi, nel fondo d'oro (finemente ornato nei bordi con lacche graffite a motivi quasi alla Pinturicchio) e nello schema compositivo, dal contorno fortemente profilato, il senso del dipinto rimane inequivocabilmente individuale, non solo per il riapparirvi di segni già noti (nel volto della Vergine
e nella sua mano sinistra, tratta forse dal medesimo cartone che servì per il tondo) ma anche per un certo qual umore affettivo, modestamente in sordina, che conferisce all'insieme un singolare accento bolognese-laziale.
I) P . SARNELLI, Guida de' Forestieri ... , 4a ed., r688, p . 499; J. A. CROWE e G. B. CAVALCASELLE, Painting in N . Italy, r87r, II, p . roI.
2) G . FILANGIERI di SATRIANO, in Arch. St. per le Provo Napoletane, IX, r884, p. r03.
FIG. 5 - GIÀ PARIGI, COLLo PRIVATA - A. RIMPATTA; MADONNA COL BAMBINO
49 4
©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte