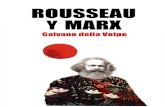328 Perla Critica--secondo Marx
-
Upload
hotjohn-martiello -
Category
Documents
-
view
89 -
download
2
description
Transcript of 328 Perla Critica--secondo Marx

gfp.328 - Economia, Roma 2013 materiali didattici per i corsi universitari 1991-2011
____________________________________________________________
PERLA CRITICA dell’economia politica – secondo Marx
a cura di gianfranco pala________________________________________________________
René Magritte, Il sorriso del diavolo (1966)
Originalità
Oggigiorno – s’è lamentato il sig. K – sono innumerevoli coloro che si vantano pubblicamente di poter scrivere da soli grossi libri
e ciò viene approvato da tutti. Il filosofo cinese Ciuang-tse ancora nel vigore degli anni
scrisse un libro di centomila parole formato per nove decimi da citazioni. Da noi tali libri non possono più essere scritti perché manca l’ingegno.
Ne viene di conseguenza che si preparano i pensieri solo nel proprio laboratorio
perché chi non ne produce abbastanza ha l’impressione di essere pigro. Succede così che non esiste un solo pensiero utilizzabile,
né alcuna formulazione di un pensiero che possa essere citata. Occorre ben poco a costoro per la loro opera!
Una penna e un po’ di carta sono le sole cose che sappiano mostrare! E senza alcun aiuto, soltanto col magro materiale che uno può portare
sulle proprie braccia, innalzano le loro capanne! Essi non conoscono edifici più grandi di quelli
che uno è in grado di costruire da sé!
[Bertolt Brecht, Storie da calendario]

Di più non possiamo fare
A volte ho sognato un lavoro di respiro veramente grande,che spaziasse a tutto campo attraverso
elemento, oggetto, significato e stile.Ciò, temo, rimarrà un sogno, ma dobbiamo continuare a inseguirlo!
Non è facile pervenire a una concezione dell’intero costruito con parti appartenenti a diverse dimensioni.
Altrimenti, di fronte a una nuova parteche conduce in una direzione completamente differente, in tempi remoti,
la ricostruzione delle dimensioni prima esplorate facilmente svanisce.Diventa il “passato”. Ma in un successivo momento critico,
in una nuova dimensione, può diventare di nuovo il “presente”.Abbiamo trovato le parti, ma non l’intero!
Devo riuscire a esprimere facilmente e rapidamente il fenomenodel nesso simultaneo con codeste molteplici dimensioni.
Ci manca ancora la forza fondamentale: le masse non sono con noi.Ma noi cerchiamo le masse. Le mie parole non si rivolgono a ciascuno
in isolamento, ma si integrano e mettono a fuoco le impressioni.Di più non possiamo fare.
[Paul Klee, On modern art, 1928]
Avvertenza generale
Sono riuniti i materiali 1991-2011, qui con un titolo, Perla critica, che gioca con un classico calembour – costruito per una polisemia, o meglio per una voluta parasemia parziale – su ciò che per Marx era abituale: Per la critica dell’economia politica. La raccolta antologica comprende autori vari – soprattutto Marx, ma anche qualche “economista” borghese riprodotto emblematicamente quale riferimento per una critica moderna – e i frammenti sono estratti dai testi originali senza alcun commento, ma ovviamente selezionati secondo un’arbitraria scelta del curatore e così tagliati e collazionati per darne forma di sintesi in funzione della loro finalità didattica politica: sia per una preliminare formazione [dopo l’Introduzione storica teorica generale, si veda la prima parte, Critica dell’economia politica], sia poi per una successiva specializzazione [si veda la seconda parte, Accumulazione e crisi], che hanno costituito rispettivamente le due parti dell’originario corso annuale dell’ordinamento quadriennale, e in séguito il corso di base del triennio dell’ordinamento semestrale e il corso specialistico del biennio sempre semestrale (in effetti si trattava di “semestri” che duravano solo ... due mesi e mezzo, per circa quaranta ore di lezione ciascuno; ossia poco più di un’ora per paragrafo!).
I corsi hanno avuto sia un carattere formativo iniziale (merce, valori, prezzi, modi di produzione, ecc.) sia poi un approfondimento solo su alcuni temi, prevalentemente limitandosi a quelli che più facilmente si richiamano all’attualità (quindi carattere mondiale dell’accumulazione di capitale, sue crisi, forme finanziarie, imperialismo, ecc.). Certamente – a parte le trattazioni specifiche su salario, denaro, concorrenza, stato e mercato mondiale, che Marx progettava di sviluppare nel piano di elaborazione sul capitale, ma i cui concettiche erano abbozzati con maggiore o minore (sullo stato, a es.) ampiezza nei suoi manoscritti, qui presi in considerazione – la mancanza maggiore nella presente ridottissima antologia riguarda il dibattito e la sua trattazione sulla “rendita fondiaria”. Ma questa grave scelta è dovuta sostanzialmente al fatto che la lunghezza e la complessità dell’analisi marxiana, pur da lui stesso elaborata, non avrebbe potuto essere inclusa in un corso specialistico di soli complessivi due mesi e mezzo, senza un impraticabile appesantimento dello stesso. Perciò, anche in considerazione del mutare dei tempi, seguendo le sue stesse indicazioni si è semplicemente considerata la produzione agricola come parte integrante degli sviluppi della produzione industriale capitalistica moderna, fatta salva la fondamentale individuazione del “ricambio organico con la natura”.
I testi “classici” scelti per l’introduzione e le due parti sono indicati complessivamente in coda alle avvertenze specifiche; per una maggiore semplificazione della composizione dei materiali, ovviamente molto
2

ridotti rispetto alle centinaia di pagine da cui provengono (cui pertanto si rinvia per completezza), in calce a ogni pezzo tagliato e incollato ne è indicato il luogo, con una sigla corrispondente a quella riportata nell’e -lenco delle fonti usate. Trattandosi nella forma originale di un taglia e incolla materiale (cioè con forbici e nastro adesivo) e poi di una scansione del testo così composto, entrambe le operazioni sono state controllate. Ma è certo che siano ancora sfuggiti errori (a es. nella scansione sono stati spesso confusi i caratteri l e t [così lutto per tutto, fallo per fatto, ecc.], e e c, o pure a e o [aggettivo per oggettivo, ecc.], e diverse parole intere inspiegabili; si ringraziano pertanto i lettori che eventualmente trovino residui refusi o sviste e li segnalino. Inoltre certamente, dato il carattere di collazione del testo, redazionalmente ci saranno alcuni singoli brani ripetuti, ma in contesti diversi, o simili per la loro provenienza da testi differenti dello stesso autore.
Si segnala che nei testi originali Marx e Engels usano sempre il termine tedesco arbeit per lavoro come generica costrizione, in condizioni di sforzo, fatica, pena, sostanzialmente di illibertà, e specificamente lohn-arbeit per lavoro salariato dal capitale; quindi, nonostante che i traduttori italiani (e le lingue neolatine) così come nel loro uso ottocentesco, si riferiscano al lavoro quale generale “operare” come attività creativa libera, qui si è preferito ignorare la traduzione italiana di arbeiter, usualmente data come “operaio” anziché lavoratore (e derivati), sostituendo quest’ultima, secondo il significato marxiano, a quell’altra universalistica in quanto priva dello spessore storico sociale denotato dal marxismo, che invece si trova nei libri tradotti. Inoltre è stata corretta la traduzione italiana dove Keynes scrisse capital instruments che invece in italiano è stata data come <attività capitali> (avendo così inteso <capitali> come aggettivo, nel senso cioè di principali o fondamentali ecc.) anziché come si desume dal contesto come “strumenti di capitale” (in genere strumenti di garanzia finanziaria per la raccolta di fondi).
Infine per le rispettive due parti, oltre ai programmi di studio delineati, agli indici e alle fonti bibliografiche e relativi acronimi, sono riportate anche – in forma di una sola prefazione unificata – quelle che erano le due prefazioni, le sole cose “non classiche” scritte dal curatore docente [e che sono separatamente già disponibili in rete rispettivamente ai numeri per la prima parte gfp.310 e per la seconda gfp.304, ora il tutto riunito in un solo testo a gfp.328]. Scelte analoghe di ripubblicazione, nelle forme qui ritenute più confacenti, riguardano gli occhielli iniziali e i bei disegni e quadri finali – tutto di grandi autori – che accompagnavano copertine e testi originali, e che sono già in larga parte reperibili ai numeri di rete qui sopra indicati.
Avvertenza: Introduzione e I parte
Queste letture mirano a quella formazione di economisti, necessaria per comprendere appieno l’attualità del mondo contemporaneo, fornendo un’adeguata preparazione economica, che rivesta ampi aspetti culturali, storici e sociali, e non soltanto tecnici, sul piano internazionale. L’insegnamento è breve e quindi vuole essere di semplice apprendimento per gli studiosi, ai quali è rivolto e, tuttavia, è richiesta una sufficiente apertura mentale per accogliere la necessaria comprensione comparata degli strumenti di analisi forniti dalle differenti teorie economiche. Ciò è tanto più importante e delicato nei termini delle questioni economiche internazionali, in quanto sono più generalmente diffuse e note le categorie dominanti, peraltro più che sufficientemente definite e illustrate altrove.
La comparazione suggerita, perciò, viene soprattutto stabilita tra le più note teorie economiche e le teorie economiche classiche (da Petty a Smith a Ricardo, fino alla critica di Marx) i cui concetti sono via via divenuti meno frequentati. Senonché, la loro conoscenza può offrire proficui suggerimenti proprio per integrare le medesime categorie (ruotanti intorno ai temi tipici del corso di laurea: valori, prezzi, salari, profitto, occupazione, merce, denaro, sviluppo, crescita, arretratezza, internazionalizzazione, ecc.), ma in altra maniera definite. A tal fine, si suggerisce la lettura diretta dei testi originali, prima di accedere a qualsivoglia interpretazione, e si fornisce il materiale in questo senso. Inoltre, l’apprendimento degli strumenti logici di analisi della critica dell’economia politica, pur riferendosi perciò anche a epoche storiche e sociali trascorse, è qui inteso in senso preminentemente categoriale economico proiettato verso l’attualità, per fornire quella capacità formativa in grado di comprendere i fenomeni osservabili nel mondo contemporaneo (si pensi, a es., a temi che non possono che avere oggi tutti un’inevitabile rilevanza internazionale, quali rivoluzione industriale, forza-lavoro, divisione e organizzazione del lavoro, conflitti sociali, rapporti di proprietà, progresso tecnico, fasi di trasformazione mondiale, ecc.).
Sicché – dopo una prefazione tesa solo a mostrare i nessi dell’attualità con la sua base storica e che, come tale, costituisce unicamente una chiave interpretativa per i successivi testi “classici” – questi ultimi sono raggruppati secondo le relative questioni trattate. Dopo una preliminare e generale introduzione storica, si affrontano specificamente i modi di produzione, rivoluzione industriale e processo di lavoro – saranno affrontati, certamente dal punto di vista dei concetti economici significativi sul mercato mondiale ma per la
3

loro possibile immediata operatività, alcuni temi generali, su testi classici autentici (secondo l’ammonimento del “filosofo cinese Ciuang-tse” a proposito della brechtiana Originalità).
= Introduzione storica sul mercato mondiale, generale e comune sia alla prima che alla seconda parte, per inquadrare la nascita del capitalismo in Gran Bretagna (ma come caso iniziale ed emblematico per i successivi sviluppi sull’intero mercato mondiale) e le sue trasformazioni, fino all’avvicendamento, l’una per l’altra secondo i paragoni e i ricorsi storici che chi legge potrà fare, di altre potenze capitalistiche mondiali.
- Formazione economica, storica e sociale del modo di produzione capitalistico, quale categoria capace, a partire dalle precedenti forme economiche precapitalistiche, di fornire una chiave di lettura per le successive fasi di trasformazione del capitalismo stesso su scala mondiale – avendo sempre al centro la forma di merce del prodotto – dalle sue condizioni originarie e concorrenziali a quelle monopolistiche finanziarie; rientrano in questo contesto anche i primi cenni, non specialistici, di riferimento e raccordo con le forme di commercio e finanziamento internazionale (debito estero, ide, ecc.), e con le mutevoli funzioni degli organismi sovrastatuali (da Bretton Woods e la sua crisi, all’integrazione mondiale ed europea in particolare, ecc.), fino ai cambiamenti del ruolo dello stato.
- Caratteristiche del processo di lavoro (lavoro salariato) quali invarianti di tutta l’epoca storica moderna nel loro rapporto di capitale, dalle prime forme classiche passando attraverso le critiche a esse, proprio per capirne la specificità attuale nell’intero mercato mondiale; tali caratteristiche forniscono le definizioni semplici adeguate a spiegare sia le trasformazioni, avvenute in due secoli, di divisione, cooperazione e organizzazione del lavoro (fino alle attuali forme di “flessibilità”, anche contrattuali); sia la proliferazione territoriale della forza-lavoro, economicamente salariata, e della sua sperequata riserva su scala mondiale; sia, conseguentemente, le più antiche, e allo stesso tempo moderne, forme internazionali di salario adeguate al concetto di capitale contemporaneo.
- Significato della “rivoluzione industriale” (automazione del moto), in senso lato, in quanto avvio, non solo storico e sociale ma fondamentalmente economico, di una nuova epoca a essa coeva: quella capitalistica, avente valenza internazionale e non solo britannica; in ciò si inseriscono alcune altre indicazioni: sia sui mutamenti degli equilibri economici, sociali e territoriali, attraverso la loro diffusione planetaria, trasversalmente agli stati mediante “filiere”, ancora in continuo divenire, e caratterizzati dal prevalere di ragioni di scambio ineguali; sia sulle trasformazioni delle macchine che hanno portato ovunque all’attuale seconda grande rivoluzione industriale mondiale (automazione del controllo) con la tecnologia dell’informazione.
Hieronymus Bosch, Disegno (1500 ca.)
Avvertenza: II parte
La tematica tratta argomenti che concernono una fase particolare, non solo economica ma anche storica, sociale e politica, del mondo contemporaneo. Da un lato, c’è l’urgenza pratica data dalla prolungata stagnazione del processo di accumulazione mondiale, per una crisi ultradecennale tuttora irrisolta, sfociata da tempo in speculazione su un capitale fittizio; d’altro lato, ci sono la necessità dell’accumulazione di capitale, epperò della necessarietà della crisi del modo di produzione capitalistico in quanto tale, quali nodi teorici specifici dell’attuale società. Sulla base di questa duplice caratteristica, si potranno comprendere i concetti che spiegano l’alternarsi delle fasi di accumulazione e crisi, proprio portando l’osservazione sulla realtà empirica quotidianamente esibita da dati informativi e istituzioni internazionali.
Gli argomenti sono fondati sulla teoria dell’accumulazione e delle crisi e chiariscono la documentazione specialistica ufficiale delle istituzioni internazionali. La prefazione, a cura del docente, è tesa a mostrare i
4

moltissimi nessi dell’attualità con la sua base storica, accennando a questioni come la recrudescenza della conflittualità interimperialistica, il significato delle forme del neocorporativismo sul mercato mondiale, la speculazione, la contesa tra le aree valutarie, ecc. Anche in questo caso la prefazione costituisce solo una chiave interpretativa per i successivi testi “classici”; tuttavia, essa è intesa precipuamente proprio per sollecitare l’approfondimento nella prospettiva del compimento critico dello studio di ciascuno. Le quattro parti dell’antologia dei materiali saranno quindi affrontate, certamente dal punto di vista dei concetti economici significativi sul mercato mondiale ma per la loro possibile immediata operatività, su testi classici autentici.
- Processo di accumulazione del capitale e mercato mondiale: connaturato al concetto del modo di produzione capitalistico e alle immanenti contraddizioni dell’accumulazione di capitale, tale processo è caratterizzato da ricorrenti crisi da sovraproduzione, contrariamente a quanto si intende con “globalizzazione” (senza gerarchia tra capitali e tra stati) o con “nuova economia” (senza saturazione del mercato). Esso costituisce la categoria portante della fase storica degli ultimi due o tre secoli, e denota sia il carattere storicamente “progressivo” del modo di produzione capitalistico, sia i suoi limiti intrinseci; a essi non possono far fronte né gli interventi degli stati e degli organismi sovranazionali, nelle continue modificazioni dei loro ruoli, né la loro presunta “regolazione”, nell’allargamento massimo possibile del mercato mondiale dei capitali e del credito. Tale secolare processo è teoricamente spiegato dall’immutabile adeguatezza concettuale della legge generale dell’accumulazione e delle sue immanenti contraddizioni. La dispersione per il pianeta delle forze di lavoro e le difficoltà crescenti incontrate dagli organismi sovranazionali vanno spiegate in questa luce.
- Imperialismo e contraddizioni del capitale: inevitabile esito dell’accumulazione e delle sue periodiche crisi da sovraproduzione, dalle prime forme di concorrenza atomistica tra entità di dimensioni non significative per il mercato, a quella tra gruppi monopolistici finanziari sempre più grandi e a carattere transnazionale, operanti per aree valutarie. Una teoria corretta delle varie fasi dell’imperialismo capitalistico non assume solo definizioni “pure” ma esamina la realtà in continua trasformazione; l’innovazione scientifica e tecnologica, e i cambiamenti culturali che l’accompagnano anche in relazione al problematico “ricambio organico con la natura”, così come le prefigurazioni per una trasformazione sociale del modo di produzione stesso, fanno parte di ciò.
- Prodromi della crisi: la saturazione del mercato mondiale si manifesta attraverso l’antitesi tra circolazione e produzione; il carattere capitalistico del tempo e delle forme materiali e sociali della circolazione contiene in sé la potenzialità di sviluppo della crisi. La metamorfosi delle diverse funzioni del capitale (denaro, produzione, merce) nel complessivo ciclo della sua metamorfosi descrivono teoricamente la potenzialità di tale crisi, la cui forma monetaria è la prima a venire in luce, ma non ne costituisce la causa. La speculazione su un capitale “fittizio”, e il ricorrente scoppio delle “bolle” da essa create, ne è con queste ultime solo una conseguenza.
- Eccesso di sovraproduzione: invariante di tutte le contraddizioni dell’accumulazione di capitale, è denotato da una tendenza alla saturazione del mercato mondiale e alla sovraproduzione, fenomeno tipico del solo modo di produzione capitalistico e del suo necessario processo illimitato di accumulazione di valore, e non della produzione di ricchezza in genere. La ricorrenza delle crisi fa esplodere il capitale simultaneamente in ogni sua forma, storica politica e militare, sociale ma anzitutto economica (condizioni oggettive della produzione e soggettive racchiuse nel lavoro). I limiti del capitale e le sue tendenze si mostrano significativamente nello sviluppo del credito, nelle forme della concorrenza e nel carattere antitetico della socializzazione.
I materiali sono presentati come antologia di testi “classici”, qui appunto selezionati a frammenti e sottoposti a un “montaggio” per fini didattici – di cui, solo per confronto e possibile completamento con le parti necessariamente omesse, sono indicate qui sotto le fonti. Dopo ogni brano riportato, è indicato il luogo originario di provenienza [con una sigla in corsivo, come quella appresso apposta, seguita da numeri, romano e arabo, riferentisi a volumi, quaderni, parti, capitoli e paragrafi, secondo l’indicazione di ciascun autore].
Nella compilazione fatta si è seguito, come detto nel primo occhiello di Bertolt Brecht, il suggerimento dell’“originalità” di comporre “un libro di centomila parole formato per nove decimi da citazioni” (in realtà quasi centottanta mila formato per otto decimi da citazioni), giacché diceva il vecchio filosofo cinese “da noi tali libri non possono più essere scritti perché manca l’ingegno”; nel secondo occhiello, trattando la seconda parte della crisi del capitale, prevale con decisione la considerazione fatta da Paul Klee l’anno precedente la “grande crisi del 1929” per cui di fronte a un tracollo pratico diceva “ci manca ancora la forza fondamentale: le masse non sono con noi. Ma noi cerchiamo le masse. Le mie parole non si rivolgono a ciascuno in isolamento, ma si integrano e mettono a fuoco le impressioni. Di più non possiamo fare”.
5

Albrecht Dührer, La rivolta dei contadini (1525)[disegno del progetto per una colonna – mai fatta realizzare]
INDICE
PrefazioneI
1989: il “crollo del muro” dopo due secoli1991: Wall street journal – “La sua ombra resta” 2000: la lunga ultima crisi irrisolta2010: le contraddizioni del capitale-merceII
Il conflitto con la realtà – premessaLa resistibile ascesa del capitale – accumulazione I “fratelli nemici” – imperialismoIl consenso coatto – corporativismoLa sindrome di Mida – crisiLa maschera dei derivati – speculazioneL’ultima istanza – aree valutarieDon Chisciotte e l’osteria dell’avvenire – conclusione
INTRODUZIONE
0. Storia del mercato mondiale e dell’imperialismo0.1. La rivoluzione industriale0.2. L’espansione economica internazionale0.3. Le radici economiche dell’imperialismo0.4. Il mercato mondiale del capitale finanziario
PRIMA PARTE
I.1. Modi di produzioneI.1.1. La produzione e le forme precapitalistiche
6

I.1.2. La formazione del capitaleI.1.3. La sottomissione formale e reale al capitaleI.1.4. La produzione: processo lavorativoI.1.5. La produzione: processo di valorizzazioneI.1.6. La merce: lavoro, valore, denaroI.1.7. La merce: aliquota del prodotto del capitale totale I.1.8. La circolazione monetaria (reddito e capitale)
I.2. Mercato del lavoroI.2.1. La divisione del lavoroI.2.2 La cooperazione e l’organizzazione del lavoroI.2.3 La merce forza-lavoro (lavoro salariato)I.2.4. Le forme del salario (valore della forza-lavoro)I.2.5. La riserva di lavoroI.2.6. Il lavoro produttivo e il lavoro improduttivoI.2.7. Le “false spese” di produzione (costi di circolazione)
I.3. MacchineI.3.1. La nascita del macchinarioI.3.2. Le caratteristiche delle macchineI.3.3. Le contraddizioni dell’industria meccanicaI.3.4. L’uso capitalistico delle macchineI.3.5. Le implicazioni sociali del macchinismo capitalisticoI.3.6. Il sistema di macchine e il mercato mondialeI.3.7. La scienza e il capitale fissoI.3.8. A mo’ di epilogo transitorio: l’intelligenza generale della società
SECONDA PARTE
II.1. Accumulazione e mercato mondialeII.1.1. La legge generale dell’accumulazione II.1.2. L’innovazione nel processo industriale II.1.3. Il mercato mondiale e l’internazionalizzazione II.1.4. Lo scambio ineguale e la sovranazionalità
II.2. Imperialismo e contraddizioni del capitaleII.2.1. Il capitale finanziarioII.2.2. La fase superiore del capitalismoII.2.3. I difetti della società economicaII.2.4. Le contraddizioni immanenti all’accumulazione
II.3. Prodromi della crisiII.3.1. Il tempo di circolazioneII.3.2. La circolazione materialeII.3.3. La metamorfosi delle funzioni del capitaleII.3.4. Il processo complessivo della circolazioneII.3.5. Il capitale fittizio e la speculazione
II.4. Eccesso di sovraproduzioneII.4.1. L’arresto dell’accumulazione e la crisiII.4.2. La sovraproduzione e lo sviluppo della crisiII.4.3. Gli ostacoli al processo di produzioneII.4.4. I limiti del capitale: credito e scala di produzioneII.4.5. Le tendenze del capitale: concorrenza e socializzazione
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI, ACRONIMI, DISEGNI E QUADRI
7

PREFAZIONE
I
“C’è chi sostiene che l’economista non possa trovare nella storia che la verifica di determinate ipotesi particolari (come sarebbe, a es., l’ipotesi di concorrenza perfetta, nel senso di riconoscere se esse, in un senso semplice e immediato, si possano considerare valide per un determinato periodo; e che al di là di ciò non c’è altro che la facile e pericolosa estrapolazione di tendenze passate nel tempo futuro. Questa tesi sembra trascurare, in primo luogo, il fatto che qualunque previsione economica è necessariamente basata su determinate ipotesi riguardanti la presenza (o l’assenza) di tendenze al mutamento, ipotesi la cui probabilità non può assolutamente essere valutata se non facendo riferimento al passato; in secondo luogo, che la rilevanza obiettiva delle questioni cui una determinata teoria si sforza di dare risposta può essere giudicata solo alla luce della conoscenza delle forme di sviluppo e della connessione degli avvenimenti del passato. In altre parole, non è già questione di verificare ipotesi particolari, ma di esaminare sia i rapporti interni di un sistema complesso di ipotesi, sia il rapporto tra questo e la realtà nel suo svolgimento; di scoprire, studiando l’evoluzione di una situazione complessiva, gli elementi che la costituiscono, e le loro connessioni reali, determinando quali di essi siano più suscettibili di mutamento, e quali abbiano maggior peso nel produrre il mutamento di altri; di porre, infine, delle domande allo sviluppo economico, per comprendere quali siano quelle che è giusto porre, sia al passato sia al presente, e quali siano i rapporti essenziali su cui occorre concentrare l’attenzione” [Maurice Dobb, Problemi di storia del capitalismo, prefazione]
Queste poche righe, tratte dalla prefazione del classico libro di Dobb, illustrano a sufficienza la ragione per cui lo studio della storia della rivoluzione industriale, nei suoi tre secoli di svolgimento attraverso le sue forme epocali, fornisca categorie teoriche economiche di riferimento capaci di far comprendere anche gli avvenimenti di grandissimo momento che si stanno svolgendo nella vita presente della società civile. Spesso l’insufficiente comprensione o il fraintendimento degli accadimenti quotidiani dipende dall’acquiescenza alla banalità del senso comune e alla acriticità dell’accettazione di spiegazioni superficiali e fenomeniche, che per la maggior parte non costituiscono spiegazioni ma giustificazioni dell’esistente. Un cambiamento di prospettiva teorica può far scoprire realtà sconosciute.
1989: il “crollo del muro” dopo due secoli
Il bicentenario della rivoluzione francese è stato celebrato nella maniera più adeguata [le osservazioni che seguono risalgono all’epoca del “crollo del muro” di Berlino]. Al di là della mera scadenza simbolica, la bor-ghesia trionfante ha potuto salutare l’apoteosi del mercato mondiale, unificato per la prima volta nella storia dell’umanità. L’inevitabile crisi di reversibilità delle economie pianificate e di comando dei regimi del realsocialismo orientale, in Europa e Asia, ha coronato con successo l’assedio della merce protrattosi per oltre mezzo secolo. Le contraddizioni interne a quei regimi hanno fatto il resto, mentre la crisi capitalistica internazionale degli ultimi decenni ha lanciato il segnale per l’assalto finale. Il risultato dell’unificazione del mercato mondiale del capitale è però da considerare solo come l’avvio dell’ultimo atto del dramma, se non si vuole che questo si muti in tragedia.
Dopo quasi cinque secoli dall’inizio della storia moderna della vita del capitale, comincia ora la storia del suo compimento, del suo lungo atto finale appunto. Solo sul mercato mondiale, nella massima fluidità mobilità e universalizzazione, il capitale si adegua al suo concetto. Ma così facendo, e saturando tutti gli spazi disponibili, esso crea anche le condizioni del suo deperimento, del suo superamento dialettico. Che sia questo il senso della storia è evidente a chiunque non si rinchiuda nell’apologia di un modo di produzione e di una forma sociale ritenuta eterna, come invece da oltre un secolo predica l’economia politica dominante. Qualunque realtà prodotta dagli uomini, come nasce, è destinata a perire: il capitale, come forma di relazione storica sociale, è una di codeste realtà. Non si vede perché molti si ostinino a far credere che, nell’economia, non debba essere così. Il problema è cercare di capire quale sistema – tra i tanti possibili, di cui nessuno ha il crisma dell’ineluttabilità – possa seguire al deperimento e alla fine del capitalismo, e di agire di conseguenza, affinché non si giunga all’esito tragico del dramma, con l’autodistruzione della società umana.
La comprensione delle profonde ristrutturazioni in atto da qualche anno a questa parte – con la seconda grande rivoluzione industriale dell’automazione del controllo – serve a codesto scopo. Capire il come perché e quando dei vari momenti di questa fase di trasformazione epocale – in relazione alle potenzialità offerte dallo sviluppo della scienza, delle macchine e delle altre forze produttive del lavoro sociale, alle condizioni della reale socializzazione dei processi produttivi e vitali messi in moto dal capitale, e alla necessità del tempestivo ristabilimento degli equilibri demografici e ambientali per un organico ricambio con la natura –
8

dovrebbe essere un compito minimo per chi voglia interessarsi di questioni economiche e sociali. Il chiarimento delle determinazioni teoriche, che aiutino a fornire spiegazioni sempre più scientificamente credibili, è parte essenziale di tutto ciò.
La breve storia recente, che qui si richiama sommariamente, ebbe inizio circa alla metà degli anni 1960, nel corso dei quali si può fare risalire la svolta più importante della storia economica e politica contemporanea – l’avvio dell’ultima crisi di un’epoca – allorché cominciarono a invertirsi le principali tendenze del capitalismo Usa. Gli avvenimenti successivi – nel mondo intero, fino al rammentato crollo del realsocialismo e ai minacciosi vènti di guerra – hanno tutti le loro lontane radici, la cause causanti, in quegli anni: le motivazioni successive sono solo cause emergenti, occasionali se non pretestuose. La saturazione del mercato mondiale a cagione della sovraproduzione incombente, l’interruzione del ciclo di metamorfosi e di accumulazione del capitale internazionale, la disoccupazione di massa, l’inflazione generalizzata, la pletora di capitale monetario con la crisi del credito internazionale e i palliativi monetaristici, la caduta del tasso di profitto col conseguente inasprimento della concorrenza sul mercato mondiale fino a esiti protezionistici – sono tutte conseguenze di quella svolta.
Quali siano stati gli accadimenti internazionali nel biennio 1968-69 ognuno sa. Nel 1970-71 il dollaro venne dichiarato inconvertibile e poi svalutato, aprendo la strada inizialmente incerta e controversa all’affer -mazione dello yen e del marco. In codesta situazione, la crisi del capitalismo mondiale, ancora guidato dagli Usa, impose nel 1972-73 l’aumento indiscriminato dei prezzi di tutte le materie fondamentali. Si cominciò dalle materie prime e dai prodotti agricoli. Contrariamente a quanto troppo spesso si ripete, la crisi delle fonti di energia e il cosiddetto shock petrolifero fu solo l’ultimo passo compiuto in quella gestione della crisi che avrebbe dato il via al processo di inflazione. Le condizioni per una nuova spartizione del mercato mondiale erano appena poste. Le manovre sono ancora in corso; le armi usate sono di ogni genere; l’esito è tuttora incerto. Fu a partire dagli anni 1974-75 che il capitale multinazionale, per bocca del segretario di stato Usa, Henry Kissinger, cominciò a discutere di nuovo ordine economico internazionale. La controffensiva dei paesi imperialisti [quelli che con un tortuoso giro di parole sono detti economie industrializzate a capitalismo maturo] era solo alle prime mosse, cariche di contraddizioni interne tra i protagonisti.
Liquidato l’antagonismo che le classi lavoratrici e popolari avevano manifestato nei precedenti anni caldi – attraverso la coppia di disoccupazione e inflazione, nell’unico brodo di coltura sempre adeguato, quello recessivo [talché la cosiddetta stagflazione lungi dall’essere una stranezza va considerata la norma in siffatte circostanze] – l’agone mondiale era pronto per accogliere la ridefinizione della proprietà e dell’assetto finanziario e la ristrutturazione industriale del capitale multinazionale. Contraddittoriamente, la tendenza all’unificazione del mercato mondiale e alla transnazionalità del capitale, però, doveva e deve fare ancora i conti con i superstiti tortuosi percorsi di interessi e privilegi, più o meno lobbistici, vincolati alle entità nazionali, rappresentate ancora dalle antiche strutture statuali.
In codesto quadro si determinò e si sviluppo la crisi del credito internazionale, rovesciatasi in tragedia economica e sociale per i paesi debitori, e l’avventura dell’economia di carta con la speculazione borsistica e monetaria, espressasi attraverso la precaria prevalenza teorica e pratica del cosiddetto neo-monetarismo. Negli anni 1980 la sovrabbondanza di credito monetario favorì la sublimazione del capitale col predominio delle banche sull’industria, del denaro sulla merce, della speculazione sulla produzione. Il debito – privato e pubblico – è la denominazione speculare del credito. La spirale credito-debito pubblico portò all’aumento abnorme degli interessi passivi, sotto l’egida del (neo)liberismo monetarista trionfante: una vittoria di Pirro, per il colpo di coda di un dollaro agonizzante, che è servita però a spostare verso la sfera privata la precedente attenzione sociale della spesa, per molti anni a venire. La cosiddetta terziarizzazione delle economie capitalistiche mature – con il connesso falso mito del post-industriale, generato da una effettiva parziale deindustrializzazione dell’economia Usa – nasce essa stessa su tale terreno. Anche se si tende sovente a dimenticarlo, l’intero svolgimento di questi fatti fu messo in moto quindici anni prima.
Tutto ciò non fu che il preludio del drastico processo di razionalizzazione economica, sociale e istituzionale, che ognuno ha potuto sperimentare. Codesta razionalizzazione ha nella ristrutturazione del processo di produzione industriale, sul piano internazionale, il suo fulcro. Soltanto negli ultimi anni la rivoluzione tecnologica ha potuto cominciare a restituire alcuni suoi frutti al capitale mondiale. Ciò è ovvio, in quanto essa può sviluppare la sua capacità di valorizzazione solo dopo che il capitale abbia riassestato il processo di lavoro e la divisione internazionale di codesto lavoro. Ma proprio in tale riassetto, non tutti i comparti settoriali e nazionali del capitale mondiale hanno potuto o possono cogliere i medesimi risultati. Nonostante l’apoteosi del mercato mondiale, celebrata alla fine degli anni 1980 con la provvisoria ma necessaria cancellazione dalla faccia della terra di aree economiche finora sottratte al dominio del capitale, la nuova spartizione economica del mondo è ancora tutt’altro che definita. La conflittualità interimperialistica tra le tre aree dominanti – americana-Usa, asiatica-Giappone, europea-Germania – è tuttora viva e, si direbbe, latente in quanto non giunta a completa, incerta e rischiosa, maturazione. Ancora dopo venticinque anni la crisi è irrisolta.
9

1991: “la sua ombra resta” 1
Le conseguenze della caduta del comunismo. I governi comunisti sono crollati e coloro che erano socialisti hanno abbracciato il libero mercato. Anche i cospiratori golpisti sovietici evitano l’etichetta di “marxisti”. Senonché Karl Marx influenza le moderne concezioni storiche ed economiche. Milioni di persone propendono per l’alterazione del proprio comportamento attraverso l’uso di droghe come Valium o Prozac, anziché ricorrere alla psicoterapia. Senonché le più recenti ricerche sul funzionamento cerebrale derivano direttamente dalle idee di Sigmund Freud. Le indagini dei fisici sull’origine dell’universo mettono in discussione le teorie della relatività. Senonché il lavoro di Albert Einstein puntella quello di molti fisici moderni, sollevando la stessa domanda che gli altri si pongono su Marx e Freud: aveva ragione? Forse, più di qualsiasi altro grande pensatore della storia, Marx, Freud e Einstein hanno informato di loro stessi il xx secolo. Sono tutti nati nel XIX secolo, e solo Einstein ha svolto la maggior parte del suo lavoro in tempi più recenti. Senonché le loro idee erano così sorprendenti e lungimiranti da entrare nella coscienza popolare in una maniera che non esiteremmo a definire “moderna”. Essi minarono i dogmi dei loro tempi e, così facendo, ne crearono di nuovi per i nostri. Ancora oggi, i loro nomi accendono controversie che spaziano dai fondamentalismi religiosi all’avanguardia scientifica. Avendo conformato così il XX secolo, non è probabile che essi aiutino a ridisegnare anche il XXI?
Gli eventi tumultuosi dei due anni 1989-90 – innanzitutto il collasso del comunismo in molti paesi – hanno mandato i marxisti a nascondersi. Nessun grande pensatore è stato così ampiamente discreditato come Marx – almeno come lo si vuole dipingere. Il marxismo, politicizzato e attuato da Vladimir Lenin, sembra moribondo.2 Ma anche se le popolazioni, recentemente liberate, dell’Europa dell’est e dell’Urss, inneggiano all’apparente eclissi di Marx, altri scorgono nuove cognizioni nella sua opera. L’analisi rivoluzionaria di Marx, infatti, si concentra quasi esclusivamente sul capitalismo, non sul socialismo, e ancora oggi diversi abusi sorgono dal capitalismo sfrenato. Idee rintracciabili nel lavoro di Marx hanno la loro eco nell’attuale dibattito economico e sociale in paesi capitalistici quali Usa, Canada ed Europa occidentale. In tali posti, naturalmente, commentatori politici e sociali non citano Marx. Ma essi spesso affrontano questioni che non erano riconosciute come tali fino al suo avvento. Ecco alcuni esempi della sua acuta influenza:
- Benessere sociale. Marx intendeva raddrizzare le crescenti disparità tra ricchi e poveri. Oggi molti politici Usa, specialmente “democratici”, pianificano campagne che deplorano i guadagni finanziari dei ricchi a favore di un’ulteriore redistribuzione del reddito3.
- Movimento ambientalista. Marx preconizzò che l’interesse personale non regolato avrebbe condotto a risultati socialmente indesiderabili. A es., si lamentava dell’inquinamento del Tamigi, proprio come oggi fa la popolazione nell’area di Boston. E diceva ciò quando pochissime persone si occupavano di questioni ambientali.
- Leggi di emergenza sulla sicurezza. Marx disse che una concorrenza aperta avrebbe eroso il tessuto morale della società, producendo individui alienati interessati solo del proprio guadagno. Predisse il collasso del capitalismo ma, ironicamente, la sua analisi si può in qualche maniera applicare alla disintegrazione dei governi comunisti, i cui regimi erano costruiti sul suo stesso pensiero, ma non secondo le sue specificazioni.
“Marx non scrisse praticamente niente sul socialismo o sul comunismo” – dice Samuel Bowles, un economista marxista4 dell’università del Massachusetts. Cosicché, non c’è stato nulla negli eventi recenti che abbiano indotto il prof. Bowles a rifiutare l’etichetta marxista. “Il fulcro degli eventi nell’Europa dell’est è
1 Sulla prima pagina del Wall street journal – il ben noto quotidiano finanziario di proprietà della Dow Jones & co. – di lunedì 25 novembre 1991, a firma di un redattore, certo Henry F. Myers, fu pubblicato il seguente articolo sul “grande analista” Karl Marx. Il suo titolo (sopratitolo corrente e sottotitolo) – Le sue statue crollano, la sua ombra resta; Marx non può essere ignorato. Nella sua critica del capitalismo, il grande analista aiuta a ridisegnare l’attualità: Das Kapital – è estremamente significativo. Nonostante questo istruttivo esempio – ovviamente argomentato dal punto di vista della più forte borghesia al potere – in Italia la stampa padronale e i suoi altri mezzi di comunicazione, o chi parla a vanvera di “comunismo”, e tantomeno l’accademia costituita, hanno mai dato il benché minimo rilievo all’importanza dell’analisi marxiana. Non occorre dire che la compiuta interpretazione dell’opera di Marx è decisamente altra; senonché, in mancanza di un’appropriata elaborazione critica, anche la sia pur minima conoscenza della sua “analisi” è parte integrante del pensiero economico per chiunque, ancorché ridotta a mera spiegazione descrittiva. Con tutti i suoi limiti, l’articolo del Wsj rappresenta l’inequivocabile dimostrazione di quanto sia inevitabile lo studio serio del marxismo, ancora oggi. Proprio per evidenziare codesti limiti, oggettivi e non interpretativi, sono state qui però inserite anche le note seguenti di definizione e chiarimento, in relazione a concetti, termini e persone. Sono state inoltre tolte alcune poche frasi inutili, riferentisi a temi e personaggi esclusivamente vincolati all’epoca (inizio anni 1990) in cui fu scritto l’articolo.
2 Quanto asserito per Marx – il discredito attribuibile a “come lo si vuole dipingere” – può pedissequamente essere ripetuto per la cattiva lettura dell’opera di Lenin, del quale invece la classe dominante vuol disfarsi politicamente.
3 Come in parte specificato anche appresso, secondo alcuni interpreti, è evidente come Marx aborrisse riferire la propria critica del capitalismo alla mera “redistribuzione del reddito” (tema prettamente keynesiano).
4 In realtà, Samuel Bowles appartiene a quella schiera di economisti detti “regolazionisti”, che ha solo sfiorato alcune categorie marxiste in un’eclettica contaminazione teorica con il keynesismo di sinistra e lo sraffismo, al di fuori della marxiana teoria del valore (cfr. la successiva nota 15).
10

consistito nel collasso della proprietà pubblica dei mezzi di produzione. – ha sottolineato – Sicché c’è una gran quantità di cose da ripensare a proposito delle economie socialiste, ma poco su quelle capitalistiche”.
Gli economisti non marxisti, in genere, concordano. Essi osservano, a es., che gli scritti di Marx stesso non menzionano mai la pianificazione centrale. Marx era un utopista5 il quale assunse, più o meno, che, una volta che il socialismo avesse soppiantato il capitalismo, molti dei problemi del mondo sarebbero spariti. Egli era – dice Allan Metzler, economista Carnegie Mellon – colpito dalla “delusione liberale”, in base alla quale tutto ciò di cui ogni società ha bisogno è “dare potere alle brave persone per raggiungere buoni risultati”. L’attenzione di Marx per il capitalismo – dice Philip Mirowski dell’università Notre Dame – spiega i motivi del “trattino”, ossia del perché la maggior parte delle persone abbia discusso non delle idee marxiste, quanto di quelle marxiste-leniniste. Lenin, non Marx, delineò un sistema comunista.
In molte maniere, tuttavia, proprio l’opera di Marx ha influenzato il pensiero occidentale. Michael Novak, dell’American enterprise institute, nota come “la maggior parte delle definizioni di "capitalismo" date dai dizionari siano prese da Marx”; esse sottolineano la proprietà dei mezzi di produzione rispetto al ruolo innovativo dell’imprenditore. E in molte università occidentali, sostiene il prof. Mirowski, il marxismo rimane “un’importante forza culturale”, non tanto tra gli economisti quanto in dipartimenti di letteratura e storia sociale. Neppure il collasso del comunismo in molti paesi è riuscito a spazzar via i caposaldi dell’ideologia marxista. Le persone in tali paesi parlano di “economia di mercato” senza capire ciò che dicono. Essi continuano a opporsi alla proprietà privata, denigrano i profitti come semplice furto e vogliono che ciascuno guadagni quanto qualsiasi altro.
L’influsso sulla storia. L’opera di Marx conserva la propria influenza come sistema intellettuale di analisi. Esso “rimane insostituibile e di grande momento, sebbene molti dettagli della sua spiegazione si siano di-mostrati erronei” – ha scritto, nel suo libro Marxismo, pro e contro, Robert Heilbroner, professore alla New school for social research di New York. Come Platone e Freud, Marx ha instaurato un modo di indagine vòlto a raggiungere la realtà nascosta “sotto la superficie della storia”, egli ha aggiunto. “La combinazione marxiana di introspezione e metodo modifica permanentemente la maniera in cui la realtà viene così percepita”.
Egli è pervenuto a ciò sia ponendo domande molto acute, sia fornendo risposte alquanto originali. Il maggior esempio della sua originalità sta nella sua interpretazione della storia, la teoria per cui, nelle sue stese parole, “il modo di produzione della vita materiale determina il carattere generale del processo di vita sociale, politica e spirituale”. È difficile trovare precedenti significativi di questa idea, secondo cui le forme della produzione e i rapporti di scambio definiscono l’intera formazione sociale. La straordinarietà di Marx sta anche nel fatto che “pochissimi pensatori nella storia” abbiano avuto un tale influsso – dice Daniel T. Rodgers, professore di Storia del pensiero americano a Princeton. “I socialisti e i comunisti usano le sue opere come testi”. John Kenneth Galbraith ha osservato come i precedenti pensatori radicali abbiano criticato il capitalismo, ma che solo Marx con il suo “lavoro ha apportato un’autorità e una convinzione incomparabilmente più grande dei socialisti predecessori”. Pertanto ciò ha rafforzato notevolmente le argomentazioni socialiste – sostenendo non solo i governi autoproclamatisi socialisti ma anche la tendenza universale a interventi governativi6 nelle economie nazionali, compresa quella Usa.
Ma l’opera di Marx ha svolto un ruolo curiosamente striminzito nella rivoluzione russa. Paul Johnson, lo storico britannico, definisce Lenin un opportunista che “ha completamente ignorato il nucleo dell’ideologia di Marx, il determinismo storico della rivoluzione”7. Al contrario, sostiene Johnson, Lenin riteneva che “il ruolo decisivo era svolto dalla volontà umana: la sua”. Neppure i comunisti cinesi seguirono gli scritti di Marx8. Nondimeno, si possono attribuire a Marx – che a volte ha suggerito di imporre il nuovo ordine con la forza – le colpe del totalitarismo comunista? Può uno che ha immaginato alcune cose essere ritenuto responsabile delle azioni dei suoi seguaci di anni dopo? Il cristianesimo e altre religioni sollevano le stesse questioni. Ha l’uomo del "discorso della montagna" favorito realmente l’Inquisizione spagnola? Come il suo contemporaneo Charles Dickens, Marx propendeva indubbiamente per i poveri9. Intanto, lui e sua moglie, che hanno avuto cinque figli, erano loro stessi poveri. Ma, ciò che più importa, è che in quell’epoca le condizioni di lavoro erano orribili.
5 Basti leggere ciò che Marx e Engels scrissero sugli “utopisti” – da loro considerati sempre più reazionari, col passare del tempo, a eccezione cioè di quelli che fino al XVIII secolo portarono avanti disegni storici anacronistici, epperò criticamente costruttivi (a es., Saint-Simon, Fourier, Owen, per non dire di Giordano Bruno, Campanella, Erasmo, More, ecc.) – per capire quanto quell’etichetta sia impropriamente attribuita a Marx.
6 L’attribuzione a Marx di criteri relativi all’intervento pubblico in economia rientra piuttosto nella lettura post-marxista, invalsa in Usa ma non solo, di derivazione keynesiana e regolazionista (v. note 3 e 4).
7 Sia Marx che Engels, in numerosi scritti, prefazioni e commenti a opere fraintese, e altrove, hanno chiaramente argomentato come la loro teoria non fosse affatto “deterministica”; confondere il “determinismo” con la dialettica è vizio frequente della superficialità dominante, indipendentemente da ciò che si pensi della dialettica stessa.
8 Pur senza sottoporre a necessaria discussione l’opera di Lenin, né quella di Mao, non ha alcun significato scientifico, e neppure analitico o semplicemente testuale, liquidare così ideologicamente quell’opera successiva rispetto a Marx (v. nota 2).
9 Come è facile riscontrare dai testi, e come si può anche leggere più avanti in altre interpretazioni citate nell’articolo, il riferimento di Marx alla povertà non era mai immediato, ma visto come conseguenza dei rapporti di proprietà e di classe.
11

In Das Kapital, il suo capolavoro in tre volumi, Marx cita a lungo i rapporti di medici e ispettori di fabbrica. A es., un magistrato di Nottingham nel 1860 diceva: “gli adolescenti di nove o dieci anni sono tirati giù dai loro squallidi letti alle tre o alle quattro del mattino e costretti a lavorare per la mera sussistenza fino alle 10, 11 o 12 della sera”. Marx riferisce anche di un bambino di sette anni che lavorava sedici ore al giorno per fare carta da parati, il cui padre ricordava: “io spesso mi dovevo inginocchiare per nutrirlo mentre lui restava in piedi davanti alla macchina, dato che non poteva lasciarla o fermarla”. Le condizioni nelle miniere britanniche, per le donne come per gli uomini, erano anche più spaventose.
Lo stesso Marx era furioso per gli abusi che avvenivano in Inghilterra, la sua patria d’adozione, e spinse per molte riforme10 alle quali oggi pochi si oppongono. A es., propose limitazioni alla giornata lavorativa e norme sulla sicurezza nelle fabbriche. Denunciò anche l’adulterazione del pane a Londra. Ma, soprattutto, denunciò l’intero sistema capitalistico e, come critico, fu formidabile. Studiando per anni nella biblioteca del British museum a Londra, divenne indubbiamente la massima autorità mondiale sulla storia del pensiero economico. Fu anche – come afferma il prof. Heilbroner in The worldly philosophers – “lo studioso tedesco per eccellenza, lento, meticoloso, coscienziosamente e anche cautamente perfezionista”.
Un analista nato. Marx, arrabbiato e spesso irascibile, era anche un analista nato, al punto che la sua analisi senza limiti portò i suoi sforzi a trasformare le sue lunghissime annotazioni in libri. Il primo libro di Das Kapital fu pubblicato nel 1867, dopo diciotto anni di lavoro; gli altri due libri furono sistemati da Friedrich Engels, amico e collaboratore di Marx, dopo la morte di quest’ultimo avvenuta nel 1883. Marx sezionò inflessibilmente il capitalismo, cominciando con le transazioni basilari, svelandone poi i problemi e indicandone il collasso. Sebbene non abbia mai prospettato precisamente, disastro dopo disastro, alcuna previsione su come tale collasso sarebbe accaduto, disse che il capitalismo sarebbe crollato per le sue stesse contraddizioni interne, ossia a causa delle stesse forze che lo hanno fatto progredire. Tra gli altri problemi – disse – la dura concorrenza, combinata con l’introduzione di macchinario sempre più produttivo, avrebbe provocato una disastrosa caduta dei profitti. Premonì anche, genericamente, che i lavoratori sarebbero diventati sempre più poveri – e sempre più propensi alla rivolta. Queste indicazioni non sono state confermate. Negli anni 1920-30, il prof. Rodgers ha sostenuto che le teorie di Marx “non si adattavano” al successo del fascismo11. Sicché molti storici conclusero, in contrasto con gli scritti di Marx, che non le forze economiche ma la cultura, le idee, il nazionalismo e anche mere manovre politiche contavano di più. Il nazionalismo, a es., ha minato i movimenti proletari internazionali, e grandi cambiamenti nello sviluppo di una nazione possono derivare da nient’altro che da qualche capriccio dei politici.
Differenze di classe. Ma nonostante che il rozzo determinismo economico12 sia stato superato, il lavoro di Marx conserva molte frecce al suo arco. Oggi il prof. Rodgers dice che “il neo-marxismo 13 ha una notevole influenza” sulla ricerca storica attraverso la sua sottolineatura degli “effetti dei rapporti di classe nella storia”. Esso studia “le differenze tra le classi, non tra ricchi e poveri, a proposito della loro integrazione nel sistema di produzione e dei cambiamenti nella composizione di classe. Si tratta di uno strumento analitico che potenzialmente è di chiunque”. Esso influenza gli storici sociali – afferma Lloyd Gardner, professore Rutgers di storia diplomatica americana – “a causa della natura dei gruppi sociali che essi studiano. Se si studia il movimento operaio, a es., si è predisposti in tale direzione”. Ma esso influenza indirettamente anche gli storici della diplomazia. Barton Bernstein, di Stanford, cita l’onnipresente argomentazione secondo cui gli interessi per gli affari influiscono pesantemente sulla politica estera Usa.
Per molti economisti, come per molti storici, Marx è troppo datato per seguirlo, ma troppo importante per ignorarlo. Stephen Marglin, che si autodefinisce “eclettico” a Harvard, sottolinea le concezioni precorritrici marxiane sul lavoro. Marx – egli afferma – gettò nuove basi riconoscendo che “il lavoro è fondamentalmente differente dalle altre merci. Diversamente da quando si compra un’arancia, quando si assume un lavoratore occorre ottenere da lui del lavoro. E il lavoratore ha il suo proprio campo d’azione”. Tra gli altri contributi di Marx all’economia, il prof. Marglin ne ricorda “il rilievo dato all’accumulazione, il processo di investimento e di formazione del capitale fisso”; così come “l’insistenza sull’instabilità e sul processo evolutivo di cui il capitalismo è parte”; le riflessioni sui “rapporti del capitalismo con la politica, il sistema giuridico, le tendenze culturali, ecc.”; e l’idea secondo cui “la strutturazione delle classi intorno agli interessi economici è essenziale per comprendere il funzionamento e i mutamenti dell’economia”.
10 Il discorso delle “riforme” attribuito a Marx è molto più complesso, ma rientra qui in ciò che si è detto a proposito dell’inter -vento pubblico; Marx partiva sempre dalla considerazione del “modo di produzione” e non dalla distribuzione del reddito (v. nota 3).
11 Le opinioni generali qui espresse non sono in realtà suffragate da alcun riscontro obiettivo (semmai nei recenti tempi di crisi sembrerebbe proprio il contrario, ossia vere le indicazioni marxiane); in particolare, le teorie economiche marxiste (dal monopolio al capitale finanziario, fino all’imperialismo e alla guerra) “si adattano” assai bene alle forme economiche e politiche del fascismo.
12 v. nota 7.13 Il cosiddetto “neo-marxismo” – come tutto ciò che a cui è premesso “neo” – non ha con l’opera di Marx punti fondamentali di
contatto, rappresentando piuttosto un’ibridazione con altre tesi, più o meno dominanti (v. alcune precedenti note, a partire dalla 4); in particolare, esso abbandona la marxiana teoria del valore e del plusvalore (cfr. successiva nota 17), il che, qualunque giudizio si dia alla questione, costituisce una differenziazione essenziale.
12

Richiamando con forza l’attenzione su codeste tendenze, Marx ha sollevato importanti questioni che gli economisti immediatamente successivi hanno ignorato, ma che quelli venuti dopo non possono più evitare. Un esempio: respingendo la “legge di Say” – secondo cui “l’offerta crea la propria domanda” – e con essa l’ipotesi dell’economia classica di una implicita tendenza alla piena occupazione, Marx ha messo al centro il problema delle recessioni economiche. Sebbene egli non abbia divisato una teoria compiuta dei cicli economici14, ha tuttavia fornito un’ampia gamma di spiegazioni che hanno stimolato – e continuano ancora a farlo, soprattutto in tempi bui – l’indagine economica. Inoltre – sostiene il prof. Bowles – “molte anticipazioni di Marx erano esatte: l’avvento dell’industria su larga scala, la concentrazione del potere e del controllo, il ruolo dinamico della tecnologia”.
Democrazia trascurata. Tuttavia Marx “sottostimò la capacità del sistema di riformare se stesso” – sostiene il prof. Marglin. “Il capitalismo odierno è molto diverso da quello dell’epoca di Marx”. In particolare, Marx sottostimò la capacità del governo, spinto dalla competizione politica (specialmente dopo l’ottenimento del diritto di voto da parte dei lavoratori), di aiutare i poveri. “Evidentemente Marx non anticipò l’ampia estensione dell’intervento statale nella sfera delle imprese attraverso la regolazione, la proprietà pubblica, la crescita della socializzazione del capitale e del sistema fiscale del reddito pubblico, e l’incanalamento del risparmio e dei fondi governativi per soddisfare i bisogni collettivi” – scrisse Leo Rogin, che fu economista presso l’università di California, a Berkeley. Nonostante la grande attenzione riservata ai mutamenti tecnologici, Marx non valutò appieno l’enorme afflusso di ricchezza dovuta al macchinario moderno, alla catena di montaggio e alla riduzione di costi dei trasporti ferroviari. Né riuscì a vederne le implicazioni per il miglioramento delle condizioni di vita, malgrado gli evidenti vantaggi in tutta Europa15.
“Marx ha perso l’occasione per vedere quanto bene il capitalismo potesse fare per i lavoratori” – dice John Rœmer, dell’università di California, a Davis. I lavoratori sono diventati avidi di spartirsi i frutti del sistema piuttosto che capovolgerlo, più borghesi piuttosto che affrontare la rivoluzione. La scarsa attenzione per i cambiamenti che avvenivano intorno a lui era particolarmente pericolosa proprio per l’impostazione analitica che Marx aveva. Egli non concepì il capitalismo come eroso dalla cupidigia: avanzò un’argo-mentazione molto più fondamentale – e quindi anche più forte. Egli postulò un capitalismo ideale, perfettamente competitivo, e sostenne che anche in un simile sistema il male sarebbe stato intrinseco e la condanna inevitabile. Senonché, postulando una concorrenza perfetta, Marx escluse la possibilità che un sistema di concorrenza imperfetta potesse mitigare i rigori del capitalismo puro 16. I capitalisti possono non avere bisogno di estrarre fino all’ultima oncia di lavoro dai lavoratori per rimanere in affari. E se le “imperfezioni” comprendono i sindacati, i lavoratori possono trarre vantaggio dalla loro aumentata capacità di trattativa.
In larga misura il Marx “genio analitico” è stato cacciato in un vicolo dal Marx “agitatore rivoluzionario”. Adottando dagli economisti classici la teoria del valore17 basata sul lavoro – la teoria secondo cui il valore di ogni merce è determinato dalla quantità di lavoro socialmente richiesto per produrla – Marx ha reso obsoleta gran parte della sua opera. Wassily Leontiev, dell’università di New York, sostiene che Marx sapeva che “i prezzi effettivi dei beni non sono proporzionali” al lavoro incorporato in essi, ma la teoria “aveva una finalità politica molto forte” – per dimostrare lo sfruttamento. Le teorie di Marx sono datate anche per altri motivi. A es., egli propugnava la ripartizione della proprietà piuttosto che la distribuzione del reddito, e riteneva in genere che le imprese familiari tipiche del XIX secolo sarebbero rimaste la forza dominante.
“Marx commise un serio errore supponendo che la proprietà implicasse sempre il controllo” – asserisce il prof. Marglin. “C’è ora una classe dirigente completamente nuova che anni fa non esisteva” – dice il prof. Mirowski, e aggiunge: “l’esistenza delle moderne imprese azionarie costituisce un vero problema per Marx,
14 Nessuno ha potuto svolgere, ammesso che sia possibile, un esame completo delle cause dei cicli economici – e delle crisi in generale – ma forse Marx è stato l’unico a riuscire a impostarne correttamente la dinamica, attraverso lo studio dialettico dei mutamenti oggettivi dell’economia; naturalmente, nella sua disamina non c’è traccia di analisi “econometriche” (poiché non è questo il vero problema), certo per l’epoca storica in cui scriveva, ma soprattutto per scelta teorica.
15 Le mere differenze storiche, un secolo e mezzo dopo, sono tautologiche. Senonché le questioni fattuali stesse sono inquadrate in un diverso contesto mondiale, di cui Marx era perfettamente consapevole. Gli “evidenti vantaggi” raggiunti in Europa o in Usa (nei paesi imperialistici, cioè) non possono oggi essere esaminati senza vedere anche le condizioni di lavoro e di vita – di fame – della metà della popolazione del pianeta. Perciò l’intero quadro cambia. Allora, proprio oggi, di fronte a una crisi devastante, sembra ogni giorno più chiaro come il capitalismo – su scala mondiale – non sia riuscito in positivo a “riformare se stesso”; di qui l’attri -buzione a Marx di una presunta mancanza nell’esame dell’“estensione dell’intervento statale attraverso la regolazione” è del tutto fuori luogo (v. nota 4).
16 Assolutamente in nessun punto degli scritti di Marx – non di quelli di suoi supponenti interpreti – si può rintracciare la considerazione effettuale di un “capitalismo ideale”; questo della “purezza” delle ipotesi è un inveterato vizio dell’economia marginalistica (non a caso spesso chiamata “economia pura”); anzi, nessun economista, prima di Marx, considerò l’economia reale e la concorrenza – lungi dall’essere “postulata” come pura – anche, e soprattutto tendenzialmente, come lotta tra grandi monopoli.
17 L’incomprensione del significato fondante e dei successivi sviluppi dialettici (mutamenti di forma) della teoria del valore (e del plusvalore) da parte di Marx – non in continuità ma in forte critica rispetto agli economisti classici (Smith e Ricardo innanzitutto) – ha occupato disastrosamente gran parte del dibattito in questione, anche tra i sedicenti marxisti; mai Marx, contrariamente a quanto fanno presumere esimi “marxisti”, e lungi dal voler “dimostrare lo sfruttamento” con ciò, ha fatto intendere che i reali prezzi di mercato (e neppure quelli di produzione) coincidessero con i “valori” (forme di valore): la “trasformazione” consiste proprio in questo necessario mutamento di forma.
13

perché esse non sono le vere protagoniste nel suo modello” 18. Consci di tali problemi, anche molti marxisti ammettono che gran parte di Marx sia datato. Avrebbe molto da ripensare, dice il prof. Bowles, specialmente alla luce della “lunga fase di espansione postbellica e dello straordinario miglioramento del livello di vita”19.
Il potere dello stato. Il prof. Heilbroner, anche lui autodefinitosi eclettico, sostiene che “Marx era un convinto democratico, sostenitore degli strati sociali inferiori, ma non delle procedure democratiche. La sua propensione era rivolta a un unico livello socioeconomico della società”. Conseguentemente, Marx trascurava l’importanza di un quadro legislativo. Il prof. Bowles afferma che perciò Marx “non dava peso alla potenzialità dittatoriale dello stato, il che costituiva un grave errore”20.
In generale, tuttavia, le concezioni di Marx conservano ancora un enorme peso e quasi certamente avranno effetti positivi anche nel XXI secolo. Il suo interesse per la massa dei lavoratori e il suo convincimento che il governo debba interessarsi di loro continuerà a riecheggiare nei discorsi economici e politici. Pochi desiderano tornare a un capitalismo sfrenato; perfino i più fervidi liberisti sostengono che sia necessario un intervento pubblico nelle questioni economiche. Il dibattito verte infatti sull’estensione e sulla tipologia di tale intervento. Il prof. Heilbroner sostiene che Marx è e rimarrà “il grande filosofo dell’economia capitalistica”. Nel regno delle idee, prosegue il professore, in Marx “la comprensione del capitalismo equivale a quella di Freud nella psicologia”, e Marx “continuerà a essere una fonte, così come lo è Adam Smith”21.
2000: la lunga ultima crisi irrisolta
Il protrarsi della lunga crisi, e la sua mancata soluzione, ha comportato – almeno nell’ultimo decennio – una profonda modificazione del carattere delle relazioni internazionali, a partire da quelle economiche. Queste ragioni vanno ricercate, pertanto, per qualsiasi analisi economica che abbia senso e concetto, nelle caratteristiche di quell’ultima crisi in corso ormai da più di un trentennio. Dalla metà degli anni 1960 a oggi il tasso medio di sviluppo dell’economia mondiale si è dimezzato (dal 5-6% al 2,5-3%), e la crescita del pil pro capite è passata da un ritmo medio del 2,6% all’1,3%, prefigurando una tendenza verso un drastico arresto dello sviluppo. Si tratta di una crisi – come sempre caratterizzata da un eccesso di sovraproduzione generale di merce, denaro e capitale – venuta a collocarsi epocalmente in coincidenza con l’avvio pratico della seconda grande rivoluzione industriale, quella informatica dell’automazione del controllo, con la fine dell’egemonia economica assoluta Usa, con il conseguente crollo del sistema delle “economie di comando” del realsocialismo, e in sintesi con la presenza del deterrente nucleare che rende per ora impraticabile la strategia bellica generalizzata di distruzione del capitale, in tutte le sue forme, la quale soltanto può fornire la chiave della fuoriuscita dalla crisi stessa.
Gli anni 1990 sono stati, così, caratterizzati da un massiccio processo di centralizzazione dei capitali (fusioni & acquisizioni – m&a in inglese), soprattutto mediante un loro trasferimento nelle attività speculative in tutte le principali borse del mondo. Nel lontano 1840, un banchiere britannico, Leatham, chiamava col nome di fiction l’emissione di quei titoli che oggi sono i cosiddetti “derivati”, croce e delizia della “nuova economia” e delle scommesse sui “titoli tecnologici”. Appunto così, mediante l’emissione di “puri e semplici mezzi di circolazione”, si crea il cosiddetto capitale fittizio (che include anche i titoli del debito pubblico). Il concetto e la parola stessa “speculazione” significano proprio questo: che la quotazione dei titoli non è determinata dal provento “reale” dell’attività che essi rappresentano ma, appunto, da una valutazione “speculativa” – ossia, dalla capacità di indagare e far congetture – sul provento atteso e previsto in “anticipo”.
Nell’ultima grande ondata di “fusioni e acquisizioni” che sta attraversando il mercato mondiale, perciò, a cambiare sono soprattutto e anzitutto gli assetti di proprietà, attraverso cui il capitale finanziario propriamente detto esercita concretamente le forme di controllo sulle imprese che riesce ad acquisire. Proprio analizzando la centralizzazione, già Marx [cfr. Il capitale, I.23] osservava che “ciò che perde l’uno, guadagna l’altro”. Il capitale è giunto a uno dei suoi massimi livelli di “schizofrenia”; mentre alcune imprese credono
18 È vero assolutamente il contrario. Parlando delle tendenze storiche del capitale, Marx nel terzo libro del Capitale, a proposito della funzione trasformatrice del credito, ha anticipato in maniera netta e mirabile il ruolo futuro delle società per azioni (quindi della proprietà privata collettiva e non più individuale e personale), fino alla “soppressione del modo di produzione capitalistico nell’ambito dello stesso modo di produzione capitalistico, quindi una contraddizione che si distrugge da se stessa”, in quanto “produ -zione privata senza il controllo della proprietà privata”.
19 Rimarrebbe da decidere se un simile “ripensamento” dovesse occorrere anche “alla luce della lunga fase” di crisi attuale, in cui il livello di vita mondiale non è certo “straordinariamente” migliorato (v. nota 15).
20 Che Marx non trascurasse il quadro legislativo è evidente a una semplice lettura dei suoi scritti (tra l’altro aveva fatto studi di giurisprudenza e di filosofia del diritto); solo che aveva una concezione non esteriore della democrazia e del potere, ben diversa da quella dominante, in quanto la sua è basata sui rapporti di proprietà e di classe.
21 Quindi, nonostante tutte le limitazioni relative alla lettura di Marx date dal Wsj, qui messe in risalto, rimane la basilare importanza del fatto che perfino quel giornale, portavoce del massimo centro finanziario mondiale, afferma che le “concezioni di Marx conservano un enorme peso anche nel XXI secolo”.
14

di accumulare, per altre il galoppare della crisi è palese, sì che i capitali esistenti non possono rinnovarsi come tali – come capitale, cioè – nelle stesse mani. Le masse di capitale, così accresciute mediante la centralizzazione, si riproducono e aumentano più rapidamente delle altre, senza tuttavia che cresca in assoluto il capitale in funzione, produttivo o monetario.
A essere interessati dagli sconvolgimenti proprietari sono i gruppi capitalistici di tutto il pianeta, in una ristrutturazione che ridefinisce anche la vecchia composizione della classe lavoratrice non meno e anzi proprio a causa dei rivolgimenti interni alla classe proprietaria. La crisi, dunque, è crisi del mercato mondiale. In un periodo di crisi mondiale gli investimenti diretti esteri, meglio noti come ide, crescono meno degli investimenti di portafoglio, gestiti dai cosiddetti investitori istituzionali (le grandi società di intermediazione finanziaria, banche d’affari, fondi pensione e di investimento, che si affiancano alle banche di credito ordinario, imponendo a queste ultime la trasformazione giuridica in banche universali o “alla tedesca”) le cui strategie vengono orientate dagli organismi sovranazionali all’uopo preposti, particolarmente Fondo monetario internazionale e Banca mondiale.
Il capitalismo mondiale ha ormai a tal punto assunto la forma transnazionale come dominante, che la vecchia concezione dell’imperialismo britannico è grandemente mutata. La teoria “classica” dell’imperiali -smo fu formulata per primo, guardando al suo paese, dal liberale inglese John Atkinson Hobson; ma le sue considerazioni sulla Gran Bretagna sono emblematiche e rappresentative anche per l’oggi, in quanto riferibili a tutti gli stati dominanti. È significativo che lo stesso Hobson [di cui perciò sono riportate nella seguente introduzione, proprio in questa chiave, le sue analisi sulle “radici economiche dell’imperialismo”] prenda in considerazione esplicita, oltre alla Gran Bretagna, la Germania e la Francia, e soprattutto anche gli Stati uniti d’America e il Giappone: le stesse prime cinque potenze del mondo attuale (almeno finora).
Nikolaj Bukharin [cfr. L’economia del periodo di trasformazione] cominciava ad analizzare compiutamente l’imperialismo “classico” agli inizi del XX secolo (sulla scia del suo precursore Hobson). “Il capitalismo moderno – scriveva – è un capitalismo mondiale. Questo significa che i rapporti di produzione capitalistici dominano nel mondo intero, e tutte le parti del nostro pianeta sono legate fra loro da un solido vincolo economico. L’economia mondiale è un’unità reale esistente con legàmi anche tra imprenditori di differenti "paesi"”, pur se contrapposti alla maniera in cui questi “paesi” sono collegati tra loro. Ma si tratta di “parti del lavoro sociale ripartito su scala mondiale, che si completano reciprocamente sul piano economico. La connessione e interdipendenza generale dei singoli stati capitalistici tra loro li rende parti integranti di un sistema generale, mondiale”. Ciò avveniva, e avviene tuttora, attraverso accordi tra grandi gruppi monopolistici, finanziamento e penetrazione del capitale bancario nell’industria, controllo dei pacchetti azionari, partecipazione, ecc., e con la presenza dei medesimi “dirigenti” in banche e industrie.
Il capitale che comincia a operare in una data forma, in una o più regioni del mondo, se è adeguato alla fase transnazionale dell’imperialismo, è pronto a trasformarsi secondo le esigenze di codesta fase. Nel disperato tentativo di contrastare e porre un freno all’irrazionalità della crisi capitalistica sul mercato mondiale, già all’inizio del secolo XX, cominciava a stabilirsi il cosiddetto “controllo a catena”, messo in atto per definire la gerarchia del dominio: capitale monopolistico finanziario - grande capitale - piccolo capitale – azionisti. Scrive Giulio Pietranera [nell’Introduzione al Capitale finanziario di Rudolph Hilferding, in Il capitalismo monopolistico finanziario, la Città del Sole, Napoli 1998] che “con il sistema delle "società a catena", il capitalista viene, per così dire, fagocitato da un’impresa all’altra e pertanto "forzato" sia nella sua destinazione che nella concreta utilizzazione del suo capitale”.
Certamente, non è che sia cambiata la modalità capitalistica dell’operare del sistema, ma il suo funzionamento si è adeguato alla moderna forma dell’intero mercato mondiale dei capitali. Esso è una precisa realtà almeno dalla fine del secolo scorso, dopo la prima lunga “grande crisi” mondiale iniziata nel 1870, con la trasformazione del capitalismo concorrenziale nell’imperialismo del capitale monopolistico finanziario. Utilizzando la categoria di imperialismo, unitamente a quella di mercato mondiale, sopra entrambe le quali sta il concetto di modo di produzione capitalistico, non c’è alcun bisogno di termini e riferimenti ideologici quali “globalizzazione” et similia. Questa – e nient’altro – è la “mondializzazione” dell’imperialismo del capitale, con tutto ciò che segue in termini di circolazione ecc.
Delle mode attuali intorno a “globalizzazione”, “nuova economia” (con tanto di moneta e commercio elettronici), precedute di poco da “geopolitica”, “neoliberismo”, “finanziarizzazione”, “postfordismo” e via indebolendo il pensiero informatizzato, rimane soltanto ciò che esse hanno di accidentale, triviale, estrinseco e passeggero. Con le categorie empiriche del tipo “globalizzazione” o simili, infatti, si trasferisce in una dimensione territoriale senza gerarchia, geografica naturale e astorica, un concetto che viceversa si è sviluppato storicamente in termini di relazionalità sociale, di dinamica dei modi di produzione e di rapporti di proprietà, obliterandone così proprio la determinazione contraddittoria di processo la cui stessa potenzialità è innervata sull’antiteticità e conflittualità di classe. Ed è precisamente ciò che l’ideologia dominante – l’ideologia della classe dominante – si prefigge.
15

Per un coordinamento strategico diventa perciò della massima importanza il grado di integrazione degli anelli nella catena dell’impresa centrale, così come il prolungamento del rapporto a industrie collegate verticalmente e l’estensione geografica della catena esterna nella totalità del mercato mondiale (solo a titolo di esempio, forse la prima concatenazione strategica dell’imperialismo – per filiere si direbbe oggi – si deve a quello che può essere considerato l’archetipo di catena dei cicli produttivi: il complesso militare-industriale, così chiamato dagli esperti del Pentagono e della Casa bianca dei tempi di Eisenhower). L’importanza da attribuire alla strategia finanziaria di simili concatenazioni planetarie affluisce negli organismi direttivi delle holding. Ormai il grande capitale agisce trasversalmente sull’intero mercato mondiale, per filiere appunto, sia di tipo produttivo, sia particolarmente di carattere finanziario (cosa che è più rilevante della prima, ancorché meno o per niente considerata). Ma basti pensare alla struttura delle holding – finanziarie, appunto – capogruppo di grossi complessi industriali, monetari (anche a carattere speculativo), creditizi, assicurativi, commerciali, ecc., per capire dove e come vengano prese le decisioni strategiche.
Si assiste così a fenomeni quali i cosiddetti “snellimento” o “dimagrimento” dell’impresa (downsizing), “esternalizzazione” di funzioni precedentemente svolte all’interno dell’impresa (outsourcing), “corridoi” (euroasiatici e altro), “vantaggio competitivo” (come direbbe Porter), oltre a centralizzazione e trasformazione degli assetti proprietari internazionali, con rovesciamento del ruolo tra organismi sovrastatuali e stati nazionali, privatizzazioni se reputate efficaci, ecc. le quali riconducono tutta la dinamica al fenomeno della subfornitura – per usare un solo termine a fianco di “filiere”.
Il senso dell’estensione massima del concetto di concatenazione – complesso, catena, filiera, ecc. – sta dunque nel considerarne la forma finanziaria (quindi non meramente “monetaria”), la quale strategicamente e correttamente è intesa come “fusione” di industria e banca, produzione e circolazione di capitale, merce e denaro, il che corrisponde teoricamente al ciclo di metamorfosi delle tre forme di funzione del capitale (denaro, produttivo e merce). Si investe di meno in capitale fisso nei paesi dominanti, ma ovunque si investa, in qualsiasi forma reale o monetaria, ciò che conta è la logica strategica delle scelte di investimento, la catena di operazioni che si apre o si chiude, in un processo in cui non sempre è agevole scorgere gli anelli, i legàmi sotterranei.
La connotazione transnazionale dell’imperialismo contemporaneo supera dialetticamente la precedente caratterizzazione multinazionale, che permane come base funzionale del capitale monopolistico finanziario operante nel mercato mondiale. Ormai non è più soltanto il capitale proveniente o riferentesi a una particolare base nazionale (storicamente, in misura preponderante, dopo la seconda guerra mondiale imperialistica, gli Usa) che viene investito, opera e preleva profitti in territori di “molte nazioni” straniere; la forma transnazionale del capitale monopolistico finanziario comincia ad abbattere tutti i confini geografici dei vecchi stati nazionali storici. Si può perciò dire che il ruolo della statualità nazionale sia conservato ma superato (l’aufhebung hegeliano) al tempo stesso.
È come un gioco di “scatole cinesi”, ma in una specie di quarta dimensione, dove si perda la misura fisica dell’interno che è più grande dell’involucro che sta fuori, poiché quest’ultimo tendenzialmente può essere maggiormente rilevante pur essendo ancora provvisoriamente più piccolo. L’esportazione di capitali anziché merci è il tratto caratteristico della fase imperialistica del capitalismo, già alla fine del XIX secolo, ancorché la seconda forma, relativa al movimento di merci fosse allora, e forse lo è ancora, quella quantitativamente prevalente rispetto al flusso dei capitali. E così pure accade, perciò, oltre che per lo stato nazionale, anche per le forme tradizionali della concorrenza tra capitali, per la produzione media e piccola, per quella artigianale, per le conduzioni familiari, ecc., che continuano a sussistere, benché dominate e residuali.
A maggior ragione le figure nazionali e multinazionali, racchiuse in “poli” imperialistici confliggenti tra loro, non decadono, ma nel loro estrinsecarsi sono completamente ridefinite dalla trasversalità transnazionale dominante. Pur permanendo cionondimeno una “base nazionale” di elezione, ogni grande capitale finanziario centralizzato è, da un lato, il coacervo della partecipazione (per fusioni, acquisizioni o accordi di altro genere) di capitali operanti provenienti da diverse nazioni, e, dall’altro, il risultato, come si è accennato, di una concatenazione di strategie finanziarie e di produzioni in filiera che passano indifferentemente “attraverso nazioni” diversissime.
In effetti, il tentativo di far coincidere la funzionalità di un’area capitalistica mondiale (anche sotto la specie di “area valutaria”, come si preciserà tra poco) con la sua estensione territoriale geografica – il dollaro con gli Usa, l’euro con l’Ue, ecc. – è banale. La forma pratica della territorialità è, come tale, ineliminabile, ma la funzione imperialistica del capitale, che si esprime attraverso l’egemonia della valuta cui far riferimento, si estende ben al di là (o si restringe al di qua) dei confini geografici, concettualmente spuri. È precisamente attraverso la capacità funzionale di imporre codesta egemonia che nell’imperialismo moderno del mercato mondiale si gioca la superiorità transnazionale di un capitale su un altro, avvalendosi trasversalmente delle istituzioni a proprio servizio. Il reale grande problema dell’imperialismo transnazionale – al di fuori della sua ingannevole territorialità, ed essenzialmente in quanto capitale – consiste, però,
16

proprio nel non riuscire a stringersi in un polo unico. La contraddizione intrinseca al capitale stesso è proprio quella di non poter ridurre all’uno il molteplice. Perciò, per il capitale e per quanti lo studiano, guardare alla sua trasversalità entro le diverse aree aiuta a capire come la conflittualità tra i suoi molteplici elementi – con quella delle “catene” di produzione e valorizzazione da essi poste in essere – non appaia pertanto solo e fondamentalmente nella dimensione territoriale nazionale.
Lo scontro interimperialistico – per la sua stessa definizione transnazionale – non può limitarsi, perciò, al confronto diretto tra i tre “poli” dominanti (Usa-America, Germania-Europa, Giappone-Asia). Il loro raggio d’azione attraversa dunque l’intero mercato mondiale, provocando sempre più spesso situazioni di collisione indiretta tra catene trasversali ai poli stessi, per definire la nuova divisione internazionale del lavoro, proprio perché gli anelli (orizzontali e verticali) di siffatte catene attraversano gerarchicamente diversi paesi, e con molte sovrapposizioni territoriali e di interessi; è ovvio che la stessa conflittualità imperialistica sia trasversale ai paesi coinvolti. Gli stati nazionali di tipo dominante, ora, sono condizionati dalla circostanza che nella loro lotta devono seguire gli interessi di tutti i capitali capofila, sia di quelli a base nazionale interna, anche se operanti altrove nel mercato mondiale, sia di quelli a base estera di stanza sui rispettivi territori.
I principali vantaggi di tali strategie e procedure – traducibili in ultima analisi in termini di minori costi e quindi di maggiore penetrazione nei mercati – sono ottenuti con una ristrutturazione che è facilitata al massimo grado dall’aumento della scala di produzione; ciò conferma la ricordata tendenza all’enorme processo di centralizzazione nei grandi gruppi transnazionali posti al vertice di quella piramide di subfornitori via via più piccoli, fino al lavoro a domicilio, così collocati in rigida subordinazione gerarchica. Una simile ridefinizione della struttura dei cicli produttivi sull’intero mercato mondiale si impone, dunque, come fondamento della nuova divisione internazionale del lavoro, tanto dal punto di vista materiale tecnico quanto da quello sociale proprietario, che si mettono in opera anche riorganizzando il processo lavorativo con lavoro multifunzionale.
La socializzazione del lavoro, dunque, è oggi nascosta dentro cicli produttivi, bensì inanellati in lunghe catene, ma sottratti perfino alla percezione immediata e alla pratica dei produttori medesimi. Dal punto di vista della classe lavoratrice, e della sua componente salariata e operaia in particolare, diventa peculiare l’evidenziazione teorica e l’amplificazione pratica delle contraddizioni del modo di produzione capitalistico: non solo quelle tra capitale e lavoro salariato prese a sé stanti, ma anche quelle interne al capitale medesimo e immanenti a esso, quale condizione necessaria per lo scoppio delle prime. Ma se queste ultime troppo frequentemente sfuggono alla coscienza della classe lavoratrice, neppure le prime pervengono alla sua conoscenza.
La nuova organizzazione imperialistica del lavoro si esprime, di conseguenza, nella forma della nuova doppia flessibilità di lavoro e macchine, completata nella flessibilità del salario. La sintesi dell’intero processo, in tutte le sue tre componenti indicate, è una maggiore quantità di pluslavoro non pagato. Su tali basi anche le forme del salario si sono potute adeguare alle esigenze moderne della produzione di plusvalore. Il cottimo è la forma di salario che, in genere, corrisponde meglio al concetto di capitale industriale, coartando il lavoratore all’autocontrollo dello sfruttamento, ormai con una tendenza all’equiparazione internazionale. Ciò che l’ideologia dominante chiama “partecipazione” è in realtà coercizione al consenso, il che corrisponde alla scomposizione dei cicli produttivi su scala mondiale.
Un breve corollario istituzionale può meglio chiarire la fase. La verifica della stretta connessione politica tra potere economico e forme statuali si ha nel relativo “omomorfismo” tra le tipologie organizzative delle imprese e degli apparati pubblici. La comune matrice è data, appunto, dai rapporti di proprietà, quella relazionalità di classe della società che passa dal capitale allo stato. Le forme del primo “informano” di sé le seconde, adeguandone il funzionamento amministrativo giuridico alle mutevoli esigenze della proprietà privata delle condizioni della produzione. Come si va dalla manifattura alla concorrenza, dal monopolio alla società per azioni, da trust e cartelli alla holding finanziaria fino alla sua scala transnazionale, con tanto di filiera produttiva e strutturazione a rete, così si possono leggere le forme istituzionali mutuate appunto dalla ricordata organizzazione del grande capitale monopolistico finanziario transnazionale.
In altri termini, gli elementi di comparazione si rappresentano via via nella separatezza individuale e localistica all’atomismo concorrenziale, nella forma assembleare dell’azionariato, con potere di minoranza carpito con regole maggioritarie da parte dei consigli d’amministrazione, nella generalizzazione transnazionale di tali forme amministrative in holding finanziarie, che si esprimono sempre più con l’autocrazia monocratica e con l’operatività decisionistica di presidente o amministratore delegato, nella cui logica rientra anche il formale decentramento, operativo ma non strategico, ecc. Si pensi, dunque, al succedersi di parlamentarismo assolutistico e costituzionale, suffragio universale, decisionismo dell’esecutivo, presidenzialismo, e perfino al “federalismo” nella sua duplicità di accentramento forte accompagnato da decentramento diffuso.
17

La tematica delle aree valutarie – nell’ambito della fase transnazionale dell’economia mondiale – illustra nel miglior modo la rilevanza che le monete stesse di riferimento hanno trasversalmente a stati e territori. Le “aree valutarie” infatti – pur muovendo da una sede fisica ben individuabile, e tutt’altro che “deterritorializzata”, alla quale corrisponde necessariamente la strategia politica economica di egemonia sul mondo – attraversano l’intero mercato mondiale. Così, attualmente, una grande impresa transnazionale la quale, magari dopo una fusione, operi contemporaneamente nei tre “continenti” imperialistici, può ancora decidere su quale valuta fare aggio.
La “catena del valore” – o in qual altro modo la si voglia chiamare – costituisce perciò lo strumento di base per l’analisi dei costi di un’impresa, gruppo o holding, quanto più essa operi con una forma di disseminazione diffusa del proprio ciclo di produzione. Attraverso un simile strumento ci si pone nella condizione di individuare nel dettaglio quali elementi di costo siano espressi in una valuta o nell’altra e in particolare quale sia la valuta principale (dollaro o euro, soprattutto, mai moneta locale) in cui si possano presentare in divenire anche i prezzi di vendita. Tale struttura è in grado di individuare l’andamento di tutte le determinanti di costo – costi di produzione soprattutto, ma anche, in subordine, costi di circolazione – delle varie catene, o cordate delle filiere, nelle diverse aree valutarie, piuttosto che nelle zone o sfere di influenza dei contrapposti poli; ciò include l’effetto valutario di riferimento nelle fatturazioni.
È perciò particolarmente importante se i costi siano pagati in valute locali meno pregiate, rispetto ai prezzi finali di vendita, ancora prevalentemente fatturati in dollari, per cui la differenza che sorge dall’incidenza delle diverse aree valutarie si trasforma in maggiori (o minori) profitti. La capacità d’influenza transnazionale di ogni moneta (dollaro in testa) è dunque legata al controllo delle aree valutarie di riferimento. Come si fa a trasferire la ricchezza prodotta altrove? Pagando i costi di produzione a livelli più bassi, a esempio nelle valute locali, e vendendo a prezzi più alti (la qual cosa, del resto, è regolarmente avvenuta nella storia del capitalismo). È lo strumento monetario – gestione di massa monetaria, tasso d’interesse e tasso di cambio, da parte delle banche centrali e dei governi (sovra)nazionali – che è capace di influire su qualsiasi capitale che debba operare con costi, prezzi, debiti, imposte, ecc. denominati nella valuta specifica gestita “nazionalmente” da quella o da quell’altra amministrazione bancaria centrale o governativa. Questo è il significato di aree valutarie. Un recente documento del Fmi affronta assai bene il problema delle aree valutarie. Naturalmente, il Fmi non lega affatto la dinamica delle crisi con gli interventi dello stesso Fmi e della Bm e con le scelte strategiche di politica economica degli Usa. Tuttavia, la descrizione della perdurate ancorché contraddittoria dominanza del dollaro – quale valuta di riferimento nel mercato dei capitali, non solo in quello delle merci, in forma relativamente indipendente dalla base di provenienza del capitale che lo impiega – è assolutamente attendibile.
Ma proprio per quella contraddizione, il Fmi stesso (nel 2000) si è limitato a osservare come gli Usa finanzino il loro disavanzo corrente prendendo a prestito dal resto del mondo “quasi esclusivamente in dollari; la maggior parte dei capitali che affluiscono negli Usa sono costituiti da ide e da investimenti di portafoglio; ma anche più del 90% del debito estero verso le banche è in dollari, il che si riflette in un’accumulazione di patrimonio Usa nelle mani di investitori internazionali”. E ciò può proseguire finché gli Usa riescano “sostenere un disavanzo commerciale molto maggiore di quanto sia possibile per qualunque altro paese, le cui obbligazioni (prevalentemente a breve termine, non solo bancarie) siano denominate in valuta straniera”, ossia, per la maggior parte di essi, in dollari, e continuino a garantire agli investitori, indipendentemente dalla loro nazionalità di appartenenza, alti rendimenti coperti dal rischio. Qualsiasi possibile intervento sul corso dei cambi, da parte delle banche centrali dei paesi dominati, viene così vanificato.
Perciò la determinazione di aree valutarie di riferimento supera in importanza la mera collocazione storica geografica dell’investimento; lo sviluppo preferenziale di alcune anziché altre piazze finanziarie trae da qui una spiegazione possibile. Attualmente la cosiddetta “dollarizzazione” Usa è intrinsecamente contraddittoria, proprio perché avviene in una fase di crisi, anziché in quella fase di crescita che fu dovuta alla lunga ricostruzione postbellica. Il possibile dilemma su quale riferimento monetario mondiale fosse da scegliere non sussisteva neppure nell’epoca del secondo dopoguerra, con il dollaro come unica valuta riconosciuta per i pagamenti internazionali, e quindi con tutte le monete “ancorate” al dollaro stesso (dollar standard e gold exchange standard basato sulla convertibilità della moneta Usa).
Oggi, invece, la “dollarizzazione” (o vari criteri di currency board), cui si conforma gran parte dell’eco-nomia mondiale, è diventata un preciso obiettivo che l’imperialismo Usa vuole perseguire. Quindi il tentativo di imposizione transnazionale del dollaro come valuta privilegiata, se non unica, per alcune transazioni, cerca di agevolare l’accumulazione di capitale, proprio perché – in un mercato “mondializzato” – essa non è nazionale (pur avendo “base” Usa centralizzata) ma transnazionale. In tali circostanze ora mutate, alla multi-nazionalità dell’operatività del capitale, tipica della fase, relativamente breve ma molto stabile, del ventennio Usa del secondo dopoguerra, è subentrata la trans-nazionalità delle basi stesse di provenienza della
18

partecipazione agli investimenti, caratteristica sempre più straripante dell’affiancamento di altri poli imperialistici all’egemonia Usa in evidente contraddizione.
Il dominio valutario, pertanto in conformità al concetto mondiale di capitale, torna a essere gerarchicamente superiore in rango rispetto alla semplice base di provenienza nazionale di ciascun capitale stesso. Dopo la crisi della fine degli anni 1960 – con l’invalidazione degli accordi di Bretton Woods – proprio la flessibilità dei cambi, dipendente inevitabilmente dall’instabilità del dominio mondiale e della corrispondente divisione internazionale del lavoro, è stata il sintomo che ha evidenziato lo spiazzamento dell’intero sistema di potere economico, col rispettivo sistema valutario. È dopo il 1970 che, palesatasi la crisi, la storia è cambiata: fin da allora – non dopo l’11 settembre 2001 – si sarebbe dovuto dire “nulla sarà più come prima”! Il fatto che dopo più di trent’anni la strategia Usa sia stata consolidata dall’accettazione dell’economia cinese nell’Omc, non toglie che quella strategia debba ancora fare i conti con l’euro come nuova possibile valuta di riferimento, dato che per ora i dirigenti cinesi sembrano non disdegnare quest’ultima contro il dollaro. Ciò che potrà succedere dopo è tutto da scoprire.
La prospettiva, in conclusione, è assai più complessa, drammatica e conflittuale: si gioca l’intera prevalenza sul mercato mondiale, soprattutto attraverso i poli imperialistici e conseguentemente anche tra di essi, di cui la contesa tra area del dollaro e area dell’euro è oggi la massima espressione. Se perciò la compresenza di stati nazionali, formalmente sovrani, permane, a seconda del grado di dipendenza dei singoli stati da quelli dominanti, tale forma si dilegua. Da un lato, si sviluppa così la loro “sovranità limitata”, la quale parallelamente, dal lato opposto, è provocata dall’egemonia sempre più marcata del nòcciolo dei paesi imperialisti, fino alla sostanziale negazione della loro indipendenza statuale.
Del resto l’economia reale, su cui si basano tutti gli aspetti monetari e fittizi, altro non è se non la spasmodica e violenta ricerca di pieno controllo del mercato mondiale da parte dell’imperialismo. Gli Usa in testa – imitati dall’Ue – stanno cercando di individuare le aree di investimento più proficue per estendere l’area valutaria del dollaro oltre i confini puramente geografici dello stato. Perfino il governatore della Fed si è mostrato ogni giorno più preoccupato della situazione di crisi (necessariamente monetaria, nella sua apparenza iniziale). Il decentramento produttivo connesso al processo di ristrutturazione e di centralizzazione ha così rappresentato la mossa iniziale – reale, non monetaria fittizia – inevitabile e indispensabile, ma ciò non è bastato per venire a capo della crisi.
Secondo dati Unctad, nel 2000 gli ide avevano raggiunto i 1.300 mrd $ (con una crescita del 18% in un anno), ma già con una prospettiva di riduzione del 40% nel 2001, a causa dello spostamento sulle attività di m&a quasi raddoppiate: tutto ciò secondo la previsione fatta prima dell’11 settembre! Si sosteneva che l’e-spansione degli ide costituisce “la principale forza di integrazione internazionale” – ... e perciò stesso anche di crisi (ma questa circostanza non è conosciuta, e neppure asserita). Circa 63 mila imprese transnazionali controllano più di 800 mila imprese affiliate, e gestiscono più di due terzi del “commercio” mondiale. Ma i primi 30 paesi di destinazione ricevono più del 95% degli ide, mentre i primi 30 paesi imperialisti emettono praticamente il 99% degli ide in uscita (ossia una forte concentrazione verso l’alto). Sono infatti, data la concentrazione, gli stessi paesi imperialisti che contano direttamente per i ¾ degli ide anche in entrata. Usa, Ue e Giappone hanno avuto, nel 2000, ide in entrata per oltre il 70%, e in uscita per più dell’80% (soprattutto per incroci di m&a).
Non è banale ricordare che ciascuna delle tre principali “zone” imperialistiche (anche se angustamente considerate sulla loro semplice base territoriale) già una decina di anni fa dipendeva dalle altre due, in misura più o meno crescente secondo il proprio rango: gli Usa per circa il 50%, l’Europa il 60% e il Giappone il 70%. Siccome nel 2001 gli ide sono stati soppiantati da m&a, a seguito dello stato di crisi, anche questo dimezzamento (pari a circa mille mrd $) ha avuto effetto immediato quasi solo sui paesi imperialisti: ma data la ricordata dipendenza, anche quantitativa, dei paesi dominati, sia attraverso le imprese affiliate sia per le attività speculative, la diffusione della crisi stessa a macchia d’olio è stata ovvia conseguenza Nella misura in cui i vincoli territoriali non si addicono al capitale, che per sua destinazione è mondiale, oggi la qualità dominante su tutte le altre ancora presenti è la diffusione degli investimenti di capitale nell’intero mercato mondiale.
Lo scontro tra capitali imperialistici, anche tra differenti cordate all’interno di ogni filiera, continua perciò senza tregua. E si potrebbe anche dire “senza quartiere”, perché letteralmente, volendo significare senza un luogo fisico di lotta di concorrenza, preciso e prefissato, ciò è caratterizzato appunto dalla trasversalità. Epperò quello stesso scontro non fa che aggravare le contraddizioni, le crisi e le forme di lotta, che mutano in tale maniera l’espressione e la tipologia delle manifestazioni fenomeniche che codesta forma essenzialmente accompagnano. Perciò si è detto come esso non possa apparire quale scontro diretto tra stati (o superstati o “poli”) e debba conseguentemente essere espletato “fuori casa”. Di qui il mutato ruolo qualitativo delle forme statuali nell’epoca dell’imperialismo transnazionale e il manifestarsi delle stesse contraddizioni intercapitalistiche.
19

Anche la guerra interimperialistica – quella combattuta militarmente con le armi – avviene oggi surrettiziamente tra alleati, sotto forma di aggressione a uno o l’altro paese dominato – “per interposta persona” – per così dire. La prima guerra del golfo, a es., serviva a mettere in ginocchio il Giappone, quella nei Balcani l’Europa, ecc. (non potendo ancora, letteralmente, parlare di “terrorismo”, che appunto è ineffabile). La direttrice Balcani-Caucaso ha rappresentato, per la strategia Usa, il punto di penetrazione euro-asiatico, attraverso la vecchia e nuova “via della seta” – oggi “corridoio 8” – che porta allo snodo di Pechino, attraverso l’Afghanistan. La seconda guerra del golfo, scontando la prevista trappola irakena, serviva soprattutto per bloccare l’avanzamento dell’euro. Il controllo militare, a questo punto, è necessario. I corridoi, dai Balcani al Pacifico, possono tenere d’occhio tutto il medioriente (attraverso telecomunicazioni, strade, aeroporti, infrastrutture bancarie, ecc.) per spianare la strada alla penetrazione del capitale imperialistico tutto.
2010: le contraddizioni del capitale-merce
Non è che la produzione capitalistica di merce abbia mostrato solo in quest’ultimo anno le contraddizioni che caratterizzano l’economia capitalistica. Anzi, esse esistono fin dall’affermazione di questo sistema. Ma gli eventi del 2010 l’hanno evidenziata, con la manifestazione più evidente di una crisi “cartacea” speculativa che pur perdura in termini reali da oltre quaranta anni: averla ignorata o sottovalutata per decenni ha messo in luce la mancanza di coerenza e il crogiolarsi nell’ignoranza delle cose reali da parte di tanti falsi eruditi. In ultima analisi, ciò sottolinea al contrario l’importanza di soppesare compiutamente le contraddizioni reali della merce capitalistica.
La domanda a fini di consumo generata soltanto dai lavoratori, infatti, non può mai, da sola, fornire un motivo all’accumulazione e all’impiego del capitale, tali da aumentare costantemente il valore di scambio dell’intera massa. Ciò vuol dire che le forze produttive vengono messe in moto soltanto da una produzione illimitata, con una continua creazione di nuove attività di produzione, allargamento delle vecchie, attraverso la quale le vecchie conquistano nuovi mercati, ecc. Il movimento del capitale è punto di partenza e di arrivo: ciò che in realtà include anche il consumo, poiché la merce prodotta dev’essere venduta, ma per il movimento del capitale singolo è indifferente che cosa diventi in séguito questa merce. Invece le condizioni della riproduzione sociale sono riconoscibili appunto dal fatto che dev’essere dimostrato che cosa diventa ogni parte di valore di questo prodotto complessivo.
L’assurda manipolazione del “senso comune” sul ruolo del consumo messa in atto dal potere borghese si basa direttamente sulla “percezione sensibile” del fenomeno. La controversa funzione del consumo finale è stata pesantemente falsata dall’ideologia borghese e dall’ignoranza da essa seminata; ma la pervasività degli stereotipi borghesi sembra avere un’incidenza incrollabile anche tra le masse della sedicente sinistra. Si sa che la causa ultima di tutte le crisi effettive è sempre la povertà e la limitazione di consumo delle masse, in contrasto con la tendenza della produzione capitalistica a sviluppare le forze produttive che pone come unico suo limite la capacità assoluta di consumi della società. Ma va osservato che il processo reale viene oscurato sia dal capitale commerciale (ossia dal denaro, poiché il commerciante non fabbrica niente) e direttamente dal capitale monetario, che manipola il processo di circolazione del capitale industriale. Poi avviene la divisione del plusvalore, in mano al capitalista industriale, tra proprietario fondiario (rendita), usuraio e banche (interesse), governo e suoi impiegati, rentiers, ecc. Questi signori compaiono di fronte al capitalista industriale come compratori e, in quanto tali, come monetizzatori delle sue merci, dimenticando da quale fonte essi ricevano il denaro.
Va sottolineata anzitutto una primissima distinzione marxiana assolutamente dirimente. Il salario nelle mani del lavoratore non è più salario, bensì fondo di consumo destinato all’acquisto di mezzi di sussistenza. Solo nelle mani del capitalista esso è salario, vale a dire la parte del capitale che è destinata ad essere scambiata con la forza-lavoro. Per il capitalista, il lavoratore ha riprodotto una forza-lavoro vendibile, sicché in questo senso lo stesso consumo del lavoratore avviene in funzione del capitalista. Questa parte del tempo di lavoro si trasforma in tempo di lavoro per il capitalista. Pertanto si dovrà centrare tutta la critica sul consumo rispetto al diverso ruolo che esso assume, secondo da chi e come è fatto secondo i l funzionamento specifico del modo di produzione capitalistico.
Il consumo sans phrase da un lato e la speculazione dall’altro diventano i due “mostri sacri” che il sistema adora per supporre di uscire dalla crisi. E gli “esperti” del potere non fanno che seguire queste fantasie, supponendole vere. Così praticamente tutta la stolta fraseologia dominante fa “credere” che entrambe queste azioni – il consumo in primo luogo, che è quello che qui più interessa specificamente – possano far ripartire l’economia (per dove?), e pertanto essa pompa su consumatori e cosiddetti “risparmiatori”. Ed è allora che, quando ci si accorge che le masse (in tutto il mondo) non hanno sufficiente denaro da trasformare in merci, allora i sicofanti del potere, più o meno occulto, “scoprono” che chi ha più
20

denaro, poco o molto, può arricchirsi utilizzandolo per la speculazione: che è ritenuta altrettanto valida, e senza limiti (come i miracoli della nuova economia), del consumo. Infatti! sono due buchi nell’acqua, ma per gli spenditori le perdite sono reali.
Considerare che un capitalista fornisca a un altro merce-capitale per accumulazione – altrimenti con consumo individuale non ci sarebbe alcuna riproduzione – è basilare per capire significato e ruolo del consumo sotto il predominio del capitale. Il modo di produzione capitalistico presuppone produzione e vendita su vasta scala; perciò si rivolge non al consumatore finale individuale, ma al consumatore produttivo, cioè al capitalista industriale (e quindi anche al lavoratore salariato che lo integra). È il capitale industriale di un settore della produzione che fornisce a un altro settore mezzi di produzione per la forza-lavoro. E ciò avviene solo mediante una domanda pagante da capitale a capitale. Del resto, il sistema capitalistico non conosce altre specie di consumo all’infuori del consumo pagante. Allorché, come moneta, il denaro serva per la spesa del reddito – cioè per lo scambio tra i consumatori individuali e tutti i commercianti che vendono ai consumatori individuali (distinti dai produttori) – è tutt’altra faccenda dal trasferimento di capitale. La differenza è dunque in realtà tra forma monetaria del reddito e forma monetaria del capitale e non tra circolazione e capitale. Il fatto che gli “economisti” confondano due cose così diverse non è motivo sufficiente per presentarle come distinzioni concettuali.
Ma – e qui ritorna il punto centrale – la domanda creata dai lavoratori non può mai essere una domanda adeguata, perché contiene una contraddizione che non può estendersi a tutta la produzione. Infatti – come caso limite – se così fosse non ci sarebbe alcun profitto e conseguentemente non ci sarebbe motivo di occupare i lavoratori. È proprio l’esistenza di un profitto su una merce che presuppone una domanda esterna a quella dei lavoratori. A eccezione dei suoi propri lavoratori per ciascun capitalista la massa complessiva di tutti gli altri lavoratori non è una massa di lavoratori, ma una massa di consumatori; ed è per questo che egli desidera restringere il più possibile il consumo dei “suoi” lavoratori, il loro salario, poiché per lui codesto salario costituisce un costo, una spesa e cioè una perdita. Il rapporto tra un capitalista e i lavoratori degli altri capitalisti rivela soltanto l’illusione – reale per lui – di ciascun capitalista, ma non modifica per nulla il rapporto generale tra capitale e lavoro salariato.
La contraddizione è appunto questa: per l’intera classe dei capitalisti ogni aumento salariale non conta come maggior spesa per consumo ma come maggior costo (di capitale variabile), come perdita della classe. Il capitale stesso considera allora il consumo finale, la domanda da parte dei lavoratori – ossia il pagamento del salario, su cui questa domanda poggia – non come un guadagno, ma come una perdita. Ecco la ragione per cui la domanda di questi lavoratori non può mai essere una domanda adeguata, poiché non rappresenta una produzione che ne mette in movimento un’altra. Il capitale nella sua totalità non può procurarsi dei consumatori nei lavoratori del capitale altrui, ma vale solo per ogni singolo capitale. Ma nel totale “scomparendo o riducendosi la domanda esterna alla domanda dei lavoratori”, subentra il collasso. Rimane la possibilità concreta per il capitale imperialistico di far aumentare entro la propria economia anche il consumo dei propri lavoratori, affinché essi siano garantiti rispetto all’estero, a scapito dei lavoratori del resto del mondo che hanno prodotto quelle merci. Questo significa “imperialismo” per i lavoratori garantiti dei paesi dominanti, e agisce perciò alla maniera di una “spesa in disavanzo” – di stampo keyenesiano – che potrebbe riequilibrarsi solo in un futuro qualora non si diffondesse il crollo generale del mercato mondiale.
Distinguere due fasi della circolazione è dunque indispensabile. La vendita della merce prodotta – la sua liquidazione in denaro, in quanto denaro – è in una prima fase (quella di reddito ovvero di denaro in quanto tale) un atto comunque cercato da ogni capitalista, anche commerciale o comunque improduttivo. Per la vendita pura e semplice è del tutto indifferente che la domanda provenga dai produttori (capitalisti in quanto personificazione del capitale, sia quello costante sia nella forma variabile della forza-lavoro) o pure dai consumatori (in genere, salariati inclusi). In questa maniera la concorrenza fa valere il carattere sociale della produzione e del consumo. Ma una volta compiuta questa azione – per la quale basta cioè trovare un acquirente qualsivoglia, anche un consumatore finale, un “ozioso”, ecc., che non fa tornare in circolazione quel denaro a fini riproduttivi – deve intervenire una seconda fase del processo di circolazione (quella di capitale, appunto). Queste due fasi sono dialetticamente legate, epperò vanno tenute distinte e pertanto mai sovrapposte e identificate tra di loro. Tutto ciò presuppone l’esistenza di classi e categorie differenti, che si ripartiscono il reddito totale della società consumandolo tra di loro come reddito individuale.
Ora perciò non basta più presupporre che il singolo capitalista possa prima convertire in denaro le parti costitutive del suo capitale mediante la vendita del suo prodotto-merce e poi ritrasformarle in capitale produttivo, ricomprando gli elementi della produzione sul mercato delle merci. Sono tutti elementi materiali di produzione del capitale sociale, parti integranti del movimento del prodotto complessivo, che si connette con il movimento di capitali individuali. Ma questa nuova accumulazione può incontrare difficoltà se mancano possibilità di investimento e conseguente saturazione della produzione ed eccessiva offerta di capitale da prestito; questa “pletora di capitale monetario da prestito – sostiene Marx – attesta semplicemente i limiti della produzione capitalistica. La speculazione creditizia che ne segue prova che non esiste nessun
21

ostacolo positivo all’impiego di questo capitale eccedente”. L’ostacolo è dovuto ai limiti della valorizzazione stessa del capitale in quanto capitale, il che accentua la necessità di spingere il processo di produzione al di là dei suoi limiti capitalistici.
Tutto ciò va avanti fino alla formazione di “bolle” monetarie cartacee attraverso l’emissione e la moltiplicazione di titoli cosiddetti “derivati”, ecc. – la cui mancanza fa confondere il consumo di reddito disponibile con la possibile illusoria crescita economica, senza mediazioni, per il reinvestimento. Non si vuole capire che ci si ferma irrazionalmente alla prima fase, con l’illusoria speranza di uscire dalla crisi, perché c’è ancora reddito da spendere e da dissipare nei paesi imperialisti, ma che ciò avviene ai danni del resto del mondo e delle classi e delle popolazioni dominate, con un effetto nullo sulla crescita reale dell’economia mondiale. Notava uno scrittore del XIX sec. che “un popolo frugale e laborioso impiega la sua attività per soddisfare la domanda di una nazione ricca e dedita al lusso”. Anche Adam Smith osservava che ciò che può fruttare un reddito al suo proprietario, può non fruttare alcun reddito aggiuntivo alla comunità; e perciò che “il reddito dell’intera popolazione non può essere minimamente aumentato da essa”. “Del resto – arguisce con estrema chiarezza Marx – nella misura in cui tutta la faccenda non si riduce ad una ipocrita fraseologia della "filantropia" borghese, che in generale consiste nel pascere il lavoratore di "pii desideri", ciascun capitalista pretende, è vero, che i suoi lavoratori risparmino, ma vuole anche che siano soltanto i suoi a risparmiare, perché gli stanno di fronte come lavoratori; ma per l’amore del cielo non lo faccia il restante mondo dei lavoratori, giacché questi gli stanno di fronte come consumatori. A dispetto di tutta la "pia" fraseologia, egli ricorre allora a tutti i mezzi pur di stimolarli al consumo, di dare nuove attrattive alle sue merci, di convincerli a crearsi nuovi bisogni”.
Secondo i sicofanti del potere un maggior “consumo”, non meglio definito, potrebbe far ripartire l’intera economia, la produzione e il mitico pil (che misura solo il valore di scambio, e non la ricchezza d’uso); in tal maniera ignorando ancora una volta che si consuma soltanto ciò che è stato precedentemente prodotto, e quindi che è la produzione a dover essere conclusa già prima che le merci possano essere consumate e non viceversa, come il cattivo “senso comune” vorrebbe. Nessuno mette in circolazione più di quanto ottenga, ma può ottenere soltanto quanto vi abbia messo. Un singolo lavoratore può impegnarsi al di sopra del limite normale, e più di quanto debba farlo per vivere come lavoratore, soltanto perché un altro sta al di sotto di quel limite. I padroni vorrebbero che anche i lavoratori non garantiti risparmiassero in periodi di prosperità per riuscire a sopravvivere in periodi di crisi, subendo licenziamenti, sospensioni dal lavoro, chiusure periodiche, più forte diminuzione del salario sociale in termini reali, ecc. L’inevitabile crack provoca il licenziamento dei lavoratori e i salari vengono di nuovo compressi al loro minimo e oltre.
L’attenzione principale degli economisti dovrebbe essere rivolta alle forze produttive e al loro futuro libero sviluppo e non, come sempre più spesso avviene, alla semplice ricchezza accumulata che colpisce l’occhio, che è soltanto nominale e non consiste di oggetti reali bensì di semplici titoli giuridici prodotti e perpetuati mediante gli espedienti, diritti sulle future forze produttive annue della società (è la ricordata speculazione). La pretesa borghese, invece, è che i lavoratori – chi, quando e come può – paghino anche il consumo, magari altrui, e abbiano sempre un tenore di vita minimo, a vantaggio di tutto il capitale. Abbassamento del salario e prolungato orario di lavoro, ecco “il nocciolo del procedimento razionale e sano che deve elevare il lavoratore alla dignità di consumatore razionale”, affinché egli trasformi in denaro per la massa di oggetti che la civiltà e il progresso delle invenzioni gli hanno reso accessibili.
Anche la percezione popolar-sindacale si lamenta analogamente, senza capire il reale ruolo e i limiti del consumo nel capitalismo, precipitando in un senso comune d’accatto, effettivamente rispondente alla realtà fenomenica. In tale maniera non viene mai neppure sfiorata la causa classista del fenomeno. Gli è che in tutte le crisi si ha un movimento ciclico che colpisce i lavoratori. L’imprenditore non potendo vendere i suoi prodotti non può assumere lavoratori: non può vendere i suoi prodotti perché non ha compratori; non ha compratori perché i lavoratori non hanno niente altro da scambiare all’infuori del loro lavoro e appunto per questo essi non possono scambiare il loro lavoro. Non è male rammentare che il salario per il lavoratore è in positivo un reddito, ma da spendere per consumare in funzione del capitale. È nelle mani del capitalista che compra la forza-lavoro che, in quanto parte variabile del capitale, costituisce un costo. “Il salario minimo vale non per il singolo individuo, ma per la specie. Singoli lavoratori, milioni di lavoratori non ricevono abbastanza per vivere e riprodursi; ma il salario dell’intera classe operaia, entro i limiti delle sue oscillazioni, è uguale a questo minimo” – scriveva Marx già centosessant’anni fa.
La grande borghesia vuole che i lavoratori garantiti e i piccoli borghesi subalterni del loro paese consumino il più possibile: non importa a scapito di chi, dentro o fuori del paese imperialista. La tendenza del capitale è illusoria e contraddittoria, anche teoricamente. Essa consiste, infatti, da un lato nell’aumentare il più possibile l’agglomerato dei lavoratori nella loro veste di consumatori in massa delle merci, mentre dall’altra si predica il risparmio nazionale; ma i due gruppi di soggetti non possono che essere differenti. Nella misura in cui è assorbita una massa di merci, ciò che il lavoratore può risparmiare come denaro, non è comunque capitale. Non c’è dubbio che l’esistenza della classe operaia sia necessaria per la classe dei
22

capitalisti, perciò anche il consumo del lavoratore mediato attraverso lo scambio monetario contro mezzi di sussistenza. Anche il consumo individuale del lavoratore in quanto tale, portatore della forza-lavoro, reagisce sulla produzione stessa; ma questo contraccolpo non interessa il lavoratore nel suo scambio così come non interessa qualsiasi altro venditore di una merce; anzi, dal punto di vista della semplice circolazione esso cade al di fuori del rapporto economico. È evidente che come una società non può smettere di consumare, così non possa smettere di produrre; ma una quantità determinata del prodotto è destinata fin dal principio al consumo produttivo, in forme naturali diverse dal consumo individuale. È così che gli apologeti del consumo finale delle merci non riproduttive presentano tuttora il consumo individuale alla percezione sensibile della masse come deus ex machina della ripresa economica e della supposta uscita dalla crisi – e al polo opposto il risparmio.
Le merci sono dunque consumate in due modi: in modo riproduttivo per il capitale, poiché esse sono state scambiate, insieme ai mezzi di produzione, con una forza-lavoro che le ha prodotte; in modo improduttivo per i lavoratori, poiché esse sono state scambiate con mezzi di sussistenza. Il risultato del primo è la vita dei capitalisti, il risultato del secondo è la vita dei lavoratori stessi. I lavoratori, per trovarsi sempre sul mercato come materia sfruttabile da parte dei capitalisti, devono prima di tutto vivere, devono quindi conservarsi mediante il consumo individuale. Ma questo stesso consumo è qui presupposto soltanto come condizione del consumo produttivo della forza-lavoro mediante il capitale. Marx sostiene poco dopo che “la domanda di forza-lavoro da parte del capitalista è insieme, indirettamente, domanda dei mezzi di consumo che entrano nel consumo della classe operaia”. Ma non è il capitale variabile a essere speso in questa forma dal lavoratore: è il salario, il denaro del lavoratore, che ricostituisce per il capitalista il capitale variabile.
Ciò che è realmente così convertito è il valore, lavoro oggettivato in cui è direttamente rappresentato o con il quale viene scambiato dopo essere stato convertito in denaro. È la merce e il suo valore che ora operano come capitale, e che non costa nulla alla classe capitalistica che, come classe, lo possiede e ne gode gratuitamente. “Caratterizza il cretinismo dell’economia volgare il fatto che essa spacci per ciclo caratteristico del capitale questa circolazione che non entra nel ciclo del capitale, la circolazione della parte del prodotto-valore consumata come reddito” [Marx]. Senonché è proprio del consumo individuale finale senza distinzioni ciò di cui invece si occupa l’ideologia economica dominante, altrimenti salterebbero sùbito fuori le differenze di classe su scala mondiale.
È sufficiente qui dire [anche se la crisi è analizzata specificamente nel corso specialistico] che nella fase attuale dell’imperialismo transnazionale, in particolare, se la merce con prezzo di monopolio entrasse nel consumo necessario dei lavoratori, tale prezzo sarebbe pagato con una detrazione dal salario reale (ossia dalla massa dei valori d’uso che i lavoratori riceverebbero con la stessa massa di lavoro) e dal profitto degli altri capitalisti deboli. La sovraproduzione, da momentanea, diviene una necessità sempre più imperativa, il mercato mondiale diviene più esteso per la concorrenza universale. Anche le crisi stesse diventano più violente e i salari si fanno sempre più aleatori. Ogni nuova crisi suscita inoltre immediatamente una concorrenza molto maggiore tra i lavoratori. La produzione prosegue in condizioni più difficili e per sostenere la concorrenza bisogna lavorare su scala allargata e concentrare i capitali in mani sempre meno numerose. Queste difficili condizioni della produzione si estendono ugualmente ai lavoratori, in quanto parte del capitale. Essi si trovano in condizioni sempre più difficili, cioè devono dare più lavoro per un salario sempre più basso. Ma tanto più la forza produttiva si sviluppa e tanto maggiore è il contrasto in cui viene a trovarsi con la base ristretta su cui poggiano i rapporti di consumo.
Si crea un continuo conflitto tra un consumo limitato su basi capitalistiche e una produzione che tende continuamente a superare questo limite; si vuole inoltre che quei paesi in cui il modo capitalistico di produzione non è sviluppato, consumino e producano come i paesi a produzione capitalistica, per poter pagare ai lavoratori del proprio i mezzi di sussistenza necessari così messi a disposizione del consumo unicamente quando esso si riconverte in capitale. Secondo i padroni lo stato capitalista deve rimettere, dice Marx, “alle altre nazioni più stupide il consumo delle sue merci e in generale il processo del consumo”, e invece proprio esse fingono di dimenticare che scopo del capitale è la valorizzazione e poi la speculazione . Marx ha precisato che “questa vendita non ha assolutamente nulla a che fare con lo stato reale della domanda. Essa ha a che fare solo con la domanda di pagamento, con l’assoluta necessità di trasformare merce in denaro. Allora scoppia la crisi. Essa diventa visibile non nell’immediata diminuzione della domanda per il consumo individuale, ma nella diminuzione dello scambio di capitale con capitale, del processo di riproduzione del capitale”: ossia nel crollo di tutta la produzione e nell’arresto di ogni nuovo investimento.
Bisogna, sempre, tener presente il mercato mondiale e, quando si parla di aumento del salario in un paese, sapere che esso è compensato dalla disoccupazione dei lavoratori in altri paesi. Salario e condizione dei lavoratori dipendono sempre più dal mercato mondiale. “Designare col nome di fraternità universale lo sfruttamento giunto al suo stadio internazionale, è un’idea che poteva avere origine solo in seno alla borghesia”, sottolineava Marx. E il liberale Hobson chiamava “una nemesi dell’imperialismo che le arti e i
23

mestieri della tirannia, acquisite ed esercitate nel nostro impero illiberale, siano rivolte contro le nostre libertà in patria” con “totale noncuranza o aperto disprezzo per l’infrazione delle libertà del cittadino e per l’abrogazione dei diritti e delle usanze costituzionali”: è il “costante riflusso del veleno dell’autocrazia irresponsabile dal nostro impero illiberale, intollerante e aggressivo”.
Riassumendo, per i lavoratori il proprio consumo individuale è un puro e semplice incidente del processo di produzione. Il consumo individuale dei lavoratori continua dunque ad essere sempre un momento della produzione e della riproduzione del capitale, giacché il capitalista consuma produttivamente nel processo lavorativo la loro forza-lavoro e non i mezzi di sussistenza dei lavoratori. La circolazione tra commerciante e consumatore, che si identifica col commercio al dettaglio, non rientra nella circolazione immediata del capitale. La spesa in mezzi di consumo non costituisce affatto ricchezza nuova. Le crisi si manifestano nel commercio all’ingrosso e nelle banche, che mettono il capitale monetario della società a loro disposizione. Le banche fanno pressione per il pagamento prima che le merci vengano rivendute. Cominciano allora le vendite forzate, le vendite per pagare. E così si verifica il collasso che stronca in una volta l’apparente prosperità. E dunque il cosiddetto pil non aumenta assolutamente di nulla, solo si trasferisce da una tasca all’altra.
Gli “economisti” servono per garantire che le spese sociali non gravino sullo stato, ma soprattutto che, senza dare nell’occhio, non incidano sui capitalisti e sulle loro tasche, ma, in fin dei conti, incombano sulla classe operaia, che deve perciò risparmiare per i capitalisti. La supposta “sovranità-del-consumatore” fa il paio con lo strazio dello stantìo ritornello di “domanda-e-offerta” in nome delle “regole-del-liberomercato” e serve alla classe al potere e ai suoi sicofanti accademici per celare la vera “sovranità del produttore”. In codesta maniera all’adulato consumatore rimane l’illusione di essere “sovrano di un regno del nulla”.
II
Il conflitto con la realtà – premessa
Se, nel modo di produzione capitalistico, l’accumulazione si riveste di tutte le antinomie e ambiguità possibili – ed essa può essere rappresentata, con le immagini di Paul Klee, dalla “dea serpente” – il periodico eccesso di sovraproduzione e l’inevitabile interruzione del processo dell’accumulazione stessa è evidenziata dalle contraddizioni della crisi – la “sua nemica” di cui indossa gli abiti. Si può continuare a parafrasare i commenti ai disegni del pittore svizzero, da lui stesso scritti in una data di preludio alla grande crisi, come fu il 1928 (mentre il disegno riportato in copertina, non per caso, è di un altro anno iniziale di tragedia, il 1940) [cfr. Paul Klee, On modern art, Faber, London 1948]. Non solo nelle arti grafiche, ma anche in quella “scienza triste” che è l’economia, infatti, si mostra “il contrasto tra classicismo e romanticismo, forma di espressione che cerca convulsamente di staccarsi dalla terra e di porsi al di sopra della sua realtà, per trionfare, con le sue proprie forze, sulla gravità”. Gli economisti, nell’analisi che tre decenni prima fece Lenin [Le caratteristiche del romanticismo economico (1897)] sono “intellettuali romantici, ogni giorno di più in conflitto con la realtà, la quale sviluppa le contraddizioni di cui non hanno saputo valutare la profondità; le tesi fondamentali del romanticismo e della concezione piccolo-borghese del capitalismo ripongono tutte le loro speranze nel debole sviluppo del capitalismo, implorano che questo sviluppo venga frenato”.
Sempre Klee denuncia l’atteggiamento “romantico oppressivamente patetico”, col rifiuto di “afferrare le forze, ostili alla terra, per emergere”. Pertanto “non si può, con gli ottimisti, considerare questo mondo come "il migliore dei mondi possibili"”; ma, per sapere che, “nella sua forma attuale, non è il solo mondo possibile”, basta estendere “la propria concezione dal presente al passato e dal passato al futuro, in un processo di trasformazione senza fine, mai compiuto, in un mondo che appaia, in ogni tempo, sempre diverso, casualmente stabilito nel tempo e nello spazio”. Solo una tale concezione è in grado si procurare “un senso di libertà, che non conduce a predeterminate fasi di sviluppo”. Ecco, per finire questa parafrasi elaborata dall’“artista” Klee in tempi bui, è sufficiente pensare alle acrobazie ancora oggi fatte dagli economisti per giustificare l’esistente.
La resistibile ascesa del capitale – accumulazione
Il capitale è un rapporto sociale. Dunque, la totalità del mercato mondiale rappresenta due momenti di tale relazionalità internazionale: i. del capitale con se stesso (molteplicità dei capitali particolari,
24

concorrenza e anarchia della produzione, a fondamento delle crisi da sovraproduzione), e ii. del capitale con il lavoro salariato (antagonismo di classe, antitesi tra lavoro morto e lavoro vivo e composizione organica del capitale stesso, a fondamento della caduta tendenziale del tasso di profitto). Senza la prima condizione, la seconda non sarebbe neppure pensabile e dicibile, giacché il lavoro salariato esiste solo come parte variabile del capitale totale. Se, come si dirà, con l’espansione imperialistica transnazionale si accumula capitale su scala mondiale crescente, questa accumulazione si presenta necessariamente anche come aumento internazionale di capitale variabile. Ma “capitale variabile” non è altro che la maniera priva di fronzoli per chiamare il proletariato; tant’è vero che con la crisi – la “nemica” della dea accumulazione – licenziamenti e disoccupazione rappresentano il risvolto antropomorfo della necessaria distruzione periodica di capitale variabile. È precisamente questa circostanza che racchiude la forma antitetica del processo sociale di internazionalizzazione, giacché, riproducendo se stesso su scala allargata, il capitalismo è la sola forza capace di produrre anche il proletariato mondiale come classe. Il nuovo ordine tenta così una sintesi nell’unificazione del mercato mondiale, che – in mancanza dell’impossibile soppressione della molteplicità capitalistica – prova almeno a regolare l’internazionalizzazione del proletariato a esclusivo vantaggio dell’internazionalizzazione del capitale, quella mondializzazione che va sotto il nome improprio di “globalizzazione”.
Il capitale si adegua proprio nella misura in cui riesce ad accrescere il suo comando sul lavoro, ossia in ragione della crescente proletarizzazione della popolazione del pianeta. Qui sono i termini che saranno esaminati a proposito della questione del nuovo ordine imperialistico del lavoro. Nella presente fase storica pare che le lotte sociali di più grande momento siano quelle rivolte a salvaguardare i diritti violati nei confronti di emarginati ed esclusi, per sesso o per razza, per religione o per handicap psicofisici, per condizione sociale o politica, e così via diversificando. Senonché codesti gruppi rappresentano minoranze rispetto al resto della società inscritta nel rapporto tra capitale e lavoro salariato. Ciò conviene al capitale per differenziare le forme dell’antagonismo sociale e deviarle rispetto al carattere peculiare e immanente, specificamente determinato, del suo comando: il rapporto di produzione e di proprietà. In nome dell’attenzione alle minoranze volta a volta sfavorite, viene rimossa la forma del dominio caratteristico e sempre attivo nel modo di produzione capitalistico: l’uso della forza-lavoro, ossia in termini sociologici sindacali lo sfruttamento del lavoro salariato. In tale rimozione si provoca così la dimenticanza del fatto, apparentemente banale, che lo sfruttamento capitalistico riguarda non minoranze particolari ma la maggioranza universale della popolazione mondiale affatto priva di proprietà. Sembra ormai un paradosso – soprattutto nelle società del capitalismo “avanzato” in ogni senso, sviluppato e marcescente – ritenere che la contraddizione principale sia quella delle maggioranze oppresse e non quella delle minoranze occasionali, sia pure ridotte alla fame, ma così costrette proprio dall’espansione mondiale del rapporto capitalistico. Già a Hegel era chiaro che la povertà cresce insieme – al polo opposto – alla ricchezza.
L’organizzazione capitalistica del lavoro occupa, dunque, un posto centrale nell’accumulazione di capitale, riguardando precisamente il suo elemento variabile, quello che produce il plusvalore che poi si trasforma in profitto (e rendita, interesse, imposte, ecc.). Tale processo è tanto più segnato da innovazioni quanto più si susseguono a ritmo crescente le fasi dell’imperialismo del capitale nel pianeta. Perciò occorre notare il forte ritardo anche per la semplice comprensione del processo medesimo, ritardo favorito dal diffondersi di false ideologie, di vaghe affermazioni sociologistiche; si prenda, a mo’ di esempio, quella che presupporrebbe la “fine della classe operaia”, proprio mentre perfino i rapporti della Bm indicano che ben prima del 2010 si dovrebbero raggiungere i 4 miliardi di “lavoratori dipendenti”, ossia salariati o stipendiati: proletariato mondiale. Tutto ciò si svolge in una spirale discendente di rabbassamento culturale che produce a sua volta ulteriore caduta, cioè un effettivo dileguarsi della coscienza di massa. Il problema consiste, dunque, nel dover capire scientificamente i punti alti delle contraddizioni in cui si è venuta avviluppando la nuova divisione internazionale del lavoro e la nuova composizione di classe.
Si generalizza così l’aspirazione del capitale – storica, ma che per esso è eterna – a portare il tempo di lavoro a coincidere col tempo di produzione: la costrizione all’aumento della durata e dell’intensità (attraverso straordinari, saturazione di tempi, turni, cicli continui, cottimi, ecc., spesso racchiusi sotto l’etichetta della “flessibilità” che riassume ogni irregolarità del rapporto di lavoro, anche dei lavoratori in “riserva stagnante”) testimonia sempre più circostanziatamente dell’intero processo di comando del capitale sul lavoro, che sta nel ricatto salariale la cui indiscutibile clausola “scientifica” è la contemporanea produzione di plusvalore (profitto) da accumulare, senza la quale accumulazione – come ben sottolineato da Adam Smith – non si dà neppure il lavoro salariato. [Avendo trattato altrove tali temi generali, qui basta ricordare che la nuova organizzazione capitalistica del lavoro, anche nell’epoca attuale dell’imperialismo, è passata sotto nomi usa-nipponici quali total quality control o qualità totale, just in time, kanban, kaizen, ecc.].
La rigidità del sistema di macchine della linea di montaggio tayloristica ha mostrato presto i suoi limiti, in concomitanza con la capacità operaia di esprimere una propria rigidità. Ma per l’eliminazione di tutte le
25

forme degli sprechi – di tempo, di materiali, di spazio – è necessario portare al massimo grado l’aumento della scala di produzione. Ciò spiega, parallelamente alla crescente concentrazione di nuovo capitale conseguente all’accumulazione stessa dovuta a investimenti netti, l’enorme processo di centralizzazione, mediante acquisizioni (o fusioni) del vecchio capitale già esistente, nelle grandi imprese transnazionali. Entrambi i movimenti si situano al vertice di una piramide di subfornitori via via più piccoli, fino al lavoro a domicilio, tutto in una rigida subordinazione gerarchica che ridefinisce la divisione internazionale del lavoro. Perciò, riorganizzandolo in tale maniera, si rende “flessibile” proprio il processo lavorativo (con lavoro multifunzionale), spezzando quella rigidità nelle fasi di attività umana interposta tra una macchina e l’altra. Flessibilizzazione del lavoro significa irrigidimento del capitale, e viceversa. Il capitale, come detto, entro la propria unità contraddittoria, conduce così oggettivamente anche a quella del proletariato mondiale (come classe in sé). Ciò che il capitale mondiale ha posto in essere, si mostra in tutta la sua evidenza come capacità del suo adeguamento storico. Certo, quell’oggettiva unificazione è ancora tutta dentro la sua ottica, che nelle articolazioni locali del proletariato mondiale riesce proprio per ciò a trovare e imporre il consenso coatto neocorporativo, nel senso appresso specificato.
L’azione del capitale, in direzione dell’allargamento sistematico della propria sfera d’intervento, è incessante. Il dominio del modo di produzione capitalistico si è esteso ormai praticamente, almeno sul piano qualitativo, all’intero pianeta. L’unificazione del mercato mondiale è avvenuta e manca solo il suo compimento quantitativo, il riempimento pratico di tutti i suoi pori; perciò si è detto che l’unico “internazionalismo” effettuale è a tutt’oggi quello del capitale. Non a caso Marx ha posto il mercato mondiale al centro della sua analisi sulle caratteristiche epocali del modo di produzione capitalistico. Da un lato, la produzione di ricchezza astratta, valore, denaro (quindi la forma stessa del lavoro astratto in generale) si sviluppa nella misura in cui il lavoro concreto particolare, divenuto totalità di differenti modi di lavoro, abbraccia il mercato mondiale. Questa trasformazione del lavoro contenuto nel prodotto in lavoro sociale – che è possibile soltanto sulla base del commercio internazionale e del mercato mondiale – è, a un tempo, precondizione e risultato della produzione capitalistica. Nel mercato mondiale, dunque, la produzione di valore è posta come totalità, così come ciascuno dei suoi momenti, in cui nello stesso tempo tutte le contraddizioni si mettono in movimento.
Alcuni pochi elementi descrittivi consentono di mostrare come il capitale che oggi dà il segno, ovunque nel mercato mondiale, sia il capitale transnazionale, dominante qualitativamente:
i. la presunta tendenza storica allo “snellimento” della scala di produzione [una volta andava in voga il cosiddetto “piccolo-è-bello”, ormai fortunatamente caduto in disgrazia e sminuito anche dai suoi antichi fautori] è risultata tanto immotivata teoricamente quanto indimostrata praticamente; si è dovuto constatare che quasi tutte le imprese minori produttrici (non quelle di mera prestazione di servizi, turismo, ristorazione, ecc., riparazione o piccolo commercio) sono nel giro della “subfornitura” o dell’“esternalizzazione”, ecc. e pertanto di fatto economicamente integrate nella struttura del processo di produzione monopolistico transnazionale, mediante processi apparentemente contraddittori di centralizzazione strategica finanziaria (holding) e decentramento operativo produttivo; a conferma di tale tendenza, c’è l’ultradecennale recente, e non conclusa, eccezionale ondata di acquisizioni e fusioni [m&a, dicono gli anglofoni] tesa a razionalizzare il menzionato processo di centralizzazione della proprietà;
ii. la cosiddetta, impropriamente, “deindustrializzazione” rimanda dunque alla definizione di filiere produttive integrate nella nuova divisione internazionale del lavoro; si tratta piuttosto, propriamente, di “dislocazione” della produzione industriale su scala mondiale, auspice anche lo sviluppo senza precedenti delle comunicazioni, in ogni accezione, dai trasporti di merci (soprattutto semilavorati) alla trasmissione di dati per informazione e controllo; tale nuova divisione internazionale del lavoro mira a integrare le nuove economie con più bassi costi del lavoro e di produzione in genere, soprattutto nella prospettiva dell’imponente crescita asiatica, l’unica attualmente praticabile.
Epperò, l’unificazione del mercato mondiale, oggi potenzialmente raggiunta, ha posto il sistema imperialistico del capitalismo transnazionale all’avvio dell’ultimo lungo giro della propria spirale discendente. Tale discesa, fino alla definitiva scomparsa – in una maniera o nell’altra, quale che ne sia la direzione e l’esito, verso una reale socializzazione oppure verso una nuova barbarie – del modo di produzione capitalistico, può forse ancora durare molti decenni, ammesso che non occorra addirittura misurarla con la lunghezza secolare, ma ha ormai potenzialmente inscritta in sé la portata e la compiutezza storica della propria inesorabile fine. Il globo terracqueo è quello che è, è dimensionalmente e concettualmente finito, e con esso sono finite anche le possibilità di espansione egemonica del capitale. Quest’ultimo modo di produzione, pur essendo esso stesso un risultato caduco della storia umana, abbisognerebbe viceversa di una tendenzialità infinita per il proprio processo di accumulazione.
Infatti – essendo il valore l’unico obiettivo sensibile del capitale (“produzione per la produzione”, fine a se stessa, ovverosia senza limiti) – sinonimo di “accumulazione” è necessariamente produzione di sovra-va-lore (poiché l’ottenimento di plus-valore – la circolazione e realizzazione del capitale-merce con profitto – è
26

il solo obiettivo della produzione capitalistica). Il che in altri termini, trasponendo il prefisso “sovra”, non è altro che, concettualmente e semanticamente, sovra-produzione di valore. Questa pertanto è la condizione ordinaria della produzione capitalistica per l’accumulazione; ma essa si trasmuta altresì, allorché divenga patologica – perché, saturando il mercato mondiale, corrispondente a capitale-merce non vendibile con profitto – in eccesso di sovraproduzione, eccesso di produzione di plusvalore rispetto alla norma, all’ordinario andamento dell’accumulazione di capitale. L’irrazionalità dell’infinità conduce necessariamente il capitale alla periodicamente ricorrente crisi da sovraproduzione. Come inevitabile corollario storico di ciò, proprio l’adeguamento del capitale al suo concetto, nell’unificazione del mercato mondiale, ha inverato con sé anche la dissoluzione del falso comunismo e del socialimperialismo, ponendo così, a un tempo, le basi per l’avvio possibile di un’era di rivoluzionamento: come detto, o verso una società di tipo superiore o verso una forma possibile di barbarie, la quale peraltro già procede minacciosa.
In un contesto di prolungata difficoltà e crisi dell’accumulazione, come è quello degli ultimi decenni del XX sec., il maggior successo del capitale mondiale nella seconda fase di quel periodo è consistito proprio per ora quasi solo nella rammentata capacità di spezzare provvisoriamente la forza della classe antagonistica, sconfiggendola praticamente ovunque, e annullandone entità e coscienza. Tuttavia codesto, appunto, è fin qui l’unico vero successo del capitale nella fase della sua più prolungata e profonda crisi di questo secolo (e forse della sua intera storia moderna). In effetti, il vero grande problema del capitale nel suo concetto – cioè, non solo attuale, nella fase dell’imperialismo transnazionale, che è aspramente conflittuale e non ha l’aspetto surrettizio di un supponente “impero” conglobato – è di non riuscire a stringersi in un polo unico. Né, verosimilmente, potrà mai riuscirci, in quanto capitale. La contraddizione intrinseca al concetto stesso di capitale è proprio questa: non poter ridurre all’uno il molteplice.
Ma le ricorrenti espressioni di conflittualità (non solo) economica tra capitali, stati, nazioni, indicano la misura in cui i vari tentativi di risoluzione non si siano compiuti. Dalla forma tripolare del potere imperialistico, che aveva fatto finalmente rapida giustizia dell’ormai superato confronto circoscritto a uno scontro politico militare tra le due superpotenze, americana e russa, e che ha segnato la prima fase della conflittualità della crisi in corso, si è giunti, senza tuttavia risolvere la contraddizione, al consolidamento di due tendenze, contrapposte ma entrambe necessarie, le quali hanno sussunto proprio la scontro tra i “poli” imperialistici. Da un lato, si evidenzia sempre più sul mercato mondiale la conflittualità tra i molti capitali, nella forma finanziaria transnazionale, che non può che essere mediata – se del caso, anche con la forza – da quella tra stati nazionali. D’altro lato, gli stessi “fratelli nemici” del capitale transnazionale convergono nella costruzione del nuovo ordine mondiale corporativo, considerandolo come processo universale, la cui effettuazione, tuttavia, non può che verificarsi attraverso ambiti locali e nazionali, attraverso grandi riforme istituzionali e guerre regionali.
I “fratelli nemici” – imperialismo
La contestazione dell’imperialismo, quale si è manifestata nelle vesti della “serie no global” o delle mode univocamente “imperiali” a prescindere dalla forma storica capitalistica, merita forse qualche osservazione più precisa. Ogni atteggiamento critico nei confronti dell’imperialismo, specie oggi nelle sue forme transnazionali, è sicuramente valido sintomo del disagio che le contraddizioni del suo dominio dispotico provoca a ogni livello. Ciò nondimeno, sarebbe sbagliato ritenere che fosse dello stesso segno qualsiasi critica dell’imperialismo, indistintamente racchiusa ideologicamente nel termine “anti-imperialismo”. Lenin, al proposito, asseriva di stare dalla parte dell’imperialismo contro il vecchio capitalismo concorrenziale, come dalla parte di quest’ultimo contro il feudalesimo. Marx aveva premesso di essere favorevole al “libero scambio” contro il protezionismo mercantilistico dei “cartisti”. Sicché, è bene considerare la maggior parte delle critiche odierne “contro l’imperialismo” secondo la loro precisa collocazione sociale, cioè di classe. Si equivoca spesso, mettendo sotto la ricordata generica etichetta “antimperialismo” cose molto diverse. Si confondono così, anzitutto, le forme corrispondenti alle varie fasi dell’imperialismo stesso (particolarmente quella nazionale classica e quella attuale transnazionale); conseguentemente, sul piano pratico dell’evidenza della storia, succede che molti critichino l’“imperialismo Usa” (sicuramente quello tuttora dominante, se non altro per il suo monopolio di potenza militare e bellica) prendendo erroneamente come sinonimo di “antimperialismo” il termine “antiamericanismo”, dal punto di vista di altri imperialismi più deboli.
Si verifica allora la disdicevole circostanza per cui contro l’imperialismo transnazionale si erga in prima linea la barriera costituita dalla sperata rivincita degli imperialismi nazionali, più o meno sopraffatti, al cui séguito si schierano i capitali nazionali della piccola e media borghesia, non integrati nella concatenazione transnazionale stessa, fino ai nazionalismi più diretti, ambigui se non biechi. Non si dimentichi che anche il fascismo e il nazismo si “dichiararono” antimperialistici, in quanto a parole contrari alla “plutocrazia capitalistica” (oltreché, naturalmente, al comunismo), e nei fatti antiamericani e antinglesi. Fanno poi,
27

soprattutto recentemente, da contorno folcloristico, tutti i “movimenti antisistema”, aclassisti e interclassisti, i quali sostanzialmente si appellano senza cessa all’armonia e alla filantropia dell’Uomo! Le classi nazionali della borghesia, media e piccola, hanno assunto di fatto la guida di quasi tutti tali movimenti; ma la contraddizione di un fronte di alleanze è stato ben evidenziato dagli avvenimenti della rivoluzione francese del 1789 – ancora oggi sentimentalmente fraintesi dalla democrazia socialista – con la strumentale subordinazione al terzo stato opportunista del quarto stato popolare e proletario in formazione (così come il massacro dei contadini tedeschi da parte dei prìncipi luterani).
Nel contesto storico attuale, quindi, la proletarizzazione crescente a livello planetario diviene in tal modo organicamente funzionale alla precarizzazione delle condizioni di esistenza delle masse popolari internazionali. Il potere “nazionale” ne cattura il consenso volutamente frammentato e disperso con l’imperialismo altrui, articolando le masse stesse nelle molteplici particolarità e nazionalità negate o sopravvissute solo in quanto apparenti. Il nuovo ordine ne esige appunto quel riassetto funzionale, attraverso l’approvazione fornita da tutte le istituzioni della mediazione sociale (apparati statali, partiti, sindacati, chiese, famiglie, televisioni, giornali, ecc.), unitamente al ricatto (lavoro, povertà, fame, persecuzione politica, guerra, ecc.), per ostacolare e prevenire qualunque critica che possa prefigurare un’alternativa di potere. Come si specificherà tra breve, la partecipazione neocorporativa, nella sua parvenza di parificazione, è la forma suadente per distogliere dall’antagonismo di classe coloro che vivono l’oppressione imperialistica, senza però che ancora riescano del tutto ad adeguarsi a essa.
L’apologetica economica fornisce, proprio dagli inizi degli anni 1870 con la “grande depressione” alle soglie dell’epoca imperialistica, le giustificazioni dell’imperialismo stesso, giustificazioni che il potere capitalistico desiderava e brama sempre più urgentemente; la “volgarizzazione” dell’economia a quel punto lo impone definitivamente (perfino la scuola ricardiana viene dissolta), e la centralizzazione monopolistica finanziaria dell’imperialismo si presenta come “verità” del capitalismo. “La maggior parte delle spiegazioni costituiscono delle giustificazioni”, asseriva Bertolt Brecht. Ora, pur se “economia” non è sinonimo di “parificazione” o “corporativismo” tout court¸ proprio questa è la tendenza intrinseca del capitale. In effetti, il “salario” in quella ideologia trionfante resta solo un “nome”. Infatti, le tesi economiche “ufficiali” (marginalistiche o keynesiane, ecc., senza differenza teoretica alcuna) chiamano sì “salario” il reddito attribuito ai lavoratori, ma lo calcolano in base al loro “contributo produttivo”, sul prodotto già ottenuto tutti insieme; perciò si fa intendere che nessuno dipenda da nessun altro, e che siano considerati tutti uguali in una supposta “pluralità” dei cosiddetti fattori di produzione. Il lavoro, in tali tesi, cessa di essere “la sola fonte del valore di scambio e la fonte attiva del valore d’uso” [Tp, q.XV, f.861].
Ma se il salario (o lo stipendio) non è il pagamento di un lavoratore dipendente – un lavoratore che dipende da qualcun altro, come l’intenderebbe il buon senso di qualsiasi pendolare costretto ogni mattina a salire su un mezzo di trasporto per andare al lavoro – che “salario” è? Quale lavoratore “dipendente”, come tale, può decidere alcunché in merito al processo lavorativo e produttivo stesso? Di quale lavoro alle altrui dipendenze potrebbe trattarsi? Questa, invece, è solo quella che è chiamata “partecipazione” – al prodotto, ma non certo alle decisioni, “spartizione della torta”, dicono – ed è il miraggio di tutte le tesi economiche dominanti. Esse pretendono di presentare il lavoratore non come dipendente ma come “prestatore d’opera”, non alle dipendenze altrui ma padrone di se stesso anche nella propria attività e ... disoccupazione. In realtà, si è visto che si tratta di “partecipare” solo al ricatto dei risultati di una produzione assolutamente incontrollabile, nelle sue linee strategiche, da parte dei non proprietari. Il neocorporativismo, si dirà, sta pertanto già entro la trasformazione del processo di lavoro nei rapporti economici del modo di produzione, e non solo nella tecnica o nelle risultanze giuridiche istituzionali.
L’“economia politica”, incrollabilmente fondata su schemi cosiddetti “neoclassici”, marginalistici o keynesiani – come se il keynesismo stesso non fosse, tutt’intero, nato cresciuto e morto entro le spoglie del liberismo senza frase – anela dunque intrinsecamente alla visione corporativa. A es., nella funzione di produzione neoclassica, la presenza di lavoro senza altra qualificazione, in una molteplicità di altri fattori produttivi, è funzionale al sistema. La forma sociale della dipendenza del lavoro non c’è, è lì svanita, svuotando il concetto stesso di rapporto sociale del “capitale”. Essa sostiene che “per "lavoratore" s’intende qualsiasi persona che viva del suo lavoro. Contadini, artigiani, operai, artisti, preti, soldati, re, sono tutti lavoratori”. E “anche i profitti devono essere considerati come retribuzione del lavoro”. Sicché afferma che il salario è il prezzo che l’imprenditore paga per le merci che gli fornisce il lavoratore. “La parola "salario" è superflua in economia politica” – dicono conseguentemente, per bocca di Silvio Gesell, il carneade “vate” di Keynes – poiché quel “salario” non sarebbe altro che il prezzo del prodotto, meno ciò che va al capitale! Scompare ogni riferimento a un qualsiasi agente della produzione capitalistica che si caratterizzi invece per avere alle sue dipendenze dei lavoratori. Misurando i compensi dei lavoratori sui guadagni delle aziende, viene fatta mutare la sua stessa figura nei rapporti con il capitale, il che trasforma qualitativamente quel compenso (mettendo sullo stesso piano lavoratori e imprenditori) e non solo quantitativamente. L’afflato corporativo si presenta così come cointeressenza obbligatoria alle sorti del capitale.
28

Perciò il liberismo, in ogni sua apparenza, comunque esprime come classe il comando del capitale sulla merce forza-lavoro, in tutte le successive fasi di sviluppo del modo di produzione capitalistico. Gli economisti, nel vano tentativo di “staccarsi dalla terra e di porsi al di sopra della realtà”, per ripeterla con Klee, si pongono continuamente in conflitto con la realtà medesima, poiché nessuna delle loro rappresentazioni teoretiche corrisponde minimamente all’effettivo funzionamento di questo sistema di produzione; ossia, più si va avanti e sempre minori possono essere le verifiche, come si suol dire, del “realismo delle ipotesi”. Dunque, con questi appoggi il “liberismo” dell’imperialismo del 2000 ha potuto portare alla ribalta anche una serie di “nuove” post-mistificazioni, che dalla “finanziarizzazione” alla “globalizzazione”, ecc. sono approdate alla “nuova economia” delle tecnologie informatiche. Dunque, l’“effetto perverso” – così lo chiamano – della cosiddetta globalizzazione si chiama in realtà con la parola molto semplice, impiegata cent’anni fa da Hobson, e poi da Hilferding, Bukharin, Lenin, Grossmann, Pietranera e altri: imperialismo, o se si vuole essere più precisi, oggi imperialismo nella fase transnazionale del mercato mondiale dei capitali.
La categoria “imperialismo” perciò è da sola sufficiente rispetto alle mode attuali intorno a “globalizzazione”, “nuova economia”, precedute di poco da “geopolitica”, “neoliberismo”, “finanziarizzazione”, “postfordismo” ecc.: rimane soltanto ciò che esse hanno di “accidentale, triviale, estrinseco e passeggero”, come direbbe Hegel. Perciò è necessario intendere quale sia il preciso ordine gerarchico di tali categorie mistificanti, come operino le acquisizioni in comparti guida, strategici per il capitale finanziario (in filiere come le tlc, l’auto, il chimico farmaceutico alimentare, il bancario, ecc.), tali da modificare profondamente il quadro degli assetti proprietari, dei rapporti di proprietà. In questo quadro assumono rilievo le motivazioni della “ristrutturazione competitiva dei costi di produzione” (quella che l’aziendalista usamericano Michael Porter l’ha definita come nuova “catena del valore”). Importante però è comprendere che il mercato mondiale del capitale non è costituito da un generico “reticolo” di interdipendenze paritetiche, ma che esso viceversa implica precisi rapporti internazionali di dominanza, una “gerarchia” appunto.
Marx ricorda che l’astrofisico modenese Ottavio Finetti, alias Geminiano Montanari, trattando Della moneta nel 1683, già intravedeva che “stando in sua casa” ognuno poteva provvedersi di “ogni mercanzia”, e goderne, dappoiché “tutto il globo terrestre” – globale in questo senso astronomico – era divenuto quasi come “una sola città”: dopo oltre tre secoli, questa sembrerebbe essere ancora la migliore descrizione possibile delle attuali transazioni elettroniche (commercio e moneta). Appare senz’ombra di dubbio come la circolazione del plusvalore, e del capitale che lo genera, è bensì insostituibile per le sorti del capitale stesso sul mercato mondiale, ma può riposare solo su una sua produzione già avvenuta, che pertanto nessuna circolazione è assolutamente in grado di sostituire. Tutte queste funzioni – pienamente integrate nel processo di concentrazione (investimenti netti) e centralizzazione (acquisizioni e fusioni) del capitale – rimangono gregarie del complessivo ciclo di accumulazione del medesimo capitale produttivo sempre più grande, senza il quale esse neppure avrebbero esistenza. Giustamente è stato osservato, a tale proposito, che gli Usa sono il paese meno “globalizzato” del mondo. E ciò, appunto, ha una sua esplicita spiegazione dimostrativa proprio nei termini dell’imperialismo: gli Usa appaiono così precisamente perché sono tuttora, per antonomasia, il paese “globalizzante”, ossia quello predominante nel sistema imperialistico del capitale transnazionale.
Non è mai male ripetere che il corretto concetto (marxista) di capitale finanziario consiste nella fusione e simbiosi monopolistica del capitale produttivo (industriale in senso lato) – che è e rimane la base del tutto, come è stato poco sopra rammentato in merito al processo di centralizzazione – col capitale monetario (bancario, ecc.). La moderna forma finanziaria, cioè, non può essere confusa e identificata solo con quest’ultima funzione unilaterale, monetaria, essenziale ma non causa determinante, soprattutto se circoscritta alla speculazione borsistica e fittizia. Nell’imperialismo, in tutte le sue fasi, il carattere dominante del capitale monopolistico finanziario ha perciò questa accezione di totalità; mentre, nella sua unilateralità è sempre la funzione produttiva quella determinante, e quindi ciò fa sì che la circolazione puramente monetaria, nella sua reciproca unilateralità, ne rimanga determinata.
“Nelle categorie economia monetaria, economia creditizia, è accentuato ed emerge come contrassegno distintivo non l’economia, cioè il processo di produzione stesso, ma il modo dello scambio, corrispondente all’economia. L’economia monetaria è comune a ogni produzione di merci, e il prodotto appare come merce nei più differenti organismi sociali di produzione. Di fatto, la produzione capitalistica è la produzione di merci come forma generale della produzione, soltanto perché qui il lavoro stesso appare come merce, perché il lavoratore vende il lavoro, cioè la funzione della sua forza-lavoro. Il rapporto monetario diventa un rapporto immanente alla produzione stessa. Ma questo rapporto, riguardo alla base, si fonda sul carattere sociale della produzione, non nel modo dello scambio; al contrario, questo scaturisce da quello. Del resto corrisponde all’orizzonte borghese, in cui il concludere affarucci occupa tutta la mente, di non vedere nel carattere del modo di produzione il fondamento del modo dello scambio a esso corrispondente, ma viceversa” [C. II,4]
29

In effetti, è peculiarmente dalla conoscenza del complessivo riassetto operativo del moderno capitale monopolistico finanziario che deriva la possibilità di comprendere sia le condizioni (eventuali) di ripresa del -l’accumulazione su scala mondiale, sia quindi del rapporto critico tra capitale operante e produttivo e capitale speculativo e monetario, sia infine delle caratteristiche della ricomposizione e dislocazione di classe del proletariato mondiale. Le ricerca di un tale possibile riassetto è per ora l’ultimo vulnerabile tentativo di accordo tra i capitali in lotta, per rinviare ulteriormente tra loro uno scontro diretto non più soltanto economico. Si tratta ancora di un processo aperto, che si è svolto a tappe: la crisi avviatasi in Usa alla metà degli anni 1960; la controffensiva imperialistica della metà degli anni 1970, prevalentemente ancora Usa attraverso il “piano Kissinger” per il nuovo ordine mondiale; la redistribuzione monetaria con la speculazione reaganiana degli anni 1980, che ha creato il problema del debito estero e l’“esportazione interna” in borsa di capitale (per dirla con Grossmann); da ultima, all’avvio degli anni 1890, la “soluzione finale” della guerra fredda.
Il consenso coatto – neocorporativismo
Il lungo e tormentoso viaggio del corporativismo, nella sua veste più moderna, tra le pieghe dell’imperia-lismo del capitale, offre la cronaca del “ritorno” di questa peculiare forma di relazionalità sociale come neocorporativismo. Esso è una forma necessaria di relazioni che è da osservare nei suoi contenuti strutturali prima ancora che nelle diverse vesti metamorfosate che di volta in volta le vengono offerte dalla parvenza sociale e istituzionale. Sicché, sotto una discreta varietà di organizzazioni dello stato e della società civile, si celano analoghe tendenze di mutamento delle forme sociali assunte dal modo di produzione capitalistico nella sua fase imperialistica, e in particolare oggi nella forma dell’imperialismo transnazionale. Siffatte tendenze prescindono, in un cero qual senso, dalle circostanze – autoritarie, totalitarie, democratiche o populiste – nelle quali il potere si rappresenta; in questa ottica furono espressioni anticipatrici del moderno corporativismo tanto l’Italia fascista, esplicitamente corporativa, quanto la Germania nazista, rappresentata sotto l’egida dello stato etico forte e dispotico, ma nella piena continuità economica dalla banca centrale al ministero dell’economia, cioè dalla falsa socialità di Weimar al terzo reich, rappresentata dal dr. Schacht; tanto il Giappone del celeste impero il cui fascismo era celato dietro la maschera della filiazione divina, quanto il più terreno new deal rooseveltiano, che rivestì le analoghe regole neocorporative con una parvenza democratica, storicamente più consona ai tempi. Epperò è l’eternizzazione del rapporto di capitale, nella sua improbabile armonia, che costituisce l’obiettivo ideologico su cui la grande borghesia monopolistica finanziaria transnazionale mira a ottenere il consenso di massa.
Del resto Engels, nella seconda lettera da lui scritta a Marx, il lontano 19 novembre 1844, rappresentava la tendenza già allora in atto, e per ciò stesso prematuramente visibile a chi avesse occhi per vederla, con queste parole: “Fa attenzione, prossimamente sorgerà nell’Uckermark un nuovo messia, che ti raffazzonerà Fourier alla Hegel, costruirà il falansterio partendo dalle categorie eterne e lo porrà come una legge eterna dell’Idea che ritorna in sé, secondo cui capitale, talento e lavoro partecipano al profitto in parti determinate. Questo sarà il nuovo Testamento della "hegeleria", il vecchio Hegel sarà il vecchio Testamento, lo "stato", la legge, sarà un’"educatore a Cristo", e il falansterio, nel quale le latrine saranno disposte secondo la logica necessità, diverrà il "nuovo cielo" e la "nuova terra", la nuova Gerusalemme che discende dal cielo ornata come una sposa, come si potrà leggere per esteso nella nuova Apocalisse. E quando tutto ciò sarà compiuto, arriverà la Critica critica a spiegare che essa è tutto nel tutto, che essa riunisce nella sua testa capitale, talento e lavoro, che tutto ciò che viene prodotto è prodotto da essa e non dalla massa imponente, e sequestrerà tutto per sé. Questa sarà la fine della "pacifica democrazia" hegeliana dei berlinesi”.
Quella non fu solo la fine dei pacifici democratici berlinesi di metà ottocento – che tuttavia, al di là della “hegeleria”, con la fondamentale verità della scienza della logica che Engels e Marx riconoscevano a Hegel poco avevano a che fare. Quella è stata la fine di tutti i “progressisti conservatori” – per dirla ancora con il Marx del Discorso sul libero scambio – del giorno d’oggi, che in Italia e altrove, con la loro sposa ornata da “qualità totale”, si atteggiano a “nuovi messia” della “pace sociale”, dello “stato sociale”, e di tutto ciò che essi, “educatori a Cristo”, amano etichettare con “sociale”. Al posto di una simile etichetta andrebbe invece piuttosto scritto “coercitivamente assistenziale” e neocorporativo, dove perfino “le latrine sono disposte secondo la logica necessità” delle nuove falangi del capitale. Quella è anche la fine degli “economisti illuminati” – come li definiva ancora Marx nel Capitale – la cui piena sintonia con la pseudoparificazione neocorporativa è stata prima illustrata.
In questo senso, il neocorporativismo è il modello sociale che meglio integra il nuovo ordine del lavoro – in quanto apparentemente interclassista o aclassista, fondato sul consenso coatto, sulla rappresentazione della partecipazione come “democrazia industriale” o “democrazia economica”, sulla parvenza dell’autocontrollo di produzione e retribuzione – organizzando la centralizzazione assoluta del comando in forma di delega
30

rigorosamente fiduciaria e coercitiva. Ma l’intera costruzione economica dominante – fino alla simulata distinzione tra “economia salariale” (wage economy, la chiamano) ed “economia della partecipazione” (share economy, dicono erroneamente) – è, come si è sopra argomentato, concettualmente “corporativa”. Grazie alla ideologia prevalente – ideologia dominante, occorre dire, non certo “pensiero unico” che implicherebbe la fine di ogni dialettica della storia – tutta la quota salariale insicura e oscillante è in questa maniera subordinata al principio della partecipazione, in nome del corporativismo.
Mentre il moderno corporativismo è una dottrina politica elaborata dai teorici dello stato fascista, sulla scorta del corporativismo storico ottocentesco o addirittura medievale, che si impone attraverso la forza armata della classe dominante, il corporativismo contemporaneo, o neocorporativismo, persegue gli stessi obiettivi del corporativismo precedente con altri mezzi, apparentemente incruenti. Le forze produttive della società vengono sempre presentate come corpora, corpi, corporazioni; ma – come Marx insegna, dalla Critica della filosofia hegeliana del diritto [b, § 297] al 18 brumaio [III, VII] al Capitale [III. 49] – è una falsa astrazione considerare l’economia “nazionale”, il cui modo di produzione è fondato sul valore in forma capitalistica, quale “corpo collettivo” (comunque esso sia mascherato sotto la specie del moderno stato corporativo o neocorporativo), che lavora per i bisogni della nazione.
Perciò tale rappresentazione è da considerare una pura parvenza, necessaria solo a chi diffonde chiacchiere ideologiche sul “sistema paese” o locuzioni simili (possono stare “sulla stessa barca” sia i comandanti schiavisti, sia i guardiani con le fruste, sia i galeotti che sono gli unici a remare, obbligati con la forza, per far navigare le “galere”). Dunque, lo stato borghese moderno – che è privatizzato per destinazione capitalistica – è preposto a svolgere una funzione di mediazione, socialmente “pacificatrice”. Così esso, in generale, sostituisce e coordina gli interessi particolari in una forma corporativa moderna superiore, quale “formalismo di stato”, nel grande “corporativismo generale” dell’imperialismo che scaccia il piccolo corporativismo particolaristico. Tuttavia, anche la forma del corporativismo assume caratteri diversi a seconda che si sia in una fase di crescita o di crisi dell’imperialismo capitalistico. E in caso di crisi, per le ambiguità che essa sottende, il capitale procede a una separazione delle masse, chiamando la maggioranza al consenso per la repressione delle minoranze. Man mano che il costo sociale delle politiche neocorporative assistenziali nella crisi supera la soglia della tollerabilità e del consenso popolari, si può perciò facilmente regredire al corporativismo fascista espressamente violento.
Gli apparati sindacali definiscono erroneamente “corporative”, viceversa, le lotte meramente economiche per il salario che, al di fuori del controllo degli apparati stessi, conducono i lavoratori di determinate categorie (che appunto è corretto definire semplicemente “categoriali”, non essendo minimamente parti attive né i padroni né il governo). Simile errata nozione di “corporativismo” non ha riscontro nella storia politica e teorica. Il motivo di ciò è abbastanza chiaro. Il corporativismo, al contrario, implica infatti l’imposizione della volontà generale della classe proprietaria, padronale, al proletariato subalterno, svuotato di qualsiasi autonoma determinazione, estorcendo a quest’ultimo il consenso e la partecipazione. È più che ovvio, allora, che in questa accezione compiuta il corporativismo – in ogni sua forma storica, classica, moderna o nuova – abbia le sue radici nell’intera economia del capitalismo, e in particolare nel suo peculiare carattere di classe.
Il corporativismo basato sull’“autodisciplina” dei produttori – tutti i produttori, capitalisti in testa (si rammenti quanto dianzi scritto conformemente alle teorie economiche dominanti) – affida le funzioni di controllo agli organismi istituzionali corporativi che sono completamente in mano ai rappresentanti del capitale finanziario. Così lo stato, nell’estendere il suo “controllo” e le sue attribuzioni economiche, viene continuamente integrandosi e fondendosi con il capitale finanziario. Tutti gli innumerevoli organi, apparentemente tecnici, ma sostanzialmente dotati di ampi poteri discrezionali esecutivi, sono diretti da elementi personalmente legati ai gruppi dominanti del capitale monopolistico [cfr. Giulio Pietranera, Il capitalismo monopolistico finanziario, la Città del Sole, Napoli 1998]. È in questa maniera che opera lo “stato sociale” o del benessere [welfare state, appunto], il quale con la sua crisi ha favorito l’approfondimento della polarizzazione di classe (aristocrazia proletaria e nuove classi medie) negli stati imperialistici, rovesciandola a danno dei dominati, entro un paese e ovunque nel mondo. Tale supposta “socialità” ha permesso al capitale mondiale di passare dal corporativismo moderno (espressamente prevaricatore) a quello “nuovo”, edulcorato con il consenso estorto, apparentemente senza armi e senza “camicia nera”. La sostanza non muta, o meglio muta funzionalmente a quanto occorre per assolvere ai nuovi compiti. Entrambe le forme, autoritaria e democratica, esprimono infatti la “violenza adeguata” alla fase dell’accumulazione (crescita del capitale) o crisi (sua interruzione).
Nella “fine” delle classi consiste la natura pattizia del corporativismo in genere, e di quello “neo” in particolare. allorché il capitale riesce a estorcere un totale consenso di massa, per imporre come “norma” il proprio dominio di classe sull’intera popolazione. È la fase della crescita e dell’accumulazione di plusvalore in cui la lotta può procedere senza intoppi a senso unico, nel comando assoluto del capitale sul processo sociale di produzione e di lavoro. La “pacifica”, o pacificata, collaborazione nazionalcorporativa è il risultato di tutto ciò. Ma qualora l’eccesso di sovraproduzione di valore erompa in una crisi – che ormai da tempo ha portata
31

planetaria – lo strisciante disagio sociale si fa sempre più palese. Il potere di classe del capitale non riesce a continuare a coartare consensualmente tutte le masse popolari. Lo spirito di solidarietà – imposto dal corporativismo perché a esso connaturato e che ricorre sempre all’occultamento del conflitto insito nella lotta di concorrenza (che avviene anche tra monopoli) – viene reso selettivo dal capitale stesso.
La parvenza “democratica” del corporativismo moderno è quella che ha conferito forma adeguata al cosiddetto neocorporativismo. Smesse le vesti esteriori della violenza contro le masse, esso però, in fase di crisi, se non riesce a ridurle tutte all’inerzia, le sa dividere, riservando la repressione armata contro i ribelli, i diversi, gli “anomici” emarginati (“comunisti”, dissidenti in genere, scioperanti, migranti, razzizzati, ecc.). Per giunta, lo stato corporato scatena contro costoro l’astio delle “forze-sane”, della “maggioranza-silenziosa”, dei “cittadini” tout court ai quali vien fatto credere e dire di non sopportare più le “angherie” dei diversi. Il cammino seguito da questa versione del corporativismo, per la sorte a esso favorevole che le è stata riservata, merita pertanto una specifica attenzione storica economica.
Il dividere le masse per continuare a comandare serve oggi al capitale, colpendo duramente le parti più refrattarie e autonome dalle gerarchie del potere, per esercitare esplicitamente quella repressione di cui, comunque dissimulata, il capitale monopolistico finanziario ha ineluttabilmente bisogno. Codesto divide et impera – dal dominio imperialistico sui paesi stranieri rimbalzato sulla composizione di classe all’interno (come già insegnava Hobson) – conserva intatta l’attitudine imperialistica corporativa verso quella parte del proletariato, e della popolazione, che accede a far sì che la borghesia possa disporre della volontà dei subalterni. Chi non accetta deve subire le discriminazioni fattegli imporre col silenzioso consenso di quella parte succube della massa che costituisce il “gregge senza idee”, per dirla con Marx. Questa forma del neocorporativismo della fase di crisi ha perciò aspetti maggiormente selettivi, rispetto a quella largamente “assistenziale” assunta nella fase di accumulazione o di ripresa. Per dare a qualcuno, a qualcun altro bisogna togliere. E se l’apparenza fa credere ai più che il risultato sia favorevole alla maggioranza assopita, basterebbe fare un po’ di conti per vedere sùbito che il saldo è negativo (meno tasse dirette per tutti – precisava sempre Hobson – nascondono molte più imposte indirette, maggiori tariffe, prezzi più alti, ecc. per chiunque, tranne che per i capitalisti più ricchi).
La forma del neocorporativismo del “nuovo ordine mondiale” imposto dalla fase di crisi dell’accumulazio-ne di plusvalore è questa. Non tragga perciò in inganno l’assenza di uno scontro frontale generalizzato, qui rimane solo nel limbo della parvenza. Lo scontro esplicito, che c’è “per eccezione”, è infatti sovrastato dal “consenso coatto” estorto precisamente a quel “gregge senza idee”. Dunque, è neocorporativismo anche quello che apparentemente non è. La finzione di duelli in punta di fioretto serve solo per inficiare esteriormente l’accordo di “tavoli triangolari” delle trattative governo-industria-sindacati. C’è sempre, e in abbondanza, tra i sedicenti rappresentanti politici e sindacali dei lavoratori, chi “consente”, se non con il governo, con il potere in generale. L’importante, per la borghesia al potere, è portare dalla sua parte – con la seduzione della “democrazia”, dell’armonia e della “pace sociale” – la maggioranza delle masse espropriate di ogni strumento difensivo e disgregate programmaticamente, per poter inibire con la forza e strangolare le restanti frazioni a essa ostili.
“La collaborazione è in atto. Bisogna costruire un fronte unico dell’economia, bisogna eliminare tutto ciò che può turbare il processo produttivo, raccogliere in fascio le energie produttive del paese nell’interesse della nazione” – così aveva parlato Mussolini nel 1923. E diceva ancora che, mentre i capitalisti “utilizzano lo stato di pace sociale instaurato dal governo fascista, sarei felice domani di avere nel mio governo i rappresentanti diretti delle masse operaie organizzate”. Franklin Delano Roosevelt aveva definito Mussolini come un “ammirevole gentleman italiano”.
Roosevelt varò espressamente le politiche economiche del new deal (1933-1937) sulla scia di quelle dello stato corporativo fascista e sulla base analitica datane da John Maynard Keynes [il cui perseguimento di un obiettivo corporativo, come quello del cosiddetto “stato sociale”, fu da lui stesso riproposto privilegiatamente agli economisti nazisti, poiché – scriveva nella prefazione all’edizione tedesca della Teoria generale – esso “si adatta assai più facilmente alle condizioni di uno stato totalitario”]. Quello che preme qui rapidamente ricordare, perciò, sono i rapporti tra il moderno corporativismo fascista italiano e il “nuovo corso” [new deal], “fascista democratico” sul piano della politica economica, del corporativismo rooseveltiano. Dopo la crisi del 1929 (diminuzione tra il 1929 e il 1932 del pil del 30%, collasso del sistema creditizio, disoccupazione di massa, disagio sociale), gli Usa propugnarono l’intervento pubblico in economia, per raggiungere la “pace sociale” con la creazione e il sostegno di sindacati “legalizzati” corporativi che facessero della collaborazione la loro strategia principale.
Il neocorporativismo si presenta perciò quale risultato economico sociale e politico istituzionale nuovo delle vecchie attività di ipostatizzazione ideologica del modo di produzione capitalistico. Le novità del neocorporativismo rispetto ai corporativismi storici sono, dunque, la dimensione tendenzialmente planetaria e la natura pattizia e legale della repressione della lotta di classe. Patto e legge erano bensì presenti anche in molte versioni delle dottrine e degli ordinamenti possibili del corporativismo storico, ma solo come
32

paravento ideologico dell’esercizio illegale della violenza. Al cospetto della violenza, che è innanzitutto caratteristica invariante di tutto il potere nelle sue forme strutturali e statuali, il neocorporativismo pretende all’accettazione della coincidenza pratica di legalità e repressione. È pertanto la concezione stessa del neocorporativismo che ne risulta “elevata”. La subordinazione degli interessi del lavoro al capitale, che lo comanda e ne determina anche le direzioni economiche e politiche, continua a contraddistinguerlo anche nella fase transnazionale dell’imperialismo, ma stavolta nell’intero ordine economico mondiale e con un’interiorizzazione di massa sempre più convinta perché debellata. Il neocorporativismo contemporaneo (lo si voglia chiamare concertativo, consociativo, compartecipazione, cogestione, ecc.: co.co.co.co.co... .) è capace di assumere proteiformemente aspetti assai differenti.
Il falso “accordo” subalterno, nelle mutate vesti della “partecipazione”, o lo scontro frontale con le frange meno integrabili delle classi lavoratrici, sono ambedue modi di essere del neocorporativismo, in quanto capaci di piegare e sottomettere l’autonoma volontà del proletariato, coartando altresì il consenso della massa contro le avanguardie di lotta. Il moderno corporativismo “fascista” perseguiva gli stessi fini economici del corporativismo “democratico” in doppiopetto rooseveltiano, il quale peraltro (con rare sporadiche e saltuarie eccezioni) ha prevalso storicamente sul primo modellando il neocorporativismo.
La sindrome di Mida – crisi
La grande borghesia imperialistica transnazionale, che già ora – come proprietà di classe, di contro alla proprietà privata individuale – rappresenta la proprietà comune del capitale monopolistico finanziario è ormai costituita in larga misura come classe per sé a livello mondiale. In connessione con la costituzione di questa classe, si va consolidando sempre più quel fenomeno, già descritto da Engels e Marx, relativo alla formazione di un vasto strato sociale di nuove classi medie improduttive – assimilate socialmente alla piccola e media borghesia, ma non economicamente giacché senza proprietà delle condizioni oggettive della produzione – subalterne e perfettamente funzionali alla grande borghesia mondiale, e rispetto a essa ossequiose e servili. “Bella prospettiva” definì Marx questa trasformazione in moderna “servitù” (letteralmente, in quanto fornitrice di “servizi”) di una gran parte della popolazione lavoratrice nell’epoca dell’imperialismo finanziario e speculativo: prospettiva che rischia di essere mortale se non interviene tempestivamente un’adeguata coscienza critica.
Tutte le trasformazioni economiche, sociali e politiche, avvenute abbastanza repentinamente negli anni 1980, dopo il fracasso del decennio prima, sull’intera scena mondiale, sono conseguenza mediata dell’ultima crisi dell’imperialismo avviatasi alla dopo la metà degli anni 1960 in Usa, i l cui eccesso di sovraproduzione, che ha determinato insostenibilità dei costi e taglio della spesa, è presto divenuto mondiale. Nella contesa per il mercato mondiale, la crisi stessa non può che essere ricondotta, perciò, pur nelle successive fasi e con tutte le mediazioni del caso, a quella medesima contesa. Dunque, le date, i tempi e le cadenze dianzi indicate risalgono indietro negli anni molto più di quanto sia comunemente attribuito dalla maggioranza delle interpretazioni. Non si spiega compiutamente il quadro della grande trasformazione del potere capitalistico mondiale, se non lo si àncora agli eventi critici – “strutturali” fin dagli inizi, determinatisi appunto nella seconda metà degli anni 1960 – e non solo nella recente fase degli anni 1990.
L’eccesso di sovraproduzione irrisolto a livello planetario ha scatenato l’horror della borghesia – e appresso a essa quello delle nuove classi medie subalterne, e del proletariato da queste ultime ideologicamente guidato e sottomesso – per il prolungato ristagno dell’accumulazione di capitale su scala mondiale. Sotto questa luce, a séguito della saturazione di tutto il mercato mondiale, va letta anche la “necessaria” tendenza di trasferimento e uso del pubblico a favore dei privati, come fase della crisi, in tutto il mondo: privatizzazione e deregolamentazione. Già in occasione della crisi economica del fascismo italiano negli anni 1930, Pietro Grifone scriveva che “la perdita della ricchezza è soprattutto un fatto pubblico. La teoria, della "socializzazione delle perdite" non poteva trovare formulazione più eloquente; essa, in parole povere, sostiene questo: quando gli affari vanno bene sono i capitalisti che, soli, debbono beneficiarne; quando le cose vanno male allora è lo stato che deve accollarsi le perdite” [Capitalismo di stato e imperialismo fascista, la Città del Sole, Napoli 2002, cap.VI]. Di qui il falso mito del “ritorno al mercato”: alla parola d’ordine “più mercato” non ha corrisposto mai e in nessun posto l’altro motto “meno stato”, ma “più stato”, nel senso di un imperturbabile sostegno all’impresa e alla speculazione privata.
Si rinuncia così alla conclamata presunta funzione “sociale” dello stato; il cosiddetto “stato sociale”, sulla cui natura capitalistica di sostegno alla domanda in fase di espansione e di corrispondente taglio in fase di recessione, è fonte di molta confusione, soprattutto presso la disposizione conservatrice dei “progressisti”. Sicché, l’agire statuale – immaginato super partes – è sempre più decisamente orientato nel senso neocorporativo transnazionale. Esso tende a ottenere la partecipazione consensuale delle rappresentanza istituzionale dei lavoratori, deprivati della propria autonomia decisionale, per occultare così in forma
33

apparentemente “non violenta” la lotta di classe della borghesia, nelle diverse postazioni territoriali locali (nazionali o regionali) in cui essa agisce. Purché si riesca a lasciarsi alle spalle un’anacronistica ottica nazionale, si possono facilmente individuare i fondamentali motivi di crisi in base ai quali si è in grado di inquadrare l’attuale contesto imperialistico transnazionale. Nel quadro internazionale, sono il Fmi, la Bm e gli altri organismi sovrastatuali che continuano a fare sufficientemente bene il loro “lavoro” di centri di direzione strategica del capitale. È di primaria importanza, perciò, capire il ruolo di codesti organismi, proprio in merito alle diverse parvenze del neocorporativismo dell’ordine mondiale contemporaneo.
Dunque, al parassitismo del capitale imperialistico fa da sponda istituzionalmente lo stato, in diverse forme adeguate via via alle successive fasi storiche attraversate. Ma, come appena detto, esso è sovrastato sempre più, quasi totalmente, nella sua dimensione “nazionale”, a causa dell’operare transnazionale del mercato dei capitali. Tutti gli organismi, statuali e sovrastatuali, sono chiamati a favorire anzitutto la circolazione monetaria del capitale, a cominciare da quello speculativo. Attraverso il circuito del debito pubblico per il credito privato, con il conseguente pagamento di onerosi interessi passivi, lo stato è “privatizzato”. L’importanza degli ostacoli al fluire regolare della circolazione si denota nello svolgimento della crisi stessa, “la cui origine, e i mezzi per fronteggiarla, venivano ricercati nella sfera più superficiale e astratta di questo processo, la sfera della circolazione monetaria”; era quella scuola che a metà ottocento Marx, trattando del credito, chiamava dei “meteorologi economici”, i quali non comprendevano – ma seguitano a non comprendere, oggi come allora – che “non si trattava più di fenomeni economici isolati, ma delle grandi tempeste del mercato mondiale, in cui si scatena il conflitto di tutti gli elementi della produzione borghese”.
La crisi di liquidità, che si andava sempre più evidenziando alla fine del grande sviluppo postbellico mise in luce la mancanza di “fede” nel capitale Usa. “Al momento della crisi si ha la pretesa che tutte le cambiali, i titoli, le merci debbano essere a un tratto e contemporaneamente convertibili in moneta bancaria e tutta questa moneta bancaria a sua volta in oro. Come carta l’esistenza monetaria delle merci ha soltanto un’esi-stenza sociale. È la fede che rende beati: la fede nel valore monetario come spirito immanente delle merci, la fede nel modo di produzione e nel suo ordine prestabilito” – scriveva Marx, nel Capitale [III.35], in polemica contro i “monetaristi” della sua epoca. È la sindrome di Mida, a cui l’oro non può servire a niente.
Da qui proviene altresì quell’altalenante affarismo e panico, contagioso anche per l’incosciente senso comune dei “pesci piccoli” delle masse, da parte degli speculatori finanziari, affogati nel capitale fittizio (quel capitale, cioè, espresso soltanto in titoli cartacei, azioni o obbligazioni e loro cosiddetti “derivati”, senza necessità di alcun corrispettivo nel sistema produttivo). Di tale capitale monetario, come in ogni fase di difficile fuoriuscita da una crisi che ristagna, ce n’è una pletora, tanto maggiore quanto più sia caduto il tasso di profitto industriale. La moneta mondiale in giro per il pianeta si presenta perciò, in una simile fase, in forma molto frantumata. Ma codesta è la sua forma necessaria. L’eccesso di liquidità da questo lato corrisponde, dall’altro, alla ricerca di liquidità da parte del capitale industriale, che è costretto a restare inattivo per la carenza di prospettive di valorizzazione. La conflittualità tra le due forme di capitale è altrettanto necessaria, senza per ciò stesso turbare l’immanente unitarietà contraddittoria del capitale stesso in tutte le sue possibili forme di esistenza: si tratta, infatti, di una contraddizione interna al capitale, e non antitetica. Essa comporta antagonismo di tipo concorrenziale tra i molti capitali nelle loro diverse forme di funzione (capitale produttivo, merce, denaro) ed è immanente alla determinazione medesima di capitale.
Tale frantumazione monetaria, con al massimo tre o quattro valute “pregiate” a guidare le danze, si palesa in tutta la sua evidenza. Il tentativo di soluzione di codesta contraddizione si traduce nella lotta di concorrenza per la spasmodica ricerca, da parte del capitale in generale nelle sue molteplici articolazioni, di far denaro – più denaro possibile, in qualsivoglia maniera – senza passare attraverso la regolare mediazione della merce, ossia senza la fase della produzione. È il momento della speculazione che, come ricordava Henryk Grossmann, si avvicenda alla valorizzazione produttiva – non le subentra in antitesi – nella fase di più profonda discesa della crisi da sovraproduzione. Gli agenti del capitale che ne sono protagonisti sono perciò esattamente gli stessi, in una funzione integrata per la loro sopravvivenza e riproduzione. In ciò si mostra la “sublimazione” dell’imperialismo, il suo stadio di parassitismo spesso definito “putrescente”.
Dovrebbe far riflettere la circostanza per cui gli Usa in crisi abbiano estorto la fiducia internazionale, imponendola e costruendola sulla forza, e tenendola ormai solo mediante la frapposizione fittizia di un “muro di carta” tra l’economia reale e l’economia monetaria. Ma questa gestione della crisi, monetaria e soprattutto speculativa, è stata efficace almeno sul piano ideologico, tanto da riuscire a occultare, o quanto meno travisare, le cause e le origini reali della grande ultima crisi mondiale irrisolta da oltre trent’anni – concedendo volta a volta spazio a pseudospiegazioni.
Si è girovagato a tutto campo dai cosiddetti shocks petroliferi, con tanto di inflazione additata come dèmone dotato di vita e volontà propria, alle questioni del debito estero, mai proposto dal suo versante dialetticamente antitetico, qual è quello del “credito”; dalle geremiadi sul presunto eccesso del costo del lavoro per unità di prodotto [clup], poi regolarmente smentito nei fatti, dall’impoverimento delle masse delle
34

popolazioni mondiali, e nei principi, da constatazioni come quella di Taiichi Ohno secondo cui “il segreto del successo sta nel pieno controllo dell’impresa sul sindacato”; fino alle artatamente instabili frequenti oscillazioni del corso dei cambi, come aspetto fenomenico, quindi tecnico e secondario, della questione, e al conflitto tra le aree valutarie da intendere, come si sa, in senso non territoriale geografico, ma nella loro reale causa quale problema strutturale.
Le pseudospiegazioni fenomeniche, sopra appena esemplificate, non hanno così tardato a trasformarsi in “luoghi comuni”, isolati dal contesto: le crisi petrolifere (1973-1979, prima e seconda, con una lamentevole reiterazione nel 2004, quando i prezzi in termini di potere d’acquisto costante sono comunque restati al di sotto di quelli di venticinque anni prima), lo Sme e Maastricht, il piccolo-è-bello, la competitività e il libero-mercato, il boom reaganiano, il postindustriale e il postfordismo, prima i “miracoli” e poi il panico di borsa, il crollo del muro di Berlino, la moneta unica europea, il terrorismo ecc. Tali descrizioni rimangono tuttavia, per ripetere Brecht, solo “giustificazioni” superficiali, non assurgendo neppure a “spiegazioni” parziali; esse sono come appese nel vuoto, se non si fa riferimento alla durissima lotta interimperialistica che ha preceduto quegli eventi.
Praticamente viene invece messa la sordina a diverse constatazioni “ufficiali”. Il ritmo di crescita media della produzione dell’intera economia mondiale è dimezzato da una trentina d’anni, il che significa che anche l’occupazione per ottenere un prodotto così ridotto per un lungo tempo non sia potuta che crollare, e in misura anche maggiore in conseguenza delle ristrutturazioni tecnologiche. Secondo i dati della Bm, l’incre-mento del pil pro capite mondiale si è ridotto a un misero +1%, dal quasi +4% (con un’apparente risalita nel nuovo secolo, solo per lo straordinario balzo capitalistico di Cina e India – quasi la metà del mondo!).
La polarizzazione sociale registra un impoverimento mondiale crescente che ha ridotto alla fame più di un miliardo di persone. Inoltre, poco meno della metà della popolazione del pianeta “vive” – sopravvive – con un dollaro al giorno e possiede la stessa “ricchezza” delle sole prime 500 famiglie del mondo intero; quindi, se i beni di queste ultime rifluissero a quei più di due miliardi e mezzo di persone, esse disporrebbero nientepopodimenoche di ... due dollari al giorno, quindi senza alcun futuro riproduttivo! Né si tiene presente che tutti i beni prodotti e disponibili sul mercato mondiale (ammesso e non concesso che possano bastare già oggi per far vivere sei miliardi di persone) sono attualmente ottenuti nel e col modo di produzione capitalistico, ossia con orari prolungati, ritmi insostenibili e condizioni di lavoro insopportabili: che, se – per necessità e scelta sociale – si volessero abolire, abbatterebbero drasticamente la produzione stessa. E così da capo, ecc., e allora via attutendo qualsiasi clamore sconveniente.
La crescente sincronizzazione tra i diversi paesi della crisi mondiale a impose pertanto una strategia di risposta dell’imperialismo transnazionale che doveva perciò procedere di pari passo con l’acuirsi delle contraddizioni interimperialistiche, più tra le diverse frazioni del grande capitale monopolistico finanziario che tra i paesi stessi. Questi ultimi, adattando le preesistenti forme statuali nazionali, non facevano altro – e così hanno continuato sempre più a fare – che rappresentare le mediazioni tra quelle diverse frazioni di capitale, secondo il rispettivo peso specifico “nazionale” di provenienza, fosse essa locale o estera ma stanziale su quel particolare territorio. Fu in quei frangenti, infatti, che si cominciò a parlare del progetto del nuovo ordine mondiale [il ricordato “piano” predisposto tra il 1974 e il 1975 da Henry Kissinger, all’epoca segretario di stato Usa – l’antica parola d’ordine corporativa nazionalsocialista era Neue Ordnung].
Sicché, fin dal periodo 1975-80 le modifiche, poste in atto dalla frazione imperialistica dominante, cercarono di rivestire un carattere organico alle nuove esigenze di riproduzione e valorizzazione dell’intero capitale mondiale: profondi ed estesi processi di ristrutturazione tendevano e tendono tuttora verso un sistema di accumulazione basato sulla ripresa di dominio sulla rigidità del mercato del lavoro, tutto e sempre nel nome notorio della “flessibilità”, da una parte attraverso investimenti a elevata composizione organica e, dall’altra, mediante un decentramento dell’attività produttiva della grande industria verso aree economiche esterne (esternalizzazione, subfornitura, ide, ecc.). Fu in quello stesso periodo e contesto, perciò, che due tendenze, già in agguato alla fine degli anni 1960, si rafforzarono e si amplificarono: l’aumento dell’inflazione e della disoccupazione. Così, il precipitare della crisi a livello mondiale ha ridisegnato contemporaneamente la ripresa del comando assoluto del capitale sul lavoro, con la nuova organizzazione e divisione internazionale del lavoro, su scala planetaria, di cui si è detto, nelle spoglie del neocorporativismo transnazionale.
Le politiche restrittive sono quindi conseguenza di uno stato di crisi previa, di ben più remota data e assai duratura. In tutta questa lunga e irrisolta fase, il conflitto di classe è stato soprattutto agìto dalla borghesia, col proletariato “in sonno”. In questo senso, a es., l’inflazione non ha mai costituito per il padronato un “pericolo” di per sé – nel senso di una sciagura inesorabile o di una forza della natura – bensì è sempre stata governata quale precisa strategia di lotta dalla frazione predominante della borghesia mondiale. L’inflazione (come l’eccedenza di popolazione lavorativa) ha rappresentato il sintomo di una forte tensione del processo, carente, di accumulazione del capitale, per il quale, attraverso di essa, le diverse frazioni del capitale si sono battute anche tra loro. Ma la borghesia mondiale, appunto, la può derubricare – insieme alle altre
35

contraddizioni – non appena abbia eliminato non solo la resistenza proletaria, ma altresì quella dei propri “fratelli nemici” più deboli; ossia, quando la frazione dominante del capitale imperialistico, che necessita di condizioni più stabili, può cominciare una ripresa, sia pur moderata e parziale, del processo di accumulazione.
D’altra parte, la formazione del mercato mondiale – che, fino a un certo punto, il sistema capitalistico ha il compito storico di costituire – si presenta necessariamente, proprio per le relazioni universali che stabilisce a livello internazionale, anche come fondamento materiale di una potenziale nuova forma di produzione, quale che sia questa forma: il diverso agire umano può pervenire a una o a un’altra, a es., al socialismo di transizione o a un nuovo dispotismo corporativo. Ma è comunque certo che le eruzioni violente della contraddizione del mercato mondiale, ossia le crisi, accrescano gli elementi tendenziali di disfacimento del vecchio sistema della produzione sociale. Il mercato mondiale del capitale costituisce allora, insieme, la premessa e il supporto dell’intera trasformazione sociale, e le sue crisi rappresentano il sintomo generale del superamento della premessa e la spinta all’assunzione di una nuova forma storica. Esso perciò, sostiene Marx, si pone già come forma di transizione verso un nuovo sistema di produzione.
La maschera dei derivati – speculazione
“Lo scopo delle banche è di facilitare gli affari. Affari e speculazione sono così strettamente collegati che è difficile dire dove finisca l’affare e dove cominci la speculazione. Dovunque esistono banche, si ottiene il capitale con più facilità e a minor prezzo. Il buon prezzo del capitale favorisce la speculazione, allo stesso modo che il buon prezzo della carne e della birra favorisce l’ingordigia e l’ubriachezza”. Queste chiare parole che il banchiere inglese James Gilbart scriveva nel lontano 1834 illustrano al meglio il carattere di “ingordigia e ubriachezza” insiti nella speculazione, nel “normale” corso degli affari. Il fraintendimento dell’operare della speculazione stessa, in relazione alla sua forma monetaria, bancaria e borsistica, sovente scambiata con gravi margini di erroneità con quella “finanziaria”, è tipico della superficialità dell’economia borghese, che tuttavia domina anche nella cosiddetta “sinistra”. Già Marx, affrontando le tematiche della superficie del mercato dei capitali, criticava le “meteorologie” monetarie e speculative borsistiche, che ne rappresentano il culmine, fino alle forme del capitale fittizio. Per comprenderle meglio è bene aver chiara la separazione tra capitale monetario e capitale operante, le loro peculiari forme, e la “rappresentazione” mistificatoria che ne dà l’ideologia dominante (e, a sua imitazione, quella dominata).
Lo smisurato odierno sviluppo dei cosiddetti nuovi “strumenti finanziari”, con la loro altrettanto smisurata “volatilità” è fonte, a un tempo, delle tendenze neo-monetariste della moderna meteorologia economica e delle forme monetarie delle ricorrenti crisi. Per analizzarla occorre porre correttamente i termini della formazione del capitale “fittizio” e dell’emissione dei titoli che lo rappresentano: se siano “emessi assennatamente oppure no, se rappresentino prodotti o non rappresentino nulla”. È impossibile precisare in quale misura tali titoli provengano da transazioni reali, ossia da vendite e da acquisti effettivi, e in quale misura essi siano creati artificialmente: così scriveva nel 1840 un altro banchiere britannico dello Yorkshire, Leatham, il quale chiamava col nome – oggi assai “spettacolare” – di fiction l’emissione di “cambiali di comodo” in sostituzione di altri titoli. Appunto così si crea il cosiddetto capitale fittizio mediante l’emissione di “puri e semplici mezzi di circolazione”, che hanno per scopo di trasferire tali titoli di credito: oggi si chiamano “titoli derivati”. I banchieri diventano così gli amministratori generali del capitale monetario. Tuttavia, assieme ai cosiddetti investitori istituzionali (società finanziarie e di assicurazione, gestori di fondi di investimento e di fondi pensione, fino alla raccolta della “spazzatura” [ junk bonds] di borsa), le grandi banche dell’imperialismo transnazionale sono sempre più tentate anche a giocare d’anticipo sull’economia reale della produzione.
Il concetto e la parola stessa “speculazione” significano proprio questo: che la quotazione dei titoli non è determinata dal provento “reale” dell’attività che essi rappresentano ma, appunto, da una valutazione “speculativa” –capacità di far congetture – sul provento atteso e previsto in “anticipo”. Tutto il movimento autonomo del capitale che si trasforma in capitale fittizio, nasce da simili anticipazioni. Lo snodo dell’intera faccenda sta dunque proprio nel capire quale parte dei titoli emessi corrisponda ad attività produttive reali, valori effettivamente esistenti, proprietà di capitale operante, e quale altra parte invece sia solo una finzione, una “replica” più volte ripetuta di quegli stessi valori effettivi, precedentemente rappresentati, sulla cui base si costruisce l’intero castello di carta. L’unica cosa che perciò gli operatori di borsa capiscono, a questo proposito, è che questi titoli sono “assolutamente regolari, purché si mantengano entro certi limiti”. Ecco, occorre capire i limiti: quante più repliche si fanno della fiction, quanti titoli facciano aggio e “leva” su una sola quantità effettiva di valore e non rappresentando nulla.
Anticipando operazioni su titoli in misura di gran lunga più estesa di quanti siano i mezzi liquidi disponibili, si sottoscrivono titoli per i quali il denaro liquido è sufficiente appena a coprire i primi
36

versamenti, “scommettendo” sul futuro. Un tal gioco d’anticipo è un vero e proprio gioco d’azzardo. Il flusso dei pagamenti si arresta, il tasso ufficiale di sconto e il sistema dei tassi di interesse si alza, i titoli diventano negoziabili a tassi spaventosi, che si possono definire di “usura”, o non sono negoziabili affatto, la quotazione del loro “valore” nominale crolla, proprio perché non rappresentano alcun “valore”, non rappresentano nulla. Il generale arresto del flusso dei pagamenti sui titoli provoca la bancarotta di quanti, piccoli sprovveduti e medi o grandi avventurieri, hanno scommesso ripetutamente su un unico, limitato, valore reale già considerato come “pegno” per troppe diverse persone: è il momento del “panico” di borsa. Ma – avverte Marx – questo capitale non ha una duplice esistenza (poi moltiplicata a dismisura). Se il movimento autonomo della quotazione di questi titoli di proprietà consolida l’apparenza che essi costituiscano un “capitale reale”, la maggior parte del capitale monetario di questo tipo (presso banche, investitori istituzionali, ecc.) è puramente fittizio e la quotazione dei titoli che lo esprimono viene regolata indipendentemente dal valore del capitale effettivo che tali titoli rappresentano.
Questa figura del capitale monetario genera le concezioni più insensate, al punto che gli operatori finanziari giungono a concepire quei titoli, e tutti i loro cosiddetti “derivati”, come merci – nuovi “prodotti” finanziari e bancari, dicono loro. E difatti essi si trasformano in “merci” nella misura in cui il loro prezzo ha un movimento e un modo di fissarsi suo proprio. Il loro “valore” di mercato differisce dal loro “valore” nominale indipendentemente dal cambiamento di valore del capitale effettivo. Si vende ad altri il mero titolo di proprietà, il certificato di credito, alle condizioni stabilite dal loro prezzo di mercato La formazione di capitale fittizio rientra nella figura della “capitalizzazione”. Si capitalizza, cioè, ogni flusso di reddito regolare e periodico, in base al tasso medio di interesse, come se provenisse realmente da un capitale dato in prestito, anche quando così non è, e tutti ciò è e rimane illusorio.
Ma, per colui che acquista un titolo di proprietà che prometta tale reddito come “interesse”, esso rappresenta giuridicamente il suo “capitale”, e si consolida l’idea che “rappresenti” il capitale come un automa che si valorizza per se stesso. Dunque, tutti i titoli che si riferiscono alla parte fittizia del capitale monetario non sono in realtà che un’accumulazione di diritti, titoli giuridici, sulla produzione futura e da essa separati. Il loro valore monetario non costituisce capitale in senso proprio, ma agisce infallibilmente come il mezzo più efficace per l’accentramento dei patrimoni monetari e finanziari. Il crollo delle quotazioni di borsa dei titoli del capitale fittizio non esprime un effettivo arresto della produzione e l’economia reale non risulta impoverita di un centesimo in seguito allo scoppio di queste “bolle di sapone di capitale monetario” nominale, giacché la crisi reale è avvenuta già molto prima, anche qualora non si sia completamente palesata.
Dunque, la crisi reale ha un’“apparenza monetaria”. Scriveva Marx [C. III,30] che “l’impresa appare sempre quasi eccessivamente sana proprio immediatamente prima del crollo. La prova migliore viene fornita dai rapporti nei quali tutti i direttori di banca, i commercianti, in breve tutti i competenti invitati a testimoniare, si congratulavano vicendevolmente per la prosperità e solidità degli affari – proprio un mese prima che scoppiasse la crisi. E, fatto curioso, lo storico della crisi fa rivivere ancora una volta questa illusione. Gli affari sono sempre sanissimi e il loro svolgimento progredisce a un ritmo favorevole fino a che il crollo avviene tutto in una volta”. Come i ciechi di Brügel l’umanità intera marcia – senza vedere – incoscientemente verso il precipizio, e a comportarsi così non sono tanto e solo le banche centrali e le borse americane europee e asiatiche (ché è il loro sporco mestiere).
Questa voragine non riguarda esclusivamente l’economia; la crisi irrisolta ha enormi implicazioni sociali e politiche in senso proprio, ma colpisce anche la natura a causa del collasso planetario immanente. È ogni giorno più evidente come i cosiddetti “esperti” neppure concepiscano l’immensa portata del crollo annunciato dell’economia Usa e in genere di tutta l’economia mondiale del capitale, ormai orientata sulla deriva della sua figura fittizia e pertanto della pura speculazione. La drammatica crisi della situazione economica e sociale è pari solo all’irreversibilità del baratro che la natura ha aperto davanti al cammino dell’umanità. La cecità è pressoché totale e l’incoscienza non è da meno. Sia la pseudo-sinistra, e anche la presunta sinistra di classe, sono così lontane dal marxismo da ignorare la questione.
“La crisi non è ancora finita”!, scoprono con enorme ritardo gli addetti ai lavori. Perfino Draghi – come presidente del fondo per la stabilità finanziaria – ha capito che “il sistema ha accumulato un debito eccessivo i cui rischi e le cui dimensioni non sono stati correttamente valutati”. Molti hanno chiuso gli occhi davanti alla voragine – definendo “psicologica” la crisi – per non volerla vedere, come se essa non ci fosse. Pur col ritardo accumulato, però, si stanno spaventando tutti, agenti teorici e pratici del capitale; tuttavia se non sono travolti dal loro stesso panico fanno finta di niente, e cercano mezzucci per scaricare gli enormi oneri reali sulle popolazioni sparse per il pianeta. Dunque, gli esperti – dopo aver fomentato tutta la criminalità finanziaria possibile – si rifugiano nel dire che c’è stata un’eccessiva disinvoltura nella valutazione del rischio. Strumenti della deriva creditizia, denominati quali “credito strutturato” [operazioni speculative, mascherate come “protezione” dei depositanti in condizioni di sicurezza, in realtà per dare mano libera alle stesse istituzioni finanziarie in borsa e alle banche] si riferiscono alla natura delle garanzie per le attività
37

“fuori bilancio”, per le quali è richiesto un rafforzamento delle riserve patrimoniali data l’esposizione creditizia che tutto ciò comporta. Il vecchio sogno di una parte padronale di “regolare” il capitale, programmarlo, si riaffaccia al cospetto di ogni difficoltà insuperabile.
Cionondimeno il Fmi, nel panorama sulla stabilità finanziaria, ha presto stimato la perdita complessiva (soldi ... “bruciati”!?) di quella impropriamente chiamata “crisi finanziaria” in 1 mmrd $ [1.000.000.000.000 $! (millemiliardi di dollari), cifra a dodici zeri, per i più incomprensibile], che è più corretto dire “crisi monetaria”. I “teorici” del capitalismo asseriscono che ... “l’impatto della crisi della finanza si trasmette all’economia reale”: non il contrario. Con tutto ciò continuano a chiamarlo liberomercato! È tutto il capitale mondiale, ma soprattutto a cominciare da quello a base Usa, che si è rifugiato – dal periodo del monetarismo, fino agli inizi degli anni 2000 e della fandonia della “nuova economia” – nella pura speculazione. Con la grande crescita di ogni sorta di “derivati”, esso ha cercato di occultare la crisi reale da sovraproduzione che risale a fine anni 1960. Quello che è falsamente detto “nuovo capitalismo”, cioè, mira solo a raccogliere profitti senza badare alla produzione; l’aumento “formale” contabile del pil in Usa fu dovuto ai consumi privati a debito, ma non alla ripresa della produzione reale.
Il capitale fittizio è riuscito unicamente nell’intento di imbellettare la propria ricchezza con enormi trasferimenti dalle masse popolari all’1% dei più ricchi del mondo: questa è stata l’operazione dei derivati, mentre tutti gli indici reali (produzione, investimenti, occupazione, salari, ecc.) continuano ascendere, sotto i livelli di quarant’anni prima. In dieci anni le acquisizioni di titoli (primari ma soprattutto derivati) sono passate da meno di mille miliardi a quasi 4 mmrd $. Si può dire che i derivati siano nati da obbligazioni, azioni e scambi tradizionali. Senonché essi hanno raggiunto e superato già inizialmente i 300 mmrd $, stimati almeno sei volte di più delle transazioni effettive (pil), e poi oltre. Molto grosso modo funzionano così: le finanziarie di vario genere prendono a prestito da un intermediario i titoli delle imprese da conquistare le quali, per provare ad allargare i loro affari, si indebitano a lungo termine, rischiando fallimenti. È un “movimento senza fine” scrisse Marx, che accade anche laddove come “nel capitale produttivo d’interesse la circolazione si presenta abbreviata, si presenta nel suo risultato, senza la mediazione [della produzione di merce], in stile, per cosi dire, lapidario, come denaro che equivale a più denaro, valore più grande di se stesso” [C, I.4].
La sovraproduzione, gli investimenti netti, i profitti crescono e quindi la formazione di capitale è in declino dalla fine degli anni 1960. I salari orari in Usa sono al livello del 1979, abbassati per cercare di recuperare i profitti in calo e spostare la razzìa delle entrate sul capitale fittizio, sulla speculazione, e non per mezzo della produzione divenuta impossibile. Il sedicente nuovo capitalismo “premia” gli speculatori posti al di sopra dei dirigenti operanti, e i “finanzieri” sopra al capitale produttivo; codesto “nuovo capitalismo” è sempre più transnazionale. Nella storia quando uno stato fa sì che la propria base industriale sia decimata (attraverso “giochi” sulla produzione come chiusura di fabbriche, esternalizzazione e subfornitura, e finanziari come i “paradisi fiscali” o pure attività offshore) rimane solo l’appoggio alla bramosia delle proprie élite criminali. I prestiti ipotecari e i mutui, che hanno avuto inizio in tangibili operazioni di compravendita di case, si sono propagati rapidamente in una spirale di bolle speculative e frenesie di mercato basate su aspettative irreali: scelte avventate, irresponsabilità fiscale, comportamenti criminosi, ecc. al grido: “bramosia è bello!”.
Per questo fine gli agenti del capitale finanziario fittizio stipulano un’“assicurazione” su un investimento per il quale scommettono che aumenti, prima che esso scenda di nuovo. Ma se la speculazione va male i giocatori d’azzardo della speculazione si dileguano. Essi “distruggono ogni cosa sulla loro strada, come le tèrmiti”, portando alla rovina coloro (pensionati, lavoratori, piccoli cosiddetti risparmiatori, ecc.) che si affidano ai loro “consigli”. I derivati sul debito ingrandiscono così a dismisura la “leva” (detta in linguaggio anglofono leveredged buy out) delle acquisizioni per carpirne quote future sul titolo sottostante, che man mano diventa sempre più un fittizio prestito secondario (a es., si stima che per ogni barile effettivo di greggio trattato ce ne siano duecento “scommessi” sulle contrattazioni future: è la speculazione tramite derivati; sono analoghe le speculazioni sui cereali, pane e pasta, ecc.). Tali “leve” speculative fruttano centinaia di milioni di dollari non solo agli azionisti di simili “imprese” finanziarie di predazione (bande di speculatori detti, appunto, “predatori”) ma anche ai dirigenti.
Per questi eufemisticamente si parla di premi di ... produttività: ai meglio pagati venti dirigenti Usa, tutti insieme, vanno ogni anno circa 660 mln $ (cioè in media più di 30 mln $ ciascuno), contro uno stipendio medio annuo di un impiegato stabile di 30 mila $ – più di mille volte, ossia mille anni di lavoro per uno o pure mille lavoratori come un solo dirigente! L’azione dei fondi di investimento (fondi pensione, assicurazioni, fondazioni o singoli danarosi) compra, con il pretesto di dare finanziamenti, imprese in crisi di liquidità – sottovalutandole e togliendole dalle quotazioni in borsa per sottrarle alla conoscenza di potenziali acquirenti – prosciugandone le casse e appropriandosene (la suddetta forma di centralizzazione per acquisizione). Questo tipo di “fondi” è fuori controllo, senza osservatori e sorveglianza, e anzi spesso ricevono sussidi e facilitazioni fiscali; rientrano qui i mutui immobiliari edilizi, secondari: quindi le banche
38

presentano il conto ai loro mutuatari “scrausi” per trovare il contante a esse mancante. Molte banche e altre istituzioni finanziarie hanno obblighi di pagamento largamente superiori alle loro riserve alle quali hanno immediato accesso. In Usa le grandi banche sono arrivate a prestare fino a 30 volte il valore delle proprie riserve, sostanzialmente così “falsificando”, come si spiegherà tra breve, il denaro prestato.
Tutto ciò non precorre altro che l’impossibilità per i mercati creditizi di funzionare “correttamente”, secondo i dettami del “nuovo” imperialismo transnazionale fittizio. Le operazioni di leva speculativa sul futuro sono diminuite almeno di sei volte, segno che gli utili attesi sono praticamente spariti, precipitando verso zero, ma in preparazione di nuove “bolle”. La crisi dei derivati “scrausi” immobiliari, e simili, è dunque soltanto il catalizzatore di una crisi più vasta che influisce ormai su tutti gli attivi finanziari usamericani, per lo spostamento delle banche dal prestito all’attività speculativa nei fondi “chiusi” di investimento, che si dibattono per non fallire, e si fanno quotare in borsa verosimilmente per “socializzare” le perdite future piuttosto che dividere gli utili in corso.
Per Marx, 150 anni fa, “il sistema creditizio di questi rispettabili banditi, ai quali si uniscono i finanzieri e gli speculatori di borsa, i potenti prestatori di denaro, e gli usurai che pullulano attorno a essi, rappresenta un accentramento enorme e assicura a questa classe di parassiti una forza favolosa, tale non solo da decimare periodicamente i capitalisti industriali, ma anche da intervenire nel modo più pericoloso nella produzione effettiva – e questa banda non sa nulla della produzione e non ha nulla a che fare con essa” [C. III, 33].
L’ultima istanza – aree valutarie
Ebbene, le contraddizioni sono reali, prima che valutarie; ma, come in ogni crisi, i fenomeni monetari vengono alla luce prima della loro stessa causa che, in fondo, è solo l’eccesso di sovraproduzione di valore (ossia, come spiegato, l’eccesso di produzione di plusvalore, da ordinario divenuto patologico), sì che l’ef-fetto monetario stesso venga da molti equivocato con la causa stessa, il che non è mai. Infatti, mentre la crisi da eccesso di sovraproduzione non si era ancora palesata, tanto che perfino la maggioranza dei critici-di-sinistra tende ad ascrivere l’anno di inizio di quella crisi al 1973 (... il primo shock petrolifero, al solito, dimenticando tutto il resto), tutti i vari eventi di carattere più o meno monetario già si susseguivano a ritmo incalzante. Questi ultimi hanno accompagnato il collasso del sistema di Bretton Woods: ufficialmente dal 1971, ma anticipato dalla demonetizzazione dell’oro nel 1968 e, ancor prima, nel 1965, dall’avvio lento ma progressivo del processo inflazionistico dei prezzi Usa e, quindi, mondiale. In quelle circostanze – e anzi a partire dal 1958 allorché le monete europee cominciarono a emanciparsi dall’invasione dei dollari spostandosi sull’oro e ratificando tardivamente la loro convertibilità – fu proprio nel 1965 che la Francia gaullista corse, contro la prepotenza mondiale della moneta Usa, all’accaparramento di riserve auree e uscì dalla Nato.
Gli esiti di quel collasso – e le vere cause reali che l’hanno infine determinato – testimoniano tutt’oggi della durissima lotta intercapitalistica, ancora in corso con aspetti sempre più virulenti, che ha portato allo sgretolamento e alla ridefinizione del sistema di potere economico e politico del dopo guerra fredda, un po’ ovunque, dal Giappone all’unificazione della Germania, dalla “disunificazione” di Urss, Jugoslavia e Comecon in genere, alla separazione armata di Israele e Palestina, agli smembramenti aggressivi di Afghanistan e Irak, e così via rimescolando carte politiche e carte geografiche, in nome dell’economia del capitale. Gli assetti di potere internazionale basati sui rapporti di forza emersi dalla II guerra mondiale avevano fatto il loro tempo. Tuttavia, fin dagli anni 1980, di fronte alla caduta degli investimenti e alla capacità produttiva inutilizzata, sancite dalla crisi del mercato mondiale, l’imperialismo transnazionale confermava la propria irrequietezza per il mancato raggiungimento di un equilibrio rispetto alle esigenze di riassetto della divisione internazionale del lavoro. Mancando il ristabilimento di un equilibrio reale del capitale mondiale, non può neppure stabilizzarsi una parità monetaria (e tanto meno una fissità nel corso dei cambi).
Nel senso della periodizzazione causale seguita, e qui riproposta riassuntivamente, conviene pertanto prescindere dal riferimento allo “spettro” della grande crisi del 1929, da molti evocato a séguito di recenti crolli borsistici. È molto più significativo, invece, il confronto dell’oggi con la grande depressione del XIX secolo, allora sotto l’egida del nascente imperialismo, di lunga durata dal 1867 al 1896 [con una curiosa coincidenza di cadenze un secolo dopo, dall’incubazione iniziale a partire dal 1867 fino all’eruzione violenta nel 1873 (anche allora con uno spostamento in avanti – proprio il ’73! – della data iniziale della presunta causa agente), una ricaduta intorno al 1878-79, poi una breve ripresa culminata intorno al 1883, una nuova recrudescenza della crisi dal 1890, fino al passaggio di fase intorno al 1896]. Quella crisi depressiva caratterizzò l’inizio del crollo del dominio britannico, il passaggio all’imperialismo monopolistico e la tortuosa e travagliata ascesa del capitalismo Usa. Ossia, le cause economiche della sovraproduzione, di
39

rilevanza concettuale, hanno attraversato tempi di distruzione e ristrutturazione del capitale su scala mondiale, necessariamente prolungati.
Lo stesso periodo storico fu anche segnato da moltissime fasi politiche intermedie, tutte sotto la medesima insegna: guerra civile di secessione in Usa, restaurazione Meiji in Giappone, guerra franco-prussiana, Comune di Parigi, unificazione tedesca con Bismarck, guerre di indipendenza e unità d’Italia, per non dire della preparazione del futuro Commonwealth britannico sulla base dei cosiddetti dominions coloniali dell’“impero” in prospettiva della prima guerra mondiale, della formazione del movimento sindacale e partitico e socialista, della risposta cattolica con la “dottrina sociale” della chiesa, oltre che di altri episodi mondialmente minori ma non meno significativi. Quei periodi furono tutti accompagnati da fenomeni industriali e commerciali, oltre che monetari, la cui somiglianza con la fase attuale può sembrare straordinaria.
I ricordati fatti di questa storia pluridecennale della crisi irrisolta indicano chiaramente anche le categorie della crisi stessa, da cui emergono gli elementi per spiegare la conflittualità tra le aree imperialistiche: sovraproduzione eccedente, caduta del tasso di profitto, concorrenza, hanno cominciato a segnare gli anni 1960; arresto dell’accumulazione, riproduzione della sovrapopolazione lavorativa di riserva, in tutte le sue forme (e non solo della disoccupazione in senso keynesiano), precedettero poi la ristrutturazione della seconda grande rivoluzione industriale dell’automazione del controllo, a partire dagli anni 1970; centralizzazione finanziaria ed espropriazione dei capitali dispersi, in carenza di nuova accumulazione (investimenti netti), caratterizzarono successivamente il “monetarismo” degli anni 1980 (debito estero, acquisizioni, speculazione, fondi di investimento, operazioni di borsa, ecc.); allargamento potenziale e spartizione del mercato mondiale furono la conseguenza che si è protratta nelle forme della guerra economica, a segnare l’avvio degli anni 1990; la turbolenza pandemica sta caratterizzando i conflitti interimperialistici, anche bellici “per interposta persona”, spingendosi fino nel XXI secolo. Tutti quei fatti rispecchiano oggi, come si vedrà, lo scontro economico tra valute (soprattutto area del dollaro e area dell’euro, piuttosto che Usa e Ue o America ed Europa).
La “superficie” rappresentata dalle crisi monetarie (borsistiche in particolare) può così essere agevolmente inquadrata in tale quadro, purché si abbia la capacità di analizzare la stretta connessione tra investimenti diretti all’estero e investimenti speculativi di portafoglio, questi ultimi soprattutto da parte dei cosiddetti “investitori istituzionali” nel capitale volante [detto flying capital]; ciò in quanto codesto fenomeno borsistico avviene sostanzialmente con l’appoggio degli stati (o dei sovra-stati) attraverso politica fiscale e interventi di “ultima istanza” da parte delle banche centrali, sotto l’egida delle politiche di “aggiustamento strutturale” guidate a livello internazionale da Fmi e Bm, e ora anche da Omc. Da tutto ciò prende quota se possibile anche una collusione – nella permanenza di una collisione tendenziale interimperialistica, che pur sempre rimane come “rumore di fondo” – tra le principali “aree” delle valute imperialistiche (in particolare, appunto, tra dollaro Usa ed euro Ue), e più in particolare ancora tra alcune fondamentali “catene transnazionali” inanellate nelle filiere del mercato mondiale stesso.
Quando i bollettini di borsa “soffrono”, perché lamentano e riflettono il precario stato dell’economia, ciò vuol solo dire che mancano ancora le condizioni per il riassetto generale dell’accumulazione mondiale. Ovvero, per meglio dire, quando i padroni sollevano “in codice” il falso problema della mancanza di liquidità per l’accumulazione, unitamente alla pletora di capitale monetario, facendo intendere che il denaro si sperda per altre vie, nei “buchi neri” dei bilanci statali, significa “in chiaro” che i tempi e i modi per la ripresa della produzione di plusvalore risultano ancora inadeguati. Su queste basi, il processo continuo di conflittualità irrisolta genera il protezionismo delle legislazioni antimonopolio e commerciali, in chiave di difesa dei capitali provenienti dalla propria “base nazionale”. Così, le contraddizioni interimperialistiche si presentano trasversalmente e solo mediate dalle contraddizioni tra stati nazionali.
Le vecchie contraddizioni tra stati o sovra-stati – Usa, Ue e Giappone – si sono estese e compiute nelle aree di influenza (americana, europea e asiatica, ora con la Cina in testa), con una trasversalità valutaria che travalica i confini territoriali, essendo i “confini” tra capitali superati da tempo. Qui rientra il contenzioso mediorientale, la contraddizione islamica, la riconquista dell’Africa, la normalizzazione dell’America latina, ecc. L’Onu predica investimenti diretti nel terzo mondo, anche come antidoto contro i rischi delle migrazioni verso i paesi imperialisti. Ma tutto ciò non basta a esorcizzare l’effetto boomerang che i capitalisti improvvidi hanno attirato su loro stessi dopo aver demolito – solo per cercare di sopravvivere qualche anno di più – le fonti di produzione dei paesi dominati. A chi ha distrutto anche la propria base produttiva, come gli Usa, non resta che la minaccia a mano armata.
La nascita dell’euro è il risultato del forzoso ricompattamento di un certo equilibrio nei rapporti di forza della frazione di capitale mondiale basato nell’area europea, per fronteggiare l’imperialismo a base Usa finora prevalente. Senonché, ciò che ancora manca in simile fronteggiamento tra aree è una reale complessiva ripresa dell’accumulazione, pur nella diversificazione del mercato mondiale. I dati, appena riportati, della crescita dimezzata del pil mondiale, a es., lo esprimono a chiare cifre, mostrando tra le righe
40

che l’economia Usa è realmente poco più che stagnante. Essa riesce perlopiù a simulare una crescita solo “contabilmente”, a scapito delle economie deboli, dominate e saccheggiate, com’è del resto indirettamente confermato dall’andamento del Nyse (borsa di Wall street), soprattutto nel comparto tecnologico Nasdaq, molto più che dimezzato in meno di un anno (da sopra 5000 nel marzo 2000 a meno di 1800 l’anno dopo). I cicli economici delle crisi capitalistiche permangono, dunque, in tutta la loro portata.
Anzi, le breve riprese, parziali o false, a singhiozzo o presunte, si inscrivono in una depressione cronica profonda irrisolta per la carenza di distruzione di capitale che perdura dagli anni 1970 (ciò che richiama ulteriormente la menzionata forte analogia con la “grande depressione” del 1870). L’immanenza economica, storica e sociale, anche della crisi del XIX sec., ha potuto far sì che la sua forma monetaria abbia potuto assumere sempre più nettamente quegli aspetti che hanno definitivamente affermato la loro configurazione nel corso del secolo successivo, fino a oggi. Non è qui questione, dunque, di cercare sottili, quanto futili, distinzioni tra le politiche regolazioniste keynesiane e quelle privatistiche del monetarismo, tentando di attribuire a queste ultime una volontà di scontro diretto e frontale tra padroni e lavoratori, riservando alle prime una visione di intervento “sociale” concertativo. Si è anche provato a rintracciare aspetti progressivi e “rate di socialismo” (come le chiamavano i “fabiani”) nelle forme del neocorporativismo, relegando l’accusa di “neoliberismo” alle politiche della sola “destra” antikeynesiana, per cercare di salvare la “sinistra” keynesiana, fingendo di non farle “sapere cosa fa la destra”. Di tutto ciò si è già discusso.
Il conflitto tra dollaro e euro (con lo yen rimasto indietro, e che è nell’evenienza sostenuto dallo yuan e dalla rupia) va piuttosto inscritto, soprattutto, nei diversi gradi di inserimento (per prezzi di vendita e costi di produzione; ma anche, in subordine, per i costi di circolazione aggrediti dalla fantomatica “nuova economia”) delle varie catene, o cordate delle filiere, nelle diverse “aree valutarie”, anziché nelle zone o sfere di influenza dei contrapposti imperialismi. In altri termini, continuare a riferirsi soltanto alla separatezza e contrapposizione territoriale o “nazionale” dei capitali imperialistici può trarre in inganno. Le “aree valutarie”, invece, attraversano l’intero mercato mondiale, e in questo senso sono più adeguate al concetto di imperialismo transnazionale. Proprio in quanto caratterizzate da acquisizioni, fusioni e investimenti all’estero, le imprese transnazionali, da un lato, persistono nelle strutture produttive esistenti nelle diverse dislocazioni o ne installano di nuove e, dall’altro, spostano la loro gravitazione nell’area valutaria (valuta di riferimento per costi e prezzi) più favorevole, indipendentemente dalla loro localizzazione territoriale. Sullo sfondo del tentativo della Federal reserve Usa [Fed] di resuscitare di fatto la “dollarizzazione” 1945-1970 per rilevanti parti o segmenti del mercato mondiale – di contro all’euro – si tratta perciò di individuare nel dettaglio quali elementi di costo siano espressi in dollari e quali in altre valute (euro, innanzitutto, o yen) e in quale valuta quindi si presentino in divenire anche i prezzi di vendita.
Un simile dilemma, in effetti, non sussisteva neppure nell’epoca del secondo dopoguerra, con il dollaro come unica valuta riconosciuta per i pagamenti internazionali, e quindi con tutte le monete “ancorate” al dollaro stesso (dollar standard e gold exchange standard basato sulla convertibilità della moneta Usa). Oggi, invece, la cosiddetta “dollarizzazione” di gran parte ancora dell’economia mondiale è un preciso obiettivo che la Fed vorrebbe perseguire per il capitale imperialistico ancora gravitante intorno alla moneta Usa. Perciò, attualmente, una grande impresa transnazionale la quale, magari dopo una fusione, operi contemporaneamente nei tre “continenti” imperialistici, può così ancora decidere su quale valuta fare aggio. L’ultima questione riporta tutta alla problematica, dianzi detta, relativa alla ristrutturazione dei costi di produzione, anche in quanto essa incida (fenomenicamente attraverso il corso dei cambi e attraverso la ricordata e impropriamente detta “nuova economia”) sulle condizioni di approvvigionamento degli elementi della produzione, ma pure proprio sui prezzi di vendita dei prodotti ottenuti (tanto beni finali, quanto prodotti intermedi).
Da quanto precede, si possono dedurre alcuni argomenti chiave di indagine: struttura attuale dei costi di produzione (incluso l’effetto valutario di riferimento nelle fatturazioni); riorganizzazione (centralizzazione più decentramento) del sistema produttivo industriale su scala mondiale (fino alla subfornitura e al lavoro a domicilio, eventualmente attraverso l’informatizzazione della circolazione nella forma delle “false spese” di produzione); filiere di produzione, catene transnazionali e vantaggio competitivo (alla Porter); conseguente ricomposizione internazionale del lavoro dipendente (operaio, impiegatizio fino ai gradi dirigenti intermedi; industriale, finanziario e di servizio). La “finanziarizzazione” dell’economia, così impropriamente detta, è perciò inserita – come la supposta “nuova economia” – nella necessità che il capitale finanziario (propriamente definito come capitale industriale più capitale monetario, secondo quanto si è sopra precisato) abbia mano libera di spaziare, liquidandosi – ossia, rendendosi liquido – ora nella forma produttiva e ora, assai più frequentemente nelle fasi di crisi, in quella della circolazione e soprattutto della speculazione. L’Europa accompagna necessariamente codesta tendenza.
Ma molte altre tematiche possono essere desunte dalle precedenti. A es., anche la “questione del petrolio” (o meglio sarebbe dire dell’“energia”, col gas in prima linea) assume ben altro spessore se la si colloca non solo nel più generale fabbisogno di materie prime fondamentali per qualsiasi produzione, ma soprattutto in
41

quanto strategia monetaria tendente a incassare la valuta necessaria per effettuare la maggior parte delle transazioni mondiali in qualsiasi merce. Così pure il problema delle risorse idriche per la produzione industriale di massa, che, in effetti, può essere in prospettiva più grave di quello stesso energetico. Le aree che hanno l’una o l’altra risorsa di base in abbondanza, o comunque in condizioni di monopolio naturale, entrano pertanto direttamente nel giro della concatenazione del mercato mondiale (si rammentino, come fatto esemplare, le dispute intorno al cosiddetto “corridoio 8” dai Balcani, attraverso Kurdistan in prospettiva mediorientale, Caucaso, Iran, Afghanistan, Pakistan, Nepal, Tibet, Asia centrale in genere, fino allo sbocco cinese sul Pacifico.
Donchisciotte e l’osteria dell’avvenire – conclusione
Ora, che gli “stati della borghesia” debbano tutti configurarsi su tali esigenze del mercato mondiale, è di per sé evidente. La razionalità della storia, la cui “eterogenesi dei fini” ne è elemento caratteristico e costitutivo, mostra tragicamente che la realtà del mercato capitalistico mondiale depone per la “regressiva progressività” – ovverosia l’ossimoro marxiano della “distruttività” delle sue forze “produttive” – quale si sta verificando in séguito all’ipocrisia delle “guerre preventive” che hanno disgregato una schiera sempre più grande di stati sovrani, facendone aumentare al contempo il ... “numero” legalmente riconosciuto dall’Onu.
Ma non si può far girare all’indietro la ruota della storia! D’altronde, la classe lavoratrice è travolta come entità autonoma e “inglobata”, anche semanticamente, nel cosiddetto “mondo del lavoro”, ineffabilmente indifferente, e non riesce a ritrovare quella sua propria specifica entità che la renderebbe capace – nelle società in cui predomina il modo capitalistico della produzione sociale, vale a dire oggi nell’“universo mondo” – di farsi valere come proprietaria di quell’unica e peculiare merce che è la forza-lavoro, dal cui uso soltanto, che avviene solo dopo il suo scambio, pur se supposto equo, dipende la vita del capitale e del suo stesso “modo di produzione e di vita”. “Ricostruire” una propria coscienza di ciò è estremamente difficile.
Il proletariato mondiale – ossia la classe di tutti i produttori lavoratori “dipendenti” (non tanto e non solo giuridicamente, ma anzitutto economicamente salariati o stipendiati dai proprietari, quale che sia la forma pseudocontrattuale in cui essi appaiano) – può però percorrere la lunga strada che porta a costruire ex novo tale coscienza. Certo, ciò si fonda su tutte le esperienze storiche, non sottratte alla memoria, di vittorie ma anche e forse soprattutto di sconfitte; senonché, come definiva la coscienza stessa Friedrich Engels, ciò significa in primo luogo conoscenza scientifica del funzionamento concreto del modo di produzione capitalistico contemporaneo, contro ogni fuga in avanti verso la cattiva infinità di un “dover essere” soggettivistico politico.
A togliere ogni pia illusione su quella che troppi presumono essere una fragile e breve tenuta del modo di produzione capitalistico, con fantastiche attese messianiche di veder sorgere rapidamente e ineluttabilmente il-sol-dell’avvenir, bastino le sintetiche osservazioni proprio di Marx e di Engels; il primo ripeteva sempre, anzitutto, che rifuggiva dal “prescrivere ricette per l’osteria dell’avvenire” [cfr., a es., Poscritto alla II ed. del Capitale], dato che “se noi non trovassimo già occultate nella società, così com’è, le condizioni materiali di produzione e i loro corrispondenti rapporti di scambio, adeguati a una società senza classi, tutti i tentativi di farla saltare sarebbero sforzi donchisciotteschi” [cfr. Lineamenti fondamentali, q.I, f.22]. Insomma, la realtà materiale si trova “così com’è” e non la si può inventare con gesti di buona volontà: è storia civile. Del resto, entrambi [cfr. Engels-Marx, L’ideologia tedesca, I.2], molti anni prima, nel 1845, constatavano che “il comunismo è possibile empiricamente solo come un’azione dei popoli dominati tutti in una volta e simultaneamente, ciò che presuppone lo sviluppo universale delle forze produttive e le relazioni mondiali che esso comunismo implica. Solo con questo sviluppo universale delle forze produttive possono aversi relazioni universali fra gli uomini, perché senza di esso si generalizzerebbe soltanto la miseria e quindi col bisogno ricomincerebbe anche il conflitto per il necessario e ritornerebbe per forza tutta la vecchia merda”.
************************************************************************
MATERIALI DIDATTICI
PRIMA PARTE
INTRODUZIONE
42

0. Storia del mercato mondiale e dell’imperialismo
0.1. La rivoluzione industriale
La rivoluzione industriale costituisce la più fondamentale trasformazione della vita umana in tutta la storia universale tramandata da documenti scritti. Per un breve periodo essa coincise con la storia di un solo paese, la Gran Bretagna. Un’intera economia mondiale fu costruita sopra questo paese, o piuttosto attorno ad esso, e pertanto la Gran Bretagna ascese temporaneamente a una posizione di influenza e potenza universali, senza paragone con altri stati della sua misura, e senza possibilità di confronto in un prevedibile futuro. Vi fu un momento nella storia del mondo in cui la Gran Bretagna poteva essere definita, se non siamo troppo pedanti, come la sola officina della terra, la sola grande nazione importatrice ed esportatrice, la sola che si occupasse dei trasporti, la sola potenza imperialistica, e quasi la sola nazione che investisse all’estero; e per queste ragioni, la sola potenza navale e la sola che svolgesse un’autentica politica mondiale. Gran parte del suo monopolio era semplicemente dovuto alla solitudine del pioniere, sovrastante su tutti proprio a causa dell’assenza di altri concorrenti.
Quando altri paesi si industrializzarono, quel monopolio fini automaticamente, anche se l’apparato di transazioni economiche mondiali costruito da e per la Gran Bretagna rimase indispensabile al resto del mondo ancora per un certo tempo. Nondimeno, per la maggior parte del mondo l’era “britannica” dell’industrializzazione fu soltanto una fase, quella iniziale o una fra le prime, della storia contemporanea. Il problema dell’origine della rivoluzione industriale già di per sé si prospetta difficile, ma lo diventa ancora di più se non ne chiariamo i termini. Sarà bene quindi cominciare con una rapida precisazione.
In primo luogo, la rivoluzione industriale non consistette semplicemente in un’accelerazione dello sviluppo economico, ma in un’accelerazione dello sviluppo dovuta alla trasformazione economica e sociale, e conseguita attraverso questa. I primi osservatori, che concentrarono la loro attenzione sulle vie qualitativamente nuove di produzione, cioè le macchine, il sistema delle fabbriche e tutto il resto, seguirono un istinto esatto, anche se talvolta con senso critico insufficiente. L’industrializzazione capitalistica richiede per certi aspetti un’analisi differente da quella impiegata per quella non capitalistica, perché dobbiamo spiegare in che modo la ricerca del profitto privato portò a una trasformazione tecnologica, quando non è affatto ovvio che ciò avvenga automaticamente.
In secondo luogo, la rivoluzione industriale inglese fu la prima della storia. Questo non significa che si sia partiti da zero, o che non possano essere rintracciate fasi precedenti di un rapido sviluppo industriale e tecnologico. Nondimeno, nessuna di esse diede inizio alla fase caratteristica della storia moderna, quella di uno sviluppo economico che si perpetua grazie a una rivoluzione tecnologica e a una trasformazione sociale continue. Essendo stata la prima, è stata anche, sotto aspetti sostanziali, differente da tutte te rivoluzioni sociali successive. Non può essere spiegata in primo luogo o in parte, con fattori esterni come, ad esempio, l’imitazione di tecniche più avanzate, l’importazione di capitali, l’influsso di un’economia mondiale già industrializzata. Le rivoluzioni che seguirono poterono valersi dell’esperienza, dell’esempio e delle risorse inglesi. L’Inghilterra poté avvantaggiarsi molto limitatamente di quello che era stato fatto in altri paesi.
Comunque, la rivoluzione industriale non può essere spiegata in termini puramente inglesi, perché la Gran Bretagna costituì una parte di un’economia più ampia che possiamo chiamare l’“economia europea” o l’“economia mondiale degli stati marittimi europei”. Il paese fu solo una parte di una rete più ampia di relazioni economiche, che includeva varie aree “sviluppate”, alcune delle quali erano anche aree d’industria-lizzazione potenziale o ambita, ma includeva anche aree di “economia dipendente”, oltreché margini di economie straniere non ancora sostanzialmente connesse con l’Europa. Queste economie dipendenti erano date in parte da vere e proprie colonie (come nelle Americhe) o da ristrette zone commerciali e d’importanza strategica (come in Oriente), e in parte da regioni che erano fino a un certo grado specializzate economicamente nel sopperire alle richieste di aree “sviluppate” (come in alcune parti dell’Europa orientale).
Il mondo sviluppato era collegato con il mondo dipendente grazie a una certa suddivisione dell’attività economica: da una parte un’area relativamente urbanizzata, dall’altra zone che producevano e largamente esportavano prodotti agricoli o materie prime. Queste relazioni possono essere definite come un sistema dì flussi economici: di attività commerciali, di pagamenti internazionali, di trasferimenti di capitali, di migrazioni, e cosi via. L’“economia europea” aveva mostrato chiari segni di espansione e sviluppo dinamico per più secoli, anche se aveva subito gravi rovesci e aveva mostrato notevoli spostamenti, particolarmente nel periodo dal secolo XIV al XV e nel secolo XVII.
Tuttavia è importante rilevare che essa tese a dividersi, almeno a partire dal secolo XVI, in unità politico-economiche (stati territoriali) indipendenti e in concorrenza fra di loro, come ad esempio l’Inghilterra e la Francia, ciascuno con una struttura economica e sociale sua propria, e ciascuna avente regioni e settori
43

progrediti, e dipendenti o arretrati. Fin dal secolo XVI era diventato abbastanza ovvio che se si fosse verificata una rivoluzione industriale, questa non avrebbe potuto attuarsi che nell’ambito di un sistema economico europeo. Non sussistevano dunque seri ostacoli al trasferimento di uomini da attività non industriali a industriali. Il paese aveva accumulato capitali ed era di una ampiezza sufficiente a permettere investimenti nelle attrezzature necessarie per una trasformazione economica, peraltro non molto costose, prima delle ferrovie. Non vi era scarsità di capitali, né relativa né assoluta. Il paese non costituiva semplicemente un’economia di mercato (un’economia, cioè, in cui il grosso dei beni e dei servizi sono comperati e venduti agendo fuori dell’ambito familiare) ma sotto molti aspetti formava un unico mercato nazionale. Possedeva inoltre un esteso e abbastanza sviluppato settore manifatturiero, e un apparato commerciale altamente sviluppato.
Il mercato interno, ampio e in espansione com’era, poteva espandersi soltanto lungo quattro direttrici principali, tre delle quali non avevano probabilità di consentire una grande rapidità. Poteva aversi un incremento demografico, cosa che crea un maggior numero di consumatori (e, naturalmente, di produttori); un trasferimento di popolazione da redditi non monetari a monetari, il che crea un maggior numero di acquirenti; e una sostituzione di merci prodotte industrialmente al posto di più vecchie forme di manufatti o merci importate. I vantaggi principali del mercato interno preindustriale furono quindi la sua grande ampiezza e la sua stabilità. Esso non avrà contribuito sostanzialmente alla rivoluzione industriale, ma indubbiamente favorì lo sviluppo economico e, ciò che più conta, fu sempre pronto a proteggere le industrie esportataci, più dinamiche, contro le fluttuazioni e i collassi che erano il prezzo pagato per il loro superiore dinamismo. Esso venne in loro aiuto negli anni ‘80 del secolo XVIII, quando la guerra e la rivoluzione americana le sconquassarono e ancora, probabilmente, dopo le guerre napoleoniche. Ma, cosa più importante, il mercato interno fornì gli elementi di fondo per una economia industriale generalizzata.
Le industrie esportatrici lavoravano invece in condizioni molto differenti e potenzialmente molto più rivoluzionarie. Esse fluttuavano ampiamente, con punte di variazione fino al 50% l’anno, cosicché il manufatturiere capace di spingersi in avanti approfittando delle espansioni di mercato poteva fare colpi colossali. Alla lunga queste industrie riuscirono a espandersi molto di più, e più rapidamente, del mercato interno. La domanda interna aumentò, ma quella esterna si moltiplicò. Se occorreva una scintilla, fu dal mercato esterno che essa scaturì. La manifattura del cotone, la prima a essere industrializzata, era sostanzialmente collegata com il commercio d’oltremare. Ogni oncia della sua materia prima doveva essere importata dalle aree sub-tropicali e tropicali e, come vedremo, i suoi prodotti erano destinati soprattutto all’esportazione. Dalla fine del secolo essa era un’industria che esportava la maggior parte della produzione totale, forse i due terzi già nel 1805.
Il motivo di questa straordinaria potenzialità d’espansione fu che le industrie esportatici non dipendevano dal modesto tasso di sviluppo “naturale” della domanda interna di un qualche paese. Potevano invece creare l’illusione che vi fosse un rapido sviluppo principalmente in due modi: conquistando una serie di altri mercati d’esportazione già appartenenti ad altri paesi, e annullando la concorrenza all’interno di determinati paesi, ossia impiegando i mezzi politici o semipoliticì della guerra e della colonizzazione. La nazione che fosse riuscita a concentrare a proprio beneficio i mercati d’esportazione di altri popoli o anche a monopolizzare i mercati d’esportazione mondiali in un periodo di tempo sufficientemente breve, poteva espandere le proprie industrie esportatrici con un ritmo che rese la rivoluzione industriale non solo possibile, ma talvolta virtualmente obbligatoria per i suoi imprenditori. E questo è quanto la Gran Bretagna riuscì a fare nel secolo XVIII. Ma la conquista dei mercati con la guerra e la colonizzazione richiedeva non soltanto un’economia capace di sfruttarli, ma anche un governo disposto a muover guerra e a colonizzare a beneficio dei manufatturieri britannici. Questo fatto ci porta al terzo fattore della genesi della rivoluzione industriale: il governo. Qui il vantaggio della Gran Bretagna sui suoi concorrenti potenziali è più che evidente. A differenza dì alcuni di essi (come la Francia) essa era disposta a subordinare tutta la sua politica estera a fini economici. I suoi obiettivi bellici erano commerciali e, ciò che era la stessa cosa, marittimi.
Gli obiettivi economici della Gran Bretagna non erano dominati soltanto da interessi commerciali e finanziari, ma anche, e sempre più, dal gruppo di pressione dato dai manifatturieri. Nelle cinque grandi guerre dell’epoca, la Gran Bretagna fu nettamente sulla difensiva in una soltanto. Il risultato di questo secolo di guerre intermittenti fu il più grande trionfo mai raggiunto da una sola nazione: un virtuale monopolio in fatto di colonie d’oltremare fra le potenze europee, e ancora un predominio navale su scala mondiale. Inoltre le guerre, mettendo in ginocchio le maggiori concorrenti della Gran Bretagna in Europa, tesero a far aumentare le esportazioni; la pace tendeva semmai a rallentarle.
Il ruolo dei tre settori principali della domanda nella genesi dell’industrialismo può essere sintetizzato nel modo seguente. Le esportazioni, sostenute dal sistematico e aggressivo aiuto del governo, fecero scoccare la scintilla e, assieme ai tessuti di cotone, costituirono il “settore di guida” dell’industria. A esse furono anche dovuti importanti miglioramenti nei trasporti marittimi. Il mercato interno fornì gli elementi di fondo per un’economia industriale generalizzata e (tramite il processo d’urbanizzazione) l’incentivo per importanti
44

miglioramenti nei trasporti interni, una salda base per l’industria carbonifera e per alcune importanti innovazioni tecnologiche. Il governo appoggiò sistematicamente i mercanti e i manufatturieri, e fornì alcuni incentivi, per niente trascurabili, alle innovazioni tecniche e allo sviluppo delle industrie produttrici di attrezzature.
La rivoluzione industriale fu generata in queste decadi, dopo gli anni ‘40 del secolo, quando il massiccio ma lento sviluppo delle economie interne si combinò con la rapida (estremamente rapida dopo il 1750) espansione dell’economia internazionale; e si verificò in un paese che afferrò le opportunità internazionali di accaparrarsi una grossa fetta dei mercati d’oltremare. Chi dice rivoluzione industriale, dice cotone. Quando pensiamo alla rivoluzione vediamo, come i turisti stranieri che visitavano allora l’Inghilterra, la nuova e rivoluzionaria città di Manchester che diede il nome alla scuola di economia liberale che dominò il mondo. E non v’è dubbio che si tratta di una prospettiva esatta. La rivoluzione industriale britannica non fu certo solo cotone o Lancashire e nemmeno soltanto prodotti tessili, e il cotone perse il primato dopo un paio di generazioni. Tuttavia il cotone fu il battistrada del mutamento industriale, e costituì la base economica delle prime regioni che non sarebbero esistite se non fosse stato per l’industrializzazione, e che espressero una nuova forma di società, quella del capitalismo industriale, basata su una nuova formula di produzione: la “fabbrica”.
Il nuovo mondo dell’industrialismo nella sua forma più ovvia non era da cercare nei centri minerari, ma a Manchester e dintorni. La manifattura del cotone fu un tipico sottoprodotto di quella corrente, sempre più veloce, di commercio internazionale e specialmente coloniale, senza del quale, come abbiamo visto, non si può spiegare la rivoluzione industriale. La sua materia prima, che si cominciò ad adoperare in Europa mista a lino per fabbricare una versione meno costosa del prodotto tessile (il fustagno), era quasi interamente coloniale. La sola industria cotoniera “pura” conosciuta in Europa nei primi anni del secolo XVIII fu quella dell’India, il cui prodotto (il calicò) era venduto dalle compagnie commerciali orientali all’estero e in patria, dove incontrava l’aspra concorrenza delle manifatture interne di lana, di lino e di seta. L’industria laniera inglese ottenne nel 1700 di fare bandire del tutto l’importazione, riuscendo in tal modo per caso a offrire alle future manifatture interne di cotone mano libera sul mercato interno. Queste ultime erano ancora troppo arretrate per rifornire il mercato, tuttavia il primo prodotto della, moderna industria cotoniera, il calicò stampato, si affermò come un parziale sostituto delle importazioni in vari paesi europei.
Il cotone acquisì in questo modo quel suo caratteristico legame col mondo sottosviluppato, un legame che conservò e rafforzò attraverso tutte le fluttuazioni della fortuna. Le piantagioni coltivate dagli schiavi nelle Indie occidentali fornirono la materia prima fino quando, negli anni ‘90 del secolo, l’industria cotoniera trovò una nuova e virtualmente illimitata fonte di rifornimento nelle piantagioni coltivate dagli schiavi negli Stati Uniti meridionali, i quali divennero cosi in complesso un’economia dipendente dal Lancashire. In tal modo, il centro di produzione più moderno conservò ed estese la forma di sfruttamento più antica.
Il cotone era e rimase essenzialmente un’industria d’esportazione. Di tanto in tanto si affacciava sui remunerativi mercati d’Europa e degli Stati Uniti, ma le guerre e il sorgere della concorrenza locale misero un freno a questa espansione, e l’industria cotoniera ritornò spesso a qualche nuova o vecchia regione del mondo sottosviluppato. Dopo la metà del secolo XIX, trovò il suo sbocco principale nell’India e nell’Estremo oriente. L’industria cotoniera britannica fu certamente ai suoi giorni la migliore del mondo, ma giunse al suo termine perché aveva cominciato ad affidarsi non più alla sua superiorità concorrenziale ma a un monopolio di mercati coloniali e sottosviluppati che le era consentito dall’impero, dalla marina e dalla supremazia com-merciale britannici. I suoi giorni erano ormai contati alla fine della prima guerra mondiale, quando gli indiani, i cinesi e i giapponesi poterono fabbricare o anche esportare le loro merci di cotone senza essere ostacolati da interferenze politiche britanniche.
Il problema tecnico che determinò la natura della meccanizzazione nell’ambito dell’industria cotoniera fu lo squilibrio fra l’efficienza della filatura e della tessitura. Il filatoio, un congegno assai meno produttivo del telaio a mano (specialmente del telaio accelerato dalla spoletta, che fu inventata negli anni ‘30 del secolo XVIII e si diffuse negli anni ‘60), non riusciva a rifornire a sufficienza i tessitori. Tre invenzioni note a tutti equilibrarono la bilancia: il filatoio multiplo, degli anni ‘60, che consentiva a un solo filatore nel suo cottage, di filare vari fili in una volta; il telaio ad acqua del 1768, basato sull’originale idea di filare combinando cilindri e fusi; e la fusione dei due congegni, il filatoio intermittente degli anni ‘80 , a cui fu tosto applicata la forza vapore. Le ultime due innovazioni implicarono una produzione di fabbrica. I cotonifici della rivoluzione industriale furono essenzialmente delle filande e complessi per cardare il cotone prima di filarlo.
La tessitura tenne il passo con queste innovazioni grazie a una moltiplicazione di telai a mano e di tessitori. Il telaio a vapore divenne il signore della tessitura. Lo schiacciante predominio mondiale che il Lancashire aveva raggiunto in quel periodo lo rese tecnicamente conservatore, anche se non stagnante. La tecnologia della lavorazione del cotone era abbastanza semplice e così, come vedremo, furono le tecnologie della maggior parte delle altre industrie a provocare nel loro insieme la rivoluzione industriale. La prima abbisognava di scarse nozioni scientifiche o capacità tecniche che superassero la portata di un meccanico
45

pratico e abile dei primi anni del secolo XVIII. Aveva anche scarso bisogno della forza vapore, perché anche se l’industria cotoniera veniva adottando il motore a vapore rapidamente e in misura maggiore delle altre industrie (tranne la mineraria e la metallurgica), ancora nel 1838 un quarto della forza motrice era fornita dall’acqua.
Ciò non rifletteva una mancanza di innovazioni scientifiche o di interesse da parte dei nuovi industriali per la rivoluzione tecnica. Al contrario, le innovazioni scientifiche abbondavano, ed erano tosto applicate a fini pratici da scienziati che ancora rifiutavano di distinguere, come si fece in seguito, tra pensiero “puro” e “applicato”. E gli industriali assorbivano le innovazioni senza por tempo in mezzo quando erano necessarie e vantaggiose e, soprattutto, applicavano un rigoroso razionalismo ai loro metodi di produzione, il che è caratteristico di un’epoca scientifica. I padroni del cotone impararono presto a costruire secondo un criterio puramente funzionale. Eppure i primi esperimenti di illuminazione a gas non risalivano a prima del 1792. Non esitarono a candeggiare e tingere i tessuti adottando le più recenti invenzioni della chimica, una scienza di cui si può dire che sia diventata maggiorenne fra gli anni ‘70 e ‘80 del secolo XVIII, con la rivoluzione industriale. Si pensi che l’industria chimica divenuta fiorente in Scozia nel 1800 per via di queste applicazioni, dovette la sua fortuna al suggerimento, dato appena nel 1786 da Berthollet a James Watt, che il cloro poteva essere impiegato per il candeggio.
La prima fase della rivoluzione industriale fu tecnicamente piuttosto primitiva non perché non esistessero una scienza e una tecnologia migliori, ma perché gli uomini non vi ponevano interesse e non si riuscivano a persuadere a valersene. Fu semplice perché in genere l’applicazione di idee e accorgimenti semplici – e spesso si trattava di idee vecchie di secoli e niente affatto costose da applicare – già bastava a dare risultati eccellenti. Fu una situazione fortunatissima, perché diede a quel fenomeno pionieristico che fu la rivoluzione industriale una fortissima, forse essenziale, spinta in avanti. In altre parole, si trattò di una situazione che riduceva al minimo quei requisiti essenziali di capacità, di capitali disponibili, di ampiezza dell’attività o dell’organizzazione e pianificazione statale, senza di cui nessuna industrializzazione può essere raggiunta. La verità era che in quella fase si poteva vendere praticamente tutto, specialmente data la rozzezza del cliente interno e di quello straniero. Un nuovo sistema industriale basato su una nuova tecnologia emerse cosi con grande rapidità e facilità fra le fattorie e i villaggi del piovoso Lancashire. Ma emerse, come abbiamo visto, grazie a una combinazione di vecchi e nuovi elementi, con i nuovi che infine prevalsero. Il capitale accumulato nell’àmbito dell’industria sostituì le ipoteche sulle fattorie e le economie dei locandieri, i tecnici sostituirono gli inventivi tessitori-falegnami, e i telai a vapore i tessitori a mano, mentre un proletariato di fabbrica sostituì la combinazione di poche aziende meccanizzate e una massa di dipendenti domestici.
Possono essere menzionate due conseguenze di questo stato di cose. La prima è la struttura operativa estremamente decentralizzata dell’industria cotoniera (lo stesso vale anche per la maggior parte delle industrie britanniche del secolo XIX), e questo perché dovette il suo fiorire alle attività non pianificate di uomini mediocri. Essa emerse, ed è in gran parte rimasta, come un complesso di organizzazioni altamente specializzate di media ampiezza, spesso anche parecchio localizzate, comprendenti mercanti di vario tipo, filatori, tessitori, tintori, rifinitori, candeggiatori, stampatori, e cosi via, in molti casi specializzati anche all’interno delle loro branche, collegati l’uno all’altro da una fitta rete di transazioni affaristiche individuali che li faceva congiungere “nel mercato”. Una tale struttura presenta il vantaggio della flessibilità e si presta facilmente a una rapida espansione iniziale, ma negli stadi successivi dello sviluppo industriale, quando i vantaggi tecnici ed economici della pianificazione e della integrazione sono assai maggiori, presenta caratteristiche di rigidità e inefficienza preoccupanti.
La seconda conseguenza fu la nascita di un forte movimento sindacale in un’industria normalmente caratterizzata da organizzazioni di categoria che erano molto deboli o instabili perché si trattava di manodopera composta in gran parte di donne e bambini, immigrati non qualificati e cosi via. Le unions dell’industria cotoniera del Lancashire si basavano su una minoranza di maschi specialisti. Nondimeno, in base ai livelli del secolo XVIII, fu un’industria rivoluzionaria. Essa configurò una nuova relazione economica fra gli uomini, un nuovo sistema di produzione, un nuovo ritmo di vita, una nuova società, una nuova era storica.
Il nuovo sistema che i contemporanei videro esemplificato soprattutto nel Lancashire, consisteva, così sembrò loro, di tre elementi. Il primo era dato dalla divisione della popolazione industriale in datori di lavoro capitalisti, e in lavoratori i quali non possedevano niente eccetto la loro forza lavorativa che vendevano in cambio dei salari. Il secondo era dato dalla produzione nella “fabbrica”, una combinazione di macchine specializzate e lavoro umano anch’esso specializzato, o, come la definì un suo primo teorico, il dottor Andrew Ure, “un grosso automa formato da vari organi meccanici e intellettuali che agiscono con un accordo costante ... e sono tutti subordinati a una forza motrice autoregolantesi”. Il terzo consisteva nella dominazione dell’intera economia, anzi di tutta la vita, a opera degli scopi di profitto dei capitalisti. Alcuni dei teorici, coloro che non vedevano niente di fondamentalmente sbagliato nel nuovo sistema, non si preoccuparono di distinguere fra i suoi aspetti sociali e quelli tecnici. C’era abbondanza di uomini e donne
46

che vivevano di lavoro salariato, anche se molti costituivano ancora versioni, peraltro degenerate, di artigiani, piccoli proprietari terrieri in cerca di lavoro per il tempo libero, piccoli imprenditori a tempo perso e cosi via: tutta gente che un tempo era stata indipendente. Ma pochi erano i veri lavoratori salariati.
[RI. 1-3]
0.2. L’espansione economica internazionale
Abbiamo dovuto aspettare la tecnologia della metà del secolo XX per rendere possibile nella produzione di fabbrica quelle semiautomazioni o automazioni che i “filosofi del vapore” della prima metà del secolo XIX previdero con tanta soddisfazione e che riuscirono a discernere nelle imperfettissime e arcaiche filande della loro epoca. Prima dell’avvento della ferrovia non vi era probabilmente un ramo di attività, con l’eccezione forse di qualche rara officina del gas e di qualche impianto chimico, che un tecnico industriale moderno non considererebbe di interesse soltanto archeologico. Tuttavia, il fatto che le filande ispirassero visioni di lavoratori disumanizzati e ridotti ad “automi” e “braccia” prima di essere liberati dal macchinario “autooperante” (automatico), è ugualmente significativo.
La “fabbrica” – col suo flusso logico di procedimenti, ciascuno dato da una macchina specializzata a cui badavano “braccia” specializzate, e tutti tenuti insieme dal passo inumano e costante del motore e dalla disciplina della meccanizzazione – illuminata a gas, con uno scheletro di ferro, e fumante, era una forma rivoluzionaria di lavoro. Anche se i salari pagati dalle fabbriche tendevano ad essere più alti che nell’industria domestica (con l’eccezione di quelli di lavoratori manuali qualificatissimi e versatili), si notava una riluttanza a lavorare nelle fabbriche perché questo comportava la perdita di un diritto dato dalla nascita, l’indipendenza. Senza dubbio questo era uno dei motivi per cui le fabbriche erano piene di donne e fanciulli, gente più trattabile. Tuttavia, sotto questo rispetto l’industria del cotone non fu di importanza eccezionale, e mancò della capacità diretta di stimolare le industrie che avevano maggior bisogno di spinta, cioè le industrie pesanti del carbone, del ferro e dell’acciaio, alle quali non offrì un grande mercato. Ma la produzione di carbone nel suo complesso obbligò l’industria mineraria a mutamenti tecnici pionieristici, a pompare l’acqua dalle miniere, sempre più profonde, e soprattutto a trasportare il minerale dai filoni carboniferi alla superficie e di lì ai porti e ai mercati. L’industria del carbone svolse quindi assai prima di James Watt un ruolo pionieristico nei confronti del motore a vapore, ne impiegò le versioni migliorate del meccanismo d’estrazione a partire dagli anni ‘90 del secolo XVIII, e soprattutto inventò e sviluppò la ferrovia.
L’industria del ferro dovette superare difficoltà maggiori. Prima della rivoluzione industriale la produzione di ferro in Gran Bretagna non era notevole né per quantità né per qualità. Le guerre in generale e la marina in particolare diedero all’industria del ferro un incoraggiamento costante e spesso un mercato. La produzione di combustibili fu per essa un incentivo permanente al progresso tecnico. Per questi motivi, fino a quando non si ebbe l’avvento della ferrovia, la capacità produttiva tese a superare quella di assorbimento del mercato, e i suoi rapidi scatti in avanti erano seguiti da penose depressioni che gli industriali cercavano di risolvere cercando nuovi impieghi per il loro metallo, e di lenire con prezzi concordati e diminuendo la produzione. Tre innovazioni fondamentali aumentarono la capacità produttiva dell’industria del ferro: la fusione del metallo con l’impiego del carbone coke anziché del carbone di legna, le invenzioni del puddellaggio e della laminazione, entrambe sfruttate più ampiamente negli anni ‘80 del secolo XVIII, e, dopo il 1819, la corrente d’aria calda di James Neilson. Esse inoltre spostarono definitivamente le locazioni dell’industria del ferro verso i campi carboniferi. Dopo le guerre napoleoniche, quando l’industrializzazione cominciò a prender piede in altri paesi, il ferro conquistò un importante mercato d’esportazione. L’industrializzazione britannica diede vita a una domanda interna di articoli di metallo molto varia, trattandosi non soltanto di macchine utensili, ma anche di ponti, tubi, materiale per costruzione e utensili domestici.
L’industria siderurgica stimolò non soltanto tutte le industrie consumataci di ferro, ma anche quella carbonifera (il cui prodotto impiegava per un quarto del totale nel 1842), l’adozione del motore a vapore, e, per lo stesso motivo valido per l’industria carbonifera, anche i trasporti. Nondimeno, come avvenne per il carbone, il ferro non iniziò la sua vera rivoluzione industriale prima dei decenni di mezzo del secolo XIX, ossia cinquant’anni dopo del cotone. Infatti, mentre le industrie produttrici di beni di consumo hanno un mercato anche nelle economie preindustriali, quelle produttrici di beni strumentali ne trovano uno solo in economie industrializzate e in corso di industrializzazione. Fu l’epoca della ferrovia, che triplicò la produzione di carbone e ferro in vent’anni e virtualmente creò un’industria dell’acciaio. Anche altrove si ebbero un evidente e forte sviluppo economico e una trasformazione industriale, ma non ancora una rivoluzione industriale. Un gran numero di industrie, come quelle produttrici di vestiario (eccetto le calze), calzature, materiale per costruzione e d’uso domestico, continuarono a lavorare secondo schemi interamente tradizionali, salvo l’impiego, in qualche caso, di nuovo materiale. Tutt’al più provarono a soddisfare la
47

domanda in vasta espansione estendendo il “sistema interno” che mutava artigiani indipendenti in manodopera impoverita e sudata che lavorava in scantinati urbani e officine sistemate nei solai. L’industria-lismo non creò fabbriche di mobilio e di vestiario, ma abili e organizzati stipettai declinanti verso la condizione di abitatori di topaie, e quegli eserciti affannati e tubercolotici di cucitrici e camiciaie che commuovevano l’opinione della classe media anche in quell’epoca tanto insensibile.
Già verso la metà del secolo XVIII, l’agricoltura non dominava più l’economia della Gran Bretagna come succedeva invece per la maggior parte degli altri paesi, e nel 1800 essa probabilmente non occupava più di un terzo della popolazione e contribuiva nella stessa proporzione alla formazione del reddito nazionale. Ma la rivoluzione industriale impose inevitabilmente nella terra dei mutamenti fondamentali. Sia i proprietari terrieri sia un’ampia sezione degli agricoltori erano preoccupati e angustiati dalle conseguenze sociali del progresso agricolo. Ma è caratteristico dell’agricoltura agli inizi dell’era industriale che il suo disfacimento sociale superi nella maggior parte dei casi la capacità iniziale del settore non agricolo d’assorbire manodopera, e che i poveri delle campagne siano lenti ad abbandonare la vita degli antenati.
Due questioni resero drammatico il problema sociale dello sconvolgimento agricolo: le “recinzioni” e la “legislazione sui poveri”. Le “recinzioni” significavano che campi già liberi o di proprietà comune diventavano unità terriere private e indipendenti, o significavano suddivisioni di terre prima comuni ma non coltivate (boschi, pascoli “deserti” e così via) in proprietà privata. Le “recinzioni”, cosi come una ripartizione più razionale delle proprietà private (mediante scambi, acquisti o cessioni in affitto di strisce di terra al fine di ottenere unità più compatte), erano state praticate già da lungo tempo; e a partire dalla metà del secolo XVII, senza, causare troppi fermenti. Dal 1760 circa i grandi proprietari terrieri (ancora una volta sfruttando il loro controllo del governo) affrettarono il processo di conversione delle terre in un insieme di proprietà soltanto private, valendosi sistematicamente di leggi fatte approvare dal parlamento.
A favore della recinzione giocava il fatto che essa consentiva l’utilizzazione di terre non coltivate e rendeva il coltivatore “miglioratore”, orientato in senso commerciale, indipendente dai suoi vicini legati alla tradizione e antiquati. D’altro canto, ci fu una classe che la recinzione danneggiò gravemente: quella dei coltivatori di minor conto che integravano il reddito dei loro piccoli appezzamenti talvolta col lavoro salariato e talvolta con i vantaggi, miseri ma d’importanza estrema per loro, dati dai diritti comuni: pascoli per gli animali, legna da ardere, materiale da costruzione, legno per riparare gli attrezzi, recinti e cancelli, e cosi via. La recinzione poté bene trasformarli in semplici salariati, ma fece ancora di più, perché andò trasformando loro e i braccianti da membri uguali di una comunità, con un distinto complesso di diritti, in inferiori dipendenti dai ricchi. Non si trattava di un mutamento insignificante. Negli anni ‘90 del secolo XVIII il conseguente decadimento dei contadini poveri aveva raggiunto proporzioni catastrofiche in parti dell’Inghilterra meridionale e orientale, e toccò alla legislazione sui poveri di occuparsi del problema. Furono fissati dei minimi di paga, dipendenti dal prezzo del granoturco. Se i guadagni scendevano sotto i minimi fissati, si doveva ricorrere a un’integrazione con i sussidi per i poveri.
Si è molto discusso sugli effetti dovuti a questo sistema di sicurezza sociale che si era propagato spontaneamente. Si può ritenere che sia esatta l’opinione tradizionale, secondo cui essi furono disastrosi. Secondo quel sistema, tutti i contribuenti locali sussidiavano i proprietari agricoli (e specialmente i più grossi, che impiegavano una numerosa manodopera), in misura tanto maggiore quanto più erano bassi i salari che i proprietari pagavano. Era un sistema che impoveriva, demoralizzava e immobilizzava il lavoratore, il quale poteva sperare di evitare appena la fame nella sua parrocchia, ma solo li e in nessun altro posto; e poi, comportava una netta discriminazione a sfavore dei celibi o di chi aveva famiglie poco numerose. Fece salire i sussidi per i poveri senza diminuirne la povertà: le spese si raddoppiarono dagli anni ‘50 ai tardi anni ‘80 del secolo XVIII, arrivarono ancora a raddoppiarsi nei primi anni del secolo seguente, e poi ancora nel 1817.
Nel frattempo, comunque, la produzione e la produttività agricole salirono. La rivoluzione industriale e la scienza quasi non influirono sull’agricoltura prima dei tardi anni ‘30. In seguito il progresso fu molto rapido. Si affermò rapidamente l’uso di fertilizzanti; nel 1842 fu brevettato il superfosfato, e dal 1840 al 1847 le importazioni di guano peruviano salirono da virtualmente zero a più di 200.000 tonnellate. L’“alta agricoltura” coi suoi forti investimenti e la sua pesante meccanizzazione, dominò i medi anni del secolo, e a cominciare dal 1837 circa si ebbe un forte aumento di produttività delle colture. L’agricoltura britannica, dopo i settantanni d’espansione prima del 1815 e due o tre decenni incerti, entrò nella sua epoca aurea. Negli anni ‘50 del secolo migliorò rapidamente anche la sorte dei miserabili braccianti, anche se questo non fu dovuto a progressi dell’agricoltura, ma a quella “fuga” in massa dalla terra verso le ferrovie, le miniere, le città e i territori d’oltremare, che causò una provvidenziale scarsità di manodopera e un lieve aumento dei salari.
La prima fase dell’industrializzazione britannica, quella tessile, aveva raggiunto i suoi limiti; stava per iniziare una nuova fase industriale che avrebbe fornito fondamenta assai più salde per lo sviluppo economico: la fase basata sulle industrie produttrici di beni primari, sul carbone, il ferro e l’acciaio. L’epoca che fu di crisi per l’industria tessile fu quella stessa che permise l’affermarsi del carbone e del ferro, l’epoca
48

delle costruzioni delle ferrovie. C’erano due ragioni convergenti perché questo avvenisse. La prima era la crescente industrializzazione nel resto del mondo, che offriva un mercato in rapida espansione per quel tipo di materie prime che potevano essere importate solo comperandole dall’“officina del mondo” e che non potevano ancora essere prodotte in quantità sufficiente in patria. La seconda ragione ha comunque poco a vedere con l’aumentare della domanda. Consiste nella pressione con cui i capitali sempre più vasti cercavano proficui investimenti, cosa di cui furono una prova la costruzione delle ferrovie. La maggior parte dei capitali disponibili andò a finire.
L’economia semplicemente non offriva opportunità per investimenti di quella portata, e d’altra parte la sempre maggiore tendenza di uomini d’affari che pure avevano idee chiare a tirar fuori denaro da investire in iniziative senza profitto – ad esempio, per costruire giganteschi, spaventosi e costosissimi edifici municipali – testimonia non soltanto della sempre maggiore prosperità di quella gente, ma anche di una sempre maggiore eccedenza di capitali rispetto a quelli di cui le industrie abbisognavano per i reinvestimenti. Lo sbocco più ovvio per questi capitali eccedenti erano gli investimenti all’estero, e probabilmente le esportazioni di capitali superarono le importazioni già al termine del secolo XVIII. Le guerre permisero di fare prestiti agli alleati della Gran Bretagna, e l’epoca postbellica prestiti per reinsediare i governi continentali reazionari. Possono essere rilevate tre conseguenze di questo mutato stato di cose nell’orientamento dell’economia britannica.
La prima fu la rivoluzione industriale nelle industrie pesanti, che per la prima volta rifornirono l’econo-mia con abbondanti quantitativi di ferro e, cosa più importante, di acciaio (fino allora prodotto con metodi piuttosto antiquati e su piccola scala). L’espansione di queste industrie fu quindi doppiamente utile: offrirono alla manodopera non qualificata un lavoro meglio remunerato, e assorbendo l’eccedenza rurale, migliorarono la sorte dei lavoratori agricoli rimasti nelle campagne, le cui condizioni cominciarono a migliorare nettamente, e anche con forti sbalzi, negli anni ‘50 del secolo scorso. Comunque, il sorgere delle industrie produttrici di materie prime stimolò nella stessa misura l’impiego di manodopera qualificata nei campi in rapida espansione dell’ingegneria, della costruzione di macchine, navi e cosi via. Rafforzarono cosi grandemente un’aristocrazia del lavoro che si considerava, ed era, in condizioni assai migliori di quelle del grosso della classe operaia. La seconda conseguenza della nuova era fu quindi data, come evidente, da un notevole miglioramento dell’occupazione in tutti i settori e da un trasferimento su vasta scala della manodopera da lavori peggio pagati a meglio pagati. È a questo che si dovette in gran parte la generale sensazione di un miglioramento del tenore di vita, e l’allentarsi della tensione sociale durante gli anni aurei della media epoca vittoriana, perché in effetti i livelli salariali di molte classi di lavoratori non aumentarono di parecchio, mentre le abitazioni e le comodità urbane rimasero su un livello impressionantemente basso. Una terza conseguenza fu il notevole aumento delle esportazioni di capitale britannico all’estero. Questa emigrazione di capitali era, naturalmente, solo una parte di un forte flusso di profitti e di risparmi in cerca di investimenti; e, grazie alla trasformazione del mercato dei capitali nell’epoca delta ferrovia, spianò la via alla ricerca di investimenti non per l’antiquato mezzo dei beni immobili o delle obbligazioni statali, ma tramite le azioni industriali.
L’aritmetica fu lo strumento fondamentale della rivoluzione industriale. Non si trattò semplicemente di un processo di addizione e sottrazione, bensì di un mutamento sociale fondamentale. Esso trasformò le vite degli uomini fino a renderle irriconoscibili. C’è, indubbiamente, una relazione fra la rivoluzione industriale in quanto fornitrice di comodità e in quanto trasformatrice sociale. Le classi le cui vite furono meno trasformate furono anche, normalmente, quelle che più ricavarono benefici in termini materiali (e viceversa) e il fatto che non riuscissero a capire che cosa stesse angustiando le altre classi, o a porvi rimedio, fu dovuto a uno stato di soddisfazione non solo materiale, ma anche morale.
Le semplici massime della filosofia utilitaria e dell’economia liberale, volgarizzate negli slogan dei giornalisti e dei propagandisti pagati da quei nuovi potenti fornivano la guida di cui c’era bisogno, e se questo non bastava, l’etica tradizionale, protestante o d’altra confessione dell’imprenditore ambizioso, e la parsimonia, il duro lavoro, il puritanismo morale, facevano il resto. Le fortezze del privilegio aristocratico, della superstizione e della corruzione dovevano ancora essere abbattute. Fino agli anni ‘30 del secolo, quasi non si era affacciato a quegli uomini il problema di che cosa fare con i capitali eccedenti, che potevano essere spesi per avere agi a sufficienza, e essere reinvestiti nelle aziende in espansione. L’ideale di una società individualista, di un’unità familiare che soddisfaceva tutti i propri bisogni materiali e morali andava bene per loro, perché erano uomini che non avevano più bisogno di tradizioni. C’era sempre il denaro, la casa comoda lontana dal fumo dell’opificio e dall’ufficio di contabilità, la moglie devota e modesta, il circolo di famiglia, i piaceri dei viaggi, dell’arte, della scienza e della letteratura. Era gente di successo e rispettata. C’era solo l’incubo della bancarotta e dei debiti a rattristarne talvolta la vita.
La classe media, che aveva raggiunto il successo, e quelli che speravano di emularla, erano molto soddisfatti. Non così i poveri che lavoravano, e che secondo la natura delle cose erano la maggioranza, il cui mondo e il cui modo di vita tradizionale la rivoluzione industriale distruggeva senza una sostituzione
49

automatica con qualcosa d’altro. È questo disgregamento che è alla base della questione circa gli effetti sociali dell’industrializzazione. Il lavoro, in una società industriale, è sotto molti aspetti differente da quello che si svolge in una società preindustriale. In primo luogo esso è soprattutto il lavoro dei “proletari”, che non hanno fonti di reddito degne di nota eccetto un salario in contanti che ricevono per la loro opera. Inoltre il proletario, il cui unico legame con il proprio datore di lavoro è quello del salario, va distinto dal “servo” o dal dipendente preindustriale, che ha col “padrone” una relazione umana e sociale molto complessa e comportante doveri per entrambe le parti, anche se non equamente divisi. La rivoluzione industriale sostituì il servo e l’uomo col lavorante e “le braccia”. In secondo luogo, il lavoro industriale, e specialmente il lavoro meccanizzato di fabbrica, impone una regolarità, una routine e una monotonia che non si notano nei ritmi preindustriali di lavoro, dipendenti dalle variazioni delle stagioni e del tempo, dalla molteplicità dei compiti in occupazioni non sottoposte alla razionale divisione del lavoro, dai capricci di altri esseri umani o animali, o anche dal fatto che un uomo può desiderare di divertirsi anziché di lavorare. Questo valeva anche per il lavoro preindustriale salariato svolto dai lavoratori qualificati, come gli artigiani a giornata la cui invincibile tendenza a non iniziare il lavoro prima del martedì mattina (“lunedì santo”) era la disperazione dei loro padroni. L’industria porta la tirannia dell’orologio, la macchina che fissa il tempo, e porta una complessa interazione dei processi, con tempi accuratamente stabiliti; si ha cioè la misurazione della vita non in stagioni (i termini quadrimestrali in cui scadono i contratti d’affitto) e nemmeno in settimane e giorni, ma in minuti, e si ha soprattutto una regolarità meccanizzata del lavoro che è in conflitto non soltanto con la tradizione, ma con tutte le inclinazioni di un’umanità tuttora non completamente disposta ad accettare un simile stato di cose. E dato che gli uomini non adottavano spontaneamente queste novità, bisognò obbligarli con la disciplina e le multe, con leggi sul lavoro dipendente.
In terzo luogo, l’attività lavorativa dell’età industriale veniva svolta sempre più nell’ambiente della grande città (una novità rispetto al passato), e questo malgrado il fatto che la più antiquata delle rivoluzioni industriali avesse dato vita a parecchie delle sue attività in villaggi industrializzati di minatori, tessitori, fabbricanti di chiodi e catene, e altri lavoratori specializzati. Nel 1750 erano solo due in Gran Bretagna le città con oltre cinquantamila abitanti, Londra e Edinburgo; nel 1800 ce n’erano già otto, e nel 1851 ventinove, fra cui nove con più di centomila abitanti. In quell’epoca, gli abitanti delle città erano diventati più numerosi degli altri, e quasi un terzo della popolazione viveva in città con più di cinquantamila abitanti. E che città! Non c’era soltanto il fatto che erano coperte da una coltre di fumo e impregnate di cattivo odore, e che i servizi pubblici elementari – il rifornimento di acqua, i servizi igienici, la pulizia delle strade, gli spazi aperti, e cosi via – non riuscivano a tenere il passo con l’immigrazione di massa nelle città, causando cosi, specialmente dopo il 1830, epidemie di colera, febbre tifoidea, e un numero spaventoso e costante di morti dovute ai grandi assassinii delle aree urbane nel secolo XIX, l’inquinamento dell’aria e dell’acqua che si risolvevano nelle malattie respiratorie e in quelle intestinali. Il principio degli economisti liberali della classe media era che gli uomini dovevano accettare quei lavori che il mercato offriva, quali che fossero le condizioni dell’offerta, e che un uomo razionale sarebbe ricorso al risparmio e alle assicurazioni, individualmente o attraverso iniziative collettive volontarie, per garantirsi contro gli incidenti, le malattie e la vecchiaia. Gli altri poveri, si ammetteva, non dovevano essere lasciati a morire di fame, ma non avrebbero dovuto ricevere più del minimo indispensabile (ammesso che esistesse un minimo inferiore ai salari più bassi offerti dal mercato). La legislazione riguardante i poveri, più che essere volta ad aiutare gli sfortunati, intendeva imprimere un marchio sui falliti della società che ammettessero di esserlo.
Gli anni fra il 1873 e il 1896 sono noti agli storici economici, che li hanno discussi più animatamente di quanto abbiano fatto con qualunque altra fase di congiuntura economica del secolo XIX, come il periodo della “grande depressione”. La “grande depressione” non può essere spiegata in termini esclusivamente britannici, perché fu un fenomeno di portata mondiale anche se i suoi effetti furono diversi da un paese all’altro e in alcuni, in modo particolare negli Stati Uniti, in Germania e in altri che da poco si erano affacciati sulla scena industriale, come i paesi scandinavi, costituì tutto sommato un periodo di straordinario progresso anziché di stagnazione. Tuttavia in complesso la “grande depressione” contrassegnò la fine di una fase dello sviluppo economico – la prima, o, se si preferisce, la fase “britannica dell’industrializzazione” – e l’inizio di un’altra. In termini generali, il boom della metà del secolo fu dovuto all’iniziale (o virtualmente iniziale) industrializzazione delle principali economie “sviluppate” all’esterno della Gran Bretagna, e al fatto che si aprirono alla produzione di beni primari e all’agricoltura nuove aree prima d’allora non sfruttate perché inaccessibili o sottosviluppate. Per quanto riguardava i paesi industriali, si trattò di una specie di estensione della rivoluzione industriale britannica e della tecnologia su cui questa era basata. Per quanto riguardava i produttori di beni primari, si trattò della costruzione di un sistema globale di trasporti basato sulla ferrovia, su navi migliori (e in misura sempre crescente azionate dal vapore), capace di collegare regioni utilizzabili economicamente con relativa facilità, e varie aree minerarie, ai loro mercati nei settori urbanizzati e industriali del mondo. Entrambi i processi stimolarono enormemente l’economia britannica senza peraltro arrecarle danni apprezzabili. Tuttavia, né l’uno né l’altro potevano continuare indefinitamente.
50

Ma la crisi non fu soltanto temporanea. Essa rivelò che molti altri paesi erano ormai diventati capaci di produrre da sé, magari anche per l’esportazione, quel che prima in pratica era stato disponibile soltanto in Gran Bretagna. E rivelò anche che la Gran Bretagna era preparata ad adottare solo uno dei possibili metodi, per fronteggiare la situazione. A differenza di altri paesi (per esempio la Francia, la Germania e gli Stati Uniti), che adottarono tariffe doganali protettive sia per la loro agricoltura sia per i loro mercati industriali interni, la Gran Bretagna si attenne fermamente al libero scambio. Essa fu poi ugualmente riluttante a battere quella strada della concentrazione economica sistematica – con la formazione di trust, cartelli, gruppi monopolistici e così via – che fu così caratteristica della Germania e degli Stati Uniti negli anni ‘80. Essa era troppo profondamente impegnata con la tecnologia e l’organizzazione affaristica della prima fase dell’industrializzazione, che l’avevano servita cosi bene, per aderire entusiasticamente a quella tecnologia e a quel tipo di conduzione industriale del tutto nuovi e rivoluzionari che avevano fatto la loro apparizione negli anni ‘90 del secolo. Questo la lasciò con una sola importante via d’uscita, tradizionale per il paese anche se adottata anche dalle potenze concorrenti: la conquista economica, e in misura crescente politica, delle aree mondiali non ancora sfruttate. La via, cioè, dell’imperialismo.
L’epoca della “grande depressione” diede cosi inizio all’epoca dell’imperialismo; di quell’imperialismo ufficiale che prese la forma della spartizione dell’Africa negli anni ‘80 del secolo scorso, di quell’imperiali -smo semiufficiale con consorzi nazionali o internazionali che assumevano la direzione finanziaria dei paesi deboli e di quello non ufficiale dato dagli investimenti all’estero. Occorre mettere in rilievo un’ulteriore conseguenza della grande depressione, vale a dire il sorgere di un gruppo concorrenziale di potenze industriali economicamente progredite. Si trattò della fusione della rivalità politica con quella economica, della fusione dell’iniziativa privata con l’appoggio statale, come è dimostrato da un rafforzamento del protezionismo e da un aumento della frizione imperialistica. In misura sempre crescente, il mondo degli affari, in un modo o in un altro si rivolgeva allo stato non soltanto per offrirgli mano libera, ma per salvarlo. Una nuova dimensione si affermò nell’ambito della politica internazionale, e, cosa significativa, dopo un lungo periodo di pace generale le grandi potenze si addentrarono in un’altra epoca di guerre mondiali.
[RI. 4-6]
0.3. Le radici economiche dell’imperialismo
Gli interessi economici del paese nel suo insieme sono subordinati a quelli di certi interessi particolari che usurpano il controllo delle risorse nazionali e le usano per il loro profitto privato. Questa non è un’accusa né strana né mostruosa: è la malattia più comune di tutte le forme di governo. Le famose parole di Sir Thomas More sono tanto vere ora come quando le scrisse: “ovunque vedo una cospirazione di uomini ricchi che cercano il proprio vantaggio sotto il nome e il pretesto del bene comune”. Sebbene il nuovo imperialismo sia stato un cattivo affare per il nostro paese, esso è stato un buon affare per certe classi e certi commerci all’in -terno della nazione. Le grandi spese per armamenti, le guerre costose, i gravi rischi e difficoltà della politica estera, i freni imposti alle riforme sociali e politiche interne, benché abbiano portato grave danno alla nazione, sono servite molto bene ai concreti interessi economici di certe attività e professioni.
È inutile occuparsi di politica se non si riconosce chiaramente questo fatto centrale e se non si capisce quali siano questi interessi particolari, nemici della salvezza nazionale e del bene pubblico. Dobbiamo abbandonare le analisi puramente sentimentali che spiegano le guerre e gli altri gravi errori nazionali come scoppi di animosità patriottica o come manchevolezze nell’arte di governo. Senza dubbio a ogni scoppio di guerra non solo l’uomo della strada, ma anche l’uomo in divisa è spesso ingannato dall’astuzia con cui motivazioni aggressive e avidi propositi si vestono con abiti difensivi. Infatti si può affermare con sicurezza che non vi è stata una sola guerra che si ricordi che, per quanto scopertamente aggressiva possa apparire allo storico spassionato, non sia stata presentata alla gente che era chiamata a combattere come una necessaria politica di difesa, in cui erano in ballo l’onore dello stato e forse anche la sua stessa esistenza. Si può vedere più chiaramente la vera natura politica dell’imperialismo se lo si confronta con le parole d’ordine di progresso condivise verso la metà del secolo da uomini moderati di entrambi i grandi partiti nazionali, sebbene con interpretazioni che variavano di grado: pace, economia, riforme e autogoverno popolare. Nemmeno ora troviamo alcun abbandono formale dei principi di governo che questi termini esprimono, e una larga fetta di liberali dichiarati crede o afferma che l’imperialismo non è in contraddizione con il mantenimento di tutte queste virtù. Questa affermazione tuttavia è smentita dai fatti. I decenni dell’imperialismo sono stati prolifici di guerre; molte di queste guerre sono state motivale direttamente dall’aggressione delle razze bianche sulle “razze inferiori”, e si sono concluse con la conquista con la forza del territorio. Ogni passo dell’espansione in Asia, Africa e nel Pacifico è stato accompagnato da spargimento di sangue; ogni potenza imperialista mantiene un esercito sempre più grande pronto per missioni all’estero; rettificazione delle frontiere, spedizioni punitive, e altri eufemismi usati al posto della parola guerra, sono
51

stati in continuo aumento. La Pax britannica, che era sempre stata una impudente falsità, è divenuta un grottesco mostro di ipocrisia. L’affermazione della scuola del “si pacem vis, para bellum” secondo cui solo gli armamenti costituiscono la migliore sicurezza per la pace, è basata sull’assunzione che esiste un vero e duraturo antagonismo di interessi tra i vari popoli che sono chiamati a subire questo mostruoso sacrificio.
La nostra analisi economica ha mostralo che vi è antagonismo solo tra gli interessi delle cricche concorrenti degli uomini d’affari investitori, imprenditori che lavorano su commesse statali, esportatori di manufatti, e certe classi professionali; essa ha mostrato che queste cricche, usurpando l’autorità e la voce del popolo, usano le risorse pubbliche per far avanzare i loro interessi privati, e spendono il sangue e il denaro del popolo in questo vasto e disastroso gioco militare, simulando antagonismi nazionali che non hanno base nella realtà. La follia disastrosa di queste guerre, il danno materiale e morale che ne deriva anche al vincitore, appare cosi chiaramente allo spettatore disinteressato che egli comincia a disperare che uno stato raggiunga l’età della ragione; e tende a considerare questi cataclismi come prodotti dall’esistenza di un irrazionalismo di fondo nella politica. Ma un’attenta analisi delle relazioni esistenti tra gli affari e la politica mostra che l’imperialismo aggressivo, che cerchiamo di spiegare, non è per niente il prodotto delle cieche passioni delle razze o della follia mista alle ambizioni dei politici. È molto più razionale di quanto non appaia a prima vista. Irrazionale com’è dal punto di vista dell’intera nazione, esso è invece perfettamente razionale dal punto di vista di alcune classi interne alla nazione.
Qual è dunque il diretto risultato economico dell’imperialismo? Un gran dispendio di denaro pubblico per navi, fucili, equipaggiamento e provviste per l’esercito e la marina, che cresce e produce enormi profitti quando ci si trova di fronte a una guerra o a un allarme di guerra; nuovi prestiti pubblici e fluttuazioni significative nelle borse interne e in quelle estere; più posti per soldati e marinai e per servizi diplomatici e consolari; miglioramento nelle condizioni di investimento all’estero tramite la sostituzione della bandiera straniera con quella britannica; conquista di mercati per certi tipi di esportazioni, protezione e assistenza per i commerci britannici in queste attività; occupazioni per ingegneri, missionari, cercatori d’oro, allevatori di bestiame e altri emigranti. Cosi alcuni interessi economici e professionali specifici che prosperano sulla spesa imperialistica o sulle conseguenze di tale spesa si contrappongono all’interesse comune, e, convergendo istintivamente verso una stessa meta, si trovano uniti da una grande comprensione reciproca nel sostenere qualsiasi impresa imperialistica. Nella stessa posizione stanno i grandi produttori di manufatti per l’esportazione, che guadagnano soddisfacendo i bisogni veri o artificiali dei nuovi paesi che noi annettiamo o verso i quali ci apriamo una strada. Manchester, Sheffield e Birmingham, per citare tre casi rappresentativi, sono pieni di fabbriche in concorrenza tra loro per imporre sui nuovi mercati tessuti e oggetti di metallo, motori, attrezzi, macchinari, liquori, armi da fuoco. I debiti pubblici che maturano nelle nostre colonie e nei paesi stranieri che cadono sotto il nostro protettorato o la nostra influenza, sono in grande misura prestiti che noi abbiamo fatto sotto forma di ferrovie, motori, armi da fuoco e altro materiale tecnicamente avanzato prodotto da fabbriche inglesi. La produzione di ferrovie, canali e altre opere pubbliche, l’insediamento di fabbriche, l’apertura delle miniere, il miglioramento dell’agricoltura nei nuovi paesi stimolano un interesse specifico in importanti industrie manifatturiere e alimentano una salda fede imperialista nei loro proprietari.
Da questo punto di vista le nostre colonie sono ancora come le descrisse cinicamente James Mill, “un vasto sistema di soccorso esterno per le classi ricche”. Alcuni importanti mercati esteri rappresentano una necessità economica per il nostro paese, perché con le sue esportazioni esso deve acquistare cibo e materiali grezzi che non può produrre, o che può produrre solo con grande difficoltà. Questo fatto fa sì che l’esistenza di un rilevante mercato estero diventi una questione di vitale importanza per la Gran Bretagna. Ma al di là dei limiti dì questa necessità pratica, è giusto considerare il valore dei nostri mercati esteri come misuralo non dal valore aggregato delle merci che vendiamo all’estero, ma dal maggior guadagno che otteniamo vendendole all’estero rispetto a quello che otterremmo vendendo le stesse merci sui mercati interni (o vendendo in essi corrispondenti quantità di altre merci). Infatti è del tutto ingiustificato assumere che, se queste merci non sono vendute all’estero, né quelle stesse merci, né loro sostituti potrebbero essere venduti sui mercati interni, nemmeno a prezzi inferiori; non esiste un limite naturale e necessario alla proporzione di prodotto nazionale che può essere venduto e consumato in patria. Naturalmente è preferibile vendere merci all’estero quando, cosi facendo, si possono ottenere maggiori profitti; ma il guadagno netto per l’industria e per il reddito nazionale deve essere misurato non dal valore della vendita all’estero, ma dal suo carattere più profittevole. Queste riflessioni sono necessarie per farci capire 1) che non è giusto misurare l’importanza del commercio estero tramite la proporzione esistente in ogni dato momento tra il suo volume e il suo valore da un lato e quelli dello scambio interno dall’altro; 2) che non è assolutamente necessario, per il progresso industriale di una nazione, che il suo commercio estero debba in ogni circostanza mantenersi al passo col suo mercato interno. Quando una nazione moderna ha raggiunto un alto livello di sviluppo in quelle attività industriali che riforniscono la sua popolazione delle merci più necessarie e utili, una porzione crescente delle sue energie produttive comincerà a venir dirottata verso generi superiori di attività industriali, verso i servizi di trasporto, verso la distribuzione e verso i servizi professionali, pubblici e privati; queste attività producono
52

merci e servizi meno adatti nel complesso al commercio internazionale di quelli più semplici su cui è concentrato lo sforzo produttivo nei più bassi stadi di civilizzazione. Se questo è vero, sembrerebbe che, mentre fino a un certo punto nello sviluppo della vita nazionale il commercio estero dovrà crescere rapidamente, da quel momento in poi esso dovrà declinare, non in misura assoluta di grandezza o di crescita, ma in misura relativa sia di grandezza sia di crescita.
Ma il fattore economico di gran lunga più importante per spiegare l’imperialismo riguarda gli investimenti. Il crescente cosmopolitismo del capitale è stato il principale cambiamento economico degli ultimi decenni. Ogni nazione industrialmente avanzata ha puntato a collocare una parte sempre maggiore dei suoi capitali al di fuori della sua area politica, in paesi stranieri, o nelle colonie, e a ricavare un reddito crescente da questa fonte. Non è esagerato dire che la politica estera moderna della Gran Bretagna si è concretizzata soprattutto in una lotta per accaparrarsi profittevoli mercati d’investimento. Un anno dopo l’altro la Gran Bretagna è diventata sempre più una nazione che vive sui tributi dall’estero, e le classi che ricevono questi tributi hanno avuto un incentivo continuamente crescente a utilizzare la politica dello stato, il tesoro pubblico e la forza pubblica per estendere il campo dei loro investimenti privati e per salvaguardare e migliorare gli investimenti già compiuti. Questo è, forse, il fatto più importante accaduto nella politica moderna; e l’oscurità in cui è avvolto costituisce un grave pericolo per il nostro paese.
Ciò che è vero della Gran Bretagna, lo è anche per la Francia, la Germania, gli Stati Uniti e tutti i paesi in cui il capitalismo moderno ha messo grandi risparmi eccedenti nelle mani di una plutocrazia o di una borghesia risparmiatrice. Una distinzione ben nota è quella che passa tra paesi creditori e debitori. La Gran Bretagna è stata per qualche tempo di gran lunga il più grande paese creditore; e la politica con cui le classi investitrici si servirono degli strumenti dello stato per i loro interessi privati è illustrata nel modo più ampio dalla storia delle sue guerre e annessioni. Ma la Francia, la Germania e gli Stati Uniti sono avanzati velocemente lungo lo stesso cammino. Ma, pur essendo utili a spiegare certi fatti economici, i termini “creditore” e “debitore” se applicati ai paesi oscurano l’aspetto più significativo di questo nuovo imperialismo. Infatti, mentre da un lato, come appare dall’analisi svolta sopra, molti debiti, forse la maggioranza, erano “pubblici”, dall’altro invece i crediti erano quasi sempre fatti da privati.
L’imperialismo aggressivo, che costa così caro al contribuente, che è di così scarso valore al produttore e al commerciante, che è causa di così gravi e incalcolabili pericoli per i cittadini, è invece una fonte di grandi guadagni per l’investitore che non riesce a trovare in patria impieghi profittevoli per il suo capitale e insiste che il governo lo aiuti per poter fare investimenti profittevoli e sicuri all’estero. E se ora, avendo in mente le enormi spese per armamenti, le guerre rovinose, l’impudenza o la frode diplomatica con cui i governi moderni cercano di estendere il loro potere territoriale, poniamo la semplice e pratica domanda: cui bono?, la prima e più ovvia risposta è: l’investitore. Gli investitori, che hanno collocato il loro denaro in terre straniere a condizioni che tengono pieno conto dei rischi connessi con la situazione politica del paese in cui investono, desiderano però usare le risorse del nostro governo per minimizzare questi rischi e aumentare così il valore del capitale e gli interessi sui loro investimenti privati.
Se è probabile che gli interessi particolari dell’investitore si scontrino con l’interesse pubblico e portino a una politica rovinosa, ancor più pericolosi a questo riguardo sono gli interessi particolari del finanziere, cioè di chi compra e vende i titoli di investimento. Infatti un gran numero dei piccoli investitori, per ragioni di affari e per politica, si comportano in larga misura come pedine delle grandi case finanziarie, che usano titoli e azioni non tanto come investimenti per ricavarne un interesse, quanto come strumenti di speculazione nel mercato del denaro. I magnati della borsa trovano il loro guadagno nel maneggiare grandi quantità di titoli e azioni, nel lanciare nuove società, nel manipolare le fluttuazioni dei valori dei titoli. Questi grandi interessi finanziari – le operazioni bancarie, quelle di intermediazione, il risconto, il lancio dei prestiti, la promozione di nuove società – formano il nucleo centrale del capitalismo internazionale. Uniti dai più forti legami organizzativi, sempre nel più stretto contatto l’uno con l’altro e pronti a ogni rapida consultazione, situati nel cuore della capitale economica di ogni stato, controllati, per quanto riguarda l’Europa, principalmente da uomini di una razza particolare, uomini che hanno dietro di sé molti secoli di esperienza finanziaria, questi grandi interessi finanziari sono in una posizione unica per manipolare la politica delle nazioni, Non è possibile utilizzare rapidamente una grande quantità di capitale se non con il loro consenso tramite le loro agenzie finanziarie. Qualcuno pensa davvero che uno stato europeo potrebbe iniziare una grande guerra, o che un cospicuo finanziamento statale potrebbe venir sottoscritto se la casa Rotschild e le sue associate vi si opponessero?
Ogni grande atto politico che implica un nuovo flusso di capitali, o una grande fluttuazione nei valori degli investimenti esistenti deve ricevere il benestare e l’aiuto concreto di questo piccolo gruppo di re della finanza. La politica di questi uomini, è vero, non porta necessariamente alla guerra; quando la guerra porterebbe un danno troppo grande e duraturo alla struttura industriale, che rappresenta il fondamento ultimo ed essenziale di ogni attività speculativa, essi usano la loro influenza in favore della pace. La finanza manipola le forze patriottiche di politici, soldati, filantropi e agenti di commercio: l’entusiasmo per
53

l’espansione che proviene da queste fonti, per quanto forte e genuino, è anormale e cieco; mentre l’interesse finanziario ha quelle qualità di concentrazione e di previsione di calcolo che sono necessarie per far funzionare l’imperialismo. Uno statista ambizioso, un soldato di frontiera, un missionario pieno di zelo, un commerciante intraprendente possono suggerire o perfino iniziare un passo di espansione imperiale, possono collaborare per istruire l’opinione pubblica patriottica sull’urgente bisogno di un nuovo avanzamento; ma la decisione finale rimane al potere finanziario. D’altra parte l’influenza diretta esercitata dalle grandi aziende finanziarie sull’“alta politica” è sostenuta dal controllo che esse esercitano sul corpo dell’opinione pubblica attraverso la stampa, che in ogni paese “civile” sta diventando sempre di più un loro obbediente strumento. Mentre i giornali finanziari specializzati impongono “fatti” e “opinioni” alla comunità degli affari, la maggior parte della stampa passa sempre di più sotto il dominio consapevole o inconsapevole dei finanzieri; il fatto che la stampa dipenda interamente per i suoi profitti dalle colonne di pubblicità, ha creato una riluttanza peculiare a opporsi ai gruppi finanziari organizzati che hanno il controllo di una parte molto grande di essa.
Quando lo spirito del nudo dominio ha bisogno di rivestirsi per mostrarsi alle classi istruite di una nazione, allora le necessarie decorazioni morali e intellettuali gli vengono cucite su misura; la chiesa, la stampa, la scuola e l’università, e la macchina politica, i quattro strumenti principali dell’istruzione popolare, sono adatti al suo servizio. Dal cristianesimo del “rimboccarsi le maniche” della generazione che ci precede al cristianesimo imperiale di oggi vi è solo un passo: l’aumento dei poteri attribuiti ai sacerdoti e la dottrina dell’autorità nelle chiese ufficiali si accordano bene col militarismo e con l’autocrazia politica. Goldwin Smith ha giustamente osservato come “la forza sia il naturale alleato della superstizione, e la superstizione lo sappia bene”. Quanto alla potentissima macchina della stampa e dei giornali, nella misura in cui non è direttamente posseduta e adoperata dai finanzieri per scopi finanziari (come è generalmente il caso in ogni grande centro industriale e finanziario), è sempre influenzata e spesso dominala dagli interessi delle classi che controllano la pubblicità da cui dipende la sua sopravvivenza; via via che il gruppo di interessi che formano il nucleo economico dell’imperialismo si rafforza e diventa più consapevole della sua politica, si fa ogni anno più rara e più precaria l’esistenza di giornali indipendenti, che abbiano una circolazione cosi vasta e cosi solida da poter “ controllare” o trattenere la pubblicità in barba a una politica che non piace alle classi che fanno la pubblicità.
La macchina politica è “mercenaria” perché è una macchina, e ha bisogno di costanti riparazioni e lubrificazioni da parte dei membri ricchi del partito; il macchinista sa da chi prende i soldi, e non può andare contro il volere di coloro che sono in effetti i padroni del partito e basta che stringano i cordoni della borsa per fermare automaticamente la macchina. Il recente imperialismo sia della Gran Bretagna che dell’America è stato materialmente aiutato dai generosi contributi di uomini come Rockfeller, Hanna, Rhodes, Beit alle finanze dei partiti per l’elezione di rappresentanti “imperialisti” e per l’educazione politica del popolo. Più serio di tutti è il persistente tentativo di assicurare il sistema scolastico all’imperialismo mascherato da patriottismo. Catturare l’infanzia del paese, meccanizzare il suo libero gioco nella routine dell’esercitazione militare, coltivare le sopravvivenze selvagge della combattività, avvelenare la sua prima comprensione della storia con false idee e pseudo-eroi, e di conseguenza con la denigrazione e l’ignoranza di ogni lezione del passalo veramente vitale e nobile, stabilire un punto di vista “geocentrico” dell’universo morale in cui gli interessi dell’umanità sono subordinati a quelli del “paese” (e così, con una facile rapida e naturale deduzione, quelli del “paese” a quelli dell’“io”), alimentare l’orgoglio sempre arrogante della razza in un’età in cui il più delle volte prevale una fiducia in sé, che per necessaria conseguenza porta a disprezzare le altre nazioni, e in questo modo avviare i bambini alla vita con false misure di valore e senza il desiderio di apprendere dalle fonti straniere – imprimere questa insularità di fondo della mentalità e della morale all’infanzia di una nazione e chiamarlo patriottismo è il più scorretto abuso di educazione che sia possibile immaginare.
Tuttavia il potere della chiesa e dello stato sull’istruzione primaria è volto coerentemente a questo scopo, mentre la mescolanza di clericalismo e accademismo autocratico che domina l’istruzione secondaria di questo paese riversa il suo entusiasmo negli stessi nefasti canali. Infine, i massimi centri della nostra cultura, le università, corrono il pericolo di una nuova distorsione della libertà di indagine e di espressione. Un nuovo tipo di “pio fondatore” minaccia la libertà intellettuale. Le nostre università, invero, non devono più essere i difensori fedeli della ortodossia religiosa, coloro che reprimono la scienza, falsificano la storia, e plasmano la filosofia in modo da preservare gli interessi della chiesa e del re. Gli studi accademici e i loro insegnanti devono impiegare gli stessi metodi ma per scopi differenti: la filosofia, la scienza naturale, la storia, l’econo-mia, la sociologia, devono ora essere impiegate per elevare nuove fortezze contro l’attacco delle masse diseredale agli interessi costituiti della plutocrazia. L’insegnamento effettivo è scelto e controllato, ovunque si trovi utile impiegare le arti della selezione e del controllo, dagli interessi economici che utilizzano gli interessi accademici costituiti. Non si può seguire la storia della teoria economica e politica durante l’ultimo secolo senza riconoscere che la selezione e il rifiuto di determinate idee, ipotesi e formule, la loro
54

organizzazione in scuole e tendenze di pensiero, e la propaganda di esse nel mondo intellettuale, sono state chiaramente orientate dalla pressione degli interessi di classe. Come si può ben sospettare, è nell’economia politica, a causa del suo vertere sugli affari e sulla politica, che si trova l’esempio più probante.
L’interferenza con la libertà intellettuale è raramente diretta, raramente personale, sebbene tanto negli Stati Uniti che nel Canada si siano avuti casi della più volgare caccia alle streghe. Il vero pericolo sta nella nomina di un insegnante piuttosto che nella sua cacciata, nella definizione degli argomenti che devono essere insegnati, nell’attenzione relativa che deve essere attribuita a ogni questione, e in quali testi e altro materiale didattico deve essere usato. L’ossequio al rango e al denaro, perfino nelle antiche università inglesi, è stato messo così a nudo, e la necessità di nuovi aiuti finanziari per sviluppare nuove facoltà neppure necessariamente così grande agli occhi degli accademici, che il pericolo che abbiamo indicato cresce sempre. Non è tanto il peso della “manomorta” che bisogna temere, quanto quello di quella viva: un’università così sfortunata da dare posti a insegnanti che, trattando le questioni vitali della politica e dell’economia, insegnano verità profondamente e ovviamente antagonisliche rispetto agli interessi delle classi di cui aveva richiesto l’aiuto finanziario, commetterebbe un suicidio.
Se le cose stanno cosi, è inevitabile che l’imperialismo cerchi sostegno intellettuale nei nostri contri di cultura e che usi il nerbo dell’istruzione per questo scopo. Il milionario che fa una donazione a Oxford non compra apertamente gli uomini che devono insegnare e non ha nemmeno bisogno di stabilire per contratto quello che deve essere insegnato. Ma la pressione pratica dell’imperialismo è tale che quando si nomina un professore di storia è diventato sempre più difficile assicurarsi la nomina, per studiosi che seguono le tendenze intellettuali di un John Morley, di un Frederik Harrison o di un Goldwin Smilh, così come essere scelto alla cattedra di economia per un economista che ha idee radicale sulla necessità di controllare il capitale. Non è necessaria alcuna prova formale: l’istinto dell’autoconservazione finanziaria è sufficiente. Il prezzo che le università pagano preferendo il denaro e la posizione sociale alla distinzione intellettuale nella scelta del rettore e andando a cercare soldi tra i milionari per l’attrezzatura di nuove scuole scientifiche è questa obbedienza agli interessi politici ed economici dei loro padroni: la loro filosofia, la loro storia, la loro economia, perfino la loro biologia deve riflettere nella dottrina e nel metodo la considerazione che si deve al proprio mecenate, e il fatto che questa deferenza sia inconscia aumenta il danno arrecato alla causa della libertà intellettuale. Ma questi argomenti non sono conclusivi. È possibile che gli imperialisti rispondano così: “Dobbiamo avere mercati per i nostri prodotti in continuo aumento, dobbiamo avere nuovi sbocchi per investire il nostro sovrappiù di capitale e per utilizzare le energie della popolazione in eccesso: una tale espansione è una necessità vitale per una nazione con una capacità produttiva grande e sempre crescente come la nostra. Per quanto questo processo di espansione imperiale sia costoso e pericoloso, esso è necessario perché la nostra nazione continui a esistere e a progredire; se noi l’abbandonassimo dovremmo rassegnarci a lasciare lo sviluppo del mondo ad altre nazioni, che dappertutto si infiltrerebbero nei nostri commerci; e perfino metterebbero in difficoltà i mezzi che abbiamo per procurarci il cibo e le materie prime necessarie per la nostra popolazione. Si vede cosi che l’imperialismo non è una scelta ma una necessità”.
[IM. I.2; II,1-3]
0.4. Il mercato mondiale del capitale finanziario
Gli effetti concreti di questa argomentazione economica sulla politica sono illustrati in modo sorprendente dalla storia recente degli Stati Uniti. Questo paese ha rotto improvvisamente con la sua politica conservatrice, che era stata sostenuta fermamente da entrambi i suoi partiti politici ed era legata alle tendenze istintive e tradizionali della popolazione americana; esso si è gettato in una rapida carriera imperiale, per la quale non possedeva l’equipaggiamento né materiale ne morale, mettendo a repentaglio i principi e la pratica della libertà e dell’eguaglianza per instaurare una politica militarista e per soggiogare con la forza popoli che non ha poi potuto far partecipare alle condizioni proprie della cittadinanza americana.
Questo fatto di voler far volare l’aquila americana è stato un puro capriccio, uno scoppio di ambizione politica da parte di una nazione arrivata a un’improvvisa realizzazione del suo destino? Niente affatto. Lo spirito d’avventura, la “missione di civiltà” americana, come forze propulsive dell’imperialismo, sono stati chiaramente subordinati alla forza determinante del fattore economico. Il carattere drammatico del cambiamento di rotta è causato appunto dalla rapidità senza precedenti con cui si è sviluppala la rivoluzione industriale negli Stati Uniti a partire dagli anni ‘80. Durante quel periodo gli Stati Uniti, con le loro ricchezze naturali senza pari, le loro immense risorse di lavoro specializzato e generico, e il loro genio per l’invenzione e l’organizzazione, svilupparono l’economia industriale meglio attrezzata e più produttiva che si sia mai vista al mondo. Favorite da rigide tariffe protettive, le loro industrie metallurgiche, tessili, meccaniche, di confezioni, di mobili e così via sbocciarono nel corso di un’unica generazione dall’infanzia alla piena maturità e, dopo essere passate per un periodo di intensa concorrenza, conseguirono, sotto la direzione di
55

abili imprenditori fondatori di grandi cartelli industriali, una capacità produttiva maggiore di quella che fosse mai stata raggiunta nei paesi industriali più avanzati d’Europa.
Un periodo dì concorrenza sfrenata, seguito da un rapido processo di fusioni, gettò un’enorme quantità di ricchezza nelle mani di un piccolo numero di capitani d’industria. In effetti, la presenza contemporanea di concorrenza spietata da un lato, e di concentrazione industriale dall’altro, è prova tangibile del grado di congestione di capitale esistente nelle industrie manifatturiere che sono entrate nell’economia delle macchine. Non ci riferiamo qui ad alcuna questione teorica relativa alla possibilità di produrre con i metodi delle macchine moderne più merci di quante possano trovare un mercato. Ai nostri fini è sufficiente notare che la capacità produttiva di un paese come gli Stati Uniti può crescere così in fretta da eccedere la domanda del suo mercato interno. Chiunque abbia dimestichezza con queste cose non potrà negare un fatto che tutti gli economisti americani riconoscono; cioè che questa condizione è appunto stata raggiunta dagli Stati Uniti alla fine del secolo, almeno per quanto riguarda le industrie più sviluppate. Le sue attività manifatturiere erano sature di capitali e non ne potevano assorbire più.
Fu chiaramente questa improvvisa domanda di mercati esteri per le merci e per gli investimenti la responsabile dell’adozione dell’imperialismo come politica e come pratica da parte del partito repubblicano, al quale appartenevano appunto i grandi capitani d’industria e i grandi finanzieri e che era da essi controllato. L’entusiasmo avventuroso del presidente Theodore Roosevelt e il suo “partito del destino” e della “missione ci-vilizzatrice” non ci devono ingannare. Furono i Rockefeller, i Pierpont Morgan e i loro associati che ebbero bisogno dell’imperialismo e che lo imposero saldamente sulle spalle di questa grande repubblica occidentale. Essi avevano bisogno dell’imperialismo perché volevano usare le risorse nazionali del loro paese per trovare un utilizzo conveniente per il loro capitale che altrimenti sarebbe risultalo superfluo. Perfino la Gran Bretagna era pressata a difendersi e si dava al protezionismo. I grandi produttori e finanzieri americani dovevano così guardare alla Cina, al Pacifico e al sud America per cercare occasioni più profittevoli; protezionisti per principio e per pratica, essi insistettero per procurarsi il più stretto monopolio possibile di questi mercati. La spesa pubblica necessaria per intraprendere una espansione imperiale di questo tipo rappresentava una immensa occasione di profitto per questi uomini, come finanzieri negoziatori di prestiti, come costruttori o proprietari di navi sostenuti dai sussidi del governo, come fornitori e produttori di armi e di altri strumenti dell’imperialismo.
La rapidità di questa rivoluzione politica è dovuta alla rapidità con cui questo bisogno si è manifestato. L’imperialismo americano è stato così il prodotto naturale di una pressione economica causata da un rapido balzo avanti del capitalismo Usa che non poteva più trovare in patria un impiego adeguato per i propri prodotti e per i propri investimenti e perciò aveva bisogno di mercati esteri. Questi stessi bisogni esistevano anche nei paesi europei e, come è noto, portarono i governi lungo lo stesso cammino. La sovraproduzione, vale a dire l’esistenza di impianti manifatturieri eccessivi da un lato, e il sovrappiù di capitale che non poteva trovare un investimento profittevole all’interno del paese dall’altro, forzarono la Gran Bretagna, la Germania, l’Olanda, la Francia a collocare porzioni sempre più grandi delle loro risorse economiche al di fuori dell’area del loro attuale dominio politico.
È questa situazione che rappresenta la radice economica dell’imperialismo. Se i consumatori del nostro paese aumentassero il loro livello di consumo in modo tale da mantenere il passo con l’aumento della nostra capacità produttiva, non vi sarebbe un eccesso di merci o di capitali così rilevante da farci usare l’imperiali -smo per trovare mercati “di sbocco”: il commercio estero, naturalmente, esisterebbe lo stesso; ma non vi sarebbe difficoltà a scambiare un piccolo sovrappiù dei nostri manufatti con il cibo e le materie prime di cui abbiamo annualmente bisogno. Perciò, se ci sono beni che non possono essere consumati, o che non possono nemmeno venire prodotti perché è evidente che non saranno consumati, e se c’è una quantità di capitale e di lavoro che non può trovare piena occupazione perché i suoi prodotti non possono essere consumati, l’unica spiegazione possibile di questo paradosso è che coloro che hanno capacita di consumare si rifiutano in realtà di trasformare questa capacità in effettiva domanda di merci. Ma nessuno può seriamente sostenere che una cattiva direzione possa essere la causa delle saturazioni ricorrenti dell’industria moderna e delle sue conseguenti depressioni; o che, quando si verifica una crisi di sovraproduzione nelle principali manifatture, vi siano ampie possibilità dì utilizzo in altre industrie per il capitale in sovrappiù e per il lavoro. Il carattere generale di questo eccesso di capacità produttiva è provato d’altra parte dall’esistenza in questi periodi di grandi depositi bancari di denaro inutilizzalo che cerca ogni sorta di investimento profittevole e non ne trova nessuno. Se esistesse una tendenza a distribuire la ricchezza o la capacità di consumo secondo i bisogni, è evidente che i consumi crescerebbero con ogni aumento della capacità produttiva, poiché i bisogni umani sono illimitati, e non potrebbe esistere un eccesso di risparmio. Ma la situazione è completamente diversa in una economia dove la distribuzione non ha una relazione fissa con i bisogni, ma è determinata da altre condizioni che attribuiscono ad alcune persone una capacità di consumo largamente superiore ai loro bisogni o ad ogni possibile uso, mentre altri sono privati della possibilità di consumare perfino quello che serve a mantenere la loro efficienza fisica.
56

Il risultato è quello di una cronica congestione di capacità produttiva e di merci prodotte che abbassa i prezzi interni, che spreca molto denaro in pubblicità per cercare di ottenere delle ordinazioni e che, periodicamente, causa una crisi seguita da un crollo, durante il quale grandi quantità di lavoro e di capitale rimangono inutilizzate e senza remunerazione. L’obiettivo principale del cartello o di ogni altro tipo di unione e appunto quello di rimediare a questo spreco e a queste perdite sostituendo l’avventata sovraproduzione con una regolamentazione dell’attività produttiva. Ma per ottenere questo il cartello stringe o anche chiude i vecchi canali di investimento, e limita la corrente del risparmio che viene investito all’esatto ammontare richiesto per mantenere normale la produzione corrente. Tuttavia questa rigida limitazione, a sua volta, sebbene sia richiesta dall’economia di ogni cartello preso separatamente, non conviene al titolare del cartello, che è portato a compensare la regolamentazione della produzione in patria, con l’apertura di nuovi canali esteri capaci di assorbire la sua produzione ed i suoi risparmi eccedenti. Si arriva così alla conclusione che l’imperialismo rappresenta lo sforzo dei grandi controllori dell’industria di allargare il canale per far affluire la loro ricchezza eccedente alla ricerca di mercati e di occasioni d’investimento all’estero che possano assorbire merci e capitali che essi non sono in condizione di vendere o di usare in patria.
Abbiamo spiegato quali sono le forze dominanti dell’interesse di classe che stimolano e sostengono questa falsa politica economica. E non vi è certo nessuna garanzia che queste forze non continuino ad operare in questo modo anche nel futuro. È inutile attaccare l’imperialismo o il militarismo nella loro manifestazione politica se non si punta l’ascia alla radice economica dell’albero e se le classi che hanno interesse all’imperialismo non vengono private dei redditi eccedenti che cercano questo sfogo. Abbiamo identificato con l’imperialismo quasi tutti gli interessi organizzati che sono comunemente considerati come interessi capitalistici, inclusa la proprietà della terra. La maggior parte di essi partecipano direttamente all’uno o all’altro dei due tipi di vantaggi che scaturiscono da questa politica: gli interessi, i profitti, e gli impieghi creati dalla politica imperialista, o gli interessi, i profitti e gli impieghi legati direttamente alle stesse spese militari e civili. Non si può certo negare che una spesa pubblica continuamente crescente, a parte ogni giustificazione politica, sia una fonte diretta di guadagno per certi interessi ben organizzati e potenti; e che per essi la politica imperialista rappresenti lo strumento principale per ottenere questo aumento di spesa. Inoltre, mentre chi dirige questa politica decisamente parassitaria sono dei capitalisti, essa può tuttavia far presa su gruppi specifici di lavoratori. In molte città le più importanti attività dipendono da impieghi e contratti pubblici; l’atteggiamento filo-imperialista dei centri metallurgici e dei cantieri navali è da attribuirsi in non piccola misura a questo elemento, I parlamentari utilizzano apertamente la loro influenza per assicurare contratti ed affari diretti ai loro elettori e ogni aumento della spesa pubblica gonfia questa pericolosa tendenza.
Ma il più chiaro significato della finanza imperialista, tuttavia, appare non dal lato della spesa, ma da quello della tassazione. Gli obiettivi di quegli interessi economici che usano la borsa pubblica per scopi di guadagno privato sarebbero in larga misura sconfitti se essi dovessero trovare i soldi per riempire quella borsa. Far passare l’incidenza diretta della tassazione dalle loro spalle a quelle di altre classi o della posterità è per loro una naturale politica di auto-difesa. D’altra parte, se le forze capitalistico-imperialiste volessero scaricare apertamente il peso della tassazione sulle spalle del popolo, con un sistema di governo a suffragio popolare risulterebbe assai difficile varare una politica così dispendiosa. La gente deve pagare, ma non deve sapere che sta pagando o quanto sta pagando; e il pagamento deve essere diluito su un periodo quanto più lungo possibile. Sarebbe effettivamente impossibile finanziare la politica imperialista con una tassazione diretta dei redditi o delle proprietà. Se ogni cittadino fosse messo in grado di rendersi direttamene conto del costo del militarismo e della guerra pagando in denaro contante, militarismo e guerra non potrebbero esistere in tutti i luoghi in cui è presente una forma qualsiasi di controllo popolare. Perciò l’imperialismo tende ovunque ad incrementare la tassazione indiretta: non tanto per ragioni di convenienza, quanto per nascondere le cose. O forse sarebbe più giusto dire che l’imperialismo si avvantaggia della preferenza codarda e stupida che hanno gli uomini della strada di farsi ingannare con i contributi al fondo pubblico; esso usa questa comune follia per il proprio vantaggio. È raro che un governo, anche nel mezzo di gravi fatti d’emergenza, sia in grado di imporre un’imposta sui redditi; d’altra parte anche le imposte sulla proprietà sono generalmente evase quando riguardano la proprietà mobiliare; e sono sempre impopolari. È tuttavia probabile che si farà un tentativo di nascondere il carattere complessivo della politica protezionista nelle nebbie della propaganda dell’imperialismo. La protezione non si chiamerà protezione, ma libero scambio all’interno dell’impero; una tariffa protezionista nasconderà il suo aspetto discriminatorio e si maschererà da tassa comune per i paesi dello Zolverein imperiale. I grandi cambiamenti economici, che richiedono l’uso di una determinata macchina politica, inventano quella macchina; così anche l’imperialismo si sforzerà di nascondere il sistema finanziario protezionista, che cerca di costruire, sono un grande risultato politico chiamato Federazione dell’Impero. La probabilità di successo in questo tentativo di federazione è cosa che va considerata a sé; qui la questione ci interessa solo come strada verso la protezione. Da molte parti così diventa chiaro che il protezionismo è il naturale alleato dell’imperialismo.
57

La radice economica dell’imperialismo è il desiderio di forti interessi organizzati della finanza e dell’in-dustria di assicurarsi e di sviluppare a spese della nazione e con la forza dello stato nuovi mercati per le loro merci e i loro capitali eccedenti. La guerra, il militarismo e un’“ardente politica estera” sono i mezzi necessari a questo scopo. Questa politica implica un largo aumento della spesa pubblica. Se gli imperialisti dovessero attingere il denaro necessario dalle loro tasche con le imposte sui redditi e sulla proprietà il gioco non varrebbe la candela; almeno per quanto riguarda i mercati delle merci. Essi devono trovare il modo di far ricadere le spese sul grande pubblico. Ma nei paesi in cui esiste il suffragio popolare e un governo rappresentativo ciò non può esser fatto apertamente. La tassazione deve essere indiretta e deve cadere su quegli articoli di consumo o di uso generale che fanno parte del livello comune di vita e la cui domanda, se vengono tassati, non diminuisce o non si sposta verso sostituti. Questa protezione non serve solo gli scopi della finanza imperiale, che tassa il consumatore ignorante e impotente per procurare lauti guadagni a influenti interessi economici: a quanto sembra essa fornisce a questi, come produttori, anche un secondo vantaggio perché protegge il loro mercato interno che è minacciato dalla concorrenza estera e perché gli permette di aumentare i prezzi nei confronti dei consumatori del loro paese; cosa che gli dà la possibilità di ottenere più alti profitti.
Per coloro i quali pensano che il commercio estero in condizioni normali sia uno scambio leale di merci e di servizi, può sembrare difficile spiegare come questi interessi economici si propongano da un lato di e-scludere le merci estere dai loro mercati, mentre allo stesso tempo cercano di spingere le loro merci sui mercati esteri. Ma dobbiamo ricordare a questi economisti che qui il primo motore non è il commercio, ma l’investimento: si ritiene infatti che un’eccedenza di esportazioni rispetto alle importazioni sia il modo più conveniente per favorire gli investimenti all’estero; e quando una nazione (o più precisamente le sue classi investitrici) ha deciso di diventare un paese creditore o parassita senza alcun limite, non c’è ragione perché le sue esportazioni e le sue importazioni debbano essere in pareggio perfino in un lungo periodo di anni. Tutta la lotta del cosiddetto imperialismo sul fronte economico è una lotta per un crescente parassitismo e le classi impegnate in questa lotta chiedono la protezione come il loro più utile strumento. La protezione, tuttavia, non è il solo metodo finanziario adatto all’imperialismo.
Infatti in ogni momento esiste un limite definito alla quantità di spesa corrente che può essere finanziata tassando i consumatori; mentre invece la politica dell’imperialismo per essere efficace richiede a volte la spesa di grosse somme impreviste per la guerra e per gli equipaggiamenti militari. Queste spese non possono essere coperte dalla tassazione corrente; debbono essere trattate come spese in conto capitale, il cui pagamento può essere differito indefinitamente, oppure coperto da un fondo di ammortamento che si forma lentamente e che rimane in sospeso per lungo tempo. Inoltre, la creazione del debito pubblico è una caratteristica usuale e significativa dell’imperialismo. Come la protezione, anch’esso serve a un doppio scopo: da un lato fornisce una alternativa per sfuggire alla tassazione sui redditi e sulla proprietà che altrimenti sarebbe inevitabile, dall’altro crea una forma utilissima di investimento molto vantaggioso per risparmi inutilizzati. Così la creazione di un debito pubblico grande e crescente non è solo la conseguenza necessaria di una spesa imperialista troppo grande per le entrate correnti, o di una qualche improvvisa estorsione forzata per un’indennità di guerra o altra penalità pubblica; è anche un obiettivo diretto della finanza imperialista, così come l’obiettivo dell’usuraio è di spingere il cliente in mezzo a difficoltà finanziarie in modo che esso debba continuare a ricorrere a lui. Un’analisi degli investimenti esteri dimostra che i debiti pubblici o garantiti dallo stato sono in larga misura nelle mani di investitori e finanzieri di altre nazioni; e la storia mostra, nei casi dell’Egitto, della Turchia e della Cina, quale sia il peso che hanno sulla politica i proprietari di titoli pubblici, o i potenziali proprietari di essi.
D’altra parte questo mezzo finanziario non è solo conveniente nei casi di nazioni straniere, nei cui riguardi esso rappresenta uno strumento importante o un pretesto per commettere abusi; per le classi finanziarie l’esistenza di un grosso debito nazionale rappresenta un notevole vantaggio. Mettere in circolazione e trattare questi prestiti pubblici è un grosso affare e un mezzo per esercitare importanti pressioni politiche nei momenti cruciali. Infine, dove il capitale tende continuamente ad essere eccessivo, ulteriori debiti servono come mezzo di drenaggio finanziario. Così l’imperialismo con le sue guerre e i suoi armamenti è senza dubbio responsabile per i debiti crescenti delle nazioni continentali; e mentre la prosperità industriale senza pari della Gran Bretagna e l’isolamento degli Stati Uniti hanno permesso a queste due nazioni negli ultimi decenni di sfuggire a questa rovinosa gara all’indebitamento, il periodo della loro immunità è finito; entrambe, impegnate come sembrano in un imperialismo senza limiti, soccomberanno sempre di più alle loro classi che prestano denaro vestite da imperialiste e da patriote.
Le più importami riforme sociali, come il miglioramento del sistema dell’istruzione pubblica, un ampio intervento nelle questioni del suolo e della casa in città e in campagna, il controllo pubblico del traffico degli alcolici, le pensioni di vecchiaia, la legislazione per migliorare le condizioni dei lavoratori – comportano considerevoli spese di denaro pubblico ottenuto con la tassazione imposta dalle autorità centrali e locali. Ora, con le spese militari sempre crescenti, l’imperialismo chiaramente prosciuga i fondi del denaro pubblico che
58

potrebbe essere impiegato per questi scopi. Gli interessi costituiti che noi consideriamo come i principali promotori della politica imperialista, mirano a un doppio scopo, perché cercano di ottenere un loro guadagno privato commerciale e finanziario a costo di spese e pericoli per la comunità; e al tempo stesso perché proteggono la loro supremazia economica e politica in patria dai movimenti per le riforme sociali. Il proprietario di aree edificabili, il proprietario terriero, il banchiere, l’usuraio; e poi il finanziere, il fabbricante di birra, il proprietario di miniere, il padrone della ferriera, il costruttore di navi; e poi gli esportatori, i produttori per l’esportazione e i mercanti, il clero della chiesa di stato, le università e le grandi scuole privale, i sindacati legali e i funzionari pubblici si sono uniti, tanto in Gran Bretagna che sul continente, per organizzare una comune resistenza politica contro attacchi al potere, alla proprietà e ai privilegi che essi rappresentano in varie forme e gradi. Dopo che dietro la pressione delle masse è stata concessa la forma del potere politico, ossia le istituzioni elettive e un largo diritto di voto, essi stanno lottando per impedire alle masse di ottenere la sostanza di questo potere e di usarlo per stabilire una uguaglianza nelle condizioni economiche.
È, invero, una nemesi dell’imperialismo che le arti e i mestieri della tirannia, acquisite e esercitate nel nostro impero illiberale, siano rivolle contro le nostre libertà in patria. Coloro che sono stati colti di sorpresa dalla totale noncuranza o dall’aperto disprezzo mostrato dall’aristocrazia e dalla plutocrazia di questo paese per l’infrazione delle libertà del cittadino e per l’abrogazione dei diritti e delle usanze costituzionali non hanno consideralo a sufficienza il costante riflusso del veleno dell’autocrazia irresponsabile dal nostro impero “illiberale, intollerante e aggressivo”. Gli effetti politici, reali e necessari, del nuovo imperialismo, cosi come si mostrano nel caso della più grande potenza imperialista, possono essere riassunti in questo modo. Esso è una minaccia costante alla pace, fornisce continue tentazioni di ulteriori aggressioni su terre occupate da “razze inferiori” e fomenta la discordia tra la nostra nazione e le altre nazioni con ambizioni imperialistiche rivali; all’acuto pericolo di guerra aggiunge il pericolo cronico e la degradazione del militarismo, che non guasta solo le concrete risorse fisiche e morali delle nazioni, ma blocca il corso stesso della civiltà. Consuma in modo illimitato e incalcolabile le risorse finanziarie di una nazione con i preparativi militari, bloccando la spesa delle entrate correnti dello stato per progetti pubblici produttivi e gravando la posterità con pesanti carichi di debito. L’imperialismo sta solo cominciando a mettere in pratica tutte le sue risorse e a fare del governo delle nazioni un’arte raffinata: la larga concessione del diritto di voto, controllato da un popolo la cui istruzione ha raggiunto lo stadio della capacità di leggere carta stampata senza esercitare alcuna critica, favorisce immensamente i disegni degli astuti politici affaristi che, controllando la stampa, la scuola, e se necessario la chiesa, impongono l’imperialismo alle masse nella forma attraente di un patriottismo sensazionale.
Abbiamo anche intravisto la possibilità di una più ampia alleanza di stati occidentali, una federazione europea di grandi potenze che, lungi dal promuovere la causa della civiltà mondiale, potrebbe presentare il gigantesco pericolo di un parassitismo occidentale, prodotto dall’esistenza di un gruppo di nazioni industriali avanzate, le cui classi superiori ricevessero grandi tributi dall’Asia e dall’Africa, coi quali manterrebbero vaste e docili masse di dipendenti, non più occupati nelle principali attività dell’agricoltura e della manifattura, ma nei servizi personali o in attività industriali minori sotto il controllo di una nuova aristocrazia finanziaria. Coloro che deridono questa teoria e non la giudicano degna di considerazione guardino alle odierne condizioni economiche e sociali delle regioni dell’Inghilterra meridionale che sono già ridotte in questo stato, e riflettano sulla vasta estensione che questo sistema potrebbe assumere se la Cina fosse sottomessa al controllo economico di simili gruppi di finanzieri, investitori, e funzionari politici e economici, che assorbirebbero la più grande riserva potenziale di profitti che il mondo abbia mai conosciuto, per consumarla in Europa. La situazione è troppo complessa, e il gioco delle forze mondiali troppo imprevedibile, perché questa o qualsiasi altra interpretazione in un solo senso del futuro sia possibile: ma le tendenze che oggi dominano l’imperialismo dell’Europa occidentale si muovono in questa direzione e, a meno che non siano contrastate o deviate, portano verso una conclusione di questo tipo.
Se le classi dirigenti delle nazioni occidentali potessero realizzare i loro interessi con una simile combinazione (e ogni anno il capitalismo diventa più internazionale), e se la Cina non fosse in grado di sviluppare una resistenza armata, si presenterebbe certamente l’eventualità di un impero parassita che riprodurrebbe su vasta scala molti aspetti dell’impero romano quando era verso la fine. Questo porterebbe la logica dell’imperialismo molto lontano sulla via della sua realizzazione; le sue necessarie tendenze di fondo all’oligarchia incontrollata in politica e al parassitismo in economia, sarebbero apertamente mostrate dalla condizione delle nazioni “imperialiste”. La maggior parte dell’Europa occidentale potrebbe allora assumere l’aspetto e il carattere che hanno già alcuni luoghi come il sud dell’Inghilterra, la Riviera e alcune zone dell’Italia e della Svizzera piene di turisti e di ricchi residenti, piccoli nuclei di ricchi aristocratici che ricevono dividendi e pensioni dall’Estremo Oriente e che hanno con sé un gruppo un po’ più ampio di impiegati e commercianti e un vasto gruppo di servitori personali e lavoratori occupati nei trasporti e negli stadi finali della lavorazione dei beni più deperibili: tutti i principali rami dell’attività economica
59

scomparirebbero e i principali beni alimentari e prodotti manufatti arriverebbero come un tributo dall’Asia e dall’Africa.
In che misura l’avvento del Giappone allo stato di potenza politica e industriale di prim’ordine influirà sul problema dell’imperialismo in Asia è una domanda che si presenta in modo sempre più pressante all’atten-zione delle nazioni occidentali. Tuttavia, è impossibile nascondersi ciò che il recente comportamento del Giappone, come nazione orientale dotata di tutte le capacità pratiche della civiltà occidentale, ha mostrato, ossia che esso è in grado di alterare profondamente il corso della storia asiatica nel prossimo futuro; questi vantaggi derivano in parte da certe energie mentali che i giapponesi dimostrano, e in parte dai fattori geografici e razziali della situazione. Riassumendo i fatti noti, sembra che i giapponesi, come popolo, abbiano assimilato in due generazioni tutte le conoscenze meccaniche e politiche dell’occidente che contribuiscono alla forza militare, commerciale e sociale di una nazione; mentre, d’altra parte, sono in grado di far funzionare questi strumenti della civiltà con altrettanta cura e in modo più economico per la collettività di quanto abbiano fatto tutte le nazioni che gli sono state maestre.
Se questa è “imitazione” è un’imitazione molto intelligente, poiché è noto che i giapponesi hanno scelto accuratamente le armi, le macchine, le leggi e le abitudini da adottare, e che essi fanno funzionare le loro istituzioni politiche, sociali ed economiche facilmente e in modo efficiente. Il meraviglioso successo del Giappone sembra che sia in larga misura dovuto a due fonti interne alla sua economia. In primo luogo, sembra che i giapponesi siano in grado di fornire una grande quantità di energie mentali alle complesse operazioni della vita moderna senza lo spreco di energie nervose che si ha tra i popoli occidentali: sembra che essi compiano più facilmente una maggiore quantità di lavoro mentale. In secondo luogo, sembra che uno spirito civico più diffuso, più intenso e più incoraggiato produca una migliore cooperazione delle attività individuali per il bene comune di quanto non si abbia presso alcun popolo occidentale: vi è meno spreco da indolenza, corruzione o altra malattia burocratica, mentre un’alta considerazione per il servizio pubblico pervade la mentalità popolare. Questo intenso patriottismo e questo sacrificio di sé possono essere solo le sopravvivenze psicologiche di un vecchio ordine sociale che sta scomparendo; ma finché permane, esso offre una grande forza operativa per ulteriori attività.
È possibile che sia aperta al Giappone una tale occasione per giocare un nuovo grande ruolo nella storia dell’imperialismo: se è così, non sembra che le sue alleanze temporanee con le potenze europee lo spostino da un corso che sembra al suo popolo un chiaro esempio di “destino manifesto” come una delle tante imprese dell’imperialismo annoverate negli annali dell’Inghilterra e degli Stati Uniti. Pensando alle possibilità di realizzazione di questo nuovo capitolo della storia mondiale, molto dipende dalla misura in cui il Giappone mantiene la sua indipendenza finanziaria e riesce a evitare di diventare la pedina del capitalismo internazionale nel grande lavoro di sviluppo della Cina. Se la futura industrializzazione del Giappone e della Cina dovesse essere condotta principalmente con le loro proprie risorse di capitale e di capacità organizzative, in modo da superare rapidamente un breve periodo di dipendenza dall’Europa per il capitale e le conoscenze tecniche, la grande potenza industriale dell’Estremo Oriente potrebbe lanciarsi subito sui mercati mondiali come il concorrente più grande e più capace nelle industrie delle grandi macchine, e potrebbe prima prendere per sé il commercio dell’Asia e del Pacifico, e poi inondare i mercati dell’Occidente e costringere le nazioni occidentali a un ancor più rigoroso protezionismo, con il corollario della diminuita produzione.
[IM. I.7; II.5-6]
PRIMA PARTE
I.1. Modi di produzione
I.1.1. La produzione e le forme precapitalistiche
Oggetto della nostra analisi è anzitutto la produzione materiale.Il punto di partenza è costituito naturalmente dagli individui che producono in società – e perciò dalla
produzione socialmente determinata degli individui. Il singolo e isolato cacciatore e pescatore con cui cominciano Smith e Ricardo, appartengono alle immaginazioni prive di fantasia che hanno prodotto le robinsonate del XVIII sec. Quando si parla dunque di produzione, si parla sempre di produzione a un
60

determinato livello di sviluppo sociale – della produzione di individui sociali. Da ciò porrebbe sembrare che, per parlare in generale della produzione, noi dovessimo o seguire il processo di sviluppo storico nelle sue diverse fasi, oppure dichiarare fin dall’inizio che abbiamo a che fare con una determinata epoca storica, e quindi ad esempio con la moderna produzione borghese, che in effetti è il tema specifico della nostra analisi. Ma tutte le epoche della produzione hanno certi caratteri in comune, certe determinazioni comuni. La produzione in generale è un’astrazione, ma un’astrazione che ha un senso, nello misura in cui mette effettivamente in rilievo l’elemento comune, lo fissa e ci risparmia una ripetizione. Tuttavia questo elemento generale, ovvero l’elemento comune che viene astratto e isolato mediante comparazione, è esso stesso qualcosa di complessamente articolato, che si dirama in differenti determinazioni.
Di queste, alcune appartengono a tutte le epoche; altre sono comuni solo ad alcune. Alcune determinazioni saranno comuni tanto all’epoca più moderna quanto alla più antica. Senza di esse sarà inconcepibile qualsiasi produzione; allora bisogna isolare proprio ciò che costituisce il loro sviluppo, ossia la differenza da questo elemento generale, mentre le determinazioni che valgono per la produzione in generale devono essere isolate proprio affinché per l’unità – che deriva già dal fatto che il soggetto, l’umanità, e l’oggetto, la natura, sono i medesimi – non venga poi dimenticata la diversità essenziale. In questa dimenticanza consiste appunto tutta la saggezza degli economisti moderni che dimostrano l’eternità e l’armonia dei rapporti sociali esistenti. Un esempio di questa dimostrazione: nessuna produzione è possibile senza uno strumento di produzione, non foss’altro questo strumento che la mano; nessuna produzione è possibile senza lavoro passato, accumulato, non foss’altro questo lavoro che l’abilità assommata e concentrata nella mano del selvaggio mediante l’esercizio ripetuto; il capitale è tra l’altro anche uno strumento di produzione, anche lavoro passato, oggettivato; dunque il capitale è un rapporto naturale eterno, universale. Ovverosia, a condizione che io tralasci proprio quell’elemento specifico che solo trasforma uno “strumento di produzione”, un “lavoro accumulato”, in un capitale.
Ogni produzione è un’appropriazione della natura da parte dell’individuo, entro e mediante una determinata forma di società, In questo senso è una tautologia dire che la proprietà (l’appropriazione) è una condizione della produzione. Ma è ridicolo saltare da questo fatto ad una determinata forma della proprietà, per esempio alla proprietà privata (il che per giunta suppone una forma antitetica, la non-proprietà, anch’essa come condizione). La storia mostra piuttosto che la proprietà comune è la forma più originaria, una forma che, nella veste di proprietà comunale, svolge ancora per lungo tempo una funzione importante. L’economia borghese come mera forma storica del processo di produzione rinvia, al di là di se stessa, a precedenti modi storici di produzione. Non è necessario perciò, per enucleare le leggi dell’economia borghese, scrivere la storia reale dei rapporti di produzione. Ma l’esatta intuizione e deduzione di tali rapporti in quanto sono essi stessi sorti storicamente, conduce sempre a prime equazioni che rinviano ad un passato che sta alle spalle di questo sistema. Queste indicazioni, unite all’esatta comprensione del presente, offrono poi anche la chiave per intendere il passato – che è un lavoro a sé a cui pure speriamo di arrivare. Questa osservazione esatta porta d’altra parte a individuare anche dei punti nei quali c’è l’indizio di un superamento dell’attuale forma dei rapporti di produzione – e quindi un presagio del futuro, un movimento che diviene. Se da una parte le fasi preborghesi si presentano come fasi soltanto storiche, cioè come presupposti superati, le attuali condizioni della produzione si presentano d’altra parte come condizioni che superano anche se stesse e perciò pongono i presupposti storici per una nuova situazione sociale.
Le condizioni essenziali sono poste nel rapporto stesso così come si presenta originariamente: 1) da una parte, la presenza della forza-lavoro viva come mera esistenza soggettiva, separata dai momenti della sua realtà oggettiva, e perciò separata tanto dalle condizioni del lavoro vivo quanto dai mezzi di esistenza, dai mezzi di sussistenza, dai mezzi di autoconservazione della forza-lavoro viva; da un parte, dunque, la possibilità vivente del lavoro in questa assoluta astrazione; 2) il valore che si trova dall’altra parte, o lavoro oggettivato, deve essere un’accumulazione di valori d’uso, abbastanza grande da fornire le condizioni materiali non soltanto per la produzione dei prodotti o valori necessari a riprodurre o a conservare la forza-lavoro viva; ma anche per assorbire pluslavoro per fornirle il materiale oggettivo; 3) un libero rapporto di scambio – circolazione di denaro – tra le due parti; una relazione tra gli estremi basata sui valori di scambio – non su rapporti di signoria e di servitù; il che vuol dire, quindi, una produzione che non fornisce immediatamente i mezzi di sussistenza al produttore, ma è invece mediata dallo scambio, e che tanto meno può impossessarsi immediatamente del lavoro altrui, ma deve invece comprarlo dal lavoratore stesso, ottenerlo mediante lo scambio; infine 4) una delle due parti – quella che rappresenta le condizioni materiali del lavoro sotto forma di valori autonomi, per sé stanti deve presentarsi come valore e contemplare come scopo ultimo la creazione del valore, l’autovalorizzazione, la creazione di denaro – e non immediatamente il godimento e la creazione di un valore d’uso.
Le condizioni originarie della produzione (o, che è lo stesso, la riproduzione degli uomini, il cui numero aumenta attraverso il processo naturale dei due sessi; giacché questa riproduzione, se da un lato si presenta come appropriazione degli oggetti da parte dei soggetti, dall’altro si presenta altresì come formazione degli
61

oggetti, come sottomissione degli oggetti a uno scopo soggettivo, come trasformazione di questi in risultati e ricettacoli dell’attività soggettiva) non possono essere originariamente prodotte esse stesse – essere cioè risultati della produzione. Non è l’unità degli uomini viventi e attivi con le condizioni naturali inorganiche del loro ricambio materiale con la natura, e per conseguenza la loro appropriazione della natura, che ha bisogno di una spiegazione o che è il risultato di un processo storico, ma la separazione di queste condizioni inorganiche dell’esistenza umana da questa esistenza attiva, una separazione che si attua pienamente soltanto nel rapporto tra lavoro salariato e capitale.
Proprietà significa dunque, originariamente, nient’altro che il rapporto dell’uomo con le condizioni naturali della produzione in quanto gli appartengono, in quanto sono sue, e in quanto sono presupposte con la sua propria esistenza; il rapporto con esse in quanto presupposti naturali di se stesso, i quali formano per così dire solo il prolungamento del suo corpo. Egli non ha, a rigore, un rapporto con le proprie condizioni di produzione; egli esiste bensì in duplice modo, soggettivamente in quanto uomo stesso, oggettivamente in queste condizioni naturali inorganiche della sua esistenza. Un grado determinato dello sviluppo delle forze produttive dei soggetti che lavorano – a cui corrispondono rapporti determinati tra questi e con la natura: ecco in che cosa si dissolve, in ultima istanza, sia la loro comunità, sia la proprietà, che su di essa si basa. Fino ad un certo punto c’è riproduzione. Poi questa si rovescia in disgregazione. Originariamente, dunque, proprietà significa rapporto del soggetto che lavora (che produce) (e che si riproduce) con le condizioni della sua produzione o riproduzione in quanto gli appartengono. Essa avrà pertanto anche diverse forme secondo le condizioni di questa produzione. La produzione stessa ha per scopo la riproduzione del produttore in, e con, queste sue condizioni oggettive di esistenza. La questione che qui ci interessa in primo luogo è questa: il rapporto del lavoro col capitale, ossia con le condizioni oggettive del lavoro come capitale, presuppone un processo storico che dissolve le diverse forme in cui il lavoratore è proprietario o il proprietario lavora.
Dunque innanzitutto: 1) Dissoluzione del rapporto con la terra – col suolo – quale condizione naturale di produzione, con cui egli sta in rapporto come con la sua propria esistenza inorganica, laboratorio delle sue forze e dominio della sua volontà. Tutte le forme in cui si presenta questa proprietà presuppongono una comunità, i cui membri, pur se tra loro possono esistere differenze formali, in quanto suoi membri sono proprietari. La forma originaria di questa proprietà è pertanto la stessa proprietà comune diretta (forma orientale, modificata nella forma slava; sviluppata fino all’opposto, ma pur sempre base nascosta anche se contraddittoria nella proprietà antica e germanica). 2) Dissoluzione dei rapporti in cui egli figura come proprietario dello strumento. Come la forma suddetta di proprietà fondiaria presuppone una comunità reale, cosi questa proprietà del lavoratore sullo strumento presuppone una particolare forma di sviluppo del lavoro manifatturiero come lavoro artigiano; a questo è connesso il sistema delle corporazioni, ecc. (Qui il lavoro stesso è ancora per metà artigianale, per metà fine a se stesso; ecc. L’organizzazione dei maestri artigiani. Il capitalista stesso è ancora maestro. L’abilità particolare nel lavoro garantisce anche il possesso dello strumento, ecc. ecc. Ereditarietà quindi, in certo qual modo, della tecnica di lavoro, insieme con l’organizzazione del lavoro e lo strumento del lavoro. Le città medievali. Il lavoro è ancora lavoro personale; un determinato sviluppo autosufficiente di capacità unilaterali, ecc.). 3) Ambedue i casi implicano che egli prima di produrre possegga i mezzi di consumo necessari per vivere come produttore – durante la sua produzione, quindi prima del completamento di questa. Come proprietario fondiario egli appare provvisto direttamente del fondo di consumo necessario. Come maestro artigiano egli lo ha ereditato, guadagnato, risparmiato, e come garzone artigiano egli è dapprima apprendista, condizione questa in cui egli non figura ancora affatto come vero e proprio lavoratore autonomo, ma siede in modo patriarcale alla mensa del maestro. Come lavorante (effettivo), esiste una certa comunanza del fondo di consumo posseduto dal maestro. Anche se questo non è proprietà del lavorante, in virtù delle leggi della corporazione, delle sue tradizioni ecc, egli è per lo meno associalo al possesso, ecc. 4) Dissoluzione, d’altra parte, anche dei rapporti in cui gli stessi lavoratori, le stesse capacità di lavoro vive fanno ancora parte direttamente delle condizioni oggettive della produzione e come tali vengono appropriate – in cui cioè sono schiavi o servi della gleba. Per il capitale, condizione della produzione non è il lavoratore, ma solo il lavoro. Se può farlo compiere dalle macchine o addirittura dall’acqua, dall’aria, tanto meglio. E il capitale non si appropria del lavoratore, ma del suo lavoro – non immediatamente ma mediatamente attraverso lo scambio.
Questi sono ora, da un lato, i presupposti storici necessari per trovare il lavoratore come lavoratore libero, come capacità lavorativa priva di oggettività, puramente soggettiva, che si contrappone alle condizioni oggettive della produzione come alla sua non proprietà, come a proprietà altrui, a valore per se stante, a capitale. Da una parte si presuppongono processi storici che hanno posto una massa di individui dì una nazione, ecc. nella condizione se non inizialmente di lavoratori effettivamente liberi, tuttavia di lavoratori che lo sono potenzialmente [δυνάμει], la cui unica proprietà è la loro capacità lavorativa e la possibilità di scambiarla con valori esistenti; individui ai quali tutte le condizioni oggettive della produzione stanno di fronte come proprietà altrui, come loro non-proprietà, ma al tempo stesso scambiabili come valori, e pertanto appropriabili fino a un certo grado, mediante lavoro vivo. In tutti questi processi di dissoluzione si
62

vedrà, ad un esame più attento, che vengono dissolti rapporti di produzione in cui predomina il valore d’uso, la produzione per l’uso immediato; il valore di scambio e la sua produzione presuppone il predominio dell’altra forma.
Ciò che in primo luogo qui ci interessa è questo: il processo di dissoluzione, che trasforma una massa di individui di una nazione, ecc, in salariati δυνάμει liberi – individui costretti solo dalla loro mancanza di proprietà a lavorare e a vendere il loro lavoro – presuppone d’altra parte non che le tradizionali fonti di reddito e, parzialmente, le condizioni di proprietà di questi individui siano scomparse, ma al contrario, che sia mutata soltanto la loro utilizzazione, che il loro modo di esistenza si sia trasformato, sia passato come libero fondo in altre mani, o anche in parte sia rimasto nelle stesse mani. Ma una cosa è chiara; il processo che ha separato una massa di individui dai loro tradizionali rapporti in un modo o nell’altro positivi con le condizioni oggettive del lavoro, che ha negato questi rapporti e così ha trasformato questi individui in lavoratori liberi,è lo stesso processo che ha liberato δυνάμει queste condizioni oggettive del lavoro – terra, materia prima, mezzi di sussistenza, strumenti dì lavoro, denaro, o tutto ciò insieme – dal loro tradizionale legame con gli individui che ne sono stati poi staccati. Lo stesso processo che ha contrapposto alle condizioni oggettive del lavoro la massa sotto forma di lavoratori, liberi, ha anche contrapposto ai lavoratori liberi queste condizioni sotto forma di capitale. Il processo storico è consistito nella separazione di elementi tradizionalmente uniti – il suo risultato non è pertanto la scomparsa di uno degli elementi, ma la comparsa di ciascuno di questi in una relazione negativa con l’altro – il lavoratore libero (potenzialmente) da una parte, il capitale (potenzialmente) dall’altra. La separazione delle condizioni oggettive al polo delle classi che sono state trasformate in lavoratori liberi deve presentasi altresì come una autonomizzazione di queste stesse condizioni al polo opposto.
Se si considera il rapporto tra capitale e lavoro salariato non come rapporto che già di per sé regola e domina la totalità della produzione, ma nella sua genesi storica – cioè se si considera la trasformazione originaria di denaro in capitale, il processo di scambio tra il capitale che esiste soltanto δυνάμει da una parte, e i liberi lavoratori che esistono δυνάμει dall’altra – allora si impone naturalmente quella semplice osservazione su cui fanno tanto chiasso gli economisti: che la parte che si presenta come capitale deve possedere le materie prime, gli strumenti di lavoro e i mezzi di sussistenza affinché il lavoratore possa vivere durante la produzione, prima cioè che questa sia compiuta. E ciò implica inoltre che deve esserci stata dalla parte del capitalista un’accumulazione – un’accumulazione precedente al lavoro e non scaturita da esso – che lo mette in condizione di far lavorare il lavoratore, di mantenerlo efficiente, di mantenerlo come forza-lavoro viva. Questa azione del capitale, indipendente dal lavoro, non posta da esso, viene poi ulteriormente trasferita da questa storia della sua genesi al presente, viene trasformata in un momento della sua realtà e della sua efficienza, della sua autoformazione. Finalmente poi da ciò viene dedotto il diritto eterno del capitale ai frutti del lavoro altrui, o piuttosto il suo modo di guadagno viene sviluppato dalle semplici e “giuste” leggi dello scambio di equivalenti. La ricchezza esistente sotto forma di denaro può essere permutata con le condizioni oggettive del lavoro solo perché e se queste sono staccate dal lavoro stesso.
[LF. M;IV;V]
I.1.2. La formazione del capitale
Nella fase che precede la società capitalistica, il commercio domina l’industria: il contrario avviene nella società moderna. Il commercio reagirà naturalmente più o meno sulle comunità che vi partecipano; sottometterà sempre più la produzione al valore di scambio, facendo dipendere sempre maggiormente godimenti e sussistenza dalla vendita, anziché dall’uso immediato dei prodotti. Esso dissolve con ciò gli antichi rapporti. Aumenta la circolazione monetaria. Si impadronisce non più semplicemente della eccedenza della produzione, ma a poco a poco investe la produzione stessa e sottomette al suo potere interi rami di produzione. Questo effetto dissolvente tuttavia dipende grandemente dalla natura delle comunità produttrici.
Fino a che il capitale commerciale media lo scambio dei prodotti di comunità poco sviluppate, il profitto commerciale non solo ha l’apparenza di frode e di inganno, ma deriva in gran parte da essi. Indipendentemente dal fatto che il capitale commerciale sfrutta la differenza dei prezzi di produzione dei diversi paesi (e in questo senso usa le proprie forze per la perequazione e la fissazione dei valori delle merci), quei modi di produzione hanno come conseguenza che il capitale commerciale si impossessa dì una parte predominante del plusprodotto, come intermediario fra comunità la cui produzione è ancora orientala essenzialmente verso il valore d’uso e la cui organizzazione economica è tale per cui la vendita della parte di prodotto che entra in generale nella circolazione, quindi in generale la vendita dei prodotti al loro valore, è di importanza secondaria. Il capitale commerciale, quando predomina, rappresenta quindi dappertutto un sistema di saccheggio, come del resto anche il suo sviluppo, presso i popoli dell’antichità come dei tempi
63

moderni, è direttamente collegato con saccheggio violento, pirateria, ratto di schiavi, servaggio (nelle colonie); così a Cartagine, a Roma e più tardi presso i veneziani, portoghesi, olandesi ecc.
Lo sviluppo del commercio e del capitale commerciale orienta dovunque la produzione verso il valore di scambio, ne aumenta il volume, ne accresce la varietà e le imprime un carattere internazionale, trasforma il denaro in moneta mondiale. Il commercio esercita perciò dovunque un’azione più o meno disgregatrice sulle organizzazioni preesistenti della produzione, le quali, in tutte le loro diverse forme, sono principalmente orientale verso il valore d’uso. Quale efficacia abbia tuttavia questa azione disgregatrice sull’antico modo di produzione, dipende soprattutto dalla solidità e dall’intima struttura di quest’ultimo. E dove sfoci questo processo di disgregazione, ossia quale nuovo modo di produzione si sostituisca all’antico, non dipende dal commercio, ma dal carattere stesso del vecchio modo di produzione. Nel mondo moderno esso sfocia nel modo capitalistico di produzione. Ciò mostra che questi risultati stessi erano determinati ancora da altre circostanze oltre che dallo sviluppo del capitale commerciale. È nella natura delle cose che non appena l’industria urbana, in quanto tale, si separi dall’agricola, i suoi prodotti sono fin dal principio delle merci, la cui vendita richiede quindi la mediazione del commercio. La dipendenza del commercio dallo sviluppo delle città e d’altro lato la dipendenza di queste ultime dal commercio sono fino a qui evidenti; ma occorre che intervengano altre circostanze perché l’industria si sviluppi di pari passo. Non vi è dubbio alcuno – e proprio questo fatto ha dato origine a concezioni completamente false – che nei sec. XVI e XVII le rivoluzioni profonde che si verificarono nel commercio in seguito alle scoperte geografiche e che intensificarono rapidamente lo sviluppo del capitale commerciale, costituiscono un momento fondamentale, accelerando il passaggio dal modo feudale di produzione a quello capitalistico.
L’improvvisa espansione del mercato mondiale, la molteplicità delle merci in circolazione, la rivalità fra le nazioni europee per impadronirsi dei prodotti dell’Asia e dei tesori dell’America, il sistema coloniale, contribuirono fondamentalmente a spezzare i limiti feudali della produzione. Ciò nonostante nel suo primo periodo, ossia il periodo della manifattura, il modo di produzione moderno ai sviluppa unicamente là dove le condizioni necessarie per la sua applicazione si erano venute creando nel Medioevo. Si confronti ad es. l’Olanda con il Portogallo. E se nel sec. XVI ed ancora in parte nel sec. XVII l’ampliamento improvviso del commercio e la creazione di un nuovo mercato mondiale esercitavano una influenza decisiva sulla rovina dell’antico modo di produzione e sullo slancio del modo capitalistico, ciò accadeva perché il modo capitalistico di produzione esisteva già. Il mercato mondiale costituisce esso stesso la base di questo modo di produzione. D’altro lato la necessità immanente del capitalismo di produrre su una scala sempre più ampia, trascina ad una estensione continua del mercato mondiale, cosicché non è il commercio che qui rivoluziona l’industria ma l’industria che rivoluziona continuamente il commercio. Anche la supremazia del commercio è ora collegata alla preponderanza più o meno grande dello condizioni della grande industria. Si confronti ad esempio Inghilterra ed Olanda.
La storia della decadenza dell’Olanda come nazione commerciale dominante, è la storia della subordinazione del capitale commerciale al capitale industriale. La resistenza, che oppongono alla azione disgregatrice del commercio la solidità interna e la coesione di alcuni modi di produzione nazionali e precapitalistici, si manifesta in maniera evidentissima nei rapporti dell’Inghilterra con le Indie e la Cina. La vasta base del modo di produzione è qui costituita dall’unità della piccola agricoltura o dell’industria domestica, al che in India si aggiunge ancora la forma delle comunità rurali fondate sulla proprietà comune del suolo, che era del resto anche in Cina la forma originaria. In India gli inglesi usarono al tempo stesso della loro diretta forza politica ed economica, come dominatori e come proprietari terrieri, per spezzare queste piccole comunità economiche. Il loro commercio esercita qui una funzione rivoluzionaria sul modo di produzione unicamente in quanto, con i bassi prezzi delle loro merci, essi distruggono la filatura e la tessitura che costituisce da tempi antichissimi parte integrante, di questa unità della produzione industriale-agricola, e distruggono in tal modo la comunità.
Il passaggio dal modo di produzione feudale si compie in due maniere. Il produttore diventa commerciante e capitalista, si oppone all’economia agricola naturale ed al lavoro manuale stretto in corporazioni della industria medioevale urbana. Questo è il cammino effettivamente rivoluzionario. Oppure il commerciante si impadronisce direttamente della produzione. Questo ultimo procedimento, sebbene storicamente rappresenti una fase di transizione – si prenda l’esempio del clothier inglese del XVIII secolo che pone sotto il suo controllo i tessitori, i quali tuttavia sono indipendenti, vende ad essi la lana e compera da essi il panno – non porta in sé e per sé alla rivoluzione dell’antico modo di produzione, che esso invece conserva e salvaguarda come sua condizione. Il fabbricante era in gran parte fabbricante solo di nome, in realtà semplice commerciante che lascia lavorare i tessitori secondo il loro antico sistema sparpagliato ed ha unicamente l’autorità del commerciante, per il quale essi in realtà lavorano. Questo procedimento ostacola dappertutto il modo capitalistico di produzione vero e proprio e scompure con il suo sviluppo. Senza rivoluzionare il modo di produzione, esso peggiora unicamente la situazione dei produttori diretti, li trasforma in semplici salariati e proletari in condizioni peggiori di quelli che sono direttamente sottomessi al
64

capitale e si appropriano il loro pluslavoro sulla base dell’antico modo di produzione. Il commerciante diventa industriale o piuttosto fa lavorare per suo conto la piccola industria su base artigiana, soprattutto quella di campagna. D’altro lato il produttore diventa commerciante.
Gli elementi di produzione entrano nel processo di produzione in quanto merci che egli stesso ha comperato. Ed invece di produrre per il singolo commerciante o per un cliente determinato, il tessitore di panno produce ora per il mondo del commercio. Il produttore è esso stesso commerciante. Il capitale commerciale non compie ora che il processo di circolazione. Esso trasforma il prodotto in merce, parte in quanto esso gli crea un mercato, parte perché porta nuovi equivalenti di merci e nuove materie prime e prodotti ausiliari per la produzione e con ciò apre rami di produzione che fin dall’inizio sono fondati sul commercio, tanto sulla produzione per il mercato ed il mercato mondiale, che su condizioni di produzione che derivano dal mercato mondiale. Non appena la manifattura, e ancor più la grande industria, acquistano una certa potenza, esse si creano da parte loro il mercato, lo conquisitano con i loro prodotti. Il commercio diventa ora servo della produzione industriale, la cui condizione di vita è il continuo ampliamento del mercato. Una sempre più estesa produzione in massa inonda il mercato esistente e lavora quindi sempre all’ampliamento di questo mercato, a spezzare i suoi limiti. Ciò che limita questa produzione in massa non è il commercio (in quanto quello esprime solo la domanda esistente) ma la grandezza del capitale in funzione e la forza produttiva del lavoro che si è sviluppata. Il capitalista industriale ha continuamente davanti a sé il mercato mondiale, confronta e deve continuamente confrontare i suoi propri prezzi dì costo con i prezzi di mercato non solo del suo paese ma del mondo intero. Questo confronto nei primi tempi è compito quasi esclusivo dei commercianti ed assicura così al capitale commerciale la supremazia su quello industriale.
La prima concezione teorica del modo di produzione moderno – il mercantilismo – partì necessariamente dai fenomeni superficiali del processo di circolazione, quali essi si manifestano autonomizzati nel movimento del capitale commerciale, e non si rese quindi conto che dell’apparenza delle cose. In parte perché il capitale commerciale è in generale la prima manifestazione autonoma del capitate. In parte a causa dell’influenza preponderante che esso esercita nel primo periodo di rovesciamento della produzione feudale, nel periodo di formazione della produzione moderna. La vera scienza dell’economia moderna non comincia che là dove la trattazione teorica passa dal processo di circolazione al processo di produzione.
[C. III,20]
Quando i fondi che un uomo possiede sono appena sufficienti a mantenerlo per pochi giorni o per poche settimane, raramente egli pensa di trarne un reddito. Egli li consuma nel modo più parco possibile e cerca, con il suo lavoro, dì guadagnare qualcosa che possa rimpiazzarli prima che siano interamente consumati. Il suo reddito è tratto, in questo caso, esclusivamente dal suo lavoro. Questa è la condizione della maggior parte dei poveri che lavorano in tutti i paesi. Ma quando possiede fondi sufficienti a mantenerlo per mesi o anni, è naturale ch’egli cerchi di trarre un reddito dalla maggior parte di essi, riservando per il suo consumo immediato soltanto quanto basta a mantenerlo finché questo reddito non cominci a entrare. Mantenere e aumentare il fondo che può essere destinato al consumo immediato è l’unico fine e l’unico scopo. È questo fondo che nutre, veste e alloggia il popolo, la cui ricchezza o miseria dipende dall’abbondanza o dalla scarsità dei rifornimenti destinati al consumo immediato.
In tutti i paesi dove esista sufficiente sicurezza, ogni uomo di comune intelletto cercherà di impiegare i fondi di cui può disporre per procurarsi un godimento presente o un profitto futuro. Se vengono impiegati per procurarsi un godimento presente, si tratta di fondi destinati al consumo immediato. Se vengono impiegati per procurarsi un profitto futuro, procureranno questo profitto o rimanendo presso di lui o allontanandosene. Un uomo il quale, dove esista sufficiente sicurezza, non impieghi tutto il fondo di cui dispone, sia esso di sua proprietà, oppure preso a prestito da altre persone, nell’uno o nell’altro di questi tre modi, dev’essere completamente pazzo. In quei disgraziati paesi dove gli uomini temono continuamente la violenza di coloro che comandano, essi in effetti sotterrano e nascondono gran parte dei loro fondi per averli sempre a portata di mano, in modo da trasportarli in qualche posto sicuro, nel caso che siano minacciati da una di quelle calamità a cui si considerano in ogni momento esposti.
Il grande commercio di ogni società civile è quello che si svolge tra gli abitanti della città e quelli della campagna. Esso consiste nello scambio del prodotto grezzo con quello manufatto, direttamente oppure con l’intervento della moneta o di qualche specie di carta che rappresenta la moneta. La campagna fornisce alla città i mezzi di sussistenza e i materiali per la manifattura. La città rimborsa quest’offerta rimandando agli a-bitanti della campagna una parte del prodotto manufatto. Si può dire molto opportunamente che la città, nella quale non c’è e non può esserci alcuna riproduzione di sostanze, ricavi tutta la sua ricchezza e tutta la sua sussistenza dalla campagna. Non per questo però si deve immaginare che il guadagno della città rappresenti la perdita della campagna. I guadagni di entrambe sono mutui e reciproci e la divisione del lavoro è, in questo come in tutti gli altri casi, vantaggiosa per tutte le diverse persone impiegate nelle varie occupazioni in cui il lavoro stesso è suddiviso.
65

Dal momento che, per la natura delle cose, la sussistenza viene prima della comodità e del lusso, l’attività che procura la prima deve necessariamente aver preceduto quella che fornisce i secondi. Perciò la coltivazione e il miglioramento della campagna, che dà la sussistenza, devono necessariamente aver preceduto la crescita della città, che fornisce solo i mezzi della comodità e del lusso. È soltanto il prodotto in sovrappiù della campagna, cioè ciò che eccede il mantenimento dei coltivatori, che costituisce la sussistenza per la città, la quale può quindi crescere solo con l’aumentare di quel prodotto in sovrappiù. È vero che senza l’assistenza di alcuni artigiani la coltivazione della terra non può aver luogo, se non a prezzo di grandi difficoltà e di interruzioni continue. Anche questi artigiani hanno bisogno, di tanto in tanto, di assistenza l’uno dall’altro e siccome la loro residenza non è necessariamente legata, come quella dell’agricoltore, a un luogo preciso, essi si stabiliscono naturalmente l’uno nelle vicinanze dell’altro e formano così una piccola città o un villaggio.
Gli abitanti della città e quelli della campagna sono reciprocamente gli uni i servitori degli altri. La città è una fiera o un mercato continuo al quale gli abitanti della campagna si recano per scambiare i loro prodotti grezzi con quelli manufatti. È questo commercio che fornisce agli abitanti della città sia i materiali del loro lavoro che i mezzi della loro sussistenza. La quantità di prodotto finito che essi vendono agli abitanti della campagna regola necessariamente la quantità di materiali e di viveri che acquistano. Perciò la loro occupazione e la loro sussistenza non possono aumentare se non in proporzione all’aumento della domanda di prodotti finiti da parte della campagna e questa domanda può aumentare solo in rapporto all’estendersi del miglioramento e della coltivazione della terra. Infatti, in ogni epoca e in ogni società, la parte in sovrappiù del prodotto grezzo e manufatto, cioè quella per cui non c’è domanda interna, deve essere inviata all’estero per essere data in cambio di qualcosa per cui ci sia una certa domanda interna. Quindi, secondo il corso naturale delle cose, ogni società che comincia a formarsi è diretta prima all’agricoltura, poi alle manifatture, e infine al commercio estero. Quest’ordine di cose è cosi naturale che credo in certa misura sia stato sempre osservato in ogni società, qualsiasi territorio abbia avuto.
Ma per quanto quest’ordine naturale delle cose debba aver avuto luogo in qualche misura in ogni società, in tutti i moderni stati europei esso è stato sotto molti aspetti completamente rovesciato. Il commercio estero di alcune delle loro città vi ha introdotto manifatture più raffinate, cioè quelle adatte per la vendita in luoghi remoti e le manifatture e il commercio estero insieme hanno dato occasione ai principali miglioramenti del -l’agricoltura. Gli usi e i costumi che la natura dei loro regimi d’origine aveva introdotto, e che restarono dopo che quei regimi erano stati profondamente trasformati, le costrinsero necessariamente a quest’ordine di cose innaturale e retrogrado.
[RN. II,1; III,1]
Denaro e merce non sono capitale fin da principio, come non lo sono i mezzi di produzione e di sussistenza. Occorre che siano trasformati in capitale. Ma anche questa trasformazione può avvenire soltanto a certe condizioni che convergono in questo: debbono trovarsi di fronte e mettersi in contatto due specie diversis-sime di possessori di merce, da una parte il proprietario di denaro e di mezzi di consumo e di sussistenza, al quale importa di valorizzare mediante l’acquisto di forza-lavoro altrui la somma di valori posseduti; dall’altra parte lavoratori liberi, venditori della propria forza-lavoro e quindi venditori di lavoro. Lavoratori liberi nel duplice senso che essi non fanno parte direttamente dei mezzi di produzione come gli schiavi, i servi della gleba ecc. né ad essi appartengono i mezzi di produzione, come al contadino coltivatore diretto ecc., anzi ne sono liberi, privi, “senza”. Con questa polarizzazione del mercato delle merci si hanno le condizioni fondamentali della produzione capitalistica. Il rapporto capitalistico ha come presupposto la separazione fra i lavoratori e la proprietà delle condizioni di realizzazione del lavoro. Una volta autonoma, la produzione capitalistica non solo mantiene quella separazione, ma la riproduce su scala sempre crescente. Il processo che crea il rapporto capitalistico non può dunque essere null’altro che il processo di separazione del lavoratore dalla proprietà delle proprie condizioni di lavoro, processo che da una parte trasforma in capitale i mezzi sociali di sussistenza e di produzione, dall’altra trasforma i produttori diretti in lavoratori salariati.
La struttura economica della società capitalistica è derivata dalla struttura economica della società feudale. La dissoluzione di questa ha liberato gli elementi di quella. Il produttore immediato, il lavoratore, ha potuto disporre della sua persona soltanto dopo aver cessato di essere legato alla gleba e di essere servo di un’altra persona o infeudato ad essa. Per divenire libero venditore di forza-lavoro, che porta la sua merce ovunque essa trovi un mercato, il lavoratore ha dovuto inoltre sottrarsi al dominio delle corporazioni, ai loro ordinamenti sugli apprendisti e sui garzoni e all’impaccio delle loro prescrizioni per il lavoro. Così il movimento storico, che trasforma i produttori in lavoratori salariati si presenta, da un lato, come loro liberazione dalla servitù e dalla coercizione corporativa; e per i nostri storiografi borghesi esiste solo questo lato. Ma dall’altro lato questi affrancati diventano venditori di se stessi soltanto dopo essere stati spogliati di
66

tutti i loro mezzi di produzione e di tutte le garanzie per la loro esistenza offerte dalle antiche istituzioni feudali.
I capitalisti industriali, questi nuovi potentati, hanno dovuto per parte loro non solo soppiantare i maestri artigiani delle corporazioni, ma anche i signori feudali possessori delle fonti di ricchezza. Da questo lato l’a -scesa dei capitalisti si presenta come frutto di una lotta vittoriosi tanto contro il potere feudale e contro i suoi rivoltanti privilegi, quanto contro le corporazioni e contro i vincoli posti da queste al libero sviluppo della produzione e al libero sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo. Fanno epoca, dal punto di vista storico, tutti i rivolgimenti che servono di leva alla classe dei capitalisti in formazione; ma soprattutto i momenti nei quali grandi masse di uomini vengono staccate improvvisamente e con la forza dai loro mezzi di sussistenza e gettate sul mercato del lavoro come proletariato eslege. L’espropriazione dei produttori rurali, dei contadini e la loro espulsione dalle terre costituisce il fondamento di tutto il processo. Cosi la popolazione rurale espropriata con la forza, cacciata dalla sua terra, e resa vagabonda, veniva spinta con leggi fra il grottesco e il terroristico a sottomettersi, a forza di frusta, di marchio a fuoco, di torture, a quella disciplina che era necessaria al sistema del lavoro salariato.
Non basta che le condizioni di lavoro si presentino come capitale a un polo e che all’altro polo si presentino uomini che non abbiano altro da vendere che la propria forza-lavoro. E non basta neppure costringere questi uomini a vendersi volontariamente. Man mano che la produzione capitalistica procede, si sviluppa una classe operaia che per educazione, tradizione, abitudine, riconosce come leggi naturali ovvie le esigenze di quel modo di produzione. L’organizzazione del processo di produzione capitalistico sviluppato spezza ogni resistenza; la costante produzione di una sovrapopolazione relativa tiene la legge dell’offerta e della domanda di lavoro, e quindi il salario operaio, entro un binario che corrisponde ai bisogni di valorizzazione del capitale; la silenziosa coazione dei rapporti economici appone il suggello al dominio del capitalista sul lavoratore. Si continua, è vero, sempre ad usare la forza extraeconomica, immediata, ma solo per eccezione. Per il corso ordinario delle cose il lavoratore può rimanere affidalo alle “ leggi naturali della produzione”, cioè alla sua dipendenza dal capitale, che nasce dalle stesse condizioni della produzione, e che viene garantita e perpetuata da esse.
Quando è salito a un certo grado, questo modo di produzione genera i mezzi materiali della propria distruzione. A partire da questo momento, in seno alla società si muovono forze e passioni che si sentono incatenate da quel modo di produzione: esso deve essere distrutto, e viene distrutto. La sua distruzione, che è la trasformazione dei mazzi di produzione individuali e dispersi in mezzi di produzione socialmente concentrali, e quindi la trasformazione della proprietà minuscola di molti nella proprietà colossale di pochi, quindi l’espropriazione della gran massa della popolazione, che viene privata della terra, dei mezzi di sussistenza e degli strumenti di lavoro; questa terribile e difficile espropriazione della massa della popolazione costituisce la preistoria del capitale. La proprietà privata acquistata col proprio lavoro, fondata per così dire sulla unione intrinseca della singola e autonoma individualità lavoratrice e delle sue condizioni di lavoro, viene soppiantata dalla proprietà privata capitalistica che è fondata sullo sfruttamento di lavoro che è sì lavoro altrui, ma, formalmente, è libero. Appena questo processo di trasformazione ha decomposto a sufficienza l’antica società in profondità e in estensione, appena i lavoratori sono trasformati in proletari e le loro condizioni di lavoro in capitale, appena il modo di produzione capitalistico si regge su basi proprie, assumono una nuova forma l’ulteriore socializzazione del lavoro e l’ulteriore trasformazione della terra e degli altri mezzi di produzione in mezzi di produzione sfruttati socialmente, cioè in mezzi di produzione collettivi, e quindi assume una forma nuova anche l’ulteriore espropriazione dei proprietari privati. Ora, quello che deve essere espropriato non è più il lavoratore indipendente che lavora per sé, ma il capitalista che sfrutta molti lavoratori.
Questa espropriazione si compie attraverso il gioco delle leggi immanenti della stessa produzione capitalistica, attraverso la centralizzazione dei capitali. Ogni capitalista ne colpisce a morte molti altri per suo conto. Di pari passo con questa centralizzazione ossia con l’espropriazione di molti capitalisti da parte di pochi, si sviluppano su scala sempre crescente la forma cooperativa del processo di lavoro, la consapevole applicazione tecnica della scienza, lo sfruttamento metodico della terra, la trasformazione dei mezzi di lavoro in mezzi di lavoro utilizzabili solo collettivamente, l’economia di tutti i mezzi di produzione mediante il loro uso come mezzi di produzione del lavoro combinato, sociale, mentre tutti i popoli vengono via via intricati nella rete del mercato mondiale e così si sviluppa in misura sempre crescente il carattere internazionale del regime capitalistico. Il modo di appropriazione capitalistico che nasce dal modo di produzione capitalistico, e quindi la proprietà privata capitalistica, sono la prima negazione della proprietà privata individuale, fondata sul lavoro personale. Ma la produzione capitalistica genera essa stessa, con l’ineluttabilità di un processo naturale, la propria negazione. È la negazione della negazione.
[C. I,24]
67

I.1.3. La sottomissione formale e reale al capitale
Il processo lavorativo è sottoposto al capitale (è il suo proprio processo) e il capitalista vi entra in qualità di dirigente, considerandolo insieme e immediatamente come processo di sfruttamento del lavoro altrui. È questo che io chiamo sottomissione formale del lavoro al capitale – forma generale di qualunque processo di produzione capitalistico, ma nello stesso tempo forma particolare accanto al modo dì produzione specificamente capitalistico nella sua forma sviluppata, giacché la seconda forma ingloba la prima, mentre la prima non ingloba necessariamente la seconda. Il processo di produzione è ormai divenuto processo dello stesso capitale, un processo che si svolge sotto la direzione del capitalista, con i fattori del processo lavorativo in cui si è trasformato il suo denaro e allo scopo preciso di fare del denaro più denaro. A questi cambiamenti, tuttavia, non si è finora accompagnata una trasformazione sostanziale nel modo d’essere vero e proprio del processo lavorativo, del processo di produzione reale.
Al contrario, è nella natura delle cose che la sottomissione del processo lavorativo al capitale si verifichi per ora sulla base di un processo lavorativo ad esso preesistente, configuratosi sulla base di antichi e diversi processi produttivi e di altre e diverse condizioni della produzione: il capitale si sottomette un processo lavorativo dato, esistente – per esempio, il lavoro artigianale o il lavoro agricolo corrispondente alla piccola economia contadina autonoma – e le modificazioni che possono tuttavia verificarsi all’interno del processo lavorativo, non appena esso soggiaccia al comando del capitale, possono essere soltanto conseguenze graduali della già avvenuta sottomissione dei processi lavorativi dati, tradizionali, al capitale. Il fatto che l’intensità del lavoro aumenti, che la durata del processo lavorativo si prolunghi, che il lavoro si svolga più ordinato e continuo sotto l’occhio interessato del capitalista ecc., questo fatto non cambia in sé e per sé il carattere del processo lavorativo reale, del modo vero e proprio di lavoro. Tutto ciò contrasta decisamente con il modo di produzione specificamente capitalistico (lavoro su grande scala ecc.) che si sviluppa man mano che la produzione capitalistica progredisce; modo di produzione che, insieme ai rapporti fra i diversi agenti della produzione, rivoluziona anche il modo d’essere del lavoro e la forma reale dell’intero processo lavorativo.
Le due forme hanno in comune il rapporto capitalistico come rapporto di coercizione inteso a spremere pluslavoro dal lavoro salariato, dapprima solo prolungando la durata del tempo di lavoro – rapporto che non poggia su alcun legame di signoria e dipendenza personale, ma nasce unicamente dalla diversificazione delle funzioni economiche. Mentre però il modo di produzione specificamente capitalistico conosce anche altri modi di estorsione di pluslavoro e plusvalore, invece, sulla base di un modo di produzione esistente, quindi di uno sviluppo dato della forza produttiva del lavoro e di un modo di lavoro corrispondente a questa forza produttiva, il plusvalore può essere prodotto solo prolungando la durata del tempo di lavoro: sotto la forma del plusvalore assoluto. È a questa forma di produzione del plusvalore che corrisponde la sottomissione formale del lavoro al capitale.
Ciò in cui, fin dall’inizio, il processo di lavoro sottomesso formalmente al capitale si distingue – e va sempre più distinguendosi – anche sulla base del modo di lavoro tradizionale, è la scala su cui esso è eseguito; quindi, da un lato, il volume dei mezzi di produzione anticipati, dall’altro il numero degli lavoratori sottoposti al comando di un solo imprenditore. Ciò che, per esempio sulla base del modo di produzione delle corporazioni medievali, appare come limite massimo in numero di garzoni impiegati ecc., per il rapporto capitalistico non può rappresentare neppure il limite minimo. Il rapporto capitalistico è infatti ancora solo nominalmente tale, là dove il capitalista non impiega almeno un numero di lavoratori così grande che il plusvalore prodotto basti sia come reddito per il suo consumo privato sia come fondo di accumulazione, in modo da dispensarlo dal lavoro immediato e permettergli di agire solo come capitalista, sorvegliante e direttore del processo, assolvendo così con volontà e coscienza la funzione propria del capitale impegnato nel processo di autovalorizzazione. Questo allargamento della scala della produzione costituisce anche la base reale su cui, in condizioni storiche favorevoli come quelle del XVI secolo, si erige il modo di produzione specificamente capitalistico, sebbene esso possa apparire in modo sporadico, senza dominare l’intera società, in singoli punti, anche in seno a formazioni sociali più antiche. Il carattere distintivo della sottomissione formale del lavoro al capitale si rivela nel modo più chiaro se si ricordano le condizioni in cui il capitale esiste già in funzioni subalterne, ma non ancora nella sua funzione dominante (che determina l’intera forma sociale) di acquirente diretto di forza-lavoro e appropriatore immediato del processo produttivo.
Con la produzione del plusvalore relativo l’intera forma reale del modo di produzione si modifica e sorge un modo di produzione specificamente capitalistico (anche dal punto di vista tecnico), sulla cui base soltanto si sviluppano quei rapporti dì produzione fra i diversi agenti della produzione, e in particolare fra capitalisti e salariati, che a tale modo di produzione corrispondono. L’incremento delle forze produttive sociali del lavoro, o delle forze produttive del lavoro direttamente sociale, socializzato (reso collettivo) mediante la cooperazione, la divisione del lavoro all’interno della fabbrica, l’impiego delle macchine, e, in genere, la trasformazione del processo di produzione in cosciente impiego delle scienze naturali, della meccanica, della
68

chimica ecc. e della tecnologia per dati scopi, come ogni lavoro su grande scala a tutto ciò corrispondente (solo questo lavoro socializzato è infatti in grado di applicare i prodotti generali dell’evoluzione umana, per esempio le matematiche, al processo di produzione immediato, allo stesso modo d’altra parte che l’intero sviluppo di queste scienze presuppone un dato livello del processo di produzione materiale), questo incremento, dicevamo, della forza produttiva del lavoro socializzato in confronto al lavoro più o meno isolato e disperso dell’individuo singolo, e con esso l’applicazione della scienza – questo prodotto generale dello sviluppo sociale – al processo di produzione immediato, si rappresentano ora come forza produttiva del capitale anziché come forza produttiva del lavoro, o solo come forza produttiva del lavoro in quanto identico al capitale; in ogni caso, non come forza produttiva del lavoratore isolato e neppure dei lavoratori cooperanti nel processo di produzione.
Questa mistificazione, propria del rapporto capitalistico in quanto tale, si sviluppa ora molto più di quanto potesse avvenire nel caso della pura e semplice sottomissione formale del lavoro al capitale. È d’altra parte soltanto qui, che il significato storico della produzione capitalistica appare nella sua evidenza specifica, proprio attraverso la trasformazione dello stesso processo di produzione immediato e lo sviluppo delle forze produttive sociali del lavoro. Non solo nella “rappresentazione” ma nella “realtà”, l’aspetto sociale, “la socialità” ecc., del lavoro si erge di fronte al lavoratore come elemento non soltanto estraneo ma ostile e antagonistico, apparendo oggettivato e personificato nel capitale. Allo stesso modo che la produzione del plusvalore assoluto può essere considerata come l’espressione materiale della sottomissione formale del lavoro al capitale, la produzione del plusvalore relativo può considerarsi come l’espressione della sottomissione reale dal lavoro al capitale. In ogni caso, alle due forme del plusvalore, assoluta e relativa, considerate ciascuna per sé in esistenza separata – e il plusvalore assoluto precede sempre il plusvalore relativo – corrispondono due forme distinte di sottomissione del lavoro al capitale, o due forme distinte di produzione capitalistica, di cui la prima è sempre la battistrada della seconda, benché questa, che è la più sviluppata, possa a sua volta costituire la base per l’introduzione della prima in nuove branche produttive:
1) Il rapporto puramente monetario fra colui che si appropria il pluslavoro e colui che lo fornisce. La subordinazione, nella misura in cui si verifica, nasce qui dal contenuto determinato della vendita, non da una subordinazione a essa precedente per cui il produttore sia posto, nei confronti dello sfruttatore del suo lavoro, in un rapporto diverso da quello monetario (rapporto fra possessore di merce e possessore di merce) a causa di rapporti politici ecc.; è solo in quanto possessore delle condizioni del lavoro che qui il compratore riduce il venditore in dipendenza economica da sé; non v’è alcun rapporto politico e socialmente fissato di supremazia e sudditanza;
2) questo punto è implicito nel primo rapporto, perché, se cosi non fosse, il lavoratore non avrebbe bisogno di vendere la propria forza-lavoro – il fatto che le sue condizioni oggettive di lavoro (mezzi di produzione) e le sue condizioni soggettive di lavoro (mezzi di sussistenza) stanno di fronte al lavoratore come capitale, come monopolio dell’acquirente della sua forza-lavoro. Quanto più completamente queste condizioni del lavoro gli si contrappongono come proprietà altrui, tanto più completo è normalmente il rapporto fra capitale e lavoro salariato, e quindi tanto più completa è la sottomissione formale del lavoro al capitale come condizione e premessa della sua sottomissione reale. Non esiste qui ancora nessuna differenza nel modo stesso di produzione, il processo lavorativo, considerato dal punto di vista tecnologico, si svolge esattamente come prima, con la sola differenza che è un processo lavorativo subordinato al capitale.
Tuttavia, nello stesso processo produttivo si sviluppa, come si è già osservato, a) un rapporto economico di supremazia e sudditanza, perché è il capitalista che consuma forza-lavoro e quindi la sorveglia e la dirige; b) una grande continuità e intensità del lavoro e un maggior risparmio nell’impiego delle condizioni di lavoro, perché tutto è predisposto affinché il prodotto non rappresenti che tempo di lavoro socialmente necessario (e, se possibile, ancor meno), e ciò sia in rapporto al lavoro vivo impiegato nella sua produzione, sia in rapporto al lavoro oggettivato che entra, come valore dei mezzi di produzione utilizzati, nella creazione di valore. Nella sottomissione formale del lavoro al capitale, l’obbligo al pluslavoro mediante costrizione – e quindi l’obbligo, da un lato, di creare bisogni e mezzi per soddisfarli, dall’altro di produrre più del livello dei bisogni tradizionali del lavoratore – e la creazione di tempo libero ai fini di uno sviluppo indipendente dalla produzione materiale, ricevono soltanto una forma diversa da quella dei modi di produzione precedenti, ma una forma che potenzia la continuità e intensità del lavoro, che aumenta la produzione, che favorisce lo sviluppo delle variazioni nella capacità lavorativa e quindi la diversificazione dei modi di lavoro, e che infine risolve il rapporto fra il possessore delle condizioni di lavoro e il lavoratore in puro e semplice rapporto di compravendita o rapporto monetario, eliminando dai rapporti di sfruttamento tutte le incrostazioni patriarcali, politiche o anche religiose, del passato. Certo, anche il rapporto di produzione presenta di riflesso un nuovo rapporto di supremazia e sudditanza (che si traduce pure in espressioni politiche ecc.). Meno la produzione capitalistica supera il livello del rapporto formale, meno questo rapporto stesso è sviluppato, in quanto presuppone soltanto piccoli capitalisti il cui modo di formazione e occupazione non differisce gran che da quello degli lavoratori.
69

La differenza nel tipo di rapporto di supremazia e sudditanza, senza incidere ancora sul modo di produzione, si rivela soprattutto là dove lavori sussidiari agricoli e domestici, esercitati unicamente per il fabbisogno della famiglia, vengono trasformati in branche di lavoro autonomamente capitalistiche. Allo stesso modo, la sottomissione reale del lavoro al capitale – il modo di produzione propriamente capitalistico – ha inizio soltanto là dove capitali di un certo volume si sono impadroniti direttamente della produzione, sia che il mercante diventi capitalista industriale, sia che sulla base della sottomissione formale si siano formati dei più grossi capitalisti industriali. Permane qui la caratteristica, generale della sottomissione formale, cioè la diretta subordinazione del processo lavorativo, comunque sia esercitato dal punto di vista tecnologico, al capitale. Ma su questa base si erge un modo di produzione tecnologicamente (e non solo tecnologicamente) specifico, che modifica la natura reale del processo lavorativo e le sue reali condizioni – il modo di produzione capitalistico. Solo quando esso appare in scena, ha luogo la sottomissione reale del lavoro al capitale. La sottomissione reale del lavoro al capitale si sviluppa in tutte le forme che generano, a differenza dal plusvalore assoluto, plusvalore relativo.
Alla sottomissione reale del lavoro al capitale si accompagna una rivoluzione completa (che prosegue e si ripete costantemente) nel modo stesso di produzione, nella produttività del lavoro, e nel rapporto fra capitalisti e lavoratori. La sottomissione reale del lavoro al capitale va di pari passo con le trasformazioni nel processo produttivo che abbiamo già illustrate: sviluppo delle forze produttive sociali del lavoro e, grazie al lavoro su grande scala, applicazione della scienza e del macchinismo alla produzione immediata. Da una parte, il modo di produzione capitalistico, che ora appare veramente come un modo di produzione sui generis, dà alla produzione materiale una forma diversa; dall’altra, questa variazione della forma materiale costituisce la base per lo sviluppo del rapporto capitalistico, la cui forma adeguata corrisponde perciò a un determinato grado di sviluppo delle forze produttive sociali del lavoro. Si è già visto che un minimo dato e sempre crescente di capitale nelle mani di singoli capitalisti è sia la premessa necessaria, che, d’altra parte, il risultato costante del modo di produzione specificamente capitalistico.
Il capitalista deve essere proprietario o detentore di mezzi di produzione su scala sociale; quindi in una grandezza di valore che ha perduto ogni rapporto con quanto può essere prodotto dal singolo o dalla sua famiglia. Il minimo di capitale è tanto maggiore in un ramo dello produzione, quanto più esso è condotto capitalisticamente, quanto più la produttività sociale del lavoro vi si è sviluppata. Nella stessa proporzione il capitale deve crescere in grandezza di valore e assumere dimensioni sociali, spogliandosi di ogni veste individuale. La produttività del lavoro, la massa di produzione, popolazione e sovrapopolazione, che questo modo di produzione determina, dànno continuamente vita (grazie a capitale e lavoro liberati) a nuove branche produttive, in cui il capitale può riprendere a funzionare su scala più modesta e ripercorrere le diverse tappe di sviluppo finché esse pure non funzionino su scala sociale. E questo è un processo ininterrotto. Nello stesso tempo, la produzione capitalistica tende a impadronirsi di tutti i rami di industria in cui non regna ancora sovrana, e dove continua a vigere soltanto una sottomissione formale.
Il risultato materiale della produzione capitalistica, oltre allo sviluppo delle forze produttive sociali del lavoro, è l’aumento della massa della produzione e l’accrescersi e diversificarsi delle sfere produttive e delle loro ramificazioni, premessa necessaria, questa, di uno sviluppo corrispondente del valore di scambio dei prodotti – dalla sfera in cui essi agiscono e si realizzano come valori dì scambio. Certo, “la produzione per la produzione” – la produzione come fine in sé – entra già in scena con la sottomissione formale del lavoro al capitale, dal momento in cui il fine immediato della produzione generale diventa quello di produrre il più possibile e la grandezza maggiore possibile di plusvalore al momento in cui il valore di scambio del prodotto assurge a scopo dominante. Ma questa tendenza immanente del rapporto capitalistico si realizza in forma adeguata – e diviene una condizione necessaria anche dal punto di vista tecnologico – solo quando si è sviluppato il modo di produzione specificamente capitalistico e, con esso, la sottomissione reale del lavoro al capitale. È una produzione non vincolata da prestabilite e predeterminanti limitazioni dei bisogni. (Il suo carattere antagonistico crea però dei limiti alla produzione che essa cerca costantemente di superare; di qui le crisi, la sovraproduzione ecc). È questo uno dei lati per cui essa si distingue dai modi di produzione precedenti: se volete, il suo lato positivo. D’altra parte, il suo lato negativo o antagonistico: la produzione in contrapposto ai produttori e senza riguardo per essi; il vero produttore come semplice mezzo per produrre; la ricchezza materiale come fine in sé; infine, e di conseguenza, lo sviluppo di questa ricchezza materiale in antitesi e a spese dell’uomo. Produttività del lavoro in genere = massimo di prodotto con minimo di lavoro, e quindi merci il più possibile a buon mercato. Nel modo di produzione capitalistico, questa diventa una legge indipendentemente dalla volontà dei singoli capitalisti. E questa legge si realizza solo coinvolgendo l’altra: che cioè la scala della produzione non dipende da bisogni dati, ma al contrario la massa dei prodotti dipende dalla scala della produzione (sempre crescente) prescritta dal modo di produzione. Il suo fine è che ogni prodotto ecc. contenga il più possibile di lavoro non pagato, cosa che si può ottenere soltanto con la produzione per la produzione.
70

Ciò si presenta, da una parte, come legge, nella misura in cui il capitalista il quale producesse su scala troppo piccola incorporerebbe nei prodotti più lavoro di quanto socialmente necessario – e quindi come applicazione adeguata della legge del valore, che solo sulla base del modo di produzione capitalistico si sviluppa in forma completa – dall’altra come spinta del capitalista singolo a cercar di abbassare il valore individuale della sua merce al disotto del suo valore socialmente stabilito, per infrangere questa stessa legge o volgerla astutamente a suo vantaggio. Tutte queste forme di produzione (del plusvalore relativo), oltre al crescente minimo di capitale necessario alla produzione hanno in comune il fatto che le condizioni sociali del lavoro di molti lavoratori direttamente cooperanti permettono come tali un risparmio in contrasto con la loro dispersione nel caso della produzione su scala più modesta, perché l’efficienza di queste stesse condizioni di produzione collettive non determina un aumento proporzionalmente eguale della loro massa e del loro valore: la loro utilizzazione collettiva e simultanea fa tanto più cadere il loro valore relativo (in rapporto al prodotto), quanto più la loro massa assoluta di valore cresce.
[VI. 1,10-16]
I.1.4 La produzione: processo lavorativo
La produzione di valori d’uso o beni non cambia per il fatto la sua natura generale per il fatto che essa avvenga per il capitalista e sotto il suo controllo. Quindi il processo lavorativo deve essere considerato in un primo momento indipendentemente da ogni forma sociale determinata. In primo luogo il lavoro è un processo che si svolge fra l’uomo e la natura, nel quale l’uomo per mezzo della propria azione produce, regola e controlla il ricambio organico fra se stesso e la natura: contrappone se stesso, quale una fra le potenze della natura, alla materialità della natura. Egli mette in moto lo forze naturali appartenenti alla sua corporeità, braccia e gambe, mani e testa, per appropriarsi i materiali della natura in forma usabile per la propria vita. Operando mediante tale moto sulla natura fuori di sé e cambiandola, egli cambia allo stesso tempo la natura sua propria. Sviluppa le facoltà che in questa sono assopite e assoggetta il gioco dello loro forze al proprio potere. Qui non abbiamo da trattare delle prime forme di lavoro, di tipo animalesco e istintive. Lo stadio nel quale il lavoro umano non s’era ancora spogliato della sua prima forma di tipo istintivo si ritira nello sfondo lontano delle età primeve, per chi vive nello stadio nel quale il lavoratore si presenta sul mercato come venditore della propria forza-lavoro. Il nostro presupposto è il lavoro in una forma nella quale esso appartiene esclusivamente all’uomo.
Il ragno compie operazioni che assomigliano a quelle del tessitore, l’ape fa vergognare molti architetti con la costruzione delle sue cellette di cera. Ma ciò che fin da principio distingue il peggiore architetto dall’ape migliore è il fatto che egli ha costruito la colletta nella sua testa prima di costruirla in cera. Alla fine del processo lavorativo emerge un risultato che era già presente al suo inizio nella idea del lavoratore, che quindi era già presente idealmente. Non che egli effettui soltanto un cambiamento di forma dell’elemento naturale; egli realizza nell’elemento naturale, allo stesso tempo, il proprio scopo, che egli conosce, che determina come legge il modo del suo operare, e al quale deve subordinare la sua volontà. E questa subordinazione non è un atto singolo e isolato. Oltre lo sforzo degli organi che lavorano, è necessaria per tutta la durata del lavoro, la volontà conforme allo scopo, che si estrinseca come attenzione: e tanto più è necessaria quanto meno il lavoro, per il proprio contenuto e per il modo dell’esecuzione, attrae seco il lavoratore; quindi quanto meno questi lo gode come gioco delle proprie forze fisiche e intellettuali.
I momenti semplici del processo lavorativo sono la attività conforme allo scopo, ossia il lavoro stesso; l’oggetto del lavoro; e i mezzi di lavoro. La terra (nella quale dal punto di vista economico è inclusa anche l’acqua), come originariamente provvede l’uomo di cibarie, di mezzi di sussistenza bell’e pronti, si trova a essere, senza contributo dell’uomo, l’oggetto generale del lavoro umano. Tutte le cose che il lavoro non fa che sciogliere dal loro nesso immediato con l’orbe terracqueo, sono oggetti di lavoro che l’uomo si trova davanti per natura. Se invece l’oggetto del lavoro è già filtrato, per così dire, attraverso lavoro precedente, lo chiamiamo materia prima. Ogni materia prima è oggetto di lavoro; ma non ogni oggetto di lavoro è materia prima. L’oggetto di lavoro è materia prima soltanto quando ha subito un cambiamento mediante il lavoro. Il mezzo di lavoro è una cosa o un complesso di cose che il lavoratore inserisce fra sé e l’oggetto del lavoro, e che gli servono da conduttore della propria, attività su quell’oggetto. Il lavoratore utilizza le proprietà meccaniche, fisiche, chimiche delle cose, per farle operare come mezzi per esercitare il suo potere su altre cose, conformemente al suo scopo. Non è quel che viene fatto, ma come vien fatto, con quali mezzi di lavoro, ciò che distingue le epoche economiche. I mezzi di lavoro non servono soltanto a misurare i gradi dello sviluppo della forza lavorativa umana, ma sono anche indici dei rapporti sociali nel cui quadro vien compiuto il lavoro. Oltre alle cose che trasmettono l’efficacia del lavoro al suo oggetto, e quindi in un modo o
71

nell’altro servono come conduttori dell’attività, il processo lavorativo annovera fra ì suoi mezzi, in un senso più ampio, anche tutte le condizioni oggettive che in genere sono richieste affinché esso abbia luogo.
Queste condizioni non rientrano direttamente nel processo lavorativo, il quale però senza di esse può non verificarsi affatto, o si verifica solo incompletamente. Il mezzo universale di lavoro di questo tipo è ancora una volta la terra stessa, poiché essa dà al lavoratore il locus standi e al processo lavorativo dà il suo campo d’azione. Dunque nel processo lavorativo l’attività dell’uomo opera, attraverso il mezzo di lavoro, un cambiamento dell’oggetto di lavoro che fin da principio era posto come scopo. Il processo si estingue nel prodotto. Il suo prodotto è un valore d’uso, materiale naturale appropriato a bisogni umani mediante cambiamento di forma. Il lavoro s’è combinato col suo oggetto. Il lavoro si è oggettivato, e l’oggetto è lavorato. Quel che dal lato del lavoratore s’era presentalo nella forma del moto, ora si presenta dal lato del prodotto come proprietà ferma, nella forma dell’essere. Il lavoratore ha filato, e il prodotto è un filato. Se si considera l’intero processo dal punto di vista del suo risultato, cioè del prodotto, mezzo di lavoro e oggetto di lavoro si presentano entrambi come mezzi dì produzione, e il lavoro stesso si presenta come lavoro produttivo.
Una cosa può essere valore d’uso senza essere valore. Il caso si verifica quando la sua utilità per l’uomo non è ottenuta mediante il lavoro: aria, terreno vergine, praterie naturali, legna di boschi incolti, ecc. Una cosa può essere utile e può essere prodotto di lavoro umano senza essere merce. Chi soddisfa con la propria produzione il proprio bisogno, crea sì valore d’uso, ma non merce. Per produrre merce, deve produrre non solo valore d’uso, ma valore d’uso per altri, valore d’uso sociale. Infine, nessuna cosa può essere valore, senza essere oggetto d’uso. Se è inutile, anche il lavoro contenuto in essa è inutile, non conta come lavoro e non costituisce quindi valore. Come valori d’uso le merci sono soprattutto di qualità differente, come valori di scambio possono essere soltanto di quantità differente, cioè non contengono nemmeno un atomo di valore d’uso. Ma, se si prescinde dal valore d’uso dei corpi delle merci, rimane loro soltanto una qualità, quella di essere prodotti del lavoro. Eppure anche il prodotto del lavoro ci si trasforma non appena lo abbiamo in mano. Se noi facciamo astrazione dal suo valore d’uso, facciamo astrazione anche dalle parti costitutive e forme corporee che lo rendono valore d’uso. Col carattere dì utilità dei prodotti del lavoro scompare il carattere di utilità dei lavori rappresentati in essi, scompaiono dunque anche le diverse forme concrete di questi lavori, le quali non si distinguono più, ma sono ridotte tutte insieme a lavoro umano eguale, lavoro umano in astratto.
Consideriamo ora il residuo dei prodotti del lavoro. Non è rimasto nulla di questi all’infuori di una medesima spettrale oggettività, d’una semplice concrezione di lavoro umano indistinto, cioè di dispendio di forza lavorativa umana senza riguardo alla forma del suo dispendio. Queste cose rappresentano ormai soltanto il fatto che nella loro produzione è stata spesa forza lavorativa umana, è accumulato lavoro umano. Come cristalli di questa sostanza sociale a esse comune, esse sono valori, valori di merci. Nel rapporto di scambio delle merci stesse il loro valore di scambio ci è apparso come una cosa completamente indipendente dai loro valori d’uso. Dunque, un valore d’uso o bene ha valore soltanto perché in esso viene oggettivato, o materializzato, lavoro astrattamente umano. E come misurare ora la grandezza del suo valore? Mediante la quantità della “sostanza valorificante”, cioè del lavoro, in esso contenuta. La quantità del lavoro a sua volta si misura con la sua durata temporale, e il tempo di lavoro ha a sua volta la sua misura in parti determinate di tempo, come l’ora, il giorno, ecc.
Il lavoro che forma la sostanza dei valori è lavoro umano eguale, dispendio della medesima forza lavorativa umana. La forza lavorativa complessiva della società che si presenta nei valori del mondo delle merci, vale qui come unica e identica forza-lavoro umana, benché consista di innumerevoli forze-lavoro individuali. Tempo di lavoro socialmente necessario è il tempo di lavoro richiesto per rappresentare un qualsiasi valore d’uso nelle esistenti condizioni di produzione socialmente normali, e col grado sociale medio di abilità e intensità di lavoro. Se dal processo lavorativo risulta come prodotto un valore d’uso, in esso entrano come mezzi di produzione altri valori d’uso, prodotti di processi lavorativi precedenti. Lo stesso valore d’uso che è il prodotto di questi ultimi costituisce il mezzo di produzione di quel lavoro. Quindi i prodotti non sono soltanto risultato, ma anche, insieme, condizione del processo lavorativo. Ecco dunque: che un valore d’uso si presenti come materia prima, mezzo di lavoro o prodotto dipende assolutamente dalla sua funzione determinata nel processo lavorativo, dalla posizione che occupa in esso; e col cambiare di questa posizione cambiano quelle determinazioni. Dunque, col loro ingresso in nuovi processi lavorativi in qualità di mezzi di produzione, i prodotti pèrdono il carattere di prodotti e funzionano ormai soltanto coma fattori oggettivi del lavoro vivente. Se dunque i prodotti presenti non sono soltanto risultati ma anche condizioni d’esistenza del processo lavorativo, d’altra parte, l’unico mezzo per conservare e realizzare come valori d’uso questi prodotti di lavoro trascorso è gettarli nel processo lavorativo, dunque il loro contatto con il lavoro vivente.
Il lavoro consuma i suoi elementi materiali, i suoi oggetti e il suo mezzo, se ne ciba, ed è quindi processo di consumo. Tale consumo produttivo si distingue dal consumo individuale per il fatto che quest’ultimo
72

consuma i prodotti come mezzi di sussistenza dell’individuo vivente, mentre il primo li consuma come mezzi di sussistenza del lavoro, cioè della attuantesi forza-lavoro dell’individuo stesso. Il prodotto del consumo individuale è quindi lo stesso consumatore, il risultato del consumo produttivo è un prodotto distinto dal consumatore. In quanto il suo mezzo e il suo oggetto stesso sono già prodotti, il lavoro consuma prodotti per creare prodotti, ossia utilizza prodotti come mezzi di produzione di prodotti. Ma come il processo lavorativo si svolge originariamente soltanto fra l’uomo e la terra che esiste già senza il suo contributo, in esso continuano ancora sempre a servire quei mezzi di produzione che esistono per natura, che non rappresentano nessuna combinazione di materiale naturale e di lavoro umano.
Il processo lavorativo, come l’abbiamo esposto nei suoi movimenti semplici e astratti, è attività finalistica per la produzione di valori d’uso; appropriazione degli elementi naturali per i bisogni umani; condizione generale del ricambio organico fra uomo e natura; condizione naturale eterna della vita umana; quindi è indipendente da ogni forma di tale vita, e anzi è comune egualmente a tutte le forme di società della vita umana. Perciò non abbiamo avuto bisogno di presentare il lavoratore in rapporto con altri lavoratori. Sono stati sufficienti da una parte l’uomo e il suo lavoro, e dall’altra la natura e i suoi materiali. Come dal sapore del grano non si sente chi l’ha coltivato, così non si vede da questo processo sotto quali condizioni esso si svolga, sotto la sferza brutale del sorvegliante di schiavi o sotto l’occhio inquieto del capitalista.
Torniamo al nostro capitalista in spe. L’abbiamo lasciato dopo che aveva acquistato sul mercato tutti i fattori necessari al processo lavorativo, i fattori oggettivi ossia i mezzi di produzione, il fattore personale ossia la forza-lavoro. Ha scelto, con l’occhio scaltro del conoscitore, i mezzi di produzione e le forze-lavoro convenienti al suo genere particolare di operazioni, filatura, calzoleria, ecc. Dunque il nostro capitalista si mette a consumare la merce che ha comprato: la forza-lavoro; cioè fa consumare i mezzi di produzione al detentore della forza-lavoro, al lavoratore, attraverso il suo lavoro. Naturalmente la natura generale del processo lavorativo non cambia per il fatto che il lavoratore lo compie per il capitalista invece che per se stesso. Ma neppure la maniera determinata di fare stivali o di filare il refe può cambiare in un primo momento per l’inserirsi del capitalista. In un primo momento questi deve prendere la forza-lavoro come la trova sul mercato; tanto vale anche per il lavoro da essa compiuto, com’era sorto in un periodo nel quale non c’erano ancora capitalisti. La trasformazione anche del modo di produzione attraverso la subordinazione del lavoro al capitale può avvenire solo più tardi, e va quindi considerala più tardi.
Ora, il processo lavorativo nel suo svolgersi come processo di consumo della forza-lavoro da parte del capitalista ci mostra due fenomeni peculiari. Il lavoratorie lavora sotto il controllo del capitalista, al quale appartiene il tempo del lavoratore. Il capitalista sta attento a che il lavoro si svolga per bene e che i mezzi di produzione vengano impiegati appropriatamente; dunque fa attenzione a che non si sperperi materia prima, e che lo strumento dì lavoro non venga danneggiato, cioè che venga logorato soltanto quanto è reso necessario dal suo uso nel lavoro. Però, in secondo luogo: il prodotto è proprietà del capitalista, non del produttore diretto, del lavoratore. Il capitalista paga, p, es., il valore giornaliero della forza-lavoro. Dunque per quel giorno l’uso di essa gli appartiene come quello di ogni altra merce, p. es. di un cavallo noleggiato per un giorno. Al compratore della merce appartiene l’uso della merce, e infatti il possessore della forza-lavoro, dando il suo lavoro, non dà altro che il valore d’uso che ha venduto. Dal momento che egli è entrato nell’officina del capitalista, il valore d’uso della sua forza-lavoro, cioè l’uso di essa, il lavoro, è appartenuto al capitalista. Questi, mediante la compera dalla forza-lavoro ha incorporato il lavoro stesso, come lievito vivo, ai morti elementi costitutivi del prodotto, che anch’essi gli appartengono. Dal suo punto di vista il processo lavorativo è semplicemente il consumo della merce forza-lavoro, da lui acquistata, merce ch’egli tuttavia può consumare soltanto aggiungendole mezzi di produzione. Il processo lavorativo è un processo che si svolge fra cose che il capitalista ha comprato, fra cose che gli appartengono. Dunque il prodotto di questo processo gli appartiene,
Il valore d’uso non è affatto la cosa qu’on aime pour elle-même, nella produzione delle merci. Quivi in genere i valori d’uso vengono prodotti soltanto perché e in quanto essi sono sostrato materiale, depositari del valore di scambio. E per il nostro capitalista si tratta di due cose: in primo luogo egli vuol produrre un valore d’uso che abbia un valore di scambio, un articolo destinato alla vendita, una merce, e in secondo luogo vuol produrre una merce il cui valore sia più alto della somma dei valori delle merci necessarie alla sua produzione, i mezzi di produzione e la forza-lavoro, per le quali ha anticipato sul mercato il suo buon denaro. Non vuole produrre soltanto un valore d’uso, ma una merce, non soltanto valore d’uso, ma valore, e non soltanto valore, ma anche plusvalore. Il capitale non ha inventalo il pluslavoro. Ovunque una parte della società possegga il monopolio dei mezzi di produzione, il lavoratore, libero o schiavo, deve aggiungere al tempo di lavoro necessario al suo sostentamento tempo di lavoro eccedente per produrre i mezzi di sostentamento per il possessore dei mezzi di produzione. Tuttavia nel capitalista la voracità di pluslavoro si presenta nell’impulso a uno smodato prolungamento della giornata lavorativa. Il tasso del plusvalore è l’espressione esatta del grado di sfruttamento della forza-lavoro da parte del capitale, cioè del lavoratore da parte del capitalista. In realtà noi abbiamo considerato finora, com’è evidente, soltanto un lato del processo,
73

dato che qui si tratta di produzione di merci. Come la merce stessa è unità di valore d’uso e valore, anche il processo di produzione della merce deve essere unità di processo lavorativo e di processo di formazione di valore.
[C. I,5]
I.1.5. La produzione: processo dì valorizzazione
Consideriamo ora il processo di produzione anche come processo di formazione di valore. in quanto si considera il valore, cioè il tempo di lavoro richiesto per la produzione, i differenti e particolari processi lavorativi, separati nel tempo e nello spazio, possono venir considerati come fasi distinte e successive di un solo e medesimo processo lavorativo. Tutto il lavoro contenuto è lavoro trascorso. Che il tempo di lavoro richiesto per la produzione dei suoi elementi costitutivi sia trascorso prima, si trovi cioè al passalo remoto, mentre invece il lavoro adoperato direttamente per il processo conclusivo stia più vicino al presente, e sia al passato prossimo, è una circostanza del tutto indifferente, non cambia nulla alla quantità complessiva del tempo di lavoro incorporato in quella cosa. Così pure il tempo di lavoro contenuto nel materiale lavorativo e nei mezzi di lavoro può essere considerato senz’altro come speso semplicemente in uno stadio precedente del processo.
I valori dei mezzi di produzione, sono dunque parti costitutive del valore, cioè del valore del prodotto. Ora, è d’importanza decisiva che, per tutta la durata del processo, venga consumato soltanto il tempo di lavoro socialmente necessario, in condizioni di produzione normali, cioè in condizioni sociali medie. Poiché soltanto il tempo di lavoro socialmente necessario conta come creatore di valore. Determinate quantità di prodotto, fissate in base alla esperienza, non rappresentano ormai altro che determinate quantità di lavoro, masse determinate di tempo di lavoro cristallizzato. Ormai sono semplicemente materializzazione d’un’ora, di due ore, d’un giorno di lavoro sociale. Consideriamo il prodotto del processo lavorativo prolungato. Il colpo è riuscito, finalmente. Il denaro è trasformato in capitale. Tutti i termini del problema sono risolti e le leggi dello scambio delle merci non sono state affatto violate. Si è scambiato equivalente con equivalente; il capitalista, come compratore, ha pagato ogni merce al suo valore; poi ha fatto quel che fa ogni altro compratore dì merci; ha consumato il loro valore d’uso. Il processo di consumo della forza-lavoro che insieme è processo di produzione della merce. Il capitalista torna ora sul mercato e vende merce dopo aver comprato merce. Tutto questo svolgimento di trasformazione in capitale del denaro del nostro capitalista, avviene e non avviene nella sfera della circolazione. Avviene attraverso la mediazione della circolazione, perché ha la sua condizione nella compera della forza-lavoro sul mercato delle merci; non avviene nella circolazione, perché questa non fa altro che dare inizio al processo di valorizzazione, il quale avviene nella sfera della produzione. E così “tout est pour le mieux dans le meilleur de mondes possibles”.
Il capitalista, trasformando denaro in merci che servono per costituire il materiale di un nuovo prodotto ossia servono come fattori del processo lavorativo, incorporando forza-lavoro vivente alla loro morta oggettìvità, trasforma valore, lavoro trapassato, oggettivato, morto, in capitale, in valore autovalorizzantesi; mostro animato che comincia a “lavorare” come se avesse amore in corpo. Ma confrontiamo il processo di creazione di valore e il processo di valorizzazione: quest’ultimo non è altro che un processo di creazione di valore prolungato al di là di un certo punto. Se il processo di creazione di valore dura soltanto fino al punto nel quale il valore della forza-lavoro pagato dal capitale è sostituito da un nuovo equivalente, è processo semplice di creazione di valore; se il processo di creazione di valore dura al di là di quel punto, esso diventa processo di valorizzazione. Inoltre, se confrontiamo il processo di creazione del valore col processo lavorativo, quest’ultimo consiste nel lavoro utile, che produce valori d’uso. Qui il movimento viene considerato qualitativamente, nel suo modo e nella sua caratteristica particolari, secondo il suo fine e il suo contenuto. Il medesimo processo lavorativo si presenta invece solo dal suo lato quantitativo nel processo di creazione del valore. Qui si tratta ormai soltanto del tempo del quale il lavoro abbisogna per condurre a termine le sue operazioni, ossia della durata del dispendio utile di forza-lavoro. Qui anche le merci che vengono immesse nel processo lavorativo non valgono più come fattori materiali, determinati in base alla loro funzione, della forza-lavoro operante per il proprio fine: contano ormai soltanto come quantità determinate di lavoro ogget-tivato. Che sia contenuto nei mezzi di produzione o che venga aggiunto mediante la forza-lavoro, il lavoro conta ormai soltanto secondo la sua misura di tempo. Ammonta a tante ore, tante giornate, ecc.
Tuttavia conta solo in quanto il tempo consumato per la produzione del valore d’uso è necessario socialmente. Ciò comprende vari elementi. La forza-lavoro deve funzionare in condizioni normali. Tuttavia, il carattere normale dei fattori oggettivi del lavoro non dipende dal lavoratore, ma dal capitalista. Un’altra condizione è il carattere normale della forza-lavoro stessa. Questa deve possedere, per la specialità nella quale viene adoperata, la misura media prevalente di attitudine, rifinitura e sveltezza. Ma il nostro capitalista
74

ha comprato sul mercato del lavoro forza-lavoro di bontà normale. Questa forza dev’essere spesa con la misura media abituale di sforzo, nel grado d’intensità usuale in quella data società. Il capitalista veglia a ciò con lo stesso scrupolo che mette in atto perché non si sprechi tempo senza lavorare. Ha comprato la forza-lavoro per un periodo determinato, e ci tiene ad avere il suo. Non vuole essere derubato. E infine – e per questo lo stesso personaggio ha un proprio code penal – non ci deve essere nessun consumo irrazionale di materia prima e di mezzi di lavoro, perché materiale o mezzi di lavoro sciupati rappresentano quantità di lavoro oggettivato spese in maniera superflua, e quindi non contano e non entrano nel prodotto della creazione del valore. Vediamo ora che la distinzione precedentemente ottenuta attraverso l’analisi della merce, fra il lavoro in quanto crea valore d’uso, e il medesimo lavoro in quanto crea valore, si è ora presentata come distinzione fra i differenti aspetti del processo di produzione.
Il processo di produzione, in quanto unità di processo lavorativo e di processo di creazione di valore, è processo di produzione di merci; in quanto unità di processo lavorativo e di processo di valorizzazione, è processo di produzione capitalistico, forma capitalistica della produzione delle merci. Abbiamo già notato che per il processo di valorizzazione è del tutto indifferente che il lavoro appropriatosi dal capitalista sia lavoro semplice, lavoro sociale medio, oppure lavoro più complesso, lavoro di importanza specifica superiore. Il lavoro che viene stimato come lavoro superiore, più complesso, in confronto al lavoro sociale medio, è l’estrinsecazione d’una forza-lavoro nella quale confluiscono costi di preparazione superiori, la cui produzione costa più tempo di lavoro, e che quindi ha valore superiore a quello della forza-lavoro semplice. Se il valore di questa forza è superiore, essa si manifesterà anche in lavoro superiore e si oggettiverà quindi, negli stessi periodi di tempo, in valori relativamente superiori. Il plusvalore risulta soltanto attraverso un’eccedenza quantitativa di lavoro, attraverso la durata prolungata del medesimo processo produttivo.
[C. I,5]
Il processo di produzione è unità immediata di processo lavorativo e processo di valorizzazione, così come il suo risultato diretto, la merce, è unità immediata di valore d’uso e valore di scambio. Ma il processo lavorativo non è che mezzo al fine del processo di valorizzazione, e il processo di valorizzazione in quanto tale è essenzialmente processo di produzione di plusvalore, processo di oggettivazione di lavoro non pagato. È questo che determina specificamente il carattere totale del processo produttivo. Se consideriamo il processo di produzione sotto due angoli distinti, 1) come processo lavorativo, 2) come processo di valorizzazione, è però chiaro che esso è un unico, indivisibile processo di lavoro. Non si lavora due volte: una per creare un prodotto utile, un valore d’uso, per trasformare i mezzi di produzione in prodotti; l’altra per produrre valore e plusvalore, per valorizzare il valore. Ne segue che il processo lavorativo appare come processo di valorizzazione e perché il lavoro concreto aggiunto nel suo corso è (per la sua intensità) eguale a un tanto di lavoro socialmente necessario a una data quantità di lavoro sociale medio, e perché questa quantità rappresenta, oltre al quantum contenuto nel salario, un quantum addizionale. È questo il calcolo quantitativo del particolare lavoro concreto come lavoro medio sociale necessario, un calcolo tuttavia al quale corrisponde l’elemento reale 1) dell’intensità normale del lavoro (il fatto che per creare una data quantità di prodotto si impiego solo il tempo di lavoro a ciò socialmente necessario), e 2) del prolungamento del processo lavorativo al di là della durata necessaria per reintegrare il valore del capitale variabile.
Ho già dimostrato che in tutti gli economisti fino ad oggi l’analisi della merce sulla base del “lavoro” è ambigua e incompleta. Non basta ridurre la merce a “lavoro”; bisogna ridarla al lavoro nella duplice forma in cui, da un lato, si presenta come lavoro concreto nel valore d’uso delle merci e, dall’altro, è calcolato come lavoro socialmente necessario nel valore di scambio. Nel primo caso, tutto dipende dal suo particolare valore d’uso, dal suo carattere specifico, che imprime al valore d’uso da esso prodotto il suo specifico marchio e ne fa un valore d’uso concreto differente da altri, quel particolare articolo. Quando invece lo si calcola come elemento creatore dì valore e la merce come sua oggettivazione, allora si astrae completamente dalla sua particolare utilità, dalla sua natura e dal suo modo d’essere determinati. Come tale, esso è lavoro indifferenziato, generale, socialmente necessario, indifferente a qualsivoglia contenuto, e quindi trova nella sua espressione autonoma, nel denaro, nella merce come prezzo, un’espressione comune a tutte le merci e solo distinguibile per la sua quantità. Qui il lavoro contenuto nei mezzi di produzione è una certa quantità di lavoro sociale generale e quindi si esprime in una data grandezza di valore o somma di denaro; di fatto, nel prezzo di questi mezzi di produzione. Il lavoro aggiunto, d’altra parte, è una data quantità addizionale di lavoro sociale generale e quindi si esprime in una grandezza di valore o somma di denaro addizionale. Il lavoro già contenuto nei mezzi di produzione è lo stesso del lavoro aggiunto ex novo; l’unica differenza è che l’uno è oggettivato in valori d’uso e l’altro coinvolto nel processo di questa oggettivazione; l’uno è passato, l’altro presente; l’uno è morto, l’altro vivo; l’uno è oggettivato nel perfetto, l’altro sì oggettiva nel presente.
Nella misura in cui il lavoro passato sostituisce lavoro vivo, esso stesso diventa un processo; si valorizza; è un fluens che genera una fluxio. Questo suo assorbire lavoro vivo addizionale è il processo della sua valorizzazione, la sua metamorfosi in capitale, in valore che si valorizza; la sua trasformazione da grandezza
75

di valore costante in grandezza di valore variabile o in processo. È quindi eminentemente in questo senso – nel senso cioè del processo di valorizzazione, in cui risiede il vero scopo della produzione capitalistica – che il capitale come lavoro oggettivato (lavoro accumulato, preesistente o come altro si voglia chiamarlo) si oppone ed è opposto dagli economisti al lavoro vivo (immediato ecc.). Ma qui gli economisti cadono in ambiguità e contraddizioni continue per non aver sviluppato con chiarezza l’analisi della merce sulla base del lavoro nella sua duplice forma (errore visibile pure in Ricardo). Ma è solo nello stesso processo produttivo che il lavoro oggettivato, succhiando lavoro vivo, si trasforma in capitale, solo cosi il lavoro si trasforma in capitale. All’interno del processo lavorativo, questi oggetti non hanno altro senso che di fungere da mezzi di vita del lavoro, suoi valori d’uso – in rapporto al lavoro vivo, come sua materia e suo mezzo; in rapporto al prodotto del lavoro, come suoi mezzi di produzione; in rapporto al fatto che questi ultimi sono già dei prodotti, come prodotti in quanto mezzi per creare un nuovo prodotto. Ma questi oggetti non recitano questa parte nel processo lavorativo perché il capitalista li comperi, perché siano la forma modificata del suo denaro; al contrario, egli li compera appunto perché essi recitino, questa parte nel processo lavorativo.
Per il fatto di essere consumate nel processo lavorativo, o consumate produttivamente, le merci non diventano capitale; diventano elementi del processo lavorativo. In quanto il capitalista compera questi elementi oggettivi del processo lavorativo, essi rappresentano, certo, il suo capitale. Ma altrettanto vale per il lavoro: anch’esso rappresenta il suo capitale, perché il lavoro appartiene al compratore di capacità lavorativa allo stesso titolo delle condizioni oggettive del lavoro da lui acquistate. E gli appartiene l’intero processo lavorativo, non soltanto i suoi elementi singoli: il capitale che prima esisteva sotto forma di denaro ora esiste sotto forma di processo lavorativo. Ma che il capitale si sia impossessato del processo lavorativo e che di conseguenza il lavoratore lavori per il capitalista invece che per sé, non cambia nulla alla natura generale del processo medesimo. Come oro e argento non divengono per natura denaro perché il denaro prende, fra l’altro, la forma di oro e di argento, cosi la materia e il mezzo di lavoro non diventano per natura capitale perché il denaro, nel trasformarsi in capitale, si converte nei fattori del processo lavorativo e perciò si rappresenta necessariamente in materia e mezzo di lavoro. Eppure, gli stessi economisti moderni i quali ridono dell’ingenuità del sistema monetario quando alla domanda: Che cos’è il denaro?, esso risponde: Il denaro è oro e argento, non si vergognano, se si domanda loro: Che cos’è il capitale?, di rispondere: Il capitale è del cotone. Dicono infatti nulla di diverso, costoro, quando dichiarano che la materia e il mezzo di lavoro, i mezzi di produzione o i prodotti usati per una nuova produzione, insomma le condizioni oggettive del lavoro, sono per natura capitale in quanto e perché, per le loro proprietà materiali di valori d’uso, servono nel processo lavorativo?
Una sedia a quattro gambe ricoperta di velluto rappresenta in date circostanze un trono; ma non per questo una sedia, cioè un oggetto che serve per sedersi, diviene un trono per la natura del suo valore d’uso. Questo assurdo di scambiare un dato rapporto sociale di produzione che si rappresenta in oggetti, in cose, per una proprietà naturale materiale di questi stessi oggetti, di queste stesse cose, balza agli occhi sfogliando il primo dei migliori compendi di economia politica e leggendo ad apertura di pagina che gli elementi del processo di produzione, ricondotti alla loro forma più generale, sono la terra, il capitale, e il lavoro. Da una parte, si elencano gli elementi del processo lavorativo amalgamati con gli specifici caratteri sociali che a un dato stadio dello sviluppo storico essi possiedono, dall’altro vi si aggiunge un elemento che appartiene al processo lavorativo in quanto processo eterno svolgentesi fra l’uomo e la natura in generale, indipendentemente da qualunque particolare forma storica. Vedremo poi come l’illusione degli economisti – per cui si scambia per processo lavorativo la sua appropriazione da parte del capitale, e quindi si trasformano senz’altro in capitale gli elementi oggettivi del processo lavorativo perché il capitale si converte fra le altre cose negli clementi materiali, oggettivi, di questo processo – come, dicevamo, questa illusione, che negli economisti classici dura solo finché essi considerano il processo di produzione capitalistico esclusivamente sotto l’angolo visuale del processo lavorativo, nasca dalla natura stessa del processo di produzione capitalistico. Ma ci si accorge subito che è un metodo molto comodo per dimostrare l’eternità del modo di produzione capitalistico, ovvero per fare del capitale un elemento naturale immutabile dell’esistenza umana.
Il lavoro è condizione naturale eterna dell’esistenza umana. Il processo lavorativo non è altro che lo stesso lavoro considerato nel momento della sua attività creatrice. Dunque, gli elementi generali del processo lavorativo sono indipendenti da qualunque sviluppo sociale dato, e sia il mezzo che la materia del lavoro, formati in parte di prodotti di lavoro precedente, recitano la loro parte in ogni processo lavorativo in tutti i tempi e in qualunque circostanza. Se, quindi, applico loro l’etichetta di capitale nella fiduciosa convinzione che “sem-per aliquid haeret” [qualcosa resta pur sempre appiccicato], ho bell’e dimostrato che l’esistenza del capitale è una legge naturale eterna della produzione umana e che il chirghiso il quale taglia dei giunchi con un coltello rubato a un russo per farsene una barca, è un capitalista alla stessa stregua del signor von Rothschild.
[VI. 1.4-5]
76

I.1.6. La merce: lavoro, valore, denaro
Ogni uomo è ricco o povero secondo la misura in cui può permettersi di godere delle necessità, dei comodi e dei piaceri della vita umana. Ma dopo che la divisione del lavoro si è pienamente affermata, il lavoro di un singolo uomo può provvedere solo a una piccolissima parte di queste cose. La parte di gran lunga maggiore egli la deve trarre dal lavoro dell’altra gente e sarà ricco o povero secondo la quantità di lavoro che può comandare, ovvero che può permettersi di comprare. Il valore di una merce, per la persona che la possiede e che non intende usarla o consumarla lei stessa ma scambiarla con altre merci, è quindi uguale alla quantità di lavoro che essa la mette in grado di comprare o di comandare. Il lavoro è dunque la misura reale del valore di scambio di tutte le merci. Il lavoro è il primo prezzo, l’originaria moneta d’acquisto con cui si pagano tutte le cose. Non è stato con l’oro o con l’argento, ma col lavoro, che sono state comprate in origine tulle le ricchezze del mondo. Ogni merce, inoltre, viene scambiata, e quindi paragonata, più spesso con altre merci che col lavoro. È quindi più naturale stimare il suo valore di scambio in base alla quantità di qualche altra merce, piuttosto che in base alla quantità di lavoro.
In quello stadio primitivo e rozzo della società che precede l’accumulazione dei fondi e l’appropriazione della terra, il rapporto fra le quantità di lavoro necessarie a procurarsi diversi oggetti sembra sia la sola circostanza che possa offrire una qualche regola per scambiarli l’uno con l’altro. Non appena i fondi si sono accumulati nelle mani di singole persone, alcune di loro li impiegheranno naturalmente nel mettere al lavoro gente operosa, a cui forniranno materiali e mezzi di sussistenza allo scopo di trarre profitto dalla vendita delle loro opere o da ciò che il loro lavoro aggiunge al valore dei materiali. L’imprenditore dell’opera rischia i suoi fondi dell’impresa. Il valore che i lavoratori aggiungono ai materiali si divide dunque in questo caso in due parti, una delle quali paga il loro salario, mentre l’altra paga i profitti di chi li impiega sul complesso dei fondi che ha anticipato per i materiali e i salari. Costui non potrebbe avere alcun interesse a impiegare i lavoratori, se dalla vendita della loro opera non si attendesse qualcosa di più di quanto è sufficiente a rimpiazzare i suoi fondi; e non potrebbe avere alcun interesse a impiegare dei fondi grandi piuttosto che piccoli, se i suoi profitti non mantenessero un certo rapporto con l’ammontare dei suoi fondi. Si può forse pensare che i profitti dei fondi sono solo un diverso nome per il salario di un tipo particolare di lavoro, il lavoro di ispezione e di direzione. Essi sono invece affatto diversi, sono regolati da principi assolutamente autonomi e non hanno alcun rapporto con la quantità, con la durezza e con l’ingegno di questo supposto lavoro di ispezione e di direzione. Essi sono regolati esclusivamente dal valore dei fondi impiegati, e sono maggiori o minori in rapporto all’ammontare di questi. Nel prezzo delle merci i profitti dei fondi costituiscono dunque una parte componente del tutto diversa dai salari del lavoro, e regolala da principi interamente diversi.
[RN. I,5-6]
Il valore di una merce, ovvero la quantità di ogni altra merce con la quale si scambierà, dipende dalla relativa quantità di lavoro necessaria alla sua produzione, e non dal maggiore o minore compenso che per tale lavoro viene corrisposto. L’utilità non è quindi la misura del valore di scambio, sebbene sia assolutamente essenziale a tale valore. Se non fosse in alcun motto utile – se in altre parole non potesse in alcun modo contribuire alla nostra soddisfazione – una merce sarebbe priva di valore di scambio, per quanto potesse essere scarsa, o comunque potesse essere cospicua la quantità di lavoro necessaria per procurarsela. Vi sono merci, il cui valore è determinato esclusivamente dalla scarsità. Non esiste lavoro che possa accrescere la quantità di tali merci, e perciò il loro valore non può diminuire per un aumento dell’offerta. Rientrano in questa categoria statue e quadri rari, libri e monete scarsi, vini di particolare qualità ecc. di cui vi sia una quantità molto limitata. Il loro valore è del tutto indipendente dalla quantità di lavoro originariamente necessaria per produrli. Quelle merci, comunque, formano una piccolissima parte della massa di merci scambiate giornalmente nel mercato.
La parte di gran lunga maggiore delle merci che sono oggetto di desiderio è procurata dal lavoro; queste possono essere moltiplicate quasi illimitatamente non in un solo paese, ma in molti paesi, se siamo disposti a erogare il lavoro necessario per ottenerle. Perciò, quando parliamo di merci, del loro valore di scambio e delle leggi che ne regolano i prezzi relativi, intendiamo sempre riferirci esclusivamente alle merci la cui quantità può venire accresciuta con l’impiego della operosità umana e sulla cui produzione la concorrenza agisce senza limitazione. Che questo sia il vero fondamento del valore di scambio di tutte le cose, eccettuate quelle che non si possono accrescere per mezzo dell’operosità umana, è dottrina della massima importanza nell’economia politica; giacché da nessun’altra fonte derivano in questa scienza tanti errori e tante divergenze di opinione come dalle idee vaghe che sono attribuite alla parola valore. Se la quantità di lavoro realizzata nelle merci ne regola il valore di scambio, ogni incremento della quantità di lavoro deve aumentare il valore della merce nella quale esso si manifesta, così come ogni diminuzione deve diminuirlo. Non solo il
77

lavoro applicato direttamente alla produzione delle merci influisce sul loro valore, ma anche il lavoro che viene erogato nella produzione degli attrezzi, degli utensili e dei fabbricati con cui tale lavoro è assistito.
[PEP. I]
La grandezza di valore dì una merce rimarrebbe quindi costante se il tempo di lavoro richiesto per la sua produzione fosse costante. Ma esso cambia con ogni cambiamento della forza produttiva del lavoro. La forza produttiva del lavoro è determinata da molteplici circostanze, e, fra le altre, dal grado medio di abilità del lavoratore, dal grado di sviluppo e di applicabilità tecnologica della scienza, dalla combinazione sociale del processo di produzione, dall’entità e dalla capacità operativa dei mezzi di produzione, e da situazioni naturali. Il valore delle merci sta in rapporto inverso alla forza produttiva del lavoro; e altrettanto il valore della forza-lavoro, perché determinato da valori di merci. Invece, il plusvalore relativo sta in rapporto diretto alla forza produttiva del lavoro. Cresce col crescere della forza produttiva, e cala col calare di essa. È istinto immanente e tendenza costante del capitale aumentare la forza produttiva del lavoro par ridurre più a buon mercato la merce, e con la riduzione a più buon mercato della merce ridurre più a buon mercato il lavoratore stesso. Per il capitalista che produce la merce, il valore assoluto di questa è, in sé e per sé, indifferente: gli interessa solo il plusvalore insito nella merce e realizzabile nella vendita. La realizzazione di plusvalore implica di per se stessa la reintegrazione del valore anticipato. Dunque, nella produzione capitalistica la economia di lavoro mediante lo sviluppo della forza produttiva del lavoro non ha affatto lo scopo di abbreviare la giornata lavorativa. Ha solo lo scopo di abbreviare il tempo di lavoro necessario per la produzione di una determinata quantità di merci. Entro i limiti della produzione capitalistica, lo sviluppo della forza produttiva del lavoro ha lo scopo di abbreviare la parte della giornata lavorativa nella quale il lavoratore deve lavorare per se stesso, per prolungare, proprio con quel mezzo, l’altra parte della giornata lavorativa nella quale il lavoratore può lavorare gratuitamente per il capitalista.
Il secondo periodo del processo lavorativo, nel quale il lavoratore sgobba oltre i limiti del lavoro necessario, gli costa certo lavoro, dispendio di forza-lavoro, ma per lui non crea nessun valore. Esso crea plusvalore, che sorride al capitalista con tutto il fascino d’una creazione dal nulla. Chiamo tempo di lavoro soverchio [o eccedente] questa parte della giornata lavorativa, e pluslavoro [surplus labour] il lavoro speso in esso. Per conoscere il plusvalore è altrettanto decisivo intenderlo come puro e semplice coagulo di tempo di lavoro soverchio, come pluslavoro semplicemente oggettivato, quanto è decisivo, per conoscere il valore in generale, intenderlo come puro e semplice coagulo di tempo di lavoro, come semplice lavoro oggettivato. Solo la forma per spremere al produttore immediato, al lavoratore, questo pluslavoro, distingue le formazioni economiche della società; p. es., la società della schiavitù da quella del lavoro salariato.
Le merci non diventano commensurabili per mezzo del denaro. Viceversa, poiché tutte le merci come valori sono lavoro umano oggettivato, quindi sono commensurabili in sé e per sé, possono misurare i loro valori in comune in una stessa merce speciale, ossia in denaro. Il denaro come misura di valore è la forma fenomenica necessaria della misura immanente di valore delle merci, del tempo di lavoro. La forma generale d’equivalente è una forma del valore in genere. Quindi può spettare ad ogni merce. D’altra parte una merce si trova in forma generale di equivalente solo perché e in quanto viene esclusa da tutte le altre merci, come equivalente E solo dal momento nel quale questa esclusione si limita definitivamente a un genere specifico di merci, la forma unitaria relativa di valore del mondo delle merci ha raggiunto consistenza oggettiva e validità generalmente sociale. Ora il genere specifico di merci con la cui forma naturale s’è venuta identificando man mano socialmente la forma di equivalente, diventa merce denaro, ossia funziona come moneta. La sua funzione specificamente sociale, e quindi il suo monopolio sociale, diventa quella di rappresentare la parte dell’equivalente generale entro il mondo delle merci. Una merce determinata, l’oro, ha conquistalo storicamente questo posto privilegiato fra le merci. L’oro si presenta come denaro nei confronti delle altre merci solo perché si era presentato già prima come merce nei confronti di esse; e appena ha conquistato il monopolio di questa posizione nell’espressione di valore dei mondo delle merci, diventa merce denaro, e solo dal momento nel quale esso è già diventato merce denaro; ossia la forma generale di valore è trasformata nella forma di denaro.
Il processo di scambio produce uno sdoppiamento della merce in merce e in denaro, opposizione esterna nella quale esse rappresentano la loro opposizione immanente di valore d’uso e di valore. In questa opposizione le merci come valori di uso si oppongono al denaro come valore di scambio. D’altra parte, tutte e due le parti dell’opposizione sono merci, quindi unità di valore d’uso e valore. Ma questa unità di cose differenti presenta se stessa in ognuno dei due poli inversamente all’altro, e con ciò rappresenta simultaneamente anche il loro rapporto reciproco. La merce è realmente valore d’uso, il suo essere valore appare solo idealmente nel prezzo, il quale la riferisce all’oro che le sta di fronte, come a sua reale figura di valore. Queste forme opposte delle merci sono le forme reali di movimento del loro processo di scambio. la trasformazione della merce in denaro si compie nella stessa misura della trasformazione dei prodotti del lavoro in merci. Il denaro è il loro equivalente generale, esse si comportano come merci particolari nei
78

confronti del denaro come merce universale. Ed esse si confrontano e si misurano l’una con l’altra quali quantità d’oro differenti, e così si sviluppa tecnicamente la necessità di riferirle a una quantità d’oro fissata, come loro unità di misura. Tale unità di misura, a sua volta, viene ulteriormente sviluppata a scala, mediante la sua suddivisione in parli aliquote. Come misura dei valori e come scala dei prezzi il denaro adempie a due funzioni del tutto diverse. È misura dei valori, quale incarnazione sociale del lavoro umano; è scala dei prezzi quale peso stabilito di un metallo. Come misura di valore, serve a trasformare i valori delle merci varie e multicolori in prezzi, in quantità ideali di oro; come scala dei prezzi esso misura quelle quantità d’oro. Sulla misura dei valori si misurano le merci come valori, invece la scala dei prezzi misura quantità d’oro su una quantità d’oro, non il valore d’una quantità d’oro sul peso delle altre. Per la scala dei prezzi occorre fissare un determinato peso d’oro come unità di misura. Qui, come in tutte le altre determinazioni di misura di grandezze omonime, la stabilità dei rapporti di misura è decisiva.
S’è visto che la forma di denaro è soltanto il riflesso delle relazioni di tutte le altre merci che aderisce saldamente ad una merce. Che l’oro sia merce costituisce dunque una scoperta soltanto per colui che parte dalla sua figura compiuta per analizzarla a posteriori. Il processo di scambio non dà, alla merce che esso trasforma in denaro, il suo valore, ma la sua forma specifica di valore. La confusione fra le due determinazioni ha indotto a ritenere immaginario il valore dell’oro e dell’argento. E poiché la moneta in certe sue determinate funzioni può essere sostituita con semplici segni di se stessa, è sorto l’altro errore ch’essa sia un semplice segno. D’altra parte, in tutto ciò c’era l’intuizione che la forma di denaro della cosa le sia esterna, e sia pura forma fenomenica di rapporti umani nascosti dietro di essa. Il contegno degli uomini, puramente atomistico nel loro processo sociale di produzione, e quindi la figura materiale dei loro propri rapporti di produzione, indipendente dal loro controllo e dal loro consapevole agire individuale, si mostrano in primo luogo nel fatto che i prodotti del loro lavoro assumono generalmente la forma di merci. Quindi l’enigma del feticcio denaro è soltanto l’enigma del feticcio merce divenuto visibile e che abbaglia l’occhio.
Il prezzo è il nome di denaro del lavoro oggettivato nella merce. L’equivalenza della merce e della quantità di denaro il cui nome costituisce il prezzo della merce, è quindi una tautologia, come, in genere, l’espressione relativa di valore di una merce è sempre l’espressione dell’equivalenza di due merci. Con la trasformazione della grandezza di valore in prezzo, questo rapporto necessario si presenta come rapporto di scambio di una merce con la merce denaro esistente fuori di essa. Però, in questo rapporto può trovare espressione tanto la grandezza di valore della merce, quanto il più o il meno, nel quale essa è alienabile in date circostanze. La possibilità di un’incongruenza quantitativa fra prezzo e grandezza di valore, sta dunque nella forma stessa di prezzo. E questo non è un difetto di tale forma, anzi al contrario ne fa la forma adeguata d’un modo di produzione, nel quale la regola si può far valere soltanto come legge della media della sregolatezza, operante alla cieca. La forma di prezzo, tuttavia, non ammette soltanto la possibilità d’una incongruenza relativa fra grandezza di valore e prezzo, cioè fra la grandezza di valore e la sua espressione in denaro, ma può accogliere una contraddizione qualitativa, cosicché il prezzo, in genere, cessi d’essere espressione di valore, benché il denaro sia soltanto la forma di valore delle merci. Cose che in sé e per sé non sono merci, p. es., coscienza, onore, ecc, dai loro possessori possono essere considerate in vendita per denaro e così ricevere la forma di merce, mediante il prezzo dato loro. Quindi formalmente una cosa può avere un prezzo, senza avere un valore. Qui l’espressione di prezzo diventa immaginaria, come certe grandezze della matematica. D’altra parte, anche la forma di prezzo immaginaria, come p. es. il prezzo del terreno incolto, che non ha nessun valore, perché in esso non è oggettivato lavoro umano, può celare un rapporto reale di valore, o una relazione da tale rapporto derivata.
La forma di prezzo implica l’alienabilità delle merci contro denaro e la necessità di tale alienazione. D’al -tra parte, l’oro funziona come misura di valore ideale soltanto perché si muove come merce denaro già nel processo di scambio. Nella misura ideale dei valori sta dunque in agguato la dura moneta. Nelle varie sfere di produzione, in monopoli artificiali o naturali, e specialmente nel monopolio della proprietà si rende possibile un prezzo di monopolio superiore al prezzo di produzione e al valore delle merci, su cui il monopolio esercita la sue azione; i limiti dati dal valore delle merci non sarebbero per questo soppressi. La ripartizione del plusvalore fra le diverse sfere di produzione subirebbe indirettamente una perturbazione locale, che però lascerebbe invariati i limiti di questo plusvalore stesso. I limiti, entro i quali il prezzo di monopolio influirebbe sulla regolazione normale dei prezzi delle merci, sarebbero nettamente determinali e potrebbero essere esattamente calcolati.
[C. I.3;5;6;8;10; III.50]
I.1.7. La merce: aliquota del prodotto del capitale totale
La merce, come forma elementare della ricchezza borghese è il presupposto della formazione del capitale. D’altra parte, le merci appaiono ora come il prodotto del capitale, e mostrano che la merce come prodotto
79

del capitale, come sua parte costitutiva aliquota, come depositaria del capitale che si è valorizzato e che perciò contiene in sé una quota parte del plusvalore creato, dev’essere considerata in modo diverso da come la consideravamo in quanto merce singola autonoma. La merce singola in quanto prodotto del capitale e, in realtà, parte elementare del capitale riprodotto e valorizzato, si differenzia dalla merce singola dalla quale eravamo partiti come presupposto della formazione del capitale, insomma dalla merce considerata autonomamente, anche perché la vendita della merce singola al suo prezzo non realizza da sola né il valore del capitale anticipato per la produzione né quello del plusvalore da esso prodotto. Tutta la difficoltà sta nel fatto che le merci non vengono scambiate semplicemente come merci, ma come prodotti di capitali. Si noti che, come pure depositarie del capitale – non solo materialmente come parti del valore d’uso di cui il capitale consta, ma come depositarie del valore di cui il capitale si compone – le merci possono essere vendute al prezzo corrispondente al loro valore individuale e tuttavia al di sotto del loro valore come prodotti del capitale e come parti costitutive del prodotto totale in cui il capitale autovalorizzatosi esiste.
Se ora una parte del prodotto totale fosse venduto al suo prezzo e le rimanenti porzioni rimanessero invendibili, l’atto di vendita riprodurrebbe solo la parte del capitale totale originario che è stata venduta: come depositaria del capitale totale, cioè come prodotto attuale unico del capitale totale, quella parte sarebbe stata venduta al di sotto del suo valore e l’altra parte alla parte di valore mancante. Il prezzo complessivo delle merci prodotte da un capitale determinato in un tempo determinato deve soddisfare questa rivendicazione. In qualsiasi modo i prezzi delle diverse merci vengano all’inizio fissati o regolati reciprocamente, il loro movimento è determinato dalla legge del valore. Anche astraendo dall’azione decisiva della legge del valore, è dunque conforme alla realtà considerare i valori delle merci, non solo da un punto di vista teorico ma anche storico, come il prius dei prezzi di produzione. Quando si afferma che le merci dei vari rami di produzione vengono vendute ai loro valori si vuole, naturalmente, solo dire che il loro valore costituisce il punto attorno al quale gravitano i prezzi di queste merci, e verso il quale si ristabilisce l’equilibrio delle loro incessanti oscillazioni sopra e sotto tale valore. Sarà sempre necessario fare una distinzione tra il valore di mercato e il valore individuale delle singole merci che vengono prodotte dai diversi produttori.
Lo scambio sviluppato di merci, e la forma della merce come forma sociale universalmente necessaria del prodotto, sono unicamente il risultato del modo di produzione capitalistico. La merce, in quanto tale, si esprime tangibilmente nell’unilateralità e nel carattere di massa del prodotto, il quale deve essere realizzato come valore di scambio, e quindi percorrere il ciclo di metamorfosi di ogni merce, come necessità per il rinnovo e la continuità del processo di produzione. Il problema non è qui, come per la merce autonoma, che la si venda al suo valore, ma che sia venduta al suo valore (prezzo) la merce in quanto depositaria del capitale anticipato per la sua produzione e perciò in quanto aliquota del prodotto totale del capitale. Occorre che essa sia venduta al suo prezzo come parte aliquota del valore totale del prodotto (e che questo coincida col valore totale venduto). Poiché con lo sviluppo della produzione capitalistica e la riduzione del prezzo delle merci a esso conseguente la loro massa cresce, aumenta il numero delle merci che devono essere vendute; è quindi necessaria per la produzione capitalistica un’incessante espansione del mercato.
Al fine di semplificare le cose, consideriamo come una unica merce tutta la massa di merci di un ramo di produzione e come unico prezzo la somma dei prezzi di tutte le merci identiche. Tutto quello che è stato detto a proposito di una singola merce, può essere integralmente applicato alla massa di merci di un determinato ramo di produzione, disponibile sul mercato. Quanto si è affermato, ossia che il valore individuale della merce corrisponde al suo valore sociale, esprime ora, in un’ulteriore applicazione o determinazione, il fatto che la quantità complessiva delle merci contiene la quantità di lavoro sociale necessaria alla sua produzione e che il valore di tale quantità corrisponde al suo valore di mercato.
La produzione capitalistica distrugge la base stessa della produzione mercantile semplice [einfache warenproduktion], la produzione individuale indipendente e lo scambio tra i possessori di merci, cioè lo scambio di equivalenti. Il processo di produzione immediato è costantemente e inseparabilmente processo lavorativo e processo di valorizzazione, così come il prodotto è unità di valore d’uso e di valore di scambio, cioè merce. La merce, così come esce dalla produzione capitalistica, presenta una determinazione diversa da quella che possedeva quando eravamo partiti da essa come elemento e presupposto della produzione capitalistica, in quanto prodotto indipendente in cui si era oggettivata una certa quantità di tempo di lavoro, e che perciò possedeva un valore (di scambio) di una grandezza data. Ma nella merce è oggettivata una somma totale di lavoro. La merce singola appare, non solo materialmente, come parte del prodotto totale del capitale, come parte aliquota della massa di merci da esso generata: non ci stanno più davanti merci isolate, prodotti singoli; come risultato del processo abbiamo non merci indipendenti, ma una massa di merci in cui si è riprodotto il valore del capitale anticipato più il plusvalore. Il lavoro speso in ogni singola merce non entra in conto; vale solo come aliquota del valore totale a essa spettante e idealmente computato.
La merce ora si mostra nel volume e nelle dimensioni della vendita che deve aver luogo, affinché l’origi-nario valore capitale e il plusvalore da esso prodotto si realizzino, cosa che non si ottiene vendendo al valore
80

loro proprio le singole merci o parti di esse. Si verificherebbe una svalutazione generale o una distruzione di capitale, sebbene il deprezzamento, consistente nel fatto che il produttore venderebbe la merce a un prezzo inferiore, si traduca necessariamente in un aumento di prezzo dalla parte del denaro, ovvero in un deprezzamento della merce prodotta rispetto al denaro, e un generale deprezzamento dei prezzi implichi generalmente sempre un aumento del prezzo del denaro, ossia della merce [particolare] su cui tutte le altre vengono stimate. In periodo di crisi si verifica dunque al tempo stesso, fino ad un certo momento, una svalutazione generale o distruzione di capitale. La svalutazione può essere generale, assoluta, non solo relativa come il deprezzamento, perché il valore non esprime semplicemente, come il prezzo, un rapporto tra una merce e un’altra, bensì il rapporto tra il prezzo della merce e il lavoro in essa oggettivato, ovvero tra una quantità di lavoro oggettivato della medesima qualità, e un’altra quantità.
La maggior parte delle merci, considerate come masse di un dato prodotto, sono divisibili secondo le misure abitualmente applicate a esse in quanto valori d’uso. Il prodotto totale del capitale, qualunque grandezza abbia, può sempre riguardarsi come una sola merce, come un solo valore d’uso, il cui valore di scambio appare quindi nel prezzo totale – che, stando al suo concetto generale, è sin dall’inizio unicamente la forma monetaria del valore – come espressione del valore totale del prodotto totale. Il suo valore totale è determinante, in generale, solo per il valore della massa di prodotti. Semplificando, si può considerare la questione come se l’intero capitale fosse interamente contenuto, senza residui, nel prodotto del capitale totale da analizzare. A eccezione del nuovo lavoro aggiunto, gli elementi della produzione capitalistica entrano essi stessi nel processo produttivo già come merci, quindi con dati prezzi. Il valore della singola merce si determina dividendo il prezzo totale del prodotto totale per le parti aliquote in cui, secondo l’unità di misura data, il prodotto si suddivide, ossia dividendo il prezzo totale del prodotto per il numero di unità di misura contenute nella massa del suo valore d’uso. In conclusione, il prezzo della singola merce si determina calcolando il suo valore d’uso come aliquota del prodotto totale, e il suo prezzo come aliquota corrispondente del valore totale generato dal capitale.
Tutta la polemica sulla possibilità e necessità della sovraproduzione al livello del capitale, verte sul problema se il processo di valorizzazione del capitale nella produzione implichi immediatamente la sua valorizzazione nella circolazione; se cioè la sua valorizzazione nel processo di produzione sia la sua valorizzazione reale. Oppure si afferma che domanda e offerta sono identiche e perciò debbono corrispondersi (ed è la posizione di Mill, imitato dall’insulso Say). L’offerta cioè sarebbe una domanda misurata dalla sua propria quantità. Ma qui si fa una gran confusione. All’interno del processo di produzione [immediata] la valorizzazione si identificava completamente con l’oggettivazione (del tempo) di pluslavoro, e perciò senza altri limiti se non quelli in parte presupposti, in parte posti nell’àmbito di questo stesso processo, ma che in esso lo sono sempre come ostacoli da superare. Ora invece compaiono ostacoli esterni al processo stesso.
Anzitutto, da un punto di vista del tutto superficiale, la merce è valore di scambio solo nella misura in cui è al tempo stesso valore d’uso, vale a dire oggetto di consumo (di che tipo di consumo, per ora è ancora indifferente); essa cessa di essere valore di scambio quando cessa di essere valore d’uso (giacché non esiste ancora di nuovo come denaro). Ma non appena essa cessa di essere valore d’uso, cessa anche di essere oggetto della circolazione (a meno che non sia denaro). Ma come nuovo valore e valore in generale sembra che essa trovi un ostacolo nel volume degli equivalenti esistenti, e anzitutto del denaro, inteso non come mezzo di circolazione ma come denaro. Il plusvalore (evidentemente, quello relativo al valore originario) richiede un equivalente supplementare. Il suo primo ostacolo dunque è il consumo stesso – il bisogno che se ne ha. Quando si dice che la merce ha un valore d’uso, si afferma che essa soddisfa un bisogno sociale qualsiasi. Fino a che si sono considerate soltanto le merci individuali, si poteva supporre che il bisogno di ogni merce determinata – essendo la sua quantità già espressa nel prezzo – esistesse realmente. Tale quantità diventa tuttavia un fattore essenziale non appena si considerino, da un lato, il prodotto di un intero ramo di produzione e, dall’altro, il bisogno sociale.
In base alle premesse finora poste non è ancora assolutamente possibile parlare di un bisogno insolvibile, ossia di un bisogno di una merce il quale non abbia da dare in cambio anch’esso una merce o denaro. In secondo luogo però deve esserci un equivalente per essa; ma poiché all’origine si è premesso che la circolazione fosse una grandezza fissa – di un volume determinato – e, d’altra parte, il capitale nel processo di produzione ha creato un nuovo valore, sembra in realtà che per quest’ultimo non possa esserci alcun equivalente. Sicché quando il capitale esce dal processo di produzione per rientrare di nuovo in circolazione, sembra che esso trovi, come produzione, un ostacolo nella grandezza esistente del consumo, o della capacità di consumo. Come valore d’uso determinato, la sua quantità è fino a un certo punto indifferente; solo a un determinato grado – poiché soddisfa soltanto un determinato bisogno – esso cessa di essere richiesto per il consumo. Non la singola merce appare come risultato del processo, ma la massa delle merci nelle quali si è riprodotto il valore del capitale totale più un plusvalore, e solo in quanto parte aliquota il prodotto diventa merce. Non è più il lavoro impiegato sulla singola merce particolare, che nella maggior parte dei casi non
81

potrebbe più essere calcolato, ma è il lavoro totale, il valore totale diviso per il numero dei prodotti ciò che determina il valore del singolo prodotto e lo costituisce come merce.
Come valore d’uso determinato, unilaterale, qualitativo, la sua stessa quantità è solo fino a un certo grado indifferente; giacché esso è richiesto soltanto in una determinata quantità, ossia in una certa misura. Si impone ora di esaminare la misura, ossia la quantità di questo bisogno sociale. Si supponga che questa massa di merci rappresenti l’offerta ordinaria, astraendo dalla possibilità che una parte delle merci prodotte venga temporaneamente sottratta al mercato. Ora se la domanda corrispondente a questa massa di merci rappresenta la domanda ordinaria, la merce sarà venduta al suo valore di mercato. Se invece la quantità è diversa dalla domanda, si avrà uno scarto tra il prezzo di mercato e il valore di mercato. Ma questa misura è data in parte dalla sua qualità di valore d’uso – dalla sua specifica utilità, dalla sua capacità di essere adoperato – e, in parte, dal numero di coloro che scambiano e che hanno bisogno di questo determinato consumo: dal numero dei consumatori moltiplicato per la grandezza del bisogno che essi hanno di questo specifico prodotto. Quando la massa delle merci prodotte è superiore a quella che può essere venduta ai valori medi di mercato sono le merci prodotte nelle condizioni più favorevoli che regolano il valore di mercato.
Il valore d’uso, in se stesso, non ha l’illimitatezza del valore in quanto tale. Solo fino a un certo grado certi oggetti possono essere consumati e sono oggetti di bisogno. Come valore d’uso dunque il prodotto ha un ostacolo in se stesso, nel bisogno che se ne ha, ostacolo che però non ha la sua misura nel bisogno di coloro che producono, bensì nel bisogno globale di coloro che scambiano. Quando cessa il bisogno di un determinato valore d’uso, questo cessa di essere valore d’uso. Qualora la massa dei prodotti superasse questo bisogno, le merci dovrebbero essere vendute al di sotto del loro valore di mercato. La domanda e l’offerta presuppongono la trasformazione del valore in valore di mercato, e dato che esse agiscono sul fondamento capitalistico, dato che le merci sono un prodotto del capitale, presuppongono altresì i processi di produzione capitalistici e di conseguenza rapporti assai più complessi della semplice compravendita delle merci. Con esse non si ha a che fare più semplicemente con una trasformazione formale del valore delle merci in prezzo, ossia con un mero cambiamento di forma; si ha a che fare con determinate differenze quantitative che si stabiliscono tra i prezzi di mercato e i valori di mercato e per giunta tra i prezzi di mercato e i prezzi di produzione.
Se si modificasse il valore di mercato, si modificherebbero anche le condizioni alle quali la massa complessiva delle merci potrebbe essere venduta. Se dunque la domanda e l’offerta regolano il mercato, o più esattamente, gli scarti tra prezzo di mercato e valore di mercato, il valore di mercato da parte sua regola il rapporto tra domanda ed offerta, vale a dire determina il punto attorno al quale le fluttuazioni della domanda e dell’offerta fanno oscillare i prezzi di mercato. Si noti qui di passaggio che il “bisogno sociale”, ossia ciò che regola il principio della domanda, risulta essenzialmente dal rapporto che esiste tra le diverse classi e dalla rispettiva posizione economica, vale a dire dipende innanzitutto dal rapporto tra il plusvalore complessivo e il salario, e, in secondo luogo, dal rapporto tra le diverse parti nelle quali si scompone il plusvalore (profitto, interesse, rendita fondiaria, imposte, ecc.). Si dimostra qui una volta di più che il rapporto tra domanda e offerta non può spiegare assolutamente nulla fino a che non si sia messa in luce la base su cui si fonda questo rapporto.
Considerando le cose più da vicino si vede che le medesime condizioni che determinano il valore di una singola merce, si ripresentano qui come condizioni che determinano il valore dell’insieme delle merci di uno stesso tipo. Questo si verifica perché la produzione capitalistica è per sua natura produzione in massa, e si vende come prodotto comune di tutto un ramo di produzione o come un contingente più o meno considerevole la produzione fatta in piccola quantità da molti piccoli produttori isolati. La misura del valore d’uso è data dal bisogno che se ne ha. Tutte le contraddizioni della circolazione rivivono in una nuova forma. Il prodotto come valore d’uso è in contraddizione con se stesso come valore; cioè, finché esso esiste in una determinata qualità, come una cosa specifica, come un prodotto di determinate proprietà naturali, come sostanza del bisogno in contraddizione con la sua sostanza che esso, come valore, possiede esclusivamente nel lavoro oggettivato. Questa volta però questa contraddizione non è più posta, come nella circolazione, soltanto in modo da essere una differenza puramente formale; qui invece l’esser misurato dal valore d’uso è rigorosamente determinato come un esser misurato dal bisogno globale che coloro che scambiano hanno di tale prodotto – vale a dire dalla quantità del consumo globale. Questo consumo globale qui si presenta come la misura del prodotto in quanto valore d’uso e perciò anche in quanto valore di scambio.
Ora abbiamo che la misura della sua presenza è data dal suo stesso carattere naturale. Per essere convertito nella forma generale, il valore d’uso deve essere presente soltanto in una quantità determinata; una quantità, la cui misura non sta nel lavoro in esso oggettivato, bensì scaturisce dalla sua natura di valore d’uso, o meglio di valore d’uso per altri. La valorizzazione consiste nella possibilità reale di una maggiore valorizzazione. È chiaro che coloro che rappresentano tutte le merci consumate dai lavoratori e tutte le merci consumate dai capitalisti avrebbero prodotto troppo – troppo relativamente alla proporzione in cui essi devono aumentare il capitale. La sovraproduzione generale insomma si verificherebbe non perché, delle
82

merci destinate al consumo dei lavoratori e di quelle destinate al consumo dei capitalisti, se ne siano prodotte relativamente troppo poche, ma al contrario perché se ne sono prodotte troppe sia delle une che delle altre – non troppe rispetto al consumo, ma troppe per mantenere la giusta proporzione tra consumo e valorizzazione; troppe rispetto alla valorizzazione. Il fatto che ogni singolo prodotto, od ogni determinata quantità di un certo tipo di merci, possa contenere soltanto il lavoro sociale richiesto per la sua produzione e che quindi il valore di mercato complessivo di tale tipo di merci rappresenti, da questo punto di vista, soltanto il lavoro sociale necessario, non esclude che una parte del tempo di lavoro sociale vada disperso qualora quella merce sia stata prodotta in una quantità superiore a quella richiesta temporaneamente dal bisogno sociale: la massa di merci rappresenta sul mercato una quantità di lavoro sociale assai inferiore a quella che essa contiene in realtà. Di conseguenza queste merci devono essere vendute al di sotto del loro valore di mercato e può anche accadere che una parte di esse rimanga completamente invenduta.
Lo scambio o la vendita delle merci al loro valore costituisce la legge razionale, naturale, del loro equilibrio; è su di essa che bisogna fondarsi per spiegare le eccezioni, e non sulle eccezioni per spiegare la legge stessa. Perché una merce sia venduta al suo valore di mercato, ovvero a un prezzo corrispondente al lavoro sociale necessario che essa contiene, occorre che la quantità complessiva di lavoro sociale destinato alla massa complessiva di questo genere di merci corrisponda alla quantità del bisogno sociale esistente per essa, ovvero del bisogno sociale che è in grado di pagare. In questo caso l’offerta si è modificata, quantunque la domanda sia rimasta inalterata e perciò si è verificata una relativa sovraproduzione. Tra una determinata quantità di prodotti che si trovano sul mercato e il loro valore di mercato esiste unicamente il seguente rapporto: presupposto un determinato grado di produttività del lavoro, la produzione d’una quantità determinata di prodotti richiede, in ogni particolare ramo produttivo, una quantità determinata di tempo di lavoro sociale; tale rapporto varia tuttavia completamente da un ramo di produzione all’altro e non dipende né dall’utilità di questi prodotti né dalla particolare natura dei loro valori d’uso.
Ogni singolo capitalista, come anche il complesso dei capitalisti in ogni particolare ramo della produzione, è interessato allo sfruttamento e al grado di sfruttamento di tutta la classe lavoratrice da parte del capitale totale non solo per solidarietà di classe, ma per un diretto interesse economico, giacché il tasso medio del profitto è legato al grado di sfruttamento del lavoro complessivo da parte del capitale complessivo. Ogni particolare ramo del capitale e ogni singolo capitalista sono ugualmente interessati alla produttività del lavoro sociale attivato dal capitale totale. Questa interna divisione concettuale del capitale si presenta, nello scambio, sotto forma di proporzioni determinate e limitate – anche se continuamente mutevoli nel corso della produzione – riguardanti lo scambio reciproco tra i capitali. Così è data anche la proporzione in cui ciascun capitale deve scambiare con l’altro che rappresenta un momento determinato di se stesso, e quella in cui ciascun capitale deve scambiare in generale. Ma la loro necessità interna si manifesta durante la crisi, che pone fine violentemente all’apparenza della loro indifferenza reciproca. Sono rompicapo di questo genere quelli che disorientano Proudhon, poiché egli guarda solo al prezzo della merce singola, autonoma, e non considera la merce come prodotto del capitale totale e quindi il rapporto in cui il prodotto totale con i suoi prezzi rispettivi concettualmente si divide.
Ricardo, e con lui tutta la sua scuola, non ha mai compreso le crisi moderne e reali, nel corso delle quali la contraddizione del capitale scoppia in colossali tempeste che minacciano sempre più la sua stessa funzione di base della società e della produzione. Si comprende anche il motivo per cui quegli stessi economisti i quali non ammettono che il valore delle merci venga determinato dal tempo di lavoro, dalla quantità di lavoro contenuto in esso, parlano sempre dei prezzi di produzione come dei punti intorno ai quali oscillano i prezzi di mercato. Essi lo possono fare giacché il prezzo di produzione è già una forma affatto esteriore – e prima facie vuota di contenuto – del valore, la forma che si presenta nella concorrenza, nella coscienza del capitalista volgare e quindi può presentarsi anche in quella dell’economista volgare. Quanto esposto sta a dimostrare con una precisione che potremmo definire matematica i motivi per cui i capitalisti, i quali si comportano come dei falsi fratelli allorché si fanno concorrenza, rappresentano ugualmente una vera e propria massoneria nei confronti della classe operaia nella sua totalità.
[LF. IV,16-39; C. III,10; VI. III; TP. XIV,807]
I.1.8. La circolazione monetaria (reddito e capitale)
Al denaro la funzione di mezzo di circolazione spetta soltanto perché esso è il valore delle merci, divenuto indipendente. Il suo movimento come mezzo di circolazione è quindi, di fatto, soltanto il movimento di forma proprio delle merci, il quale dunque si deve rispecchiare anche in maniera sensibile nel corso del denaro. Ogni merce, al suo primo passo nella circolazione, al suo primo cambiamento di forma, cade fuori della circolazione, nella quale poi entra sempre merce nuova. Invece il denaro, come mezzo di circolazione, abita continuamente nella sfera della circolazione, e si aggira continuamente in essa. Sorge
83

quindi il problema di quanto denaro assorba continuamente questa sfera. Col salire e col cadere della somma dei prezzi delle merci, deve proporzionalmente salire o cadere la massa del denaro circolante. Data la somma di valore delle merci e data la velocità media delle loro metamorfosi, la quantità del denaro ossia del materiale monetario in corso, dipende dal suo proprio valore L’illusione che i prezzi delle merci, viceversa, siano determinati dalla massa dei mezzi di circolazione, e questa massa sia determinata a sua volta dalla massa del materiale monetario che si trova in un dato paese, ha la sua radice, nei suoi primi sostenitori, nell’ipotesi assurda che entrino merci senza prezzo e denaro senza valore nel processo della circolazione.
Dalla funzione del denaro come mezzo di circolazione sorge la sua figura di moneta. La parte di peso d ’o-ro rappresentata nel prezzo ossia nel nome in denaro delle merci, deve presentarsi di contro ad esse, nella circolazione, come pezzo d’oro di identico nome, ossia moneta. Come già la definizione della scala di misura dei prezzi, la monetazione è affare che spetta allo stato. Nelle differenti uniformi nazionali che oro e argento portano quando sono moneta, ma che poi tornano a svestire sul mercato mondiale, si fa luce la distinzione fra le sfere interne o nazionali della circolazione delle merci e la loro sfera generale, il mercato mondiale. Cose che sono, relativamente, senza valore, cedole di carta, possono funzionare in vece sua come moneta. Nelle marche metalliche di denaro il carattere puramente simbolico è ancora in certo modo latente. Nella carta moneta esso salta agli occhi. È proprio vero: “Ce n’est que le premier pas qui coûte”.
Qui si tratta solo della carta moneta statale a corso forzoso. Essa nasce direttamente dalla circolazione metallica. Quindi essa può essere sostituita con simboli cartacei. Ma se oggi tutti i canali della circolazione vengono riempiti di carta moneta al pieno limite della loro capacità d’assorbimento di denaro, domani essi potranno essere sovrappieni, in conseguenza delle oscillazioni della circolazione delle merci. Ogni misura è perduta. Ma se la carta sorpassa la sua, misura, cioè la quantità di moneta d’oro della medesima denominazione che potrebbe circolare, essa rappresenta entro il mondo delle merci, e astrazion fatta dal pericolo d’un discredito generale, ormai soltanto la quantità di oro determinata dalle sue leggi immanenti, e quindi anche l’unica che possa rappresentare. L’effetto è lo stesso che se si fosse alterato l’oro, nella sua funzione di misura dai prezzi. La carta moneta è segno d’oro, cioè segno di denaro. Il suo rapporto coi valori delle merci sta solo nel fatto che questi vengono espressi idealmente con le medesime quantità d’oro che sono rappresentate simbolicamente e visibilmente dalla carta. Lo carta moneta è segno dì valore solo in quanto rappresenta quantità d’oro che sono anche quantità di valori, come tutte le altre quantità di merci. Si domanda perché l’oro possa essere sostituito con semplici segni di se stesso, senza alcun valore proprio. Ma esso è sostituibile a questo modo solo in quanto viene isolato o reso indipendente nella sua funzione di moneta o mezzo di circolazione.
Nella sua figura di valore, la merce si spoglia di ogni traccia del suo valore d’uso naturale ed originario, e del lavoro utile particolare al quale deve la sua nascita, per abbozzolarsi nella materializzazione sociale uniforme del lavoro umano indifferenziato. Quindi nel denaro non si vede di che stampo è la merce in esso trasformata. Una merce, nella sua forma di moneta, ha l’identico aspetto dell’altra. Quindi il denaro può essere sterco, benché lo sterco non sia denaro. La rappresentazione indipendente del valore di scambio della merce è qui solo un momento fuggevole. Quindi, in un processo che fa passare costantemente il denaro da una mano all’altra, è sufficiente anche la sua esistenza puramente simbolica. Però con lo sviluppo della circolazione delle merci, si sviluppano situazioni per le quali la cessione della merce viene separata nel tempo dalla realizzazione del suo prezzo. Un possessore di merci vende merce esistente, l’altro compra come puro e semplice rappresentante di denaro o come rappresentante di denaro futuro. Il venditore diventa creditore, il compratore diventa debitore. Poiché qui muta la metamorfosi della merce ossia lo sviluppo della sua forma dì valore, anche al denaro è assegnata un’altra funzione. Esso diventa mezzo di pagamento.
La moneta di credito proviene immediatamente dalla funzione del denaro come mezzo di pagamento, in quanto anche certificati di debito per le merci vendute riprendono a circolare, per la trasmissione dei crediti. D’altra parte, con l’estendersi del credito si estende la funzione del denaro come mezzo di pagamento. Come tale, esso riceve forme proprie di esistenza, con le quali inabita nella sfera delle grandi transazioni commerciali; mentre la moneta (d’oro o d’argento) viene respinta soprattutto nella sfera del piccolo commercio. A un certo grado di intensità e di ampiezza della produzione delle merci la funzione del denaro come mezzo di pagamento oltrepassa la sfera della circolazione delle merci. La funzione del denaro come mezzo di pagaménto implica una contraddizione immediata. Finché i pagamenti si compensano, il denaro funziona solo idealmente, come denaro di conto. Questa contraddizione erompe in quel momento delle crisi di produzione e delle crisi commerciali che si chiama crisi monetaria. Essa avviene soltanto dove sono sviluppati pienamente il processo a catena continua dei pagamenti e un sistema artificiale per la loro compensazione. Quando si verificano turbamenti generali di questo meccanismo, e quale che sia l’origine di essi, il denaro si cambia improvvisamente e senza transizioni, e, da figura solo ideale della moneta di conto, eccolo denaro contante. Non è più sostituibile con merci profane. Nel commercio mondiale le merci dispiegano universalmente il loro valore. Dunque, la loro forma autonoma di valore si presenta quivi di fronte ad esse, ovviamente, come moneta mondiale. Solo sul mercato mondiale il denaro funziona in pieno
84

come quella merce la cui forma naturale è allo stesso tempo forma immediatamente sociale di realizzazione del lavoro umano in abstracto. Il suo modo di esistenza diventa adeguato al suo concetto.
Il processo di scambio della merce si compie dunque nei seguenti mutamenti di forme:
Merce - Denaro - MerceM → D → M
Quanto al contenuto materiale il movimento è M-M, scambio dì merce con merce, ricambio organico del lavoro sociale, nel cui risultato si estingue il processo stesso.
M-D. Prima metamorfosi della merce, ossia vendita. Il salto del valore della merce dal corpo della merce nel corpo dell’oro è il “salto mortale” della merce. L’atto di spogliarsi della forma originaria di merce si compie mediante l’alienazione della merce, cioè avviene nel momento nel quale il suo valore d’uso attira veramente l’oro che nel suo prezzo era soltanto rappresentato. La realizzazione del prezzo, ossia della forma di valore solo ideale della merce, è quindi, viceversa, e contemporaneamente, realizzazione del valore d’uso solo ideale del denaro, la trasformazione della merce in denaro è contemporaneamente trasformazione del denaro in merce. Il processo unico è processo bilaterale: dal polo del possessore di merci è vendita, dal polo opposto del possessore di denaro è compera. Ossia: vendita è compera, M-D è anche D-M.
D-M. Seconda metamorfosi, ossia metamorfosi conclusiva della merce: compera. Poiché il denaro è la figura trasmutata di tutte le altre merci, ossia il prodotto della loro alienazione generale, esso è la merce assolutamente alienabile. Esso legge tutti i prezzi a rovescio e così si rispecchia in tutti i corpi di merci che gli si offrono come materiale del suo stesso farsi merce.
Consideriamo ora la metamorfosi complessiva d’una merce: in primo luogo vediamo che essa consiste di due movimenti opposti e integrantisi a vicenda, M-D, D-M. Le due fasi inverse del movimento della metamorfosi dello merci costituiscono un ciclo: forma di merce, spogliazione della forma di merce, ritorno alla forma di merce. La merce stessa, certo, qui è determinata per opposizione. Al punto di partenza essa è per il suo possessore un non-valore d’uso, al punto di arrivo è invece valore d’uso. Il processo di circolazione non si estingue perciò, come lo scambio immediato di prodotti, col cambiamento di luogo e di mano dei valori d’uso. Il denaro non scompare per il fatto che alla fine cade fuori della serie di metamorfosi di una merce. Esso torna sempre a precipitare su un punto della circolazione sgombrato dalle merci. La sostituzione di merce con merce lascia contemporaneamente il denaro attaccato alla mano di un terzo. La circolazione essuda continuamente denaro.
Non ci può esser nulla di più sciocco del dogma che la circolazione delle merci implichi la necessità d’un equilibrio delle vendite e delle compere, poiché ogni vendita è compera, e vice versa: ma ciò dovrebbe dimostrare che il venditore porta al mercato il suo proprio compratore. Vendita e compera sono un atto identico come relazione reciproca fra due persone polarmente opposte, possessore di merce e possessore di denaro. Come azioni della stessa persona, costituiscono due atti polarmente opposti. La circolazione spezza i limiti cronologici, spaziali e individuali dello scambio di prodotti proprio perché nell’opposizione di vendita e compera scinde l’identità immediata presente nel dare in cambio il prodotto del proprio lavoro e nel prendere in cambio il prodotto del lavoro altrui. Che i processi contrapponentisi indipendentemente l’uno dall’altro costituiscano una unità interna, significa però anche che la loro unità interna si muove in opposizioni esterne; questa contraddizione immanente riceve le sue forme sviluppate di movimento nelle opposizioni della metamorfosi delle merci. Quindi queste forme includono la possibilità, ma soltanto la possibilità delle crisi. Lo sviluppo di tale possibilità a realtà esige tutto un àmbito di rapporti che dal punto di vista della circolazione semplice delle merci non esistono ancora.
La circolazione delle merci è il punto di partenza del capitale. La produzione delle merci e la circolazione sviluppata delle merci, cioè il commercio, costituiscono i presupposti storici del suo nascere. Il commercio mondiale e il mercato mondiale aprono nel secolo XVI la storia moderna della vita del capitale. Se facciamo astrazione dal contenuto materiale della circolazione delle merci, dallo scambio dei vari valori d’uso, e se consideriamo soltanto le forme economiche generate da questo processo, troviamo che suo ultimo prodotto è il denaro. Questo ultimo prodotto della circolazione delle merci è la prima forma fenomenica del capitale.
Denaro come denaro e denaro come capitale si distinguono in un primo momento soltanto attraverso la loro differente forma di circolazione. La forma immediata della circolazione delle merci è M-D-M: trasformazione di merce in denaro e ritrasformazione di denaro in merce, vendere per comprare. Ma accanto a questa forma, ne troviamo una seconda, specificamente differente, la forma D-M-D: trasformazione di denaro in merce e ritrasformazione di merce in denaro, comprare per vendere. Il denaro che nel suo movimento descrive quest’ultimo ciclo, sì trasforma in capitale, diventa capitale, ed è già capitale per sua destinazione. Consideriamo un po’ più da vicino il ciclo D-M-D. Come la circolazione semplice delle merci, esso contiene due fasi antitetiche l’una all’altra. Nella prima fase, D-M, compera, il denaro viene trasformato in merce. Nella seconda fase, M-D, vendita, la merce viene ritrasformata in denaro. Ma l’unità delle due fasi
85

è il movimento complessivo che scambia denaro contro merce, e questa stessa merce, a sua volta, contro denaro.
Il risultato nel quale sì risolve tutto il processo è: scambio di denaro contro denaro, D-D. Quel che importa è in primo luogo di caratterizzare le distinzioni di forma fra i cicli D-M-D e M-D-M: così si avrà anche la distinzione di contenuto che sta in agguato dietro quelle distinzioni di forma. Ciascuno dei due cicli è l’unità delle medesime fasi antitetiche. Ma quel che distingue a priori i due cicli M-D-M e D-M-D è l’ordine inverso delle identiche e antitetiche fasi del ciclo. La circolazione semplice delle merci comincia con la vendita e finisce con la compera; la circolazione del denaro come capitale comincia con la compera e finisce con la vendita. Là è la merce a costituire il punto di partenza e il punto conclusivo del movimento; qui è il denaro. Nella prima forma l’intermediario della circolazione complessiva è il denaro; nella seconda è, viceversa, la merce. Nella circolazione M-D-M il denaro viene trasformato, alla fine, in merce che serve come valore d’uso. Dunque il denaro è definitivamente speso. Nella forma inversa, D-M-D, invece, il compratore spende denaro per incassare denaro come venditore. Il denaro viene quindi soltanto anticipato: suo scopo determinante è quindi il valore stesso di scambio. Una somma di denaro si può distinguere da un’altra somma di denaro, in genere, soltanto mediante la sua grandezza. Dunque il processo D-M-D non deve il suo contenuto a nessuna distinzione qualitativa dei suoi estremi, poiché essi sono entrambi denaro, ma lo deve solamente alla loro differenza quantitativa. In fin dei conti, vien sottratto alla circolazione più denaro di quanto ve ne sia stato gettato al momento iniziale. La forma completa di questo processo è quindi D-M-D’, dove D’=D+ΔD, cioè è eguale alla somma di denaro originariamente anticipata più un incremento.
Chiamo plusvalore [surplus value] questo incremento, ossia questo eccedente sul valore originario. Quindi nella circolazione il valore originariamente anticipato non solo si conserva, ma altera anche la propria grandezza di valore, mette su un plusvalore, ossia si valorizza. E questo movimento lo trasforma in capitale, Qui il valore diventa soggetto di un processo nel quale esso, nell’assumere forma di denaro e forma di merce passando continuamente dall’una all’altra, altera anche la propria grandezza, e, in qualità di plusvalore, si stacca da se stesso in qualità di valore iniziale; valorizza se stesso. Perché il movimento durante il quale esso mette su plusvalore è il movimento suo proprio, il suo valorizzarsi, quindi la sua autovalorizzazione. Il valore diventa dunque valore in processo, denaro in processo, e come tale capitale. Viene dalla circolazione, ritorna in essa, si conserva e si moltiplica in essa, ne ritorna ingrandito e torna a ripetere sempre di nuovo lo stesso ciclo . D-D’, denaro figliante denaro – money which begets money – così suona la descrizione del capitale in bocca ai suoi primi interpreti, i mercantilisti. Di fatto, quindi, D-M-D’ è la formula generale del capitale, come esso si presenta immediatamente nella sfera della circolazione. Se vengono scambiate merci oppure denaro e merci, cioè, equivalenti, evidentemente nessuno estrae dalla circolazione più valore di quanto non ve ne immetta. Quindi non ha luogo nessuna formazione di plusvalore. La formazione di plusvalore e quindi la trasformazione di denaro in capitale non può dunque essere spiegata né per il fatto che i venditori vendano le merci al di sopra del loro valore, né per il fatto che i compratori le comperino al di sotto del loro valore. Quindi i sostenitori coerenti della illusione che il plusvalore scaturisca da un supplemento nominale di prezzo, ossia dal privilegio del venditore di vendere la merce troppo cara, suppongono una classe che compri soltanto senza vendere.
Il denaro col quale tale classe compra costantemente deve affluirle costantemente da parte degli stessi possessori di merci, senza scambio, gratuitamente, a qualsiasi titolo, di diritto o di forza. Dunque, ci si può vigilare come si vuole, il risultalo è sempre lo stesso. La circolazione ossia lo scambio delle merci non crea nessun valore. Nel corso della nostra indagine incontreremo come forma derivata, oltre il capitale mercantile, il capitale che porta interessi; e vedremo allo stesso tempo perché essi appaiono storicamente prima della forma fondamentale moderna del capitale. S’è visto che il plusvalore non può sorgere dalla circolazione, e che quindi nella sua formazione non può non accadere alle spalle della circolazione qualcosa che è invisibile nella circolazione stessa. La trasformazione del denaro in capitale deve essere spiegata sulla base di leggi immanenti allo scambio di merci, cosicché come punto di partenza valga lo scambio di equivalenti. Il nostro possessore di denaro, che ancora esiste soltanto come bruco di capitalista, deve comperare le merci al loro valore, le deve vendere al loro valore, eppure alla fine del processo deve trame più valore di quanto ve ne abbia immesso. Il suo evolversi in farfalla deve avvenire entro la sfera della circolazione e non deve avvenire entro la sfera della circolazione. Queste sono le condizioni del problema. Hic Rhodus, hic salta!
[C. I.1-5; III.50]
I.2. Mercato del lavoro
86

I.2.1. La divisione del lavoro
La causa principale del progresso nelle capacità produttive del lavoro, nonché della maggior parte dell’ar -te, destrezza e intelligenza con cui il lavoro viene svolto e diretto, sembra sia stata la divisione del lavoro. La divisione del lavoro, comunque, nella misura in cui può essere introdotta, determina in ogni mestiere un aumento proporzionale delle capacità produttive del lavoro. Sembra che la separazione di diversi mestieri e occupazioni sia nata proprio in conseguenza di questo vantaggio e in genere essa è più spinta nei paesi più industriosi che godono di un più alto livello di civiltà: ciò che è opera di un sol uomo in uno stadio primitivo della società diviene infatti opera di parecchi in una società progredita. Questo grande aumento della quantità di lavoro che, a séguito della divisione del lavoro, lo stesso numero di persone riesce a svolgere, è dovuto a tre diverse circostanze: primo, all’aumento di destrezza di ogni singolo lavoratore; secondo, al risparmio del tempo che di solito si perde per passare da una specie di lavoro a un’altra; e infine all’invenzione di un gran numero di macchine che facilitano e abbreviano il lavoro e permettono a un solo uomo di fare il lavoro di molti.
In primo luogo, la maggior destrezza del lavoratore non può che accrescere la quantità di lavoro che è in grado di svolgere; e la divisione del lavoro, riducendo l’attività di ogni uomo a una sola semplice operazione e facendo di quest’operazione l’unica occupazione della sua vita, non può che accrescere di molto la destrezza del lavoratore, e la destrezza di una persona che ha passato tutta la vita a compiere quelle operazioni è di solito molto maggiore. Certe operazioni vengono eseguite a una velocità tale che nessuno penserebbe che la mano dell’uomo ne sia capace, sa non l’avesse visto con i propri occhi.
In secondo luogo, il vantaggio che si ottiene risparmiando il tempo che si perde di solito nel passare da un tipo di lavoro a un altro è molto maggiore di quanto non si riesca a immaginare a prima vista. È impossibile passare molto velocemente da un tipo di lavoro a un altro, che venga svolto in un luogo diverso e con arnesi completamente diversi. Quando si sta per cominciare un nuovo lavoro, raramente si è molto appassionati e partecipi; la mente, come si dice, è altrove e per un po’ di tempo ci si gingilla invece d’impegnarsi con diligenza.
In terzo luogo, infine, ognuno può rendersi conto di quanto il lavoro sia facilitato e abbreviato dall’uso di apposite macchine. Non c’è bisogno di fare esempi. Mi limiterò a osservare che l’invenzione di tutte le macchine che tanto facilitano e abbreviano il lavoro sembra si debba in origine alla divisione del lavoro. Quando tutta l’attenzione delle menti è indirizzata verso un unico scopo, è molto più probabile che si scoprano metodi più semplici e rapidi per raggiungerlo, che non quando l’attenzione è dispersa fra una grande varietà di cose. Ora, in conseguenza della divisione del lavoro, l’intera attenzione di ogni uomo viene indirizzata verso un unico oggetto molto semplice.
È dunque naturale aspettarsi che, tra coloro che sono impiegati in un singolo ramo di attività, qualcuno possa escogitare metodi più semplici e rapidi per svolgere il suo lavoro, sempre che la natura del cómpito consenta tali miglioramenti. Gran parte delle macchine di cui si fa uso nelle manifatture in cui il lavoro è suddiviso furono in origine invenzioni di comuni lavoratori, i quali, venendo tutti impiegati ciascuno in qualche operazione molto semplice, finirono per indirizzare i loro pensieri a escogitare metodi più facili e rapidi per compierla. Non tutti i perfezionamenti delle macchine, però, sono derivati dalle invenzioni di coloro che le usavano abitualmente. Molti perfezionamenti sono stati realizzati grazie all’ingegnosità dei costruttori di macchine, quando costruirle divenne il contenuto di una professione specifica. Questa divisione del lavoro, da cui tanti vantaggi sono derivati, non è in origine il risultato di una consapevole intenzione degli uomini, che preveda la generale prosperità che ne risulta. Si tratta invece della conseguenza necessaria, per quanto assai lenta e graduale, di una particolare inclinazione della natura umana che non si preoccupa certo di un’utilità così estesa: l’inclinazione a trafficare, a barattare e a scambiare una cosa con l’altra.
La differenza tra i talenti naturali degli uomini è in effetti molto minore di quel che si pensa; e, in molti casi, le diversissime inclinazioni che sembrano distinguere in età matura uomini di diverse professioni sono piuttosto effetto che causa della divisione del lavoro. La differenza tra due personaggi tanto diversi come un filosofo e un volgare facchino di strada, per esempio, sembra derivi non tanto dalla natura quanto dall’abitu -dine, dal costume e dall’istruzione. Quando vennero al mondo, e fino a sei o otto anni, potevano anche somigliarsi molto e magari i genitori e i compagni di gioco non sarebbero stati capaci di notare nessuna differenza significativa. Ma a questa età, o poco dopo, vengono indirizzati a occupazioni molto diverse, sicché da allora comincia a essere avvertita una differenza di talenti che cresce a poco a poco fino a che la vanità del filosofo giunge a non riconoscere più quasi nessuna somiglianza. Poiché la possibilità di scambiare è la causa originaria della divisione del lavoro, la misura in cui la divisione del lavoro si realizza non può che essere limitata dalla misura di tale possibilità o, in altre parole, dall’ampiezza del mercato. Quando il mercato è molto ristretto non esistono incentivi a dedicarsi esclusivamente a una singola occupazione, non essendoci la possibilità di scambiare tutta la parte in sovrappiù del prodotto del proprio lavoro che supera il consumo, con le parti del prodotto degli altri uomini delle quali si ha bisogno.
87

[RN. I,1]
Quella cooperazione che poggia sulla divisione del lavoro si crea la propria figura classica nella manifattura, e predomina come forma caratteristica del processo di produzione capitalistico durante il vero e proprio periodo della manifattura, il quale, così all’ingrosso, va dalla metà del secolo XVI all’ultimo terzo del diciottesimo. La manifattura ha origine, cioè si elabora dal lavoro artigianale, in duplice maniera: da un lato, parte dalla combinazione, di mestieri di tipo differente, autonomi, i quali vengono ridotti a dipendenza e unilateralità fino al punto da costituire ormai operazioni parziali reciprocamente integrantisi del processo di produzione d’una sola e medesima merce; dall’altro lato, la manifattura parte dalla cooperazione di artigiani dello stesso tipo, disgrega lo stesso mestiere individuale nelle sue differenti operazioni particolari, e le isola e le rende indipendenti fino al punto che ciascuna di esse diviene funzione esclusiva d’un lavoratore particolare. Quindi la manifattura, da una parte introduce o sviluppa ulteriormente la divisione del lavoro in un processo di produzione; dall’altra parte, combina mestieri prima separati. Ma qualunque ne sia il punto particolare di partenza, la sua figura conclusiva è sempre la stessa: un meccanismo di produzione i cui organi sono uomini.
Per intendere esattamente la divisione del lavoro nella manifattura è d’importanza essenziale tener fermo ai punti seguenti: in primo luogo, qui l’analisi del processo di produzione nelle sue fasi particolari coincide completamente con la disgregazione d’una attività artigianale nelle sue differenti operazioni parziali. Composta o semplice l’operazione rimane artigianale, e quindi dipendente dalla forza, dalla abilità, dalla sveltezza e dalla sicurezza del lavoratore singolo nel maneggio del suo strumento. Il mestiere rimane la base. Questa base tecnica ristretta esclude una analisi realmente scientifica del processo di produzione, poiché ogni processo parziale percorso dal prodotto dev’essere eseguibile come lavoro artigianale parziale. E proprio perché a questo modo l’abilità artigianale rimane fondamento del processo di produzione, ogni lavoratore viene appropriato esclusivamente a una funzione parziale, e la sua forza-lavoro viene trasformata nell’organo di tale funzione parziale, vita natural durante. Infine questa divisione del lavoro è una specie particolare della cooperazione e molti dei suoi vantaggi scaturiscono dalla natura generale della cooperazione, e non da questa sua forma particolare.
I diversi processi graduali sono trasformati da una successione temporale in una giustapposizione spaziale. Di qui la fornitura di maggior quantità di merce finita nello stesso spazio di tempo. Quella simultaneità deriva, certo, dalla forma cooperativa generale del processo complessivo, però la manifattura non solo trova presenti le condizioni della cooperazione, ma le crea in parte per la prima volta, scomponendo l’attività di tipo artigianale. D’altra parte essa raggiunge questa organizzazione sociale del processo lavorativo solo saldando uno stesso lavoratore a uno stesso particolare. Poiché il prodotto parziale di ogni lavoratore parziale è insieme nulla più d’un grado particolare di sviluppo dello stesso manufatto, quel che un lavoratore consegna all’altro, oppure un gruppo di lavoratori consegna all’altro gruppo, è la materia prima di quest’ultimo lavoratore o gruppo. Il risultato del lavoro dell’uno costituisce il punto di partenza del lavoro dell’altro. Quindi un lavoratore occupa qui l’altro direttamente. Il tempo di lavoro necessario per raggiungere l’effetto utile prefìsso in ogni processo parziale viene fissato in base all’esperienza, e il meccanismo complessivo della manifattura poggia sul presupposto che in un tempo di lavoro dato si raggiunga un risultato dato. Solo con questo presupposto i differenti processi di lavoro reciprocamente integrantisi possono continuare ininterrottamente, uno accanto all’altro nel tempo e nello spazio. È evidente che questa diretta dipendenza reciproca dei lavori e quindi dei lavoratori, costringe ogni singolo individuo ad adoperare per la sua funzione solo il tempo necessario, e che così si genera una continuità, uniformità, regolarità, un ordine e in ispecie anche una intensità di lavoro molto differenti da quelle del mestiere indipendente o anche della cooperazione semplice.
Nella produzione delle merci, il fatto che si adoperi per una merce soltanto il tempo di lavoro socialmente necessario per la sua produzione, si presenta in genere come costrizione esterna della concorrenza, perché, per esprimerci superficialmente, ogni singolo produttore deve vendere la merce al suo prezzo di mercato. Invece nella manifattura la fornitura di una data quantità di prodotti entro un tempo di lavoro dato diventa legge tecnica dello stesso processo di produzione. Tuttavia, differenti operazioni abbisognano di periodi di tempo diseguali e quindi forniscono quantità disegnali di prodotti parziali in periodi di tempo eguali. Se dunque lo stesso lavoratore deve eseguire giorno per giorno sempre e soltanto quella stessa operazione, per differenti operazioni dovrà essere adoprato un differente numero proporzionale di lavoratori. Qui ritorna il principio della cooperazione nella sua forma più semplice: impiego contemporaneo di molte persone che fanno qualcosa di omogeneo; ma ora lo fanno come espressione d’un rapporto organico. Dunque la divisione manifatturiera del lavoro non semplifica e non moltiplica soltanto gli organi qualitativamente differenti del lavoratore sociale complessivo, ma crea anche una proporzione matematica fissa per l’estensione quantitativa di quegli organi, cioè per il numero relativo dei lavoratori, ossia per la grandezza relativa dei gruppi di lavoratori in ogni funzione particolare.
88

Con la articolazione qualitativa, essa sviluppa anche la regola e proporzionalità quantitativa del processo di lavoro sociale. Il singolo gruppo, dato da un certo numero di lavoratori i quali compiono la stessa funzione parziale, consiste di elementi omogenei e costituisce un organo particolare del meccanismo complessivo. Il rapporto fra la divisione manifatturiera del lavoro e la divisione sociale del lavoro, costituisce la base generale di ogni produzione di merci. Se si tien presente soltanto il lavoro per sé preso, si può designare la separazione della produzione sociale nei suoi grandi generi, come agricoltura, industria, ecc, come divisione del lavoro in generale; la ripartizione di questi generi di produzione in specie e sottospecie, come divisione del lavoro in particolare; e infine la divisione del lavoro entro una officina come divisione del lavoro in dettaglio. La divisione del lavoro nella società e la corrispondente limitazione degli individui a sfere professionali particolari si sviluppa da punti di partenza opposti, allo stesso modo della divisione del lavoro nella manifattura. A fondamento di ogni divisione del lavoro sviluppata e mediata attraverso scambio di merci, è la separazione di città e campagna. Si può dire che l’intera storia economica della società si riassuma nel movimento di questo antagonismo. Che cos’è che caratterizza la divisione del lavoro di tipo manifatturiero? Che il lavoratore parziale non produce nessuna merce. È solo il prodotto comune dei lavoratori parziali che si trasforma in merce. La divisione del lavoro all’interno della società è mediata dalla compra e vendita dei prodotti di differenti branche di lavoro; la connessione fra i lavori parziali nella manifattura è mediata dalla vendita di differenti forze-lavoro allo stesso capitalista, il quale le impiega come forza-lavoro combinata.
La divisione del lavoro di tipo manifatturiero presuppone la concentrazione dei mezzi di produzione in mano ad un solo capitalista, la divisione sociale del lavoro presuppone la dispersione dei mezzi di produzione fra molti produttori di merci indipendenti l’uno dall’altro. La regola seguita a priori e secondo un piano nella divisione del lavoro nell’interno dell’officina, opera soltanto a posteriori nella divisione del lavoro all’interno della società, come necessità naturale ulteriore, muta, percepibile negli sbalzi barometrici dei prezzi del mercato, che sopraffa l’arbitrio sregolato dei produttori delle merci. La divisione del lavoro di tipo manifatturiero presuppone l’autorità incondizionata del capitalista su uomini che costituiscono solo le membra di un meccanismo complessivo di sua proprietà; la divisione sociale del lavoro contrappone gli uni agli altri produttori indipendenti di merci, i quali non riconoscono altra autorità che quella della concorrenza, cioè la costrizione esercitata su di essi dalla pressione dei loro interessi reciproci; come anche nel regno animale il bellum omnium contra omnes preserva più o meno le condizioni di esistenza di tutte le specie. Quindi quella stessa coscienza borghese che celebra la divisione del lavoro a tipo manifatturiero, l’annessione a vita del lavoratore a una operazione di dettaglio e la subordinazione incondizionata del lavoratore parziale al capitale, esaltandole come una organizzazione del lavoro che ne aumenta la forza produttiva, denuncia con altrettanto clamore ogni consapevole controllo e regolamento sociale del processo sociale di produzione, chiamandolo intromissione negli inviolabili diritti della proprietà, nella libertà e nell’autodeterminantesi “genialità” del capitalista individuale. È assai caratteristico che gli entusiasti apologeti del sistema delle fabbriche, polemizzando contro ogni organizzazione generale del lavoro sociale, non sappian dire niente di peggio, fuorché: tale organizzazione trasformerebbe in una fabbrica tutta la società.
L’anarchia della divisione sociale del lavoro e il dispotismo della divisione del lavoro a tipo manifatturiero sono portato l’una dell’altro nella società del modo capitalistico di produzione; invece forme di società precedenti ad essa, nelle quali la separazione dei mestieri prima si è sviluppata spontaneamente, poi s’è cristallizzata e infine è stata consolidata legislativamente, offrono da una parte il quadro d’una organizzazione del lavoro sociale secondo un piano, e autoritaria, ma d’altra parte escludono completamente la divisione del lavoro entro l’officina, oppure la sviluppano solo su scala infima o solo sporadicamente o casualmente. Un certo rattrappimento intellettuale e fisico è inseparabile perfino dalla divisione del lavoro nell’insieme della società in generale. Ma il periodo della manifattura, portando molto più avanti questa separazione sociale delle branche di lavoro, e d’altra parte intaccando la radice stessa della vita dell’individuo già in virtù della sua peculiare divisione del lavoro, fornisce anche per primo il materiale e l’impulso alla patologia industriale: “suddividere un uomo, è eseguire la sua condanna a morte, se merita la condanna; è assassinarlo se non la merita. La suddivisione del lavoro è l’assassinio d’un popolo” [Urquhart].
Mediante l’analisi della attività artigiana, la “specializzazione degli strumenti di lavoro, la formazione dei lavoratori parziali, il loro raggruppamento e la loro combinazione in un meccanismo complessivo, la divisione manifatturiera del lavoro crea l’articolazione qualitativa e la proporzionalità quantitativa dei processi sociali di produzione, crea quindi una determinata organizzazione del lavoro sociale, sviluppando così una nuova forza produttiva sociale del lavoro. Come forma specificamente capitalistica del processo di produzione sociale, la divisione manifatturiera del lavoro è soltanto un metodo particolare per generare plusvalore relativo, ossia per aumentare a spese dei lavoratori l’autovalorizzazione del capitale. Produce nuove condizioni di dominio del capitale sul lavoro. Se dunque da una parte essa si presenta come progresso storico e momento necessario di sviluppo nel processo della formazione economica della società, dall’altra
89

parte si presenta come un mezzo di sfruttamento incivilito e raffinato. L’economia politica, che solo nel periodo manifatturiero prende piede come scienza speciale, considera la, divisione sociale del lavoro, in genere, solo dal punto di vista della divisione del lavoro di tipo manifatturiero, come mezzo per produrre più merce con la stessa quantità di lavoro, e quindi per ridurre le merci più a buon mercato e per accelerare l’accumulazione del capitale.
[C. I,12]
I.2.2. La cooperazione e l’organizzazione del lavoro
La produzione capitalistica comincia realmente, come abbiamo veduto, solo quando il medesimo capitale individuale impiega allo stesso tempo un numero piuttosto considerevole di lavoratori, e quindi il processo lavorativo s’estende e si ingrandisce e fornisce prodotti su scala quantitativa piuttosto considerevole. L’ope-rare di un numero piuttosto considerevole di lavoratori, allo stesso tempo, nello stesso luogo (o, se si vuole, nello stesso campo di lavoro), per la produzione dello stesso genere di merci, sotto il comando dello stesso capitalista, costituisce storicamente e concettualmente il punto di partenza dalla produzione capitalistica. Per esempio, in riferimento al modo della produzione in sé, la manifattura non si distingue ai suoi inizi dalla industria artigiana delle corporazioni quasi per altro che per il maggior numero dei lavoratori occupati contemporaneamente dallo stesso capitale. La giornata lavorativa di ogni singolo esiste come parte aliquota della giornata lavorativa complessiva. Dunque la legge della valorizzazione, in genere, si realizza completamente per il singolo produttore soltanto quando egli produce come capitalista, impiega molti lavoratori allo stesso tempo, e quindi mette in moto fin da principio lavoro sociale medio.
Anche se il modo di lavoro rimane identico, l’impiego contemporaneo d’un numero piuttosto considerevole di lavoratori effettua una rivoluzione nelle condizioni oggettive del processo lavorativo. Edifici nei quali lavori molta gente, depositi di materie prime, ecc, recipienti, strumenti, apparecchi, ecc. che servano a molti nello stesso tempo o a turno, in breve, una parte dei mezzi di produzione viene ora consumato in comune nel processo lavorativo. Questa economia nell’impiego dei mezzi di produzione deriva soltanto dal loro consumo comune nel processo di lavoro di molte persone. Ed essi vengono ad avere questo carattere in quanto sono condizioni di lavoro sociale ossia sono condizioni sociali del lavoro, a differenza dei mezzi di produzione dispersi e relativamente costosi di singoli lavoratori o piccoli maestri artigiani indipendenti, anche quando i molti lavorano insieme soltanto per essere nello stesso luogo, e non lavorano l’un con l’altro. Una parte dei mezzi di lavoro acquista questo carattere sociale prima che lo acquisti lo stesso processo lavorativo.
La forma del lavoro di molte persone, che lavorano l’una accanto all’altra e l’una assieme all’altra secondo un piano, in uno stesso processo di produzione, o in processi di produzione differenti ma connessi, si chiama cooperazione la somma meccanica delle forze dei lavoratori singoli è sostanzialmente differente dal potenziale sociale di forza che si sviluppa quando molte braccia cooperano contemporaneamente a una stessa operazione indivisa; p. es. quando c’è da sollevare un peso, da girare un argano, o da rimuovere un ostacolo. Qui il lavoro singolo non potrebbe produrre affatto l’effetto del lavoro combinato oppure potrebbe produrlo soltanto in periodi molto più lunghi oppure soltanto su infima scala. Qui non si tratta soltanto di aumento della forza produttiva individuale mediante la cooperazione, ma dì creazione d’una forza produttiva che dev’essere in sé e per sé forza di massa. Astrazion fatta dal nuovo potenziale di forza che deriva dalla fusione di molte forze in una sola forza complessiva, il semplice contatto sociale genera nella maggior parte dei lavori produttivi una emulazione e una peculiare eccitazione degli spiriti vitali – animal spirits – le quali aumentano la capacità di rendimento individuale dei singoli. Benché molte persone compiano insieme e contemporaneamente la stessa operazione, oppure operazioni dello stesso genere, il lavoro individuale di ciascuno può tuttavia rappresentare, come parte del lavoro complessivo, differenti fasi del processo di lavoro di per sé preso, fasi che l’oggetto del lavoro percorre più rapidamente in conseguenza della cooperazione. Ad es., quando dei muratori fanno catena per passare le pietre da costruzione di mano in mano dai piedi fino alla cima d’una impalcatura, ciascuno di essi fa la stessa cosa, ma tuttavia le singole operazioni costituiscono parti continue d’una operazione complessiva, fasi particolari che nel processo lavorativo debbono esser percorse da ogni pietra da costruzione, e attraverso le quali p. es. le ventiquattro mani del lavoratore complessivo la mandano avanti più alla svelta delle due mani di ogni singolo lavoratore che salga e scenda per l’impalcatura. L’oggetto del lavoro percorre lo stesso spazio in un tempo più breve.
La giornata lavorativa combinata, che nello spazio attacca l’oggetto del lavoro da molte parti, poiché il lavoratore combinato o lavoratore complessivo ha occhi e mani davanti e di dietro, e possiede fino a un certo punto la dote dell’ubiquità, fa procedere il prodotto complessivo più alla svelta che non dodici giornate lavorative di dodici ore di lavoratori più o meno isolati, che debbono iniziare il loro lavoro in maniera più unilaterale. Parti differenti del prodotto, separate nello spazio, progrediscono nello stesso tempo. La giornata
90

di lavoro combinata produce quantità di valore d’uso maggiori della somma di egual numero di giornate lavorative individuali singole, e quindi diminuisce il tempo di lavoro necessario per produrre un determinalo effetto utile. Che la giornata lavorativa combinala riceva tale forza produttiva accresciuta, nel caso dato, perché essa eleva la potenza meccanica della forza-lavoro, o perché dilata nello spazio la sfera d’azione del lavoro, o perché contrae nello spazio, in rapporto alla scala di produzione, il campo di produzione, o perché nel momento critico rende liquido molto lavoro in poco tempo, o perché eccita l’emulazione dei singoli intensificandone gli “spiriti vitali”, o perché imprime alle operazioni dello stesso genere compiute da molte persone il carattere della continuità e della multilateralità, o perché compie contemporaneamente operazioni differenti, o perché economizza i mezzi di produzione mediante l’uso in comune di essi, o perché conferisce al lavoro individuale il carattere di lavoro sociale medio – in ogni caso, la forza produttiva specifica della giornata lavorativa combinata è forza produttiva sociale del lavoro, ossia forza produttiva del lavoro sociale. E deriva dalla cooperatone stessa.
Nella cooperazione pianificata con altri il lavoratore si spoglia dei suoi limiti individuali e sviluppa le facoltà della sua specie. Dunque, il numero dei lavoratori impegnati nella cooperazione, ossia la scala della cooperazione, dipende in primo luogo dalla grandezza del capitale che il capitalista singolo è in grado di esborsare per l’acquisto di forze-lavoro; cioè, dipende dalla misura nella quale ogni singolo capitalista dispone di volta in volta dei mezzi dì sussistenza di molti lavoratori. Dunque, la concentrazione di masse piuttosto grandi di mezzi di produzione in mano di singoli capitalisti è condizione materiale della cooperazione dei lavoratori salariati, e la misura della cooperazione, ossia la scala della produzione, dipende dalla misura di tale concentrazione. Con la cooperazione di molti lavoratori salariati il comando del capitale si evolve a esigenza della esecuzione del processo lavorativo stesso, cioè a condizione reale della produzione. La funzione di direzione, sorveglianza, coordinamento, diventa funzione del capitale appena il lavoro ad esso subordinato diventa cooperativo. La funzione direttiva riceve note caratteristiche speciali in quanto funzione specifica del capitale. Motivo propulsore e scopo determinante del processo capitalistico di produzione è in primo luogo la maggior possibile autovalorizzazione del capitale, cioè la produzione di plusvalore più grande possibile, e quindi il maggiore sfruttamento possibile della forza-lavoro da parte del capitalista.
Con la massa dei lavoratori simultaneamente impiegati cresce la loro resistenza, e quindi necessariamente la pressione del capitale per superare tale resistenza. La direzione del capitalista non è soltanto una funzione particolare derivante dalla natura del processo lavorativo sociale e a tale processo pertinente; ma è insieme funzione di sfruttamento di un processo lavorativo sociale, ed è quindi un portato dell’inevitabile antagonismo fra lo sfruttatore e la materia prima vivente da lui sfruttata. Così pure, col crescere del volume dei mezzi di produzione che il lavoratore salariato si trova davanti come proprietà altrui, cresce la necessità del controllo affinché essi vengano adoprati convenientemente. Inoltre, la cooperazione dei lavoratori salariati è un semplice effetto del capitale che li impiega simultaneamente; la connessione delle loro funzioni o la loro unità come corpo produttivo complessivo stanno al di fuori dei lavoratori salariati, nel capitale che li riunisce e li tiene insieme. Quindi ai lavoratori salariati la connessione fra i loro lavori si contrappone, idealmente come piano, praticamente come autorità del capitalista, come potenza d’una volontà estranea che assoggetta al proprio fine le loro azioni.
Dunque la direzione capitalistica è, quanto al contenuto, di duplice natura a causa della duplice natura del processo produttivo stesso che dev’essere diretto, il quale da una parte è processo lavorativo sociale per la fabbricazione di un prodotto, dall’altra parte processo di valorizzazione del capitale; ma quanto alla forma è dispotica. Questo dispotismo sviluppa poi le sue forme peculiari mano a mano che la cooperazione si sviluppa su scala maggiore. Prima, il capitalista viene esentato dal lavoro manuale appena il suo capitale ha raggiunto quella grandezza minima che sola permette l’inizio della produzione capitalistica; ora torna a cedere a sua volta a un genere particolare di lavoratori salariati la funzione della sorveglianza diretta e continua dei singoli lavoratori e dei singoli gruppi di lavoratori. Una massa di lavoratori operanti insiemi; sotto il comando dello stesso capitale ha bisogno di dirigenti (managers) e di sorveglianti (foremen, overlookers, contromaitres) industriali, i quali durante il processo di lavoro comandano in nome del capitale.
Il capitalista paga quindi il valore delle cento forze-lavoro autonome, ma non paga la forza-lavoro combinata dei cento lavoratori. Come persone indipendenti i lavoratori sono dei singoli i quali entrano in rapporto con lo stesso capitale ma non in rapporto reciproco fra loro. La forza produttiva sviluppata dal lavoratore come lavoratore sociale è forza produttiva del capitale. La forza produttiva sociale del lavoro si sviluppa gratuitamente appena i lavoratori vengono posti in certe condizioni; e il capitale li pone in quelle condizioni. Siccome la forza produttiva sociale del lavoro non costa nulla al capitale, perché d’altra parte non viene sviluppata dal lavoratore prima che il suo stesso lavoro appartenga al capitale, essa si presenta come forza produttiva posseduta dal capitale per natura, come sua forza produttiva immanente. Di fronte al contadino o all’artigiano indipendenti, non è la cooperazione capitalistica che si presenta come una forma
91

storica particolare della cooperazione, ma è proprio la cooperazione di per sé che si presenta come una forma storica peculiare del processo di produzione capitalistico, che lo distingue specificamente.
Come la forza produttiva sociale del lavoro sviluppata mediante la cooperazione si presenta quale forza produttiva del capitale, così la cooperazione stessa si presenta quale forma specifica del processo produttivo capitalistico, in opposizione al processo produttivo dei singoli lavoratori indipendenti o anche dei piccoli mastri artigiani. È il primo cambiamento al quale soggiace il reale processo di lavoro per il fatto della sua sussunzione sotto il capitale. Questo cambiamento avviene in maniera naturale e spontanea. Il suo presupposto che è l’impiego simultaneo di un numero considerevole di salariati nello stesso processo lavorativo, costituisce il punto dì partenza della produzione capitalistica. E questo coincide anche con l’esistenza dello stesso capitale. Se quindi il modo capitalistico di produzione da una parte si presenta come necessità storica affinché il processo lavorativo si trasformi in un processo sociale, d’altra parte questa forma sociale del processo lavorativo si presenta come metodo applicato dal capitale per sfruttare il processo stesso più profittevolmente mediante l’accrescimento della sua forza produttiva. Nella sua forma semplice che abbiamo finora considerato, la cooperazione coincide con la produzione su scala di una certa grandezza, ma non costituisce affatto una forma fissa, caratteristica di un’epoca particolare dello sviluppo del modo capitalistico di produzione. La cooperazione semplice è ancora sempre la forma predominante di quei rami di produzione nei quali il capitale opera su larga scala, senza che la divisione del lavoro o le macchine vi abbiano una parte importante. La cooperazione rimane la forma fondamentale del modo di produzione capitalistico, benché la sua figura semplice, per sé presa, si presenti come forma particolare accanto alle sue altre forme più evolute.
[C. I,11]
Non è possibile prendere in esame sistemi o schemi di organizzazione che a lungo andare non siano soddisfacenti tanto per i datori di lavoro quanto per i lavoratori, che non dimostrino che i loro reali interessi sono coincidenti, e che non realizzino una cooperazione completa e cordiale che potrà essere sfruttata di comune accordo anziché separatamente. Al contrario è convinzione assoluta di entrambe le parti che, in molte delle questioni più vitali, gli interessi reali dei datori di lavoro siano necessariamente opposti a quelli dei lavoratori. Alti salari e basso costo di manodopera sono la base della migliore organizzazione. La possibilità di abbinare alti salari con basso costo di manodopera si basa principalmente sull’enorme differenza tra la quantità di lavoro che, in circostanze favorevoli, può compiere un lavoratore di prim’ordine e il lavoro normalmente compiuto dal lavoratore medio. Tutti i datori di lavoro sanno che c’è differenza tra il lavoratore medio e il lavoratore di prim’ordine; ma che il lavoratore di prim’ordine possa fare nella maggior parte dei casi da due a quattro volte più di quanto vien fatto da un lavoratore medio, è noto solo a pochi. Il secondo fatto egualmente interessante su cui si basa la possibilità dì abbinare salari alti con basso costo di manodopera, è questo: i lavoratori di prim’ordine sono non solo desiderosi, ma lieti di lavorare alla loro massima velocità, purché siano pagati dal 30 al 100 % più della media della loro categoria. È opinione di chi scrive, d’altra parte, che, per il loro stesso bene, è importante che i lavoratori non siano pagati troppo, né troppo poco. Se i salari sono troppo alti, molti lavorano irregolarmente e tendono a diventare più o meno fiacchi, irrequieti e dissidenti. Così, assicurando al lavoratore un salario alto e all’imprenditore un basso costo del lavoro, apparirà evidente a entrambi che i loro interessi sono comuni.
Per riassumere, quindi, in ogni stabilimento si dovrebbe fare in modo:a) che ogni lavoratore sia assegnato, per quanto possibile, alla più alta categoria di lavoro alla quale
abilità e fisico lo rendono idoneo;b) che ad ogni lavoratore si richieda di fornire la massima quantità di lavoro che un lavoratore di prim’or-
dine della sua categoria può eseguire senza danno per la sua salute;c) che ogni lavoratore, quando lavora al rendimento massimo di un lavoratore di prim’ordine, venga
pagato dal 30 al 100 % più della media della sua categoria. Ecco cosa vuol dire alti salari e basso costo di manodopera.Queste condizioni non solo giovano ai reali interessi dei padroni, ma tendono ad elevare i lavoratori al più
alto livello raggiungibile, sfruttando le loro migliori facoltà, stimolando la loro ambizione, retribuendoli con una paga sufficiente a migliorare il loro tenore di vita. Non c’è dubbio che la tendenza dell’uomo medio (in tutti i campi della vita) lo porta a lavorare con un ritmo lento ed agevole e che solo dopo aver osservato e ragionato per un bel po’, oppure in séguito ad esempi, a richiami di coscienza o a pressioni esterne, assume un’andatura più spedita. Codesta naturale tendenza a prendersela comoda risulta grandemente accentuata allorché si raggruppi un certo numero di persone a fare lo stesso lavoro con una paga giornaliera fissa, uguale per tutti. La naturale infingardaggine degli uomini è un serio inconveniente; ma la piaga di gran lunga peggiore di cui soffrono tanto la manodopera quanto i datori di lavoro, è l’abitudine sistematica di fingere di lavorare. Questo si può fare solo quando i dipendenti sono fermamente convinti che non si abbia intenzione
92

di adottare, anche nel lontano futuro, il salario a cottimo; ed è quasi impossibile far sì che lo credano quando il lavoro ha caratteristiche tali da ritenere attuabile tale sistema.
L’imprenditore viene considerato un avversario, se non un nemico; e viene completamente a mancare quella reciproca fiducia che deve sussistere fra il dirigente ed i suoi sottoposti, l’entusiasmo, la sensazione che si lavora tutti per lo stesso fine e che a ciascuno spetterà una parte del profitto. Lo scopo principale del-l’organizzazione industriale deve essere quello di assicurare un massimo di benessere all’imprenditore e anche un massimo di benessere ad ogni prestatore d’opera. Il principio basilare dell’organizzazione scientifica, al contrario, sostiene che il vero interesse dei due gruppi è il medesimo per entrambi; che il benessere dell’imprenditore non può durare a lungo se non è accompagnato dal benessere per il lavoratore, e viceversa; e che è possibile dare a chi lavora ciò di cui ha bisogno – alto salario – e all’imprenditore ciò che egli richiede per i suoi prodotti – basso costo di fabbricazione. Per un individuo oppresso dal lavoro, ne esistono cento che intenzionalmente dànno un rendimento inferiore, molto inferiore alle loro possibilità, per tutta la loro vita, e perciò deliberatamente favoriscono lo stabilirsi di quelle condizioni che alla fine provocano in maniera inevitabile salari bassi.
L’enorme risparmio di tempo e quindi l’aumento di produzione che si potrebbero realizzare in ognuna delle nostre industrie sostituendo movimenti rapidi a quelli lenti e non razionali della manodopera ed eliminando quelli non necessari, non può essere compiutamente apprezzato se non da chi ha visto con i propri occhi il miglioramento ottenuto mediante una completa analisi dei movimenti e dei tempi di lavorazione, eseguita da persona competente. È solo dopo aver raggiunto nel programma riorganizzativo questo stadio (la manodopera è stata adeguatamente selezionata; da un lato si sono prese opportune precauzioni nei riguardi delle possibilità di sovraffaticarla, mentre dall’altro lato sono state allontanate le tentazioni di eseguire un lavoro meno accurato e si sono realizzate le più favorevoli condizioni produttive), che deve essere compiuto l’ultimo passo, per assicurare i vantaggi più desiderati sia dalla manodopera ( alti salari), sia dai datori di lavoro (una più elevata produzione nella migliore qualità, ciò che significa basso costo produttivo). Però il passaggio dall’organizzazione empirica a quella scientifica non solo implica lo studio della velocità adatto, per un dato lavoro e il perfezionamento degli attrezzi e degli utensili d’officina, ma richiede anche che tutti i lavoratori dello stabilimento mutino radicalmente la loro mentalità sia nei riguardi delle proprie occupazioni che nei riguardi dei datori di lavoro. Il perfezionamento materiale che bisogna realizzare sulle macchine per poter ottenere forti aumenti di produzione, come pure lo studio dei movimenti, seguito da un minuzioso rilievo del tempo in cui ogni individuo deve eseguire il lavoro, possono essere compiuti con relativa rapidità.
Queste nozioni scientifiche possono venir determinate attraverso analisi relativamente semplici dei movimenti necessari ai lavoratori per eseguire qualche piccola parte del loro lavoro e attraverso lo studio dei tempi relativi; tale indagine viene normalmente compiuta da una persona fornita semplicemente di un cronometro e di un taccuino con opportune suddivisioni. Centinaia di questi cronometristi sono attualmente impiegati allo scopo di stabilire semplici nozioni scientifiche dove prima esisteva il solo empirismo. Si stabilisce che il metodo scelto come il migliore divenga di impiego normale, e tale rimanga; che di esso vengano messi al corrente gli istruttori (facenti parte della direzione a struttura funzionale) e poi, ad opera di questi ultimi, tutti i lavoratori dello stabilimento, finché il procedimento suddetto non venga rimpiazzato da una successione di movimenti più rapida e razionale. Per questa semplice strada vengono sviluppati, uno dopo l’altro, gli elementi della scienza organizzativa. Con lo stesso procedimento si studiano le diverse attrezzature impiegate in un’industria. Secondo la teoria dell’organizzazione basata sullo spirito di iniziativa della manodopera e sull’incentivo, ad ogni prestatore d’opera si richiede di usare nel modo migliore il suo discernimento per eseguire il compito nel più breve tempo. Senza dubbio alcuni fra quelli che hanno un particolare interessamento per le classi lavoratrici si rammaricheranno che nel sistema scientifico il prestatore d’opera, una volta che gli si è insegnato a fare il doppio del lavoro eseguito nel periodo precedente, non riceva, un salario doppio; mentre altre persone, alle quali interessa di più ricavare forti utili, rimpiangeranno che con questo sistema vengano corrisposte alla manodopera retribuzioni più elevate che in precedenza. Sembra una madornale ingiustizia che, una volta eseguita la pura e semplice constatazione che un manovale addetto al trasporto della ghisa, ad esempio, arriva, dopo adeguato addestramento, ad accatastare un peso di materiale 3,6 volte superiore a quello che trasportava prima, non riceva altro che un aumento salariale pari al 60 %.
Non è però esatto formarsi un giudizio definitivo prima di aver considerato tutti gli elementi che intervengono nella questione. A prima vista, si nota la presenza di due sole parti nella transazione: manodopera e datore di lavoro. Trascuriamo così la terza grande parte interessata, l’intera popolazione, i consumatori, che acquistano quanto gli altri due producono e sono quelli che, in fin dei conti, pagano sia i salari della manodopera, sia gli utili degli imprenditori. Perciò i diritti di questa categoria sono superiori, tanto a quelli dei prestatori d’opera, quanto a quelli dei datori di lavoro; ad essa deve venire attribuita una quota adeguata di ogni guadagno. Infatti uno sguardo alla storia dello sviluppo industriale mostra che dopo
93

tutto è l’intera popolazione quella che riceve la parte maggiore dei benefici derivanti dal progresso tecnico. Ritornando ora al caso dei manovali addetti al trasporto dobbiamo ritenere che la maggior parte del guadagno derivante dal forte aumento nel lavoro eseguito si riverserà alla fine sulla popolazione, sotto forma di prezzi più bassi. Prima di decidere come ripartire la quota rimanente fra manodopera e datori di lavoro, prima cioè di stabilire quanto rappresenta un equo e ragionevole compenso per chi esegue il lavoro e quanto invece deve essere lasciato all’impresa sotto veste di profitto occorre esaminare la questione da ogni lato. Il manovale non rappresenta un tipo di lavoratore eccezionale, difficile a trovarsi: egli è semplicemente un individuo che ha, in misura maggiore o minore, le caratteristiche di un bue, pesante di mente e di corpo. Il fatto che costui fornisca una buona produzione giornaliera non è dovuto al suo spirito di iniziativa o alla sua intelligenza, ma alle conoscenze scientifiche sviluppate da un altro che gliele ha insegnate.
[OSL. I,1; II,1]
I.2.3. La merce forza-lavoro (lavoro salariato)
All’inizio la merce, ci si è presentata come qualcosa di duplice, valore d’uso e valore di scambio. In un secondo tempo s’è visto che anche il lavoro, in quanto espresso nel valore, non possiede più le stesse caratteristiche che gli sono proprie come generatore di valori d’uso. Questo punto è il perno sul quale muove la comprensione dell’economia politica. Chiamiamo senz’altro lavoro utile il lavoro che si presenta in tal modo nel valore d’uso del suo prodotto o nel fatto che il suo prodotto è un valore d’uso. Da questo punto di vista il lavoro viene sempre considerato in rapporto al suo effetto utile. Dunque si e visto: nel valore d’uso di ogni merce c’è una determinata attività, produttiva e conforme a un fine, cioè lavoro utile. Valori d’uso non possono stare a confronto l’uno con l’altro come merci se non ci sono in essi lavori utili qualitativamente differenti. In una società ì cui prodotti assumono in generale la forma della merce, cioè in una società di produttori di merci, tale differenza qualitativa dei lavori utili che vengono compiuti l’uno indipendentemente dall’altro come affari privati di produttori autonomi, si sviluppa in un sistema pluriarticolato, in una divisione sociale del lavoro. Quindi il lavoro, come formatore dì valori d’uso, come lavoro utile, è una condizione, d’esistenza dell’uomo, indipendente da tutte le forme della società, è una necessità eterna della natura che ha la funzione di mediare il ricambio organico tra uomo e natura, cioè la vita degli uomini. Il procedimento del-l’uomo nella sua produzione può essere soltanto quello stesso della natura: cioè semplice cambiamento delle forme dei materiali. E ancora: in questo stesso lavoro di formazione l’uomo è costantemente assistito da forze naturali.
Passiamo ora dalla merce in quanto oggetto d’uso al valore della merce. Se si fa astrazione dalla determinatezza dell’attività produttiva e quindi dal carattere utile del lavoro, rimane in questo il fatto che è un dispendio di forza-lavoro umana, dispendio di cervello, muscoli, nervi, mani, ecc. umani: ed in questo senso sono lavoro umano. Sono soltanto forme differenti di spendere forza-lavoro umana. Quindi lavoro identico rende sempre, in spazi di tempo identici, grandezza identica di valore, qualunque possa essere la variazione della forza produttiva. Ma esso fornisce nello stesso periodo di tempo quantità differenti di valori d’uso: in più quando la forza produttiva cresce, in meno quando cala. Dunque quella stessa variazione della forza produttiva che aumenta la fecondità del lavoro e quindi la massa dei valori d’uso da esso fornita, diminuisce la grandezza di valore, di questa massa complessiva aumentata, quando accorcia il totale del tempo di lavoro necessario alla produzione di quella massa stessa. E viceversa.
[C. I,1]
Nella misura stessa in cui l’economia politica si sviluppava – e questo sviluppo, per quanto concerne i principi fondamentali, trovò la sua più acuta espressione in Ricardo – essa rappresentava il lavoro come l’unico elemento del valore e l’unico creatore del valore d’uso, e lo sviluppo delle forze produttive come l’u-nico mezzo per l’accrescimento reale della ricchezza; il massimo sviluppo delle forze produttive del lavoro come la base economica della società. Questa in realtà è la base della produzione capitalistica. L’opera di Ricardo, in particolare, rappresentando la legge del valore come non infranta né dalla proprietà fondiaria né dall’accumulazione capitalistica ecc., si preoccupa propriamente solo di eliminare tutte le contraddizioni o fenomeni che paiono contraddire questa concezione. Ma il lavoro è concepito come unica sorgente del valore di scambio e come la sorgente attiva del valore d’uso. Enunciando questa contraddizione, l’economia politica esprimeva soltanto l’essenza della produzione capitalistica o, se si vuole, del lavoro salariato; del lavoro estraniato a se stesso, al quale la ricchezza da esso creata si contrappone come ricchezza estranea, la propria forza produttiva come forza produttiva del suo prodotto, il suo arricchimento come impoverimento di se stesso, la sua forza sociale come forza della società su di esso. Ma questa forma determinata, specifica, storica del lavoro sociale, quale si manifesta nella produzione capitalistica, è enunciata da questi economisti
94

come forma generale, eterna, verità di natura, e questi rapporti di produzione sono enunciati come i rapporti assolutamente (non storicamente) necessari, naturali e razionali del lavoro sociale.
[TP. III,21]
Per forza-lavoro o capacità di lavoro intendiamo l’insieme delle attitudini fisiche e intellettuali che esistono nella corporeità, ossia nella personalità vivente d’un uomo, e che egli mette in movimento ogni volta che produce valori d’uso di qualsiasi genere. Tuttavia, affinché il possessore di denaro incontri sul mercato la forza-lavoro come merce, debbono essere soddisfatte diverse condizioni. Se si parte da questo presupposto, la forza-lavoro come merce può apparire sul mercato soltanto in quanto e perché viene offerta o venduta come merce dal proprio possessore, dalla persona della quale essa è la forza-lavoro. Affinché il possessore della forza-lavoro la venda come merce, egli deve poterne disporre, e quindi essere libero proprietario della propria capacità di lavoro, della propria persona. Egli si incontra sul mercato con il possessore di denaro e i due entrano in rapporto reciproco come possessori di merci, di pari diritti, distinti solo per esser l’uno compratore, l’altro venditore, persone dunque giuridicamente eguali. La continuazione di questo rapporto esige che il proprietario della forza-lavoro la venda sempre e soltanto per un tempo determinato; poiché se la vende in blocco, una volta per tutte, vende se stesso, si trasforma da libero in schiavo, da possessore di merce in merce. Il proprietario di forza-lavoro, quale persona, deve riferirsi costantemente alla propria forza-lavoro come a sua proprietà, quindi come a sua propria merce; e può farlo solo in quanto la mette a disposizione del compratore ossia gliela lascia per il consumo, sempre e soltanto, transitoriamente, per un periodo determinato di tempo, e dunque non rinuncia alla sua proprietà su di essa La seconda condizione essenziale affinché il possessore del denaro trovi la forza-lavoro sul mercato come merce, è che il possessore di questa non abbia la possibilità di vendere merci nelle quali si sia oggettivato il suo lavoro, ma anzi, sia costretto a..mettere in vendita, come merce, la sua stessa forza-lavoro, che esiste soltanto nel suo corpo vivente.
Dunque, per trasformare il denaro in capitale il possessore di denaro deve trovare sul mercato delle merci il lavoratore libero; libero nel duplice senso che disponga della propria forza lavorativa come propria merce, nella sua qualità di libera persona, e che, d’altra parte, non abbia da vendere altre merci, che sia privo ed esente, libero di tutte le cose necessarie per la realizzazione della sua forza-lavoro. Per il possessore di denaro, che trova il mercato del lavoro come sezione particolare del mercato delle merci, non ha alcun interesse il problema del perché quel libero lavoratore gli si presenti nella sfera della circolazione. E per il momento non ha interesse neppure per noi. Noi teniamo fermo, sul piano teorico, al dato di fatto, come fa il possessore di denaro sul piano pratico. Una cosa è evidente, però. La natura non produce da una parte possessori di denaro o di merci e dall’altra puri e semplici possessori della propria forza lavorativa. Questo rapporto non è un rapporto risultante dalla storia naturale e neppure un rapporto sociale che sia comune a tutti i periodi della storia. Esso stesso è evidentemente il risultato d’uno svolgimento storico precedente, il prodotto di molti rivolgimenti economici, del tramonto di tutta una serie di formazioni più antiche della produzione sociale.
Il valore della forza-lavoro, come quello di ogni altra merce, è determinato dal tempo di lavoro necessario alla produzione, e quindi anche alla riproduzione, di questo articolo specifico. In quanto valore, anche la forza-lavoro rappresenta soltanto una quantità determinata di lavoro sociale medio, oggettivato in essa. La forza-lavoro esiste soltanto come attitudine naturale dell’individuo vivente. Quindi la produzione di essa presuppone l’esistenza dell’individuo. Data l’esistenza dell’individuo, la produzione della forza-lavoro consiste nella riproduzione, ossia nella conservazione di esso. Per la propria conservazione l’individuo vivente ha bisogno di una certa somma di mezzi di sussistenza. Dunque il tempo dì lavoro necessario per la produzione della forza-lavoro si risolve nel tempo di lavoro necessario per la produzione di quei mezzi di sussistenza; ossia: il valore della forza-lavoro è il valore dei mezzi di sussistenza necessari per la conservazione del possessore della forza-lavoro. Però, la forza-lavoro si realizza soltanto per mezzo della sua estrinsecazione, si attua soltanto nel lavoro. I bisogni naturali, come nutrimento, vestiario, riscaldamento, alloggio, ecc. sono differenti di volta in volta a seconda delle peculiarità climatiche e delle altre peculiarità naturali dei vari paesi. D’altra parte, il volume dei cosiddetti bisogni necessari, come pure il modo di soddisfarli, è anch’esso un prodotto della storia, e dipende quindi in gran parte dal grado d’incivilimento di un paese, e fra l’altro anche, ed essenzialmente, dalle condizioni, e quindi anche dalle abitudini e dalle esigenze fra le quali e con le quali si è formata la classe dei liberi lavoratori. Dunque la determinazione del valore della forza, lavoro, al contrario che per le altre merci, contiene un elemento storico e morale. Ma per un determinato paese in un determinalo periodo, il volume medio dei mezzi di sussistenza necessari è dato.
Le forze-lavoro sottratte al mercato dalla morte e dal logoramento debbono esser continuamente reintegrate per lo meno con lo stesso numero di forze-lavoro nuove. Dunque, la somma dei mezzi di sussistenza necessari alla produzione della forza-lavoro include i mezzi di sussistenza delle forze di ricambio, cioè dei figli dei lavoratori, in modo che questa razza di peculiari possessori di merci si perpetui
95

sul mercato. Per modificare la natura umana generale in modo da farle raggiungere abilità e destrezza in un dato ramo di lavoro, da farla diventare forza-lavoro sviluppata e specifica, c’è bisogno d’una certa preparazione o educazione, che costa a sua volta una somma maggiore o minore di equivalenti di merci. Queste spese di istruzione, infinitesime per la forza-lavoro ordinaria, entrano dunque nel ciclo dei valori spesi per la produzione della forza-lavoro. Il valore della forza-lavoro si risolve nel valore d’una certa somma di mezzi di sussistenza. Quindi varia col valore di quei mezzi di sussistenza, cioè con la grandezza del tempo-lavoro richiesto dalla loro produzione. La natura peculiare di questa merce specifica, la forza-lavoro, ha per conseguenza che quando è concluso il contratto fra compratore e venditore il suo valore d’uso non è ancor passato realmente nelle mani del compratore. Il suo valore era determinato, come quello di ogni altra merce, prima ch’essa entrasse in circolazione, poiché per produrla era stata spesa una determinata quantità di lavoro sociale, ma il suo valore d’uso consiste soltanto nella sua ulteriore estrinsecazione.
L’alienazione della forza-lavoro e il suo reale estrinsecarsi, cioè la sua esistenza come valore d’uso, sono dunque fatti distaccati nel tempo. Il valore d’uso che il possessore del denaro riceve per la sua parte dello scambio si mostra soltanto nel consumo reale, nel processo di consumo della forza- lavoro. Il possessore del denaro compera sul mercato tutte le cose necessarie a questo processo, come materie prime, ecc. e le paga al loro prezzo intero. Il processo di consumo della forza-lavoro è allo stesso tempo processo di produzione di merce e di plusvalore. Il consumo della forza-lavoro, come il consumo di ogni altra merce, si compie fuori del mercato ossia della sfera della circolazione. Quindi, assieme al possessore di denaro e al possessore di forza-lavoro, lasciamo questa sfera rumorosa che sta alla superficie ed è accessibile a tutti gli sguardi, per seguire l’uno e l’altro nel segreto laboratorio della produzione, sulla cui soglia sta scritto: No admittance ex-cept on business. Qui si vedrà non solo come produce il capitale, ma anche come lo si produce, il capitale. Finalmente ci si dovrà svelare l’arcano della fattura del plusvalore.
Il lavoro trapassato, latente nella forza-lavoro, e il lavoro vivente che può fornire la forza-lavoro, cioè i costi giornalieri di mantenimento della forza-lavoro e il dispendio giornaliero di questa sono due grandezze del tutto distinte. La prima determina il suo valore di scambio, l’altra costituisce il suo valore d’uso. Che sia necessaria una mezza giornata lavorativa per tenerlo in vita per ventiquattro ore, non impedisce affatto al lavoratore di lavorare per una giornata intera. Dunque il valore della forza-lavoro e la sua valorizzazione nel processo lavorativo sono due grandezze differenti. A questa differenza di valore mirava il capitalista quando comperava la forza-lavoro. L’utile qualità di produrre, propria della forza-lavoro, era per il capitalista soltanto la conditio sine qua non, poiché, per creare valore, il lavoro dev’essere speso in forma utile: ma decisivo era invece il valore d’uso specifico di questa merce, che è quello di esser fonte di valore, e di più valore di quanto ne abbia essa stessa.
Questo è il servizio specifico che il capitalista se ne aspetta. E in questo egli procede secondo le eterne leggi dello scambio delle merci. Di fatto, il venditore della forza-lavoro realizza il suo valore di scambio e aliena il suo valore d’uso, come il venditore di qualsiasi altra merce. Non può ottenere l’uno senza cedere l’altro. Il valore d’uso della forza-lavoro, il lavoro stesso, non appartiene affatto al venditore di essa, come al negoziante d’olio non appartiene il valore d’uso dell’olio da lui venduto. Il possessore del denaro ha pagato il valore giornaliero della forza-lavoro; quindi a lui appartiene l’uso di essa durante la giornata, il lavoro di tutt’un giorno. La circostanza che il mantenimento giornaliero della forza-lavoro costa soltanto una mezza giornata lavorativa, benché la forza-lavoro possa operare, cioè lavorare, per tutta una giornata, e che quindi il valore creato durante una giornata dall’uso di essa superi del doppio il suo proprio valore giornaliero, è una fortuna particolare per il compratore, ma non è affatto un’ingiustizia verso il venditore.
[C. I,1,4]
I.2.4. Le forme del salario (valore della forza-lavoro)
Il valore della forza-lavoro è determinato dal valore dei mezzi di sussistenza che per consuetudine sono necessari al lavoratore medio. In un’epoca determinata di una società determinala, la massa di questi mezzi di sussistenza è data, benché la sua forma possa variare, e va quindi trattata come grandezza costante. Quello che varia è il valore di questa massa. Dati questi presupposti, si è trovalo che le grandezze relative del prezzo della forza-lavoro e del plusvalore sono determinate da tre circostanze: 1. la durata della giornata lavorativa, ossia la grandezza estensiva del lavoro; 2. l’intensità normale del lavoro, ossia la sua grandezza intensiva, cosicché una determinata quantità di lavoro viene spesa entro un tempo determinato; 3. infine la forza produttiva del lavoro, cosicché una stessa quantità di lavoro fornisca, a seconda del grado di sviluppo delle condizioni di produzione, una maggiore o minore quantità di prodotti entro lo stesso tempo. Evidentemente sono possibili combinazioni diversissime, a seconda che l’uno dei tre fattori sia costante e due variabili oppure due fattori siano costanti e uno variabile o infine tutti e tre siano contemporaneamente variabili. Queste combinazioni vengono moltiplicate ancora dal fatto che, variando insieme fattori diversi, la
96

grandezza e la tendenza della variazione possono essere diverse. Nell’esposizione che segue sono presentate solo le combinazioni principali.
I. Grandezza della giornata lavorativa e intensità dal lavoro costanti (date), forza produttiva del lavoro variabile.
Dato questo presupposto il valore della forza-lavoro e il plusvalore sono determinati da tre leggi.Primo: la giornata lavorativa di grandezza data si rappresenta sempre nella massa produzione di valore,
in qualunque modo varii la produttività del lavoro e con essa la massa dei prodotti e quindi il prezzo della merce singola.
Secondo: Valore della forza-lavoro a plusvalore variano in direzione inversa l’uno nei confronti dell’altro. Una variazione nella forza produttiva del lavoro, il suo aumento o la sua diminuzione, agisce in direzione inversa sul valore della forza-lavoro, e nella stessa direzione sul plusvalore.
In queste circostanze non è dunque possibile alcuna variazione nella grandezza assoluta sia del valore della forza-lavoro sia del plusvalore, senza che al tempo stesso variino le loro grandezze relative ossia proporzionali. È impossibile che diminuiscano o aumentino alto stesso tempo. Inoltre, il valore della forza-lavoro non può diminuire e quindi il plusvalore non può aumentare senza che aumenti la forza produttiva del lavoro. Ne consegue quindi che l’aumento o la diminuzione proporzionale del plusvalore a causa di una variazione data nella forza produttiva del lavoro, risulta tanto maggiore quanto era minore originariamente la parte della giornata lavorativa che si rappresenta in plusvalore, e risulta tanto minore quanto maggiore era quest’ultima parte.
Terzo: Aumento o diminuzione dal plusvalore sono sempre conseguenza e mai causa della corrispondente diminuzione del corrispondente aumento del valore della forza-lavoro.
Siccome la giornata lavorativa è una grandezza costante, si rappresenta in una grandezza di valore costante, e ad ogni variazione di grandezza del plusvalore corrisponde una variazione di grandezza inversa nel valore della forza-lavoro, e il valore della forza-lavoro può variare solo quando varii la forza produttiva del lavoro, date queste condizioni consegue evidentemente che ogni variazione di grandezza del plusvalore deriva da una variazione inversa di grandezza nel valore della forza-lavoro. Quindi, se si è visto che nessuna variazione assoluta di grandezza nel valore della forza-lavoro e nel plusvalore è possibile senza una variazione delle loro grandezza relative, ne segue allora che non è possibile nessuna variazione delle loro grandezze di valore relative senza una variazione nella grandezza di valore assoluta della forza-lavoro.
II. Giornata lavorativa costante, forza produttiva del lavoro costante, intensità del lavoro variabile.Intensità crescente del lavoro presuppone aumento del dispendio di lavoro entro uno stesso periodo di
tempo. La giornata di lavoro più intensa s’incarna quindi in più prodotti della giornata meno intensa d’eguale numero di ore. È vero che, a forza produttiva aumentata, anche la medesima giornata lavorativa fornisce più prodotti. Ma in quest’ultimo caso il valore del prodotto singolo diminuisce perché il prodotto costa meno lavoro di prima; nel primo caso rimane invariato perché il prodotto costa, sia prima che dopo, la stessa quantità di lavoro. In questo caso il numero dei prodotti aumenta senza diminuzione del loro prezzo. Col crescere del loro numero cresce la somma dei loro prezzi, mentre nell’altro caso la medesima somma di valore si presenta semplicemente in una massa maggiore di prodotti. Quindi la giornata lavorativa più intensa s’incarna, invariato rimanendo il numero delle ore, in una più alta produzione di valore, e invariato rimanendo il valore del denaro, in più denaro. La produzione di valore della giornata più intensa varia col deviare della sua intensità dal grado sociale normale. La medesima giornata lavorativa non si rappresenta dunque, come prima, in una produzione di valore costante, ma in una produzione variabile di valore.
III. Forza produttiva e intensità del lavoro costanti, giornata lavorativa variabile.La giornata lavorativa può variare in due direzioni. Può essere abbreviata o prolungata. 1. Nelle condizioni date, ossia eguali rimanendo la forza produttiva e l’intensità del lavoro, l’abbrevia-
mento della giornata lavorativa lascia invariato il valore della forza-lavoro e quindi il tempo di lavoro necessario. Abbrevia il pluslavoro e diminuisce il plusvalore. Insieme alla grandezza assoluta di quest’ultimo diminuisce anche la sua grandezza relativa ossia la sua grandezza in rapporto alla grandezza di valore invariata della forza-lavoro. Solo abbassando il prezzo di questa al di sotto del suo valore il capitalista potrebbe evitare una perdita. Tutte le frasi correnti contro l’abbreviamento della giornata lavorativa presuppongono che il fenomeno avvenga nelle circostanze qui presupposte, mentre viceversa in realtà la variazione nella forza produttiva e nell’intensità del lavoro o precede l’abbreviamento della giornata lavorativa o lo segue immediatamente.
2. Prolungamento della giornata lavorativa. Siccome la produzione di valore nella quale si rappresenta la giornata lavorativa cresce con il prolungarsi della giornata lavorativa stessa, il prezzo della forza-lavoro e il plusvalore possono crescere contemporaneamente sia di un incremento eguale sia d’un incremento diseguale. Questo aumento contemporaneo è dunque possibile in due casi; è possibile con un prolungamento assoluto della giornata lavorativa e con un aumento della intensità del lavoro, senza quel prolungamento. A
97

giornata lavorativa prolungata, il prezzo della forza-lavoro può diminuire al di sotto del suo valore, benché nominalmente rimanga invariato o anzi salga. Il valore giornaliero della forza-lavoro è infatti valutato, come si ricorderà, in base alla durata media normale ossia al periodo di vita normale del lavoratore, e in base alla corrispondente conversione di sostanza vitale in movimento, conversione normale e commisurata alla natura umana.
IV. Variazioni contemporanee nella durata, forza produttiva e intensità del lavoro.Possono variare due fattori alla volta e uno rimanere costante, oppure possono variare tutti e tre insieme.
Possono variare in grado eguale o in grado ineguale, nella stessa direzione o in quella opposta, e quindi le loro variazioni possono annullarsi in parte o del tutto. Ma l’analisi di tutti i casi possibili sarà facile. Si troverà il risultato di ogni combinazione possibile considerando uno dopo l’altro un fattore per volta variabile e gli altri in un primo tempo costanti. Quindi prenderemo ancora nota brevemente solo di due casi importanti.
1. Forza produttiva del lavoro in diminuzione con prolungamento contemporaneo della giornata lavorativa. Quando parliamo di forza produttiva del lavoro in diminuzione, si tratta di rami di lavoro i cui prodotti determinano il valore della forza-lavoro, dunque per esempio di forza produttiva del lavoro in diminuzione a causa di un’aumentata sterilità del terreno e di un corrispondente rincaro dei prodotti del terreno
2. Intensità e forza produttiva del lavoro in aumento e contemporaneo abbreviamento della giornata lavorativa. L’aumento della forza produttiva del lavoro e la sua crescente intensità agiscono uniformemente in una direzione. Entrambe aumentano la massa dei prodotti ottenuta in ciascun periodo di tempo. Entrambe accorciano quindi quella parte della giornata lavorativa di cui il lavoratore abbisogna per la produzione dei pro-pri mezzi di sussistenza o del loro equivalente. Il limite minimo assoluto della giornata lavorativa è in genere formato da questa sua parte costitutiva necessaria ma contrattile. Se tutta la giornata lavorativa si riducesse a quella parte, il pluslavoro scomparirebbe, il che è impossibile sotto il regime del capitale. L’eliminazione della forma di produzione capitalistica permette di limitare la giornata lavorativa al lavoro necessario. Tuttavia quest’ultimo, invariate rimanendo le altre circostanze, estenderebbe la sua parte: da un lato, perché le condizioni di vita del lavoratore si farebbero più ricche e le esigenze della sua vita maggiori. Dall’altro lato, una parte dell’attuale pluslavoro rientrerebbe allora nel lavoro necessario, cioè nel lavoro necessario per ottenere un fondo sociale di riserva e di accumulazione.
Quanto più cresce la forza produttiva del lavoro, tanto più può essere abbreviata la giornata lavorativa, e quanto più può essere abbreviata la giornata lavorativa, tanto più potrà crescere l’intensità del lavoro. Da un punto di vista sociale la produttività del lavoro cresce anche con la sua economia. Quest’ultima comprende non soltanto il risparmio nei mezzi di produzione, ma l’esclusione di ogni lavoro senza utilità. Mentre il modo di produzione capitalistico impone risparmio in ogni azienda individuale, il suo anarchico sistema della concorrenza determina lo sperpero più smisurato dei mezzi di produzione sociali e delle forze-lavoro sociali oltre a un numero stragrande di funzioni attualmente indispensabili, sia in sé e per sé superflue. Date l’intensità e la forza produttiva del lavoro, la parte della giornata lavorativa sociale necessaria per la produzione materiale sarà tanto più breve, e la parte di tempo conquistata per la libera attività mentale e sociale degli individui sarà quindi tanto maggiore, quanto più il lavoro sarà distribuito proporzionalmente su tutti i membri della società capaci di lavorare, e quanto meno uno strato della società potrà allontanare da sé la necessità naturale del lavoro e addossarla a un altro strato. Il limite assoluto dell’abbreviamento della giornata lavorativa è sotto questo aspetto l’obbligo generale del lavoro. Nella società capitalistica si produce tempo libero per una classe mediante la trasformazione in tempo di lavoro di tutto il tempo di vita delle masse.
In primo luogo è evidente che il lavoratore, durante tutto il tempo della sua vita, non è altro che forza-lavoro, e perciò che tutto il suo tempo disponibile è, per natura e per diritto, tempo di lavoro, e dunque appartiene alla autovalorizzazione del capitale. Tempo per un’educazione da esseri umani, per lo sviluppo intellettuale, per l’adempimento di funzioni sociali, per rapporti socievoli, per il libero gioco delle energie vitali fisiche e mentali, perfino il tempo festivo domenicale – e sia pure nella terra dei sabbatari: fronzoli puri e semplici! Ma il capitale, nel suo smisurato e cieco impulso, nella sua voracità da lupo mannaro di pluslavoro, scavalca non soltanto i limiti massimi morali della giornata lavorativa, ma anche quelli puramente fisici. Usurpa il tempo necessario per la crescita, lo sviluppo e la sana conservazione del corpo. Ruba il tempo che è indispensabile per consumare aria libera e luce solare. Lesina sul tempo dei pasti, e lo interpone dove è possibile nel processo produttivo stesso, cosicché al lavoratore vien dato il cibo come a un puro e semplice mezzo di produzione, come si dà carbone alla caldaia a vapore, come si dà sego e olio alle macchine. Riduce il sonno sano che serve a raccogliere, rinnovare, rinfrescare le energie vitali, a tante ore di torpore quante ne rende indispensabili il ravvivamento di un organismo assolutamente esaurito.
Qui non è la normale conservazione della forza-lavoro a determinare il limite della giornata lavorativa, ma viceversa, è il massimo possibile dispendio giornaliero di forza-lavoro, per quanto morbosamente coatto
98

e penoso, a determinare il limite del tempo di riposo del lavoratore. Il capitale non si preoccupa della durata della vita della forza-lavoro. Quel che gli interessa è unicamente e soltanto il massimo di forza-lavoro che può essere resa liquida in una giornata lavorativa; e ottiene questo scopo abbreviando la durata della forza-lavoro, come un agricoltore avido ottiene aumentati proventi dal suolo rapinandone la fertilità. Con il prolungamento della giornata lavorativa, la produzione capitalistica, che è essenzialmente produzione di plusvalore, assorbimento di pluslavoro, non produce dunque soltanto il rattrappimento della forza-lavoro umana, che vien derubata delle sue condizioni normali di sviluppo e di attuazione, morali e fisiche; ma produce anche l’esaurimento e la estinzione precoce della forza-lavoro stessa. Essa prolunga il tempo di produzione del lavoratore entro un termine dato, mediante l’accorciamento del tempo che questi ha da vivere.
Primi di settembre del 1866: il Congresso internazionale dei lavoratori di Ginevra, su proposta del Consiglio generale di Londra, approvò la seguente risoluzione: “Dichiariamo che la limitazione della giornata lavorativa è una condizione preliminare, senza la quale non possono non fallire tutti gli altri sforzi di emancipazione... Proponiamo otto ore lavorative come limite legale della giornata lavorativa”. Alla superficie della società borghese il compenso del lavoratore appare quale prezzo del lavoro: una determinata quantità di denaro che viene pagata per una determinata quantità di lavoro. Qui si parla di valore del lavoro e si chiama l’espressione monetaria di quest’ultimo prezzo necessario o naturale del lavoro. D’altra parte si parla di prezzi di mercato del lavoro ossia di prezzi oscillanti al di sopra o al di sotto del suo prezzo necessario. In realtà, sul mercato delle merci si presenta direttamente al possessore di denaro non il lavoro, ma il lavoratore. Ciò che vende quest’ultimo è la propria forza-lavoro. Appena il suo lavoro comincia realmente, esso ha già cessato di appartenergli, e quindi non può più essere venduto da lui. Il lavoro è la sostanza e la misura immanente dei valori, ma esso stesso non ha valore. Nell’espressione “valore del lavoro” il concetto di valore non solo è del tutto obliterato, ma è rovesciato nel suo opposto. È un’espressione immaginaria come ad esempio valore della terra. Tuttavia queste espressioni immaginarie derivano dagli stessi rapporti di produzione. Sono categorie di forme fenomeniche di rapporti sostanziali. È cosa abbastanza nota in tutte le scienze, tranne nell’economia politica, che nella loro apparenza le cose spesso si presentano invertite. Quindi quel che essa chiama valore del lavoro [value of labour], è in realtà il valore della forza-lavoro, la quale esiste nella personalità del lavoratore ed è differente dalla sua funzione, il lavoro, quanto è differente dalle proprie operazioni una macchina.
L’inconsapevolezza di questo risultato della propria analisi, l’accettazione senza alcuna critica delle categorie “valore del lavoro”, “prezzo naturale del lavoro” ecc. come espressioni definitive e adeguate del rapporto di valore che si trattava, ha avvolto l’economia politica classica, come vedremo più avanti, in confusioni e contraddizioni insolubili, mentre ha offerto all’economia volgare una sicura base operativa per la sua superficialità, che per principio s’inchina solo all’apparenza. Vediamo ora in primo luogo in che modo il valore e i prezzi dulia forza-lavoro si presentino nella loro forma trasformata di salario. È noto che il valore giornaliero della forza-lavoro è calcolato su un dato periodo della vita del lavoratore, al quale corrisponde una data lunghezza della giornata lavorativa. Siccome il valore del lavoro non è che un’espressione irrazionale per valore della forza-lavoro, risulta ovviamente che il valore del lavoro deve essere sempre minore della sua produzione di valore, giacché il capitalista fa funzionare la forza-lavoro sempre per un tempo maggiore di quello necessario alla riproduzione del valore della forza-lavoro.
La forma di salario oblitera quindi ogni traccia della divisione della giornata lavorativa in lavoro necessario e in pluslavoro, in lavoro retribuito e lavoro non retribuito. Tutto il lavoro appare come lavoro retribuito. Nelle prestazioni di lavoro feudali il lavoro del servo feudale pur se stesso è distinto nello spazio e nel tempo, in maniera tangibile e sensibile, dal lavoro coatto per il signore del fondo. Nel lavoro degli schiavi persino la parte della giornata lavorativa, in cui lo schiavo non fa che reintegrare il valore dei propri mezzi di sussistenza, in cui dunque lui lavora in realtà per se stesso, appare come lavoro pur il suo padrone. Tutto il suo lavoro appare come lavoro non retribuito. Nel lavoro salariato all’incontro persino il pluslavoro ossia il lavoro non retribuito appare come lavoro retribuito. Là il rapporto di proprietà cela il lavoro che lo schiavo compie per se stesso, qui il rapporto monetario cela il lavoro che il lavoratore salariato compie senza alcuna retribuzione. Si comprende quindi l’importanza decisiva che ha la metamorfosi del valore e del prezzo della forza-lavoro nella forma di salario, ossia in valore e prezzo del lavoro stesso. Su questa forma fenomenica che rende invisibile il rapporto reale e mostra precisamente il suo opposto, si fondano tutte le idee giuridiche del lavoratore e del capitalista, tutte le mistificazioni del modo di produzione capitalistico, tutte le sue illusioni sulla libertà, tutte le chiacchiere apologetiche dell’economia volgare.
Per di più il movimento reale del salario mostra fenomeni i quali sembrano dimostrare che non il valore dalla forza-lavoro viene pagato, bensì il valore della sua funzione, il valore del lavoro stesso. Questi fenomeni si possono ricondurre a due grandi classi. Primo: il variare del salario con il variare della lunghezza della giornata lavorativa. Secondo: la differenza individuale fra i salari di lavoratori diversi i quali compiono la medesima funzione. Del resto per la forma fenomenica “valore o prezzo del lavoro” o “salario”,
99

a differenza del rapporto sostanziale che in essa appare cioè il valore e il prezzo della forza-lavoro, vale quel che vale per tutte le forme fenomeniche e per il loro sfondo nascosto. Le forme fenomeniche si riproducono con immediata spontaneità, come forme correnti del pensiero, il rapporto sostanziale deve essere scoperto dalla scienza. L’economia politica classica tocca in via approssimativa il vero stato delle cose, senza peraltro formularlo in modo consapevole. Essa non può farlo finché è chiusa nella sua pelle borghese.
Il salario assume a sua volta forme svariatissime, circostanza che non si può conoscere nei compendi di economia, i quali, brutalmente interessati alla materia, trascurano ogni differenza di forma. La vendita della forza-lavoro ha luogo sempre come si ricorderà, per periodi determinati di tempo. La forma mutata in cui si presentano immediatamente il valore giornaliero, il valore settimanale, ecc. della forza-lavoro è quindi la forma del “salario a tempo”, cioè il salario giornaliero, ecc. L’unità di misura del salario a tempo, il prezzo dell’ora lavorativa, è il quoziente del valore giornaliero della forza-lavoro, diviso per il numero delle ore della giornata lavorativa usuale. Come prima si sono viste le conseguenze distruttrici del sopralavoro, così si scoprono qui le fonti delle sofferenze che derivano al lavoratore dalla sua sottooccupazione. Qualora il salario a ora venga fissato in modo che il capitalista non si impegni al pagamento di un salario giornaliero o settimanale, ma solo al pagamento delle ore lavorative durante le quali egli si compiace di occupare il lavoratore, potrà occuparlo al di sotto del tempo che in origine sta alla base della valutazione del salario a ora o dell’unità di misura del prezzo del lavoro. Siccome quest’unità di misura è determinata dalla proporzione tra il valore giornaliero della forza-lavoro divisa per la giornata lavorativa di un numero di ore dato, essa naturalmente non ha più senso alcuno appena la giornata lavorativa cessi di avere un determinato numero di ore.
Il nesso fra lavoro retribuito e lavoro non-retribuito viene eliminato. Adesso il capitalista può ricavare dal lavoratore una quantità determinata di pluslavoro senza concedergli il tempo di lavoro necessario per il suo sostentamento. Egli può distruggere ogni regolarità dell’occupazione e può, secondo il solo suo comodo, arbitrio e interesse momentaneo, alternare il lavoro supplementare più mostruoso con la disoccupazione relativa o totale. Questa geremiade è interessante anche perché mostra come nel cervello del capitalista si rispecchi solo l’apparenza dei rapporti di produzione. Il capitalista non sa che anche il prezzo normale del lavoro include una determinata quantità di lavoro non retribuito e che per l’appunto questo lavoro non retribuito è la fonte normale del suo guadagno. In genere, per lui la categoria del tempo di pluslavoro non esiste, poiché essa è inclusa nella giornata lavorativa normale che egli ritiene di pagare nel salario giornaliero. Esiste bensì per lui il tempo supplementare, il prolungamento della giornata lavorativa al di là del limite corrispondente al prezzo d’uso del lavoro.
Il salario a cottimo non è altro che una forma mutata del salario a tempo come il salario a tempo è la forma mutata del valore o prezzo della forza-lavoro. A prima vista pare nel salario a cottimo che il valore d’uso venduto dal lavoratore non sia il funzionamento della sua forza-lavoro, il lavoro vivente, ma lavoro già oggettivato nel prodotto, e che il prezzo di questo lavoro non sia determinato, come nel salario a tempo, ma dalla capacità di rendimento del produttore. Ma è chiaro in sé e per sé che la differenza nella forma del pagamento del salario non muta nulla alla sua natura, benché una forma possa essere più favorevole di un’altra allo sviluppo della produzione capitalistica. Consideriamo ora un po’ più da vicino le peculiarità caratteristiche del salario a cottimo. La qualità del lavoro è qui controllata dall’opera stessa, la quale deve possedere bontà media, se il prezzo a cottimo dev’essere pagato in pieno. Il salario a cottimo diventa da questo lato fonte fecondissima di detrazioni sul salario e di truffe capitalistiche. Esso offre al capitalista una misura ben definita dell’intensità del lavoro. Soltanto il tempo di lavoro che si incarna in una quantità di merce determinata in precedenza e stabilita secondo esperienza, è considerato tempo di lavoro socialmente necessario e viene pagato come tale. Siccome qui la qualità e l’intensità del lavoro sono controllate dalla forma dello stesso salario, si rende superflua buona parte della sorveglianza del lavoro. Questa forma costituisce quindi la base tanto del moderno lavoro domestico quanto di un sistema di sfruttamento e di oppressione gerarchicamente articolato. Quest’ultimo ha due forme fondamentali.
Da una parte, il salario a cottimo facilita l’inserimento di parassiti fra capitalista e lavoratore salariato, cioè il subaffitto del lavoro [subletting of labour]. Il guadagno degli intermediari deriva esclusivamente dalla differenza fra il prezzo del lavoro pagato dal capitalista e quella parte di questo prezzo che essi lasciano realmente pervenire al lavoratore. Questo sistema si chiama in Inghilterra in modo caratteristico lo sweating system (sistema del sudore). Dall’altra parte, il salario a cottimo permette al capitalista di concludere con il capo operaio – nella manifattura con il capo di un gruppo, nelle miniere con lo scavatore del carbone, ecc., nella fabbrica con il vero e proprio operaio meccanico – un contratto per tanti e tanti articoli a un prezzo, per il quale il capo operaio stesso si assume l’arruolamento e il pagamento dei suoi lavoratori ausiliari. Lo sfruttumento degli lavoratori da parte del capitale si attua qui mediante lo sfruttamento del lavoratore da parte del lavoratore. Dato il salario a cottimo, è naturalmente interesse personale del lavoratore impegnare la propria forza-lavoro con la maggiore intensità possibile, il che facilita al capitalista un aumento del grado normale dell’intensità. Ed è allo stesso modo nell’interesse personale del lavoratore prolungare la giornata
100

lavorativa, perché così cresce il suo salario giornaliero o settimanale. Subentra così la reazione già illustrata trattando del salario a tempo, astraendo dal fatto che il prolungamento della giornata lavorativa racchiude in sé e per sé un ribasso del prezzo dal lavoro anche se il salario a cottimo rimane costante.
Nel salario a tempo si ha, con poche eccezioni, salario eguale per eguali funzioni, mentre nel salario a cottimo il prezzo del tempo di lavoro è bensì misurato mediante una determinata quantità di prodotti, ma il salario giornaliero o settimanale varia con la differenza individuale dei lavoratori, di cui l’uno in un dato tempo fornisce solo il minimo dei prodotto, l’altro la media e il terzo più della media. Qui si verificano dunque grandi differenze nelle entrate reali dei lavoratori a seconda della diversa abilità, forza, energia, perseveranza, ecc. dei lavoratori individuali. Ma il maggior campo d’azione che il salario a cottimo offre all’individualità, tende da un lato a sviluppare l’individualità e con ciò il sentimento della libertà, l’autonomia e l’autocontrollo dei lavoratori, dall’altro a sviluppare la loro concorrenza fra di loro e degli uni contro gli altri. Esso ha perciò la tendenza ad abbassare il livello medio dei salari mediante l’aumento dei salari individuali al di sopra del livello stesso. Da quanto è stato esposto sino qui risulta che il salario a cottimo è la forma di salario che più corrisponde al modo di produzione capitalistico. Sebbene non sia affatto nuovo – esso figura ufficialmente accanto al salario a tempo negli statuti dei lavoratori francesi e inglesi del secolo XIV – il salario a cottimo acquista tuttavia un campo d’azione maggiore soltanto durante il periodo della manifattura vera e propria. Nelle officine soggette alla legge sulle fabbriche il salario a cottimo diventa regola generale perché in esse il capitale non può estendere la giornata lavorativa altro che aumentando l’intensità del lavoro.
[C. I, 8;15;17-19]
I.2.5. La riserva di lavoro
L’aumento del capitale, implica l’aumento della sua parte costitutiva variabile ossia convertita in forza-la-voro. Una parte del plusvalore trasformato in capitale addizionale deve costantemente essere ritrasformata in capitale variabile ossia in un fondo addizionale per il lavoro. Le circostanze più o meno favorevoli in cui i salariati si mantengono e si moltiplicano non cambiano tuttavia nulla al carattere fondamentale della produzione capitalistica. La riproduzione su scala allargata ossia l’accumulazione riproduce il rapporto capitalistico su scala allargata, più capitalisti o più grossi capitalisti a questo polo e più salariati a quell’altro. La riproduzione della forza-lavoro, che deve incessantemente incorporarsi al capitale come mezzo di valorizzazione, che non può staccarsi da esso e la cui servitù nei confronti del capitale viene solo nascosta dall’alternarsi del capitalista individuale a cui essa si vende, costituisce effettivamente un elemento della riproduzione dello stesso capitale. L’accumulazione del capitale è quindi l’aumento del proletariato. Un aumento del prezzo del lavoro in seguito all’accumulazione del capitale significa effettivamente soltanto che il volume e il grosso peso della catena dorata che il salariato stesso si è ormai fucinato, consentono una tensione allentata. Nelle controversie su questo argomento non si è tenuto conto per lo più della cosa principale ossia della differenza specifica della produzione capilalistica. La forza-lavoro qui non è comprata per soddisfare mediante il suo servizio o il suo prodotto i bisogni personali del compratore. Lo scopo del compratore è la valorizzazione del suo capitale, la produzione di merci che contengano una maggior quantità di lavoro di quella che paga, che contengano quindi una parte di valore che a lui non costa nulla e che ciò nonostante viene realizzata mediante la vendita delle merci.
La produzione di plusvalore o il “fare di più” è la legge assoluta di questo modo di produzione. La forza-lavoro è vendibile solo in quanto conserva i mezzi di produzione come capitale, in quanto riproduce il proprio valore come capitale e fornisce nel lavoro non retribuito una fonte di capitale addizionale. Le condizioni della sua vendita, siano esse più favorevoli al lavoratore o meno, implicano quindi la necessità della sua costante rivendita e la sempre ampliata riproduzione della ricchezza come capitale. Il salario esige costantemente, come si è visto, per sua natura, la fornitura di una determinata quantità di lavoro non retribuito da parte del lavoratore. Del tutto prescindendo dall’aumento del salario accompagnato alla diminuzione dal prezzo del lavoro ecc., il suo crescere, nel caso migliore, non significa che il calare quantitativo del lavoro non retribuito che il lavoratore deve compiere. Questo calare non può mai continuare fino al punto in cui minaccerebbe il sistema stesso. Astrazion fatta dai conflitti violenti intorno al tasso del salario, Adam Smith ha già mostrato come in un conflitto del genere tutto sommato il padrone resta sempre padrone. Il prezzo del lavoro ricade a un livello corrispondente ai bisogni di valorizzazione del capitale, sia esso più basso, sia esso più alto del livello considerato normale prima dell’aumento dei salari, sia esso eguale a questo. Sono questi movimenti assoluti entro l’accumulazione del capitale che si rispecchiano come movimenti relativi entro la massa della forza-lavoro sfruttabile e quindi sembrano dovuti al movimento proprio di quest’ultima. Per usare un’espressione matematica: la grandezza dell’accumulazione è la variabile indipendente, la grandezza del salario quella dipendente, non viceversa.
101

La legge della produzione capitalistica, che sta alla base della pretesa “legge naturale della popolazione”, si riduce semplicemente a questo: il rapporto fra capitale, accumulazione e tasso del salario non è altro che il rapporto fra il lavoro non retribuito e quello retribuito di una medesima popolazione lavoratrice . Se la quantità del lavoro non retribuito, fornito dalla classe operaia e accumulato dalla classe dei capitalisti, cresce con rapidità sufficiente perché si possa trasformare in capitale solo con un’aggiunta straordinaria di lavoro retribuito, il salario cresce, e, supponendo eguali tutte le altre circostanze, il lavoro non retribuito diminuisce in proporzione. Ma non appena questa diminuzione tocca il punto in cui il pluslavoro che alimenta il capitale non viene più offerto in quantità normale, subentra una reazione: una parte minore del reddito viene capitalizzata, l’accumulazione viene paralizzata e il movimento dei salari in aumento subisce un contraccolpo. L’aumento del prezzo del lavoro rimane dunque confinato entro limiti che non solo lasciano intatta la base del sistema capitalistico, ma assicuri no anche la sua riproduzione su scala crescente.
Non può essere diversamente in un modo di produzione entro il quale il lavoratore salariato esiste per i bisogni di valorizzazione di valori esistenti, invece che, viceversa, la ricchezza materiale per i bisogni di sviluppo del lavoratore, l’accumulazione accelera, e allarga allo stesso tempo i rivolgimenti nella composizione tecnica del capitale, che ne annientano la parte costante a spese di quella variabile, e con ciò diminuiscono la domanda relativa di lavoro. La diminuzione assoluta della domanda di lavoro che necessariamente ne consegue diventa naturalmente tanto maggiore quanto più i capitali che percorrono questo processo di rinnovamento sono già accumulati in massa. Da un lato il capitale addizionale formato nel progredire dell’accumulazione attrae, in rapporto alla propria grandezza, sempre meno lavoratori. Dall’altro il capitale vecchio riprodotto periodicamente in nuova composizione respinge un numero sempre maggiore dei lavoratori prima da lui occupati. Siccome la domanda di lavoro non è determinata dal volume del capitale complessivo, ma dal volume della sua parte costitutiva variabile, essa diminuirà quindi in proporzione progressiva con l’aumentare del capitale complessivo, invece di aumentare in proporzione di esso. Essa diminuisce in rapporto alla grandezza del capitale complessivo, e diminuisce in progressione accelerata con l’aumentare di essa. Con l’aumentare del capitale complessivo cresce, è vero, anche la sua parte costitutiva variabile ossia la forza-lavoro incorporatagli, ma cresce in proporzione costantemente decrescente.
Gli intervalli in cui l’accumulazione opera come semplice allargamento della, produzione sulla base tecnica data, si accorciano. Non soltanto si rende necessaria un’accumulazione del capitale complessivo accelerata in progressione crescente per assorbire un numero addizionale di lavoratori di una certa grandezza o anche, a causa della costante metamorfosi del vecchio capitale, soltanto per occupare il numero già operante; ma, a sua volta questa crescente accumulazione e centralizzazione stessa si converte ancora in una fonte di nuovi cambiamenti nella composizione del capitale o in una diminuzione di bel nuovo accelerata della sua parte costitutiva variabile a paragone della costante. Questa diminuzione relativa della parte costitutiva variabile, accelerata con l’aumentare del capitale complessivo e accelerata in misura maggiore del proprio aumento, appare dall’altra parte, viceversa, come un aumento assoluto della popolazione lavoratrice costantemente più rapido di quello del capitale variabile, ossia dei mezzi che le dànno occupazione. È invece l’accumulazione capitalistica che costantemente produce, precisamente in proporzione della propria energia e del proprio volume, una popolazione lavoratrice relativamente addizionale, cioè eccedente i bisogni medi di valorizzazione del capitale, e quindi superflua. È questa una legge della popolazione peculiare del modo di produzione capitalistico, come di fatto ogni modo di produzione storico particolare ha le proprie leggi della popolazione particolari, storicamente valide. Una legge astratta della popolazione esiste soltanto per le piante e per gli animali nella misura in cui l’uomo non interviene portandovi la storia.
Ma se una sovrapopolazione lavoratrice è il prodotto necessario della accumulazione ossia dello sviluppo della ricchezza su base capitalistica, questa sovrapopolazione diventa, viceversa, la leva dell’accumulazione capitalistica e addirittura una delle condizioni d’esistenza del modo di produzione capitalistico. Essa costituisce un esercito industriale di riserva disponibile che apparitiene al capitale in maniera cosi completa come se quest’ultimo l’avesse allevato a sue proprie spese, e crea per i mutevoli bisogni di valorizzazione di esso il materiale umano sfruttabile sempre pronto, indipendentemente dai limiti del reale aumento della popolazione. Grandi masse di uomini devono essere spostabili improvvisamente nei punti decisivi, senza pregiudizio della scala di produzione in altre sfere: le fornisce la sovrapopolazione. Il ciclo vitale caratteristico dell’industria moderna – la forma di un ciclo di periodi di vivacità media, produzione con pressione massima, crisi e stagnazione, interrotto da piccole oscillazioni – si basa sulla costante formazione, sul maggiore o minore assorbimento e sulla nuova formazione dell’esercito industriate di riserva o della sovrapopolazione. Le alterne vicende del ciclo industriale reclutano a loro volta la sovrapopolazione e diventano uno degli agenti più energici della sua riproduzione.
L’aumento dei lavoratori viene creato mediante un processo semplice che ne “libera” costantemente una parte, in virtù di metodi che diminuiscono il numero dei lavoratori occupati in rapporto alla produzione aumentata. La forma di tutto il movimento dell’industria moderna nasce dunque dalla costante trasformazione di una parte della popolazione lavoratrice in braccia disoccupate o occupate a metà. La
102

superficialità dell’economia politica risulta fra l’altro nel fatto che essa fa dell’espansione e della contrazione del credito, che sono meri sintomi dei periodi alterni del ciclo industriale, la causa di quei periodi. Effetti diventano a loro volta cause, e le alterne vicende di tutto il processo, che riproduce costantemente i propri movimenti, assumono la forma della periodicità. Una volta consolidata quest’ultima, perfino l’economia politica riesce a concepire la produzione di una popolazione eccedente relativa, cioè eccedente riguardo al bisogno medio di valorizzazione del capitale, come condizione vitale dell’industria moderna. Alla produzione capitalistica non basta affatto la quantità di forza-lavoro disponibile che fornisce l’aumento naturale della popolazione. Per avere mano libera essa abbisogna di un esercito industriale di riserva indipendente da questo limite naturale. Finora è stato presupposto che all’aumento o alla diminuzione del capitale variabile corrisponda esattamente l’aumento o la diminuzione del numero dei lavoratori occupati. Ma, eguale restando o perfino diminuendo il numero dei lavoratori da esso comandati, il capitale variabile cresce solo più lentamente di quello che aumenti la massa del lavoro. L’aumento del capitale variabile diventa allora indice di più lavoro, ma non di un maggiore numero di lavoratori occupati.
Lo sviluppo del modo capitalistico di produzione e della forza produttiva del lavoro – causa ed effetto allo stesso tempo dell’accumulazione – mette in grado il capitalista di rendere liquida, con il medesimo esborso di capitale variabile, una maggiore quantità di lavoro sfruttando maggiormente, o in via estensiva o intensiva, le forze-lavoro individuali. Inoltre egli compra più forze-lavoro con il medesimo valore capitale soppiantando progressivamente forza-lavoro qualificata con forza-lavoro non qualificata, forza-lavoro matura con quella immatura, forza-lavoro maschile con quella femminile, forza-lavoro adulta con quella giovanile o infantile. Da un lato dunque, nel progredire dell’accumulazione, un capitale variabile maggiore rende liquida una maggior quantità di lavoro senza arruolare un maggior numero di lavoratori, dall’altro un capitale variabile della medesima grandezza rende liquida una maggiore quantità di lavoro mediante una medesima massa di forza-lavoro e infine rende liquido un maggior numero di forze-lavoro inferiori soppiantando quelle superiori. La produzione di una sovrapopolazione relativa ossia la messa in libertà di lavoratori procede perciò ancora più rapida che non la rivoluzione tecnica del processo di produzione accelerata di per sé insieme al progredire dell’accumulazione e che non la corrispondente diminuzione proporzionale della parte variabile del capitale nei confronti di quella costante.
Se i mezzi di produzione, mano a mano che aumentano di volume e di efficacia, diventano in misura minore mezzi d’occupazione dei lavoratori, questo stesso rapporto viene a sua volta modificato giacché nella misura in cui cresce la forza produttiva del lavoro il capitale aumenta la sua offerta di lavoro con rapidità maggiore che non la sua domanda di lavoratori. Il lavoro fuori orario della parte occupata della classe operaia ingrossa le file della riserva lavoratrice, mentre, viceversa, la pressione aumentata che quest’ultima esercita con la sua concorrenza sulla prima, costringe questa al lavoro fuori orario e alla sottomissione ai dettami del capitale. La condanna di una parte della classe operaia a un ozio forzoso, mediante il lavoro fuori orario dell’altra parte, e viceversa, diventa mezzo d’arricchimento del capitalista singolo e accelera allo stesso tempo la produzione dell’esercito industriale di riserva su una scala corrispondente al progresso dall’accumulazione sociale. Tutto sommato i movimenti generali del salario sono regolati esclusivamente dall’espansione e dalla contrazione dell’esercito industriale di riserva, le quali corrispondono all’alternarsi dei periodi del ciclo industriale. Non sono dunque determinati dal movimento del numero assoluto della popolazione lavoratrice, ma dalla mutevole proporzione in cui la classe operaia si scinde in esercito attivo e in esercito di riserva, dall’aumento e dalla diminuzione del volume relativo della sovrapopolazione, dal grado in cui questa viene ora assorbita ora di nuovo messa in libertà.
L’esercito industriale di riserva preme durante i periodi di stagnazione e di prosperità media sull’esercito attivo dei lavoratori e ne frena, durante il periodo della sovraproduzione e del parossismo, le rivendicazioni. La sovrapopolazione relativa è quindi lo sfondo sul quale si muove la legge della domanda e dell’offerta del lavoro. Essa costringe il campo d’azione di questa legge entro i limiti assolutamente convenienti alla brama di sfruttamento e alla smania di dominio del capitale. Vale a dire dunque che l’aumento assoluto del capitale non è accompagnato da un corrispondente aumento della domanda generale di lavoro. Il capitale agisce contemporaneamente da tutte e due le parti. Se da un lato la sua accumulazione aumenta la domanda di lavoro, dall’altro essa aumenta l’offerta di lavoratori mediante la loro “messa in libertà”, mentre allo stesso tempo la pressione dei disoccupali costringe i lavoratori occupati a render liquida una maggiore quantità di lavoro rendendo in tal modo l’offerta di lavoro in una certa misura indipendente dall’offerta di lavoratori. Il movimento della legge della domanda e dell’offerta di lavoro su questa base porta a compimento il dispotismo del capitale, “il capitale e il suo sicofante, l’economista, strepitano su una violazione dell’“eterna” e per cosi dire “sacra” legge della domanda e dell’offerta. Ogni solidarietà fra i lavoratori occupati e quelli disoccupati turba infatti l’azione “pura” di quella legge.
La sovrapopolazione relativa esiste in tutte le sfumature possibili. Ne fa parte ogni lavoratore durante il periodo in cui è occupato a metà o non è occupato affatto. Astrazion fatta dalle grandi forme, ripresentantisi periodicamente, che le imprime l’alternarsi delle fasi del ciclo industriale in modo che essa appaia ora acuta
103

al momento delle crisi, ora cronica in epoca di affari fiacchi, essa ha ininterrottamente tre forme: fluttuante, latente e stagnante Nei centri dell’industria moderna la sovrapopolazione esiste, in forma fluttuante. Essa costituisce un elemento della sovrapopolazione fluida il quale cresce col crescere dell’estensione dell’industria. Una parte di essa emigra e in realtà non fa che seguire il capitale emigrante. Il fatto che l’aumento naturale della massa dei lavoratori non saturi i bisogni di accumulazione del capitale e tuttavia li superi al tempo stesso, costituisce una contraddizione del movimento stesso del capitale. Esso abbisogna di maggiori masse di lavoratori di età giovanile, di masse minori di lavoratori in età virile. La contraddizione non è più stridente di quest’altra, che cioè in uno stesso periodo di tempo si lamenti la mancanza di braccia e molte migliaia si trovino sul lastrico, perché la divisione del lavoro li incatena a un determinato ramo d’industria. In queste condizioni l’aumento assoluto di questa frazione del proletariato richiede una forma che ingrossi il suo numero, benché i suoi elementi si consumino presto. Dunque si ha un rapido darsi il cambio delle generazioni lavoratrici. (La stessa legge non ha vigore per le altre classi della popolazione).
Non appena la produzione capitalistica si è impadronita dell’agricoltura ossia nel grado in cui se ne è impadronita, la domanda di popolazione lavoratrice agricola diminuisce in via assoluta mano a mano che vi aumenta il capitale in funzione, senza che la sua ripulsione, come anche nell’industria non agricola, venga integrata da una maggiore attrazione. Una parte della popolazione rurale si trova quindi costantemente sul punto di passare fra il proletariato urbano o il proletariato delle manifatture, e in agguato per acciuffare le circostanze favorevoli a questa trasformazione. Questa fonte della sovrapopolazione relativa fluisce dunque costantemente. Ma il suo costante flusso verso le città presuppone nelle stesse campagne una sovrapopolazione costantemente latente il cui volume si fa visibile solo nel momento in cui i canali di deflusso si schiudono in maniera eccezionalmente larga. Il lavoratore agricolo viene perciò depresso al minimo del salario e si trova sempre con un piede dentro la palude del pauperismo.
La terza categoria della sovrapopolazione relativa, quella stagnante, costituisce una parte dell’esercito dei lavoratori attivi, ma con un’occupazione assolutamente irregolare. Essa offre in tal modo al capitale un serbatoio inesauribile di forza-lavoro disponibile. Le sue condizioni di vita scendono al di sotto del livello medio normale della classe operaia, e proprio questo ne fa la larga base di particolari rami di sfruttamento del capitale. Le sue caratteristiche sono: massimo di tempo di lavoro e minimo di salario. (Abbiamo già fatto la conoscenza della sua forma principale nella rubrica del lavoro a domicilio). Essa prende le proprie reclute ininterrottamente fra i lavoratori in soprannumero della grande industria e della grande agricoltura, e specialmente anche fra quelli dei rami industriali in rovina dove l’esercizio artigianale soccombe alla manifattura e quest’ultima soccombe alle macchine. Il suo volume si estende allo stesso modo che con il volume e con l’energia dell’accumulazione; progredisce la “messa in soprannumero”. Ma essa costituisce allo stesso tempo un elemento della classe operaia che si riproduce e che si perpetua e che in proporzione partecipa all’aumento complessivo della classe operaia in misura maggiore che non gli altri suoi elementi.
Il sedimento più basso della sovrapopolazione relativa alberga infine nella sfera del pauperismo. Astrazione fatta da vagabondi, delinquenti, prostitute, in breve dal sottoproletariato, il pauperismo costituisce il ricovero degli invalidi dell’esercito dei lavoratori attivi e il peso morto dell’esercito industriale di riserva. La sua produzione è compresa nella produzione della sovrapopolazione relativa, la sua necessità nella necessità di questa; insieme a questa il pauperismo costituisce una condizione d’esistenza della produzione capitalistica e dello sviluppo della ricchezza. Esso rientra nei faux frais della produzione capitalistica, che il capitale sa però respingere in gran parte da sé addossandoli alla classe operaia e alla piccola classe media. Quanto più alta è la forza produttiva del lavoro, tanto più grande è la pressione dei lavoratori sui mezzi della loro occupazione e quindi tanto più precaria la loro condizione d’esistenza: vendita della propria forza per l’aumento della ricchezza altrui ossia per l’autovalorizzazione del capitale. Aumento dei mezzi di produzione e della produttività del lavoro più rapido di quello della popolazione produttiva si esprime quindi capitalisticamente, viceversa, nell’affermazione che la popolazione lavoratrice cresce sempre più rapidamente del bisogno di valorizzazione del capitale.
Abbiamo visto, in occasione dell’analisi della produzione del plusvalore relativo, che entro il sistema capitalistico tutti i metodi per incrementare la forza produttiva sociale del lavoro si attuano a spese del lavoratore. Ne consegue che nella misura in cui il capitale si accumula, la situazione del lavoratore, qualunque sia la sua retribuzione, alta o bassa, deve peggiorare. La legge infine, che equilibra costantemente sovrap-popolazione relativa, ossia l’esercito industriale di riserva, da una parte, e volume ed energia dell’accumulazione, dall’altra, determina una accumulazione di miseria proporzionata all’accumulazione di capitale. L’accumulazione di ricchezza all’uno dei poli è dunque al tempo stesso accumulazione di miseria, tormento di lavoro, schiavitù, ignoranza, brutalizzazione e degradazione morale al polo opposto ossia dalla parte della classe che produce il proprio prodotto come capitale. Questo carattere antagonistico dell’accumulazione capitalistica è espresso in forme diverse dagli economisti politici.
[C. I,23]
104

I.2.6. Il lavoro produttivo e il lavoro improduttivo
Il processo lavorativo è stato considerato in un primo tempo astrattamente, indipendentemente dalle sue forme storiche, come processo svolgentesi fra uomo e natura. Vi si diceva: “Se si considera l’intero processo lavorativo dal punto di vista del suo risultato, mezzo di lavoro e oggetto di lavoro si presentano entrambi come mezzi di produzione, e il lavoro stesso sì presenta come lavoro produttivo”. E si completava: “Questa definizione del lavoro produttivo, come risulta dal punto di vista del processo lavorativo semplice, non è affatto sufficiente per il processo di produzione capitalistico”. Ora dobbiamo svolgere ulteriormente questo argomento. Finché il processo lavorativo è mero processo individuale, lo stesso lavoratore riunisce in sé tutte le funzioni che più tardi si separano. Nell’appropriazione individuale di oggetti dati in natura per gli scopi della sua vita, il lavoratore controlla se stesso. Più tardi, egli viene controllato. L’uomo singolo non può operare sulla natura senza mettere in attività i propri muscoli, sotto il controllo del proprio cervello. Come nell’organismo naturale mente e braccio sono connessi, così il processo lavorativo riunisce lavoro intellettuale e lavoro manuale. Più tardi, questi si scindono fino all’antagonismo e all’ostilità. Il prodotto si trasforma in genere da prodotto immediato del produttore individuale in prodotto sociale, prodotto comune di un lavoratore complessivo, cioè di un personale combinato da lavoro, le cui membra hanno una parte più grande o più piccola nel maneggio dell’oggetto del lavoro. Quindi con il carattere cooperativo del processo lavorativo si amplia necessariamente il concetto del lavoro produttivo e del veicolo di esso, cioè del lavoratore produttivo. Ormai per lavorare produttivamente non è più necessario por mano personalmente al lavoro, è sufficiente essere organo del lavoratore complessivo e compiere una qualsiasi delle sue funzioni subordinate. La sopra citata definizione originaria del lavoro produttivo che è dedotta dalla natura della produzione materiale stessa, rimane sempre vera per il lavoratore complessivo, considerato nel suo complesso. Ma non vale più per ogni suo membro, singolarmente preso.
Ma dall’altra parte il concetto del lavoro produttivo si restringe. La produzione capitalistica non è soltanto produzione di merce, è essenzialmente produzione di plusvalore. Il lavoratore non produce per sé, ma per il capitale. Quindi non basta più che il lavoratore produca in genere. Deve produrre plusvalore. È produttivo solo quel lavoratore che produce plusvalore per il capitalista, ossia che serve all’autovalorizzazione del capitale. Se ci è permesso scegliere un esempio fuori della sfera della produzione materiale, un maestro di scuola è lavoratore produttivo se non si limita a lavorare le teste dei bambini, ma se si logora dal lavoro per arricchire l’imprenditore della scuola. Che questi abbia investito il suo denaro in una fabbrica d’istruzione invece che in una fabbrica di salsicce, non cambia nulla nella relazione. Il concetto di lavoratore produttivo non implica dunque affatto soltanto una relazione fra attività ed effetto utile, fra lavoratore e prodotto del lavoro, ma implica anche un rapporto di produzione specificamente sociale, di origine storica, che imprime al lavoratore il marchio di mezzo diretto di valorizzazione del capitale. Dunque, esser lavoratore produttivo non è una fortuna ma una disgrazia. [Nel quarto libro di quest’opera, che tratterà la storia della teoria, si vedrà più da vicino come l’economia politica classica abbia da sempre fatto della produzione di plusvalore la caratteristica decisiva del lavoratore produttivo. E quindi la sua definizione del lavoratore produttivo varia col variare della sua concezione della natura del plusvalore. Cosi i fisiocratici dichiarano che solo il lavoro agricolo è produttivo, perché esso soltanto fornisce un plusvalore].
Lavoro produttivo – nel sistema della produzione capitalistica – è dunque il lavoro che produce plusvalore per il suo employer, ossia quello che trasforma le condizioni oggettive di lavoro in capitale e il proprietario di esse in un capitalista, quindi il lavoro che produce il suo proprio prodotto come capitale. Dunque, quando parliamo di lavoro produttivo, parliamo di lavoro socialmente determinato, di lavoro che implica un rapporto del tutto determinato tra compratore e venditore del suo lavoro. È insomma produttivo soltanto il lavoro che pone il capitale variabile come variabile e quindi pone il capitale totale come C+ΔC=C+Δv; il lavoro che serve direttamente al capitale come agente della sua autovalorizzazione, come mezzo alla produzione di plusvalore. Il processo lavorativo capitalistico non sopprime le caratteristiche generali del processo lavorativo. Esso produce prodotto e merce. In questi limiti, resta produttivo il lavoro che si oggettiva in merci come unità di valore d’uso e di valore di scambio. Ma il processo lavorativo è soltanto un mezzo per il processo di valorizzazione del capitale e, sotto questo profilo, è produttivo il lavoro che si cristallizza bensì in merci ma che, ove si consideri la singola merce, rappresenta in una quota parte di quest’ultima o, se consideriamo il prodotto totale, rappresenta in una quota parte della massa totale di merci, un lavoro non pagato; quindi, un prodotto che non costa nulla al capitalista. Solo l’angusto orizzonte mentale borghese, che nella produzione capitalistica vede la forma assoluta della produzione, la sua unica forma naturale, può confondere il problema di che cosa siano, dal punto di vista del capitale, lavoro produttivo e lavoratore produttivo con la questione di che cosa sia lavoro produttivo in generale, e quindi appagarsi della risposta tautologica che è produttivo ogni lavoro il quale in genere produca, cioè metta capo, a un prodotto, a un valore d’uso qualsivoglia, a un risultato in generale.
105

È produttivo soltanto il lavoratore il cui processo lavorativo equivale al processo di consumo produttivo della forza-lavoro – del depositario di questo lavoro – da parte del capitale o del capitalista. Poiché, con lo sviluppo della sottomissione reale del lavoro al capitale e quindi del modo di produzione specificamente capitalistico, il vero funzionario del processo lavorativo totale non è il singolo lavoratore, ma una forza-lavoro sempre più socialmente combinata: le diverse forze-lavoro cooperanti, che formano la macchina produttiva totale, partecipano in modo diverso al processo immediato di produzione delle merci o meglio, qui, dei prodotti – chi lavorando piuttosto con la mano e chi piuttosto con il cervello, chi come direttore, ingegnere, tecnico ecc., chi come sorvegliante, chi come manovale, ecc. Nello scambio tra capitale e lavoro, come abbiamo visto analizzando il processo di produzione, bisogna distinguere due momenti che sono sostanzialmente differenti, sebbene si condizionino reciprocamente. In primo luogo: il primo scambio tra capitale e lavoro è un processo formale in cui il capitale figura come denaro e la capacità lavorativa come merce. In secondo luogo: il secondo momento dello scambio tra capitale e lavoro non ha in realtà niente a che fare col primo, in senso stretto non è neppure uno scambio. Si verificano due specie di scambio tra lavoro e capitale. Il primo scambio esprime semplicemente l’acquisto della capacità lavorativa e perciò del lavoro e quindi del prodotto di questo, mentre il secondo scambio esprime la diretta trasformazione di lavoro vivo in capitale, ossia la sua oggettivazione come attuazione del capitale.
Lo scambio immediato di lavoro contro capitale significa qui: 1. la trasformazione immediata del lavoro in capitale, in una componente oggettiva del capitale nel processo di produzione; 2. lo scambio di una determinata quantità di lavoro oggettivato contro la stessa quantità di lavoro vivo, più una quantità eccedente di lavoro vivo di cui ci si appropria senza scambio. L’affermazione che il lavoro produttivo è quel lavoro che si scambia immediatamente con capitale abbraccia tutti questi momenti, non è che una formula derivata per dire che esso è il lavoro che trasforma il denaro in capitale, il lavoro che si scambia con le condizioni di produzione in quanto sono capitale, che quindi non sta affatto in rapporto con queste in quanto semplici condizioni di produzione, che non sta in rapporto con le condizioni di produzione come lavoro puro e semplice, senza una specifica determinatezza sociale. Ciò implica: 1. il rapporto reciproco tra denaro e capacità lavorativa in quanto merci, la compra e la vendita tra il possessore del denaro e il possessore della capacità lavorativa; 2. la sussunzione diretta del lavoro sotto il capitale; 3. la reale trasformazione del lavoro in capitale nel processo di produzione, o, che è lo stesso, la creazione del plusvalore per il capitale. Il risultato del processo di produzione capitalistico non è né un semplice prodotto (valore d’uso) né merce, cioè valore d’uso che ha un determinato valore di scambio. Il suo risultato, il suo prodotto, è la creazione del plusvalore per il capitale, e perciò l’effettiva trasformazione di denaro o merce in capitale. Quando lo scambio del denaro col lavoro avviene direttamente, senza che quest’ultimo produca capitale, dunque quando il lavoro non è lavoro produttivo, esso viene comprato come servizio; questo termine, servizio, non è in generale altro che un’espressione per indicare il valore d’uso particolare che il lavoro fornisce. Lavoro produttivo è soltanto un’abbreviazione per indicare l’intero rapporto e modo in cui, nel processo di produzione capitalistico, la forza-lavoro e lo stesso lavoro si presentano. Da quanto abbiamo detto fin qui, risulta che il fatto d’essere produttivo è una determinazione del lavoro che non ha assolutamente nulla a che vedere, in sé e per sé, col particolare contenuto, con la particolare utilità del lavoro stesso, o con il particolare valore d’uso in cui questo si rappresenta. Ne segue che un lavoro dello stesso contenuto può essere nello stesso tempo produttivo e improduttivo.
Uno stesso lavoro (per esempio, quello del giardiniere, del sarto, ecc.) può essere eseguito da un medesimo lavoratore per conto o di un capitalista industriale o di un consumatore immediato. In entrambi i casi quel lavoratore è un salariato o giornaliero; ma, nel primo, è un lavoratore produttivo e nel secondo un lavoratore improduttivo, perché in quello produce capitale e in questo no; perché in quello il suo lavoro costituisce un elemento del processo di autovalorizzazione del capitale e in questo no. Una gran parte del prodotto annuo che viene consumato come reddito e non rientra più nel processo produttivo come mezzo di produzione, è composta dei prodotti (valori d’uso) più nefasti, che soddisfano le voglie, i capricci ecc. più meschini. Ma, per la definizione di lavoro produttivo, questo loro contenuto è del tutto indifferente (sebbene, come è naturale, se una parte sproporzionata fosse cosi riprodotta invece di essere ritrasformata in mezzi di produzione e mezzi di sussistenza che entrano di nuovo nella riproduzione sia delle merci che della stessa forza-lavoro – insomma, che vengono consumati produttivamente – lo sviluppo della ricchezza subirebbe un colpo d’arresto). Questo genere di lavoro produttivo crea valori d’uso, si cristallizza in prodotti, unicamente destinati a consumo improduttivo, e sprovvisti nella loro realtà, come articoli, di qualunque valore d’uso per il processo di riproduzione.
L’economia politica corrente è incapace di dire una parola sensata, dal punto di vista della produzione capitalistica, sui limiti della produzione di lusso. La cosa diventa però estremamente semplice se si analizzano in modo corretto gli elementi del processo di riproduzione. Se questo – o il suo progresso in quanto determinato dallo stesso incremento naturale della popolazione – trova un freno nell’impiego sproporzionato di un lavoro produttivo che si traduce in articoli non-riproduttivi, ne deriva una riproduzione
106

insufficiente dei mezzi di sussistenza o dei mezzi di produzione necessari; allora, dal punto di vista della produzione capitalistica, il lusso è condannabile. D’altra parte, per un modo di produzione il quale crea la ricchezza per i non-produttori e quindi deve darle delle forme che ne permettano l’appropriazione da parte della ricchezza dedita soltanto al godimento, il lusso è una necessità assoluta. Per il lavoratore, questo lavoro produttivo non è che un mezzo per la riproduzione dei mezzi di sussistenza necessari; per il capitalista, al quale la natura del valore d’uso e il carattere del lavoro concreto utilizzato sono, in sé e per sé, del tutto indifferenti, non è che un mezzo per far quattrini (un moyen de battre monnaie), per produrre plusvalore (de produire la survalue). In che modo sia regolato il valore di questi servizi, e in che modo questo stesso valore sia determinato dalle leggi del salario, è una questione che non ha niente a che fare con l’indagine sul rapporto di cui ci stiamo occupando, ma che appartiene al capitolo sul salario. Abbiamo visto che non è il semplice scambio tra denaro e lavoro che trasforma quest’ultimo in lavoro produttivo, e che d’altra parte il contenuto di questo lavoro è in un primo tempo indifferente. Un lavoratore può essere lavoratore salariato, giornaliero, ecc. e tuttavia mancare l’altro termine del rapporto. Ogni lavoratore produttivo è salariato, ma non per questo ogni salariato è lavoratore produttivo. Se il lavoro è comperato per consumarlo in quanto valore d’uso, in quanto servizio, anziché per sostituirlo come fattore vivente al valore del capitale variabile e incorporarlo al processo di produzione capitalistico, il lavoro non è lavoro produttivo e il salariato non è lavoratore produttivo. In questo caso, il lavoro è consumato per il suo valore d’uso, non in quanto pone valore di scambio; è consumato in modo improduttivo, non in modo produttivo; quindi il capitalista non gli sta di fronte come capitalista, come rappresentante del capitale, perché scambia con lavoro il suo denaro non come capitale, ma come reddito.
Questo fatto, che cioè con lo sviluppo della produzione capitalistica tutti i servizi si trasformino in lavoro salariato e tutti coloro che li eseguiscono in lavoratori salariati, avendo questo carattere in comune col lavoratore produttivo, induce a confondere i due termini tanto più in quanto è un fenomeno che caratterizza la produzione capitalistica e ne è generato, mentre permette ai suoi apologeti di presentare il lavoratore produttivo, perché salariato, come un lavoratore che si limita a scambiare i suoi servizi (il suo lavoro come valore d’uso) contro denaro, sorvolando bellamente sulla differenza specifica di tale “lavoratore produttivo” e della produzione capitalistica come produzione di plusvalore, come processo di autovalorizzazione del capitale, di cui il lavoro vivo non è che l’agente e in cui è incorporato. Un soldato è un salariato, e infatti riceve un “soldo”; ma non per questo è un lavoratore produttivo! Appunto perché in questa compera di servizi non è affatto contenuto lo specifico rapporto tra lavoro e capitale, o perché totalmente cancellato o perché del tutto inesistente, è naturale che essa sia la forma prediletta da Say, Bastiat e consorti per esprimere il rapporto fra capitale e lavoro. Anche il lavoratore acquista con denaro dei servizi; un modo di spendere il proprio denaro, non di trasformarlo in capitale. Nessuno acquista “prestazioni” mediche o legali come mezzo alla trasformazione del denaro così speso in capitale. Numerosi servizi entrano nei costi di consumo delle merci: per esempio, il servizio della cuoca ecc. La differenza fra lavoro improduttivo e lavoro produttivo si riduce a questo: che il lavoro sia scambiato contro denaro come denaro o contro denaro come capitale. Là dove, come nella bottega artigiana del lavoratore imprenditore di se stesso, io compero la sua merce, questa categoria non è in questione perché non v’è scambio diretto fra denaro e lavoro di qualsivoglia specie, ma fra denaro e merce.
La differenza fra lavoro produttivo e improduttivo è importante per riguardo all’accumulazione, perché solo lo scambio contro lavoro produttivo è una delle condizioni della ritrasformazione del plusvalore in capitale. Il capitalista come rappresentante del capitale produttivo, del capitale impegnato nel processo della sua valorizzazione, assolve una funzione produttiva che consiste appunto nel dirigere e sfruttare lavoro produttivo. Contrariamente ai co-divoratori di plusvalore, che non si trovano in un tale rapporto immediato e attivo con la produzione di questo, la sua classe appare la classe produttiva per eccellenza. (Come direttore del processo lavorativo, il capitalista può eseguire del lavoro produttivo nel senso che il suo lavoro è incluso nel processo lavorativo totale incorporantesi nel prodotto). La determinazione dal lavoro produttivo (e quindi anche del lavoro improduttivo come il suo contrario) poggia dunque sul fatto che la produzione capitalistica è produzione di plusvalore e il lavoro da essa impiegato è lavoro che produce plusvalore. Un paese, restando invariata la quantità dei prodotti, è tanto più ricco quanto meno numerosa, più scarsa, è la sua popolazione produttiva in rapporto alla popolazione improduttiva e al prodotto complessivo; poiché anzi la scarsità relativa della popolazione produttiva non sarebbe che un modo diverso per esprimere il grado relativo della produttività del lavoro. Proprio come per il singolo capitalista: quanto minore è il numero dei lavoratori di cui ha bisogno per produrre lo stesso surplus, tant mieux per lui.
Da un lato, la tendenza del capitale è quella di ridurre a un minimo sempre decrescente il tempo di lavoro necessario alla produzione della merce, quindi anche la quantità della popolazione produttiva in rapporto alla massa del prodotto. Dall’altro lato però la sua tendenza è invece quella di accumulare, di convertire profitto in capitale, di appropriarsi della maggior quantità possibile di lavoro altrui. Il capitale cerca di abbassare il saggio del lavoro necessario, ma cerca di impiegare, al saggio dato, la più grande quantità possibile di lavoro
107

produttivo. Il rapporto tra prodotti e popolazione è in ciò indifferente. La maggior parte degli scrittori che hanno combattuto contro la concezione smithiana del lavoro produttivo e improduttivo considerano il consumo come stimolo necessario della produzione, e perciò i salariati che vengono mantenuti col reddito, i lavoratori improduttivi, l’acquisto dei quali non produce ricchezza ma invece rappresenta esso stesso un ulteriore consumo della ricchezza, sono secondo loro altrettanto produttivi, anche in rapporto alla ricchezza materiale, quanto i lavoratori produttivi, poiché allargano il campo del consumo materiale e con ciò il campo della produzione. Questa dunque era essenzialmente un’apologia, dal punto di vista dell’economia politica borghese, in parte dei ricchi oziosi e dei lavoratori improduttivi i cui servizi vengono consumati dagli oziosi, in parte dei governi forti che fanno grandi spese, un’apologia dell’accrescimento del debito pubblico, delle prebende ecclesiastiche e statali, dei sinecuristi ecc.
È caratteristico il fatto che tutti gli economisti “improduttivi”, che nella loro disciplina non riescono a cavare un ragno da un buco, prendano posizione contro la distinzione tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo. Ma di fronte al borghese, ciò esprime, da un lato, il servilismo che consiste nel rappresentare tutte le funzioni come se fossero al servizio della produzione della ricchezza per lui; poi esprime, dall’altro lato, la tesi che il mondo borghese è il migliore di tutti i mondi possibili, che in esso tutto è utile, e che il borghese stesso è tanto cólto da riuscire a capirlo. A ciò si aggiunge lo zelo con cui questi economisti, che sono essi stessi preti, professori, ecc., cercano di dimostrare la loro utilità “produttiva”, di giustificare “economicamente” i loro salari.
[C. I,14; VI. I,14; TP. I, APP.]
I.2.7. Le “false spese” di produzione (costi di circolazione)
Nel modo di produzione capitalistico il contadino indipendente, o l’artigiano, viene diviso in due persone. In quanto possessore dei mezzi di produzione egli è capitalista, in quanto lavoratore egli è salariato di se stesso. In quanto capitalista egli paga quindi a se stesso il suo salario, e ritrae il suo profitto dal suo capitale, cioè egli sfrutta se stesso come salariato e si paga nel plusvalore (surplus value) il tributo che il lavoro deve al capitale proprio. Nella produzione capitalistica, la determinatezza sociale economica dei mezzi di produzione – il fatto che essi esprimono un determinato rapporto di produzione – si è talmente sviluppata insieme all’esistenza materiale di questi mezzi di produzione in quanto mezzi di produzione, e ne è cosi inseparabile nel modo di pensare della società borghese, che quella determinatezza (determinatezza categorica) si applica anche nel caso in cui il rapporto sia direttamente in contraddizione con essa. I mezzi di produzione diventano capitale solo in quanto essi, come potenza indipendente, sono divenuti indipendenti nei confronti del lavoro. Nel caso in questione il produttore – il lavoratore – è possessore, proprietario dei suoi mezzi di produzione. Quindi essi non sono capitale, cosi come egli non è, di fronte ad essi, lavoratore salariato. Ciononostante essi vengono considerati come capitale, ed egli stesso è diviso in due, cosicché egli, in quanto capitalista, impiega se stesso in quanto salariato. Qui, in genere, non ci si allontana dalle forme di transizione verso la produzione capitalistica, come se i diversi produttori scientifici o artistici, artigiani o professionisti, lavorino per un capitale commerciale comune; anche questo è un rapporto che non ha niente a che fare col modo di produzione capitalistico vero e proprio, e che non è stato sussunto sotto di esso neppure formalmente. Il fatto che in queste forme di transizione lo sfruttamento del lavoro sia spinto proprio al massimo non cambia niente alla cosa.
È appunto l’elemento caratteristico del modo di produzione capitalistico, quello di separare i diversi lavori, quindi anche i lavori intellettuali e manuali – ossia i lavori nei quali prevale l’uno o l’altro aspetto – e di ripartirli tra diverse persone; e ciò tuttavia non impedisce al prodotto materiale di essere il prodotto comune di queste persone, o di oggettivare il loro prodotto comune in ricchezza materiale, e ciò d’altra parte non impedisce nemmeno, ovvero non cambia per niente i termini della questione, che il rapporto in cui si trova ognuna di queste persone presa singolarmente, sia quello del salariato rispetto al capitale. Il loro lavoro consta di lavoro pagato più pluslavoro non pagato. Numerose funzioni e attività che un tempo erano circondate da un alone sacro e ritenute come fini in sé, che erano esercitate gratuitamente o remunerate in via indiretta (come tutti i professionisti, medici, avvocati ecc. in Inghilterra, dove l’avvocato e il medico non potevano e non possono intentare causa per farsi pagare dai clienti), si trasformano da una parte in lavoro salariato, per quanto diversi ne siano il contenuto e la remunerazione, dall’altro cadono – per il calcolo del loro valore, del prezzo delle diverse prestazioni, dalla prostituta al re – sotto l’impero delle leggi che regolano il prezzo del lavoro salariato.
Alla grande massa dei cosiddetti lavoratori “superiori” – come i funzionari statali, i militari, gli artisti, i medici, i preti, i magistrati, gli avvocati, ecc. – alcuni dei quali non solo non sono produttivi, ma sono sostanzialmente distruttivi, però sanno come appropriarsi di una grandissima parte della ricchezza “materiale“, un po’ vendendo le loro merci “immateriali”, un po’ imponendole con la forza, a costoro non era
108

affatto gradito di essere relegati, dal punto di vista economico, nella stessa classe dei buffoni e dei domestici, e di apparire, rispetto ai produttori veri e propri (o piuttosto agenti della produzione), come semplici consumatori, come parassiti. Ciò era una singolare profanazione proprio di quelle funzioni che erano state fino ad allora circondate da un’aureola e avevano goduto di una venerazione superstiziosa. L’economia politica, nel suo periodo classico, esattamente come la stessa borghesia nel primo periodo del suo affermarsi, assume un atteggiamento severo e critico nei confronti della macchina statale ecc. In seguito essa comprende – ciò appare anche nella pratica – e impara dalla esperienza, che la necessità della combinazione sociale, ereditata dal passato, di tutte queste classi, in parte completamente improduttive, deriva dalla sua propria organizzazione. In quanto quei “lavoratori improduttivi” non procurano godimenti e il loro acquisto dipende interamente dal modo in cui l’agente della produzione vuole spendere il suo salario o il suo profitto – in quanto anzi divengono necessari o perfino si rendono necessari, sia per le infermità fisiche (come i medici), sia per le debolezze spirituali (come i preti), sia per il conflitto tra gli interessi privati e gli interessi nazionali (come gli impiegati dello stato, tutti i legali, i poliziotti, i soldati), essi appaiono ad Adam Smith, come allo stesso capitalista industriale e alla classe operaia, come faux frais de production, che devono essere ridotti il più possibile al minimo indispensabile, e prodotti al minimo prezzo possibile.
La società borghese produce di nuovo, nella sua propria forma, tutto ciò che essa aveva combattuto nella forma feudale o assolutistica. Un compito fondamentale dei sicofanti di questa società, specialmente dei ceti superiori, è quindi, in primo luogo, quello di riabilitare teoricamente perfino la parte puramente parassitaria di questi “lavoratori improduttivi”, o anche di legittimare le pretese eccessive di quella parte di essi di cui non si può fare a meno. In realtà fu proclamata la dipendenza delle classi ideologiche ecc. dai capitalisti. Era dunque tempo di fare un compromesso e di riconoscere la “produttività” di tutte le classi che non rientrano direttamente fra gli agenti della produzione materiale. Una mano lava l’altra e bisognava dimostrare che anche dal punto di vista “produttivo”, economico, il mondo borghese, con tutti i “lavoratori improduttivi”, è il migliore di tutti i mondi; tanto più che i “lavoratori improduttivi”, dal canto loro, si abbandonavano a riflessioni critiche sulla produttività delle classi che, in generale, sono “fruges consumere nati” [Orazio: “nate per consumare i frutti della terra”] – o anche su quegli agenti della produzione, come i proprietari fondiari, che non fanno assolutamente niente, ecc. Tanto i fannulloni quanto i loro parassiti dovevano trovare il loro posto nel miglior ordinamento possibile del mondo.
Ogni servizio è produttivo per il suo venditore. Giurare il falso è produttivo per chi lo fa in cambio di quattrini sonanti. Falsificare documenti è produttivo per chi ne ritrae un guadagno. Uccidere qualcuno è produttivo per colui che si fa pagare l’omicidio. Il mestiere del sicofante, del delatore, dello scroccone, del parassita, dell’adulatore, è produttivo per chi non presta tali “services” gratuitamente. Dunque essi sono “lavoratori produttivi”, produttori non solo di ricchezza ma anche di capitale. Anche il furfante che si paga da sé, proprio come fanno i tribunali e lo stato, “impiega una forza, [...] la usa in un determinato modo, [...] produce un risultato che soddisfa un bisogno dell’uomo”, cioè dell’uomo ladro (homme voleur), e forse anche della sua moglie e dei suoi bambini. Egli è dunque un lavoratore produttivo, se ciò dipende semplicemente dal fatto di produrre un “risultato” che soddisfi un “bisogno”, oppure, come nei casi precedenti, se ciò dipende dal fatto che i suoi “servizi”, per essere “produttivi “, debbono essere da lui venduti. Mentre il dominio del capitale si estendeva, e in realtà anche le sfere di produzione che non riguardano direttamente la creazione della ricchezza materiale divenivano sempre più strettamente subordinate ad esso – specialmente le scienze positive (le scienze naturali) venivano assoggettate in quanto mezzi della produzione materiale – i subalterni [underlings] e i sicofanti dell’economia politica si credettero in dovere di esaltare e di giustificare ogni sfera di attività, rappresentandola “in connessione” con la produzione della ricchezza materiale – come un mezzo per questa – e onorarono ogni uomo facendone un “lavoratore produttivo” nel “primo” senso, cioè un lavoratore che lavora al servizio del capitale, che in un modo o nell’altro è utile a questo per il suo arricchimento, ecc. Se il signor échange, invece del domestico, volesse mantenersi un’amante, poiché il suo lavoro improduttivo frutta all’amante un valore di scambio, una retribuzione venti volte maggiore del salario dei lavoratori produttivi, questa persona contribuisce à la production des richesses in misura venti volte maggiore e un paese produce una ricchezza tanto maggiore quanto più alta è la retribuzione dei suoi domestici e delle sue amanti. Il signor Ganilh dimentica che solo la produttività del lavoro agricolo e manifatturiero, che solo l’eccedenza creata dai lavoratori produttivi, ma non pagata ad essi, fornisce in generale un fondo con cui vengono pagati i lavoratori improduttivi.
I mutamenti di forma del capitale da merce in denaro e da denaro in merce sono in pari tempo operazioni commerciali del capitalista, atti di compera e di vendita. Il tempo in cui si compiono questi mutamenti di forma del capitale è soggettivamente, dal punto di vista del capitalista, tempo di vendita e tempo di compera, il tempo durante il quale egli opera sul mercato come venditore e come compratore. Il mutamento di stato costa tempo e forza-lavoro, ma non per creare valore, bensì per produrre la conversione del valore da una forma nell’altra, e a questo riguardo il reciproco tentativo di appropriarsi, in questa occasione, una quantità eccedente di valore, non cambia nulla. Questo lavoro, ingrandito dalle maligne intenzioni di ambo le parti,
109

non crea alcun valore, come non aumenta la grandezza di valore dell’oggetto conteso il lavoro che si svolge in un processo giudiziario. Questo lavoro è un momento necessario del processo capitalistico di produzione nella sua totalità, in cui esso comprende anche la circolazione, o è da essa compreso.
Le dimensioni che assume la conversione delle merci nelle mani dei capitalisti, non possono naturalmente trasformare in creatore di valore questo lavoro che non crea alcun valore ma unicamente media un mutamento di forma del valore. Così pure il miracolo di questa transustanziazione non può avvenire per una trasposizione, cioè per il fatto che i capitalisti industriali, anziché compiere essi stessi quel lavoro ne fanno l’affare esclusivo di terze persone da essi pagate. Naturalmente, queste terze persone non metteranno a loro disposizione la propria forza-lavoro per amore dei loro beaux yeux. Comunque, il tempo di compera e di vendita non crea alcun valore. Subentra un’illusione in virtù della funzione del capitale commerciale. Ma, senza qui entrare più oltre nel merito, già dal principio è chiaro che: se mediante la divisione del lavoro una funzione che in sé e per sé è improduttiva ma è un momento necessario della riproduzione, viene trasformata da un’occupazione accessoria di molti nell’occupazione esclusiva di pochi, nel loro affare particolare, non per questo si trasforma il carattere della funzione stessa.
Supponiamo che questo agente per la compera e per la vendita sia un uomo che vende il proprio lavoro. Egli stesso appartiene ai faux frais della produzione. La sua utilità non consiste nel trasformare in produttiva una funzione improduttiva, ovvero in produttivo un lavoro improduttivo. Sarebbe un miracolo, se una simile trasformazione potesse venir effettuata mediante un siffatto trasferimento della funzione. La sua utilità consiste invece in ciò, che in questa funzione improduttiva viene impegnata una parte minore della forza-lavoro e del tempo di lavoro della società. Di più. Supponiamo che egli sia un semplice lavoratore salariato, sia pure pagato meglio. Qualunque sia la sua remunerazione, in quanto lavoratore salariato egli lavora una parte del suo tempo gratuitamente. Egli riceve giornalmente, poniamo, il prodotto di valore di otto ore di lavoro e opera durante dieci ore. La società non paga alcun, equivalente per un quinto di questo tempo attivo di circolazione di cui egli è agente. Ma se è il capitalista a impiegare questo agente, per il non-pagamento delle due ore diminuiscono i costi di circolazione del suo capitale, che costituiscono una sottrazione dalle sue entrate. Per lui questo è un guadagno positivo, perché il limite negativo della valorizzazione del suo capitale si restringe.
In qualsiasi circostanza, il tempo impiegato a tal fine è un costo dì circolazione che non apporta nulla ai valori scambiati. È il costo richiesto per tradurli da forma di merce in forma di denaro. In quanto il produttore capitalistico di merci appare come agente della circolazione, si distingue dal diretto produttore di merci solo perché egli vende e compra su scala più vasta e perciò opera da agente della circolazione in un’estensione più grande. Quando poi l’estensione del suo affare gli impone o lo mette in grado di comprare (assoldare) come lavoratori salariati propri agenti della circolazione, sostanzialmente il fenomeno ... non è mutato. Forza-lavoro e tempo di lavoro devono essere spesi in certo grado nel processo di circolazione (in quanto esso è puro e semplice mutamento di forma). Ma ciò appare ora come esborso supplementare di capitale; una parte del capitale variabile deve essere sborsata nell’acquisto di queste forze-lavoro che operano solo nella circolazione. Questo anticipo di capitale non crea prodotto né valore. Esso diminuisce pro tanto l’estensione in cui il capitale anticipato opera produttivamente. Oltre al vero e proprio comperare e vendere, tempo di lavoro viene speso nella contabilità, nello quale entra inoltre lavoro oggettivato, penna, inchiostro, carta, scrittoio, spese d’ufficio. Dunque, in questa funzione da una parte viene spesa forza-lavoro, dall’altra, mezzi di lavoro. Avviene qui proprio come per il tempo di compera e di vendita. La contabilità, come controllo e sintesi ideale del processo diviene tanto più necessaria quanto più il processo si svolge su scala sociale e perde il carattere puramente individuale; dunque più necessaria nella produzione capitalistica che non in quella sminuzzala dell’impresa artigiana e contadina, più necessaria nella produzione collettiva che non in quella capitalistica. Tuttavia i costi della contabilità si riducono con la concentrazione della produzione, e quanto più essa si trasforma in contabilità sociale.
Si tratta qui soltanto del carattere generale dei costi di circolazione, che scaturiscono dalla semplice metamorfosi delle forme, È superfluo entrare qui in tutte le loro forme particolari. Come, però, funzioni appartenenti al puro mutamento di forma del valore, quindi scaturienti dalla determinata forma sociale del processo di produzione, le quali per il produttore individuale di merci sono soltanto elementi effimeri e appena percettibili, scorrano accanto alle sue funzioni produttive o si intreccino con esse, come possano balzare agli occhi, in quanto massicci costi di circolazione, lo si vede nella semplice riscossione e spesa di denaro, non appena queste, in quanto funzioni esclusive di banche ecc., o del cassiere nelle imprese individuali, vengono autonomizzate e concentrate su vasta scala. Ciò che è da tener fermo, è che questi costi di circolazione non mutano il loro carattere per la mutata forma. Costi dunque che rincarano la merce, senza aggiungerle valore d’uso, che per la società appartengono dunque ai faux frais della produzione, per il capitalista individuale possono costituire fonte di arricchimento. D’altra parte, in quanto l’aggiunta che essi apportano al prezzo della merce non fa che suddividere in modo eguale questi costi di circolazione, non cessa con questa il loro carattere improduttivo.
110

Con lo sviluppo della produzione capitalistica la scala della produzione viene determinata in grado sempre minore dalla immediata domanda del prodotto e in grado sempre maggiore dal volume del capitale di cui dispone il capitalista individuale, dall’impulso di valorizzazione del suo capitale e dalla necessità della continuità e dell’ampliamento del suo processo di produzione. Con ciò cresce necessariamente in ogni particolare ramo di produzione la massa del prodotto che si trova sul mercato come merce, o cerca uno smercio. Cresce la massa di capitale fissata più o meno a lungo nella forma di capitale-merce. Cresce perciò la scorta di merce. Infine, la parte maggiore della società si trasforma in lavoratori salariati, gente che deve vivere alla giornata, ricevere settimanalmente e spendere quotidianamente il suo salario, che deve dunque trovare presenti i propri mezzi di sussistenza come scorta. Per quanto i singoli elementi di questa scorta possano fluire, una parte di essi deve costantemente arrestarsi affinché la scorta possa mantenere sempre il suo flusso. Tutti questi momenti provengono dalla forma della produzione e dal mutamento di forma in essa contenuto, che il prodotto deve percorrere nel processo di circolazione. Qualunque sia la forma sociale della scorta di prodotti, la sua conservazione richiede spese. Sono i costi di conservazione del prodotto sociale, sia che la sua esistenza, in quanto elemento della scorta di merce, scaturisca soltanto dalla forma sociale della produzione, cioè dalla forma di merce, e dal suo necessario mutamento di forma, sia che si consideri la scorta dì merce solo come una forma speciale della scorta di prodotti, che è comune a tutte le società, anche se non nella forma di scorte di merce, in questa forma della scorta di prodotti appartenente al processo di circolazione.
Ci si domanda ora fino a che punto questi costi entrino nel valore delle merci. La legge generale è che tutti i costi di circolazione che scaturiscono solo dal mutamento di forma della merce non aggiungono valore a quest’ultima. Sono puri e semplici costi per il realizzo del valore o per la sua trasposizione da una forma nell’altra. Il capitale sborsato in questi costi (compreso il lavoro da esso comandato) appartiene ai faux frais dello produzione capitalistica. La sostituzione di essi deve avvenire mediante il plusprodotto e costituisce, dal punto di vista dell’intera classe capitalistica, una sottrazione di plusvalore o di plusprodotto, così come per un lavoratore è perduto il tempo di cui ha bisogno per acquistare i suoi mezzi di sussistenza. Qualunque possa essere la natura di queste spese di circolazione – che esse siano inerenti alla pura attività commerciale in quanto tale, ed appartengano quindi allo spese specifiche di circolazione del commerciante, o rappresentino somme che provengono dai processi di produzione complementari che intervengono nel processo della circolazione, come spedizione, trasporto, magazzinaggio ecc. – esse presuppongono sempre, da parte del commerciante oltre al capitale monetario anticipato nell’acquisto delle merci, un capitale supplementare anticipato nell’acquisto e nel pagamento di questi mezzi di circolazione. Nella misura in cui questo elemento di costo si compone di capitale circolante, esso entra interamente come elemento addizionale nel prezzo di vendita delle merci, nella misura in cui si compone di capitale fisso vi entra proporzionalmente al suo logorìo; ma come un elemento che costituisce un valore nominale, anche se esso non costituisce alcuna effettiva aggiunta di valore alla merce, come ad es. le spese puramente commerciali della circolazione. Che esso sia circolante o fisso, tutto questo capitale supplementare entra nella formazione del tasso generale del profitto.
Lo spese di circolazione puramente commerciali (quindi esclusione fatta dello spese di spedizione, trasporto, magazzinaggio, ecc.) si risolvono nelle spese che sono necessarie per realizzare il valore delle merci, per trasformarlo da merci in denaro o da denaro in merci, per effettuare lo scambio. Tutte queste spese non vengono fatte nella produzione del valore d’uso delle merci, ma nella realizzazione del loro valore: esse sono pure spese di circolazione. Esse non rientrano, nel processo di produzione immediato, ma nel processo di circolazione, quindi nel processo complessivo di riproduzione. La sola parte di queste spese che ci interessa qui, è quella anticipata sotto forma di capitale variabile. Queste spese provengono dalla forma economica del prodotto in quanto merce. Se il tempo di lavoro che i capitalisti industriali stessi pèrdono vendendosi fra di loro le loro merci – ossia obiettivamente parlando, il tempo di circolazione delle merci – non aggiunge assolutamente valore alcuno a queste merci, è evidente che questo tempo di lavoro non muta di carattere per il fatto che esso viene a gravare sul commerciante invece che sul capitalista industriale. La trasformazione della merce (prodotto) in denaro e del denaro in merce (mezzi di produzione) è una funzione necessaria del capitale industriale e quindi una operazione necessaria del capitalista, che in realtà non è altro che il capitale personificato, dotato di coscienza e di volontà. Ma queste funzioni né accrescono il valore, né generano del plusvalore. Il commerciante, in quanto compie queste operazioni o assicura la continuità delle funzioni del capitale nella sfera della circolazione, dopo che il capitalista produttivo ha cessato di farlo, prende semplicemente il posto del capitalista industriale. Il tempo di lavoro che queste operazioni richiedono, viene impiegalo in operazioni necessarie nel processo di riproduzione del capitale, ma non aggiunge valore alcuno.
Sì pone ora la questione: come stanno le cose per il salariato commerciale impiegato dal capitalista commerciale, qui il commerciante di merci? Da un lato un tale lavoratore commerciale è un salariato come qualsiasi altro. Innanzitutto in quanto il lavoro viene comperato dal capitale variabile del commerciante, non
111

dal denaro speso come reddito e quindi non per servizio privato, ma al fine dell’autovalorizzazione del capitale per ciò anticipato. In secondo luogo in quanto il valore della sua forza-lavoro e quindi il suo salario è determinato, come per tutti gli altri lavoratori salariati, dalle spese di produzione e di riproduzione della sua forza-lavoro specifica, non dal prodotto del suo lavoro. Ma fra lui e il lavoratore direttamente impiegato dal capitale industriale vi deve essere la medesima differenza che sussiste fra il capitale industriale ed il capitale commerciale e quindi fra il capitalista industriale ed il commerciante. Il commerciante, come semplice agente della circolazione, non producendo né valore né plusvalore, neppure i lavoratori commerciali da lui occupati nelle medesime funzioni possono produrre per lui del plusvalore immediato. Qui noi supponiamo, come abbiamo fatto per i lavoratori produttivi, che il salario sia determinato dal valore della forza-lavoro, che il commerciante quindi non si arricchisca con una ritenuta sul salario, cosicché egli non porti nel suo calcolo delle spese un’esborso per lavoro che egli ha pagato solo in parte, in altre parole che egli non si arricchisca defraudando i suoi commessi, ecc. Ciò che crea delle difficoltà riguardo ai lavoratori commerciali non è certamente lo spiegare come essi producano direttamente del profitto per il loro padrone, pur non producendo direttamente del plusvalore (di cui il profitto rappresenta una semplice variazione di forma).
Il capitalista commerciale fa eseguire in gran parte dai lavoratori la funzione stessa in virtù della quale il suo denaro è capitale. Il lavoro non pagato di questi commessi, pur non creando plusvalore gli rende possibile l’appropriazione di plusvalore, il che per quanto riguarda questo capitale produce esattamente il medesimo risultato; esso è quindi la fonte del suo profitto. L’attività commerciale non potrebbe altrimenti mai essere esercitata su scala sempre più vasta, in modo capitalistico. Come il lavoro non pagato dei lavoratori crea direttamente del plusvalore per il capitale produttivo, così il lavoro non pagato dei lavoratori commerciali procura al capitale commerciale una partecipazione a quel plusvalore. Il capitale commerciale non è assolutamente altro se non una forma autonomizzata di una parte del capitale industriale che funziona nel processo di circolazione, quindi tutte le questioni che vi si riferiscono devono venire risolte ponendo in un primo tempo il problema nella forma in cui i fenomeni propri del capitale commerciale non appaiono ancora autonomi, ma in connessione diretta con il capitale industriale, come un ramo dello stesso. Nell’ufficio commerciale in opposizione alla officina, il capitale commerciale funziona ininterrottamente nel processo di circolazione. Come qualsiasi altra spesa del genere, anche questa diminuisce il tasso del profitto, in quanto il capitale anticipato aumenta, ma non il plusvalore.
Il capitalista industriale cerca quindi di ridurre al minimo queste spese di circolazione, precisamente come egli fa per le sue spese di capitale costante. Il capitale industriale non si comporta dunque rispetto ai suoi salariati commerciali allo stesso modo in cui si comporta rispetto ai suoi salariati produttivi. Maggiore è il numero di questi salariati produttivi che vengono occupati e più grande, a parità di altre circostanze, è la produzione, più considerevole è il plusvalore o profitto. Al contrario invece, maggiore è la scala della produzione e più grandi sono il valore e quindi il plusvalore da realizzare, più grande è il capitale-merce prodotto, e più aumentano in modo assoluto, se non relativo, le spese dell’ufficio, dando luogo ad una specie di divisione del lavoro. In quale misura queste spese presuppongono il profitto, si vede fra l’altro dal fatto che spesso, con l’accrescersi dei salari commerciali, una parte di questi stessi salari viene pagata con percentuali sul profitto. Il lavoratore, commerciale non produce direttamente plusvalore. Ma il prezzo del suo lavoro è determinalo dal valore della sua forza-lavoro, quindi dalle spese di produzione di questa ultima, mentre l’esercizio di questa forza-lavoro, come una tensione, applicazione di forze e logorìo, non è limitata dal valore della sua forza-lavoro più che non lo sia quella di ogni altro salariato. Non esiste quindi alcun rapporto necessario tra il suo salario e la massa di profitto che egli aiuta il capitalista a realizzare. Ciò che il lavoratore commerciale costa al capitalista e ciò che gli rende, sono grandezze diverse. Egli gli rende, non perché produce direttamente del plusvalore, ma perché contribuisce a diminuire le spese della realizzazione del plusvalore, nella misura in cui egli compie un lavoro, in parte non pagato. I lavoratori commerciali veri e propri appartengono alla classe di salariati meglio pagati, di quelli il cui lavoro è qualificato, superiore al lavoro medio.
Con tutto ciò a misura che il modo capitalistico di produzione si sviluppa, il salario ha la tendenza a diminuire, anche in rapporto al lavoro medio. In parte in séguito alla divisione del lavoro nella sfera dell’ufficio; per questo si deve stimolare lo sviluppo dell’abilità di lavoro in una unica direzione e le spese di specialiizzazione non gravano in parte sui capitalisti poiché l’abilità dei lavoratori si sviluppa con la pratica stessa e tanto più rapidamente quanto più specializzata essa diventa con la divisione del lavoro. In secondo luogo perché la preparazione, la conoscenza del commercio e delle lingue e così via, vengono diffuse con sempre maggiore rapidità, si generalizzano, diventano più facili, costano meno a misura che la scienza e l’istruzione popolare si sviluppano e che la produzione capitalistica orienta sempre più verso la pratica i metodi di insegnamento ecc. La generalizzazione dell’istruzione popolare permette il reclutamento di questi salariati da classi che prima ne erano escluse ed erano abituate ad un tenore di vita peggiore. In tal guisa essa accresce l’afflusso e la concorrenza. A parte alcune eccezioni, la forza-lavoro di questa gente si deprezza con il progresso della produzione capitalistica: il loro salario diminuisce mentre il loro rendimento si accresce. Il
112

capitalista aumenta il numero di questi lavoratori, quando vi sia da realizzare più valore e profitto. L’aumento di questo lavoro è sempre la conseguenza, mai la causa dell’aumento del plusvalore .
[C. II,6; III,17; TP. 4; VI. 13 ]
I.3. Macchine
I.3.1. La nascita del macchinario
«Quando, secondo la speciale natura dei prodotti d’ogni specie di manifatture, l’esperienza ha mostrato qual sia il più vantaggioso numero di parziali operazioni fra cui si debba dividere la fabbricazione, e il numero dei lavoratori che convenga dedicarvi, tutti gli opificii che non adotteranno un numero di lavoranti esattamente multiplo, fabbricheranno con minore economia». Questa massima dovrebbe sempre aversi di mira nei grandi stabilimenti d’industria, quantunque debbasi convenire che è impossibile eseguirla rigorosamente in pratica, anche sotto il miglior sistema di divisione del lavoro. Il primo oggetto a cui si debba badare in questo esame della ripartizione del lavoro è la proporzione dei lavoratori abili col numero totale dei lavoranti. Col crescere della domanda d’una manifattura, nasce e s’ingrandisce l’idea d’inventare qualche macchina per lavorarla. Con l’introduzione delle macchine, la produzione si aumenta, e poco a poco sorge l’idea di creare grandi opificii. Quando una gran parte del lavoro consiste nello svolgere una certa quantità di forza fisica dei lavoratore, come avviene nella tessitura, il fabbricante comprende ben tosto che se i telai fossero mossi da una macchina a vapore, un medesimo lavoratore potrebbe sorvegliarne due ed anche più ad una volta; e poiché noi abbiamo supposto che aveva uno o due artefici meccanici, egli deve regolare il numero dei suoi lavoratori in modo che la buona manutenzione dei telai e la macchina a vapore possano occupare tutto il tempo dei suoi artefici. L’introduzione della macchina a vapore avrà due effetti: l’uno che i telai lavoreranno dieci volte più presto della forza umana, l’altro che ogni uomo, dispensato dal suo travaglio fisico, potrà, come abbiamo detto, sorvegliare due telai insieme; da che risulterà che ciascuno farà quanto quattro ne facevano per l’innanzi.
Noi sappiamo che un effetto della divisione del lavoro è quello di diminuire il costo della produzione, e che con questo ribasso di prezzo sorge l’aumento della domanda. Quindi gradatamente per effetto della concorrenza, per la speranza di raccogliere grossi guadagni, considerevoli capitali vengono arrischiati nelle fondazioni di grandi opifici industriali. Esaminiamo ora l’influenza di questa massa di capitali diretti i sopra un sol punto. Il suo primo effetto è di svolgere quanto più sia possibile le suddivisioni dal lavoro. Non solamente, mercè la gran massa di capitali, si può per ogni parte dell’opera procurare la precisa quantità di attitudine che sia necessaria, ma il sistema medesimo di economia è applicato all’abilità dei lavoranti, in tutti gli stadii della produzione, dalla compra delle materie prime sino alla vendila dei prodotti. Un sistema così generale aumenta di molto la quantità di lavoro prestato da un certo numero di individui; e ha per effetto di diminuire grandemente il prezzo della merce offerta al compratore. La riunione d’un gran numero di opificii in un sol paese ha per naturale suo effetto di attirarvi da una grande distanza una moltitudine di persone, che com-prano per proprio conto, e per conto di case lontane.
Quando le fabbriche esistono da lungo tempo, i traslocamenti producono le conseguenze più gravi, perché attorno alla fabbrica è cresciuta una popolazione proporzionata. Quando un fabbricante porta cosi la sua industria in un luogo in cui prima non esisteva, il traslocamento non ha solamente l’effetto di porlo al coperto dalle associazioni di lavoratori a cui vuol sottrarsi. Se egli riesce nel suo nuovo stabilimento, l’esempio in pochi anni trascinerà altri capitalisti, e li indurrà, ad impegnare nuovi fondi nel medesimo genere d’industria. Dimodoché, quantunque una sola fabbrica sia uscita dal primo paese ove le associazioni di lavoratori determinarono questo parziale traslocamento, pure i lavoratori non perdono solamente il lavoro che quella fabbrica forniva, ma sono inoltre costretti ad abbassare in generale le loro mercedi, per effetto della rivalità che il nuovo centro d’industria ha loro creata. Tutte quelle coalizioni hanno un inevitabile funestissimo crollo nella classe dei lavoranti, cioè il traslocamento delle fabbriche verso altre località, ove i padroni possano mettersi al coperto da questa insopportabile lotta. Alcuni opificii non sono di natura tale che possano traslocarsi: lo scavo di una miniera, per esempio, si trova in tal caso, ed il suo proprietario è molto più esposto a trovarsi vessato dalle condizioni dei suoi lavoranti. Ma come i concessionari di miniere possiedono generalmente vasti capitali, cosi riescono ad introdurre una diminuzione nel prezzo delle giornate, quando essa è realmente giusta ed indispensabile. I lavoratori che lavorano ad estrarre il carbon fossile, ultimamente han formato, nel nord dell’Inghilterra, una coalizione estesissima, che andò sino agli atti di violenza. Per continuare l’impresa i proprietari delle miniere furono costretti a chiamare da altri punti del paese alcuni minatori, che consentirono a lavorare per un prezzo ragionevole, ed il cui lavoro dovette farsi proteggere
113

dall’autorilà civile, e qualche volta anche dalla forza militare. Questa crisi durò parecchi mesi; la questione era di sapere quale tra le due parti avrebbe potuto per più lungo tempo resistere senza alcun guadagno; i proprietari vinsero, come era agevole il prevedere.
Gli è tempo che tutte queste arbitrarie convenzioni spariscano. In un paese la cui ricchezza essenzialmente dipende dalla sua industria manifatturiera, bisogna che non si faccia alcuna distinzione decisa tra le varie classi, e che le più alte persone dell’aristocrazia si sentano fiere di trovarsi unite coi vincoli dell’amicizia agli uomini, i cui lavori contribuiscono alla prosperità nazionale. Già i nostri primi manifattori, i nostri più ricchi negozianti sono ammessi nelle riunioni dell’alta nobiltà, e sovente si vede quella di second’ordine associarsi a commercianti d’un rango più o meno elevato. In parecchi nostri distretti di manifatture, un’opinione funesta ed affatto erronea si è propagata fra i lavoratori: essi credono che i loro interessi siano contrari a quelli delle persone per cui conto lavorano. Da ciò viene che talune macchine utili rimangono inusitate, e qualche volta ancora vengano in parte o in tutto distrutte dai lavoratori. Da ciò viene ancora che i nuovi perfezionamenti introdotti dai padroni non si sperimentano bene, e che i lavoratori non rivolgono le loro attitudini e le loro osservazioni verso il perfezionamento dei metodi di cui si servono. Quest’errore è forse più potente nei paesi in cui le manifatture furono da poco tempo introdotte e non tengono occupate che un piccolo numero d’individui; il frequente esempio di lavoratori, i quali, con la loro buona condotta e con una diligente attenzione agli interessi dei loro padroni, son divenuti capi di opificio, ha ottenuto una larga parte d’interesse nella manifattura in cui erano occupati. Quantunque sia perfettamente vero che la prosperità dei padroni giovi ai lavoranti presi in massa, pure non sembrami che ogni individuo di questa società mista riceva una parte di profitto esattamente proporzionata a quella con cui egli contribuisce alla elaborazione, e, in generale, il sistema presente non mi sembra produrre vantaggi così immediati come si potrebbe ottenere da un altro sistema di associazione.
Sarebbe importantissimo l’introdurre nei pagamenti dei lavoratori d’un grande opificio un ordine tale che il profitto d’ogni lavoratore si collegasse alla buona riuscita della fabbrica, potendosi aumentare a misura che crescano i guadagni, senza che il padrone fosse costretto a fare alcun cambiamento nei prezzi convenuti coi suoi lavoranti. Ecco ora il progetto di un sistema che mi sembra atto a produrre importantissimi effetti per la classe dei lavoranti e per la popolazione delle campagne in generale, un sistema la cui introduzione, secondo me, tenderebbe a costantemente a rialzare i lavoranti, e darebbe un considerevole svolgimento al nostro sistema di manifatture. Esso sarebbe fondato sui seguenti principii:
1° Una parte considerevole del salario ricevuto da ogni persona impiegata in un opificio qualunque, deve dipendere dal guadagno generale dell’opificio.
2° Ciascun impiegato dell’opificio deve avere un vantaggio certo nell’applicazione immediata di qualunque perfezionamento che possa scoprire nel metodo del suo lavoro, e questo vantaggio dev’essere anche inferiore a quello che gli frutterebbe ogni altro mezzo di far valere la sua scoperta.
In quei generi d’industria ove si hanno molti lavoranti, essi han formato delle società fra di loro, e per contrappeso altre ne han formato i padroni. Queste società si propongono scopi diversi; ma sarebbe a desiderarsi che i loro componenti ne conoscano bene i veri effetti, perché i vantaggi che ne risultano, e che sono certamente considerevoli, si possano distinguere dagli inconvenienti che troppo spesso han prodotti. Le società tra padroni e tra lavoratori possono giovare per stabilire di comune accordo le regole che le due parti debbono osservare nell’estimazione del valore relativo d’ogni genere d’opera, regola affatto indispensabile per risparmiare il tempo e prevenire le quistioni. Possono anche riuscire utilissime per trasmettere dall’una all’altra città precisi ragguagli sul numero d’individui che lavorano nelle varie parti d’un ramo d’industria, sull’ammontare delle loro giornate, sulle macchine che adoprano, ecc. Una tale corrispondenza gioverebbe moltissimo ad illuminarli sui loro veri interessi; e quando giudicassero opportuno il rivolgersi all’autorità superiore pur invocare soccorsi o modificare le leggi attuali, potrebbero appoggiare la loro domanda su (questi preziosi dati, senza dei quali non si può decidere la maggiore o minore opportunità della provvidenza invocala, e che sono sempre ben più difficili a raccogliersi da persone che non siano molto abituate ed interessate nella quistione. Uno tra i più giusti e più importami scopi di tali associazioni è il determinare di comune accordo i modi pronti e sicuri di misurare la quantità di lavoro fattosi dal lavoratore.
[EM. (Babbage), passim]
La scienza [philosophy] delle manifatture è dunque un’esposizione dei generali principi, secondo cui l’in-dustria produttiva deve reggersi con l’aiuto di macchine automatiche. Lo scopo e l’effetto continuo dei progressi della scienza delle manifatture sono veramente filantropici; tendono a sollevare il lavoratore dalle minuziose pratiche che spossano il suo spirito e affaticano la sua vista, e dagli sforzi penosi e ripetuti che storcono o logorano il suo corpo. I metodi che si possono adoperare per conferire movimenti precisi a delle porzioni di materia inerte, simili ai movimenti degli esseri organizzati, sono innumerevoli, perché si compongono d’un numero infinito e d’una infinita varietà di corde, di pulegge, di ruote dentate, di chiodi, viti, leve, piani inclinati, e fanno anche agire l’aria, l’acqua, il fuoco, la luce, ecc. in un’immensità di
114

combinazioni, per produrre l’effetto bramato. L’ingegno umano si è per lungo tempo esercitato intorno a tali combinazioni, per divertire o ingannare il pubblico senza alcuno scopo d’utilità. Invenzioni automatiche come queste, per quanto mirabili siano come capi d’opera di meccanica, nulla giovano ai fisici bisogni della società. L’uomo ha quotidianamente mestiere di cibi, di fuoco, di abiti, di alloggio; deve dunque dedicare tutte le sue fisiche ed intellettuali facoltà, tutti i mezzi della natura e dell’arte, dapprima a provvedersi per sé ed i suoi, di ciò che più gli abbisogni, senza di che non potrebbe goder la vita, né trovare il riposo necessario per coltivare il suo spirito ed il suo gusto.
Il termine inglese factory system (manifattura automatica), significa tecnologicamente la cooperazione di varie classi di lavoratori, adulti e non adulti, che attendono con destrezza ed assiduità a un sistema di meccanismi produttivi, posti continuamente in moto da una forza centrale. Ma a me sembra che questo vocabolo, nel più rigoroso significato, porti seco l’idea d’un vasto automa composto di molti organi meccanici ed intellettuali che agiscono di concerto e senza interruzione, per produrre un medesimo oggetto, e stando subordinati ad una forza motrice che si muova da sé. In quei vasti opifìcii, la benefica potenza del vapore chiama attorno a sé le migliaia dei suoi sudditi, e assegna a ciascuno il suo compito, sostituendo ai loro penosi sforzi muscolari l’energia del gigantesco suo braccio, e non domandando da loro in compenso altro che l’attenzione e la destrezza opportune per correggere i lievi errori che qualche volta trascorrono nel suo lavoro. La grande docilità di questa forza motrice la rende atta a porre in moto i piccoli rocchetti del telaio da merletti, con una precisione ed una celerità che le munì più abili, dirette dall’occhio più fino, non potrebbero mai produrre. Sotto tali auspici, e conformemente alla volontà del fondatore, edifici magnifici – che per numero, ricchezza, utilità, concepimento di costruzione, sorpassano i tanto vantati monumenti del dispotismo asiatico, egiziano e romano – sono stati eretti nel breve corso di cinquant’anni da un capo all’altro del regno. Ciò mostra fino a qual punto i capitali, l’industria, le scienze possano aumentare i mezzi d’uno stato, migliorando la sorte della popolazione. Tale è il sistema delle manifatture automatiche: fecondo in prodigi di meccanica e di economia politica, esso promette, nei suoi svolgimenti futuri, di divenire il più grande strumento di civiltà sul globo terrestre, e dare all’Inghilterra, che ne è l’anima, la potenza di spargere per mezzo del suo commercio i lumi della scienza e della religione fra milioni d’individui che languiscono ancora nella regione delle tenebre e della morte. All’incontro, dovunque un metodo qualunque richieda molta destrezza ed una mano sicura, si ritira al più presto dalle braccia del lavoratore troppo destro, e sovente inclinato a delle irregolarità di vario genere, per addossarlo ad un meccanismo speciale, la cui azione automatica è così ben regolata che un fanciullo può sorvegliarla.
Il principio del sistema automatico è dunque quello di sostituire l’arte meccanica alla manodopera, e rimpiazzare la divisione del lavoro fra gli artigiani per mezzo dell’analisi di un dato metodo nei suoi principi costitutivi. Secondo il sistema del lavoro manuale, la manodopera era ordinariamente il più dispendioso elemento d’un prodotto qualunque: materiam superabat opus; ma secondo il sistema automatico, il talento dell’artigiano si trova progressivamente supplito da semplici sorveglianti meccanici. La debolezza dell’uma-na natura è tale che, quanto più abile sia il lavoratore, tanto più diviene volontario ed intrattabile, e in conseguenza, tanto meno è atto ad un sistema di meccanica, all’insieme del quale i suoi capricci possono recare un grandissimo nocumento. Il gran punto del manifattore odierno sta dunque nel combinare la scienza coi suoi capitali; nel ridurre l’ufficio dei suoi lavoratori ad esercitare vigilanza e destrezza, facoltà che ben presto si perfezionano nei giovani quando si fissano sopra un solo oggetto; ma, secondo il sistema che decompone un’operazione nei suoi principi costituenti, e che ne affida tutte le parti all’azione d’una macchina automatica, si possono affidare queste medesime parti a persone dotate di un’ordinaria capacità, dopo averle sottoposto ad una breve prova; si può anche, in caso d’urgenza, farle passare da una macchina all’altra, a volontà del direttore. Ma secondo il principio di parificazione, o il sistema automatico, le facoltà del lavoratore non vanno soggette che ad un esercizio gradevole; egli è raramente sopraffatto di fatica o di ansietà, può godere molti momenti di riposo, sia per ricrearsi, sia per meditare senza nuocere agl’interessi del suo padrone o di se stesso. Non dovendo che vegliare all’andamento d’un meccanismo ben regolato, può impararlo in poco tempo; e quando si trasferisce al servizio di un’altra macchina, varia il suo cómpito e svolge le sue idee riflettendo alle generali combinazioni che risultano dal suo lavoro e da quello dei suoi compagni. Cosi quell’esercizio delle facoltà, quel restringimento d’idee, quello stato di violenza nel corpo, che non senza ragione furono attribuite dai moralisti alla divisione del lavoro, non possono ordinariamente aver luogo sotto il regime d’una eguale distribuzione di lavoro.
In un’analisi dei principi dell’industria manifatturiera, gli uffici generali delle macchine e gli effetti dei loro perfezionamenti devono considerarsi attentamente. Vi sono tre specie di macchine:
1. Le macchine destinate a produrre la forza motrice; 2. Le macchine destinate a trasmetterla e regolarla; 3. Le macchine destinate, nell’applicazione della forza, a modificare lo varie forme della materia in
oggetti di commercio.
115

In primo luogo: le macchine che servono a produrre la forza agiscono por mezzo della gravitazione, del -l’inerzia, e della coesione. La macchina a vapore innalza e deprime alternativamente il suo enorme stantuffo, mercè la sola forza dilatatrice del vapore, o mette così in movimento il massiccio suo bilanciere ed i suoi alberi. In secondo luogo: le macchine destinate a trasmettere e regolare la forza, sono le ruote dentate, le ruote volanti di molte specie, i regolatori dello valvole, gli alberi, o le altre grandi ruote dentate delle fabbriche. In terzo luogo: lo macchine destinate ad applicare la forza per modificare la materia sembrano a primo aspetto talmente molteplici e complesse da deludere qualunque tentativo di classificazione. Ho cercato di dare uno schizzo dei loro rapporti, e dei loro accessori, nel séguito.
La filosofia delle manifatture si spiega perfettamente nell’economia della forza. Le macchine a vapore forniscono i mezzi di provvedere, non solamente al loro mantenimento, ma anche alla loro propagazione. Fanno un gran consumo di combustibile al tempo medesimo che prestano le potenti loro braccia per pom-pare le acque sotterranee, e innalzare il carbone dalle miniere; danno impiego ad un’infinità di minatori, ingegneri, costruttori di vascelli, marinai, ed esigono la costruzione di canali e strade ferrate. Procurando la facilità di mettere a profitto questi ricchi dominii dell’industria lasciano a migliaia di campi lavorativi la libertà di produrre alimenti umani, mentreché, senza di essi, questi campi medesimi si sarebbero necessariamente dovuti destinare alla nutrizione dei cavalli. D’altronde, le macchine a vapore, col basso prezzo e con la regolarità dal loro lavoro, fabbricano mercanzie a buone condizioni, a col loro cambio in prodotti stranieri, procurano in abbondanza gli oggetti necessari ai primi bisogni e al benessere della vita.
I perfezionamenti arrecati nelle macchine hanno tre specie di effetti: 1. Fan nascere la possibilità di fabbricare certi prodotti che, senza di esse, non si potrebbero affatto. 2. Pongono il lavoratore in grado di eseguire una maggiore quantità di lavoro, a parità di tempo, di sforzo e di qualità del prodotto. 3. Sostituiscono ad un travaglio quasi senz’arte, un travaglio che ottiene una grande perfezione. L’introduzione di nuove macchine in una manifattura, avendo per effetto la sostituzione del lavoro manuale, è moderata dal sistema dei brevetti d’invenzione, che lo mantiene per un certo tempo a un prezzo di monopolio, e ehe per conseguenza ne ritarda la rapida diffusione.
L’architettura automatica è una scienza di recente origine; anche oggidì non è nota al di là del circuito delle factorìes [fabbriche]. Lo scopo delle manifatture ha tre interessi da servire: quello del lavoratore, quello del padrone e quello dello stato; e la loro perfezione consiste nello svolgere e nel bene amministrare ciascuno di questi interessi. L’ente meccanico deve sempre subordinarsi all’influenza morale, ed entrambi devono cooperare alla prosperità mercantile. Tre distinti poteri concorrono alla loro vitalità; il travaglio, la scienza e il capitale. Il primo è destinato ad agire, il secondo a dirigere, il terzo a sostenere. Quando tutti e tre son d’ac-cordo, ne risulta un corpo capace di eseguire le sue multiformi funzioni, per un principio inerente d’evolu-zione, simile a quello d’un essere animato. Il lavoratore non può da sé giudicare l’estensione del danno che deriva dalla violazione del lavoro automatico. Nondimeno il lavoratore di una fabbrica, poco versato nelle grandi operazioni dell’economia politica e del commercio, agisce quasi sempre per un sentimento d’invidia contro un capitalista, e non è difficile a demagoghi artificiosi il dargli a credere che egli non riceva un sufficiente compenso all’impiego del suo tempo e della sua capacità, o che alcune ore di meno nel suo lavoro sarebbero un giusto supplemento alla sua mercede. Sembra che quest’idea, radicata da lungo tempo nello spirito dei lavoratori, vi è ancora mantenuta dai capi di quelle associazioni segrete, che tanto facilmente si organizzano in mezzo ad una classe di uomini riuniti in massa sopra un territorio ristretto.
Invece di mormorare, come han fatto, contro la prosperità dei loro padroni, e ricorrere a mezzi estremi per arrestarla nella sua via, dovrebbero, per riconoscenza, e nel loro interesse medesimo, rallegrarsi del successo a cui essi hanno contribuito. La regolarità della loro condotta e i loro talenti li renderebbero raccomandabili agli occhi dei capitalisti, che volessero formare qualche vantaggioso stabilimento, e confidarne ad abili mani la direzione. È così che taluni buoni lavoratori avrebbero ottenuto posti da sorveglianti, da direttori, da soci dei nuovi opifici, ed avrebbero procurato occupazione ad un gran numero dei loro compagni. È solamente in questo genere di progresso pacifico, che si possono innalzare e mantenere le mercedi. Senza le condizioni e le interruzioni violente cagionate dallo idee errone dei lavoratori, il sistema delle manifatture si sarebbe sviluppato ancora più rapidamente e vantaggiosamente di quel che ha fatto finora, per tutte le parti interessate; e avrebbe fornito più frequentemente esempi di abili artigiani divenuti ricchi proprietari. Ma ogni discordia respinge affatto il capitale, o gli impedisce per un certo tempo di scorrere nei canali di un commercio continuamente esposto ad essere intorbidato.
Fra tutti i pregiudizi esistenti riguardo al lavoro delle manifatture, non ve n’è alcuno che sia men fondato di quello che rappresenta questo lavoro come infinitamente più noioso o faticoso d’ogni altro, perché deve tener dietro al movimento continuo della macchina a vapore. In un filatoio o in un tessitoio di cotone, l’opera più penosa si fa dallo stantuffo che non lascia alcun grave travaglio al lavoratore; il quale non ha in generale cosa alcuna da fare, fuorché eseguire di tempo in tempo qualche delicata operazione. La maggior parte delle operazioni eseguite con l’aiuto delle macchine a vapore, richiedono un lavoro pin elevato o almeno più seguito di quello delle operazioni che si fanno a mano. Lo spirito allora agisce più che le membra, e si fa un
116

lavoro d’arte che sempre è pagato meglio del lavoro puramente manuale. Le erronee idee dei lavoratori relativamente all’influenza delle macchine sul prezzo del loro travaglio, sono la precipua cagione dei sotterfugi o delle sospensioni di lavoro. Esse producono un amaro malcontento contro i padroni e meritano un’energica confutazione. È senza dubbio importante il convincere i lavoratori che il perfezionamento delle macchine tende ad accrescere la somma di denaro che essi individualmente e collettivamente guadagnano per un determinato numero di lavoro. Questo fatto è dimostrato, con le regole infallibili dell’aritmetica. Si è egualmente provato che questi progressi hanno richiesto un maggior impiego di giovani, il cui guadagno si è in conseguenza accresciuto. Ora, a misura che la manodopera diviene più facile, il prezzo della mercanzia ribasserà e il consumo diverrà maggiore. Abbiamo già detto che il lavoro non è incessante in una fabbrica automatica, precisamente perché procede di accordo col suo potente aiuto, la macchina a vapore. Si è provato che il più faticoso lavoro nelle fabbriche è quello che non trovasi dominato dalla forza motrice, di modo che, se si vuol mettere il lavoratore al suo comodo, basta aggiungergli uno stantuffo a vapore.
La salute dei lavoratori impiegati nello manifatture ha fornito a Mr. Sadler un argomento d’indagini mediche in forma di dialoghi, che potrebbe far seguito alle comiche scene del Malato immaginario. Egli invitò parecchi celebri medici di Londra per esporre al comitato alcune ipotesi scientifiche sulla generazione delle malattie provenienti dal lavorare nelle filande di cotone; soggetto che quei medici non avevano mai veduto né studiato; e, come si doveva naturalmente aspettare, essi han dato nel loro rapporto singolari prove della flessibilità del criterio medico. Un ingegnoso medico, interrogato circa gli effetti del travaglio di notte sui fanciulli delle fabbriche, biasimò quest’uso: «Qual è il padrone, tal sarà il servo», è un proverbio applicabile tanto allo pubbliche istituzioni, quanto allo famiglie private. Il fabbricante che mena una vita irreprensibile, che intende bene i suoi interessi, e che prende a cuore la prosperità dei suoi subordinati, farà di tutto per ispirare in essi i migliori sentimenti. Se, all’incontro, egli è rilassato nei suoi costumi, se trascura di sorvegliare la condotta dei suoi subordinati quand’essi adempiono al loro ufficio, risentirà le conseguenze della sua trascuraggine nella cattiva esecuzione del lavoro, e nella mancanza di rispetto da parte loro.
Nulla egli deve aspettarsi, che non venga dalla sua propria sorveglianza; e saranno sempre vani gli sforzi che faccia per esercitare la più rigorosa vigilanza sui suoi lavoratori. Tutti cospirano, direm cosi, per istinto contro un tal padrone; qualunque pena si dia, non può mai ottenerne un buon lavoro; i suoi prodotti son sempre di qualità inferiore. In nessun caso, la massima del Vangelo, la pietà giova molto, è tanto applicabile, quanto nell’amministrazione d’una grande manifattura. Un osservatore pieno di esperienza può agevolmente scoprire, dal disordine che regni nel sistema generale d’uno stabilimento qualunque, la rilassatezza della disciplina morale, le irregolarità delle varie macchine, la perdita del tempo e della materia derivatile dalla rottura e dal rannodamento dei fili. Da un altro lato, il padrone vede con pena che la sua indulgenza verso i vizi dei lavoratori non è punto ricompensata che con l’indifferenza verso i suoi interessi, quantunque le mercedi che paga gli diano il diritto di attenderne servigi zelanti. È dunque un vantaggio, come è un dovere, per ogni capo d’opificio, l’osservare riguardo ai suoi lavoranti il precetto divino: ama il tuo prossimo come te stesso, perchè, così operando, farà circolare una nuova vita in tutte le vene dell’industria.
[FM. (Ure), passim)]
Fin da quando ho per la prima volta rivolto la mia attenzione alle questioni dell’economia politica, sono stato dell’avviso che l’applicazione di macchine che avessero l’effetto di risparmiare lavoro a un qualsiasi ramo di produzione fosse un bene per tutti, accompagnato soltanto da quel poco di inconvenienti che nella maggior parte dei casi accompagna il trasferimento del capitale e del lavoro da un impiego all’altro. Chi avesse fatto l’invenzione della macchina, o chi per primo l’avesse utilmente impiegata, verrebbe a godere un vantaggio supplementare, realizzando per un certo tempo ingenti profitti; ma, nella misura in cui la macchina diventasse di uso generale, il prezzo della merce prodotta, per effetto della concorrenza, scenderebbe fino al suo costo di produzione. Il capitalista otterrebbe allora gli stessi profitti monetari di prima, e parteciperebbe al vantaggio generale solo in qualità di consumatore, venendo messo in grado di disporre, con lo stesso reddito in denaro, di una quantità supplementare di agi e di godimenti. Anche la classe dei lavoratori, pensavo, verrebbe egualmente avvantaggiata dall’impiego delle macchine, poiché con gli stessi salari avrebbe i mezzi di comprare più merci e non subirebbe alcuna riduzione di salari, perché il capitalista avrebbe i mezzi di richiedere e di impiegare la stessa quantità di lavoro di prima, sebbene possa trovarsi nella necessità di impiegarla nella produzione dì una merce nuova, o comunque di una merce differente; ma sono convinto che la sostituzione delle macchine al lavoro umano sia spesso assai dannosa agli interessi della classe dei lavoratori; ho ragione di ritenere che il fondo da cui i proprietari terrieri e i capitalisti traggono il loro reddito può aumentare mentre l’altro fondo, da cui soprattutto dipende la classe lavoratrice, può diminuire; sicché ne consegue, se vedo giusto, che la stessa causa che può aumentare il reddito netto del paese, può nello stesso tempo rendere esuberante la popolazione e peggiorare le condizioni dei lavoratori.
Poiché, comunque, la capacità di risparmiare sul reddito per accrescere il capitale dipende necessariamente dalla capacità del reddito netto di soddisfare i bisogni del capitalista, dalla riduzione di
117

prezzo delle merci conseguente all’introduzione delle macchine non può non seguire che, in presenza degli stessi bisogni, il capitalista avrà maggiori possibilità di risparmiare, maggiore facilità di trasformare il reddito in capitale. Ma a ogni aumento del capitale egli impiegherà più lavoratori; e, perciò, una parte delle persone allontanate dal lavoro nel primo momento verrebbe impiegata in un momento successivo; e se la maggior produzione conseguente all’impiego della macchina fosse talmente grande da fornire, sotto forma di prodotto netto, la stessa quantità di viveri e di beni di prima necessità che si avevano prima sotto forma di prodotto lordo, vi sarebbe la stessa possibilità di impiegare la popolazione complessiva e non vi sarebbe quindi necessariamente un eccesso di popolazione. Io mi limito a voler dimostrare che la scoperta e l’impiego delle macchine possono essere accompagnati da una diminuzione del prodotto lordo; e questo, tutte le volte che si verifica, sarà di danno alla classe lavoratrice poiché una parte dei suoi membri verrà allontanata dal lavoro e la popolazione diventerà eccessiva rispetto ai fondi che devono darle impiego; la domanda di lavoro diminuirebbe, e le merci necessarie al mantenimento del lavoro non verrebbero prodotte con la stessa abbondanza. Se queste opinioni sono esatte, ne consegue che l’invenzione e l’utile applicazione delle macchine porta sempre all’aumento del prodotto netto del paese, sebbene dopo un trascurabile periodo di tempo possa non aumentare, e non aumenti, il valore di quel prodotto netto; che l’opinione nutrita dalla classe lavoratrice, secondo cui l’impiego delle macchine è spesso dannoso ai suoi interessi, non è fondata sul pregiudizio e sull’errore, ma è conforme sii corretti principi dell’economia politica; che se i mezzi di produzione, perfezionati grazie all’impiego delle macchine, dovessero aumentare il prodotto netto di un paese in misura grande, allora la situazione di tutte le classi verrà migliorata.
Le affermazioni che ho fatto non porteranno, spero, a concludere che l’impiego delle macchine non dovrebbe essere incoraggiato. Per chiarire il principio ho supposto che le macchine perfezionate vengano inventate all’improvviso e impiegate estensivamente; ma la verità è che queste invenzioni sono graduali e operano più nel senso di determinare l’impiego del capitale che viene risparmiato e accumulato che nel senso di distogliere capitale dagli impieghi in cui è già investito. A ogni aumento del capitale e della popolazione, i viveri generalmente aumenteranno di prezzo a causa della maggiore difficoltà di produrli. La conseguenza di un rincaro dei viveri sarà un aumento dei salari, e ogni aumento dei salari avrà tendenza a spingere in maggior misura di prima il capitale risparmiato all’impiego delle macchine. Macchine e lavoro sono in costante concorrenza e spesso le prime possono non essere impiegate finché non aumenta il prezzo del lavoro. Ho già osservato che l’aumento delle entrate nette, stimate in merci, che è sempre la conseguenza del perfezionamento delle macchine, condurrà a nuovi risparmi e a nuove accumulazioni. L’impiego delle macchine in uno stato non può mai essere scoraggiato impunemente; se al capitale non si consente di ottenere il massimo del reddito netto che l’impiego delle macchine può dare, esso verrà inviato all’estero, e questo suo esodo deve scoraggiare la domanda di lavoro in modo molto più serio del più esteso impiego delle macchine. Fino a che un capitale viene impiegato nel paese, esso deve necessariamente dar luogo a una certa domanda di lavoro; le macchine non possono funzionare senza l’ausilio degli uomini, né possono essere costruite senza il contributo del loro lavoro. Con l’investimento di una parte del capitale in macchine perfezionate, si avrà in seguito una diminuzione nella domanda di lavoro; con la sua esportazione in un altro paese la domanda sarà completamente annientata.
[PEP. XXXI]
I.3.2. Le caratteristiche delle macchine
“Presumo che basso grado di organizzazione significhi che le varie parti sono state poco specializzate per funzioni specifiche; e che noi possiamo comprendere il motivo per cui parti che debbono adempiere a funzioni diverse debbano rimanere variabili, cioè, perché la selezione naturale non debba aver preservato o respinto ogni piccola deviazione delle forme tanto accuratamente come nei casi in cui la parte deve compiere funzioni specifiche. Allo stesso modo un coltello che deve tagliare cose di ogni genere può assumere quasi qualsiasi forma, mentre lo stesso strumento, usato per scopi particolari, deve assumere una forma specifica” [Ch. Darwin, On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, London, 1859]. Differenziazione, specializzazione, semplificazione: ecco alcuni dei più importanti risultati della divisione degli strumenti e degli attrezzi di lavoro a seconda del loro impiego. La differenziazione, la specializzazione e la semplificazione degli strumenti di lavoro hanno quindi la stessa origine della divisione del lavoro; se così non fosse, sarebbe necessaria una conoscenza a priori delle leggi della meccanica, ecc. Darwin (si veda la citazione) fa la stessa considerazione a proposito della specializzazione e della differenziazione persino degli organi degli esseri viventi.
La differenziazione è la distinzione delle forme e, nello stesso tempo, il consolidamento di esse;la specializzazione consiste nel fatto che lo strumento di cui ci si serve per un determinato impiego agisce
esclusivamente nell’ambito di quest’ultimo. Sia la differenziazione, sia la specializzazione racchiudono in sé
118

la semplificazione degli strumenti, che non devono essere nient’altro che un mezzo per realizzare un’ope-razione semplice e uniforme.
La differenziazione, la specializzazione e la semplificazione degli strumenti di lavoro, nate dalla divisione del lavoro nell’industria manifatturiera, che a sua volta si basa su questa stessa divisione, e i congegni costruiti per eseguire operazioni molto semplici, tenendo conto proprio delle prime tre, sono fra i più importanti presupposti tecnologici e materiali dello sviluppo della produzione mediante macchina, in quanto elementi che rivoluzionano i metodi e i rapporti di produzione. Quindi in un certo senso dice bene Babbage: “Quanto alla divisione del lavoro, ogni singola operazione si riduce all’impiego dì un unico semplice strumento; appunto l’unione di tutti questi strumenti, messi in moto da un unico motore, costituisce la macchina” [Ch, Babbage, Traité sur l’économie des machines et des manufactures, Paris, 1833]. Quello che qui ci preme sottolineare non è solo la riduzione “di ogni singola operazione all’impiego di un unico semplice strumento “, ma anche quello che in questa riduzione si cela, e cioè la creazione di questi semplici strumenti, prodotta dalla divisione del lavoro. Innanzitutto bisogna notare che qui non si tratta di una qualsiasi rigida delimitazione tecnologica, ma di una rivoluzione nell’impiego degli strumenti di lavoro che prefigura già il modo di produzione e, insieme, anche i rapporti di produzione; quindi è in causa in particolare la rivoluzione che caratterizza il modo di produzione capitalistico.
La massa degli strumenti, insieme ai lavoratori che li mettevano in moto, fu concentrata in un’unica proprietà e assunse la forma di cooperazione semplice, in cui il minor costo di produzione derivava principalmente da tre cause: 1) dalla disciplina alla quale erano sottoposti da parte del capitale i lavoratori; 2) dall’utilizzazione collettiva di comuni condizioni di lavoro, quali a esempio edifici, strumenti, ecc.; 3) dall’acquisto di materie prime in gran quantità, ecc. Pertanto la rivoluzione industriale che caratterizza il modo di produzione capitalistico comincia con la trasformazione della parte della macchina che si trova a contatto immediato col materiale elaborato. L’organizzazione e la combinazione del lavoro, basate completamente sulla produzione mediante macchina, appariranno solo nell’officina meccanica, in cui l’intero sistema è messo in moto da un unico automa. Tuttavia la rivoluzione industriale abbraccia in primo luogo la parte della macchina che esegue il lavoro. Forza motrice è all’inizio ancora l’uomo. Tuttavia quelle operazioni alla cui esecuzione era prima necessario un virtuoso che “suonava” lo strumento, sono ora eseguite mediante la trasformazione del movimento, immediatamente provocato dall’uomo con un semplice impulso meccanico (girare una manovella, mettere in moto una ruota), in movimenti netti e precisi della macchina operatrice.
Dal momento in cui la partecipazione immediata dell’uomo alla produzione si riduce solo al fatto che egli comincia ad agire come semplice forza, da quel momento trae origine il principio della produzione mediante macchina. Il meccanismo era ormai evidente: la forza motrice poteva essere sostituita in seguito dall’acqua, dal vapore, ecc. Se esaminiamo una macchina che abbia sostituito uno strumento precedente, tipico sia della produzione artigianale sia della produzione manifatturiera, ci accorgeremo che la parte della macchina che di fatto trasforma il materiale nella maggior parte dei casi è costituita da strumenti preesistenti: e ciò persino nel caso in cui essi assumano una forma diversa per agire come parti di un unico meccanismo. La macchina è contraddistinta principalmente dal fatto che lo strumento, prima indipendente, agisce ora come parte costituente di un complesso di strumenti simili, e nello stesso tempo solo adesso ha assunto dimensioni incomparabilmente maggiori in rapporto alla potenza della forza motrice. Tuttavia l’intero meccanismo ha il compito di trasformare il movimento iniziale provocato dalla forza motrice, di mutarlo in un altro, dandogli una forma atta a far si che la macchina operatrice possa funzionare.
Le prime macchine erano fabbricate a mano, in manifatture. La produzione di macchine mediante macchina fu possibile solo dopo l’invenzione della macchina stessa e, fondamentalmente, quando si scopri un’energia tale (ad esempio il vapore) da poter essere impiegata a qualsiasi livello per mettere in moto una macchina. Invece dell’unione dì molti strumenti in un’unica macchina, questi strumenti si presentano come un qualcosa di unico per forza, dimensioni e sfera d’azione, come ad esempio molti martelli nel caso di un martello a vapore. Qui, dove lo strumento della macchina per le sue dimensioni si distingue dallo strumento del lavoratore, è sempre stata necessaria anche una forza motrice meccanica. Perciò una macchina di questo genere non può mai essere artigianale, cioè non può essere adoperata da un unico lavoratore, o dalla sua famiglia, o da una coppia di apprendisti con il loro maestro. Quanto sopra esposto fornisce una risposta anche alla domanda: in che cosa differisce la macchina dallo strumento? Non appena lo strumento è messo in moto da un meccanismo, da strumento del lavoratore – da strumento la cui resa è condizionata dall’abilità del lavoratore e ne richiede il lavoro come intermediario nel processo lavorativo – si trasforma in strumento del meccanismo e la macchina si sostituisce allo strumento.
La legge generale che scaturisce da quanto sopra esposto consiste nel fatto che le basi materiali di ogni successiva forma di produzione – sia le condizioni tecnologiche, sia la struttura economica dell’impresa ad esse corrispondente – sono create nella forma immediatamente precedente. Il lavoro a macchina, in quanto elemento rivoluzionario, non è che l’effetto immediato del predominio dei bisogni sulla possibilità di
119

soddisfarli con i precedenti mezzi di produzione. Il predominio della domanda nacque proprio grazie alle scoperte del periodo artigianale, ma anche grazie al sistema coloniale, di cui si gettarono le basi nel periodo manifatturiero e, in un certo senso, grazie al mercato mondiale in tal modo costituitosi. Insieme alla rivoluzione già compiuta nelle forze produttive – che si manifesta come rivoluzione tecnologica – arriva anche una rivoluzione nei rapporti di produzione. È appunto caratteristico della produzione capitalistica il fatto che se anche le qualità sociali del lavoro che ne aumentano la forza produttiva intervengono come forza estranea al lavoro stesso, come condizioni all’esterno di esso, come proprietà e condizioni non pertinenti al lavoro – dal momento che il lavoratore è contrapposto al capitale sempre come lavoratore isolato, che cioè sta al di fuori del legame sociale che lo unisce agli altri lavoratori – questo in primo luogo e ancor di più è in relazione alle condizioni materiali del lavoro sociale. Benché solo la forma sociale del lavoro trasformi queste condizioni esterne da quelle esistenti per il lavoratore isolato in sociali, in concentrate che, grazie a questa loro concentrazione nello spazio e nel tempo e grazie all’utilizzazione contemporanea di esse da parte di lavoratori in collaborazione, possono essere impiegate più economicamente. Possono essere impiegate in modo tale che una loro maggiore azione nel processo lavorativo si accompagni a una minore spesa, cioè a un minore consumo del loro valore, a una minore incidenza di esse nel processo di aumento del valore. È particolarmente evidente proprio nella produzione a macchina come nella coscienza del capitalista si rafforzi l’alienazione di queste condizioni di lavoro dal metodo stesso di lavoro e come questa diventi un fattore diretto contro il lavoratore.
Nel processo effettivo del lavoro questa esistenza isolata naturalmente viene meno, mentre il processo di lavoro collettivo è il vero processo del capitale, insito nel capitale. In quanto il lavoratore vi compare come lavoro, egli stesso è un momento del capitale. Nella sottomissione formale del lavoro al capitale, tali condizioni di lavoro non subiscono ulteriori trasformazioni, esse rimangono – se si considerano come oggetti – materiale di lavoro e mezzo di lavoro. Ma nel caso di un nuovo sistema di produzione, di fronte a una rivoluzione nel sistema di produzione, introdotta dalla produzione capitalistica, cambia anche la forma delle condizioni di lavoro. Esse ricevono nuovi indirizzi grazie al fatto che sono utilizzate socialmente come condizioni comuni a più lavoratori. Nella cooperazione semplice e nella manifattura fondata sulla divisione del lavoro, questa trasformazione investe solo le condizioni di lavoro comuni, cioè che possono essere utilizzate collettivamente, come ad esempio gli edifici, ecc. Nell’officina dove si produce a macchina, basata sulle macchine, la trasformazione investe proprio i mezzi di lavoro. Come nella sottomissione formale del lavoro al capitale, queste condizioni, e pertanto anche la loro forma – trasformata proprio dalla stessa forma sociale del lavoro – rimangono per i lavoratori condizione estranea. Nella produzione a macchina questa contraddizione, o addirittura alienazione, si sviluppa, come vedremo più avanti, in contrapposizione ostile. Se ora torniamo alle macchine, è chiaro che il metodo di produzione a esse corrispondente trova la sua espressione di gran lunga più completa e più classica nell’officina automatica, in cui l’impiego delle macchine si pone come applicazione di un sistema reciproco di macchine, come un tutt’uno, costituente le diverse fasi dei processi meccanici, che hanno un proprio motore comune messo in moto meccanicamente, ossia un motore primario messo in moto da forze della natura. Ma l’officina automatica è in verità un modo di produzione compiuto, corrispondente alla macchina; e quanto più è un modo di produzione compiuto, quanto più forma un sistema completo di meccanismi, tanto meno l’esecuzione di singoli processi (come nei filatoi meccanici che non funzionano automaticamente) ha bisogno di mediazione da parte del lavoro umano.
La macchina esercita un’influenza negativa sul modo di produzione fondato nella manifattura sulla divisione del lavoro e sulla specializzazione dei lavoratori sulla base di questa divisione del lavoro. La macchina deprezza la forza-lavoro che si è cosi specializzata, in parte riducendola a semplice forza-lavoro astratta, e in parte realizzando sulla base di se stessa una nuova specializzazione della forza-lavoro, il cui tratto caratteristico consiste nella sua sottomissione passiva al movimento del meccanismo stesso, nel completo adattamento del lavoratore ai bisogni e alle necessità del meccanismo. L’officina meccanica sostituisce: 1. la manifattura fondata sulla divisione del lavoro; 2. l’autonoma impresa artigiana. Sebbene l’officina meccanica neghi: 1) la cooperazione, in quanto nell’officina meccanica la macchina sostituisce la forza creata dalla cooperazione; 2) la divisione del lavoro, in quanto nell’officina meccanica viene annullata sia la cooperazione basata sulla divisione del lavoro, sia la manifattura nonostante in essa abbiano luogo sia la cooperazione, sia la divisione del lavoro. La prima non ha bisogno di spiegazioni. È altresì indispensabile notare che in quanto nell’officina meccanica lavorano le macchine, che ne costituiscono la base materiale, la semplice cooperazione gioca in essa un ruolo di gran lunga più importante della divisione del lavoro.
Compare qui naturalmente una nuova divisione del lavoro, che è propria dell’officina meccanica e che deve essere analizzata nei particolari; pertanto la divisione del lavoro non è neppure stata annullata. È stato eliminato invece il lavoro più complesso comprendente i diversi aspetti dell’attività, ed è stato sostituito da un semplice lavoro meccanico. Per semplice lavoro meccanico noi intendiamo le azioni ausiliarie che l’uomo deve compiere quando agisce sulla macchina operatrice. Ma se questa macchina viene impiegata nella manifattura basata sulla divisione del lavoro, come è già dimostrato negli esempi summenzionati, allora il
120

suo diretto fondamento è la negazione della divisione del lavoro. La specializzazione raggiunta dalla forza-lavoro grazie alla divisione del lavoro scompare e nello stesso tempo la forza-lavoro è deprezzata, in quanto la manifattura necessita, come sistema, di una gerarchia di manodopera per far sì che a un lavoro più semplice, in un punto corrisponda un lavoro più complesso in un altro. Un lavoro ancor più semplice rimpiazza il già semplice lavoro, che tuttavia è specializzato e per questo il livello della sua specializzazione, per quanto mediocre possa apparire, veniva spinto sino al virtuosismo. E qui si dà costantemente origine a un esercito di lavoratori che è quello fondamentale, occupato nelle operazioni finali, e non in quelle preliminari, né nell’opera di sorveglianza.
Nell’officina meccanica l’ossatura del meccanismo collettivo consiste di diverse macchine, ciascuna delle quali compie particolari e differenti processi produttivi che si susseguono l’uno all’altro e sono necessari nel-l’intero processo di produzione. In questo caso non c’è una forza-lavoro particolarmente evoluta che si serve come il “virtuoso” di un particolare strumento di lavoro, ma viceversa uno strumento di lavoro ha bisogno di servi speciali e costantemente affiancati al suo lavoro. Nel primo caso il lavoratore è servito da un particolare strumento di lavoro, nel secondo, invece, particolari gruppi di lavoratori sono al servizio di macchine diverse che svolgono particolari processi. Al contrario il tratto distintivo dell’officina meccanica è il generale livellamento delle operazioni, di modo che il passaggio dei lavoratori effettivamente occupati nel lavoro a macchina da una macchina all’altra può verificarsi in un tempo assai breve e senza un particolare addestramento. Nella manifattura la divisione del lavoro è causata dal fatto che particolari lavori necessari possono essere compiuti solo da forza-lavoro particolarmente specializzata e, di conseguenza, in questo caso deve verificarsi non solo una distribuzione, ma anche un’effettiva divisione del lavoro in gruppi di specializzazioni. Nell’officina meccanica, al contrario, si specializzano proprio le macchine e il loro lavoro collettivo; sebbene le macchine eseguano anche operazioni successive di un unico processo comune, richiedono ugualmente la distribuzione di particolari gruppi di lavoratori, a cui sono costantemente affidate identiche, e per di più semplici, operazioni. Si tratta quindi piuttosto di una distribuzione di lavoratori tra macchine specializzate, che di una divisione del lavoro tra lavoratori specializzati. In un caso è specializzata la forza-lavoro che impiega particolari strumenti di lavoro; nell’altro sono specializzate le macchine che vengono servite da particolari gruppi di lavoratori. Per non parlare dei semplici ausiliari, di cui abbiamo già parlato e che ritornano anche qui, la principale differenza consiste ora nella forza e nella destrezza.
Tutte queste azioni sono degne di rilievo per la loro passività, per la loro capacità d’adattamento alle operazioni e ai movimenti della macchina, per la sottomissione ad essa. Questa specializzazione della passività, ossia l’annullamento della specializzazione stessa in quanto specializzazione, caratterizza il lavoro a macchina. Perfezionare l’officina meccanica significa far sì che, nei limiti delle possibilità, venga eliminato ogni virtuosismo, che tuttavia ricompare su una base più ristretta. Questo di conseguenza è un lavoro assai semplice: è caratterizzato dalla futilità e dalla subordinazione alla macchina operatrice. Esso frena lo sviluppo della specializzazione, ma nello stesso tempo specializza proprio la mancanza di specializzazione. Svaniscono qui le ultime tracce del sentimento di soddisfazione del proprio lavoro da parte del lavoratore, domina un’indifferenza assoluta, determinata dalla stessa facilità del lavoro. Ma la macchina collettiva è fatta di macchine che ne costituiscono le parti. Gli uomini sono semplicemente l’accessorio vivo, l’appendice cosciente della macchina incosciente ma uniformemente operante.
[MC. XIX]
I.3.3. Le contraddizioni dell’industria meccanica
Nelle manifatture, com’è stato accennato prima, la divisione del lavoro imperava con particolare rigore. Con l’aumentare delle invenzioni e con la crescente richiesta dì macchine di nuova invenzione, s’è sviluppata sempre più, da una parte, la suddivisione della fabbricazione delle macchine in molteplici branche indipendenti, dall’altra, la divisione del lavoro all’interno della manifattura di macchine. Dunque qui nella manifattura vediamo il fondamento tecnico immediato della grande industria. La manifattura ha prodotto il macchinario per mezzo del quale la grande industria ha eliminato la conduzione di tipo artigianale e manifatturiero nelle prime sfere della produzione delle quali s’è impadronita. Così la industria meccanica è sorta naturalmente e spontaneamente su una base materiale inadeguata; ad un certo grado di sviluppo ha dovuto rovesciare questa sua base che da principio s’era trovata bell’e fatta e che poi aveva continuato ad elaborare nell’antica forma, e s’è dovuta creare una nuova base, corrispondente al proprio modo dì produzione. Ma a un certo grado del suo sviluppo la grande industria entrò, anche tecnicamente, in conflitto con il suo sostrato artigianale e manifatturiero. L’estensione del volume delle macchine motrici, del meccanismo di trasmissione e delle macchine utensili; una maggior complessità e varietà e una più rigorosa regolarità delle sue parti costitutive, a misura che la macchina utensile si emancipava dal modello artigianale che originariamente ne domina la struttura, e riceveva una forma libera, determinata soltanto dal suo compito
121

meccanico; la elaborazione del sistema automatico e il fatto che divenisse sempre più inevitabile l’uso di materiale di difficile lavorazione – p. es. ferro invece di legno – la soluzione di tutti questi problemi che sorgevano spontaneamente urtava dappertutto contro i limiti delle persone, limiti che perfino il personale lavoratore combinato nella manifattura aveva infranto solo per il grado, non per la sostanza.
La rivoluzione del modo di produzione in una sfera dell’industria porta con sé la rivoluzione del modo di produzione nelle altre sfere. Questo vale in primo luogo per quelle branche dell’industria che sono sì isolate a causa della divisione sociale del lavoro, cosicché ognuna di esse produce una merce indipendente, ma tuttavia s’intrecciano l’una con l’altra come fasi d’un processo complessivo. Quindi la grande industria dovette impadronirsi del proprio caratteristico mezzo di produzione, la macchina stessa, e produrre macchine mediante macchine. Solo a questo modo essa creò il proprio sostrato tecnico adeguato e cominciò a muoversi da sola. Di fatto, col crescere della industria meccanica nei primi decenni del secolo XIX, le macchine s’impadronirono a poco a poco della fabbricazione delle macchine utensili. Tuttavia, soltanto durante gli ultimi decenni le enormi costruzioni di ferrovie e la navigazione a vapore transoceanica hanno dato vita alle ciclopiche macchine adoperate per la costruzione dei primi motori. La condizione di produzione più importante per la fabbricazione di macchine mediante macchine era una macchina motrice capace di ogni potenzialità di forza, eppure allo stesso tempo completamente controllabile. Questa macchina esisteva già; era la macchina a vapore. Ma si trattava anche di produrre meccanicamente le rigorose forme geometriche necessarie per le singole parti delle macchine, retta, piano, circolo, cilindro, cono e sfera.
Se ora consideriamo quella parte del macchinario adoprata nella costruzione delle macchine, che costituisce la vera e propria macchina utensile, vediamo riapparire lo strumento artigiano, ma di volume ciclopico. Nella manifattura l’articolazione del processo lavorativo sociale è puramente soggettiva, è una combinazione di lavoratori parziali; nel sistema delle macchine la grande industria possiede un organismo di produzione del tutto oggettivo, che il lavoratore trova davanti a sé, come condizione materiale di produzione già pronta. Nella cooperazione semplice e anche in quella specificata mediante la divisione del lavoro, la soppressione del lavoratore isolato da parte del lavoratore socializzato appare ancor sempre più o meno casuale. Il macchinario, con alcune eccezioni che ricorderemo più avanti, funziona soltanto in mano al lavoro immediatamente socializzato, ossia al lavoro in comune. Ora il carattere cooperativo del processo lavorativo diviene dunque necessità tecnica imposta dalla natura del mezzo di lavoro stesso. Abbiamo visto poi come il macchinario aumenti il materiale umano sottoposto allo sfruttamento del capitale mediante l’appropriazione del lavoro delle donne e dei fanciulli, come esso confischi tutto il periodo di vita del lavoratore mediante una estensione smisurata della giornata lavorativa, e come il suo progresso, il quale consente di fornire in un tempo sempre più breve un prodotto in enorme aumento, serva infine da mezzo sistematico per rendere liquida una maggiore quantità dì lavoro in ogni momento, ossia, per sfruttare sempre più intensamente la forza-lavoro.
Passiamo ora a considerare l’insieme della fabbrica e precisamente nel suo aspetto più perfezionato. Il dott. Ure, che è il Pindaro della fabbrica automatica, la descrive da un lato come “cooperazione di classi diverse di lavoratori, adulti e non adulti, i quali sorvegliano con abilità e diligenza un sistema di meccanismi produttivi, ininterrottamente mosso da una forza centrale” (il primo motore), dall’altro come “un automa enorme, composto di innumerevoli organi meccanici e autocoscienti, i quali agiscono in vicendevole accordo e senza interruzione per produrre uno stesso oggetto, cosicché tutti questi organi sono subordinati a una sola forza motrice semovente”. Queste due espressioni non sono affatto identiche. Nell’una il lavoratore complessivo combinato ossia il corpo lavorativo sociale appare come soggetto dominante, e l’automa meccanico appare come oggetto; nell’altra l’automa stesso è il soggetto, e i lavoratori sono coordinati ai suoi organi incoscienti solo quali organi coscienti e insieme a quelli sono subordinati a quella forza motrice centrale. La prima espressione vale per qualsiasi applicazione del macchinario su larga scala, l’altra caratterizza la sua applicazione capitalistica e quindi il moderno sistema di fabbrica. A Ure piace quindi anche rappresentare la macchina centrale da cui parte il movimento, non solo come automa ma corno autocrate. “In queste grandi officine la benefica potenza del vapore raccoglie intorno a se le miriadi dei suoi sudditi”.
Insieme allo strumento da lavoro anche la virtuosità nell’usarlo trapassa dal lavoratore alla macchina. La capacità d’azione dell’utensile viene emancipata dai limiti personali della forza-lavoro umana, quindi si ha soltanto una cooperazione semplice fra i lavoratori. Con ciò è soppressa la base tecnica su cui si fonda la divisione del lavoro nella manifattura. Alla gerarchia di lavoratori specializzati che caratterizza quest’ultima, subentra quindi nella fabbrica automatica la tendenza dell’eguagliamento ossia del livellamento dei lavori da compiersi dagli addetti al macchinario, alle differenze prodotte ad arte fra i lavoratori addetti a singole parti subentrano in prevalenza le differenze naturali dell’età e del sesso, quindi si ha soltanto una cooperazione semplice fra i lavoratori. Il gruppo articolato della manifattura è sostituito dal nesso fra lavoratore capo e alcuni pochi aiutanti. Oltre a queste classi principali si ha un personale numericamente insignificante che si occupa del controllo del macchinario nel suo insieme e della sua
122

costante riparazione, come ad es. ingegneri, meccanici, carpentieri, ecc. Si tratta di una classe operaia superiore, in parte scientificamente istruita, in parte di tipo artigiano, che è al di fuori della sfera dei lavoratori di fabbrica ed è soltanto aggregata ad essi. Questa divisione del lavoro è puramente tecnica.
Ogni lavoro alla macchina richiede che il lavoratore sia addestrato molto presto affinché impari ad adattare il proprio movimento al movimento uniforme e continuativo di una macchina automatica. In quanto il macchinario complessivo costituisce esso stesso un sistema di molteplici macchine che operano simultaneamente e combinate, anche la cooperazione basata su di esso richiede una distribuzione di differenti gruppi lavoratori fra le differenti macchine. I servizi dei semplici manovali nella fabbrica sono a loro volta in parte sostituibili con macchine, in parte consentono a causa della loro assoluta semplicità un rapido e costante cambiamento delle persone caricate di questo tedioso lavoro. Ora, benché il macchinario distrugga tecnicamente il vecchio sistema della divisione del lavoro, in un primo tempo questo sistema si trascina nella fabbrica per consuetudine come tradizione della manifattura, per essere poi riprodotto e consolidalo sistematicamente dal capitale quale mezzo di sfruttamento della forza-lavoro in una forma ancor più schifosa.
Dalla specialità di tutt’una vita, consistente nel maneggiare uno strumento parziale, si genera la specialità di tutt’una vita, consistente nel servire una macchina parziale. Del macchinario si abusa per trasformare il lavoratore stesso, fin dall’infanzia, nella parte di una macchina parziale. “La malinconica svogliatezza di un tormento di lavoro senza fine, per cui si torna sempre a ripercorrere lo stesso processo meccanico, assomiglia al tormento di Sisifo; la mole del lavoro, come la roccia, torna sempre a cadere sul lavoratore spossato” [Engels]. Il lavoro alla macchina intacca in misura estrema il sistema nervoso, sopprime l’azione molteplice dei muscoli e confisca ogni libera attività fisica e mentale. La stessa facilità del lavoro diventa un mezzo di tortura, giacché la macchina non libera dal lavoro il lavoratore, ma toglie il contenuto al suo lavoro. Mediante la sua trasformazione in macchina automatica, il mezzo di lavoro si contrappone al lavoratore durante lo stesso processo lavorativo quale capitale, quale lavoro morto che domina e succhia la forza-lavoro vivente. La scissione fra le potenze mentali del processo di produzione e il lavoro manuale, la trasformazione di quelle in poteri del capitale sul lavoro, si compie, come è già stato accennato prima, nella grande industria edificata sulla base delle macchine.
La subordinazione tecnica del lavoratore all’andamento uniforme dei mezzi di lavoro e la peculiare composizione del corpo lavorativo, fatto di individui d’ambo i sessi e di diversissimi gradi d’età, creano una disciplina da caserma che si perfeziona e diviene un regime di fabbrica completo e porta al suo pieno sviluppo il lavoro di sorveglianza già prima accennato. Il codice della fabbrica in cui il capitale formula come privato legislatore e arbitrariamente la sua autocrazia sui lavoratori, prescindendo da quella divisione dei poteri tanto cara alla borghesia e da quel sistema rappresentativo che le è ancor più caro, non è che la caricatura capitalistica della regolazione sociale del processo lavorativo; regolazione che diventa necessaria con la cooperazione su grande scala e con l’uso dei mezzi di lavoro comuni, specialmente delle macchine. Alla frusta del sorvegliante di schiavi subentra il registro delle punizioni del sorvegliante. Il nostro non è che un semplice accenno alle condizioni materiali in cui viene compiuto il lavoro di fabbrica. Tutti i sensi sono lesi egualmente dalla temperatura aumentata artificiosamente, dall’atmosfera impregnata delle scorie delle materie prime, dal chiasso assordante, ecc., astrazion fatta dal pericolo di morte che si cela nell’ammucchiamento di macchine una vicinissima all’altra, che produce con la regolarità del susseguirsi delle stagioni, i propri bollettini industriali di battaglia. L’economizzazione dei mezzi sociali di produzione, che giunge a maturazione come in una serra soltanto nel sistema di fabbrica, diviene allo stesso tempo, nelle mani del capitale, depredazione sistematica delle condizioni di vita del lavoratore durante il lavoro, dello spazio, dell’aria, della luce e dei mezzi personali di difesa contro le circostanze implicanti il pericolo di morte o antiigieniche del processo di produzione, per non parlare dei provvedimenti miranti alla comodità del lavoratore. Ha torto Fourier a chiamare le fabbriche “ ergastoli mitigati”?
[C. I,13]
Il suo principio fondamentale è la sostituzione del lavoro qualificato con il lavoro semplice; e quindi anche la riduzione della massa del salario al salario medio, ossia la riduzione del lavoro necessario del lavoratore al minimo medio e la riduzione dei costi di produzione della capacità dì lavoro ai costi di produzione della capacità di lavoro semplice. Nella misura in cui il macchinario esce dal suo stadio infantile, si differenzia dalle dimensioni e dal carattere dello strumento artigianale, che originariamente sostituisce, diventa più voluminoso e più caro, richiede più tempo di lavoro per la sua produzione, il suo valore assoluto sale, benché diventi relativamente più a buon mercato, vale a dire benché il macchinario più efficiente costi meno, in rapporto alla sua efficienza, di quello meno efficiente, vale a dire benché la quantità di tempo di lavoro che costa la sua produzione aumenti in proporzione molto minore della quantità di tempo di lavoro che esso sostituisce. In ogni caso, però, il suo alto costo assoluto sale progressivamente, quindi esso aggiunge alla merce che produce un valore in assoluto maggiore, specie in confronto agli arnesi artigianali o
123

anche agli strumenti semplici e che poggiano sulla divisione del lavoro, che il macchinario sostituisce nel processo di produzione. Che ora la merce prodotta con uno strumento di produzione più caro sia più a buon mercato di quella prodotta senza di esso; che il tempo di lavoro contenuto nello stesso macchinario sia minore di quello da esso sostituito, dipende da due circostanze:
1) Quanto maggiore è l’efficienza del macchinario, tanto più esso eleva la forza produttiva del lavoro; nella proporzione nella quale rende un lavoratore capace di eseguire il lavoro di molti lavoratori, aumenta la massa dei valori d’uso e perciò delle merci che vengono prodotte con l’ausilio del macchinario nello stesso tempo di lavoro. Si accresce cosi il numero delle merci nelle quali riappare il valore del macchinario. Il valore complessivo del macchinario riappare soltanto nella complessività della merce la cui produzione ha assistito come mezzo di lavoro; questo valore complessivo si ripartisce in parti aliquote tra le singole merci dalla cui somma è costituita la massa complessiva. Quindi, quanto maggiore è questa massa complessiva, tanto minore è la componente di valore del macchinario che riappare nella singola merce. Nonostante la differenza di valore tra il macchinario e l’arnese artigiano o il semplice strumento di lavoro, nella merce entrerà una parte componente di valore minore per il macchinario che per lo strumento di lavoro e per la capacità di lavoro che la macchina sostituisce, nella stessa proporzione nella quale il valore della macchina si ripartisce su di una somma complessiva di prodotti, di merci, maggiore.
2) Già nella manifattura che riposa sulla divisione del lavoro, come nell’attività artigianale e così via, si trova che gli strumenti di lavoro (parimenti un’altra componente delle condizioni di lavoro, come i fabbricati) entrano nel processo lavorativo in tutta la loro ampiezza o direttamente come i mezzi di lavoro o indirettamente come condizioni (tipo i fabbricati) che sono necessarie affinché si svolga il processo lavorativo. Ma essi entrano solo per parti, per porzioni, nel processo di valorizzazione – cioè soltanto per quel tanto della loro ampiezza che corrisponde alla loro utilizzazione nel processo lavorativo, che corrisponde alla misura in cui con il loro valore d’uso viene in pari tempo consumato, nel processo lavorativo, il loro valore di scambio. Il loro valore di scambio riappare quindi per intero soltanto nella somma complessiva delle merci nella cui produzione essi sono serviti durante un tale periodo – durante l’intero periodo, dal loro ingresso nel processo lavorativo alla loro uscita dal processo. Perciò in ogni singola merce entra soltanto una determinata parte aliquota del loro valore.
Con l’introduzione del macchinario, con la quale i mezzi di lavoro assumono grandi dimensioni di valore e si rappresentano in voluminosi valori d’uso, cresce questa differenza tra processo lavorativo e processo di valorizzazione ed essa diventa un momento significativo nello sviluppo della forza produttiva e nel carattere, della produzione. Il lavoro passato, oggettivato, entra qui in grande quantità nel processo lavorativo, mentre solo una parte relativamente insignificante di questa parte del capitale si consuma nello stesso processo lavorativo, entra, quindi, nel processo di valorizzazione e perciò riappare come parte di valore nel prodotto. Perciò, per quanto cospicua sia la grandezza di valore rappresentata dal macchinario che entra nel processo lavorativo e dai fabbricati ecc. dati con esso, nel processo quotidiano di valorizzazione, quindi nel valore della merce, ne entra sempre soltanto una parte relativamente piccola se confrontata con questa massa complessiva di valore. Questa parte rincara relativamente la merce, ma solo in misura insignificante e in ogni caso di molto inferiore a quanto l’avrebbe rincarata il lavoro manuale sostituito dal macchinario.
È soltanto con il macchinario che la produzione sociale acquista la forza, su vasta scala, di fare entrare per intero nel processo lavorativo come mezzi di produzione prodotti che rappresentano una grande quantità di lavoro passato, quindi grandi masse di valore, mentre solo una parte aliquota relativamente piccola di essi entra nel processo di valorizzazione che si svolge durante il singolo processo lavorativo. Il capitale che entra in questa forma in ogni singolo processo lavorativo è grande, ma la proporzione nella quale il suo valore d’uso viene usurato, consumato durante questo processo lavorativo, e perciò il suo valore deve essere sostituito, è relativamente piccola. Il macchinario agisce per intero come mezzo di lavoro, ma aggiunge valore al prodotto solo nella misura in cui il processo lavorativo lo svalorizza, una svalorizzazione che è determinata dal grado di logoramento del suo valore d’uso durante il processo lavorativo. Dal grado in cui il lavoro viene sostituito dal macchinario, quindi dal grado, in cui la massa di capacità di lavoro che viene adoperata in relazione alla massa del prodotto viene quanto più possibile ridotta, la massima quantità possibile di capacità di lavoro viene sostituita dal macchinario e la parte del capitale anticipata in lavoro appare relativamente piccola rispetto alla parte del capitale anticipata in macchinario.
Una delle prime conseguenze dell’introduzione di nuovo macchinario, prima che esso sia diventato dominante nel suo ramo di produzione, è il prolungamento del tempo di lavoro dei lavoratori che continuano a lavorare con i vecchi e imperfetti mezzi di produzione. La merce prodotta con il macchinario, anche se venduta al di sopra del suo valore individuale, vale a dire al di sopra della quantità di tempo di lavoro in essa contenuto, è venduta al di sotto del precedente valore sociale, generale, dello stesso genere di prodotto. Il tempo di lavoro socialmente necessario alla produzione di questa determinata merce è perciò diminuito, ma non quello per i lavoratori che lavorano con i vecchi strumenti di produzione. Il tempo di lavoro assoluto – la giornata lavorativa complessiva – non viene ridotta, ma prolungata. La mutata forma del lavoro, la sua
124

apparente leggerezza, riversa sul macchinario ogni sforzo muscolare, e così pure l’abilità. Per questa ragione innanzi tutto il prolungamento non raggiunge l’impossibilità fisica; in secondo luogo si spezza l’opposizione del lavoratore, al quale la sua maestria ancora dominante nella manifattura, ma ora infranta, non consente più di ribellarsi; al contrario essa consente, anzi, al capitale di sostituire i lavoratori abili con lavoratori meno abili e perciò più soggetti al suo controllo. Poi la nuova classe di lavoratori, che subentra ora come elemento determinante, muta il carattere di tutto l’atelier e per sua natura è più docile al dispotismo del capitale. Cioè, specificamente: l’elemento del lavoro femminile e minorile.
Il prolungamento della giornata oltre i suoi limiti naturali, il lavoro notturno, è un risultato del sistema di fabbrica. Con l’introduzione di nuovo macchinario si susseguono migliorie l’una dopo l’altra. Pertanto, una gran parte del vecchio macchinario viene continuamente svalorizzato o diventa del tutto inutilizzabile prima di avere percorso il suo periodo di circolazione, ossia prima che il suo valore riappaia nel valore delle merci. Quanto più è ridotto il periodo della riproduzione, tanto minore è questo periodo e tanto maggiore è la possibilità per il capitalista, dopo che il valore del macchinario è tornato a lui entro termine più breve, di introdurre il nuovo macchinario perfezionato e di vendere il vecchio a buon mercato; quest’ultimo può essere nuovamente impiegato con utilità da un altro capitalista, poiché fin dall’inizio entra nella sua produzione come rappresentante di una grandezza di valore minore. Tuttavia per il capitalista non si tratta affatto semplicemente di questo, di riottenere restituita, quanto più presto è possibile, la massa di valore anticipata nel capitale fisso, di prevenirne la svalorizzazione e di possederla nuovamente in una forma disponibile, ma si tratta soprattutto dell’impiego profittevole di questo capitale, della grande massa del capitale incorporato in una forma nella quale, fintanto che non viene messo in contatto con il genere di lavoro vivo di cui esso costituisce il capitale fisso, va tanto in rovina come valore di scambio quanto è inutile come valore d’uso. Poiché la parte di capitale anticipata nel salario si è di molto ridotta rispetto al capitale complessivo, e anche specialmente rispetto al capitale fisso, e poiché la grandezza del plusvalore non dipende soltanto dal suo tasso, ma anche dal numero delle giornate lavorative impiegate simultaneamente, mentre il profitto dipende dal rapporto di questo plusvalore con il capitale complessivo, si ha allora una riduzione del tasso di profitto.
Naturalmente il mezzo più semplice per impedire questa riduzione è di prolungare, per quanto è possibile, il plusvalore assoluto mediante il prolungamento della giornata lavorativa e di trasformare cosi il capitale fisso in mezzo per appropriarsi della maggiore quantità possibile di lavoro non pagato. Se la fabbrica resta inoperosa, il fabbricante considera questo fatto come se i lavoratori lo derubassero; giacché nel capitale fisso il suo capitale ha ricevuto una forma nella quale esso è direttamente disposizione sul lavoro altrui. Perciò, non appena la concorrenza ha ridotto il prezzo della merce prodotta con il macchinario al suo valore, l’impie-go del macchinario può aumentare il plusvalore, il guadagno del capitalista, solo in quanto, per effetto del ribasso della merce, viene ribassato il valore del salario, ossia il valore della capacità di lavoro, o il tempo necessario alla sua riproduzione. Tuttavia qui si aggiunge la circostanza grazie alla quale, anche senza prolungamento della giornata lavorativa, l’impiego del macchinario aumenta il tempo di lavoro assoluto e perciò il plusvalore assoluto. Questo avviene, per così dire, attraverso la condensazione del tempo di lavoro, giacché ogni frazione di tempo viene riempita con più lavoro; l’intensità del lavoro cresce; mediante l’impiego del macchinario non solo aumenta la produttività (quindi la qualità) del lavoro, ma aumenta anche la quantità di lavoro in un dato intervallo di tempo. I pori del tempo vengono per così dire rimpiccioliti dalla compressione del lavoro. In ogni caso questo effetto dell’accorciamento del tempo di lavoro assoluto ci mostra come i fabbricanti progettino mezzi per prolungare il tempo di pluslavoro, per abbreviare quello necessario. Ci mostra in pari tempo come il macchinario non renda soltanto il singolo capace di eseguire il lavoro di molti, ma aumenti anche la quantità di lavoro che gli è richiesta, attribuisca così all’ora di lavoro un valore superiore e con ciò diminuisca il tempo relativamente necessario per il lavoratore stesso ai fini della riproduzione del salario. Questo accade, come si è detto, grazie all’aumento della velocità della macchina e alla maggiore quantità di macchinario operante che il singolo lavoratore deve sorvegliare.
[ME. V]
I.3.4. L’uso capitalistico delle macchine
La lotta fra capitalista e lavoratore salariato comincia con il rapporto capitalistico stesso e continua a infuriare durante tutto il periodo manifatturiero. Ma soltanto dopo l’introduzione delle macchine il lavoratore combatte proprio il mezzo di lavoro stesso, ossia il modo materiale di esistenza del capitale. Si rivolta contro questa forma determinata del mezzo di produzione come fondamento materiale del modo capitalistico di produzione. Ci vuole tempo ed esperienza affinché il lavoratore apprenda a distinguere le macchine dal loro uso capitalistico, e quindi a trasferire i suoi attacchi dal mezzo materiale di produzione stesso alla forma sociale di sfruttamento di esso. Come macchina, il mezzo di lavoro diviene subito concorrente del lavoratore stesso. La autovalorizzazione del capitale mediante la macchina sta in rapporto diretto col numero dei
125

lavoratori dei quali la macchina distrugge le condizioni di esistenza. Tutto il sistema della produzione capitalistica poggia sul fatto che il lavoratore vende la sua forza-lavoro come merce. La divisione del lavoro rende unilaterale questa forza-lavoro, facendone una abilità del tutto particolarizzata di maneggiare uno strumento parziale. Appena il maneggio dello strumento è affidato alla macchina, si estingue il valore d’uso e con esso il valore di scambio della forza-lavoro. Il lavoratore diventa invendibile, come carta moneta fuori corso.
Il mezzo di lavoro schiaccia il lavoratore. Certo questo antagonismo diretto si presenta in maniera più tangibile tutte le volte che macchine introdotte per la prima volta si trovano in concorrenza con l’industria tradizionale artigiana o manifatturiera. Ma anche all’interno della grande industria il continuo perfezionamento delle macchine e lo sviluppo del sistema automatico hanno effetti analoghi. Tuttavia la macchina non agisce soltanto come concorrente strapotente, sempre pronto a rendere “superfluo” il lavoratore salariato. Il capitale la proclama apertamente e consapevolmente potenza ostile al lavoratore e come tale la maneggia. Essa diventa l’arma più potente per reprimere le insurrezioni periodiche dei lavoratori, gli scioperi, ecc. contro la autocrazia del capitale. È un dato di fatto indubbio che le macchine in sé non sono responsabili di questa “liberazione” dei lavoratori dai mezzi di sussistenza. Le macchine riducono più a buon mercato e aumentano il prodotto nella branca che conquistano e in un primo momento lasciano inalterata la massa di mezzi di sussistenza prodotta in altre branche dell’industria. Dunque la società possiede, prima e dopo la loro introduzione, altrettanti mezzi di sussistenza, o anche di più, per i lavoratori spostati, astrazion fatta completamente dalla enorme parte del prodotto annuo che viene sperperata da non-lavoratori. E qui sta il punto culminante dell’apologetica economicistica! Le contraddizioni e gli antagonismi inseparabili dall’uso capitalistico delle macchine non esistono perché non provengono dalle macchine stesse, ma dal loro uso capitalistico.
Poiché dunque le macchine, considerate in sé, abbreviano il tempo di lavoro mentre, adoprate capitalisticamente, prolungano la giornata lavorativa, poiché le macchine in sé alleviano il lavoro e adoprate capitalisticamente ne aumentano l’intensità, poiché in sé sono una vittoria dell’uomo sulla forza della natura e adoprate capitalisticamente soggiogano l’uomo mediante la forza della natura, poiché in sé aumentano la ricchezza del produttore e usate capitalisticamente lo pauperizzano, ecc., l’economista borghese dichiara semplicemente che la considerazione delle macchine in sé dimostra con la massima precisione che tutte quelle tangibili contraddizioni sono una pura e semplice parvenza della ordinaria realtà, ma che in sé, e quindi anche nella teoria, non ci sono affatto. Così risparmia di doversi ulteriormente stillare il cervello, e per giunta addossa al suo avversario la sciocchezza di combattere non l’uso capitalistico delle macchine, ma le macchine stesse. Non occorre un acume particolare per comprendere che, partendo per esempio dal lavoro libero, o lavoro salariato, scaturito dalla dissoluzione della servitù della gleba, le macchine possono nascere solamente in antitesi al lavoro vivo, in quanto proprietà altrui e potere ostile ad esso contrapposti; ossia che esse gli si devono contrapporre, come capitale. Ma è altrettanto facile capire che le macchine non cesseranno di essere agenti della produzione sociale quando per esempio diventeranno proprietà degli lavoratori associati. L’economista borghese non nega affatto che dall’uso capitalistico delle macchine provengano anche inconvenienti temporanei: ma dov’è la medaglia senza rovescio? Per lui è impossibile adoprare le macchine in modo differente da quello capitalistico. Dunque per lui sfruttamento del lavoratore mediante la macchina è identico a sfruttamento della macchina mediante il lavoratore. Dunque, chi rivela come stanno in realtà le cose quanto all’uso capitalistico delle macchine, non vuole addirittura che le macchine siano adoprate in genere, è un avversario del progresso sociale!
Il primo risultato delle macchine è di ingrandire il plusvalore e insieme la massa di prodotti nella quale esso si presenta, e dunque di ingrandire, assieme alla sostanza di cui si nutrono la classe dei capitalisti e le sue appendici, questi stessi strati della società. La crescente loro ricchezza e la diminuzione relativamente costante del numero dei lavoratori richiesti per la produzione dei mezzi di sussistenza di prima necessità, generano un nuovo bisogno di lusso e insieme nuovi mezzi per soddisfarlo. Una parte abbastanza grande del prodotto sociale si trasforma in plusprodotto, e una parte abbastanza grande del plusprodotto viene riprodotta e consumata in forme raffinate e variate. In altre parole: cresce la produzione dì lusso. La raffinatezza e la varietà dei prodotti deriva anche e nella stessa misura dalle nuove relazioni col mercato mondiale create dalla grande industria. Ormai non solo si scambiano mezzi di consumo stranieri con il prodotto interno, ma inoltre nella industria nazionale affluisce una massa rilevante di materie prime, di ingredienti, di semilavorati, ecc. stranieri come mezzi di produzione. Assieme a queste relazioni col mercato mondiale cresce la richiesta di lavoro nella industria dei trasporti, che a sua volta si scinde in numerose nuove sottospecie. Infine, lo straordinario aumento raggiunto dalla forza produttiva nelle sfere della grande industria, accompagnato co-m’è da un aumento, tanto in estensione che in intensità, dello sfruttamento in tutte le restanti sfere della produzione, permette di adoprare improduttivamente una parte sempre maggiore della classe operaia, e quindi di riprodurre specialmente gli antichi schiavi domestici sotto il nome di “classe dei servitori”, come
126

domestici, serve, lacchè, ecc. sempre più in massa. Che edificante risultato dello sfruttamento capitalistico delle macchine!
[C. I,13]
L’intera rappresentazione borghese apologetica del macchinario non nega: 1. che il macchinario, ora qui ora là, ma continuamente rende eccedente una parte della popolazione, getta sul lastrico una parte della popolazione lavoratrice. Produce sovrapopolazione (quindi abbassamento del salario in alcune sfere, ora qui, ora là) non perché la popolazione cresca più rapidamente dei mezzi di sussistenza, ma perché il rapido crescere dei mezzi di sussistenza per effetto del macchinario permette di introdurre più macchinario e di ridurre perciò la domanda immediata di lavoro. Non perché diminuisca il fondo sociale, ma perché per effetto del suo crescere diminuisce relativamente la parte del medesimo che è speso in salari; 2. Ancor meno questa apologetica nega la schiavitù degli stessi lavoratori addetti alle macchine e la miseria degli operai manuali o artigiani soppiantati e mandati in rovina da esse. Quel che essa – e in parte giustamente – assicura, è in primo luogo che per effetto del macchinario (in generale dello sviluppo della forza produttiva del lavoro) il reddito netto (profitto e rendita) crescono a tal punto che il borghese ha bisogno di più lavoratori domestici di prima; se prima egli ha dovuto spendere del suo prodotto più in lavoro produttivo, ora egli può spendere di più in lavoro improduttivo, così che dunque aumentano i servi e altri lavoratori che vivono della classe improduttiva. Questa progressiva trasformazione di una parte dei lavoratori in servi è una bella prospettiva. Altrettanto confortante è per essi il fatto che per effetto della crescita del prodotto netto si aprono al lavoro improduttivo più sfere che vivono del loro prodotto e il cui interesse concorre plus ou moins, nel loro sfruttamento, con quello delle classi direttamente sfruttatrici!
In secondo luogo che per effetto dello sprone che viene dato all’accumulazione, sulla nuova base – in cui è necessario meno lavoro vivo in rapporto a quello passato – anche i lavoratori esclusi, pauperizzati o almeno la parte dell’incremento di popolazione che li rimpiazza o viene assorbita dall’ampliamento degli affari nelle stesse industrie di macchine oppure nelle attività indirette che sono diventate necessarie a causa di esso e sono aperte, oppure in nuovi campi d'impiego aperti dal nuovo capitale e che soddisfano nuovi bisogni. Questa è la seconda bella prospettiva secondo cui la classe operaia deve sopportare tutti gli “inconvenienti temporanei” – espulsione dal lavoro, dislocazione di lavoro e capitale – ma tuttavia non è perciò posto fine al lavoro salariato, questo anzi viene riprodotto su scala sempre crescente, crescente in senso assoluto, anche se relativamente decrescente in rapporto al capitale complessivo crescente che lo impiega. In terzo luogo che il consumo si raffina per effetto del macchinario. L’abbassamento del costo dei bisogni vitali immediati consente di ampliare l’àmbito della produzione di lusso. E così i lavoratori hanno questa terza bella prospettiva, che per ottenere i loro oggetti di prima necessità, lo stesso ammontare dei medesimi, lo stesso numero di lavoratori metterà in grado le classi più elevate di estendere, raffinare e diversificare l’ambito dei loro godimenti e di approfondire così l’abisso economico, sociale e politico che li separa da quelli che stanno meglio di loro. Belle prospettive, queste, e risultati davvero desiderabili per il lavoratore, quelli che derivano dallo sviluppo delle forze produttive del suo lavoro.
Ci sono due tendenze che s’incrociano continuamente; in primo luogo impiegare meno lavoro possibile per produrre la stessa o una maggiore quantità di merci, in secondo luogo impiegare un numero di lavoratori più grande possibile (benché più piccolo possibile in rapporto alla quantità delle merci da essi prodotte), perché con la massa del lavoro impiegato – ad un dato grado della forza produttiva – cresce la massa del plusvalore e del plusprodotto. L’una tendenza scaraventa sul lastrico i lavoratori e rende una popolazione eccedente, l’altra l’assorbe di nuovo ed allarga in senso assoluto la “schiavitù salariata”, così che il lavoratore oscilla sempre nella sua sorte e tuttavia non se ne libera mai. Perciò il lavoratore considera lo sviluppo delle forze produttive del suo proprio lavoro come a lui ostile, e con ragione; d’altro canto il capitalista lo tratta come un elemento da allontanare continuamente dalla produzione. Il continuo accrescimento delle classi medie che si trovano nel mezzo fra lavoratori da una parte, capitalisti e proprietari fondiari dall’altro, e che direttamente si nutrono in sempre maggior ampiezza e in gran parte del reddito, gravano come un peso sulla sottostante base lavoratrice e aumentano la sicurezza e la potenza sociale dei diecimila sovrastanti.
[TP. II,17-18]
Se a causa delle macchine si riduce la massa di lavoratori occupati in un ramo della produzione, con la contemporanea riduzione del salario conseguente alla diminuzione del prezzo delle merci, che rientrano fra quelle usate dai lavoratori, allora si riduce contemporaneamente il salario in tutti i rimanenti rami della produzione capitalistica in cui questa riduzione non si verifica, poiché si riduce il valore di uno degli elementi che la costituiscono. Nel dato caso viene utilizzata la stessa massa di lavoro di prima, ma con un capitale minore. Di conseguenza, viene disimpegnata una parte di capitale che prima veniva anticipata in salari. Questo capitale così disimpegnato può essere impiegato per ampliare gli stessi rami della produzione,
127

oppure investito. E poiché le macchine rientrano nell’una o nell’altra ipotesi (non si tratta più ormai dell’aumento del valore d’uso del reddito e che perciò la maggior parte di quest’ultimo può essere riconvertita in capitale), allora di conseguenza il capitale si disimpegna costantemente. Questa azione si verifica naturalmente con più lentezza di quanto non avvenga con la sostituzione dei lavoratori con le macchine. La macchina può sempre sostituire lavoratori che lavorino sia come artigiani indipendenti, sia nella manifattura basata sulla divisione del lavoro, non appena il prezzo della merce è perciò diminuito, e questo fenomeno si verifica ogni volta che la quota del valore, imputabile in ogni singola merce all’usura delle macchine, è minore del valore che la merce acquista con il lavoro sostituito dalla macchina. Poiché inoltre la macchina sostituisce il lavoro, va da sé che nella singola merce si somma meno lavoro vivo, oppure meno lavoro vivo produce una massa di merce uguale o maggiore di prima.
Ma poiché in seguito all’impiego delle macchine si è ridotto il numero di lavoratori messi in moto da un capitale di una data grandezza, si è ridotta anche la quantità comune di lavoro vivo messo in moto da questo capitale. Perché ora il plusvalore rimanga lo stesso, deve crescere relativamente, cioè una parte maggiore di prima di lavoro comune deve costituire pluslavoro, che è lo stesso, un minor numero di lavoratori deve produrre la stessa quantità di pluslavoro prodotta prima da un numero maggiore. Così per far sì che l’introduzione delle macchine arrechi al capitalista maggior plusvalore su un dato capitale, il plusvalore dovrebbe crescere in assoluto, cioè un numero minore di lavoratori non dovrebbe produrre altrettanto, ma più pluslavoro di quanto prima produceva un numero maggiore di lavoratori. Cade solo il salario – per non dire che un lavoro complesso si trasforma in lavoro semplice – in quanto nell’uso del lavoratore entrano merci più a buon prezzo prodotte a macchina, e pertanto cade anche il prezzo della riproduzione della forza-lavoro; il valore della forza-lavoro diminuisce e per questo il salario riflette un valore minore.
È chiaro quindi che questa diminuzione del salario a causa delle macchine non è contemporanea all’intro-duzione di queste ultime, ma graduale; ma non appena le merci prodotte a macchina sono dovunque rivalutate, il plusvalore aumenta non solo nel ramo in cui esse sono state introdotte, ma anche in tutti i rami della produzione, poiché si è verificata una diminuzione generale di uno degli elementi della forza-lavoro. Il plusvalore è aumentato, e persino in misura maggiore in quei rami in cui non sono state introdotte le macchine, poiché queste branche, pur occupando lo stesso numero di lavoratori di prima, li pagano di meno. Questo, di conseguenza, non serve a definire il ramo dell’industria che ha introdotto le macchine. Quanto più le macchine riducono il numero di lavoratori messi in moto da un dato capitale, tanto meno è possibile che la rimanente parte di lavoratori riesca a produrre una massa di pluslavoro maggiore o uguale a quella ottenuta dai lavoratori sostituiti, per quanto possa essere cresciuto il tempo di lavoro aggiunto relativo, durante il quale lavorano.
[MC. XX]
I.3.5. Le implicazioni sociali del macchinismo capitalistico
Il capitalista che introduce per primo le macchine in un singolo ramo della produzione, produce merce in un tempo di lavoro minore di quello generalmente necessario. Il valore individuale della merce è perciò inferiore al suo valore sociale. Di conseguenza, finché la produzione a macchina non sarà quella ovunque dominante in questo ramo della produzione, il capitalista può vendere questa merce a un prezzo maggiore del suo valore individuale, sebbene egli la venda a un prezzo inferiore al suo valore sociale. Il lavoro dei suoi lavoratori diventa lavoro superiore, lavoro a un livello più alto della media, e il prodotto del lavoro ha per questo un valore più alto. La macchina in tanto causa l’abbassamento immediato del salario dei lavoratori che occupa, in quanto riduce il salario dei lavoratori occupati, ad esempio, in seguito all’aumento dell’offerta di manodopera da parte dei lavoratori rimasti senza lavoro. La quantità di forza-lavoro che un dato capitale può acquistare dipende evidentemente dal valore di questa, Dal momento che l’aumento della forza produttiva del lavoro svaluta la forza-lavoro, aumenta la quantità di lavoratori occupati contemporaneamente. Gli stessi mezzi che aumentano il tasso di plusvalore relativo o diminuiscono il tempo di lavoro necessario, aumentano così la massa del plusvalore, e non solo perché aumentano il tasso dello sfruttamento di ciascun lavoratore, ma anche perché dallo stesso capitale con lo stesso tasso si possono sfruttare più lavoratori.
Di conseguenza, l’aumento del plusvalore si verifica non solo perché è aumentato il tasso del plusvalore, ma anche perché cresce la massa di lavoratori sfruttati dallo stesso capitale. Il plusvalore relativo è perciò il risultato non solo di una diminuzione del tempo di lavoro necessario, ma nello stesso tempo anche dell’au-mento del numero di lavoratori sfruttati dal capitale. Per questo l’aumento del plusvalore relativo coincide con la diminuzione del tasso del tempo di lavoro necessario, poiché questi toccano contemporaneamente entrambi i fattori del plusvalore, sia il tasso del plusvalore sia il numero di lavoratori sfruttati dal capitale. Tutto questo non contraddice in nessun modo la legge secondo cui con lo sviluppo delle forze produttive e,
128

di conseguenza, della produzione capitalistica, il rapporto tra il capitale variabile, cioè tra il capitale speso in salari, e tutto il capitale è diminuito, poiché è diminuito il suo rapporto col capitale costante. Il numero di lavoratori messi in moto dal capitale variabile è relativamente aumentato, sebbene il capitale variabile, e con ciò stesso il numero assoluto di lavoratori occupati, sia diminuito. Il plusvalore assoluto che presuppone un determinato grado di produttività può aumentare il numero di lavoratori occupati contemporaneamente, e perciò una massa di plusvalore entro un dato tasso, solo nella misura in cui il capitale cresca e, in generale, si impieghi più capitale; in ogni caso questo fa sì che il capitale cresca in quanto con l’aumento del plusvalore – in qualsiasi modo si sia prodotto – ne aumenta anche la trasformazione in capitale, aumenta l’accumulazione di capitale.
Ma il plusvalore relativo accresce immediatamente il tasso del lavoro non pagato e riduce il salario assoluto; mediante il diretto sfruttamento del lavoro delle donne e dei fanciulli, costretti a guadagnarsi da vivere, cresce cioè soprattutto la massa sociale sottoposta allo sfrutta mento del lavoro, rappresentata per il capitale da una data popolazione, crescendo di conseguenza anche la massa di pluslavoro estorta a questa popolazione lavoratrice. Prima il salario bastava per il mantenimento della famiglia. La donna lavorava nella propria casa e non presso il capitalista, mentre i bambini solo a una certa età cominciavano anche loro a guadagnare l’equivalente del loro bisogno. Il salario dell’adulto, del padre di famiglia, doveva bastare non solo al loro sostentamento, senza contare che i fanciulli già lavoravano, ma anche alla rifusione delle spese sostenute legate allo sviluppo della loro forza-lavoro, delle spese che in seguito all’introduzione delle macchine si riducevano praticamente a zero. Le donne e i fanciulli, al contrario, riproducono ora non solo l’equivalente di quello di cui hanno bisogno, ma anche nello stesso tempo producono plusvalore. Tutta la famiglia doveva di conseguenza produrre una gran massa di lavoro – lavoro necessario e pluslavoro – produrre più pluslavoro per ricavare per tutta la famiglia lo stesso salario medio.
Solo nella produzione mediante macchina e nell’officina meccanica, basata sull’applicazione di un nuovo sistema di macchine perfezionate, si verifica la sostituzione di lavoratori con parte di capitale costante (con quella parte di prodotto del lavoro che diventa nuovamente strumento di lavoro) e in generale ha luogo la formazione di eccedenza di lavoratori, come tendenza inconscia chiaramente espressa che agisce su vasta scala. Il lavoro passato interviene qui come mezzo di sostituzione del lavoro vivo o di diminuzione del numero di lavoratori. Questa diminuzione di lavoro umano rappresenta quindi una speculazione capitalistica, un mezzo per aumentare il plusvalore. Nel caso della produzione mediante macchina si verifica che il lavoratore inizi a lottare immediatamente con la forza produttiva sviluppata dal capitale, come elemento antagonista a lui stesso, cioè al lavoro vivo. La distruzione delle macchine e, in generale, l’intervento dei lavoratori contro l’introduzione delle macchine sono la prima manifestazione di guerra al modo di produzione, ai mezzi di produzione e alla produzione capitalistica altamente sviluppata.
La relativa diminuzione del tempo lavorativo necessario, e non la diminuzione del lavoro applicato in assoluto, si palesa qui come forma tangibile, forma oggettiva, poiché fondamentale resta sempre il lavoratore vivo e il numero di lavoratori contemporaneamente occupati. Tanto più che il sorgere della manifattura si manifesta nel periodo in cui le necessità, la massa di merci che entra in scambio e il commercio estero (di fatto il relativo mercato mondiale) aumentano d’un tratto in maniera colossale. Non appena si costituisce l’officina meccanica tutto è costantemente finalizzato al perfezionamento delle macchine che non solo sottomettono al sistema meccanico le parti dell’officina che tuttavia non si sono ancora sottomesse ad esso, ma diminuiscono anche il numero di lavoratori occupati e invece di lavoratori maschi adulti impiegano il lavoro delle donne e dei fanciulli e, infine, e in misura maggiore che nella manifattura, aumentano la forza produttiva della stessa quantità di lavoratori e per questo diminuiscono relativamente (e questo fenomeno è immediatamente avvertito dai lavoratori) il numero di lavoratori necessario alla produzione di una determinata massa di merci. La formula della produzione mediante macchina non consiste nel diminuire relativamente la singola giornata dì lavoro che ne costituisce una parte indispensabile, ma nel ridurre il numero dì lavoratori, cioè la giornata di lavoro collettiva, costituita da molte giornate di lavoro contemporanee che è anch’essa parte indispensabile della produzione a macchina; cioè nel sopprimere, ridurre un determinato numero di lavoratori in quanto sono superflui per la produzione di pluslavoro; per non dire dell’eliminazione della specializzazione sviluppatasi per mezzo della divisione del lavoro e della conseguente svalutazione della forza-lavoro. Il lavoro passato e la combinazione sociale del lavoro sono analizzati qui come mezzo per rendere superfluo il lavoro vivo. In altri termini, il tempo di lavoro necessario è la base su cui si sviluppa il pluslavoro. Qui al contrario, si calcola quanto plusvalore è possibile ottenere possedendo una determinata quantità di lavoro necessario.
La contraddizione tra capitale e lavoro salariato si sviluppa sino alla completa contrapposizione, in quanto il capitale, è il mezzo non solo di svalutazione della forza-lavoro viva, ma anche di trasformazione di que-st’ultima in superflua sia completamente in determinati processi, sia riducendola al minor numero possibile. Il lavoro necessario si trasforma cosi immediatamente in popolazione superflua, in quanto non serve ad ottenere pluslavoro. Per il lavoratore non si tratta solo dell’annullamento della specializzazione e della
129

svalutazione della forza-lavoro, ma anche dell’annullamento dell’unica merce in possesso della parte di lavoratori costantemente oscillante: la forza-lavoro che, in quanto ormai superflua, viene sostituita dalle macchine. Viene sostituita sia perché parte dei lavori viene eseguita completamente a macchina, sia perché diminuisce in misura assai rilevante il numero di lavoratori addetti a queste macchine, mentre i lavoratori, che ancora restano dal precedente modo di produzione, in concorrenza con le macchine cadono in miseria. Pertanto, da una parte la tendenza della produzione a macchina si esprime in un continuo licenziamento di lavoratori (da imprese meccaniche o artigianali) ma, dall’altra, in un loro costante reclutamento, dal momento che in un determinato grado di sviluppo delle forze produttive il plusvalore può essere aumentato solo attraverso l’aumento del numero di lavoratori occupati contemporaneamente.
Questa attrazione e repulsione sono caratteristiche, e di conseguenza, caratteristica è anche la continua oscillazione del livello di vita del lavoratore. Qui, di conseguenza, tanto più è evidente l’alienazione delle condizioni oggettive del lavoro – del lavoro passato – dal lavoro vivo come contraddizione diretta; nello stesso tempo il lavoro passato, cioè le forze sociali del lavoro, comprese le forze della natura e la scienza, si presenta come arma che serve in parte per gettare il lavoratore sul lastrico, ridurlo alla condizione di uomo superfluo, in parte per privarlo della specializzazione e farla finita con le rivendicazioni che su di essa si basano, in parte per sottometterlo abilmente al dispotismo organizzativo della fabbrica e alla disciplina militare del capitale. Di conseguenza, sotto questo aspetto risultano decisive le condizioni sociali del lavoro create dalla forza produttiva sociale del lavoro e dal lavoro stesso, non solo come forze estranee al lavoratore, forze appartenenti al capitale, ma anche come forze ostili ai lavoratori e che li opprimono, dirette contro ciascun lavoratore a difesa degli interessi del capitalista. La sottomissione del lavoro dell’uomo di carne e sangue al capitale, l’assorbimento del suo lavoro da parte del capitale, assorbimento in cui è racchiusa la sostanza della produzione capitalistica, interviene qui come fatto tecnologico.
La pietra angolare è pronta, il lavoro morto messo in moto e il lavoro vivo, che è solo uno dei suoi organi fornito di coscienza, si fanno palesi. Il legame vivo di tutta l’officina non poggia sulla cooperazione; ora il sistema di macchine forma un tutt’uno messo in moto da un motore primario e comprendente tutta l’officina, un tutt’uno al quale è sottomessa l’officina viva in quanto composta di lavoratori. In tal modo, il tutt’uno del sistema di macchine ha ottenuto una forma indipendente dai lavoratori e senza alcuna relazione con essi. L’officina basata sulle macchine espelle costantemente i lavoratori in quanto necessari e di nuovo attrae i respinti a funzioni create dalla macchina stessa. L’economista borghese adduce a consolazione dei lavoratori che la macchina elimina il lavoro pesante, mentre in effetti, accanto a quelli vecchi, essa crea nuovi tipi di lavori pesanti. In altre parole, poiché si tratta di lavoratori occupati proprio nell’officina meccanica – nonostante le macchine e nonostante il tormento che deriva al singolo operaio dalle macchine – la quantità dei condannati a questo lavoro pesante aumenta. Insieme alla macchina – e con l’officina meccanica basata su di essa – il dominio del lavoro passato su quello vivo diventa non solo sociale, espresso nel rapporto tra capitalista e lavoratore o, ma anche, per cosi dire, una verità tecnologica. Ci si potrebbe chiedere come in generale sia possibile che l’uso delle macchine – per non parlare del disimpegno del capitale e del lavoro – possa immediatamente creare un nuovo e più diffuso lavoro, in quanto tutto il lavoro dall’inizio alla fine, sia quello eseguito immediatamente a macchina, sia quello che la presuppone, deve essere minore della massa di lavoro contenuta nelle merci prodotte prima senza macchina.
[MC. XX]
I.3.6. Il sistema di macchine e il mercato mondiale
In origine, quando prendevamo in considerazione la trasformazione del valore in capitale, il processo lavorativo fu semplicemente assunto entro il capitale, e dal punto di vista delle sue condizioni materiali, della sua esistenza materiale, il capitale si presentò come la totalità delle condizioni di questo processo, separandosi, conformemente a esso, in certe porzioni qualitativamente differenti, ossia in materiale di lavoro (è questa, e non “materia prima” l’espressione logicamente giusta), mezzo di lavoro e lavoro vivo. Da una parte il capitale si era disgiunto, dal punto di vista della sua costituzione materiale, in questi tre elementi; d’altra parte la loro unità dinamica costituiva il processo lavorativo (o il confluire di questi elementi in un processo), e quella statica il prodotto. In questa forma gli elementi materiali – materiale di lavoro, mezzo di lavoro, lavoro vivo – si presentano soltanto come i momenti essenziali del processo lavorativo stesso, di cui il capitale si appropria. Ma questo lato materiale – o la sua determinazione di valore d’uso e processo reale – si è scisso totalmente dalla sua determinazione formale. In quest’ultima:
1) i tre elementi nei quali esso compare prima dello scambio con la forza-lavoro, ossia prima del processo reale, si presentano soltanto come sue porzioni quantitativamente differenti, come quantità di valore, di cui esso stesso costituisce l’unità, come somma. La forma materiale, il valore d’uso nel quale queste diverse porzioni esistono, non alterava affatto l’omogeneità di questa determinazione. Dal punto di vista della
130

determinazione formale l’omogeneità si presentava come semplice separazione quantitativa del capitale in porzioni;
2) nell’ambito del processo stesso, l’elemento lavoro e gli altri due si sono distinti, dal punto di vista formale, solo nel senso che gli uni si determinavano come valori costanti, e l’altro come creatore di valore. Ma nel momento in cui si è inserita la loro diversità in quanto valori d’uso, ossia il lato materiale, essa è caduta interamente fuori della determinazione formale del capitale. Ma ora, nella differenza di capitale circolante (materia prima e prodotto) e capitale fisso (mezzo di lavoro), la differenza degli elementi in quanto valori d’uso è posta nello stesso tempo come differenza del capitale in quanto capitale, nella sua determinazione formale. Il rapporto reciproco dei fattori, che era soltanto quantitativo, si presenta ora come differenza qualitativa del capitale stesso, la quale poi determina il suo movimento complessivo (rotazione). Il materiale di lavoro e il prodotto di lavoro, il precipitato neutro del processo lavorativo, in quanto materia prima e prodotto, sono anche già materialmente determinati non più come materiale e prodotto del lavoro, bensì come il valore d’uso del capitale stesso in fasi diverse.
Finché il mezzo di lavoro rimane, nel senso proprio della parola, mezzo di lavoro, così come, storicamente, immediatamente, è inglobato dal capitale nel suo processo di valorizzazione, esso subisce solo un mutamento formale per il fatto che ora non si presenta più soltanto dal suo lato materiale come mezzo del lavoro, bensì nello stesso tempo come un modo particolare di esistenza del capitale, determinato dal suo processo complessivo, come capitale fisso. Ma, una volta assunto nel processo produttivo del capitale, il mezzo di lavoro percorre diverse metamorfosi, di cui l’ultima è la macchina o, piuttosto, un sistema automatico di macchine (sistema di macchine; quello automatico è solo la forma più perfetta e adeguata del macchinario, che sola lo trasforma in un sistema), messo in moto da un automa, forza motrice che muove se stessa; questo automa è costituito di numerosi organi meccanici e intellettuali, di modo che i lavoratori stessi sono determinati solo come organi coscienti di esso.
Nella macchina, e ancor più nel macchinario come sistema automatico, il mezzo di lavoro è trasformato, dal punto di vista del suo valore d’uso, cioè della sua esistenza materiale, in una esistenza adeguata al capitale fisso e al capitale in generale, e la forma in cui esso è stato assunto come mezzo di lavoro immediato nel processo di produzione del capitale è superata in una forma posta dal capitale stesso e a esso corrispondente. La macchina non si presenta sotto nessun rispetto come mezzo di lavoro del lavoratore singolo. La sua differenza specifica non è affatto, come nel mezzo di lavoro, quella di mediare l’attività del lavoratore nei confronti dell’oggetto; ma anzi questa attività è posta ora in modo che è essa a mediare soltanto ormai il lavoro della macchina, la sua azione sulla materia prima, a sorvegliare questa azione e ad evitarne le interruzioni. A differenza quindi dallo strumento, che il lavoratore anima – come un organo – della propria abilità e attività, e il cui maneggio dipende perciò dalla sua virtuosità. Mentre la macchina, che possiede abilità e forza al posto del lavoratore, è essa stessa il virtuoso, che possiede una propria anima nelle leggi meccaniche in essa operanti e, come il lavoratore consuma mezzi alimentari, così essa consuma carbone, olio ecc. (matières instrumentales) per mantenersi continuamente in movimento.
L’attività del lavoratore, ridotta a una semplice astrazione di attività, è determinata e regolata da tutte le parti dal movimento del macchinario, e non viceversa. La scienza, che costringe le membra inanimate delle macchine – grazie alla loro costruzione – ad agire conformemente a uno scopo come un automa, non esiste nella coscienza del lavoratore, ma agisce, attraverso la macchina, come un potere estraneo su di lui, come potere della macchina stessa. La appropriazione del lavoro vivo a opera del lavoro oggettivato – della forza o attività valorizzante ad opera del valore per se stante – che è nel concetto stesso del capitale, è posta, nella produzione basata sulle macchine, come carattere del processo di produzione stesso, anche dal punto di vista dei suoi elementi materiali e del suo movimento materiale. Il processo di produzione ha cessato di essere processo di lavoro nel senso che il lavoro lo soverchi come l’unità che lo domina. Il lavoro si presenta piuttosto soltanto come organo cosciente, in vari punti del sistema delle macchine, nella forma di singoli lavoratori vivi; frantumato, sussunto sotto il processo complessivo delle macchine, esso stesso solo un membro del sistema, la cui unità non esiste nei lavoratori vivi, ma nel macchinario vivente (attivo), che di fronte al lavoratore si presenta come un possente organismo contrapposto alla sua attività singola e insignificante.
Nelle macchine il lavoro oggettivato si contrappone al lavoro vivo, nello stesso processo di lavoro, come quel potere che lo domina e in cui il capitale stesso consiste, per la sua forma, in quanto appropriazione di lavoro vivo. L’assunzione del processo di lavoro come semplice momento del processo di valorizzazione del capitale è posta anche dal lato materiale attraverso la trasformazione del mezzo di lavoro in macchine e del lavoro vivo in semplice accessorio vivente di queste macchine, mezzo della loro azione. L’aumento della produttività del lavoro e la massima negazione del lavoro necessario è, come abbiamo visto, la tendenza necessaria del capitale. La realizzazione di questa tendenza è la trasformazione del mezzo di lavoro in macchine. Con le macchine, scompare altresì, nel prodotto, ogni rapporto al bisogno immediato del produttore e quindi al valore d’uso immediato; nella forma in cui il prodotto viene prodotto, e nei rapporti in
131

cui viene prodotto, è già posto che esso viene prodotto solo come portatore di valore e che il suo valore d’uso è solo una condizione ad esso relativa. Il lavoro oggettivato, a sua volta, si presenta direttamente, nelle macchine, non solo nella forma del prodotto o del prodotto impiegato come mezzo di lavoro, ma della produttività stessa. Lo sviluppo del mezzo di lavoro in macchine non è accidentale per il capitale, ma è la trasformazione e conversione storica del mezzo di lavoro ereditato dalla tradizione in forma adeguata al capitale. In ogni impiego di macchine – consideriamo anzitutto il caso più semplice di un capitalista che investe una parte del suo capitale in macchina anziché in lavoro immediato – una parte del capitale viene sottratta alla sua parte variabile destinata a moltiplicarsi, ossia a quella parte che si scambia con lavoro vivo per aggiungersi alla parte costante, il cui valore viene soltanto riprodotto o conservato nel prodotto. Ma ciò avviene soltanto per rendere più produttiva la parte restante.
L’introduzione delle macchine, o di un aumento generale della produttività tale che questa stessa produttività abbia come suo substrato il lavoro oggettivato, dunque costa; se quindi una parte della parte di capitale che prima veniva spesa per acquistare lavoro viene spesa come elemento della parte di capitale che entra nel processo di produzione come valore costante, l’introduzione delle macchine può avvenire solamente se la proporzione di tempo di lavoro supplementare non solo rimane la stessa, ossia cresce in rapporto al lavoro vivo impiegato, bensì cresce in proporzione maggiore del rapporto tra valore delle macchine e valore dei lavoratori licenziati. Ciò può accadere, o perché deve essere defalcata tutta la spesa che veniva fatta per il precedente strumento di produzione: e in questo caso diminuisce la somma complessiva di capitale speso, e sebbene sia diminuita la proporzione della somma complessiva di lavoro impiegato in rapporto alla parte costante del capitale, il pluslavoro è rimasto lo stesso, e quindi è aumentato non solo rispetto al capitale speso in lavoro, rispetto al tempo di lavoro necessario, ma rispetto al capitale complessivo; rispetto al valore complessivo del capitale [anticipato], dato che questo è diminuito. La trasformazione del plusvalore in profitto, questa specie di calcolo del plusvalore attraverso il capitale, per quanto poggi su di una illusione circa la natura del plusvalore, o piuttosto avvolga quest’ultima in un velo, è necessaria dal punto di vista del capitale .
La riduzione del lavoro necessario rispetto al pluslavoro si esprime – se consideriamo la giornata di un singolo lavoratore – nella appropriazione da parte del capitale di una porzione maggiore della giornata lavorativa. Il lavoro vivo impiegato rimane qui identico. La legge precedente: aumentare il numero delle ore lavorative – riceve quindi ora la forma: ridurre il numero dei lavoratori necessari. Se consideriamo il plusvalore assoluto, vediamo che esso è determinato dal prolungamento assoluto della giornata lavorativa al di là del tempo di lavoro necessario. Il tempo di lavoro necessario è lavoro per il semplice valore d’uso, per la sussistenza. La giornata lavorativa supplementare è lavoro per il valore di scambio, per la ricchezza. È il primo momento del lavoro industriale. Il limite naturale – presupposto che esistano le condizioni del lavoro, ossia la materia prima e lo strumento di lavoro, o una delle due, secondo che il lavoro sia puramente estrattivo oppure formativo, isoli cioè semplicemente il valore d’uso dal corpo terrestre, oppure gli dia una forma – il limite naturale è dato dal numero delle giornate lavorative simultanee o delle forze di lavoro vive, ossia dalla popolazione lavoratrice.
A questo livello la differenza tra la produzione del capitale e i precedenti livelli di produzione è ancora semplicemente formale. La razzìa di uomini, la schiavitù, il commercio di schiavi e il lavoro coatto di questi, la moltiplicazione di queste macchine lavoratrici, il plusprodotto delle macchine che producono sono attuati qui direttamente con la violenza, mentre nel capitale sono mediati dallo scambio. Nella seconda forma del plusvalore invece, in quanto plusvalore relativo, che si presenta come sviluppo della produttività dei lavoratori, in rapporto alla giornata lavorativa come diminuzione del tempo di lavoro necessario e in rapporto alla popolazione come diminuzione della popolazione lavoratrice necessaria (questa è la forma antitetica), in questa forma, dicevamo, compare immediatamente il carattere industriale e storicamente distintivo del modo di, produzione basato sul capitale. La tendenza del capitale è, naturalmente, di collegare il plusvalore assoluto con quello relativo; ossia: massima estensione della giornata lavorativa col massimo numero di giornate lavorative simultanee, simultaneamente con la riduzione al minimo, da una parte, del tempo di lavoro necessario, dall’altra, del numero di lavoratori necessari. Questa esigenza contraddittoria, il cui sviluppo si mostrerà in varie forme di sovraproduzione, sovrapopolazione, ecc., si fa valere sotto forma di un processo in cui le determinazioni contraddittorie si redimono nel tempo. Una conseguenza necessaria di tale esigenza è la massima moltiplicazione possibile del valore d’uso del lavoro – ovvero delle branche di produzione – talché la produzione del capitale, se per un verso produce costantemente e necessariamente lo sviluppo della intensità della forza produttiva del lavoro, per l’altro verso produce costantemente e necessariamente l’illimitata molteplicità delle branche di lavoro, vale a dire la ricchezza universale, di contenuto e di forma, della produzione, sottomettendo ad essa tutti gli aspetti della natura.
[LF. VI-VII]
132

L’ideale supremo della produzione capitalistica – in corrispondenza all’aumento relativo del prodotto netto – è di ridurre il più possibile il numero di coloro che vivono di salario e di aumentare il più possibile quello di coloro che vivono di prodotto netto [plusvalore].
1. Il lavoro in quanto estrinsecazione della capacità lavorativa, in quanto sforzo, appartiene bensì al singolo lavoratore (come ciò con cui paga al capitalista quanto ne riceve), pur oggettivandosi nel prodotto come appartenente al capitalisti; per contro, la combinazione sociale nel cui ambito le singole forze-lavoro non agiscono che come organi particolari della forza-lavoro collettiva costituente l’officina totale, non solo non appartiene ad esse, ma si erge loro di fronte, è loro imposta, come ordinamento capitalistico.
2. Queste forze produttive sociali del lavoro o forze produttive del lavoro sociale si sviluppano storicamente solo con l’apparire del modo di produzione specificamente capitalistico, e quindi appaiono come alcunché di immanente al rapporto capitalistico e da esso inseparabile.
3. Con lo sviluppo del modo di produzione capitalistico, le condizioni oggettive del lavoro assumono una forma modificata a causa della dimensione in cui, e dell’economia con cui, vengono impiegate (a.prescindere completamente dalla forma del macchinismo, ecc.): diventano più evolute come mezzi di produzione concentrati, rappresentanti ricchezza sociale, e, per dir tutto in uno, grazie all’ampiezza ed efficienza delle condizioni produttive del lavoro socialmente combinato.
A parte la combinazione dello stesso lavoro, il carattere sociale delle condizioni di lavoro – compresa tra l’altro la loro forma in quanto macchinario e capitale fisso di qualunque tipo – appare come alcunché di assolutamente autonomo, separato nella sua esistenza dal lavoratore; come un modo di essere del capitale e quindi anche come organizzato dai capitalisti indipendentemente dai lavoratori. Ancor più del carattere sociale del loro lavoro, il carattere sociale assunto dalle condizioni della produzione in quanto condizioni di produzione collettive del lavoro associato appare come capitalistico, come un carattere inerente in quanto tale alle condizioni della produzione, indipendentemente dai lavoratori. I mezzi di produzione – materia e mezzo di lavoro – sono utilizzati collettivamente, e questo impiego collettivo ha come presupposto assoluto la cooperazione dei lavoratori conglomerati; non è quindi che l’espressione oggettiva del carattere sociale del lavoro e della forza produttiva sociale che ne risulta, così come perlopiù la forma particolare di queste condizioni (per esempio il macchinario) non sarebbe utilizzabile se non per il lavoro associato. Di fronte al lavoratore che si muove nel loro àmbito, tuttavia, esse appaiono quali condizioni date, da lui indipendenti, e perciò forma del capitale. Analogamente, il loro risparmio (e l’aumento del profitto e la riduzione del prezzo delle merci che ne derivano) appaiono come alcunché di affatto distinto dal pluslavoro del lavoratore, come opera e fatto del capitalista, che qui agisce tout court in quanto personificazione del carattere sociale del lavoro, della fabbrica collettiva.
[VI. I,15]
I.3.7. La scienza e il capitale fisso
L’accumulazione della scienza e dell’abilità, delle forze produttive generali del cervello sociale, rimane cosi, rispetto al lavoro, assorbita nel capitale, e si presenta perciò come proprietà del capitale, e più precisamente del capitale fisso, nella misura in cui esso entra nel processo produttivo come mezzo di produzione vero e proprio. Le macchine si presentano così come la forma più adeguata del capitale fisso, e il capitale fisso, se si considera il capitale nella sua relazione con se stesso, come la forma più adeguata del capitale in generale. D’altra parte, in quanto il capitale fisso è inchiodato alla sua esistenza di valore d’uso determinato, esso non è adeguato al concetto del capitale, che, come valore, è indifferente ad ogni forma determinata di valore d’uso e può assumere o deporre ciascuna di esse come un’incarnazione indifferente. Per questo aspetto, e cioè se si considera il capitale nel suo rapporto verso l’esterno, il capitale circolante si presenta come la forma adeguata del capitale rispetto al capitale fisso.
In quanto poi le macchine si sviluppano con l’accumulazione della scienza sociale, della produttività in generale, non è nel lavoro, ma nel capitale, che si esprime il lavoro generalmente sociale. La produttività della società si commisura al capitale fisso, esiste in esso in forma oggettiva e, viceversa, la produttività del capitale si sviluppa con questo progresso generale che il capitale si appropria gratis. La scienza si presenta; nelle macchine, come una scienza altrui, esterna al lavoratore; e il lavoro vivo si presenta sussunto sotto quello oggettivato, che opera in modo autonomo. Il pieno sviluppo del capitale ha quindi luogo – o il capitale è giunto a porre la forma di produzione ad esso adeguata – solo quando il mezzo di lavoro non solo è determinato formalmente come capitale fisso, ma è soppresso nella sua forma immediata, e il capitale fisso si presenta di fronte al lavoro, all’interno del processo di produzione, come macchina; e l’intero processo di produzione non si presenta come sussunto sotto l’abilità immediata del lavoratore, ma come impiego tecnologico della scienza. Dare alla produzione carattere scientifico è quindi la tendenza del capitale e il lavoro immediato è ridotto a un semplice momento di questo processo. Come nella trasformazione del valore
133

in capitale, così ad una analisi più precisa del capitale, risulta che esso, da un lato, presuppone un determinato sviluppo storico delle forze produttive (compresa, fra queste forze produttive, la scienza), e d’altra parte lo forza ad andare avanti.
L’ambito quantitativo e l’efficacia (intensità) in cui il capitale è sviluppato come capitale fisso indica quindi in generale il grado in cui il capitale è sviluppato come capitale, come potere sul lavoro vivo, e in cui esso si è assoggettato il processo produttivo in generale. Anche nel senso che esso esprime l’accumulazione delle forze produttive oggettivate e altresì del lavoro oggettivato. Ma se il capitale giunge a darsi la sua figura adeguata come valore d’uso all’interno del processo di produzione soltanto nelle macchine e in altre forme di esistenza materiale del capitale fisso come le ferrovie ecc. ciò non significa affatto che questo valore d’uso – le macchine in se stesse – sia capitale, o che il loro esistere come macchine si identifichi col loro esistere come capitale; così come l’oro non cesserebbe di avere il suo valore d’uso come oro quando non fosse più denaro. Le macchine non perderebbero il loro valore d’uso quando cessassero di essere capitale. Dal fatto che le macchine sono la forma più adeguata del valore d’uso del capitale fisso, non consegue minimamente che la sussunzione sotto il rapporto sociale del capitale sia il rapporto sociale di produzione ultimo e più adeguato per l’impiego delle macchine. Nella stessa misura in cui il tempo di lavoro – la mera quantità di lavoro – è posto dal capitale come unico elemento determinante, il lavoro immediato e la sua quantità scompaiono come principio determinante della produzione – della creazione di valori d’uso – e vengono ridotti sia quantitativamente a una proporzione esigua, sia qualitativamente a momento certamente indispensabile, ma subalterno, rispetto al lavoro scientifico generale, all’applicazione tecnologica delle scienze naturali da un lato, e rispetto alla produttività generale derivante dall’articolazione sociale nella produzione complessiva dall’altro – produttività generale che si presenta come dono naturale del lavoro sociale (benché sia, in realtà, prodotto storico). Il capitale lavora così alla propria dissoluzione come forma dominante della produzione.
È quindi una frase borghese assolutamente assurda quella che il lavoratore ha interessi comuni col capitalista perché questi, col capitale fisso (che è esso stesso, d’altronde, il prodotto del lavoro e nient’altro che lavoro altrui appropriato dal capitale), gli agevola il lavoro (che anzi gli sottrae con la macchina ogni indipendenza e carattere attraente) o gli abbrevia il lavoro. Il capitale impiega la macchina, invece, solo nella misura in cui essa abilita il lavoratore a lavorare per il capitale una parte maggiore del suo tempo, a riferirsi ad una parte maggiore del suo tempo come a tempo che non gli appartiene, a lavorare più a lungo per un altro. È vero che, con questo processo, la quantità di lavoro necessario alla produzione di un determinato oggetto viene ridotta a un minimo, ma solo perché un massimo di lavoro venga valorizzato nel massimo di tali oggetti. Il primo lato è importante, perché il capitale riduce qui, senza alcuna intenzione, il lavoro umano (il dispendio di forza) ad un minimo. Ciò tornerà utile al lavoro emancipato ed è la condizione della sua emancipazione. Da quanto si è detto risulta l’assurdità della tesi che vuol fare del capitale fisso una fonte di valore autonoma e indipendente dal tempo di lavoro. Esso rappresenta una fonte di questo genere solo in quanto è esso stesso tempo di lavoro oggettivato e in quanto crea tempo di lavoro supplementare.
Le macchine stesse, per il loro impiego, presuppongono, storicamente braccia in sovrabbondanza. Solo dove è presente una sovrabbondanza di forze di lavoro, intervengono le macchine a sostituire lavoro. Solo nell’immaginazione degli economisti le macchine intervengono a soccorso del lavoratore singolo. Esse possono operare solo con masse di lavoratori, la cui concentrazione di fronte al capitale è, come abbiamo visto, uno dei presupposti storici del capitale stesso. Le macchine non intervengono a sostituire forza-lavoro mancante, ma per ridurre la forza-lavoro presente in massa alla misura necessaria. Solo dove la forza-lavoro è presente in massa, intervengono le macchine. Appena il capitale fisso si è sviluppato fino a raggiungere una certa estensione – e questa estensione, come si è accennato, è il metro dello sviluppo della grande industria in generale, e cresce quindi in rapporto allo sviluppo delle forze produttive di essa (il capitale fisso stesso è l’oggettivazione di queste forze produttive, queste forze stesse come prodotto presupposto) – da questo momento in poi ogni interruzione del processo di produzione opera direttamente come diminuzione del capitale stesso, del suo valore presupposto. Il valore del capitale fisso viene riprodotto solo nella misura in cui viene consumato nel processo di produzione. Non essendo utilizzato, perde il suo valore d’uso, senza che il suo valore trapassi nel prodotto. Quindi quanto più larga è la scala di sviluppo del capitale fisso, nel significato in cui lo consideriamo qui, tanto più la continuità del processo di produzione o il flusso costante della riproduzione diventano una condizione obbligante del modo di produzione fondato sul capitale. L’appropriazione del lavoro vivo a opera del capitale acquista nelle macchine, anche da questo lato, una realtà immediata. È, da un lato, analisi e applicazione, che scaturiscono direttamente dalla scienza, di leggi meccaniche e chimiche, e che abilitano la macchina a compiere lo stesso lavoro che prima era eseguito dal lavoratore.
Lo sviluppo delle macchine per questa via ha luogo, però, solo quando la grande industria ha già raggiunto un livello più alto e tutte le scienze sono catturate al servizio del capitale; e d’altra parte le stesse macchine esistenti forniscono già grandi risorse. Allora l’invenzione diventa una attività economica e l’appli -
134

cazione della scienza alla produzione immediata un criterio determinante e sollecitante per la produzione stessa. Ma non è questa la via per cui le macchine sono sorte come sistema, e meno ancora quella su cui esse si sviluppano in dettaglio. Questa via è l’analisi, attraverso la divisione del lavoro, che già trasforma sempre di più le operazioni dei lavoratori in operazioni meccaniche, cosicché, a un certo punto, il meccanismo può subentrare al loro posto. [Ad economy of power]. Qui il modo di lavoro determinato si presenta dunque direttamente trasferito dal lavoratore al capitale nella forma della macchina, e la sua propria forza-lavoro, svalutata da questa trasposizione. Donde la lotta dei lavoratori contro le macchine. Ciò che era attività del lavoratore vivo diventa attività della macchina. Così l’appropriazione del lavoro da parte del capitale, il capitale che assorbe in sé il lavoro vivo – “come se in corpo ci avesse l’amore” – si contrappone tangibilmente al lavoratore. C’è ancora un altro lato da cui lo sviluppo del capitale fisso indica il grado di sviluppo della ricchezza in generale o di sviluppo del capitale.
L’oggetto della produzione indirizzato immediatamente al valore d’uso e altrettanto immediatamente al valore di scambio è il prodotto stesso, che è destinato al consumo. La parte di produzione indirizzata alla produzione del capitale fisso non produce immediatamente oggetti di godimento, né valori di scambio immediati; per lo meno, non valori di scambio immediatamente realizzabili. Dipende dunque dal grado già raggiunto di produttività – dal fatto cioè che una parte del tempo di produzione è sufficiente alla produzione immediata – che una parte sempre più grande venga impiegata nella produzione dei mezzi di produzione. Ciò implica che la società può attendere; che può sottrarre una gran parte della ricchezza già prodotta, sia al godimento immediato sia alla produzione destinata al godimento immediato, per impiegare questa parte ai fini di un lavoro non immediatamente produttivo (nell’ambito dello stesso processo materiale di produzione). Ciò richiede un alto livello della produttività già raggiunta e del relativo eccedente, e precisamente un livello tale che sia direttamente proporzionale alla trasformazione del capitale circolante in capitale fisso. Come la grandezza del pluslavoro relativo dipende dalla produttività del lavoro necessario, così la grandezza del tempo di lavoro – sia vivo, sia oggettivato – impiegato nella produzione del capitale fisso, dipende dalla produttività del tempo di lavoro destinato alla produzione diretta di prodotti. Una sovrapopolazione, (da questo punto di vista), così come una sovraproduzione, è, a tal fine, una condizione. Ciò vuol dire che il risultato del tempo impiegato nella produzione immediata deve essere relativamente troppo grande per i bisogni immediati della riproduzione del capitale impiegato in queste branche di industria. Quanto meno il capitale fisso dà frutti immediati, quanto meno cioè interviene nel processo di produzione immediato, tanto più grande deve essere questa relativa sovrapopolazione e sovraproduzione; ossia per costruire ferrovie, canali, acquedotti, telegrafi ecc., più che macchine direttamente attive nel processa di produzione immediato.
[LF. VI-VII]
La scienza come prodotto intellettuale generale dell’evoluzione sociale appare essa stessa come direttamente incorporata al capitale (e la sua applicazione in quanto scienza al processo di produzione materiale appare come distinta dal sapere e dalle capacità del singolo lavoratore), e lo sviluppo generale della società, essendo sfruttato dal capitale – e agendo come forza produttiva del capitale – di contro al lavoro, appare a sua volta come sviluppo del capitale, e ciò tanto più in quanto, per la grande maggioranza, gli si accompagna di pari passo uno svuotamento della capacità lavorativa. Il capitalista stesso è detentore di potere solo in quanto personificazione del capitale (per cui, nella contabilità italiana, appare sempre come figura doppia, per esempio come debitore del suo proprio capitale). La produttività del capitale consiste anzitutto, se si considera la sottomissione formale, nella pura e semplice costrizione al pluslavoro; costrizione che il modo di produzionie capitalistico condivide con modi di produzione precedenti, ma che esso esercita in una forma più favorevole alla produzione stessa. Anche considerando il rapporto puramente formale – la forma generale della produzione capitalistica, comune sia al suo modo meno sviluppato che a quello più sviluppato – non i mezzi di produzione, le condizioni materiali del lavoro, appaiono sottomessi al lavoratore, ma egli ad essi. È il capitale che impiega il lavoro. Già questo rapporto nella sua semplicità è personificazione delle cose e reificazione delle persone.
Ma il rapporto diviene più complicato e apparentemente più misterioso allorché, con lo sviluppo del modo di produzione specificamente capitalistico, non soltanto queste cose – questi prodotti del lavoro come valori d’uso e come valori di scambio – si levano in piedi di fronte al lavoratore e gli si contrappongono come “capitale”, ma si rappresentano alla forma sociale del lavoro come forme di sviluppo del capitale e perciò le forze produttive, così sviluppate, del lavoro sociale gli si rappresentano come forze produttive del capitale. Come tali forze sociali esse sono, di fronte al lavoro, “capitalizzate”. In realtà, l’unità collettiva nella cooperazione, la combinazione nella divisione del lavoro, l’impiego delle energie naturali e delle scienze, dei prodotti del lavoro come macchinario – tutto ciò si contrappone ai lavoratori singoli, in modo autonomo, come qualcosa di estraneo, di oggettivo, di preesistente, senza e spesso contro il loro contributo attivo, come pure forme di esistenza dei mezzi dì lavoro da essi indipendenti e su di essi esercitanti il proprio dominio; e l’intelligenza e la volontà dell’officina collettiva incarnate nel capitalista o nei suoi subalterni
135

[understrappers], nella misura in cui l’officina collettiva si basa sulla loro combinazione, gli si contrappongono come funzioni del capitale che nel capitalista vive.
E ciò assume forme tanto più reali, quanto più, da un lato, la loro stessa capacità lavorativa è modificata da queste forme al punto che, nella sua indipendenza – cioè fuori dal rapporto capitalistico – essa diviene impotente, la sua forza produttiva autonoma ne è schiantata, e, dall’altro, con lo sviluppo del macchinismo le condizioni del lavoro, anche dal punto di vista tecnologico, appaiono come dominanti il lavoro e nello stesso tempo lo sostituiscono, lo opprimono e lo rendono superfluo nelle sue forme autonome. In questo processo, in cui i caratteri sociali del loro lavoro fronteggiano i lavoratori come, per cosi dire, capitalizzati, le forze naturali e la scienza (questo prodotto dello sviluppo storico generale nella sua quintessenza astratta), che si ergono loro di fronte come potenze del capitale, si separano dall’abilità e dal sapere del lavoratore singolo e, pur essendo esse stesse quanto alla loro origine prodotti del lavoro, appaiono – dovunque entrino nel processo lavorativo – come incorporati al capitale. Il capitalista che impiega una macchina non ha bisogno di capirla [cfr. Ure]: e tuttavia nella macchina la scienza realizzata appare di fronte ai lavoratori come capitale. In realtà, al cospetto del lavoro tutta questa, applicazione – fondata sul lavoro associato – della scienza, delle forze della natura e dei prodotti del lavoro in grandi masse non appare se non come mezzo di sfruttamento del lavoro, come mezzo per appropriarsi pluslavoro, e quindi come forza appartenente in sé al capitale. Naturalmente, il capitale utilizza tutti questi mezzi soltanto per sfruttare il lavoro; ma, per poterlo sfruttare, deve applicarli alla produzione. È così che lo sviluppo delle forze produttive sociali del lavoro e le condizioni di questo sviluppo prendono l’aspetto di un’opera del capitale, e il lavoratore singolo si trova nei loro confronti in un rapporto non solo passivo ma antagonistico.
Così il capitale diventa un essere terribilmente misterioso. Le condizioni di lavoro si accumulano come forze sociali torreggianti di fronte al lavoratore e, in questa forma, vengono capitalizzate. Il capitale è dunque produttivo: 1. come costrizione al pluslavoro. Il lavoro è produttivo appunto perché compie questo pluslavoro, grazie alla differenza fra il valore della capacità lavorativa e la sua valorizzazione; 2. come personificazione e rappresentante, forma oggettivata, delle “forze produttive sociali del lavoro” o delle forze produttive del lavoro sociale. Come a ciò spinga la legge della produzione capitalistica – la creazione di plusvalore, ecc. – si è già visto. Essa si manifesta come costrizione che i capitalisti esercitano l’uno sull’altro e sui lavoratori: quindi, in realtà, come legge del capitale contro entrambi. La forza naturale sociale del lavoro si sviluppa non nel processo di valorizzazione in quanto tale, ma nel processo lavorativo reale. Perciò essa si rappresenta come proprietà inerente in quanto cosa al capitale, come suo valore d’uso. Il lavoro produttivo, in quanto produttore di valore, sta sempre di fronte al capitale come lavoro di lavoratori individuali, quali che siano le combinazioni sociali in cui essi entrano nel processo produttivo. Mentre quindi il capitale si contrappone ai lavoratori come forza produttiva sociale del lavoro, il lavoro produttivo si contrappone sempre al capitale come lavoro di lavoratori individuali. La trasposizione delle forze produttive sociali del lavoro in proprietà materiali del capitale è talmente radicata nell’immaginazione, che i vantaggi del macchinismo, dell’applicazione della scienza, delle invenzioni, ecc. vengono concepiti in questa loro forma alienata come nella loro forma necessaria, e quindi visti come proprietà del capitale. Al fondo di tutto questo stanno: 1) la forma nella quale, sulla base della produzione capitalistica e quindi anche nella coscienza di coloro che vi sono coinvolti, la questione si presenta; 2) il fatto storico che questo sviluppo ha luogo per la prima volta, in antitesi ai modi di produzione precedenti, nel modo di produzione capitalistico, cosicché il carattere antagonistico di questo sviluppo appare come ad esso immanente.
[VI. I,15]
I.3.8. A mo’ di epilogo transitorio: l’intelligenza generale della società
Nelle sue Six lectures delivered at Manchester, 1837, Owen afferma: le manifatture, per “essere efficaci, devono ora essere eseguite estensivamente e con un grande capitale; i piccoli padroni con piccoli capitali non hanno ora che poche possibilità di successo; è evidente infatti, ora, che perdurando l’attuale classificazione della società e l’attuale modo di condurre la vita economica, i piccoli padroni vengono sempre più scavalcati da quelli che possiedono grandi capitali. Il grande capitalista è innalzato ora alla posizione di un signore dispotico, che indirettamente ha in mano la salute, la vita, e la morte dei suoi schiavi, a suo piacimento. Questo potere egli lo ottiene associandosi ad altri grandi capitalisti che hanno gli stessi suoi interessi, sì da costringere efficacemente ai suoi disegni coloro che egli impiega. Ora il grande capitalista nuota nella ricchezza, del cui retto uso egli non ha né esperienza né conoscenza, Con la sua ricchezza ha acquistato un potere. La sua ricchezza e il suo potere accecano la sua mente, fino a fargli credere che ogni sua più atroce oppressione è una grazia accordata... I suoi servi, come vengono chiamati, di fatto i suoi schiavi, vengono ridotti alla degradazione più disperata; la maggioranza di essi viene privata della salute, del conforto domestico, delle comodità e dei sani piaceri goduti all’aria aperta nei tempi passati. Per l’eccessivo
136

esaurimento delle loro forze, dovuto alle occupazioni monotone, lungamente trascinate, essi sono indotti ad abitudini abnormi e alla distorsione del pensiero e della riflessione. Non possono avere diversivi fisici, intellettuali o morali se non della peggiore specie; tutti i veri piaceri della vita rimangono loro completamenti estranei. Ed è questo nuovo sistema industriale che crea ora la necessità di una diversa e superiore classificazione della società “ [loc.cit.].
La creazione di molto tempo disponibile oltre il tempo di lavoro necessario per la società in generale e per ogni membro di essa (ossia di spazio per il pieno sviluppo delle forze produttive dei singoli, e quindi anche della società), questa creazione di tempo di non-lavoro si presenta, al livello del capitale, come di tutti quelli precedenti, come tempo di non-lavoro, tempo libero per alcuni. Il capitale vi aggiunge il fatto che esso moltiplica il tempo di lavoro supplementare della massa con tutti i mezzi della tecnica e della scienza, perché la sua ricchezza è fatta direttamente di appropriazione di tempo di pluslavoro; giacché il suo scopo è direttamente il valore, e non il valore d’uso. In tal modo esso, malgré lui, è strumento di creazione delle possibilità di tempo sociale disponibile, della riduzione del tempo di lavoro per l’intera società ad un minimo decrescente, sì da rendere il tempo di tutti libero per il loro sviluppo personale. Ma la sua tendenza è sempre, per un verso, quella di creare tempo disponibile, per l’altro di convertirlo in pluslavoro. Se la prima cosa gli riesce, ecco intervenire una sovraproduzione, e allora il lavoro necessario viene interrotto perché il capitale non può valorizzare alcun pluslavoro.
Quanto più si sviluppa questa contraddizione, tanto più viene in luce che la crescita delle forze produttive non può più essere vincolata all’appropriazione di pluslavoro altrui, ma che piuttosto la massa lavoratrice stessa deve appropriarsi del suo pluslavoro. Una volta che essa lo abbia fatto – e con ciò il tempo disponibile cessi di avere una esistenza antitetica – da una parte il tempo di lavoro necessario avrà la sua misura nei bisogni dell’individuo sociale, dall’altra lo sviluppo della produttività sociale crescerà così rapidamente che, sebbene ora la produzione sia calcolata in vista della ricchezza di tutti, cresce il tempo disponibile di tutti. Giacché la ricchezza reale è la produttività sviluppata di tutti gli individui. E allora non è più il tempo di lavoro, ma il tempo disponibile la misura della ricchezza. Il tempo di lavoro come misura della ricchezza pone la ricchezza stessa come fondata sulla povertà, e il tempo disponibile come tempo che esiste nella e in virtù della antitesi al tempo di pluslavoro, ovvero tutto il tempo di un individuo è posto come tempo di lavoro, e l’individuo viene degradato perciò a mero lavoratore, sussunto sotto il lavoro. Le macchine più sviluppate perciò costringono ora il lavoratore a lavorare più a lungo dì quanto faccia il selvaggio o di quanto egli stesso facesse con gli strumenti più semplici e più rozzi.
L’economia effettiva – il risparmio – consiste in un risparmio di tempo di lavoro (minimo – e riduzione al minimo – di costi di produzione); ma questo risparmio si identifica con lo sviluppo della produttività. Il fatto che con lo sviluppo delle capacità produttive del lavoro le condizioni oggettive del lavoro, ossia il lavoro oggettivato debba aumentare in rapporto al lavoro vivo – una proposizione a rigore tautologica, giacché cos’altro vuol dire crescente produttività del lavoro se non che si richiede meno lavoro immediato per creare un prodotto maggiore, e che dunque la ricchezza sociale si esprime sempre di più nelle condizioni del lavoro create dal lavoro stesso – questo fatto assume, dal punto di vista del capitale, questo aspetto: che non è uno dei momenti dell’attività sociale – ossia il lavoro oggettivato – che diventa corpo sempre più potente dell’al -tro momento, del lavoro vivo, soggettivo, bensì sono le condizioni oggettive del lavoro che assumono rispetto al lavoro vivo un’autonomia sempre più colossale che si manifesta attraverso la loro stessa estensione, e la ricchezza sociale si contrappone al lavoro in dimensioni sempre più imponenti come un potere dominante ed estraneo. L’accento cade non sul fatto che l’enorme potere oggettivo, che il lavoro sociale stesso si è contrapposto come uno dei suoi momenti, sia oggettivato, ma sul fatto che esso sia alienato, espropriato, estraniato, che appartenga non al lavoratore, ma alle condizioni di produzione personificate, ossia al capitale. Finché, al livello del capitale e del lavoro salariato, la creazione di questo corpo oggettivo dell’attività avviene in antitesi alla forza-lavoro immediata – e questo processo di oggettivazione si presenta di fatto come processo di espropriazione dal punto di vista del lavoro o di appropriazione di lavoro altrui dal punto di vista del capitale – finché ciò accade questa distorsione e inversione sono effettive, non sono una mera opinione, non esistono cioè soltanto nella rappresentazione dei lavoratori e dei capitalisti. Ma evidentemente questo processo di inversione è una necessità meramente storica, è una necessità soltanto per lo sviluppo delle forze produttive da un determinato punto di partenza storico, o da una determinata base storica; non è quindi affatto una necessità assoluta della produzione; anzi è una necessità transitoria, e il risultato e lo scopo (immanente) di questo processo è di sopprimere questa base stessa cosi come questa forma del processo.
Gli economisti borghesi sono a tal punto prigionieri degli schemi di un determinato livello di sviluppo storico della società, che la necessità della oggettivazione delle forze sociali del lavoro si presenta loro inscindibile dalla necessità della alienazione di queste stesse forze in opposizione al lavoro vivo. Ma con la soppressione del carattere immediato del lavoro vivo come lavoro solamente singolo, o solo interiormente, o solo esteriormente, generale, con l’attribuzione all’attività degli individui di un carattere immediatamente ge -
137

nerale o sociale, questa forma della alienazione viene cancellata dai momenti oggettivi della produzione; con ciò essi vengono posti come proprietà, come corpo organico sociale in cui gli individui si riproducono come singoli, ma come singoli sociali. Le condizioni di questo modo di riprodurre la loro vita, di questo tipo di processo vitale produttivo, sono state poste dallo stesso processo storico-economico; sia le condizioni oggettive, sia quelle soggettive, che sono soltanto le due distinte forme delle medesime condizioni. La mancanza di proprietà del lavoratore e la proprietà del lavoro oggettivato su quello vivo, o l’appropriazione di lavoro altrui mediante il capitale – le due cose non esprimono che i due poli opposti di un medesimo rapporto – sono condizioni fondamentali del modo di produzione borghese, non suoi accidenti indifferenti. Questi modi di distribuzione sono i rapporti di produzione stessi, solamente sub specie distributionis. Le “leggi e condizioni” della produzione della ricchezza e le leggi della “distribuzione della ricchezza” sono le medesime leggi sotto diversa forma e sia le une che le altre mutano, soggiacciono al medesimo processo storico; non sono altro che momenti di un processo storico.
[LF. VI-VII]
La grande produzione (la cooperazione su vasta scala e l’impiego delle macchine) sottomette innanzi tutto su grande scala le forze della natura – il vento, l’acqua, il vapore, l’elettricità – al processo immediato di produzione, trasformandole in agenti del lavoro sociale. (Nelle forme precapitalistiche dell’agricoltura il lavoro umano non è che un aiuto del processo naturale che del resto egli non controlla). Queste forze della natura, in quanto tali, non costano nulla. Esse non sono prodotto del lavoro umano. Ma l’appropriazione di esse avviene solo con l’aiuto delle macchine che invece hanno un costo, in quanto esse stesse sono un prodotto del lavoro passato. Per questo le forze della natura, come agenti del processo del lavoro, sono fatte proprie solo grazie alle macchine anche dai proprietari di queste ultime. Poiché questi agenti naturali non costano nulla, essi entrano nel processo del lavoro, senza entrare nel processo dell’aumento del valore. Essi rendono produttivo il lavoro, senza aumentare il costo del prodotto, senza accrescere il valore della merce. L’uso di queste forze della natura su vasta scala è possibile solo là dove possono essere impiegate le macchine su vasta scala, e dove di conseguenza viene usata anche: una massa di lavoratori ad esse corrispondente e la cooperazione di questi lavoratori sottomessi al capitale.
L’impiego degli agenti naturali – in una certa misura il loro incorporamento nel capitale – coincide con lo sviluppo della scienza come fattore autonomo del processo produttivo. Se il processo produttivo diviene sfera di applicazione della scienza, allora al contrario la scienza diviene fattore, per così dire funzione, del processo produttivo. Ogni scoperta diviene la base di nuove invenzioni o di un nuovo perfezionamento dei modi di produzione. Il modo capitalistico di produzione pone per primo le scienze naturali al servizio immediato del processo di produzione, quando invece lo sviluppo della produzione fornisce gli strumenti per la conquista teorica della natura. La scienza ottiene il riconoscimento di essere un mezzo per produrre ricchezza, un mezzo di arricchimento. In questo modo i processi produttivi si pongono per la prima volta come problemi pratici, che possono essere risolti solo scientificamente. L’esperienza e l’osservazione (e le necessità dello stesso processo produttivo) hanno raggiunto ora per la prima volta un livello tale da permettere e rendere indispensabile l’impiego della scienza, lo sfruttamento della scienza e del progresso teorico dell’umanità. Il capitale non crea scienza, ma la sfrutta appropriandosene nel processo produttivo. Con ciò stesso ha luogo contemporaneamente la separazione della scienza, in quanto scienza applicata alla produzione, dal lavoro immediato, mentre nelle precedenti fasi della produzione l’esperienza e lo scambio limitato delle conoscenze erano immediatamente legati al lavoro stesso; non si sviluppavano come forza separata e indipendente da essa e perciò nel complesso non erano mai andati oltre i limiti della tradizionale raccolta di ricette esistente da tanto tempo e sviluppatasi solo molto lentamente e gradualmente (studio empirico dei segreti di ciascun artigianato). Il braccio e la mente non erano separati.
Come per macchina intendiamo la “macchina del padrone” e per sua funzione la “funzione del padrone” nel processo produttivo (nella produzione), così è tale la situazione della scienza che si incarna in questa macchina, nei modi di produzione, nei processi chimici, ecc. La scienza interviene come forza estranea, ostile al lavoro, che lo domina, e la sua applicazione è da una parte accumulazione, dall’altra sviluppo in scienza di testimonianze, di osservazioni, di segreti dell’artigianato, acquisiti per vie sperimentali per l’analisi del processo produttivo, e applicazione delle scienze naturali al processo materiale produttivo; e come tale si basa allo stesso modo sulla separazione delle forze spirituali del processo dalle conoscenze, testimonianze e capacità del singolo lavoratore, come l’accumulazione e lo sviluppo delle condizioni di produzione e la loro trasformazione in capitale si basano sulla privazione del lavoratore di queste condizioni, sulla separazione del lavoratore da esse. Inoltre, il lavoro in fabbrica lascia al lavoratore solo la conoscenza di alcuni procedimenti: questa applicazione della scienza al processo di produzione coincide con la repressione di ogni sviluppo intellettuale nel corso di questo processo. In verità, si è nonostante ciò costituito un piccolo gruppo di lavoratori altamente qualificati; tuttavia il numero dì essi non ha alcun rapporto con le masse di lavoratori “privati di conoscenze “ (entkenntnisten).
138

D’altra parte risultano altrettanto evidenti i seguenti fatti: lo sviluppo delle scienze naturali (che formano del resto la base di qualsiasi conoscenza), come quello di qualsiasi nozione (che si riferisca al processo produttivo), avviene di nuovo sulla base della produzione capitalistica che per la prima volta fornisce in larga misura alle scienze i mezzi materiali di indagine, d’osservazione, di sperimentazione. Gli uomini di scienza, poiché le scienze sono utilizzate dal capitale come mezzo di arricchimento, e perciò diventano esse stesse mezzo di arricchimento anche per gli uomini che si occupano dello sviluppo della scienza, si fanno reciproca concorrenza nel tentativo di trovare un’applicazione pratica della scienza. Solo la produzione capitalistica trasforma il processo produttivo materiale in applicazione della scienza nella produzione – in scienza messa in pratica, ma solo sottomettendo il lavoro al capitale e reprimendo il proprio sviluppo intellettuale e professionale. Nel XVIII secolo il progresso nel campo della matematica, della meccanica, della chimica e le scoperte in Inghilterra, Francia, Svezia e Germania avvennero quasi contemporaneamente. Lo stesso fenomeno si verificò anche per le invenzioni, ad esempio, in Francia. Ma il loro impiego in senso capitalistico avveniva allora solo in Inghilterra, poiché solo là i rapporti economici erano tanto sviluppati da rendere possibile lo sfruttamento del progresso scientifico da parte del capitale.
[MC. XX]
Lo scambio del lavoro vivo col lavoro oggettivato, cioè la posizione del lavoro sociale nella forma del -l’opposizione di capitale e lavoro salariato, è l’ultimo sviluppo del rapporto di valore e della produzione basata sul valore. La premessa di questa è e rimane la quantità dì tempo di lavoro immediato, la quantità di lavoro impiegato, come fattore decisivo della produzione della ricchezza. Ma nella misura in cui si sviluppa la grande industria, la creazione della ricchezza reale viene a dipendere meno dal tempo di lavoro e dalla quantità di lavoro impiegato che dalla potenza degli agenti che vengono messi in moto durante il tempo di lavoro, e che a sua volta – questa loro potente efficacia [powerful effectiveness] – non è minimamente in rapporto al tempo di lavoro immediato che costa la loro produzione, ma dipende invece dallo stato generale della scienza e dal progresso della tecnologia, o dall’applicazione di questa scienza alla produzione. La ricchezza reale si manifesta invece – e questo è il segno della grande industria – nella enorme sproporzione fra il tempo di lavoro impiegato e il suo prodotto, come pure nella sproporzione qualitativa fra il lavoro ridotto ad una pura astrazione e la potenza del processo di produzione che esso sorveglia. Non è più tanto il lavoro a presentarsi come incluso nel processo di produzione, quanto piuttosto l’uomo a porsi in rapporto al processo di produzione come sorvegliante e regolatore. (Ciò che si è detto delle macchine, vale anche per la combinazione delle attività umane e per lo sviluppo delle relazioni umane). Il lavoratore non è più quello che inserisce l’oggetto naturale modificato come membro intermedio fra l’oggetto e se stesso; ma è quello che inserisce il processo naturale, che egli trasforma in un processo industriale, come mezzo fra se stesso e la natura inorganica, della quale si impadronisce. Egli si colloca accanto al processo di produzione, anziché esserne l’agente principale. In questa trasformazione non è né il lavoro immediato, eseguito dall’uomo stesso, né il tempo che egli lavora, ma l’appropriazione della sua produttività generale, la sua comprensione della natura e il dominio su di essa attraverso la sua esistenza di corpo sociale: in una parola, è lo sviluppo dell’individuo sociale che si presenta come il grande pilone di sostegno della produzione e della ricchezza.
Il furto del tempo di lavoro altrui, su cui poggia la ricchezza odierna, si presenta come una base miserabile rispetto a questa nuova base che si è sviluppata nel frattempo e che è stata creata dalla grande industria- stessa. Non appena il lavoro in forma immediata ha cessato di essere la grande fonte della ricchezza, il tempo di lavoro cessa e deve cessare di essere la sua misura, e quindi il valore di scambio deve cessare di essere la misura del valore d’uso. Il capitale è esso stesso la contraddizione in processo, per il fatto che tende a ridurre il tempo di lavoro a un minimo, mentre, d’altro lato, pone il tempo di lavoro come unica misura e fonte della ricchezza. Esso diminuisce, quindi, il tempo di lavoro nella forma del tempo di lavoro necessario, per accrescerlo nella forma del tempo di pluslavoro; facendo quindi del tempo di pluslavoro – in misura crescente – la condizione (question de vie et de mort) di quello necessario. Da un lato esso evoca, quindi, tutte le forze della scienza e della natura; come della combinazione sociale e delle relazioni sociali, al fine di rendere la creazione della ricchezza (relativamente) indipendente dal tempo di lavoro impiegato in essa. Dall’altro lato esso intende misurare le gigantesche forze sociali cosi create alla stregua del tempo di lavoro, e imprigionarle nei limiti che sono necessari per conservare come valore il valore già creato. Le forze produttive e le relazioni sociali – entrambi lati diversi dello sviluppo dell’individuo sociale – figurano per il capitale solo come mezzi, e sono per esso solo mezzi per produrre sulla sua base limitata. Ma in realtà essi sono le condizioni per far saltare in aria questa base. “Una nazione si può dire veramente ricca, quando invece di 12 si lavora solo 6 ore. Ricchezza reale (wealth) non è il comando di tempo di pluslavoro, ma tempo disponibile, fuori di quello usato nella produzione immediata, per ogni individuo e per tutta la società” [Anonimo XIX sec., The source and remedy of the national difficulties: a letter to Lord John Russell, 1821].
139

La natura non costruisce macchine, non costruisce locomotive, ferrovie, telegrafi elettrici, filatoi automatici, ecc. Essi sono prodotti dell’industria umana; materiale naturale, trasformato in organi della volontà umana sulla natura o della sua esplicazione nella natura. Sono organi del cervello umano creati dalla mano umana; capacita scientifica oggettivata. Lo sviluppo del capitale fisso mostra fino a quale grado il sapere sociale generale – knowledge – è diventato forza produttiva immediata, e quindi le condizioni del processo vitale stesso della società sono passate sotto il controllo del general intellect [intelligenza generale], e rimodellate in conformità ad esso; fino a quale grado le forze produttive sociali sono prodotte, non solo nella forma del sapere, ma come organi immediati della prassi sociale, del processo di vita reale.
[LF. VII]
SECONDA PARTE
II.1. Accumulazione e mercato mondiale
II.1.1. La legge generale dell’accumulazione
La conversione di una somma di denaro in mezzi di produzione e in forza-lavoro è il primo movimento compiuto dalla quantità di valore che deve funzionare come capitale; e avviene nel mercato, nella sfera della circolazione. La seconda fase del movimento, cioè il processo di produzione, è conclusa appena i mezzi di produzione seno convertiti in merce il cui valore superi il valore delle sue parti costitutive, e che dunque contenga il capitale originariamente anticipato e inoltre un plusvalore. Queste merci debbono ora venir gettate di nuovo nella sfera della circolazione. Bisogna venderle, realizzarne in denaro il valore, convertire di nuovo in capitale questo denaro, e così via. Questo movimento circolare che percorre sempre le identiche fasi successive costituisce la circolazione del capitale. La prima condizione dell’accumulazione è che il capitalista sia riuscito a vendere le sue merci e a riconvertire in capitale la parte maggiore del denaro così ricevuto.
Il capitalista che produce il plusvalore, cioè estrae direttamente dai lavoratori lavoro non retribuito e lo fissa in merci, è sì il primo ad appropriarsi questo plusvalore, ma non è affatto l’ultimo suo proprietario. Deve in un secondo tempo spartirlo con capitalisti che compiono altre funzioni nel complesso generale della produzione sociale, con i proprietari fondiari, ecc. Quindi il plusvalore si scinde in parti differenti. I suoi frammenti toccano a differenti categorie di persone e vengono ad avere forme differenti, autonome fra loro, come profitto, interesse, guadagno commerciale, rendita fondiaria, ecc. Qui dunque supponiamo, da una parte, che il capitalista che produce la merce la venda al suo valore, e non ci soffermeremo oltre sul ritorno del capitalista al mercato delle merci né sulle nuove forme che il capitale assume nella sfera della circolazione, né sulle condizioni concrete della riproduzione in essa inviluppate. Dall’altra parte considereremo il produttore capitalistico come proprietario di tutto il plusvalore, ossia, se si vuole, come rappresentante di tutti coloro che partecipano con lui al bottino. Dunque, in un primo momento consideriamo l’accumulazione astrattamente, cioè come puro e semplice momento del processo immediato di produzione.
Del resto, in quanto ha luogo l’accumulazione, il capitalista riesce a vendere la merce prodotta e a riconvertire in capitale il denaro che ne ha ricavato. Inoltre: il frazionarsi del plusvalore in parti differenti non ne cambia in nulla la natura, né cambia le condizioni necessarie affinché esso diventi elemento dell’accumulazione. Qualunque sia la porzione del plusvalore che il produttore capitalistico trattiene per se stesso o cede ad altri, egli è sempre il primo ad appropriarselo. Dunque il presupposto della nostra esposizione dell’accumulazione è anche il presupposto del suo reale processo. Dall’altra parte, lo scindersi del plusvalore e il movimento mediatore della circolazione oscurano la forma fondamentale semplice del processo d’accumulazione. Quindi, se vogliamo analizzarlo allo stato puro, dobbiamo transitoriamente far astrazione da tutti i fenomeni che nascondono il gioco interno del suo meccanismo. Qualunque sia la forma sociale del processo di produzione, questo o dev’essere continuativo o deve sempre tornar a percorrere periodicamente gli stessi stadi. Come una società non può smettere di consumare, così non può smettere di produrre. Quindi ogni processo sociale di produzione, considerato in un nesso continuo e nel fluire costante del suo rinnovarsi, è insieme processo di riproduzione. Se la produzione ha forma capitalistica, così anche la riproduzione. Come nel modo di produzione capitalistico il processo lavorativo si presenta solo come mezzo
140

del processo di valorizzazione, così la riproduzione si presenta come semplice mezzo per riprodurre come capitale, cioè come valore che si valorizza, il valore anticipato. Il costume economico caratteristico di capitalista rimane all’uomo soltanto perché il suo denaro funziona in continuazione come capitale.
Dunque il processo di produzione capitalistico riproduce col suo stesso andamento la separazione fra forza-lavoro e condizioni di lavoro. E così riproduce e perpetua le condizioni per lo sfruttamento del lavoratore. Esso costringe costantemente il lavoratore a vendere la sua forza-lavoro, per vivere, e costantemente mette il capitalista in grado di acquistarla, per arricchirsi. Non è più il caso che pone capitalista e lavoratore l’uno di fronte all’altro sul mercato delle merci come compratore e venditore. È il doppio mulinello del processo stesso che torna sempre a gettare il lavoratore sul mercato delle merci come venditore della propria forza-lavoro e a trasformare il suo prodotto in mezzo d’acquisto del capitalista. In realtà, il lavoratore appartiene al capitale anche prima di essersi venduto al capitalista. La sua servitù economica è mediata e insieme dissimulata dal rinnovamento periodico della sua vendita di se stesso, dal variare del suo padrone salariale individuale e dall’oscillazione nel prezzo di mercato del lavoro. Il processo di produzione capitalistico, considerato nel suo nesso complessivo, cioè considerato come processo di riproduzione, non produce dunque solo merce, non produce dunque solo plusvalore, ma produce e riproduce il rapporto capitalistico stesso; da una parte il capitalista, dall’altra il lavoratore salariato.
In precedenza avevamo da considerare come il plusvalore nasca dal capitale, ora dobbiamo vedere come il capitale nasce dal plusvalore. Adoperare plusvalore come capitale ossia ritrasformare plusvalore in capitale significa accumulazione del capitale. Una parte del plusvalore viene consumata dal capitalista come reddito, un’altra viene adoperata come capitale, cioè accumulata. E solo in quanto egli è capitale personificato, la sua propria necessità transitoria è insita nella necessità transitoria del modo di produzione capitalistico, ma i motivi che lo spingono non sono il valore d’uso o il godimento, ma il valore di scambio e la moltiplicazione di quest’ultimo. Come fanatico della valorizzazione del valore egli costringe, senza scrupoli l’umanità alla produzione per la produzione, spingendola quindi a uno sviluppo delle forze produttive sociali e alla creazione di condizioni materiali di produzione che sole possono costituire la base reale d’una forma superiore di società il cui principio fondamentale sia lo sviluppo pieno e libero di ogni individuo. Il capitalista è rispettabile solo come personificazione del capitale; in tale qualità condivide con il tesaurizzatore l’istinto assoluto dell’arricchimento. Ma ciò che in costui si presenta come mania individuale, nel capitalista è effetto del meccanismo sociale, all’interno del quale egli non è altro che una ruota dell’ingranaggio. Oltre a ciò, lo sviluppo della produzione capitalistica rende necessario un aumento continuo del capitale collocato in un’impresa industriale, e la concorrenza impone a ogni capitalista individuale le leggi immanenti del modo di produzione capitalistico come leggi coercitive esterne. Lo costringe a espandere continuamente il suo capitale per mantenerlo, ed egli lo può espandere soltanto per mezzo dell’accumulazione progressiva.
Nelle formazioni economiche sociali più differenti si ha non soltanto riproduzione semplice, ma anche riproduzione su scala allargata, sia pure in misura differente: si produce di più e si consuma di più, in progressione, e dunque si trasforma in mezzi di produzione anche una maggior quantità di prodotto. Però questo processo non si presenta come accumulazione di capitale e quindi neppure come funzione del capitalista Anche i mezzi di produzione del lavoratore e quindi anche il suo prodotto e i suoi mezzi di sussistenza non si trovano contrapposti al lavoratore in forma di capitale. È dote naturale del lavoro vivente conservare il vecchio valore nel mentre ne crea uno nuovo. Quindi il lavoro, col crescere dell’efficienza, del volume e del valore dei suoi mezzi di produzione, e cioè con l’accumulazione che accompagna lo sviluppo della sua forza produttiva, conserva e perpetua, in sempre nuove forme, un valore capitale sempre crescente. Questa forza naturale del lavoro si presenta come forza di autoconservazione del capitale al quale essa è incorporata, proprio allo stesso modo che le forze produttive sociali del lavoro si presentano come qualità del capitale e come la costante appropriazione del pluslavoro da parte del capitalista si presenta come autovalorizzazione costante del capitale. Tutte le forze del lavoro si proiettano come forze del capitale, come tutte le forme di valore della merce si presentano come forme di denaro.
Col crescere del capitale cresce la differenza fra capitale impiegato e capitale consumato. Nella proporzione nella quale questi mezzi di produzione servono come creatori di prodotti senza aggiungere valore al prodotto, cioè nella proporzione in cui vengono usati interamente ma consumati solo parzialmente, essi forniscono, come abbiamo accennato prima, lo stesso servizio gratuito che forniscono le forze naturali, come acqua, vapore, luce, elettricità ecc. Questo servizio gratuito del lavoro trascorso, quando viene preso e animato dal lavoro vivente, s’accumula insieme all’allargarsi della scala d’accumulazione. Poiché il lavoro trascorso si traveste sempre in capitale, cioè poiché il passivo del lavoro di A, B, C, ecc. si traveste sempre nell’attivo del non-lavoratore X, borghesi ed economisti politici sono pieni di elogi per i meriti del lavoro trascorso, il quale, secondo il genio scozzese Mac Culloch deve addirittura incassare un proprio compenso (interesse, profitto, ecc.). Dunque, l’importanza sempre crescente del lavoro trascorso che collabora, in forma di mezzi di lavoro, nel vivente processo lavorativo, viene attribuita alla figura di esso estraniata al
141

lavoratore, del quale esso costituisce il lavoro trascorso e non pagato: viene attribuita alla figura di capitale di esso. Tanto gli agenti pratici della produzione capitalistica che i loro azzeccagarbugli ideologici sono incapaci di pensare il mezzo di produzione distaccato dalla maschera sociale antagonistica che oggi gli aderisce, allo stesso modo che un padrone di schiavi non è capace di pensare il lavoratore stesso distaccato dalla sua caratteristica dì schiavo.
Dato il grado di sfruttamento della forza-lavoro, la massa del plusvalore è determinata dal numero dei lavoratori che vengono sfruttati in un medesimo momento, e questo numero corrisponde, benché in proporzione variabile, alla grandezza del capitale. Dunque, quanto più il capitale cresce a mezzo dell’accumulazione successiva, tanto più cresce anche la somma di valore che si scinde in fondo di consumo e in fondo di accumulazione; il fattore più importante dì questa indagine sono la composizione del capitale e le variazioni che essa subisce nel corso del processo d’accumulazione. La composizione del capitale è da considerarsi in duplice senso. Dal lato del valore essa si determina mediante la proporzione in cui il capitale si suddivide in capitale costante, ossia valore dei mezzi di produzione, e in capitale variabile, ossia valore della forza-lavoro, somma complessiva dei salari. Dal lato della materia, quale essa opera nel processo di produzione, ogni capitale sì suddivide in mezzi di produzione e in forza-lavoro vivente; questa composizione si determina mediante il rapporto fra la massa dei mezzi di produzione usati da una parte e della quantità di lavoro necessaria per il loro uso dall’altra. Chiamerò composizione del valore la prima e composizione tecnica del capitale la seconda. Fra entrambe esiste uno stretto rapporto reciproco. Per esprimere quest’ultimo, chiamerò la composizione del valore del capitale, in quanto sia determinata dalla sua composizione tecnica e in quanto rispecchi le variazioni di questa: la composizione organica del capitale. Dove si parlerà della composizione del capitale senz’altra specificazione, si dovrà sempre intenderne la composizione organica. Fin qui abbiamo considerato solo una fase particolare di questo processo, la fase in cui l’aumento di capitale ai verifica eguale rimanendo la composizione tecnica del capitale. Ma il processo va al di là dei limiti di questa fase.
Una volta date le basi generali del sistema capitalistico, nel corso dell’accumulazione si giunge ogni volta a un punto in cui lo sviluppo della produttività del lavoro sociale diventa la leva più potente dell’accumula -zione. Il grado sociale di produttività del lavoro si esprime nel volume della grandezza relativa dei mezzi di produzione che un lavoratore trasforma in prodotto durante un dato tempo, e con la medesima tensione della forza-lavoro. La massa dei mezzi di produzione con i quali egli opera cresce insieme alla produttività del suo lavoro. Questi mezzi di produzione intervengono in ciò con duplice funzione. L’aumento degli uni è la conseguenza, quello degli altri la condizione della produttività crescente del lavoro. Che sia condizione o che sia conseguenza, la crescente grandezza di volume dei mezzi di produzione paragonata alla forze-lavoro ad essi incorporata esprime la crescente produttività del lavoro. L’aumento di quest’ultima si manifesta dunque nella diminuzione della massa di lavoro paragonata alla massa dei mezzi di produzione da essa messa in movimento ossia si manifesta nella diminuzione della grandezza del fattore soggettivo del processo di lavoro a paragone dei suoi fattori oggettivi. Questo mutamento nella composizione tecnica del capitale, l’aumento della massa dei mezzi di produzione a paragone della massa della forza-lavaro che li anima, si rispecchia nella composizione del valore del capitale, nell’aumento della parte costitutiva costante del valore capitale a spese della sua parte costitutiva variabile.
La diminuzione della parte variabile del capitale nei confronti della parte costante, ossia la mutata composizione del valore capitale, indica però solo in via approssimativa il cambiamento nella composizione delle sue parti costitutive materiali. Con la crescente produttività del lavoro non solo aumenta il volume dei mezzi di produzione da esso consumati, ma il valore di questi ultimi diminuisce a paragone del loro volume. Il loro valore aumenta dunque in assoluto, ma non in proporzione del loro volume. L’aumento della differenza fra capitale costante e variabile è quindi molto minore dell’aumento della differenza fra la massa dei mezzi di produzione in cui si converte il capitale costante e la massa di forza-lavoro in cui si converte il capitale variabile. La prima delle due differenze aumenta insieme alla seconda, ma in un grado minore. Sul terreno della produzione delle merci la produzione su larga scala può allignare solo in forma capitalistica. Una certa accumulazione di capitale nelle mani di produttori individuali di merci costituisce quindi il presupposto del modo di produzione specificamente capitalistico.
La ininterrotta ritrasformazione del plusvalore in capitale si rappresenta come grandezza crescente del capitale che entra nel processo di produzione. Questa diviene a sua volta base di una scala allargata di produzione, dei metodi ad essa concomitanti per l’incremento della forza produttiva del lavoro e per l’acceleramento della produzione di plusvalore. Se dunque un certo grado dell’accumulazione capitalistica si manifesta come condizione del modo di produzione specificamente capitalistico, quest’ultimo ha per ripercussione un’accumulazione accelerata del capitale. Insieme all’accumulazione del capitale si sviluppa quindi il modo di produzione specificamente capitalistico e, insieme al modo specificamente capitalistico, l’accumulazione del capitale. Questi due fattori economici producono, in ragion composta dell’impulso che si danno a vicenda, il cambiamento della composizione tecnica del capitale, in virtù del quale la parte
142

costitutiva variabile diventa sempre più piccola a paragone di quella costante. Ogni capitale individuale è una concentrazione più o meno grande di mezzi di produzione con il corrispondente comando su un esercito più o meno grande di lavoratori. Ogni accumulazione diventa il mezzo di accumulazione nuova. Essa allarga, con la massa aumentata della ricchezza operante come capitale, la sua concentrazione nelle mani di capitalisti individuali, e con ciò la base della produzione su larga scala e dei metodi di produzione specificamente capitalistici. L’aumento del capitale sociale si compie con l’aumento di molti capitali individuali
Due punti caratterizzano questo tipo di concentrazione che è basata direttamente sull’accumulazione, anzi è identica ad essa. Primo: la crescente concentrazione dei mezzi di produzione sociali nelle mani di capitalisti individuali è limitata, in circostanze altrimenti invariate, dal grado di aumento della ricchezza sociale. Secondo: la parte del capitale sociale domiciliata in ogni particolare sfera della produzione è ripartita su molti capitalisti, i quali sono contrapposti l’uno all’altro come produttori di merci indipendenti e in concorrenza tra di loro. L’accumulazione e la concentrazione ad essa concomitante non soltanto sono disseminate su molli punti, ma l’aumento dei capitali operanti è attraversato dalla formazione di capitali nuovi e dalla scissione di capitali vecchi. Se quindi da un lato l’accumulazione si presenta come concentrazione crescente dei mezzi di produzione e del comando sul lavoro, dall’altro si presenta come repulsione reciproca di molti capitali individuali. Contro questa dispersione del capitale complessivo sociale in molti capitali individuali oppure contro la repulsione reciproca delle sue frazioni agisce l’attrazione, di queste ultime. Non si tratta più di una concentrazione semplice dei mezzi di produzione e del comando sul lavoro, identica con l’accumulazione. Si tratta di concentrazione di capitali già formati, del superamento della loro autonomia individuale, dell’espropriazione del capitalista da parie del capitalista, della trasformazione di molti capitali minori in pochi capitali più grossi. Questo processo si distingue dal primo per il fatto che esso presuppone solo una ripartizione mutata dei capitali già esistenti e funzionanti, che il suo campo d’azione non è dunque limitato dall’aumento assoluto della ricchezza sociale o dai limiti assoluti dell’accumulazione. Il capitale qui in una mano sola si gonfia da diventare una grande massa, perché là in molte mani va perduto. È questa la centralizzazione vera e propria a differenza dell’accumulazione e concentrazione.
Non è possibile qui dare uno svolgimento delle leggi di questa centralizzazione dei capitali ossia dell’at-trazione del capitale da parte del capitale. Basterà un breve cenno sui fatti. La lotta della concorrenza viene condotta rendendo più a buon mercato le merci. Il buon mercato delle merci dipende, ceteris paribus, dalla produttività del lavoro, ma questa a sua volta dipende dalla scala della produzione. I capitali più grossi sconfiggono perciò quelli minori. Si ricorderà inoltre che, con lo sviluppo del modo di produzione capitalistico, cresce il volume minimo del capitale individuale, necessario per far lavorare un’azienda nelle sue condizioni normali. I capitali minori si affollano perciò in sfere della produzione delle quali la grande industria si sia impadronita fino allora solo in via sporadica o incompleta. La concorrenza infuria qui in proporzione diretta del numero e in proporzione inversa della grandezza dei capitali rivaleggianti. Essa termina sempre con la rovina di molti capitalisti minori, i cui capitali in parte passano nelle mani del vincitore, in parte scompaiono. Astraendo da ciò, con la produzione capitalistica si forma una potenza assolutamente nuova, il sistema del credito, che ai suoi inizi s’insinua furtivamente come modesto ausilio dell’accumulazione, attira mediante fili invisibili i mezzi pecuniari, disseminati in masse maggiori o minori alla superficie della società, nelle mani di capitalisti individuali o associati, diventando però ben presto un’arma nuova e terribile nella lotta della concorrenza e trasformandosi infine in un immane meccanismo sociale per la centralizzazione dei capitali.
Nella misura in cui si sviluppano la produzione e l’accumulazione capitalistica, si sviluppano la concorrenza e il credito, le due leve più potenti della centralizzazione. Allo stesso tempo il progresso dell’accumulazione aumenta la materia centralizzabile, ossia i capitali singoli, mentre l’allargamento della produzione capitalistica crea qua il bisogno sociale, là i mezzi tecnici di quelle potenti imprese industriali, la cui attuazione è legata a una centralizzazione del capitale avvenuta in precedenza. Oggi quindi la reciproca forza d’attrazione dei capitali singoli e la tendenza alla centralizzazione sono più forti che mai nel passato. Ma anche se l’estensione relativa e l’energia del movimento centralizzatore sono determinati in un certo grado dalla grandezza già raggiunta dalla ricchezza capitalistica e dalla superiorità del meccanismo economico, ciò malgrado il progresso della centralizzazione non dipende affatto dall’aumento positivo della grandezza del capitale sociale. Ed è questo specificamente che distingue la centralizzazione dalla concentrazione, la quale non è che un’espressione diversa per indicare la riproduzione su scala allargata. La centralizzazione può avvenire in virtù di un semplice cambiamento nella distribuzione di capitali già esistenti, cioè di un semplice mutamento nel raggruppamento quantitativo delle parti costitutive del capitale sociale. Il capitale può crescere qua fino a diventare una massa potente in una sola mano, perché là viene sottratto a molte mani individuali. In un dato ramo d’affari la centralizzazione raggiungerebbe l’estremo limite solo se tutti i capitali ivi investiti si fondessero in un capitale singolo. In una società data questo limite
143

sarebbe raggiunto soltanto nel momento in cui tutto il capitale sociale fosse riunito nella mano di un singolo capitalista o in quella di un’unica associazione capitalistica.
La centralizzazione completa l’opera dell’accumulazione mettendo in grado i capitalisti industriali di allargare la scala delle loro operazioni. Ora, che quest’ultimo risultato sia conseguenza dell’accumulazione o della centralizzazione, che la centralizzazione si compia in via violenta, cioè con l’annessione, nel quale caso certi capitali diventano per altri centri di gravità così preponderanti da spezzarne la coesione individuale e da attirare poi a sé i frammenti singoli, o che avvenga la fusione di una quantità di capitali già formati oppure in formazione, in virtù di un procedimento più blando, cioè della formazione di società per azioni, l’effetto economico rimane lo stesso. La cresciuta estensione dello stabilimento industriale costituisce dovunque il punto di partenza di una più ampia organizzazione del lavoro complessivo di molti, di uno sviluppo più largo delle loro forze motrici materiali, ossia dì una progrediente trasformazione di processi di produzione isolati e compiuti secondo consuetudine in processi di produzione combinati socialmente e predisposti scientificamente. Ma è chiaro che l’accumulazione, il graduale aumento del capitale mediante la riproduzione che dalla forma di circolo trapassa in quella di spirale, è un procedimento lentissimo a paragone della centralizzazione la quale non ha che da mutare il raggruppamento quantitativo delle parti integranti del capitale sociale.
[C, I.21-23]
II.1.2. L’innovazione nel processo industriale
Si legge alle volte che, nel diciannovesimo secolo, l’ingresso nell’area economica di nuovi paesi rappresentò la condizione di partenza, grazie alla quale si realizzò lo sviluppo economico. In un certo senso questa affermazione è vera. Se si intende dire invece che questa circostanza fu un fattore esterno, e cioè qualcosa di distinto da quello stesso sviluppo economico, sul quale avrebbe autonomamente agito, allora l’affermazione non è più vera: secondo la nostra concezione l’apertura di nuovi paesi è uno degli elementi dello sviluppo capitalistico, ed è insieme un risultato di quello stesso processo, responsabile di tutte le altre caratterizzazioni economiche della stessa epoca, una delle quali è la meccanizzazione dell’industria. Un’autorità del settore afferma, a esempio, che il tasso d’incremento della produzione totale, nel diciannovesimo secolo, non si spiega con l’“impresa capitalistica”, ma con il progresso tecnologico (invenzioni, macchinario). Non è ovviamente indifferente accettare la teoria implicita in questa affermazione, e cioè che la meccanizzazione dell’industria è un fenomeno distinto dall’“impresa capitalistica”, su cui avrebbe autonomamente influito e, quindi, è un fenomeno che avrebbe avuto uno svolgimento sostanzialmente uguale quale che fosse stata l’organizzazione sociale, oppure sostenere come noi facciamo (da questo punto di vista in totale accordo con Marx) che il progresso tecnologico è l’essenza stessa dell’impresa capitalistica e non può dunque essere da essa separato.
Il sistema di cui noi ci occupiamo implica fatti e concetti diversi, come la selezione, il cambiamento o, più in generale, l’evoluzione. Nel caso degli organismi biologici nessuno si scandalizza della distinzione tra il modo di funzionare di un organismo e la sua evoluzione nel tempo: essa non ha nulla di artificiale o di irreale, e per noi é naturale, perché i fatti ce la impongono. In secondo luogo quella distinzione non è affatto estranea ai modi di pensare nel mondo degli affari. Ogni uomo d’affari capisce che gestire la sua azienda nel modo abituale, seguendo la routine giornaliera, è una cosa, e che fondare una ditta o cambiarne la struttura e un’altra cosa, tanto è vero che affronta questi compiti con atteggiamenti marcatamente distinti tra di loro. Non avrebbe senso tentare di fondere in un unico schema quel che si deve fare e i tipi di comportamento incontrati nei due casi, semplicemente argomentando che la “vita reale” non presenta quasi mai l’uno senza gli altri, o perché il mondo reale è sempre dinamico. La risposta a chi non vuole accettare la nostra distinzione sostenendo che è troppo teorica, è semplice: attualmente tutti la usano, sia nella vita pratica che nella ricerca, anche se in modo inconscio e approssimato; è quindi meglio dare un inquadramento logico a questa pratica universale.
Chiunque lavori con gli equilibri parziali, scopre presto la necessità di uno strumento che gli dia la possibilità di trattare i processi economici affrontando il sistema nel suo insieme, cosa che non riesce a fare con i suoi strumenti “parziali”. A questo punto quella persona probabilmente integrerà il suo apparato con un sistema di relazioni tra gli aggregati sociali – come la produzione totale, il reddito totale, o il profitto netto totale – e cercherà di ragionare su questi aggregati, così come sugli elementi di primaria importanza del sistema preso nel suo insieme, e cioè la quantità di moneta, il tasso d’interesse e il livello dei prezzi. Se questi vari elementi sono combinati tra di loro in modo tale che non vi siano tendenze al cambiamento, che nascono dalle loro reciproche relazioni, si può parlare di equilibrio aggregato. Questo è il concetto di equilibrio usato, per esempio, da Kcynes nel Trattato sulla moneta. A molti fini è innegabilmente utile; ma è ovvio che questo tipo di equilibrio è compatibile con i più violenti squilibri da ogni altro punto di vista, tali
144

squilibri si manifesteranno modificando la situazione data, incluse le stesse quantità aggregate. È dunque fuorviante ragionare sull’equilibrio aggregato come se esso fosse capace di mettere in evidenza i fattori responsabili del cambiamento, e come se le perturbazioni del sistema-economico nel suo insieme trovassero in quegli aggregati soltanto la loro origine. Tale ragionamento è alla base di molte analisi erronee dei cicli economici, clic rimangono alla superficie delle cose, e non riescono a penetrare in profondità nei processi industriali sottostanti, che sono ciò che veramente conta. Questo modo di ragionare porta a trattare, in maniera meccanicistica e convenzionale, pochi indicatori isolati, e ad attribuire agli aggregati una propria vita e un significato causale, che essi non posseggono. Se pensiamo a quello che questi aggregati sono, si capisce immediatamente quanto sia facile, una volta che si sia scelto questo punto di partenza, scivolare verso tutte le superficialità delle teorie monetarie del ciclo.
La maggior parte delle variazioni intervenute nel consumo delle merci è stata imposta dai produttori ai consumatori che, il più delle volte, hanno resistito ai cambiamenti e vi sono stati poi riconciliati attraverso l’uso di complesse campagne pubblicitarie basate sul convincimento psicologico. Dal nostro punto di vista è irrilevante il fatto che solo la soddisfazione del consumatore dia significato, sotto il profilo sociale, a qualsiasi attività economica, o il fatto che le merci nuove o sconosciute debbano alla fine essere “sperimentate”, o ratificate, dai consumatori, e che sia necessario dire che sono state prodotte pensando ai desideri inespressi dei consumatori, o in base a indicazioni diverse da quelle risultanti dalla domanda effettiva. Per cambiamenti nei metodi di offerta delle merci intendiamo una serie di eventi molto più ampia di quanto, in senso letterale, significhi questa espressione. Vi facciamo rientrare l’introduzione di nuovi prodotti, che potrebbero anche servire come caso tipico: i cambiamenti nella tecnologia per produrre merci già in commercio, l’apertura di nuovi mercati o di nuove fonti di approvvigionamento, la taylorizzazione del lavoro, un miglior uso del materiale, l’avviamento di nuove organizzazioni” commerciali come i grandi magazzini – insomma qualsiasi “modo di fare le cose diversamente” nel campo economico – sono tutti esempi di quello che intendiamo dire con il termine “innovazione”. Occorre chiarire subito che questo concetto non è sinonimo di “invenzione”; indipendentemente dal suo significato, questo secondo termine è un parente molto lontano del nostro. Per di più, favorisce associazioni ingannevoli.
In primo luogo, comporta una limitazione veramente poco felice, perché tende a nascondere le vere discriminanti del fenomeno. È del tutto privo d’importanza se un’innovazione contiene una novità scientifica o no. Anche se la maggior parte delle innovazioni possono essere in qualche modo ricondotte a una qualche conquista nel regno della conoscenza teorica o pratica, ve ne sono molte per le quali ciò non è vero. L’inno-vazione è possibile senza quello che chiamiamo invenzione, e l’invenzione non necessariamente comporta u-n’innovazione, né provoca di per sé alcun effetto economicamente rilevante. I fenomeni economici che è possibile osservare nel caso speciale in cui innovazione e invenzione coincidono, non sono diversi dai fenomeni osservati in quei casi nei quali sono utilizzate preesistenti conoscenze. Sottolineare l’elemento invenzione, o definire l’innovazione attraverso l’invenzione, significherebbe dunque non soltanto sottolineare un elemento senza importanza per l’analisi economica, ma anche ridurre il fenomeno rilevante a qualcosa che ne costituisce solo una parte.
In secondo luogo, la creazione di una invenzione e la realizzazione della corrispondente innovazione sono due cose completamente diverse, anche nel caso in cui l’innovazione consista nel rendere effettiva, mediante l’azione degli operatori economici, una invenzione particolare, che è sorta in modo autonomo, o soprattutto in risposta a una data situazione economica. Se facciamo questo, ci rendiamo conto che le innovazioni sono il fatto fondamentale nella storia economica della società capitalistica, o nell’aspetto più strettamente economico di essa, e anche che da esse dipende in larga misura molto di quel che a prima vista si attribuisce ad altri fattori. Ci spieghiamo con un esempio: i processi economici moderni sono sostanzialmente legati all’urbanizzazione della popolazione e alle agevolazioni che l’azione pubblica mette a disposizione degli imprenditori. Ma nella maggior parte dei casi queste condizioni per le invenzioni future sono proprio il risultato dei processi industriali che rientrano nel nostro concetto di innovazione e che sono sorti proprio grazie alle innovazioni, o comunque resi possibili dalle stesse. Con l’espressione “evoluzione economica ”
indicheremo i cambiamenti del sistema economico provocati dalle innovazioni, inclusi i loro effetti e la risposta a essi data dal sistema economico. Certamente, niente può essere più vero dell’affermazione che l’innovazione, nel senso da noi definito, è praticamente al centro di tutti i fenomeni, di tutte le difficoltà, e di tutti i problemi della vita economica nella società capitalistica, e che tali fenomeni, difficoltà e problemi – cosi come l’estrema sensibilità del capitalismo alle perturbazioni – non ci sarebbero affatto se le risorse produttive passassero ogni anno attraverso gli stessi canali, muovendosi essenzialmente verso gli stessi fini, o se in ciò fossero ostacolate soltanto da influenze esterne.
Definiremo adesso più rigorosamente rinnovazione, mediante la funzione di produzione precedentemente introdotta. Questa funzione descrive il modo in cui varia la quantità del prodotto al variare delle quantità dei diversi fattori. Se, invece delle quantità dei fattori, facciamo variare la forma della funzione, si ha un’innova -zione. Perciò definiremo l’innovazione, molto semplicemente, come l’introduzione di una nuova funzione di
145

produzione, e ciò comprende sia il caso di una nuova merce sia nuove forme di organizzazione come la fusione, l’apertura di nuovi mercati ecc. L’innovazione sostituisce con un’altra legge quella che fino allora aveva spiegato gli effetti prodotti dalle successive immissioni di risorse. In entrambi i casi la transizione avviene con un salto dalla curva vecchia a quella nuova, che adesso vale per tutta la produzione, e non soltanto per la produzione oltre quella precedentemente realizzata con il vecchio metodo.
Se i prezzi dei fattori non sono costanti, e cambiano indipendentemente dall’iniziativa delle imprese, l’ef -fetto sulle curve di costo – totale, media e marginale – è del tutto analogo a quello dell’innovazione: esse cessano di esistere bruscamente e al loro posto ne compaiono delle nuove. È facile rendersi conto che non è possibile costruire una curva teorica di costo, che si riferisca ad esempio a un dato livello di salari in una sua parte, e a un altro livello in un’altra parte. L’analogia può quindi servire a illustrare ancora più chiaramente che è impossibile esprimere i costi marginali come decrescenti (in modo più o meno continuo) in funzione del prodotto, e i costi totali come decrescenti o soggetti a un incremento inferiore a quello che sì avrebbe altrimenti, per effetto di successive innovazioni. Ciò che predomina nel quadro della vita capitalistica e che più di ogni altra cosa ci porta a pensare che prevalgano i costi decrescenti dai quali dipendono gli squilibri, la concorrenza spietata ecc, è l’innovazione, e cioè l’introduzione nel sistema di nuove funzioni di produzione, da cui dipende il continuo spostamento delle esistenti curve di costo. Spinti da altre ragioni a mettere in discussione la validità dell’analisi che si basa sul concetto di curve di costo che decrescono monotonicamente, ci rendiamo conto di non averne bisogno, perché il concetto di una curva di costo che si sposta sotto l’urto delle innovazioni ci da tutto quello che serve per trattare i fatti, per spiegare i quali le curve di costo discendenti furono concepite.
L’impressione che le imprese che si muovono negli intervalli dei costi decrescenti siano spesso al centro delle vicissitudini della vita industriale non è errata. Ciò ci riporta all’innovazione perché le imprese che, venendosi a trovare in questi intervalli della curva, mettono a soqquadro l’esistente struttura industriale e portano così verso il monopolio, sono di solito proprio quelle che hanno introdotto nuove funzioni di produzione e che si battono per la conquista dì un proprio spazio di mercato. Se non fosse per questo, il posto che i costì decrescenti occupano nel pensiero economico potrebbe essere subito drasticamente ridimensionato. Prima di procedere, sarebbe meglio riesporre lo stesso tema mediante i ben noti concetti di Marshall, “economie interne” ed “economie esterne”. Per quanto riguarda il primo, può sembrare strano dire che, se devono spiegare la forma di una curva di costo, le economie di scala, interne alla singola impresa, necessariamente si riducono agli effetti connessi con il fenomeno di elevate dimensioni unitarie dei fattori. Ciò è vero non solo nel caso del macchinario costoso, ma anche nei casi di una più razionale divisione del lavoro o, più in generale, di una migliore “organizzazione” dei fattori, che è destinata a verificarsi quando si espande la produzione. Se per economie interne si vuole indicare il fattore industriale dominante, che si ha in mente quando ci si riferisce alla grande industria, esse sono allora dovute all’innovazione e non possono essere espresse semplicemente in funzione della produzione, anche se storicamente fossero condizionate dal suo incremento. In nessun caso sorgono difficoltà in merito al fatto che i costi decrescenti sono incompatibili con l’equilibrio concorrenziale o per quanto riguarda la spiegazione degli squilibri effettivamente osservati.
Le economie esterne consistono in una riduzione dei costi unitavi, dovuta a circostanze favorevoli connesse con la crescita di un’industria, in ispccìe con quella che si verifica in una certa località. Non è sempre facile distinguerle dalle economie interne e vi sono molti casi intermedi, dei quali non ci occuperemo. È molto più importante il fatto che “le economie esterne traggano normalmente origine dalle economie interne di qualche industria complementare” [R. F. Kahn, Economic journal, marzo 1935]. Perciò nessuna curva di costo decrescente monotonicamente può essere derivata dalle economie esterne. Il termine è ancora utile per indicare gli effetti che le innovazioni in un’industria determinano in un’altra industria e che costituiscono, una parte molto importante dei meccanismo di evoluzione economica, nel senso da noi attribuito a questa espressione. Ma non gli si deve permettere di agire come uno schermo, che nasconde le innovazioni sottostanti e finisce per essere un fattore autonomo rispetto a esse.
Ritorniamo al nostro tema. Per sottolineare meglio il modus operandi delle innovazioni, promuoveremo al rango di ipotesi alcuni fatti di osservazione corrente, connessi con la nostra analisi dei costi. Le innovazioni maggiori e anche molte innovazioni minori comportano la costruzione di “nuovi impianti” (e attrezzature) – o la ricostruzione di vecchi impianti – che richiedono un dispendio non indifferente dì tempo e di denaro. In un sistema nel quale il processo dì evoluzione procede a ritmo veloce, praticamente tutti i nuovi impianti costruiti al di là di quelli che servono alla sostituzione dei vecchi, e molti anche di questi ultimi, o incorporano una qualche innovazione o sono una risposta a situazioni riconducibili a una qualche innovazione. Nessuna impresa che sia gestita esclusivamente in base a direttrici prestabilite, indipendentemente dalla consapevolezza che la direzione possiede di questa routine, rimane a lungo fonte di profitto nella società capitalista, e arriva il giorno in cui una tale impresa non è più in grado di pagare gli interessi e neanche gli ammortamenti. Basta guardarsi intorno per capire che tipo di impresa abbiamo in mente – che vive della fama, della rete di contatti, della quasi-rendita e delle riserve accumulate in gioventù,
146

che passa decorosamente in secondo piano, indugiando nel buio di una rispettabile decadenza che fatalmente s’infittisce. Questo adattamento descrive in modo accurato le situazioni e le lotte, che si osservano nella realtà dell’evoluzione capitalistica, e in particolare il carattere dei suoi squilibri e delle sue fluttuazioni. Descrive anche quel processo di continua ascesa e decadenza delle imprese e delle industrie, che è l’elemento centrale – anche se molto trascurato – del meccanismo capitalistico. Occorre mettere in evidenza il caso delle grandi aziende, in particolare di quelle “giganti”, che spesso sono solo delle “scatole vuote” all’interno delle quali gente sempre diversa passa da innovazione a innovazione. In tali casi l’innovazione può sorgere, e frequentemente sorge, all’interno di una stessa impresa che la coordina con l’apparato preesistente e che, perciò, non ha bisogno di affermarsi nell’industria mediante un processo concorrenziale autonomo.
Per occuparsi di questo caso, che in futuro può acquistare sempre più importanza, introduciamo il concetto di “capitalismo trustificato” per distinguerlo da “capitalismo concorrenziale”. Perfino nel mondo delle imprese giganti, ne sorgono di nuove e altre decadono. Le innovazioni emergono in primo luogo dalle “giovani”, e le “vecchie” mostrano di regola sintomi di ciò che eufemisticamente viene chiamato conservatorismo. Intendiamo fare quanto segue: non intendiamo attaccare la teoria tradizionale, walrasiana o marshalliana, nelle sue stesse fondamenta. Sosteniamo anche che questo modello copre uno spazio più modesto di quanto si creda normalmente e che l’intero processo economico non può essere adeguatamente descritto da esso, o in termini di deviazioni (secondarie) dallo stesso. Ciò è soddisfacente soltanto se il processo da analizzare è quello stazionario, o quello che “cresce in modo uniforme” nel senso della nostra definizione del termine “crescita”: è ovvio che qualsiasi fattore esterno di disturbo può verificarsi a condizione che l’adattamento a esso sia passivo. Ciò equivale a dire che l’ipotesi che il comportamento economico sia perfettamente razionale e tempestivo, e anche che in linea di principio sia uguale per tutte le imprese, si può ritenere valida solo entro i limiti delle esperienze acquisite e delle motivazioni note. Nell’analisi del processo relativo a questi fatti, la teoria tradizionale rimane naturalmente al suo posto: descrive le risposte all’innovazione di quelle imprese che non si innovano.
Ogni volta che una nuova funzione di produzione e stata avviata con successo e l’industria vede realizzata la novità e risolti i suoi maggiori problemi, diventa molto più facile per altre persone fare la stessa cosa, e anche farla meglio. In realtà, sono spinte a copiarla, se possono, e alcune lo fanno subito. Si tenga presente che diventa più facile non solo fare la stessa cosa ma anche cose simili in direzioni simili – sia complementari che concorrenziali – mentre certe innovazioni, come la macchina a vapore, influenzano direttamente una grande varietà d’industrie. Ciò sembra offrire interpretazioni del tutto semplici e realistiche di due eccezionali fatti osservati: primo, che le innovazioni non rimangono eventi isolati e non sono distribuite in modo uniforme nel tempo, ma tendono al contrario ad ammassarsi, a sorgere in grappoli, semplicemente perché prima alcune imprese e dopo la maggior parte di esse seguono la scia dell’innovazione riuscita; secondo, che le innovazioni non sono in nessun momento distribuite casualmente in tutto il sistema economico, ma tendono a concentrarsi in certi settori e nei loro dintorni. Ma in molti casi, inclusi importanti casi storici, le singole innovazioni implicano, a causa della loro natura, un “grande” salto e un “grande” cambiamento. Appena una ferrovia in un paese nuovo, non ancora servito dalle ferrovie, entra a far parte del sistema, scombussola tutte le convenienze alla localizzazione, tutte le previsioni di costo, e tutte le funzioni di produzione all’interno del suo raggio di influenza e praticamente nessun “metodo” che era ottimale prima, rimane tale dopo. Il caso può essere espresso con ancora maggior forza se si considera la costruzione di ferrovie e l’elettrificazione del mondo intero come un solo processo.
I mutamenti industriali non consistono mai in un’avanzata armoniosa, in cui tutti gli elementi del sistema tendono a muoversi di conserva. In ogni momento, alcune industrie avanzano, altre rimangono indietro; e le divergenze che ne nascono sono un elemento essenziale nelle situazioni che ne conseguono. Nel settore industriale, così come in ogni altro settore della vita sociale e culturale, il progresso non solo procede impetuosamente e per salti ma anche per vie traverse, fertili di conseguenze diverse da quelle che si avrebbero seguendo le vie principali. È facile localizzare in ogni periodo storico la nascita del processo e associarla con certe industrie e, entro queste industrie, con certe imprese dalle quali sorgono i fattori di disturbo, che poi coinvolgono tutto il sistema. Al contrario, dobbiamo riconoscere che l’evoluzione è tortuosa, discontinua, disarmonica per sua natura, che la disarmonia è inerente allo stesso modus operandi dei fattori del progresso. Ciò certamente non contraddice l’osservazione: la storia del capitalismo è segnata da esplosioni e catastrofi violente, l’evoluzione è un fattore di disturbo delle strutture esistenti ed è più simile a una serie di esplosioni che a un processo di trasformazione sottile ma continuo. Ne derivano due conseguenze, una delle quali è di carattere economico, l’altra sociologica.
Primo, l’assunzione del rischio non fa parte della funzione imprenditoriale. È il capitalista che corre il rischio. L’imprenditore lo corre solo nella misura in cui, oltre a essere imprenditore, è anche capitalista, ma in quanto imprenditore perde il denaro altrui. Secondo, gli imprenditori come tali non formano una classe sociale. Anche se, in caso di successo, essi o i loro discendenti ascendono alla classe dei capitalisti, non
147

fanno parte fin dall’inizio né di questa né di qualche altra classe specifica. Ma la posizione della tipica famiglia industriale o commerciale o finanziaria trova la sua diretta origine in una qualche innovazione. Quando il loro periodo imprenditoriale è passato, è vero che quelle famiglie vivono di quasi-rendite, spesso sostenute da situazioni di monopolio o, se hanno completamente tagliato i ponti con gli affari, vivono di interesse. Ma se seguiamo queste quasi-rendite o guadagni di monopolio o capitali monetari fino alle loro fonti, quasi sempre viene fuori una nuova funzione di produzione.
[PCCE, I.1-3]
II.1.3 Il mercato mondiale e l’internazionalizzazione
Il capitalismo moderno è un capitalismo mondiale. Questo significa che i rapporti di produzione capitalistico dominano nel mondo intero e tutte le parti del nostro pianeta sono legate fra loro da un solido vincolo economico. Nella nostra epoca l’economia sociale trova la sua concreta espressione nell’economia mondiale. Essa è una unità reale esistente. A questo punto si origina la questione su quali siano le parti che agiscono coscientemente nell’economia mondiale capitalistica. Teoricamente è concepibile un capitalismo mondiale come sistema di singoli imprenditori privati. Tuttavia la struttura del capitalismo moderno è di tal genere che le organizzazioni collettivo-capitalistiche rappresentano i soggetti dell’economia: “trusts capitalistici di stato”. Le unità costituenti il sistema dell’economia mondiale moderna, non sono imprenditori singoli, ma complessi articolati, “trusts capitalistici di stato”. Certamente esistono legami internazionali anche fra singoli imprenditori di differenti “paesi”, e la natura di questi legami può in qualche concreto caso essere direttamente contrapposta al modo come questi “paesi” sono collegati fra di loro. Negli ultimi tempi tuttavia i rapporti fra gli interi complessi divengono preponderanti.
“L’economia politica” capitalistica è divenuta da sistema irrazionale a razionale organizzazione, è passata da un’economia senza soggetti a un soggetto economico. Questa trasformazione è dovuta alla crescita del capitalismo finanziario e alla fusione dell’organizzazione economica e di quella politica. Non venne però contemporaneamente eliminata in generale né l’anarchia della produzione capitalistica né la concorrenza fra i produttori di merci. Questi fenomeni non sono solamente rimasti ma si sono approfonditi in quanto si riproducono su scala economica mondiale. Il sistema dell’economia mondiale è così ciecamente irrazionale e “privo di soggetto” come l’antico sistema dell’economia nazionale. Il mercato diviene effettivamente mercato mondiale e cessa di essere “nazionale”. Il particolare carattere del trust capitalistico di stato ci illumina anche sul particolare tipo della lotta concorrenziale. Il trust capitalistico di stato è propriamente un enorme gruppo imprenditoriale articolato. Posti di fronte l’un l’altro i trusts capitalistici di stato non soltanto si contrappongono come unità che producono la medesima “merce mondiale”, ma anche come parti del lavoro sociale ripartito su scala mondiale, che si completano reciprocamente sul piano economico.
Il passaggio al sistema del capitalismo finanziario rafforza sempre più il processo di trasformazione della concorrenza. Corrispondendo anche il metodo della lotta al tipo della concorrenza, ne consegue inevitabilmente sul mercato mondiale un “inasprimento dei rapporti”. La concorrenza viene accompagnata dai metodi dell’azione immediata di potere. Perciò il sistema del capitale finanziario mondiale richiama inevitabilmente la lotta armata dei concorrenti imperialisti. Qui risiede anche la radice dell’imperialismo. La lotta delle organizzazioni capitalistico-finanziarie di stato è la più spudorata espressione delle opposizioni e dell’anarchia del metodo di produzione capitalistico, nel quale il lavoro socializzato su scala mondiale urta contro i soggetti dell’appropriazione, soggetti statali-“nazionali”. La centralizzazione del capitale distrugge la concorrenza, però d’altra parte la riproduce incessantemente su una base più allargata. Essa annienta l’anarchia delle piccole unità produttive, inasprisce però i rapporti anarchici fra le grandi componenti produttive. Gli “attriti” nel sistema economico generale scompaiono in alcuni ambiti soltanto per riaffiorare in più grandi dimensioni altrove: essi si trasformano in attriti fra le parti fondamentali del grande meccanismo mondiale. E le opposizioni fra le singole parti di questa economia si pongono su due piani principali: su quello del mutuo anarchico rapporto fra imprenditori e su quello della costruzione anarchica della società come società di classi. In altri termini: esistono tanto opposizioni “puramente economiche” come anche opposizioni “sociali”. È evidente che la prima categoria agisce immediatamente sulla seconda.
[EPT. 1]
“La lotta degli stati nazionali”, che non è altro se non la lotta dei rispettivi gruppi borghesi, non è appesa per aria. Non ci si può raffigurare questo scontro gigantesco come lo scontro di due corpi nello spazio vuoto, esso stesso al contrario è condizionato dal particolare ambiente nel quale vivono e si sviluppano gli “organismi economici nazionali”; è da gran tempo ormai che questi ultimi non sono più un complesso chiuso, ma costituiscono solo parti di una sfera più grande, dell’economia mondiale. Per questo la lotta delle
148

attuali strutture economiche nazionali deve essere prima di tutto considerata come lotta delle varie parti concorrenti dell’economia mondiale; esiste una divisione del lavoro fra le economie “nazionali”, fra diversi paesi, una divisione del lavoro che supera i limiti dell’“economia nazionale”, una divisione internazionale del lavoro. Vi sono due tipi di premesse alla divisione internazionale del lavoro: in primo luogo delle premesse naturali che scaturiscono dalla eterogeneità dell’ambiente naturale nel quale vivono i diversi “organismi produttivi”; in secondo luogo delle premesse di carattere sociale che scaturiscono dalla disparità del livello culturale, della struttura economica, del grado di sviluppo delle forze produttive. Ma le differenze naturali delle condizioni produttive, per quanto importanti, passano sempre più in secondo piano in confronto alle differenze provocate dallo sviluppo ineguale delle forze produttive nei diversi paesi. Si delinea quindi chiaramente una peculiare distribuzione delle forze produttive del capitalismo mondiale. Le due maggiori sezioni del lavoro sociale sì suddividono in paesi di due tipi, e il lavoro sociale si trova suddiviso su scala internazionale.
La divisione internazionale del lavoro trova la sua espressione nello scambio internazionale. Il lavoro sociale mondiale complessivo è diviso tra i vari paesi; il lavoro di ogni singolo paese diventa parte di questo lavoro sociale complessivo per mezzo dello scambio su scala internazionale. Questa connessione dei paesi nel processo di scambio non ha affatto il carattere di una semplice casualità, ma è ormai una condizione necessaria dell’ulteriore sviluppo sociale: inoltre lo scambio internazionale si trasforma in un processo regolare della vita economico-sociale. In tal modo la divisione mondiale del lavoro e lo scambio internazionale presuppongono la esistenza del mercato mondiale e dei prezzi mondiali. Sulla base dell’esempio del mercato delle merci noi vediamo che dietro ai rapporti dì mercato si nascondono i rapporti di produzione. Se la relazione nel processo di scambio non ha un carattere casuale noi abbiamo allora un sistema stabile di rapporti di produzione che forma una struttura economica della società dell’ampiezza corrispondente. Noi possiamo quindi definire l’economia mondiale come sistema dì rapporti di produzione e dei rapporti di scambio corrispondenti su scala mondiale. In complesso tutto il processo della vita economica mondiale contemporanea si riduce alla produzione del plusvalore e alla sua distribuzione tra diversi gruppi e sottogruppi della borghesia sulla base di una riproduzione allargata continua dei rapporti tra due classi: il proletariato mondiale da un lato e la borghesia mondiale dall’altro.
Cosi se si esamina il problema in tutta la sua estensione e nel suo aspetto oggettivo, cioè dal punto di vista delle condizioni di funzionalità della società moderna, è qui evidente una crescente non conformità fra la base dell’economia sociale nella sua dimensione mondiale e una particolare struttura dì classe della società, dove la stessa classe dirigente (la borghesia) si scinde in gruppi “nazionali” con interessi economici contraddittori, gruppi che, essendo contrapposti al proletariato mondiale, contemporaneamente sono in concorrenza gli uni con gli altri nel processo di spartizione del plusvalore effettuato su scala mondiale. La produzione ha un carattere sociale. La divisione internazionale del lavoro trasforma le economie “nazionali” particolari in parti del gigantesco processo lavorativo onnicomprensivo che abbraccia quasi tutta l’umanità. L’appropriazione assume il carattere dì appropriazione “nazionale” (statale), in cui il soggetto è rappresentato dalle colossali unioni statali della borghesia finanziaria capitalistica. Questo processo in tutte le sue molteplici forme è un processo dì internazionalizzazione della vita economica, di avvicinamento di singoli punti geografici dello sviluppo economico, di livellamento dei rapporti capitalistici, di crescente contrapposizione della proprietà concentrata della classe dei capitalisti al proletariato mondiate. Da ciò tuttavia non deriva che lo sviluppo sociale sia già entrato nello stadio di una coesistenza più o meno armonica degli stati “nazionali”. Poiché il processo di internazionalizzazione della vita economica non è affatto identico al processo di internazionalizzazione degli interessi capitalistici.
La oligarchia finanziaria che dirige la produzione, unita dalle banche in un tutto unico, è giunta al potere. Questo processo di organizzazione della produzione si è sviluppato dal basso dopo essersi consolidato nel quadro degli stati moderni che sono divenuti l’espressione precisa degli interessi del capitale finanziario. O-gni economia sviluppata nel senso capitalistico della parola si è trasformata in un trust “nazionale”-statale sui generis. D’altro lato il processo di organizzazione delle parti economicamente avanzate dell’economia mondiale si accompagna ad un incredibile acutizzarsi della loro concorrenza reciproca. Questi gruppi trovano l’estremo argomento nella forza e nella potenza della organizzazione statale e, prima di tutto, dei propri eserciti e delle flotte. La potente autorità militare dello stato è l’ultima carta nella lotta fra le grandi potenze. La capacità di lotta sul mercato mondiale dipende in tal modo dalla forza e dalla compattezza della “nazione”, delle sue risorse finanziarie e militari. L’unità nazional-statale ed economica autosufficiente che allarga all’infinito la sua forza grandiosa fino all’impero mondiale: è questo l’ideale costruito dal capitale finanziario. Il processo di internazionalizzazione della vita economica può acuire e acuisce in alto grado la contraddizione fra gli interessi dei diversi gruppi “nazionali” della borghesia. In realtà lo sviluppo degli scambi commerciali internazionali non è affatto sempre legato allo sviluppo della “solidarietà” fra i gruppi che vi partecipano. Al contrario può essere accompagnato dallo sviluppo della concorrenza più sfrenata e di
149

una lotta mortale. Allo stesso modo si pone il problema per l’esportazione del capitale. Non è affatto vero che si crei sempre una “comunanza di interessi”.
Anche qui può divenire terribilmente acuta la lotta per le sfere di impiego del capitale. Solo in un caso noi possiamo dire con sicurezza che si forma una solidarietà di interessi: è quando si tratta di uno sviluppo della compartecipazione e del cofinanziamento, cioè allorquando, grazie al possesso comune di titoli si crea una proprietà collettiva della classe dei capitalisti di vari paesi su di uno stesso oggetto. Qui effettivamente si crea una vera internazionale dell’oro; qui interviene non solo la semplice affinità, o, come ora si usa dire, il “parallelismo” degli interessi, qui si forma la loro unità. Ma parallelamente a questo processo, il corso dello sviluppo economico crea automaticamente anche la tendenza opposta, alla nazionalizzazione degli interessi capitalistici, e tutta la società umana, posta sotto il tallone pesante del capitale mondiale, tra sofferenze incredibili, sangue e fango, paga un tributo a questa contraddizione. Una valutazione delle prospettive può essere data solo sulla base dell’analisi di tutte le tendenze fondamentali del capitalismo. E se l’internaziona-lizzazione degli interessi capitalistici esprime solo un aspetto dell’internazionalizzazione della vita economica, è necessario allora esaminare anche l’altro suo aspetto, quel processo di nazionalizzazione degli interessi capitalistici che esprime nel modo più evidente l’anarchia della concorrenza capitalistica nell’ambito dell’economia mondiale, porta ai più grandiosi sconvolgimenti e catastrofi, al più grandioso sperpero di energia umana e avanza con forza il problema dell’affermazione di forme nuove di vita sociale.
Il capitalismo mondiale, il sistema produttivo mondiale assume quindi, negli ultimi tempi, la seguente forma: alcuni corpi economici compatti ed organizzati (le “grandi potenze civili”) e una periferia di paesi non sviluppati, con una struttura agraria o semiagraria. Il processo di organizzazione (che, fra l’altro, non è affatto lo scopo, o il movente dei signori capitalisti, come affermano i loro ideologi, ma solo il risultato oggettivo dei loro sforzi miranti a ottenere il massimo profitto) tende ad uscire dai limiti del quadro “nazionale”, ma qui vi sono degli ostacoli molto più sostanziali. In primo luogo è molto più facile superare la concorrenza su scala “nazionale” che su scala mondiale (gli accordi internazionali di solito sorgono sulla base di monopoli “nazionali” già esistenti); in secondo luogo la differenza di strutture economiche, e di conseguenza di costi di produzione, che c’è, rende svantaggiosi gli accordi ai gruppi “nazionali” più avanzati; in terzo luogo lo stesso collegamento con lo stato e i suoi confini rappresenta un monopolio di sempre maggiore importanza che assicura profitti supplementari. Cosi non vi è alcun dubbio che è presente una tendenza generale a circondare le “economie nazionali” con un alto muro di tariffe doganali. Con ciò non è per nulla in contraddizione il fatto che in qualche caso ci può essere diminuzione delle tariffe, concessioni reciproche negli accordi commerciali ecc.; non sono altro che eccezioni, arresti temporanei, armistizi in una guerra incessante. La tendenza generale non viene per nulla modificata da ciò, poiché essa non è un semplice fatto empirico, un fenomeno casuale che è inessenziale per i rapporti attuali; al contrario proprio la struttura del capitalismo contemporaneo porta con sé questa forma di politica economica, sorge con essa e cadrà con essa.
L’importante funzione economica che hanno attualmente le dogane porta con sé anche il carattere aggressivo della politica del “capitalismo contemporaneo”. Nella nostra epoca gli interessi del capitale finanziario esigono prima di tutto un accrescimento del proprio territorio statale, cioè dettano una politica di conquiste, di pressione militare diretta, di “usurpazione imperialistica”. Null’altro, all’infuori della formazione di un enorme territorio economicamente unito come mezzo monopolistico per la concorrenza, sottintendono anche tutti i discorsi sulla creazione dell’unione doganale dell’Europa centrale. In effetti è questo il prodotto degli interessi e dell’ideologia del capitalismo finanziario il quale, penetrando in tutti i pori dell’economia mondiale, produce contemporaneamente una fortissima tendenza alla chiusura dei corpi nazionali, alla “autarchia” economica come mezzo per rafforzare la sua posizione monopolistica. L’esportazione di capitale nelle sue attuali dimensioni e con la sua importanza attuale è provocata, come abbiamo visto, dalle particolarità dello sviluppo economico degli ultimi anni. Se la si esamina dal punto di vista della diffusione delle forme organizzate del capitalismo contemporaneo, non è altro che l’impadronirsi e la monopolizzazione di nuove sfere di impiego del capitale da parte delle aziende monopolistiche di una grande potenza o – se si prende il processo nel suo complesso – da parte dell’industria “nazionale” organizzata, del capitale finanziario “nazionale”. L’esportazione di capitale costituisce il metodo più comodo di politica economica dei gruppi finanziari, subordinando nel modo più facile nuovi settori. Ecco perché l’acutizzarsi della concorrenza fra i vari stati assume qui forme particolarmente vistose. Cosi l’internazionalizzazione della vita economica anche qui porta con sé inevitabilmente che siano risolti col ferro e col fuoco i problemi sul tappeto.
[IEM. 1,2,4,8]
II.1.4. Lo scambio ineguale e la sovranazionalità
150

Produzione di massa e vendita di massa erano, su base capitalistica, desiderabili da tempo immemorabile. Solo nella fase avanzata dell’accumulazione di capitale però, quando la valorizzazione dell’enorme capitale all’interno diventa sempre più difficile, solo in questa fase l’estensione e la sicurezza di un mercato di sbocco più grande possibile diviene una questione di vita per il capitalismo; perché solo per i vantaggi della specializzazione quali sono stati descritti è possibile essere favoriti nella lotta concorrenziale sul mercato mondiale. Da tutto questo deriva che anche nell’area nazionale si fa avanti l’idea sempre più vincente della “grande azienda” nei confronti della “piccola e media azienda”. Da qui la tendenza alla formazione di imperi sovranazionali, che subentrano al posto dello stato nazionale. Le categorie con le quali oggi si ragiona, non sono più gli stati, ma i continenti. Dato che tuttavia nel commercio internazionale non vengono scambiati equivalenti, poiché anche qui come per il mercato interno esiste la tendenza alla perequazione dei tassii di profitto, cosi le merci del paese ad alto sviluppo capitalistico, dunque di un paese con una composizione organica del capitale in media più alta, sono vendute a prezzi di produzione che sono sempre più alti dei valori, mentre al contrario le merci dei paesi con una composizione organica inferiore, con la libera concorrenza, vengono vendute a prezzi di produzione che di regola devono essere più bassi del loro valore.
In questo modo sul mercato mondiale avvengono all’interno della sfera della circolazione trasferimenti del plusvalore prodotto in un paese non sviluppato verso paesi di più alto sviluppo capitalistico, dato che la ripartizione del plusvalore non avviene secondo il numero dei lavoratori impiegati, ma in rapporto alla grandezza del capitale in funzione. In tutti questi casi qui enumerati il profitto dei paesi capitalistici di più alto sviluppo rappresenta un trasferimento del profitto da paesi poco sviluppati, per cui è del tutto indifferente se questi ultimi siano paesi capitalistici oppure non capitalistici. Infatti non si tratta di una “realizzazione” del plusvalore, prodotto capitalisticamente, in aree non capitalistiche, come afferma la teoria di Rosa Luxemburg, bensì per il paese sviluppato si origina accanto al plusvalore in esso stesso prodotto, un plusvalore addizionale che è stato prodotto in un paese meno sviluppato, e con l’aiuto della concorrenza sul mercato mondiale, cioè grazie ad uno scambio ineguale, uno scambio di non equivalenti, viene trasferito ad un paese di più alto sviluppo. Questo trasferimento del plusvalore da un paese all’altro è il risultato dei differenti gradi di sviluppo economico.
Lo stesso trasferimento di valore avviene nel commercio estero anche con un paese capitalistico, se esso è tecnicamente ed economicamente poco sviluppato. Il sovraprofitto che affluisce dalla vendita delle merci oltre il loro valore, è un guadagno che viene acquisito alla periferia dì un’economia capitalistica grazie al commercio estero; abbiamo visto che esso si presenta già agli inizi del modo di produzione capitalistico e lo accompagna sempre nel suo ulteriore sviluppo. Però solo nelle fasi molto avanzate della accumulazione di capitale, essendo sempre più difficile valorizzare l’enorme massa del capitale accumulato (il che altro non significa che la tendenza al crollo diviene effettiva) la questione dell’iniezione di profitto addizionale dall’estero, grazie al commercio estero, diviene una questione di vita per il capitalismo. Si tratta di attenuare la tendenza al crollo, di neutralizzarla. Da qui la violenza dell’espansione imperialistica proprio in questa fase tarda dell’accumulazione di capitale. In effetti, dato il trasferimento di profitto “dall’esterno”, è del tutto indifferente, se il paese sfruttato sia una terra capitalistica oppure non capitalistica (agraria), e poiché il paese sfruttato dal canto suo può sfruttare grazie al commercio estero altri paesi ancora meno sviluppati, l’accumu-lazione di capitale ha così per conseguenza nella sua fase tarda una concorrenza inasprita di tutti i paesi capitalistici sul mercato mondiale. Il paese che si trova tecnicamente ed economicamente ad un livello superiore si appropria del plusvalore addizionale a spese del paese più arretrato. Accanto all’inasprimento della pressione salariale e alla lotta di classe contro la classe operaia, l’accumulazione di capitale produce una micidiale lotta concorrenziale degli stati capitalistici fra di loro, una incessante rivoluzione della tecnica, una “razionalizzazione”, cioè una taylorizzazione o fordizzazione dell’economia delle potenze capitalistiche guida, per affermare sempre di nuovo la superiorità sul mercato mondiale mediante il vantaggio tecnico e organizzativo; d’altra parte ciò produce una inasprita politica doganale dei paesi economicamente arretrati che nella chiusura verso l’esterno credono di avere un mezzo di difesa contro la supremazia dei leviathani capitalistici.
Abbiamo tuttavia mostrato che le opposizioni imperialistiche non si esprimono soltanto nel rapporto dei paesi capitalistici rispetto a quelli agrari ma che queste opposizioni esistono anche fra gli altri stati capitalistici quando si trovano soltanto a differenti gradi dello sviluppo tecnico e dunque il paese altamente sviluppato può sfruttare quello economicamente meno sviluppato. L’imperialismo ben lontano dall’essere soltanto un “episodio” che appartiene al passato e perde sempre più di significato, è piuttosto radicato nell’essenza del capitalismo e massimamente negli alti gradi dell’accumulazione di capitale. Le tendenze imperialistiche acquisteranno dunque con il progredire dell’accumulazione sempre più forza e saranno superate soltanto insieme col superamento del capitalismo stesso. Proprio il fatto che i paesi che sviluppano sempre più la loro industria sono in misura crescente i più grandi acquirenti delle merci industriali, il fatto che i paesi industriali sono reciprocamente aree di sbocco, il fatto che per cosi dire i singoli paesi rappresentano all’interno dell’economia mondiale la stessa posizione che le singole sezioni rappresentano
151

all’interno dello schema marxiano di riproduzione, ci permette di spiegare un fenomeno. Ci riferiamo all’internazionalità dei cicli economici. Di pari passo con l’espansione della produzione aumenta anche l’importazione di materie prime, di semilavorati e l’importazione di quei prodotti industriali finiti che non sono prodotti all’interno. La maggiore importazione di materie prime e semilavorati supera nel periodo di espansione la maggiore esportazione di prodotti finiti, mentre al contrario nella fase di depressione la maggiore importazione di materie prime e di semilavorati cala e l’eccedenza di esportazione dei prodotti finiti cresce. Esiste in questo modo una significativa correlazione fra espansione e importazione di materie prime. Grazie alla mediazione dell’importazione di merci l’espansione di un paese si comunica agli altri. Cosi il ritmo dei movimenti di espansione si unifica sempre di più, anche se continuano a sussistere sempre più o meno lunghe differenze fra le oscillazioni congiunturali dei singoli paesi.
Il trasferimento di plusvalore sopra descritto, che avviene grazie al commercio da parte dei paesi economicamente poco sviluppati verso quelli di alto livello di sviluppo capitalistico si realizza dapprima in regime di libera concorrenza, senza quella influenza artificiale nella formazione del prezzo, in virtù di una posizione di fatto di monopolio che una tecnica più sviluppata concede ai paesi ad alto sviluppo capitalistico. Occorreva adesso con un’aspra lotta concorrenziale sul mercato mondiale: eliminare la partecipazione degli avversari e assicurarsi in modo esclusivo i trasferimenti di valore. Il mezzo idoneo per questo era il monopolio mondiale e la spinta alla sua formazione risiedeva nel fatto che sarebbe stato costruito altrimenti un monopolio mondiale dei concorrenti a sfavore del proprio paese. Però il commercio estero e il monopolio delle più importanti materie prime sono un’arma appropriata nella lotta per la valorizzazione, per il plusvalore; il monopolio delle materie prime dà la possibilità ai monopolisti di trasferire dall’ambito mondiale nelle proprie mani grandi porzioni del plusvalore, attraverso il pagamento di tributi da parte degli altri per attenuare la tendenza al crollo della propria economia, e prolungare in questo modo la vita del proprio sistema capitalistico. In questo fatto trova il suo fondamento la violenza smisurata con cui gli stati con grande accumulazione di capitale pongono la loro avida mano sulle materie prime del mondo a ogni grado di latitudine e longitudine, con cui il capitale mai sazio tasta il terreno a livello mondiale.
Nonostante ciò da parte borghese emergono sempre nuove idee su un controllo internazionale comune alle materie prime. Anche i tentativi per la creazione di monopoli mondiali comuni vengono sempre di nuovo intrapresi per poi crollare tuttavia di fronte alle insormontabili contrapposizioni interne di interessi dei partecipanti. Dato che anche la funzione del monopolio mondiale – come è stato chiarito – consiste nell’arricchire la propria economia nazionale, per ricavare per la propria economia un plusvalore addizionale a spese dei rimanenti stati, l’opposizione di interesse degli stati è qui una connotazione essenziale. I progetti sempre riemergenti di un comune e durevole controllo internazionale delle materie prime e della loro distribuzione sono e devono rimanere perciò pii desideri. Ancora di più però! Ricordiamo quanto si è stabilito in precedenza: come all’interno del capitalismo, pensato come sistema isolato, gli imprenditori che si sono attrezzati con una tecnica sviluppata oltre la media sociale e vendono le merci ai prezzi medi sociali, conseguono un extraprofitto a spese di quegli imprenditori la cui tecnica è rimasta al di sotto della media sociale, allo stesso modo sul mercato mondiale i paesi ad elevato sviluppo tecnico conseguiranno extraprofitti a spese di quei paesi, la cui composizione organica è inferiore, il cui sviluppo tecnico ed economico è arretrato. In questo fatto risiede anche lo stimolo e nello stesso tempo la costrizione all’incessante sviluppo della tecnica, all’attuazione di una sempre più alta composizione organica del capitale nei paesi ad alto sviluppo capitalistico. Ciò significa però che per questo motivo in questi paesi, parallelamente allo sviluppo della tecnica, all’introduzione di una sempre più elevata composizione organica del capitale sorge nello stesso tempo un campo per investimenti di capitale più vantaggiosi.
La regolazione delle migrazioni di capitali mediante il livello del tasso di profitto ha proprio per presupposto le differenze nei livelli di quest’ultimo. Marx ha mostrato le circostanze che nel progresso dell’accumulazione di capitale condizionano la caduta tendenziale del tasso di profitto e la provocano. Invece dunque di accumulare il plusvalore, cioè di accrescere il capitale, questo viene reso disponibile per l’esportazione. Certamente è soltanto un limite capitalistico, il limite della valorizzazione, e non un limite in generale. Rimangono ancora numerosi bisogni insoddisfatti nella società, e “la speculazione creditizia che ne segue prova che non esiste nessun ostacolo positivo all’impiego di questo capitale eccedente”. Ma questo è eccedente dal punto di vista capitalistico, in quanto non si valorizza. Da questo momento in poi si attua gradualmente una trasformazione strutturale del capitalismo. Quanto più la classe imprenditoriale non ha altra risorsa che l’esportazione di capitale, tanto più la borghesia “si allontana dalla attività produttiva, diventa sempre più, come ai suoi tempi la nobiltà, una classe che semplicemente intasca rendite”.
Il pensiero di fondo di questa concezione è la contraddizione immanente fra la capacità illimitata di espansione della forza produttiva e la limitata possibilità di valorizzazione del capitale sovraccumulato. Questo risulta necessariamente dallo schema marxiano di riproduzione e di accumulazione. Il limite della sovraccumulazione, della valorizzazione insufficiente, viene rotto dal credito cioè dall’esportazione di capitale e dal plusvalore addizionale che viene conseguito in questo modo. In questo senso l’esportazione di
152

capitale è necessaria e caratteristica della fase avanzata dell’accumulazione di capitale. “Per il vecchio capitalismo, sotto il pieno dominio della libera concorrenza, era caratteristica l’esportazione di merci. Per il più recente capitalismo sotto il dominio dei monopoli, è diventata caratteristica l’esportazione di capitale”. La differenza caratteristica, sottolineata da Lenin, fra il capitalismo vecchio e quello recente esiste realmente, essa però non si trova in un nesso causale necessario con la concorrenza capitalistica o con il capitalismo di monopolio, si spiega piuttosto con la differenza fra la fase iniziale e la fase tarda dell’accumulazione di capitale in un dato paese capitalistico, con un dato grado di sviluppo della tecnica. Abbiamo in precedenza accennato al fatto di come nell’economia il capitale eccedente – si parla di “disoccupazione dei capitali finanziari” – cerca sfere d’investimento. Dato che all’interno della sfera di produzione non è possibile alcun impiego, si ha l’esportazione verso l’estero o – dal punto di vista della produzione – l’esportazione di capitale all’interno, cioè l’affluire delle somme non impiegate nella attività di speculazione. L’esportazione di capitale verso l’estero e la speculazione all’interno sono fenomeni paralleli e scaturiscono da una radice comune. Nei confronti di tutti coloro che pensano che la speculazione sia soltanto un’“escrescenza” che non ha nulla a che fare con una “sana espansione”, noi sosteniamo l’opinione che la speculazione adempia una funzione necessaria. Essa rende possibile ai capitali sovraccumulati un investimento “redditizio”: che questi profitti non derivano dagli utili, ma siano trasferimenti di capitale, lo abbiamo già visto prima.
L’economia politica borghese non vuol vedere queste connessioni. Essa nota soltanto i fenomeni come essi si mostrano alla superficie e si perde perciò nella accidentalità. Perché si esporta capitale? Perché vengono ricercati in crescente misura i titoli esteri?
I. capitali inattivi nella depressione devono trovare un investimento redditizio proprio in un periodo di ristagno. Da qui si deduce l’importanza della speculazione per il capitalismo. La speculazione è un mezzo, per supplire all’insufficiente valorizzazione della attività produttiva con profitti che affluiscono dalle perdite sul corso delle azioni di estese masse di piccoli capitalisti, la cosiddetta “mano debole”, ed è quindi un potente mezzo per la concentrazione del capitale-monetario.
II. capitale privo d’investimento si procura così una serie di canali di deflusso, sia all’interno con la speculazione in borsa, sia all’estero con l’esportazione di capitale; canali appropriati ad assicurare la valorizzazione. Che questi sforzi per l’investimento del capitale sovraccumulato nella fase di depressione siano particolarmente forti, è noto ed incontestato. Che essi non si limitino esclusivamente al periodo di depressione, non dice nulla contro la concezione qui sostenuta. Dipende dunque dalla particolare situazione dei singoli settori di produzione e dalla previsione dei singoli, se e in che misura essi trovino tempestivamente un’occupazione redditizia per i loro capitali, cosi come anche nell’industria avviene un’estensione e un miglioramento della capacità produttiva proprio nel modo più incisivo nel periodo della depressione, quando la domanda delle merci è più scarsa.
Un altro canale di deflusso per il capitale sovraccumulato è costituito dall’esportazione di capitale. L’e-sportazione di capitale non è più un fenomeno occasionale, ma per tutti i paesi di avanzato sviluppo capitalistico è divenuto un fenomeno tipico e necessario. Questo tanto più per il fatto che nel capitalismo di monopolio la via dell’accumulazione di capitale a spese dei concorrenti non è più agibile per principio: non si dànno concorrenti all’interno del settore di produzione dominato monopolisticamente; il capitale viene a urtare rapidamente nei limiti di valorizzazione mostrati precedentemente e può avere respiro soltanto o con la vendita dei suoi prodotti ad acquirenti interni ed esteri a prezzi molto maggiorati o grazie all’esportazione di capitale e dunque all’iniezione di plusvalore addizionale dall’esterno.
Atteniamoci ai fatti e ai fenomeni dell’ordinamento sociale esistente. La regolamentazione, la pianificazione dell’economia è attuabile su base capitalistica? Essa è del tutto impossibile. Quanto più sul mercato interno la libera concorrenza viene sostituita dalle organizzazioni monopolistiche, tanto più si acuisce la concorrenza sul mercato mondiale. La stessa cosa vale per il cartello generale di Hilferdìtig. Esso è infatti concepibile soltanto come una serie di cartelli di singoli rami di produzione, che scambiano i loro prodotti reciprocamente. In questa forma di produzione esistono almeno due associazioni centrali come proprietari privati indipendenti che producono differenti valori d’uso (mezzi di produzione e mezzi di consumo) e li scambiano fra dì loro. Soltanto in quanto esse sussistono, può manifestarsi uno scambio e in questo modo anche un valore dì scambio. Il cartello generale di Hilferding come unico soggetto è invece inconcepibile, nella misura in cui lo si deve ancora pensare sulla immagine della produzione capitalistica, produttrice di merci. Laddove non esistono proprietari privati indipendenti l’uno dall’altro, non può aver luogo lo scambio, non si può originare dunque alcun valore di scambio. Il valore di scambio consiste proprio in una funzione della relazione di scambio; con questa scompare anche quello. Hilferding non poteva riuscire a far luce sulle condizioni essenziali di esistenza del suo cartello generale; doveva così giungere alla concezione di una società capitalistica che avrebbe la possibilità di essere “regolata”. Poiché soltanto uno dei due casi è possibile: o si tratta di un’economia “regolata” e allora cessa di essere un’economia capitalistica; se però è capitalistica, essa non può essere “regolata”! Si tratta infatti di una contraddizione logica insolubile, una contraddizione in adjecto quando Hilferding fa scomparire lo scambio del tutto e nonostante ciò parla
153

ancora di modo di produzione capitalistico. Hilferding parla della scomparsa dello scambio di merci e del valore – e questo lo deve fare per arrivare alla sua economia “regolata” – allora anche la merce forza-lavoro non dovrebbe essere scambiata o in altre parole anche il rapporto di capitale, il modo di produzione capitalistico, devono necessariamente venire meno.
Ciò che subentra al suo posto, può essere o un chiaro rapporto di dominio, come nel medioevo, o una economia comunitaria socialista. In ogni caso cessa di essere un modo di produzione capitalistico che si fonda sul libero lavoro salariato, che lavora per il mercato, dunque cessa di essere una produzione di merci. Se si afferma che il processo di scambio è eliminato, allora anche la merce forza-lavoro non può più essere comprata e venduta come merce sul mercato del lavoro, e si presuppone dunque che anche il rapporto salariale e quello di capitale sia eliminato. In questo caso non sussiste più alcuna economia capitalistica, tanto nella produzione quanto nella distribuzione. Infatti come potrebbe altrimenti essere messa a disposizione di coloro che controllano il cartello generale l’intera eccedenza sociale oltre il lavoro necessario, se non sulla base della legge del valore, sulla base dell’acquisto della forza-lavoro come merce? Se Hilferding volesse negare questo fatto, come unica via d’uscita gli resterebbe soltanto la supposizione che nel suo cartello generale, che si svolge con una produzione “regolata” e con “attribuzione” di cose alle persone da parte delle persone, questa attribuzione avvenga semplicemente grazie alla violenza fisica che alla classe operaia lascia soltanto i mezzi necessari di sussistenza, mentre fa arrivare l’intera eccedenza ai direttori del cartello generale. Questa sarebbe una bella “regolamentazione della produzione”!
[LACC. 3.2, CONCL.]
II.2. Imperialismo e contraddizioni del capitale
II.2.1. Il capitale finanziario
Per centralizzare il capitale è sufficiente la creazione di una coalizione di capitale. Con la mobilizzazione viene ampliata, contemporaneamente, la sfera del capitale coalizzabile, perché essa rende la continua ritrasformazione in denaro del capitale industriale (capitale fìsso incluso) quanto più possibile indipendente dall’effettivo riflusso che si verifica al termine di un ciclo di produzione durante il quale il capitale fisso ha dovuto funzionare. La mobilizzazione del capitale non attenua le difficoltà che si frappongono al livellamento del tasso di profitto. La coalizione del capitale – fenomeno che si sviluppa contemporaneamente a quello della mobilizzazione – elimina invece le limitazioni inerenti alla grandezza del nuovo capitale destinato ad investimenti. Grazie alla unificazione dei capitali monetari e alla crescente ricchezza della società capitalistica, la grandezza dell’impresa non rappresenta più un ostacolo al suo ulteriore sviluppo. Cosi, il livellamento del tasso di profitto diviene possibile solo mediante il trasferimento di nuovo capitale nei settori in cui il tasso di profitto è superiore alla media, mentre risulta assai difficile il deflusso del capitale dai rami produttivi in cui abbonda il capitale fisso. In questi settori la riduzione del capitale si compie soltanto attraverso la graduale scomparsa dei vecchi impianti, oppure in seguito alla distruzione del capitale in caso di bancarotta.
Le grandi imprese non solo dettano legge a tutte le altre, ma, in quanto caratterizzate da una notevole forza di capitale, esse tendono altresì a divenir sempre più simili tra loro, laddove le differenze tecniche ed economiche che potrebbero avvantaggiare alcune di esse nella lotta concorrenziale si attenuano via via. Non si tratta di una lotta tra industrie più forti e industrie più deboli, nella quale queste ultime verrebbero annientate con la conseguente eliminazione del capitale eccedente di quel settore, ma di una lotta tra eguali che può rimanere incerta per lungo tempo. Abbiamo visto che la concentrazione nell’industria provoca contemporaneamente la concentrazione delle banche, concentrazione quest’ultima che viene potenziata dalle condizioni stesse in cui si sviluppano gli affari bancari. Vedremo ora come il capitale bancario possa ampliare il credito industriale in virtù dell’azionariato e come, stimolato dalla prospettiva di realizzare utili di fondazione, dimostri un interesse sempre maggiore per il finanziamento. L’utile di fondazione dipende, però, a parità di condizioni, dal livello del profitto: a quest’ultimo il capitale bancario è perciò direttamente interessato. Con la concentrazione delle banche cresce contemporaneamente la cerchia delle imprese industriali, con le quali la banca ha diretti legami nella sua qualità di erogatrice di credito e d’istituto finanziario. Da ciò l’impegno delle banche nel favorire la formazione di monopoli; e quindi il coincidere delle tendenze del capitale bancario e del capitale industriale verso l’eliminazione della concorrenza. Sorge così una strana contraddizione: la limitazione della concorrenza è facilissima da realizzare proprio nei momenti in cui è meno necessaria (giacché un ipotetico accordo non farebbe che sanzionare lo stato di fatto esistente), e cioè durante i periodi di prosperità, mentre durante i periodi di depressione, nei quali la
154

limitazione della concorrenza sarebbe quanto mai necessaria, è quanto mai difficile concludere un qualsiasi accordo. Questa circostanza sta a spiegare come mai i cartelli si formino molto più facilmente in tempi di prosperità o, almeno, una volta superati i periodi di depressione, e come mai, durante i periodi di depressione, si disgreghino poi così spesso, massime se non sono saldamente organizzati.
L’enorme accelerazione che le “combinazioni” hanno impresso ai più recenti sviluppi del capitalismo è da attribuirsi al fortissimo impulso esercitato da un insieme di fattori economici, massime dalla cartellizza-zione. Sotto il termine “combinazione” indichiamo dunque l’associazione di imprese capitalistiche delle quali le une forniscono alle altre la materia prima, distinguendo altresì queste coalizioni, provocate dalla differenza del tasso di profitto nei diversi settori industriali, dalle unificazioni di imprese appartenenti allo stesso ramo industriale. Il fine che queste ultime perseguono, mediante l’eliminazione della concorrenza, è quello di elevare in quel ramo, al di sopra del suo livello depresso, il tasso di profitto. Si dà peraltro il caso che le imprese unificate si servano della loro posizione di forza per sconfiggere i contendenti con la più spietata concorrenza: in tal caso l’aumento del tasso di profitto interverrà soltanto allorché la meta sia stata raggiunta. La combinazione delle imprese può aver luogo in due modi. Esse possono conservare formalmente la loro autonomia definendo, contrattualmente, la loro alleanza; in questo caso si avrà una coalizione di interessi. Se, invece, le imprese si uniscono per dar vita ad una nuova impresa, parleremo allora di una fusione.
Una coalizione d’interessi del più gran numero possibile di imprese, fatta allo scopo di elevare i prezzi e con ciò il profitto mediante la più radicale eliminazione della concorrenza, è il cartello. Il cartello è dunque una coalizione di interessi monopolìstica. Una fusione che persegua lo stesso scopo impiegando lo stesso mezzo è il trust. Il trust è quindi una fusione monopolistica. Le coalizioni di interessi e le fusioni possono essere omogenee, se costituite da imprese appartenenti allo stesso ramo dì produzione, oppure combinate, se costituite da imprese appartenenti a rami produttivi tra loro complementari. Avremo perciò coalizioni di interessi o fusioni parziali, sia “omogenee” che “combinate,” cosi come cartelli o trusts “omogenei” e “combinati.” Non si deve peraltro dimenticare che oggi le coalizioni di interessi non si basano su formali contratti, ma su unioni personali, che in genere esprimono i rapporti di dipendenza del capitale. Lo stesso monopolio economico è quindi tanto più saldo quanto più grande è il capitale che può impiegare nella creazione di nuove imprese, e quanto più stretti sono i suoi legami con le banche; senza l’aiuto delle banche, o addirittura contro il loro volere, una grande impresa industriale ha oggi infatti scarse probabilità di sopravvivere. La presenza di unioni capitalistiche nell’industria si ripercuote sulla circolazione delle merci e quindi sul commercio.
Il profitto commerciale è peraltro una parte del plusvalore complessivo generato dalla produzione. Quanto maggiore è la parte che spetta al capitale commerciale, tanto minore sarà, a parità di condizioni, la parte lucrata dai capitalisti industriali. Esiste quindi un’opposizione di interessi fra capitale industriale e capitale commerciale. Da questi interessi contrapposti ha origine una lotta, che si conclude con l’assoggettamento di una delle parti all’altra, e quindi con l’instaurazione di rapporti di subordinazione capitalistici. Ciò che decide di queste lotte d’interessi è semplicemente la maggiore o minore potenza del capitale. Le unioni monopolistiche rivelano, invece, la tendenza a privare completamente il commercio della sua autonomia. L’unione monopolistica tenderà quindi a sopprimere l’autonomia del commercio: infatti, solo a questa condizione, il cartello può esercitare la sua completa egemonia sui prezzi. Abbiamo visto, però, che la cartellizzazione è già di per sé indice degli stretti legami che uniscono l’industria al capitale bancario. Di regola il cartello dispone di una potenza maggiore, e può quindi dettar legge al commercio. Lo sviluppo dell’industria capitalistica favorisce la concentrazione degli istituti bancari. Il sistema bancario concentrato costituisce a sua volta la spinta più importante per il raggiungimento del massimo grado della concentrazione capitalistica, rappresentato dai cartelli e dai trusts. Quali le ripercussioni di questi ultimi sul sistema bancario? La stessa formazione di un cartello presuppone l’esistenza di una grande banca la quale sia in grado di far fronte, in ogni momento, agli ingenti crediti e sostenere la produzione di un intero settore industriale. Il cartello provoca quindi un’ulteriore intensificazione dei rapporti tra banche e industria. In seguito all’eliminazione della libera concorrenza nell’industria, il tasso del profitto aumenta.
Una parte sempre crescente del capitale della industria non appartiene agli industriali, che lo utilizzano. Essi riescono a disporne solo attraverso le banche, le quali, nei loro riguardi, rappresentano i proprietari del denaro. Gli istituti bancari devono d’altronde fissare nell’industria una parte sempre crescente dei loro capitali, trasformandosi quindi vieppiù in capitalisti industriali. Chiamo capitale finanziario quel capitale bancario, e cioè quel capitale sotto forma di denaro che viene, in tal modo, effettivamente trasformato in capitale industriale. Nei confronti dei proprietari, esso conserva sempre la forma-denaro, viene impegnato sotto forma di capitale monetario – capitale produttivo d’interessi – e può sempre essere riscosso sotto forma di denaro. In realtà però il capitale che viene consegnato alle banche vien trasformato per massima parte, in capitale industriale, capitale produttivo (mezzi di produzione e forza-lavoro), e fissato nel processo di
155

produzione. Una parte sempre crescente del capitale investito nell’industria è capitale finanziario, vale a dire: capitale messo a disposizione delle banche perché possa essere utilizzato dall’industria.
Lo sviluppo del capitale finanziario segue di pari passo quello della società per azioni, e raggiunge il suo massimo livello con la monopolizzazione dell’industria. A misura che il capitale stesso, al suo livello più alto, diviene capitale finanziario, il magnate del capitale, il capitalista finanziario, grazie al dominio sul capitale bancario, estende il suo potere su tutto il capitale nazionale. Mentre da un lato il diffondersi del sistema protezionistico tende sempre più a suddividere il mercato mondiale in singole aree economiche separate dai confini statali, dall’altro l’evoluzione verso il capitalismo finanziario continua ad accrescere l’importanza della vastità dello spazio economico ai fini dello sviluppo della produzione capitalistica. Quanto più esteso e popolato è lo spazio economico, tanto maggiore sarà l’unità d’esercizio e quindi proporzionalmente inferiori i costi di produzione: più alto potrà essere anche il grado di specializzazione nell’àmbito dello stesso esercizio, che è un altro mezzo per ridurre, i costi di produzione. Se l’area economica è più vasta, più facile può essere il trasferimento delle industrie nei luoghi in cui le condizioni naturali siano più favorevoli e maggiore la produttività del lavoro. Non vi è dubbio, quindi, che in una produzione capitalistica di tipo progredito, il libero scambio, unificando l’intero mercato mondiale, avrebbe garantito la più grande produttività e la più razionale divisione del lavoro.
Mentre da un lato la moderna politica protezionistica contribuisce a rafforzare la perenne aspirazione del capitale all’espansione della propria area economica, dall’altro la concentrazione nelle banche di tutto il capitale monetario giacente promuove l’esportazione pianificata di capitale: i legami che le banche hanno con l’industria le spingono a concedere capitale monetario solo a patto che questo venga impiegato nelle industrie in cui hanno interessi. Questa circostanza accelera straordinariamente il processo dell’esportazione di capitale in tutte le sue forme. Con l’espressione “esportazione di capitale” intendiamo indicare la esportazione di valore destinato a generare plusvalore all’estero. È essenziale, a questo proposito, che il plusvalore rimanga a disposizione del capitale interno. Se si mette a produrre senza più ritornare in patria, ciò significa perdita di capitale e snazionalizzazione del capitale; in tal caso non si tratta più di esportazione, ma di trasferimento di capitale, con conseguente diminuzione di capitale interno e aumento di quello esterno. Soltanto se il capitale impiegato all’estero rimane a disposizione del paese d’origine e se i capitalisti di questo paese possono contare sul plusvalore da esso prodotto si può parlare di esportazione di capitale. L’esportazione di capitale, relativamente al paese esportatore, può verificarsi in due forme: il capitale può essere esportato all’estero come capitale che dà un interesse o come capitale produttore di profitto. In quest’ultimo caso esso può funzionare anche nel nuovo paese come capitale industriale, commerciale o bancario, Relativamente al paese in cui viene esportato capitale, ha importanza anche la parte del plusvalore da cui viene tratto l’interesse pagato all’estero. È l’intimo legame tra capitale industriale e capitale bancario che favorisce il rapido sviluppo dell’esportazione di capitale. Presupposto di quest’ultima è la differenza del tasso di profitto: l’esportazione di capitale è il mezzo che serve a livellare i tassi nazionali dì profitto. L’altezza del profitto dipende dalla composizione organica del capitale, e quindi dal grado di sviluppo capitalistico.
Ogni qualvolta si ha esportazione di capitale, è segno che la capacità di assorbimento del mercato estero è aumentata. L’esportazione di capitale dilata così l’ambito della capacità di consumo dei nuovi mercati. Il trapianto dei nuovi metodi di produzione e l’adozione del nuovo sistema di trasporti su base capitalistica favoriscono, contemporaneamente, il rapido sviluppo economico del paese in cui viene esportato il capitale, nonché il sorgere di un grande mercato interno – grazie alla dissoluzione del vecchio sistema economico-natu-rale – l’espansione della produzione per il mercato, e quindi l’aumento dei prodotti che possono venir esportati e che perciò servono al pagamento degli interessi del nuovo capitale importato. Non appena però i nuovi mercati, da semplici zone di smercio, divengono zone d’investimento di capitale, ciò implica anche un mutamento nel comportamento politico del paese che vi esporta il proprio capitale. L’esportazione di capitale ha accelerato (specie da quando ha incominciato ad assumere la forma di esportazione di capitale industriale e finanziario) il processo di trasformazione di tutte le antiche strutture sociali e di diffusione del capitalismo su tutta la superficie del globo. Lo sviluppo capitalistico non avrebbe certo potuto prodursi in ogni singolo paese per germinazione spontanea. Assieme al capitale vennero però importati anche il modo di produzione capitalistico con le condizioni dì sfruttamento, e addirittura al grado di sviluppo raggiunto nei paesi più progrediti. Oggi per impiantare una nuova industria, non occorre farla passare, filogeneticamente, per tutte le fasi dello sviluppo storico industriale, a partire dall’artigianato fino ad arrivare, attraverso tecniche sempre più aggiornate, ai moderni giganteschi esercizi; la si fonda senz’altro come impresa ad alto livello capitalistico. Allo stesso modo il capitalismo che viene importato in un paese vergine vi arriva nello stadio che ha ormai raggiunto nei paesi più sviluppati e può quindi dispiegarvi la sua azione rivoluzionatrice con maggior intensità e in minor tempo di quanto non abbia fatto in Inghilterra e in Olanda.
Le differenze di potenziate economico provocano nei rapporti tra gli stati le stesse conseguenze che producono, all’interno degli stati stessi, le differenze tra le varie formazioni economiche, e cioè la
156

subordinazione dei più deboli ai più forti. Lo strumento economico, di cui ci si serve per raggiungere questo risultato, è, anche qui, l’esportazione di capitale. Il paese più ricco di capitale esporta il capitale come capitale creditizio: esso diventa creditore del paese a cui appartiene chi ha contratto il debito. Tale emancipazione nazionale divenne però completamente impossibile non appena il carattere dell’esportazione di capitale cambiò. In questo modo il loro sviluppo capitalistico, e quindi anche quello politico e finanziario, rimasero bloccati fin dagli inizi. Questi paesi, economicamente tributari del capitale straniero divennero anche politicamente stati di second’ordine, costretti ad appoggiarsi sui più grandi. Si crea cosi una tendenziale solidarietà internazionale di interessi capitalistici, che accrescono enormemente la potenza del capitale; gli consentono al tempo stesso di dischiudere con rapidità ancora maggiore territori stranieri: ciò viene anche facilitato dalla pressione congiunta e quindi più intensa dai grandi stati. Se prevalga questa o quella delle tendenze in gioco è questione che dipende, volta a volta, dalle diverse situazioni concrete e, soprattutto, dalle prospettive di guadagno che l’esito della lotta può aprire. Sono qui in gioco, a livello internazionale e interstatale, fattori analoghi a quelli che all’interno di un settore industriale decidono se la lotta concorrenziale debba continuare o invece cessare in più o meno breve tempo, in seguito al costituirsi di un cartello o di un trust. Quanto maggiore è il dislivello di potenza, tanto più probabile è, in genere, la lotta. Ogni lotta vittoriosa provocherebbe però, simultaneamente, un rafforzamento del vincitore, il che implicherebbe uno spostamento dei rapporti di forza a suo favore e a sfavore di tutti gli altri.
Le esigenze del capitale finanziario favorirono in tal modo la nascita e la diffusione di elementi ideologici che il capitale finanziario poté poi facilmente utilizzare per elaborare una nuova ideologia adeguata ai propri interessi. Quest’ultima è però in netto contrasto con quella del liberalismo. Il capitale finanziario non chiede libertà, ma dominio: non tiene in alcun conto l’autonomia del singolo capitalista, anzi ne pretende l’assog-gettamento; aborrisce l’anarchia della concorrenza e promuove l’organizzazione solo per poter condurre la concorrenza in àmbiti sempre più vasti. Per riuscire in ciò, per poter conservare ed aumentare il proprio prepotere, esso ha però bisogno dello stato il quale, con la sua politica doganale, deve garantirgli il mercato interno e facilitargli la conquista di quelli esterni. Il capitale finanziario ha bisogno di uno stato politicamente forte che, nei suoi atti di politica commerciale, non sia costretto ad usare alcun riguardo agli opposti interessi di altri stati. È quindi necessario uno stato forte, capace di far valere i suoi interessi finanziari all’estero e di servirsi della propria potenza per estorcere agli stati meno potenti vantaggiosi trattati di fornitura e favorevoli transazioni commerciali; uno stato che possa spingersi in ogni parte del globo per fare del mondo intero zona di investimento del proprio capitale finanziario; uno stato, infine, sufficientemente forte per condurre una politica espansionistica.
La massima aspirazione è ora quello di assicurare alla propria nazione il dominio sul mondo, un’aspira -zione non meno illimitata di quella del capitale al profitto, da cui anzi scaturisce. Il capitale parte alla conquista del mondo e ad ogni nuova conquista esso non fa che toccare nuovi confini che sarà spinto a valicare. Questa espansione incessante è ora una inderogabile necessità economica, perché rimanere indietro significa caduta del profitto del capitale finanziario, diminuzione della sua capacità concorrenziale e, come ultimo effetto, subordinazione del territorio economico rimasto più piccolo a quello più esteso. Questa aspirazione espansionistica, causata da esigenze economiche, viene giustificata ideologicamente mediante uno strabiliante capovolgimento dell’idealità nazionale, la quale ora non riconosce più ad ogni nazione il diritto all’autodeterminazione e all’indipendenza politica e non esprime più il dogma democratico dell’uguaglianza sul piano internazionale di tutto ciò che è umano. Al contrario, le aspirazioni economiche del monopolio si rispecchiano nella posizione di privilegio che esso pretende per la propria nazione. L’imperialismo dissolve tutte queste illusioni solo per sostituire all’ormai sbiadito ideale della borghesia una nuova, grande illusione. L’abbandono dell’interesse particolaristico per un più alto interesse comune che ogni ideologia sociale deve includere per essere vitale è con ciò consumato; lo stato, un tempo estraneo al popolo, e la nazione stessa, formano ora una salda unità di cui l’idea nazionale posta al servizio della politica è la forza propulsiva. I contrasti tra le classi sono svaniti e superati a favore di un ideale della collettività. Al posto della lotta delle classi, pericolosa e senza via d’uscita per i padroni, subentra l’azione comune della nazione tutta, tesa alla conquista della grandezza nazionale. Tale ideale, che sembra costituire un nuovo legame capace di tener insieme la dilacerata società borghese, è destinato a riscuotere consensi entusiastici, perché nel frattempo il processo di disgregazione della società borghese è andato ulteriormente aggravandosi.
[CF. 11,13-15,22]
II.2.2. La fase superiore del capitalismo
“II capitale finanziario non vuole libertà, ma egemonia”, dice a ragione Hilferding.
157

L’imperialismo sorse dall’evoluzione o in diretta continuazione delle qualità fondamentali del capitalismo in generale. Ma il capitalismo divenne imperialismo capitalistico soltanto a un determinato e assai alto grado del suo sviluppo, allorché alcune qualità fondamentali del capitalismo cominciarono a mutarsi nel loro opposto, quando pienamente si affermarono e si rivelarono i sintomi del trapasso a un più elevato ordinamento economico e sociale. In questo processo vi è di fondamentale, nei rapporti economici, la sostituzione dei monopoli capitalistici alla libera concorrenza. La libera concorrenza è l’elemento essenziale del capitalismo e della produzione mercantile in generale; il monopolio è il diretto contrapposto della libera concorrenza. Ma fu proprio quest’ultima che cominciò, sotto i nostri occhi, a trasformarsi in monopolio, creando la grande produzione, eliminando la piccola industria, sostituendo alle grandi fabbriche altre ancor più grandi e spingendo tanto oltre la concentrazione della produzione o del capitale, che da essa sorgeva e sorge il monopolio, cioè i cartelli, i sindacati, i trust, fusi con il capitale di un piccolo gruppo di una decina di banche che manovrano miliardi. Nello stesso tempo i monopoli, sorgendo dalla libera concorrenza, non la eliminano, ma coesistono, originando così una serie di aspre e improvvise contraddizioni, di attriti e conflitti. Il sistema dei monopoli è il passaggio del capitalismo a un ordinamento superiore. Già questo solo fatto basta a determinare la posizione storica dell’imperialismo, giacché il monopolio, nato sul terreno della libera concorrenza, o proprio dalla libera concorrenza, è il passaggio dall’ordinamento capitalistico a un più elevato ordinamento sociale ed economico.
È noto a tutti quanto il capitale monopolistico abbia acuito tutti gli antagonismi del capitalismo. Basta accennare al rincaro dei prezzi o alla pressione dei cartelli. Questo inasprimento dogli antagonismi costituisce la più potente forza motrice del periodo storico di transizione, iniziatosi con la definitiva vittoria del capitale finanziario mondiale. Monopoli, oligarchia, tendenza al dominio anziché alla libertà, sfruttamento di un numero sempre maggiore di nazioni piccole e deboli per opera di un numero sempre maggiore di nazioni più ricche o potenti: queste le caratteristiche dell’imperialismo, che ne fanno un capitalismo parassitario e putrescente. Sempre più netta appare la tendenza dell’imperialismo a formare lo “stato rentier”, lo stato usuraio, la cui borghesia vive esportando capitali e “tagliando cedole”. Sarebbe erroneo credere che tale tendenza alla putrescenza escluda il rapido incremento del capitalismo: tutt’altro. Nell’età dell’imperialismo i singoli rami dell’industria, i singoli strati della borghesia, i singoli paesi palesano, con forza maggiore o minore, ora l’una ora l’altra di quelle tendenze. In complesso il capitalismo cresce assai più rapidamente di prima, senonché tale incremento non solo diviene in generale più sperequato, ma tale sperequazione si manifesta particolarmente nell’imputridimento dei paesi capitalisticamente più forti. Le espressioni correnti degli economisti borghesi, che scrivono intorno al moderno capitalismo, sono: “intreccio”, “mancanza d’isolamento” e così via; le banche sarebbero “imprese che per i loro compiti e la loro evoluzione non hanno carattere economico puramente privalo, ma vengono sempre più superando i limiti della regolamentazione puramente privata dell’economia”.
Che cosa significa la parola “intreccio”? Essa indica soltanto il carattere più appariscente di un processo che si va compiendo sotto i nostri occhi. Essa dimostra semplicemente che l’osservatore vede i singoli alberi, ma non si accorge del bosco. Essa traduce servilmente il lato esteriore, casuale, caotico, e tradisce nell’os-servatore un uomo che è sopraffatto dalla copia del materiale o non ne capisce più il significato e l’importan -za. “Casualmente si vanno intrecciando” i possessi delle nazioni, i rapporti tra i proprietari privati. Ma il substrato di questo intreccio, ciò che ne costituisce la base, sono i rapporti sociali di produzione che si vanno modificando. Quando una grande azienda assume dimensioni gigantesche e diventa rigorosamente sistematizzata e, sulla base di un’esatta valutazione di dati innumerevoli, organizza metodicamente la fornitura della materia prima originaria nella proporzione di due terzi o di tre quarti dell’intero fabbisogno di una popolazione di più decine di milioni; quando è organizzato sistematicamente il trasporto di questa materia prima nei più opportuni centri di produzione, talora separati l’uno dall’altro da centinaia o migliaia di chilometri; quando un unico centro dirige tutti i successivi stadi di elaborazione dalla materia prima, fino alla produzione dei più svariati manufatti; quando la ripartizione di tali prodotti, tra le centinaia di milioni di consumatori, avviene secondo un preciso piano (spaccio del petrolio in America o Germania da parte del “trust del petrolio” americano), allora diventa chiaro che si è in presenza di una socializzazione della produzione o non già di un semplice “intreccio”. Se si volesse dare la definizione più concisa possibile dell’imperialismo, si dovrebbe dire che l’imperialismo è lo stadio monopolistico del capitalismo. Tale definizione conterrebbe l’essenziale, giacché da un lato il capitale finanziario è il capitale bancario delle poche grandi banche monopolistiche fuso col capitale delle unioni monopolistiche industriali, e dall’altro lato la ripartizione del mondo significa passaggio dalla politica coloniale, estendentesi senza ostacoli ai territori non ancor dominati da nessuna potenza capitalistica, alla politica coloniale del possesso monopolistico della superficie terrestre definitivamente ripartita. È necessario cominciare dalla definizione più precisa e completa possibile dell’imperialismo.
L’imperialismo è uno stadio storico particolare del capitalismo. Questa particolarità ha tre aspetti: l’im-perialismo è 1. il capitalismo monopolistico; 2. il capitalismo parassitario o in putrefazione; 3. il capitalismo
158

agonizzante. La sostituzione del monopolio alla libera concorrenza è il tratto economico fondamentale, l’es-senza dell’imperialismo. Il monopolismo si manifesta sotto cinque aspetti principali: 1. i cartelli, i sindacati o i trust; la concentrazione della produzione ha raggiunto il grado che genera questi gruppi monopolistici di capitalisti; 2. la situazione monopolistica delle grandi banche: da tre a cinque banche gigantesche dirigono tutta la vita economica dell’America, della Francia, della Germania; 3. la conquista delle fonti di materie pri-me da parte dei trust e dell’oligarchia finanziaria (il capitale finanziario è il capitale industriale monopolistico che si è fuso con il capitale bancario); 4. la spartizione (economica) del mondo tra i cartelli internazionali è cominciata; questi cartelli internazionali che posseggono tutto il mercato mondiale e se lo spartiscono “amichevolmente” – finché una guerra non lo ridivida – sono già più di cento; l’esportazione del capitale, come fenomeno particolarmente caratteristico, a differenza dell’esportazione delle merci nell’epoca del capitalismo non monopolistico, è legata strettamente alla spartizione economica e politico-territoriale del mondo; 5. la spartizione territoriale del mondo (colonie) è terminata. Dobbiamo dare una definizione dell’imperialismo che contenga i suoi cinque principali contrassegni, e cioè: 1. la concentrazione della produzione e del capitale, che ha raggiunto un grado talmente alto di sviluppo da creare i monopoli con funzione decisiva nella vita economica; 2. la fusione del capitale bancario col capitale industriale e il formarsi, sulla base di questo “capitale finanziario”, di un’oligarchia finanziaria; 3. la grande importanza acquistata dall’esportazione di capitale in confronto con l’esportazione di merci; 4. il sorgere di associazioni monopolistiche internazionali di capitalisti, che si ripartiscono il mondo; 5. la compiuta ripartizione della terra tra le più grandi potenze capitalistiche.
L’imperialismo è dunque il capitalismo giunto a quella fase di sviluppo in cui si è formalo il dominio dei monopoli o del capitale finanziario, l’esportazione di capitale ha acquistato grande importanza, è cominciala la ripartizione del mondo tra i trust internazionali, ed è già compiuta la ripartizione dell’intera superficie terrestre tra i più grandi paesi capitalistici. Per il vecchio capitalismo, sotto il pieno dominio della libera concorrenza, era caratteristica l’esportazione di merci; per il più recente capitalismo, sotto il dominio dei monopoli, è diventata caratteristica l’esportazione di capitale. Tutto ciò, tradotto in lingua povera, significa presso a poco questo: l’evoluzione del capitalismo è giunta a tal punto che, sebbene la produzione di merci continui come prima a “dominare” e a essere considerata come base di tutta l’economia, essa in realtà è già minata e i maggiori profitti spettano ai “genî” delle manovre finanziarie. Base di tali operazioni o trucchi è la socializzazione della produzione, ma l’immenso progresso compiuto dall’umanità, affaticatasi per giungere a tale socializzazione, torna a vantaggio ... degli speculatori. Che i cartelli eliminino le crisi è una leggenda degli economisti borghesi, desiderosi di giustificare ad ogni costo il capitalismo. Al contrario, il monopolio, sorto in alcuni rami d’industria, accresce e intensifica il caos, che è proprio dell’intera produzione capitalistica nella sua totalità. In altri termini: il vecchio capitalismo, il capitalismo della libera concorrenza, con la borsa, suo regolatore indispensabile, se ne va a carte quarantotto, soppiantato da un nuovo capitalismo che presenta tutti i segni di un fenomeno di transizione, una miscela di libera concorrenza e di monopolio. Naturalmente sorge imperiosa la domanda: verso che cosa dunque “si avvia” questo modernissimo capitalismo? verso che cosa il recentissimo capitalismo, nel suo stadio imperialista, costituisce transizione? Naturalmente tra le poche banche che ancora si mantengono alla testa dell’economia capitalistica in seguito al processo di concentrazione, diventa sempre più forte la tendenza a entrare in reciproci accordi monopolistici, a formare un trust delle banche.
L’ultima parola dello sviluppo del sistema bancario è sempre il monopolio. Ma precisamente nell’intimo nesso tra le banche e l’industria appare, nel modo più evidente, la nuova funzione delle banche Nello stesso tempo si sviluppa, per così dire, un’unione personale della banca con le maggiori imprese industriali e commerciali, una loro fusione mediante il possesso di azioni o l’entrata dei direttori di banche nei consigli dì amministrazione delle imprese industriali o commerciali e viceversa. L’“unione personale” delle banche con l’industria è completata dall’“unione personale” di entrambe col governo. Pertanto i grandi monopoli capitalistici si producono o si sviluppano, a tutto vapore, per tulle le vie “naturali” e “soprannaturali”. Si forma sistematicamente una certa divisione del lavoro tra poche centinaia di finanzieri, veri re della moderna società capitalistica. Pertanto si giunge da un lato a una sempre maggiore fusione, o secondo l’indovinata espressione di N. I. Bukharin, a una simbiosi del capitale bancario col capitale industriale, e d’altro lato al trasformarsi delle banche in istituzioni veramente di “carattere universale”. Concentrazione della produzione; conseguenti monopoli; fusione e simbiosi delle banche con l’industria: in ciò si compendia la storia della formazione del capitale finanziario e il contenuto del relativo concetto.
Ma in realtà l’esperienza dimostra che basta possedere il 40% di tutte le azioni per dominare l’andamento degli affari di una società per azioni, giacché una parte dei piccoli azionisti, disseminati qua o là, non ha praticamente la possibilità di intervenire alle assemblee generali, ecc. La “democratizzazione” del possesso di azioni, dalla quale i sofisti borghesi o gli opportunisti “pseudosocialdemocratici” si ripromettono (o fingono di ripromettersi) la “democratizzazione del capitale”, l’aumento d’importanza e di funzione della piccola produzione, ecc. nella realtà costituisce un mezzo per accrescere la potenza dell’oligarchia
159

finanziaria. In generale il capitalismo ha la proprietà di staccare il possesso del capitale dall’impiego del medesimo nella produzione, di staccare il capitale liquido dal capitale industriale o produttivo, di separare il rentier, che vive soltanto del profitto tratto dal capitale liquido, dall’imprenditore e da tutti coloro che partecipano direttamente all’impiego del capitale. L’imperialismo, vale a dire l’egemonia del capitale finanziario, è quello stadio superiore del capitalismo, in cui tale separazione raggiunge dimensioni enormi. La prevalenza del capitale finanziario su tutte le rimanenti forme del capitale importa una posizione predominante del rentier e dell’oligarchia finanziaria, e la selezione di pochi stati finanziariamente più “forti” degli altri. I paesi esportatori di capitali si sono spartiti, per così dire, il mondo, ma il capitale finanziario ha condotto anche a una divisione del mondo vera e propria.
Le associazioni monopolistiche dei capitalisti – cartelli, sindacati, trust – anzitutto spartiscono tra di loro il mercato interno o si impadroniscono della produzione del paese. Ma in regime capitalistico il mercato interno è inevitabilmente connesso col mercato estero. Da lungo tempo il capitalismo ha creato un mercato mondiale. E a misura che cresceva l’esportazione dei capitali, si allargavano le relazioni estere o coloniali e le “sfere d’influenza” delle grandi associazioni monopolistiche, “naturalmente” si procedeva sempre più verso accordi internazionali tra di esse o verso la creazione di cartelli mondiali. Questo è un nuovo gradino della concentrazione mondiale del capitale e della produzione, un gradino molto più elevato del precedente. Il capitale finanziario è una potenza così ragguardevole, anzi si può dire così decisiva, in tutte le relazioni economiche e internazionali, da essere in grado di assoggettarsi anche paesi in possesso della piena indipendenza politica, come di fatto li assoggetta. Il capitale finanziario o i trust acuiscono, non attenuano, la differenza nella rapidità di sviluppo dei diversi elementi dell’economia mondiale. Ma non appena i rapporti di forza sono modificati, in quale altro modo in regime capitalistico si possono risolvere i contrasti se non con la forza? Certamente, in regime capitalistico nessun monopolio potrà completamente o per lungo tempo escludere la concorrenza del mercato mondiale (questo costituisce tra l’altro una delle ragioni della stupidità della teoria dell’ultra-imperialismo). Certo la possibilità di abbassare, mediante nuovi miglioramenti tecnici, i costi di produzione ed elevare i profitti, milita a favore delle innovazioni. Ma la tendenza alla stagnazione e alla putrefazione, che è propria del monopolio, continua dal canto suo ad agire, e in singoli rami industriali e in singoli paesi s’impone per determinati periodi di tempo.
Il possesso monopolistico di colonie particolarmente ricche, vaste e opportunamente situate, agisce nello stesso senso. Ed ancora. L’imperialismo è l’immensa accumulazione in pochi paesi di capitale liquido. Da ciò segue, inevitabilmente, l’aumentare della classe, o meglio del ceto, dei rentiers, cioè di persone che vivono del “taglio di cedole”, non partecipano ad alcuna impresa e hanno per professione l’ozio. L’esportazione di capitale, uno degli essenziali fondamenti economici dell’imperialismo, intensifica questo completo distacco del ceto dei rentiers dalla produzione e dà un’impronta di parassitismo a tutto il paese, che vive dello sfruttamento del lavoro di pochi paesi o colonie d’oltre oceano. In ciò sta l’essenza dell’imperialismo o del parassitismo imperialista. Por tale motivo nella letteratura economica sull’imperialismo è di uso corrente il concetto di “stato rentier” (rentnerstaat) o stato usuraio. Il mondo si divide in un piccolo gruppo di stati usurai e in una immensa massa di stati debitori. Qui è posto nel suo vero valore il significato degli “Stati uniti d’Europa” nella odierna congiuntura imperialistica, precisamente allo scopo di azioni “in comune” contro i negri dell’Africa, contro il “grande movimento islamico”, per mantenere “un esercito o una flotta poderosi”, contro una “coalizione cino-giapponese”, e così via. “L’Europa trasferirebbe all’umanità di colore il lavoro corporale – anzitutto il lavoro agricolo e minerario e poi anche quello delle industrie più grossolane – accontentandosi dal canto suo della parte di chi vive di rendita, il che, probabilmente, avvierebbe all’emancipazione economica o quindi anche politica delle pelli rosse e nere”.
Una dello particolarità dell’imperialismo, collegata all’accennata cerchia di fenomeni, è la diminuzione dell’emigrazione dai paesi imperialisti o l’aumento dell’immigrazione in essi di individui provenienti da paesi più arretrati, con salari inferiori. Qui sono svelati chiaramente cause ed effetti. Cause: 1) sfruttamento del mondo intero per opera di un determinato paese; 2) sua posizione di monopolio sul mercato mondiale; 3) suo monopolio coloniale. Effetti: 1) imborghesimento di una parte del proletariato; 2) una parte del proletariato si fa guidare da capi che sono comprati o almeno pagati dalla borghesia. L’imperialismo dell’inizio del XX secolo ha ultimato la spartizione del mondo tra un piccolo pugno di stati, ciascuno dei quali sfrutta attualmente (nel senso di spremere sopraprofitti) una parte del “mondo”; ha sul mercato mondiale una posiziono di monopolio grazie ai trust, ai cartelli, al capitale finanziario e ai rapporti da creditore a debitore:
Kautsky chiama ultra-imperialismo o super-imperialismo ciò che tredici anni prima di lui, Hobson chiamava inter-imperialismo. A parte la formazione di una nuova parola erudita per mezzo della sostituzione di una particella latina con un’altra, il progresso del pensiero “scientifico” di Kautsky consiste soltanto nella pretesa di far passare per marxismo ciò che Hohson descrive in sostanza come ipocrisia dei pretucoli inglesi. E quale consolazione poteva essere migliore di questa, che l’imperialismo non era poi tanto cattivo, che esso si avvicinava all’inter-(o ultra-)imperialismo capace di garantire la pace permanente? Quali che potessero
160

essere i pii desideri dei pretucoli inglesi e del sentimentale Kautsky, il senso obiettivo, vale a dire reale, sociale, della sua “teoria” è uno solo: consolare nel modo più reazionario le masse, con la speranza della possibilità di una pace permanente nel regime del capitalismo, sviando l’attenzione dagli antagonismi acuti e dagli acuti problemi di attualità o dirigendo l’attenzione sulle false prospettive di un qualsiasi sedicente nuovo e futuro “ultra-imperialismo”.
Ammesso che tutte le potenze imperialiste formino un’unica lega si avrà allora “il capitale finanziario internazionalmente unito”. Si domanda ora se, permanendo il capitalismo (e Kautsky parte appunto da questa supposizione), possa “immaginarsi” che tali leghe sarebbero di lunga durata, che esse escluderebbero attriti, conflitti o lotte nelle forme più svariate? Basta porre nettamente tale questione perché non si possa rispondere che negativamente. Infatti in regime capitalistico non si può pensare a nessun’altra base per la ripartizione delle sfere d’interessi e d’influenza delle colonie, ecc. che non sia la valutazione della potenza dei partecipanti alla spartizione, della loro generale potenza economica, finanziaria, militare, ecc. Ma i rapporti di potenza si modificano, nei partecipanti alla spartizione, difformemente, giacché in regime capitalistico non può darsi sviluppo uniforme di tutte le singole imprese, trust, rami d’industria, paesi, ecc. Mezzo secolo fa la Germania avrebbe la fatto pietà se si fosse confrontata la sua potenza capitalistica con quella dell’Inghilterra d’allora: e così il Giappone rispetto alla Russia. Si può “immaginare” che nel corso di 10-20 anni i rapporti di forza tra lo potenze imperialiste rimangano immutati? Assolutamente no. Pertanto, nella realtà capitalistica, e non nella volgare fantasia filistea, dei preti inglesi o del “marxista” tedesco Kautsky, le alleanze “inter-imperialiste” o “ultra-imperialiste” non sono altro che un “momento di respiro” tra una guerra e l’altra, qualsiasi forma assumano dette alleanze, sia quella di una coalizione imperialista contro un’altra coalizione imperialista, sia quella di una lega generale tra tutte lo potenze imperialiste. Le alleanze di pace preparano la guerra e a loro volta nascono da queste; le une e le altre forme si determinano reciprocamente e producono, su di un unico e identico terreno, dei nessi imperialistici e dei rapporti dell’eco-nomia mondiale o della politica mondiale, l’alternarsi della forma pacifica e non pacifica della lotta.
[IFSC]
II.2.3. I difetti della società economica
I difetti più evidenti della società economica nella quale viviamo sono l’incapacità a provvedere la piena occupazione e la distribuzione arbitraria e iniqua delle ricchezze e dei redditi. Per mio conto, ritengo che vi siano giustificazioni sociali e psicologiche di disuguaglianze rilevanti dei redditi e delle ricchezze, ma non di disparità tanto forti quanto quelle oggi esistenti. Vi sono pregevoli attività umane le quali, affinché possano esplicarsi completamente, richiedono il movente del guadagno e l’ambiente del possesso privato della ricchezza. Inoltre, l’esistenza di possibilità di guadagni monetari e di arricchimento privato può instradare entro canali relativamente innocui, pericolose tendenze umane, le quali, se non potessero venir soddisfatte in tal modo, cercherebbero uno sbocco in crudeltà, nel perseguimento sfrenato del potere e dell’autorità personale e in altre forme di auto-potenziamento. È meglio che un uomo eserciti la sua tirannia sul proprio conto in banca che sui suoi concittadini; e mentre talvolta si denuncia il primo quale un mezzo per raggiungere il secondo, talaltra almeno ne è un’alternativa; può essere purtuttavia saggia e prudente condotta di governo consentire che la partita si giochi, sia pure sottoponendola a norme e limitazioni, fino a quando la media degli uomini, o anche soltanto una sezione rilevante della collettività, sia di fatto dedita tenacemente alla passione del guadagno monetario.
Mi par certo che la domanda di capitale è strettamente limitata, nel senso che non sarebbe difficile accrescere la consistenza del capitale fino al punto in cui la sua efficienza marginale cadesse ad un livello molto basso. Ciò non significherebbe che l’uso degli “strumenti di capitale” verrebbe a costare quasi niente, ma soltanto che il reddito tratto da essi dovrebbe coprire poco più del loro esaurimento per logorio e obsolescenza, oltre a un certo margine per coprire il rischio e l’esercizio della capacità e del giudizio personali. Ora, sebbene questo stato di cose sia affatto compatibile con un certo grado di individualismo, esso significherebbe tuttavia l’“eutanasia del redditiero” e di conseguenza l’eutanasia del potere oppressivo e cumulativo del capitalista di sfruttare il valore di scarsità del capitale. Oggi l’interesse non rappresenta il compenso di alcun sacrificio genuino, come non lo rappresenta la rendita della terra. Il possessore del capitale può ottenere l’interesse perché il capitale è scarso, proprio come il possessore della terra può ottenere la rendita perché la terra è scarsa. Ma, mentre vi può essere una ragione intrinseca della scarsità della terra, non vi sono ragioni ìntrinseche della scarsità del capitale. A lungo andare non esisterebbe una ragione intrinseca di questa scarsità, ossia non esisterebbe un sacrificio genuino, ottenibile soltanto con l’offerta del compenso dell’interesse.
Considero perciò l’aspetto del capitalismo caratterizzato dall’esistenza del redditiero come una fase di transizione, destinata a scomparire quando esso avrà compiuto la sua opera. E con la scomparsa del
161

redditiero, molte altre cose del capitalismo subiranno un mutamento radicale. Sarà inoltre un gran vantaggio nel corso degli eventi che qui preconizzo se l’eutanasia del redditiero, dell’investitore senza funzioni, non sia nulla di improvviso, ma soltanto una graduale ma prolungata prosecuzione di quello che abbiamo visto recentemente in Gran Bretagna, e non richieda alcuna rivoluzione. Potremmo dunque mirare in pratica (poiché non vi è nulla di tutto questo che sia irraggiungibile) ad un aumento del volume di capitale finché questo non sia più scarso, cosicché l’investitore senza funzioni non riceva più un premio gratuito; e ad un sistema di imposizione diretta tale da consentire che l’intelligenza e la determinatezza e la capacità direttiva del finanziere, dell’imprenditore et hoc genus omne (i quali certamente amano tanto il loro mestiere che il loro lavoro potrebbe ottenersi ad assai minor prezzo che attualmente) siano imbrigliate al servizio della collettività, con un compenso a condizioni ragionevoli.
In certi altri aspetti la teoria precedente è piuttosto conservatrice nelle conseguenze che implica. Infatti, mentre indica l’importanza vitale di stabilire certi controlli centrali in materie ora sostanzialmente lasciate al -l’iniziativa indìviduale, essa non tocca altri campi importanti di attività. Lo stato dovrà esercitare un’influen-za direttiva circa la propensione al consumo, in parte mediante il suo sistema di imposizione fiscale, in parte fissando il tasso di interesse e in parte, forse, in altri modi. Per di più, sembra improbabile che l’influenza della politica bancaria sul tasso di interesse sarà sufficiente da sé sola a determinare un ritmo ottimo di investimento. Ritengo perciò che una socializzazione di una certa ampiezza dell’investimento si dimostrerà l’unico mezzo per farci avvicinare alla piena occupazione; sebbene ciò non escluda necessariamente ogni sorta di espedienti e di compromessi coi quali la pubblica autorità collabori con la privata iniziativa. Ma oltre a questo non si vede nessun’altra necessità di un sistema di socialismo di stato che abbracci la maggior parte della vita economica della collettività. Non è importante che lo stato si assuma la proprietà degli strumenti di produzione. Se lo stato è in grado di determinare l’ammontare complessivo delle risorse destinate ad accrescere gli strumenti di produzione e il tasso base di remunerazione per coloro che le posseggono, esso avrà compiuto tutto quanto è necessario. Inoltre le necessarie misure di socializzazione possono essere applicate gradatamente e senza introdurre una soluzione di continuità nelle tradizioni generali della società. Ma rimarrà ancora largo campo all’esercizio dell’iniziativa e della responsabilità individuale. Entro questo campo, i vantaggi tradizionali dell’individualismo varranno ancora. Fermiamoci un momento a ricordare a noi stessi quali sono questi vantaggi. Sono in parte vantaggi di efficienza, i vantaggi del decentramento e del gioco dell’interesse personale. Il vantaggio dell’efficienza e del decentramento delle decisioni e della responsabilità individuale è forse ancor maggiore di quanto supponesse il diciannovesimo secolo; e può darsi che la reazione contro l’appello all’interesse personale si sia spinta troppo innanzi. Ma, soprattutto, l’individualismo, se lo si può mondare dei suoi difetti e dei suoi abusi, è la migliore salvaguardia della libertà personale.
Mentre quindi l’allargamento delle funzioni di governo, richiesto dal compito di equilibrare l’una all’altro la propensione al consumo e l’incentivo a investire, sarebbe sembrato ad un pubblicista del diciannovesimo secolo o ad un finanziere americano contemporaneo una orribile usurpazione ai danni dell’individualismo, io lo difendo, al contrario, sia come l’unico mezzo attuabile per evitare la distruzione completa delle forme economiche esistenti, sia come la condizione di un funzionamento soddisfacente dell’iniziativa individuale. Come era conforme alla ortodossia nella seconda metà dei diciannovesimo secolo, un governo non aveva alcun mezzo disponibile per mitigare la depressione economica all’interno salvo la lotta di concorrenza per la conquista dei mercati. Se un paese vecchio e ricco avesse trascurato la lotta per i mercati, la sua prosperità sarebbe andata discendendo fino a svanire. Ma se le nazioni possono imparare a crearsi una situazione di occupazione piena mediante la propria politica interna (e, dobbiamo aggiungere, se esse possono anche raggiungere l’equilibrio nell’evoluzione demografica), non è più necessario che forze economiche importanti siano rivolte al fine di contrapporre l’interesse di un paese a quello dei suoi vicini. Sarebbero sempre possibili la divisione internazionale del lavoro e i prestiti internazionali, in adatte condizioni. Ma non esisterebbe più un motivo urgente perché un paese si trovi costretto a svendere le sue merci in un altro o a respingere le offerte del suo vicino, non perché ciò fosse necessario a metterlo in grado di pagare ciò che esso desiderasse acquistare, ma con lo scopo esplicito di sconvolgere l’equilibrio dei pagamenti in modo da sviluppare una bilancia commerciale a proprio favore. Il commercio internazionale cesserebbe di essere quello che è attualmente, ma sarebbe uno scambio volontario e senza impedimenti di merci e servizi in condizioni di vantaggio reciproco. È speranza visionaria l’avverarsi di queste idee? Hanno esse radici insufficienti nei moventi che governano l’evoluzione della società politica? Sono sicuro che il potere degli interessi costituiti si esagera di molto, in confronto con l’affermazione progressiva delle idee
[TG. 24]
II.2.4. Le contraddizioni immanenti all’accumulazione
162

II processo di produzione capitalistico consiste essenzialmente nella produzione del plusvalore, rappresentato dal plusprodotto ossia dalla parte aliquota delle merci prodotte, nella quale è oggettivato un lavoro non pagato. Non si deve mai dimenticare che la produzione dì questo plusvalore – e la riconversione di una parte di esso in capitale o accumulazione, formano una parte integrante di questa produzione di plusvalore – costituisce lo scopo immediato ed il motivo determinante della produzione capitalistica. Non si deve dunque mai rappresentare quest’ultima per ciò che non è, vale a dire come produzione avente per scopo immediato il godimento o la produzione di mezzi di godimento, per il capitalista. Con ciò si astrae completamente dal suo specifico carattere, che si presenta in tutta la sua intima essenza.
Il guadagnare questo plusvalore costituisce il processo di produzione immediato che, come si è già detto, non ha altri limiti oltre quelli sopra menzionali. Il plusvalore è prodotto non appena il pluslavoro che è possibile estorcere si trova oggettivato nelle merci. Ma con questa produzione del plusvalore si chiude solo il primo atto del processo di produzione capitalistico, la produzione immediata. Il capitale ha assimilato una quantità determinata di lavoro non pagato. Contemporaneamente allo sviluppo del processo, che si esprime in una diminuzione del tasso del profitto, la massa di plusvalore così prodotta si gonfia all’infinito. Comincia ora il secondo atto del processo. La massa complessiva delle merci, il prodotto complessivo, tanto la parte che rappresenta il capitale costante e variabile, come quella che rappresenta il plusvalore, deve essere venduta. Qua lora questa vendita non abbia luogo, o avvenga solo in parte oppure a prezzi inferiori a quelli di produzione, lo sfruttamento del lavoratore, che esiste in ogni caso, non si tramuta in un profitto per il capitalista e può dar luogo ad una realizzazione nulla o parziale del plusvalore estorto, ed anche a una perdita parziale o totale del suo capitale. Le condizioni dello sfruttamento immediato e della sua realizzazione non sono identiche: esse differiscono non solo dal punto di vista del tempo e del luogo ma anche della sostanza. Le une sono limitate esclusivamente dalla forza produttiva della società, le altre dalla proporzione esistente tra i diversi rami di produzione e dalla capacità di consumo della società. Quest’ultima, a sua volta, non è determinata né dalla forza produttiva assoluta né dalla capacità di consumo assoluta; ma dal la capacità di consumo fondata su una distribuzione antagonistica, che riduce il consumo della grande massa della società a un limite che può variare solo entro confini più o meno ristretti. Essa è inoltre limitata dall’impulso ad accumulare, ad accrescere il capitale ed ottenere delle quantità sempre più forti di plusvalore. Si tratta di una legge per la produzione capitalistica, determinata dalle incessanti rivoluzioni nei metodi di produzione, dal deprezzamento continuo del capitale esistente che ne è la conseguenza, dalla concorrenza generale e dalla necessità infine di perfezionare la produzione ed allargarne le dimensioni, al semplice scopo di conservarla ed evitare la rovina. Il mercato di conseguenza deve essere costantemente ampliato, cosicché i suoi rapporti e le condizioni che li regolano assumono sempre di più l’apparenza di una legge naturale indipendente dai produttori, sfuggono sempre di più al controllo.
La contraddizione intrinseca cerca una compensazione mediante l’allargamento del campo esterno della produzione. Ma tanto più la forza produttiva si sviluppa e tanto maggiore è il contrasto in cui viene a trovarsi con la base ristretta su cui poggiano i rapporti di consumo. E non vi è nulla di inspiegabile nel fatto che, su questa base piena di contraddizioni, un eccesso di capitale sia collegato con un eccesso crescente di popolazione; e quantunque la massa di plusvalore risulterebbe aumentata nel caso che si assorbisse l’eccesso di popolazione con l’eccesso di capitale, si accentuerebbe con ciò il conflitto tra le condizioni in cui questo plusvalore è prodotto e quelle in cui invece è realizzato. Lo sviluppo della produttività sociale del lavoro si manifesta in due modi: innanzitutto nel volume delle forze produttive già prodotte, nell’entità del valore e della massa delle condizioni di produzione che dànno luogo alla nuova produzione e nella grandezza assoluta del capitale produttivo già accumulato; in secondo luogo nella relativa esiguità della parte di capitale spesa in salario in rapporto al capitale complessivo, ossia nella quantità relativamente modesta di lavoro vivo che è richiesta per riprodurre e valorizzare un capitale determinato, per la produzione di massa. Ciò presuppone nel medesimo tempo la concentrazione del capitale.
In rapporto alla forza-lavoro impiegata, lo sviluppo della forza produttiva si palesa nuovamente sotto un duplice aspetto: innanzi tutto nell’incremento del plusvalore ossia nella diminuzione del tempo di lavoro necessario, che è richiesto per la riproduzione della forza-lavoro; secondariamente nella riduzione della quantità della forza-lavoro (numero dei lavoratori) che viene impiegata per mettere in opera un capitale determinato. Questi due movimenti non solo agiscono simultaneamente, ma si determinano reciprocamente, sono manifestazioni di una medesima legge. Essi tuttavia agiscono in senso opposto sul tasso del profitto. La massa complessiva del profitto corrisponde aIla massa complessiva del plusvalore e il tasso del profitto è espresso dalla formula pv/C = plusvalore / capitale_complessivo_anticipato. Ma il plusvalore, come totale, è determinato, in primo luogo dal suo tasso, in secondo luogo dalla massa di lavoro contemporaneamente impiegata a questo tasso o, ciò che significa la stessa cosa, dalla grandezza del capitale variabile. Da un lato uno di questi fattori, il tasso del plusvalore, aumenta; dall’altro lato il secondo fattore, il numero dei lavoratori, diminuisce in senso relativo o assoluto. In quanto lo sviluppo delle forze produttive fa diminuire la parte pagata del lavoro impiegato, esso accresce il plusvalore aumentandone il tasso; in quanto tuttavia
163

diminuisce la massa complessiva del lavoro impiegato da un determinato capitale, esso diminuisce il coefficiente numerico con cui viene moltiplicato il tasso del plusvalore per ricavarne la massa. Sotto questo rispetto, la possibilità di compensare la diminuzione del numero dei lavoratori aumentando il grado di sfruttamento del lavoro ha dei limiti insuperabili; la caduta del tasso del profitto può essere ostacolata, ma non annullata.
Con lo sviluppo del modo capitalistico di produzione diminuisce dunque il tasso del profitto, mentre la sua massa aumenta unitamente alla massa crescente del capitale messo in opera. Ma questi due momenti inerenti al processo di accumulazione non devono essere considerati solo nella loro tranquilla coesistenza, come fa Ricardo: essi contengono una contraddizione, che si manifesta in tendenze e fenomeni contrastanti: agiscno nello stesso tempo l’uno contro l’altro.
Contemporaneamente alle tendenze verso un aumento effettivo della popolazione lavoratrice, che provengono dall’aumento della parte del prodotto complessivo sociale che funziona da capitale, agiscono i fattori che creano solamente una sovrapopolazione relativa.
Contemporaneamente alla caduta del tasso del profitto, cresce la massa dei capitali e al tempo stesso si verifica una diminuzione di valore del capitale esistente, che frena questa caduta e tende ad accelerare l’accu-mulazione del valore-capitale.
Contemporaneamente alla evoluzione della forza produttiva si sviluppa anche la composizione superiore del capitale, la diminuzione relativa della parte variabile in rapporto alla costante. L’azione di queste influenze contraddittorie si manifesta tanto simultaneamente nello spazio, quanto successivamente nel tempo; periodicamente il conflitto fra le forze contrastanti erompe in crisi, le quali sono sempre solo delle temporanee e violente soluzioni dello contraddizioni esistenti, violente eruzioni che ristabiliscono momentaneamente l’equilibrio turbato.
La contraddizione, esposta in termini generali, consiste in questo: la produzione capitalistica racchiude una tendenza verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipendentemente dal valore e dal plusvalore in esso contenuto, indipendentemente anche dalle condizioni sociali nelle quali essa funziona; ma nello stesso tempo tale produzione ha come scopo la conservazione del valore-capitale esistente e la sua massima valorizzazione (vale a dire l’accrescimento accelerato di questo valore). Per la sua intrinseca natura essa tende a considerare il valore-capitale esistente come mezzo per la massima valorizzazione possibile di questo valore; turba le condizioni date in cui si compie il processo di circolazione e di riproduzione del capitale, e provoca di conseguenza degli arresti improvvisi e delle crisi del processo di produzione. La produzione capitalistica tende continuamente a superare questi limiti immanenti, ma riesce a superarli unicamente con dei mezzi che la pongono di fronte agli stessi limiti su scala nuova e più alta.
Il vero limite della produzione capitalistica è il capitale stesso, è questo: che il capitale e la sua autovalorizzazione appaiono come punto di partenza e punto di arrivo, come motivo e scopo della produzione; che la produzione è solo produzione per il capitale, e non al contrario; i mezzi di produzione non sono dei semplici mezzi per una continua estensione del processo di vita per la società dei produttori. I limiti nei quali possono unicamente muoversi la conservazione e l’autovalorizzazione del valore-capitale, che si fonda sulla espropriazione e l’impoverimento della grande massa dei produttori, questi limiti si trovano dunque continuamente in conflitto, con i metodi di produzione a cui il capitale deve ricorrere, per raggiungere il suo scopo, e che perseguono l’accrescimento illimitato della produzione, la produzione come fine a se stessa, lo sviluppo incondizionato delle forse produttive sociali del lavoro. Il mezzo – lo sviluppo incondizionato delle forze produttive sociali – viene permanentemente in conflitto con il fine ristretto, la valorizzazione del capitale esistente. Se il modo di produzione capitalistico è quindi un mezzo storico per lo sviluppo della forza produttiva materiale e la creazione di un corrispondente mercato mondiale, è al tempo stesso la contraddizione costante tra questo suo compito storico e i rapporti di produzione sociali che gli corrispondono.
E nello stesso tempo s’accentua la concentrazione perché, oltre certi limiti, un grande capitale con un basso tasso del profitto accumula più rapidamente di un capitale piccolo con un elevato tasso del profitto. Questa crescente concentrazione provoca a sua volta, non appena abbia raggiunto un certo livello, una nuova diminuzione del tasso del profitto. La massa dei piccoli capitali frantumati viene così trascinata sulla via delle avventure; speculazione, imbrogli creditizi ed azionari, crisi. Quando si parla di pletora di capitale ci si riferisce sempre o quasi sempre, in sostanza, alla pletora di capitale per il quale la caduta del tasso di profitto non è compensata dalla sua massa – e questo avviene sempre nel caso di nuovi capitali di formazione derivata – o alla pletora che questi capitali, incapaci di operare per proprio conto, mettono, sotto forma di credito, a disposizione dei dirigenti delle grandi imprese. Questa pletora di capitale è determinata dalle medesime circostanze che provocano una sovrapopolazione relativa e ne costituisce quindi una manifestazione complementare, quantunque i due fenomeni si trovino ai poli opposti, capitale inutilizzato da una parte e popolazione lavoratrice inutilizzata dall’altra.
164

Sovraproduzione di capitale, non delle merci individuali – quantunque la sovraproduzione di capitale determini sempre sovraproduzione di merci – significa semplicemente sovraccumulazione di capitale. Nella realtà, le cose si svolgerebbero in modo tale che una parte del capitale resterebbe interamente o parzialmente inattiva (perché per potersi valorizzare essa avrebbe dovuto prima soppiantare il capitale già in funzione) mentre l’altra porte verrebbe valorizzata a un tasso del profitto ridotto in seguito alla pressione del capitale totalmente o parzialmente inattivo. È tuttavia chiaro che questa effettiva diminuzione di valore dell’antico capitale non potrebbe aver luogo senza conflitto e che il capitale supplementare non potrebbe operare come capitale senza sostenere una lotta. Il tasso del profitto non diminuirebbe a causa della concorrenza derivante dalla sovraproduzione di capitale: al contrario la concorrenza entrerebbe ora in gioco in quanto caduta del tasso del profitto e sovraproduzione di capitale provengono dalle medesime cause. In ogni caso, una parte dell’antico capitale dovrebbe essere lasciata inattiva, inoperosa nella sua essenza stessa di capitale, che deve operare come capitale e dare un profitto. Ed è la concorrenza che decide quale aliquota di esso debba in particolare essere condannata all’inoperosità. Fino a che gli affari vanno bene, la concorrenza esercita, come si è visto a proposito del tasso generale del profitto, un’azione di fratellanza sulla classe capitalistica cha praticamente si ripartisce il bottino comune, in proporzione del rischio assunto da ognuno. Appena non si tratta più di ripartire i profitti ma di suddividere le perdite, ciascuno cerca di ridurre il più possibile la propria quota parte della perdita, e di riversarla sulle spalle degli altri. La perdita per la classe nell’insieme è inevitabile, ma quanto di essa ciascuno debba sopportare, in quale misura debba assumersene una parte, diventa allora questione di forza e di astuzia, e la concorrenza si trasforma in una lotta fra fratelli nemici. L’antagonismo tra l’interesse di ogni singolo capitalista e quello della classe capitalistica si manifesta allora nello stesso modo come nel periodo di prosperità si era praticamente affermata, per mezzo della concorrenza, l’identità di tali interessi.
Come si appianerà questo conflitto e come si ristabiliranno condizioni favorevoli a un movimento “sano” della produzione capitalistica? La soluzione si trova già racchiusa nella semplice esposizione del conflitto che si tratta di appianare. Essa richiede l’inattività e anche una parziale distruzione di capitale, per un ammontare corrispondente al valore di tutto il capitale supplementare o di una parte di esso. Tale perdita peraltro, come già appare dalla semplice enunciazione del conflitto, non colpisce affatto in uguale misura i diversi capitali particolari; la sua ripartizione viene invece decisa in una lotta di concorrenza nella quale, in relazione ai vantaggi particolari o a posizioni già acquistate, essa si ripartisce molto inegualmente e con manifestazioni assai diverse, cosicché un capitale viene lasciato inattivo, un secondo distrutto, un terzo subisce solo una perdita relativa o una diminuzione di valore temporanea, e così via. Ma in tutti i casi, per ristabilire l’equilibrio, si renderebbe necessario lasciare inattiva o anche distruggere una quantità più o meno grande di capitale. Questo processo si estenderebbe in parte alla sostanza materiale del capitale; ossia una parte dei mezzi di produzione, del capitale fisso e del capitale circolante, cesserebbe di funzionare, di agire come capitale; una parte delle imprese produttive già in azione verrebbe lasciata inoperosa. E sebbene il tempo intacchi tutti i mezzi di produzione (eccettuata la terra) e li deteriori, si verificherebbe, a causa dell’interruzione nel funzionamento del sistema produttivo, una distruzione assai più forte ed effettiva dei mezzi di produzione. L’effetto principale, sotto questo punto di vista, sarebbe tuttavia che questi mezzi di produzione cesserebbero di funzionare come tali; si avrebbe una distruzione più o meno lunga della loro funzione di mezzi di produzione.
La distruzione principale e a carattere più grave avverrebbe per il capitale in quanto esso possiede carattere di valore, e quindi per i valori-capitale. La parte del valore-capitale che rappresenta semplicemente dei buoni su un’aliquota del plusvalore futuro, ossia del profitto, in realtà semplici obbligazioni sulla produzione sotto forme diverse, si trova subito deprezzata in seguito alla caduta dei redditi, in base ai quali essa è calcolata. Una parte d’oro e d’argento in contanti rimane inattiva, non opera come capitale. Una parte delle merci a disposizione sul mercato può completare il suo processo di circolazione e di riproduzione solo mediante una enorme contrazione del suo prezzo, quindi mediante deprezzamento del capitale che essa rappresenta. Allo stesso modo gli elementi del capitale fisso risultano più o meno deprezzati. A questo si aggiunge che il processo di riproduzione dipende da determinate, presupposte condizioni dì prezzo e verrà quindi a trovarsi in una situazione di ristagno e di disorganizzazione a causa della diminuzione generale dei prezzi. Tale ristagno e tale disorganizzazione paralizzano la funzione del denaro come mezzo di pagamento – funzione che si è venuta determinando contemporaneamente allo sviluppo stesso del capitale e che dipende da quelle condizioni di prezzo presupposte – spezzano in cento punti la catena dei pagamenti che scadono a date fisse, vengono ulteriormente aggravate dall’inevitabile collasso del sistema creditizio sviluppatosi contemporaneamente al capitale, e portano a delle crisi burrascose e gravi, a deprezzamenti improvvisi e violenti, ad una effettiva paralisi e perturbazione del processo di riproduzione e di conseguenza ad una reale contrazione della riproduzione.
Ma altri fattori avrebbero nel medesimo tempo fatto sentire la loro influenza. Il ristagno della produzione avrebbe reso disoccupata una parte della classe operaia ed avrebbe in conseguenza costretto la parte occupata
165

ad accettare una riduzione di salario anche al di sotto del salario medio: operazione che avrebbe rispetto al capitale lo stesso identico effetto di un aumento del plusvalore assoluto o relativo, con un salario medio rimasto invariato. La diminuzione dei prezzi e la lotta di concorrenza avrebbero d’altro lato incoraggiato ogni capitalista ad accrescere – mediante l’impiego di nuove macchine, di nuovi metodi perfezionati di lavoro, di nuove combinazioni – il valore individuale del suo prodotto complessivo al di sopra del valore generale, ossia lo avrebbero incoraggialo ad accrescere la forza produttiva di una determinata quantità di lavoro, a diminuire la proporzione del capitale variabile rispetto al costante, e in conseguenza a licenziare dei lavoratori; in breve, a creare una sovrapopolazione artificiale. Inoltre, il deprezzamento degli elementi del capitale costante costituirebbe esso stesso un fattore che provocherebbe un aumento del tasso del profitto. La massa del capitale costante impiegato rispetto al variabile sarebbe accresciuta, ma il valore di questa massa potrebbe essere diminuito. Il rallentamento sopravvenuto nella produzione avrebbe preparato – entro limiti capitalistici – un ulteriore aumento della produzione.
E così il circolo tornerebbe a riprodursi. Una parte del capitale, il cui valore era diminuito in seguito al -l’arresto della sua funzione, riguadagnerebbe il suo antico valore. Ed a partire da questo momento il medesimo circolo vizioso verrebbe ripetuto con mezzi di produzione più considerevoli, con un mercato più esteso e con una forza produttiva più elevata. Ma anche nell’ipotesi spinta all’estremo che abbiamo appena fatta, la sovraproduzione assoluta di capitale non è una sovraproduzione assoluta in generale, una sovraproduzione assoluta di mezzi di produzione. Essa è solo una sovraproduzione di mezzi di produzione, in quanto questi operano come capitale e devono perciò, in proporzione al valore accresciuto che deriva dall’aumento della loro massa, valorizzare questo valore, creare un valore supplementare. E tuttavia si tratterebbe sempre di sovraproduzione, perché il capitale sarebbe incapace di utilizzare il lavoro a quel grado di sfruttamento che è richiesto dallo sviluppo “sano”, “normale” del processo capitalistico di produzione, a quel grado di sfruttamento che accresce se non altro la massa di profitto parallelamente alla massa accresciuta del capitale impiegato e non consente che il tasso del profitto diminuisca nella stessa misura in cui il capitale cresce, o che la diminuzione del tasso del profitto sia più rapida dell’aumento di capitale.
Sovraproduzione di capitale non è altro che sovraproduzione di mezzi di produzione – mezzi di lavoro e di sussistenza – che possono operare come capitale, ossia essere impiegati allo sfruttamento dei lavoratori ad un grado determinato, poiché la diminuzione del grado di sfruttamento al di sotto di un livello determinato provoca delle perturbazioni e delle paralisi nel processo capitalistico di produzione, crisi, distruzioni di capitale. Non esiste nessuna contraddizione nel fatto che questa sovraproduzione di capitale sia accompagnata da una sovrapopolazione relativa più o meno grande. Poiché le medesime circostanze che hanno accresciuto la forza produttiva del lavoro, aumentato la massa dei prodotti, ampliato i mercati, accelerato l’accumulazione di capitale come massa e come valore, e diminuito il tasso del profitto, hanno creato una sovrapopolazione relativa e creano continuamente una sovrapopolazione di lavoratori, che non possono venire assorbiti dal capitale in eccesso, perché il grado di sfruttamento del lavoro che solo consentirebbe il loro impiego non è abbastanza elevato, o almeno perché il tasso del profitto che essi produrrebbero a questo determinato grado di sfruttamento è troppo basso. Quando il capitale è inviato all’estero, questo non avviene perché sia assolutamente impossibile impiegarlo nel paese, ma perché all’estero esso può venire utilizzato a un tasso di profitto più elevato. Ma questo capitale è effettivamente superfluo riguardo alla popolazione lavoratrice occupata e a quel determinato paese in generale: come tale esso sussiste accanto a un relativo eccesso di popolazione e fornisce un esempio di come questi due fenomeni coesistano e siano interdipendenti fra loro.
D’altro lato la caduta del tasso del profitto, provocata dall’accumulazione, genera necessariamente la concorrenza. Soltanto il capitale complessivo sociale e i grandi capitalisti già saldamente installati trovano una compensazione alla caduta del tasso del profitto nell’aumento della massa dei profitti. Il nuovo capitale addizionale che funziona per proprio conto non trova tali condizioni di compensazione, deve cominciare a conquistarsele lottando; e così è la caduta del tasso del profitto che genera la concorrenza fra i capitali, e non inversamente la concorrenza che determina la caduta del tasso del profitto. Tale concorrenza è sempre accompagnata da un aumento temporaneo del salario, e quindi da una ulteriore caduta temporanea del tasso del profitto; si manifesta anche nello sovraproduzione dei prodotti, nella saturazioue dei mercati. Poiché il capitale non ha come fine la soddisfazione dei bisogni ma la produzione del profitto, e poiché può realizzare questo fine solo usando dei metodi che regolano la massa dei prodotti secondo la scala della produzione e non inversamente, si deve necessariamente venire a creare un continuo conflitto fra le dimensioni limitate del consumo su basi capitalistiche ed una produzione che tende continuamente a superare questo limite che le è assegnato. Inoltre il capitale si compone di merci e quindi la sovraproduzione del capitale comporta una sovraproduzione di merci. Quando il tasso del profitto diminuisce, il capitale da un lato raddoppia i suoi sforzi, ed ogni singolo capitalista, impiegando metodi migliori, ecc., cerca dì ridurre il valore individuale della sua merce particolare al di sotto del suo valore medio sociale, realizzando così, a dato prezzo di mercato, un sovraprofitto, d’altro lato, si verifica una ripresa della speculazione ed un generale
166

incoraggiamento alla speculazione che si esprime in appassionati tentativi di nuovi metodi di produzione, di nuovi investimenti di capitali, nuove avventure, al fine di assicurare in qualsiasi modo un extra-profitto, indipendente dal profitto medio generale e ad esso superiore.
Non esiste un capitalista il quale applichi di buon grado un nuovo metodo di produzione quando questo, pur essendo assai più produttivo ed aumentando considerevolmente il tasso del plusvalore, provoca una diminuzione del tasso del profitto. Ma un tal metodo di produzione fa diminuire il prezzo delle merci. Il capitalista vende quindi in un primo tempo le merci al disopra del loro prezzo di produzione, e forse al disopra del loro valore; egli intasca la differenza fra il costo di produzione ed il prezzo di mercato delle altre merci prodotte a costi di produzione più elevati e può fare questo perché il tempo medio necessario alla produzione di tali merci è superiore al tempo di lavoro inerente al nuovo metodo di produzione. Il suo metodo di produzione è superiore alla media sociale: ma la concorrenza non tarda a generalizzarlo e a sottometterlo alla legge comune. Ha allora inizio la diminuzione del tasso del profitto – che può manifestarsi in un primo tempo nella sfera di produzione del capitalista, per poi livellarsi al tasso del profitto delle altre sfere – senza che tutto ciò dipenda minimamente dalla volontà del capitalista. Il modo capitalistico di produzione è solo un modo di produzione relativo, i cui limiti non sono assoluti ma lo diventano per il modo di produzione stesso. Come sarebbe altrimenti possibile che possa far difetto la domanda per quelle stesse merci di cui il popolo ha bisogno, e come sarebbe possibile che si debba cercare questa domanda all’estero, su mercati lontani, per poter pagare ai lavoratori del proprio paese la media dei mezzi di sussistenza necessari? Precisamente perché solo in questo nesso, specificamente capitalistico, il prodotto in eccesso riveste una forma tale che colui che lo possiede può metterlo a disposizione del consumo unicamente quando esso si riconverte per lui in capitale.
Non vengono prodotti troppi mezzi di sussistenza in rapporto alla popolazione esistente. Al contrario, se ne producono troppo pochi per poter soddisfare in modo conveniente e umano la massa della popolazione. Non vengono prodotti troppi mezzi di produzione, per poter occupare la parte della popolazione capace di lavorare. Al contrario. Si crea innanzitutto una parte troppo grande di popolazione che effettivamente non è atta al lavoro, ed è costretta dalle sue particolari condizioni a sfruttare il lavoro altrui o ad eseguire dei lavori che possono essere considerati tali solo in un modo di produzione assolutamente miserabile. In secondo luogo, non si producono sufficienti mezzi di produzione, perché tutta quanta la popolazione capace di lavorare possa farlo nelle circostanze più produttive, in modo che il suo tempo di lavoro assoluto venga ridotto dalla massa e dall’efficienza del capitale costante impiegato durante il tempo dì lavoro. Ma vengono periodicamente prodotti troppi mezzi di lavoro e di sussistenza, perché possano essere impiegati come mezzi di sfruttamento dei lavoratori a un determinalo tasso del profitto. Vengono prodotte troppe merci, perché il valore e il plusvalore che esse contengono possano essere realizzati e riconvertiti in nuovo capitale, e nei rapporti di distribuzione e di consumo inerenti alla produzione capitalistica, ossia perché questo processo possa compiersi senza che si verifichino continue esplosioni. Non viene prodotta troppa ricchezza. Ma periodicamente viene prodotta troppa ricchezza nelle sue forme capitalistiche, che hanno un carattere antitetico.
Il limite del modo capitalistico di produzione si manifesta nei fatti seguenti:1. Lo sviluppo della forza produttiva del lavoro, determinando la caduta del tasso del profitto, genera una
legge che, ad un dato momento, si oppone inconciliabilmente al suo ulteriore sviluppo e che deve quindi di continuo essere superata per mezzo di crisi;
2. L’estensione o la riduzione della produzione non viene decisa in base al rapporto fra la produzione ed i bisogni sociali, i bisogni di un’umanità socialmente sviluppata, ma in base all’appropriazione del lavoro non pagato ed al rapporto fra questo lavoro non pagato ed il lavoro oggettivalo in generale o, per usare un’espres-sione capitalistica, in base al profitto ed al rapporto fra questo profitto ed il capitale impiegato, vale a dire in base al livello del tasso del profitto. Essa incontra quindi dei limiti ad un certo grado di sviluppo, che sembrerebbe viceversa assai in adeguato sotto l’altro punto di vista. Si arresta nom quando i bisogni sono soddisfatti, ma quando la produzione e la realizzazione del profitto impongono questo arresto.
[C. III,15]
II.3. Prodromi della crisi
II.3.1. Il tempo di circolazione
Il tempo di circolazione – nella misura in cui investe il tempo del capitalista in quanto tale – dal punto di vista economico ci riguarda tanto quanto il tempo che egli passa con la sua Lorette. Se time is money, dal
167

punto di vista del capitale lo è soltanto il tempo di lavoro altrui, il quale senza dubbio costituisce nel senso più proprio della parola il money del capitale. In rapporto al capitale in quanto tale il tempo di circolazione può coincidere col tempo di lavoro solo in quanto esso interrompe il tempo durante il quale il capitale può appropriarsi del tempo di lavoro altrui, ed è chiaro che questa relativa svalutazione del capitale non può aggiungere, ma soltanto togliere alla sua valorizzazione; oppure in quanto la circolazione costa al capitale tempo di lavoro altrui oggettivato, ossia valori. (Per esempio perché deve pagare un altro che si assuma questa funzione). In entrambi i casi il tempo di circolazione entra in considerazione solo in quanto è una soppressione, una negazione del tempo di lavoro altrui, sia che interrompa il processo di appropriazione del capitale, sia che costringa questo a consumare una parte del valore creato, a consumarlo per poter portare a termine le operazioni di circolazione, ossia per potersi porre come capitale (che è cosa molto diversa dal consumo privato del capitalista). Il tempo di circolazione entra in considerazione solo nel suo rapporto – come ostacolo, negazione – col tempo di produzione del capitale; ma questo tempo di produzione è il tempo durante il quale esso si appropria del lavoro altrui; è il tempo di lavoro altrui posto dal capitale. È somma confusione considerare il tempo sprecato dal capitalista nella circolazione come tempo che crea valore o addirittura plusvalore. Per il capitale in quanto tale non esiste tempo di lavoro al di fuori del suo tempo di produzione. Il capitalista qui non ci interessa assolutamente tranne che come capitale. E come tale la sua funzione si esplicita soltanto nel processo complessivo che noi dobbiamo considerare.
Fin qui si è assunto che il tempo di produzione coincide col tempo, di lavoro. Il problema va posto in maniera pura. Se il tempo di circolazione è il medesimo, la rotazione è meno frequente perché la fase di produzione è maggiore. Quindi il tempo usato per portare a compimento il prodotto, le interruzioni del lavoro, costituiscono qui delle condizioni di produzione. Il non-tempo di lavoro costituisce una condizione del tempo di lavoro, una condizione per fare realmente di quest’ultimo il tempo di produzione. È evidente che il problema trova la sua sede opportuna nel livellamento del tasso di profitto. Ma qui è necessario chiarirne il principio. Il ritorno più lento – questo è l’essenziale – non dipende qui dal tempo di circolazione, bensì dalle condizioni stesse entro le quali il lavoro diventa produttivo; esso rientra nelle condizioni tecnologiche del processo di produzione. Il valore, e quindi anche il plusvalore, non è = al tempo che dura la fase di produzione, bensì al tempo di lavoro, sia oggettivato che vivo, impiegato durante questa fase di produzione. Solo quest’ultimo – naturalmente nel rapporto in cui è impiegato rispetto a quello oggettivato – può creare plusvalore, perché è un tempo di lavoro supplementare. Il valore che il capitale crea in un’unica fase di circolazione, in un’unica rivoluzione, in una rotazione, è = al valore creato nel processo di produzione, ossia = al valore riprodotto + il nuovo valore. Che la rotazione la consideriamo compiuta nel punto in cui la merce è trasformata in denaro oppure nel punto in cui il denaro è ritrasformato in condizioni di produzione, il risultato, sia esso espresso in denaro oppure in condizioni di produzione, è sempre assolutamente uguale al valore creato nel processo di produzione.
La circolazione economica del prodotto comincia solo quando esso è sul mercato sotto forma di merce – soltanto allora esso circola. Il problema qui riguarda soltanto le differenze economiche, le determinazioni, i momenti della circolazione. Ciò che vogliamo anzitutto constatare è che i costi derivanti dal passaggio attraverso i diversi momenti economici in quanto tali, ossia i costi di circolazione in quanto tali, non aggiungono nulla al valore del prodotto, non sono costi che creano valore, quale che sia il lavoro che vi è connesso. Essi sono semplicemente delle detrazioni dal valore creato. I costi di circolazione, in quanto tali non creano valore, ma sono costi della realizzazione dei valori – detrazioni da questi. La circolazione è una serie di trasformazioni in cui il capitale si realizza, ma dal punto di vista del valore essa non gli aggiunge nulla, bensì lo pone nella forma del valore. Il valore potenziale che attraverso la circolazione viene trasformato in denaro, è presupposto come risultato del processo di produzione. Nella misura in cui questa serie di processi si svolge nel tempo e produce costi, cioè costa tempo di lavoro, o lavoro oggettivato, questi costi di circolazione rappresentano delle detrazioni dalla quantità del valore. Posti i costi di circolazione = 0, il risultato di una rotazione del capitale, dal punto di vista del valore, è = al valore creato nel processo di produzione. Il che vuol dire che il valore presupposto alla circolazione è quello che ne risulta. Al massimo può uscirne – per via dei costi di circolazione – uno inferiore a quello che vi è entrato. Visto da questo lato, il tempo di circolazione non aggiunge nulla al valore; il tempo di circolazione non è un tempo che crea valore accanto al tempo di lavoro.
I costi che questo processo, questa metamorfosi produce, rappresentano una detrazione dal valore della merce. La circolazione del capitale è la metamorfosi che il valore subisce attraversando diverse fasi. Il tempo che questo processo dura o costa ad essere impiantato, appartiene ai costi di produzione della circolazione, alla divisione del lavoro, alla produzione basata sullo scambio. Tutto ciò vale per una sola rotazione del capitale, ossia un solo passaggio del capitale attraverso questi suoi diversi momenti. Il processo del capitale in quanto valore ha il suo punto di partenza nel denaro e il suo punto di arrivo nel denaro, ma in una quantità accresciuta di denaro. La differenza è puramente quantitativa, D - M - M - D acquista cosi un contenuto. Se consideriamo la circolazione fino a questo punto, ci ritroviamo al punto di partenza. Il capitale
168

è ridiventato denaro. Ma nello stesso tempo esso ora è realizzato, ossia è diventata una condizione, per questo denaro, ridiventare capitale, denaro che, acquistando lavoro e passando attraverso il processo di produzione, si conserva e si moltiplica. La sua forma di denaro è posta come mera forma; una delle tante forme che esso via via assume nella sua metamorfosi. Se ora consideriamo questo punto non come punto di arrivo ma – come dobbiamo fare ora – come punto di passaggio o nuovo punto di partenza, esso stesso posto dal processo di produzione come punto di arrivo transitorio e come punto di partenza soltanto apparente, allora è chiaro che la ritrasformazione del valore posto come denaro in valore in processo, in valore che entra nel processo di produzione, ossia in rinnovamento del processo di produzione, può aver luogo solo quando è terminata la parte del processo di circolazione che si distingue dal processo di produzione.
La seconda rotazione del capitale – la ritrasformazione del denaro in capitale in quanto tale – o il rinnovarsi del processo di produzione, dipendono dal tempo che occorre al capitale per portare a termine la sua circolazione; ossia dipendono dal suo tempo di circolazione, distinto, qui, dal tempo di produzione. Ma poiché abbiamo visto che il valore complessivo creato dal capitale (valore riprodotto e valore creato ex novo), che viene realizzato nella circolazione in quanto tale, è determinato esclusivamente dal processo di produzione, la somma dei valori che possono essere creati in un periodo determinato di tempo dipenderà dal numero di ripetizioni del processo di produzione in tale periodo di tempo. La ripetizione del processo di produzione è però determinata dal tempo di circolazione, che è uguale alla velocità della circolazione. Più rapida è la circolazione, più breve è il tempo di circolazione, tanto più aumenta la frequenza di ripetizioni del processo di produzione di un medesimo capitale. In un determinato ciclo di rotazioni del capitale, dunque, la somma dei valori da esso creati (e quindi anche i plusvalori, giacché esso pone il lavoro necessario sempre come lavoro necessario soltanto ai fini del pluslavoro) è direttamente proporzionale al tempo di lavoro e inversamente proporzionale al tempo di circolazione.
Il tempo di circolazione, nella misura in cui determina la quantità complessiva del tempo di produzione in un dato periodo di tempo e da esso dipende la ripetizione del processo di produzione, cioè il suo rinnovamento in un periodo di tempo determinato, è perciò esso stesso un momento della produzione, o piuttosto si presenta come limite della produzione. La natura del capitale e della produzione basata su di esso consiste in questo: che il tempo di circolazione diventa un momento determinante ai fini del tempo di lavoro, ai fini della creazione del valore. L’autonomia del tempo di lavoro è con ciò negata, e il processo di produzione è posto come determinato dallo scambio, cosicché il rapporto sociale, e la dipendenza di questo rapporto nella produzione immediata, è posto non solo come momento materiale, ma come momento economico, come determinazione formale. Il massimo di circolazione – il limite che essa pone al rinnovamento del processo di produzione – è evidentemente determinato dalla durata del tempo di produzione durante una rotazione. È chiaro perciò che il tempo di circolazione, considerato in assoluto, è una detrazione dal massimo di valorizzazione, è < della valorizzazione assoluta. E se è così, è impossibile che una qualsiasi velocità di circolazione o una qualsiasi riduzione del tempo di circolazione possa mai creare una valorizzazione > di quella creata dalla fase di produzione stessa. Il massimo effetto della velocità di circolazione, se aumentasse a ∞, potrebbe essere quello di porre il tempo di circolazione = 0, ossia di sopprimere se stessa. Essa dunque non può essere un momento positivamente creatore di valore, giacché la sua soppressione – circolazione senza tempo di circolazione – equivarrebbe al massimo di valorizzazione, la sua negazione equivarrebbe alla massima creazione di produttività del capitale. Circolazione senza tempo di circolazione – ossia il passaggio del capitale da una fase all’altra con la stessa rapidità del concetto – sarebbe il massimo. È tendenza necessaria del capitale mirare a porre il tempo di circolazione = 0, ossia a sopprimere se stesso, giacché è soltanto in virtù del capitale che il tempo di circolazione è posto come momento determinante del tempo di produzione. Il che equivale a sopprimere la necessità dello scambio, del denaro, e della divisione del lavoro che su di essi si basa, ossia il capitale stesso. Sembra dunque che il volume del capitale possa essere sostituito dalla velocità della circolazione, e che la velocità della circolazione possa esserlo dal volume del capitale. Dal che nasce l’impressione che il tempo di circolazione sia in se stesso produttivo. È opportuno quindi chiarire la questione che questo caso pone.
Come mezzi atti ad accelerare la circolazione Storch enumera: 1) formazione di una classe di “lavoratori” che si occupi soltanto del commercio; 2) facilità di mezzi di trasporto; 3) denaro; 4) credito. Da questo variopinto assortimento emerge tutta la confusione degli economisti politici. Denaro e circolazione del denaro – che noi abbiamo chiamato qui circolazione semplice – sono un presupposto, una condizione sia del capitale stesso che della circolazione del capitale. Del denaro quale esiste, cioè quale rapporto di circolazione relativo a un livello di produzione precedente al capitale, del denaro in quanto denaro, nella sua forma immediata, non può perciò dirsi che acceleri la circolazione del capitale quando invece ne è un presupposto: il denaro, ben lungi dall’accelerare la circolazione del capitale, anzi la frena. Il denaro, considerato nell’uno e nell’altro senso, così come si riscontra nella circolazione del capitale, e cioè sia come mezzo di circolazione che come valore realizzato del capitale, appartiene ai costi di circolazione, nella misura in cui esso stesso è un tempo di lavoro impiegato da una parte per ridurre il tempo di circolazione, dall’altra per rappresentare un
169

momento qualitativo della circolazione – ritrasformazione del capitale in se stesso quale valore per se stante. Sia nell’uno che nell’altro senso esso non aumenta il valore. Nell’un senso esso è una forma – costosa, che costa tempo di lavoro, e quindi deduce dal plusvalore – di rappresentazione del valore. Nell’altro senso esso può esser considerato come una macchina che risparmia tempo di circolazione, liberando così del tempo ai fini della produzione. In quanto già in questo suo aspetto di macchina costa lavoro ed è un prodotto del lavoro, esso rappresenta, nei confronti del capitale, faux frais de production. Esso figura tra i costi di circolazione.
La circolazione originaria è il tempo di circolazione stesso in opposizione al tempo di lavoro. I costi di circolazione reali sono essi stessi tempo di lavoro oggettivato – macchine destinate a ridurre i costi originari del tempo di circolazione. Il denaro nella sua forma immediata, inerente cioè a un livello storico della produzione precedente al capitale, si presenta dunque, al capitale, come costo di circolazione, sì che la tendenza del capitale è quella di trasfigurarselo in maniera adeguata; di farne perciò il rappresentante di un momento della circolazione il quale non costi tempo di lavoro, non sia esso stesso dotato di valore. Il capitale perciò è indirizzato a sopprimere il denaro nella sua realtà tradizionale, immediata, e a trasformarlo in qualcosa di posto e altresì soppresso soltanto dal capitale, in qualcosa di puramente ideale. Non si può dunque dire, come fa Storch, che il denaro sia in generale un mezzo di accelerazione della circolazione del capitale; bisogna dire invece viceversa che il capitale cerca di trasformarlo in un momento meramente ideale della sua circolazione per giungere a sollevarlo alla forma adeguata a esso corrispondente. La soppressione del denaro nella sua forma immediata si presenta come un postulato della circolazione del denaro divenuta momento della circolazione del capitale, perché nella sua forma immediatamente presupposta esso costituisce un ostacolo alla circolazione del capitale. Circolazione senza tempo di circolazione è la tendenza del capitale; e perciò anche trasposizione degli strumenti che servono soltanto a ridurre il tempo di circolazione, in semplici determinazioni formali poste dal capitale, cosi come i distinti momenti che il capitale attraversa nella circolazione sono delle determinazioni qualitative della propria metamorfosi.
[LF. q.VI, ff.21,34,37]
II.3.2. La circolazione materiale
Il capitale, per sua natura, tende a superare ogni ostacolo spaziale. La creazione delle condizioni fisiche dello scambio – ossia dei mezzi di trasporto e di comunicazione – diventa dunque per esso una necessità, ma in tutt’altra misura: diventa l’annullamento dello spazio per mezzo del tempo. Se il prodotto immediato può essere valorizzato in massa su mercati distanti solo nella misura in cui diminuiscono i costi di trasporto, se d’altra parte mezzi di comunicazione e trasporto a loro volta non possono avere altra funzione che quella di essere sfere della valorizzazione, del lavoro gestito dal capitale; se insomma esiste un commercio di massa – attraverso cui viene reintegrato più del lavoro necessario – la produzione di mezzi di comunicazione e di trasporto a buon mercato è una condizione della produzione basata sul capitale, ed è per questo motivo che il capitale la promuove. Ogni lavoro richiesto per mettere in circolazione il prodotto finito – il quale si trova in circolazione economica solo quando è rinvenibile sul mercato – è, dal punto di vista del capitale, un ostacolo da superare, cosi come lo è ogni lavoro richiesto come condizione del processo di produzione (per esempio, i costi per la sicurezza dello scambio, ecc.). Le vie d’acqua sono le vie mobili naturali dei popoli mercantili per antonomasia. D’altra parte le strade di comunicazione sono originariamente a carico della comunità, e più tardi per lungo tempo a carico dei governi, sotto forma di ritenute nette sulla produzione a partire dal plusprodotto collettivo del paese, ma non costituiscono una fonte della sua ricchezza, vale a dire non coprono ì loro costi di produzione.
La costruzione di strade mediante il lavoro servile, oppure – ed è una diversa forma – mediante le imposte, rappresenta una trasformazione coattiva di una parte del pluslavoro o del plusprodotto del paese in strade. Affinché il singolo capitale si assuma questo compito, di costruire cioè le condizioni esterne del processo di produzione diretto – è necessario che il lavoro si valorizzi. Supponiamo una data strada tra A e B (il cui terreno non costi nulla). Ebbene essa non contiene altro che una determinata quantità di lavoro, e quindi valore. Che sia il capitalista o lo stato a costruirla, fa lo stesso. Questo problema naturalmente esiste riguardo a qualsiasi prodotto, ma assume una forma particolare quando si tratta delle condizioni generali della produzione. Poniamo che il valore della strada non si valorizzi. Che la costruzione avvenga mediante lavoro servile o mediante imposte, fa lo stesso. Ma essa viene costruita solo perché è un valore d’uso necessario alla comunità, perché questa ne ha bisogno à tout prix. Qui c’è senza dubbio un pluslavoro che il singolo deve fare, non importa se sotto la forma diretta del lavoro servile oppure in quella indiretta delle imposte sul lavoro immediato che è necessario alla sua sussistenza. Considerando l’intera società come un unico individuo, il lavoro necessario consisterebbe nella somma, di tutte quelle abilità lavorative. Nell’ambito di questi bisogni e lavori necessari si verifica una continua variazione quantitativa. Quanto più i
170

bisogni storici – i bisogni prodotti dalla stessa produzione, i bisogni sociali, quelli che sono emanazione della stessa produzione e delle relazioni sociali – sono posti come necessari, tanto più alto è lo sviluppo della ricchezza reale.
Può capitare per esempio che il concime possa essere procurato solo esportando articoli di seta. Ed ecco allora che la manifattura delle sete non figura più come un’industria di lusso, ma come un’industria necessaria all’agricoltura. Se dunque ciò che prima figurava come un lusso è ora una necessità, e i cosiddetti bisogni di lusso per esempio figurano come una necessità per l’industria più elementare, sorta per soddisfare le necessità più puramente naturali, ciò è dovuto principalmente e sostanzialmente al fatto, in questo caso, che l’agricoltura non ritrova più in sé, spontaneamente, le condizioni della propria produzione, ma anzi questa esiste al di fuori di essa come industria autonoma – e con questa sua esistenza esterna anche tutto il complesso sistema in cui vive questa industria estranea viene assorbito nella sfera delle condizioni di produzione dell’agricoltura. Questa emigrazione del settore naturale verso il settore di ciascuna industria, e questo trasferimento delle sue condizioni di produzione al di fuori di essa in un contesto generale – e perciò la trasformazione di ciò che si presentava come superfluo in necessario, in una necessità storicamente prodotta – è la tendenza del capitale. La base generale di tutte le industrie diventa lo scambio generale stesso, il mercato mondiale e quindi l’insieme delle attività, delle relazioni, dei bisogni ecc. di cui questo è costituito. Lusso è l’opposto di naturalmente necessario.
Ritorniamo ora alla nostra strada. Il fatto stesso che essa possa essere costruita dimostra che la società dispone del tempo di lavoro (lavoro vivo e lavoro oggettivato) per costruirla. Perché allora, non appena subentra la produzione basata sul valore di scambio e la divisione del lavoro, la costruzione di strade non diventa affare privato dei singoli? E là dove viene gestita dallo stato tramite le imposte, non lo è. D’abord: la società, ossia i singoli individui associati, possono disporre del tempo supplementare per costruire la strada, ma solo se sono associati. Il capitale produce la medesima associazione in altra maniera, attraverso il suo modo di scambiare col lavoro libero. Che il capitale non abbia a che fare col lavoro isolato, ma con quello combinato, così come esso è in sé e per sé già una forza sociale, combinata, è un punto, questo, che forse andrebbe trattato già qui nella storia generale della genesi del capitale. Può formarsi una classe speciale di costruttori di strade, che viene impiegata dallo stato, oppure, a tale scopo, viene adoperata una parte della popolazione occasionalmente disoccupata, con un certo numero di architetti ecc., i quali però non lavorano come capitalisti ma come servi [domestici] altamente specializzati (sulla situazione di questo lavoro tecnicamente sviluppato ecc., si vedrà in seguito). I lavoratori sono allora lavoratori salariati, ma lo stato non li impiega come tali, ma come umili servi [menial servants] Affinché il capitalista si assuma la costruzione della strada a sue spese , occorrono diverse condizioni, le quali coincidono tutte con un più alto livello di sviluppo del modo capitalistico di produzione; si presuppone un volume di capitale, del capitale concentrato nelle sue mani, tale da poter intraprendere lavori di siffatta dimensione e di cosi lenta rotazione e valorizzazione. Occorre quindi soprattutto un capitale azionario, che è la forma ultima in cui il capitale si è elaborato, nella quale esso è non solo in sé, per la sua sostanza, ma è posto nella sua forma come forza e prodotto sociali.
Se lo stato fa eseguire simili faccende attraverso appalti pubblici, ciò tuttavia avviene pur sempre mediante lavoro servile o imposte. Fatto principale rimangono però i due presupposti: 1. un capitale, utilizzabile a questo scopo nella massa richiesta, che si accontenta dell’interesse; 2. pagare il prezzo per una strada deve significare una valorizzazione per i capitali produttivi, per il capitale industriale. Il capitale in quanto tale – supposto che esista nella quantità necessaria – produrrà strade solo quando la produzione di strade è diventata una necessità per i produttori, e specialmente per il capitale produttivo; ossia una condizione per la realizzazione del profitto del capitalista. Allora anche la strada rende. Ma in questi casi si presuppone che già esista un traffico piuttosto ampio. Si tratta del medesimo presupposto, in duplice forma: da un lato la ricchezza del paese concentrata e trasformata nella forma di capitale in quantità sufficiente da intraprendere tali lavori come processi di valorizzazione del capitale; dall’altro un volume di traffico, e una consapevolezza degli ostacoli rappresentati dalla mancanza di mezzi di comunicazioni, l’una e l’altro sufficienti a far sì che il capitalista possa realizzare il valore della strada (gradualmente nel tempo) in quanto strada (vale a dire la sua utilizzazione). Tutte le condizioni generali della produzione, come strade, canali ecc., sia che esse facilitino la circolazione o la rendano addirittura possibile, oppure aumentino la produttività (come le irrigazioni ecc, che in Asia e del resto ancora in Europa, sono attuate dai governi), presuppongono, per essere intraprese dal capitale invece che dal governo che rappresenta la comunità come tale, un altissimo sviluppo della produzione capitalistica. L’abbandono dei travaux publics da parte dello stato e il loro passaggio nel dominio dei lavori intrapresi dal capitale stesso, denuncia il grado in cui la comunità reale si è costituita nella forma del capitale.
Il capitale allora la scarica sulle spalle dello stato, oppure, dove lo stato occupa ancora tradizionalmente una posizione superiore rispetto al capitale, esso possiede ancora il privilegio e la volontà di costringere la collettività [a devolvere] una parte del suo reddito, non del suo capitale, in questi lavori di pubblica utilità, i
171

quali al tempo stesso figurano come condizioni generali della produzione, e perciò non come condizione particolare per un capitalista qualsiasi; e fintantoché il capitale non assume la forma di società per azioni, esso cerca sempre soltanto le condizioni particolari della propria valorizzazione, rimettendo quelle collettive all’intero paese come bisogni nazionali. Del resto lo stato stesso e tutto ciò che direttamente o indirettamente ne dipende fa parte di queste detrazioni sul reddito, di questi, per cosi dire, costi di consumo per il singolo, che sono costi di produzione per la società. Anche una strada può aumentare talmente le capacità produttive, da creare un traffico attraverso il quale essa finisce col rendere. Possono occorrere lavori e spese, senza essere produttivi nel senso del capitale, ossia senza che il pluslavoro in essi contenuto si realizzi, attraverso la circolazione, attraverso lo scambio, come plusvalore.
Il capitale raggiunge il suo più alto sviluppo quando le condizioni generali del processo sociale di produzione non vengono create traendole dal prelievo del reddito sociale, dalle imposte pubbliche – dove è il reddito, e non il capitale, che figura come fondo di lavoro, e il lavoratore, pur essendo salariato libero come chiunque altro, tuttavia dal punto di vista economico è in un rapporto diverso – ma dal capitale in quanto capitale. Ciò denuncia da un lato il grado in cui il capitale ha subordinato a sé tutte le condizioni della produzione sociale, e perciò, dall’altro, il grado in cui la ricchezza riproduttiva sociale è capitalizzata e tutti i bisogni vengono soddisfatti nella forma dello scambio. È possibilissimo che esista un tempo di lavoro supplementare e che non venga pagato (cosa che può ben capitare a qualsiasi capitalista singolo). Dove il capitale domina (proprio come là dove c’è schiavitù e servitù della gleba o prestazione servile di qualsiasi genere) il tempo di lavoro assoluto del lavoratore è posto per lui come una condizione per poter lavorare quello necessario, cioè per poter realizzare il lavoro necessario al mantenimento della sua forza-lavoro, in valori d’uso. In ogni specie di lavoro quindi la concorrenza comporta per lui la necessità di lavorare tutto il tempo – comporta cioè il tempo di pluslavoro.
Tuttavia può darsi il caso che questo tempo di lavoro supplementare, sebbene contenuto nel prodotto, non sia scambiabile. Per il lavoratore – cosi come per gli altri salariati – si tratta di pluslavoro. Per colui che lo impiega, si tratta invece di lavoro che, se per lui ha certamente un valore d’uso, come lo ha per esempio il suo cuoco, non ha invece alcun valore di scambio, sicché tutta la distinzione tra tempo di lavoro necessario e tempo di pluslavoro non esiste. Il lavoro può essere necessario senza essere produttivo. Per creare tutte le condizioni generali, collettive della produzione – fintantoché esse non possono essere create dal capitale in quanto tale, sotto le sue condizioni – si ricorre allora ad una parte del reddito nazionale, all’erario pubblico, e i lavoratori allora non figurano come lavoratori produttivi, sebbene aumentino la produttività del capitale. Il risultato di questo excursus è insomma che la produzione di mezzi di comunicazione, ossia delle condizioni fisiche della circolazione, rientra sotto la categoria della produzione di capitale fisso, e perciò non costituisce alcun caso speciale. Solo che, parallelamente, ci si è aperta la prospettiva – che a questo punto non è ancora possibile delineare rigorosamente – di uno specifico rapporto tra il capitale e le condizioni generali, collettive, della produzione sociale, a differenza di quelle del capitale particolare e del suo particolare processo di produzione.
[LF. q.V, f.20]
II.3.3. La metamorfosi delle funzioni del capitale
Il processo ciclico del capitale si attua in tre stadi, i quali, formano le seguente serie:Primo stadio: il capitalista appare sul mercato delle merci e sul mercato del lavoro come compratore; il
suo denaro viene convertito in merce, ossia compie l’atto di circolazione D—M.Secondo stadio; consumo produttivo da parte del capitalista delle merci acquistate. Egli opera come
produttore capitalistico di merci; il suo capitale compie il processo di produzione. Il risultato è: merce di valore maggiore di quello dei suoi elementi di produzione.
Terzo stadio: il capitalista si ripresenta sul mercato come venditore; la sua merce viene convertita in denaro, ossia compie l’atto di circolazione M—D.
La formula per il ciclo del capitale monetario è dunque: D—M ... P ... M’—D’ nella quale i puntini indicano l’interruzione del processo di circolazione e M’ e D’ contrassegnano M e D accresciuti di plusvalore. La trasformazione di capitale monetario in capitale produttivo è acquisto di merci per la produzione dì merci [e precisamente per la produzione capitalistica di merci]. Solo in quanto il consumo è questo consumo produttivo, esso cade nel ciclo del capitale stesso; la sua condizione è che, mediante le merci cosi consumate, venga creato plusvalore. E ciò è qualcosa di assai differente dalla produzione e anche, dalla produzione di merci, il cui scopo è l’esistenza dei produttori; una sostituzione di merce con merce, condizionata così da produzione dì plusvalore, è qualcosa di completamente diverso da quel che è in sé uno scambio di prodotti, mediato solo dal denaro. Così invece viene intesa la cosa da parte degli economisti, a dimostrazione che non è possibile una sovraproduzione.
172

I. Primo stadio D—MD—M rappresenta la conversione di una somma di denaro in una somma di merci. Se chiamiamo L la
forza-lavoro, Pm i mezzi di produzione, la somma di merci da comperare è M=L+Pm, o, più brevemente, M<L e M<Pm. Considerato secondo il suo contenuto, D—M si presenta dunque come D—M<Pm< cioè D—M<L e <Pm si suddivide in D—L e D—Pm; la somma di denaro D si scinde in due parti, l’una delle quali acquista forza-lavoro, l’altra mezzi di produzione. Queste due serie di compere appartengono a mercati completamente differenti, l’una al mercato delle merci in senso stretto, l’altra al mercato del lavoro. Oltre a questa scissione qualitativa della somma dì merci, nella quale D viene convertito, D—M<L e <Pm
rappresenta però anche un rapporto quantitativo sommamente caratteristico. D—M<L e <Pm, ossia, secondo la sua forma generale D—M, somma di acquisti di merci, questo processo della circolazione generale delle merci è perciò insieme, come stadio nel processo ciclico autonomo del capitale, trasformazione del valore-capitale dalla sua forma di denaro alla sua forma produttiva, o, più brevemente, trasformazione di capitale monetario in capitale produttivo. Nella figura del ciclo qui esaminata per prima, il denaro appare dunque come il primo depositario del valore-capitale, perciò il capitale monetario appare come la forma nella quale viene anticipato il capitale.
D—L è il momento caratteristico della trasformazione di capitale monetario in capitale produttivo, poiché è la condizione essenziale Affinché il valore anticipato sotto forma di denaro si trasformi realmente in capitale, in valore producente plusvalore. Ma piuttosto iu virtù della sua forma, poiché nella forma del salario il lavoro viene acquistalo con denaro, e questo passa per segno distintivo dell’economia monetaria. Anche qui ciò che è considerato caratteristico non è l’irrazionale della forma. Questo irrazionale viene piuttosto trascurato. L’irrazionale consiste in ciò, che il lavoro, come elemento creatore di valore, non può esso stesso possedere un valore, dunque anche una determinata quantità di lavoro non può avere un valore che si esprima nel suo prezzo, nella sua equivalenza con una determinata quantità di denaro.
II. Secondo stadio. Funzione del capitale produttivoIl ciclo del capitale qui esaminato ha inizio con l’atto di circolazione D—M, trasformazione del denaro in
merce, compera. La circolazione, dunque, deve venire completata dall’opposta metamorfosi M—D, trasformazione di merce in denaro, vendita. Ma il risultalo immediato di D—M<L e <Pm è l’interruzione della circolazione del valore-capitale anticipato in forma di denaro. Attraverso la trasformazione di capitale monetario in capitale produttivo, il valore-capitale ha assunto una forma naturale nella quale non può continuare a circolare, ma deve passare nel consumo, e propriamente nel consumo produttivo. L’uso della forza-lavoro – il lavoro – può essere realizzato solo nel processo lavorativo.
Quali che siano le forme sociali della produzione, lavoratori e mezzi di produzione restano sempre i suoi fattori. Ma gli unì e gli altri sono tali soltanto in potenza nel loro stato di reciproca separazione. Perché in generale si possa produrre, essi si devono unire. Il modo particolare nel quale viene realizzata questa unione distingue le varie epoche economiche della struttura della società. Nel caso attuale, la separazione del libero lavoratore dai suoi mezzi di produzione è il punto di partenza dato, ed abbiamo visto come e a quali condizioni entrambi vengano riuniti nelle mani del capitalista, cioè come modo produttivo di esistenza del suo capitale. Il processo reale, nel quale insieme confluiscono i fattori personali e i fattori oggettivi della produzione di merci così riuniti, il processo produttivo, diviene perciò esso stesso una funzione del capitale, processo capitalistico di produzione.
III. Terzo stadio M’—D’La merce diviene capitale-merce come forma funzionale di esistenza del valore-capitale già valorizzato,
scaturita direttamente dallo stesso processo di produzione. Nella sua forma di merce, il capitale deve adempiere funzioni di merce. Gli articoli dei quali esso si compone, fin dall’origine prodotti per il mercato, devono essere venduti, trasformati in denaro, percorrere dunque il movimento M—D.
La funzione di M’ è ora quella di ogni prodotto-merce: trasformarsi in denaro, essere venduto, compiere la fase della circolazione M—D. Fino a che il capitale ora valorizzato perdura nella forma di capitale-merce, giace fermo sul mercato, il processo di produzione si arresta. Il capitale non opera come creatore di prodotto né come creatore di valore. Secondo il diverso grado di velocità con cui il capitale respinge la sua forma di merce e assume la sua forma di denaro, ossia secondo la rapidità della vendita, lo stesso valore-capitale, in grado assai differente, servirà come creatore di prodotto e di valore, e la scala della riproduzione si estenderà o si restringerà. Con il compimento di M’—D’, viene realizzato tanto il valore-capitale anticipato quanto il plusvalore. Il realizzo di ambedue coincide nella serie di vendite, ovvero anche nella vendita in un sol blocco dell’intera massa di merci, che M’—D’ esprime. Ma il medesimo processo di circolazione M’—D’ è differente per il valore-capitale o per il plusvalore, in quanto per ciascuno dei due esprime un differente stadio della loro circolazione, una sezione differente nella serie di metamorfosi che essi devono attraversare all’interno della circolazione.
173

Il plusvalore m è venuto alla luce solo entro il processo dì produzione. Esso compare dunque per la prima volta sul mercato delle merci, e precisamente in forma di merce; questa è la sua prima forma di circolazione, perciò anche l’atto m—d è il suo primo atto di circolazione, o la sua prima metamorfosi, che resta dunque ancora da completare mediante l’opposto atto della circolazione, ossia la metamorfosi inversa d—m. Diversamente avviene per la circolazione che il valore-capitale M compie nel medesimo atto di circolazione M’—D’, che per esso è l’atto di circolazione M—D, nel quale M=P, uguale al D originariamente anticipato. Esso ha iniziato il suo primo atto di circolazione come D, come capitale monetario, e attraverso l’atto M—D ritorna alla medesima forma; ha dunque percorso le due opposte fasi della circolazione: 1. D—M e 2. M—D e si trova ancora una volta nella forma da cui può di nuovo incominciare il medesimo processo ciclico. Ciò che per il plusvalore è la prima trasformazione della forma di merce in forma di denaro, per il valore-capitale è ritorno, ossia ritrasformazione nella sua originaria forma di denaro. Il medesimo atto di circolazione M’—D’, che è per il valore-capitale anticipato in denaro la seconda conclusiva metamorfosi, ritorno alla forma di denaro, è invece per il plusvalore, assieme a quello racchiuso nel capitale-merce e realizzato mediante la sua conversione in forma di denaro, la prima metamorfosi, trasformazione da forma di merce in forma di denaro, M—D, prima fase della circolazione.
Ci sono dunque qui due cose da osservare. Primo: la ritrasformazione conclusiva del valore-capitale nella sua originaria forma di denaro è una funzione del capitale-merce. Secondo: questa funzione comprende la prima trasformazione del plusvalore dalla sua originaria forma di merce in forma di denaro. La forma di denaro sostiene dunque qui una doppia parte: da un lato è la forma ricorrente di un valore originariamente anticipato in denaro, dunque ritorno alla forma di valore che aprì il processo; è, d’altro lato, la prima forma trasformata di un valore che originariamente entra in circolazione in forma di merce. In D’ il capitale è tornato nuovamente alla sua forma originaria D, alla sua forma di denaro; ma in una forma nella quale esso è realizzato come capitale.
IV. Il ciclo complessivo.Esaminiamo ora l’intero movimento D—M ... P... M’—D’, ovvero la sua forma sviluppata D—M <
L\Pm ... P... M’ (M+m)—D’ (D+d). Il capitale appare qui come un valore che percorre una serie di trasformazioni concatenate, reciprocamente condizionate, una serie di metamorfosi che formano altrettante fasi o stadi di un processo complessivo. Due di queste fasi appartengono alla sfera della circolazione, una alla sfera della produzione. In ciascuna di queste fasi, il valore-capitale si trova in figura differente, cui corrisponde una differente, speciale funzione. Dentro questo movimento, il valore-capitale anticipato non soltanto si conserva, ma cresce, aumenta la sua grandezza. Infine, nello stadio finale, esso ritorna alla stessa forma in cui era apparso all’inizio del processo complessivo. Questo processo complessivo è perciò un processo ciclico.
Le due forme che il valore-capitale assume entro i suoi stadi di circolazione, sono quelle del capitale monetario e del capitale-merce; la sua forma appartenente allo stadio di produzione è quella di capitale produttivo. Il capitale che nel corso del suo ciclo complessivo assume e di nuovo abbandona queste forme e in ciascuna assolve la funzione ad essa corrispondente, è capitale industriale, industriale qui nel senso che abbraccia ogni ramo della produzione condotto capitalisticamente. Capitale monetario, capitale-merce, capitale produttivo non indicano dunque qui specie autonome di capitale, le cui funzioni costituiscano il contenuto di branche parimenti autonome e separate le une dalle altre. Esse indicano qui soltanto particolari forme di funzione del capitale industriale, il quale le assume successivamente tutte e tre. Il ciclo del capitale procede normalmente solo fino a che le sue differenti fasi trapassano una nell’altra senza ristagno. Se il capitale ristagna nella prima fase D—M, il capitale monetario si irrigidisce in tesoro; se ristagna nella fase della produzione, i mezzi di produzione da una parte rimangono senza funzione, mentre la forza-lavoro, dall’altra, rimane inattiva; se nell’ultima fase M’—D’, le merci ammucchiate senza poter essere vendute ostruiscono il flusso della circolazione.
Il capitale industriale è l’unico modo di essere del capitale in cui funzione del capitale non sia soltanto l’appropriazione di plusvalore, rispettivamente di plusprodotto, ma contemporaneamente la sua creazione. Esso è perciò la condizione del carattere capitalistico della produzione; la sua esistenza implica quella del-l’antagonismo di classe tra capitalisti e lavoratori salariati. Nella misura in cui esso si impadronisce della produzione sociale, vengono sovvertite la tecnica e l’organizzazione sociale del processo lavorativo, e con ciò il tipo economico-storico della società. Capitale monetario e capitale-merce, in quanto con le loro funzioni compaiono accanto al capitale industriale come depositari di branche proprie, ormai soltanto per la divisione sociale del lavoro sono modi di esistenza, resi autonomi e sviluppati in senso unilaterale, delle differenti forme di funzione che il capitale industriale ora assume, ora abbandona entro la sfera della circolazione. Se consideriamo infine D—M ... P ... M’—D’ come forma speciale del processo ciclico del capitale accanto alle altre forme da esaminare in seguito, esso si caratterizza per ciò che segue.
Esso appare come ciclo del capitale monetario, perché il capitale industriale nella sua forma di denaro, come capitale monetario, costituisce il punto di partenza ed il punto di ritorno del suo processo complessivo.
174

La formula stessa indica che il denaro non viene qui speso in quanto denaro ma soltanto anticipato, dunque è solo forma di denaro del capitale, capitale monetario. Essa indica inoltre che il valore di scambio, non il valore d’uso, è il fine assoluto determinante del movimento. Proprio perché la figura di denaro del valore è la sua forma fenomenica autonoma, tangibile, la forma della circolazione D...D’, il cui punto di partenza e punto di arrivo è denaro vero e proprio, esprime nella maniera più tangibile il far denaro, il motivo conduttore della produzione capitalistica. Il processo di produzione appare soltanto come termine medio inevitabile, come male necessario per far denaro. Tutte le nazioni a produzione capitalistica vengono colte perciò periodicamente da una vertigine, nella quale vogliono fare denaro senza la mediazione del processo di produzione. Il processo ciclico del capitale è dunque unità di circolazione e produzione, esso include ambedue. In quanto le due fasi D—M e M’—D’ sono processi della circolazione, la circolazione del capitale fa parte della circolazione generale delle merci. Il ciclo del capitale monetario è perciò la forma fenomenica più unilaterale, quindi più evidente e caratteristica del ciclo del capitale industriale, il cui scopo e motivo conduttore, la valorizzazione del valore, il far denaro e l’accumulazione, si presenta in modo che balza agli occhi (comprare per rivendere più caro). La formula D—M ... P ... M’—D’ con il risultato D’=D+d, racchiude nella sua forma un inganno, reca un carattere illusorio, che scaturisce dalla presenza del valore anticipato e valorizzato nella sua forma di equivalente, il denaro. L’accento non poggia sulla valorizzazione del valore, ma sulla forma di denaro di questo processo, sul fatto che alla fine viene ritirato dalla circolazione più valore in forma di denaro di quanto non fosse in essa originariamente anticipato.
Il ciclo del capitale produttivo ha la formula generale: P ... M’—D’—M ... P. Esso indica la funzione periodicamente rinnovata del capitale produttivo, dunque la riproduzione, ossia il suo processo di produzione come processo di riproduzione in rapporto alla valorizzazione: non soltanto produzione, ma periodica riproduzione di plusvalore, la funzione del capitale industriale che si trova nella sua forma produttiva. Affinché il ciclo si compia normalmente, M’ deve essere venduto al suo valore e nella sua totalità. Di fatto, però, i valori dei mezzi di produzione variano; è proprio della produzione capitalistica appunto la continua variazione dei rapporti di valore, già mediante la variazione costante nella produttività del lavoro, che caratterizza la produzione capitalistica: è dunque presupposto non solo che le merci vengano comprate [e vendute] al loro valore, ma anche che durante il ciclo non subiscano alcuna variazione di valore; diversamente il processo non può svolgersi normalmente. I capitali-merce si contendono reciprocamente il loro posto sul mercato. Per vendere, gli ultimi arrivati vendono al di sotto del prezzo. I flussi precedenti non sono ancora stati resi liquidi, mentre scadono i termini di pagamento. I loro possessori devono dichiararsi insolventi, ovvero vendere a qualunque prezzo, per pagare. Questa vendita non ha assolutamente nulla a che fare con lo stato reale della domanda. Essa ha a che fare solo con la domanda di pagamento, con l’assoluta necessità di trasformare merce in denaro. Allora scoppia la crisi. Essa diventa visibile non nella immediata diminuzione della domanda di consumo, della domanda per il consumo individuale, ma nella diminuzione dello scambio di capitale con capitale, del processo di riproduzione del capitale.
D’ in quanto pura e semplice conclusione di D...D’, così come M’ quale appare entro tutti questi cicli, presi per sé esprimono non il movimento ma il suo risultato. Ma né nella forma M’ né nella forma D’, la valorizzazione che ha avuto luogo è essa stessa una funzione, sia del capitale monetario sia del capitale-merce. In quanto particolari, differenti forme, modi di essere che corrispondono a funzioni particolari del capitale industriale, il capitale monetario può compiere solo funzioni di denaro, il capitale-merce solo funzioni di merce, la differenza tra di loro è unicamente quella tra denaro e merce; il processo di produzione stesso si presenta come funzione produttiva del capitale industriale, così denaro e merce si presentano quali forme di circolazione dello stesso capitale industriale, dunque anche le loro funzioni quali sue funzioni di circolazione, che introducono le funzioni del capitale produttivo o ne scaturiscono. Solo attraverso la loro connessione come forme della funzione che il capitale industriale deve assolvere nei differenti stadi del suo processo ciclico, la funzione di denaro e la funzione di merce sono qui contemporaneamente funzione di capitale monetario e di capitale-merce, È dunque errato voler ricavare le proprietà e funzioni specifiche che caratterizzano il denaro in quanto denaro e la merce in quanto merce dal loro carattere di capitale, e altrettanto errato è, inversamente, voler derivare le proprietà del capitale produttivo dal suo modo di esistere nei mezzi di produzione.
[C. II,1-3]
II.3.4. Il processo complessivo della circolazione
La formula generale per il ciclo del capitale-merce è: M’—D’—M ... P ... M’. M’ appare non solo come prodotto, ma anche come presupposto di entrambi i cicli precedenti, poiché ciò
che per un capitale implica D—M, per l’altro implica già M’—D’, almeno in quanto una parte dei mezzi di produzione è essa stesso il prodotto-merce di altri capitali individuali che si trovano nel loro ciclo. M’ in
175

quanto M appare nel ciclo di un singolo capitale industriale non come forma di questo capitale ma come forma di un altro capitale industriale, in quanto i mezzi di produzione sono il prodotto di questo. L’atto D—M (cioè D—Pm) del primo capitale è, per questo secondo capitale, M’—D’. Nella forma M’ ... M’ il consumo dell’intero prodotto-merce è già presupposto come condizione del normale svolgimento del ciclo del capitale. Ma appunto perché il ciclo M’ ... M’ entro il suo percorso presuppone altro capitale industriale nella forma di M (=L+Pm) (e Pm comprende altri capitali di diversa specie), induce a considerarlo non solo come forma generale del ciclo, cioè come una forma sociale, nella qual forma può essere considerato ogni singolo capitale industriale (eccetto che nel suo primo investimento), perciò non soltanto come una forma di movimento comune a tutti i capitali industriali individuali, ma contemporaneamente come forma di movimento della somma dei capitali individuali, dunque del capitale complessivo della classe dei capitalisti.
Le tre figure possono essere rappresentate, se Ct sta per il processo della circolazione totale:I) D-M ... P ... M’—D’ II) P ... Ct ... P III) Ct ... P (M’)Se riassumiamo tutte e tre le forme, tutti i presupposti del processo appaiono come un suo risultato, come
un presupposto da esso stesso prodotto [e tutti i suoi risultati appaiono come suoi presupposti]. Ciascun momento appare come punto di partenza, punto intermedio e punto di ritorno, il processo totale si presenta come unità di processo di produzione e processo di circolazione; il processo di produzione diviene mediatore del processo di circolazione e viceversa. A tutti e tre i cicli è comune la valorizzazione del valore come scopo determinante, e come motivo propulsore. Se però non ci si arresta a questo lato formale, ma si considera il nesso reale delle metamorfosi dei differenti capitali individuali, dunque, di fatto, il nesso dei cicli dei capitali individuali come movimenti parziali del processo di riproduzione del capitale sociale complessivo, questo nesso non può essere spiegato dal puro a semplice scambio di forma tra denaro e merce.
In quanto ciascuno di questi cicli viene considerato come forma particolare del movimento in cui si trovano differenti capitali industriali individuali, anche questa differenza esiste sempre soltanto come differenza individuale. In realtà, però, ogni capitale industriale individuale si trova contemporaneamente in tutti e tre. 1 tre cicli, le forme di riproduzione delle tre figure del capitale, si compiono continuamente l’uno acconto all’altro. Una parte del valore-capitale, ad es., che ora opera come capitale-merce, si trasforma in capitale monetario, ma contemporaneamente un’altra parte entra dal processo di produzione nella circolazione come nuovo capitale-merce. Così il ciclo M’ ... M’ viene descritto costantemente; così pure ambedue le altre forme. La riproduzione del capitale in ciascuna delle sue forme e in ciascuno dei suoi stadi è altrettanto continua che la metamorfosi di queste forme e lo scorrere successivo attraverso i tra stadi. Qui dunque il ciclo totale è unità reale delle sue tre forme.
Il processo ciclico del capitale è interruzione costante, abbandono di uno stadio, ingresso nel successivo; spogliarsi di una forma, esistere in un’altra forma; ciascuno di questi stadi non solo condiziona l’altro, ma contemporaneamente lo esclude. La continuità è tuttavia il contrassegno caratteristico della produzione capitalistica ed è condizionata dal suo fondamento tecnico, anche se non sempre è in ogni caso raggiungibile. Vediamo dunque come avvenga la cosa nella realtà. Il ciclo reale del capitale industriale nella sua continuità, perciò, non è solo unità di processo di produzione e di processo di circolazione, ma unità di tutti e tre i suoi cicli. Ma esso può essere tale unità solo in quanto ogni differente parte del capitale può successivamente percorrere le fasi del ciclo che si susseguono, passare da una fase, da una forma di funzione, all’altra, quindi il capitale industriale, in quanto totalità di queste parti, si trova contemporaneamente nelle differenti fasi e funzioni e descrive così contemporaneamente tutti e tre i cicli. La successione di ogni parte è qui condizionata dalla contemporaneità delle parti, cioè dalla partizione del capitale. La contemporaneità, dalla quale viene condizionata la continuità della produzione, esiste tuttavia soltanto in virtù dei movimenti con cui le parti del capitale percorrono successivamente i differenti stadi. La contemporaneità è essa stessa unicamente un risultato della successione. Se, ad es., M’—D’ si arresta per una parte, se la merce è invendibile, allora il ciclo di questa parte è interrotto e non si compie la sostituzione mediante i suoi mezzi di produzione; le parti susseguenti, che in veste di M’ provengono dal processo di produzione, trovano il loro mutamento di funzione impedito dai loro predecessori. Se questo dura per qualche tempo, la produzione si riduce e l’intero processo viene costretto a fermarsi. Ogni arresto della successione reca disordine alla contemporaneità, ogni arresto in uno stadio opera un arresto più o meno grande nel ciclo complessivo non soltanto della parte di capitale arrestatasi, ma anche nel capitale individuale complessivo.
La forma successiva nella quale si raffigura il processo è quella di una successione di fasi, cosicché il trapasso del capitale in una nuova fase è condizionato dal suo abbandono dell’altra. Ogni ciclo particolare ha perciò anche come punto di partenza e punto di ritorno una delle forme di funzione del capitale. D’altro lato, il processo complessivo è di fatto l’unità dei tre cicli, che sono le differenti forme nelle quali si esprime la continuità del processo. Il ciclo totale si rappresenta per ogni forma di funzione del capitale come il suo ciclo specifico, e cioè ciascuno di questi cicli condiziona la continuità del processo complessivo; il ciclo di una
176

forma funzionale condiziona quello dell’altra. È una condizione necessaria per il processo complessivo di produzione, particolarmente per il capitale sociale, che esso sia contemporaneamente processo di riproduzione e perciò ciclo di ciascuno dei suoi momenti. Frazioni differenti del capitale percorrono successivamente i differenti stadi e forme di funzione. Ogni forma di funzione, sebbene si presenti in essa una parte sempre diversa del capitale, percorre con ciò contemporaneamente alle altre il suo proprio ciclo. Una parte del capitale, ma una sempre in mutamento, sempre riprodotta, esiste come capitale-merce che sì trasforma in denaro; un’altra, come capitale monetario che si trasforma in capitale produttivo; una terza, come capitale produttivo che si trasforma in capitale-merce. La presenza costante di tutte e tre le forme è mediata dal ciclo del capitale complessivo appunto attraverso queste tre fasi.
Nel suo insieme il capitale si trova poi contemporaneamente, spazialmente contiguo, nelle sue differenti fasi. Ma ciascuna parte passa costantemente, nell’ordine, da una fase, da una forma di funzione, nell’altra, opera così, nell’ordine, in tutte. Le forme sono così forme che fluiscono, la cui contemporaneità è mediata dalla loro successione. Ciascuna forma segue l’altra e la precede, cosicché il ritorno di una parte di capitale ad una forma è condizionato dal ritorno dell’altra a un’altra forma. Ogni parte descrive incessantemente il suo proprio giro, ma è una parte sempre diversa del capitale che si trova in questa forma, e questi giri particolari costituiscono solo momenti contemporanei e successivi del decorso totale. Solo nell’unità dei tre cicli è attuata la continuità del processo complessivo anziché l’interruzione descritta sopra. Il capitale sociale complessivo possiede sempre questa continuità e il suo processo possiede sempre l’unità dei tre cicli. Nei capitali individuali, la continuità della riproduzione viene in qualche punto più o meno interrotta. In quanto valore che si valorizza, il capitale non include solo dei rapporti di classe, un determinato carattere sociale che si fonda sull’esistenza del lavoro come lavoro salariato. Esso è un movimento, un processo ciclico attraverso stadi differenti, che a sua volta implica tre differenti forme del processo ciclico. Perciò può essere concepito soltanto come movimento e non come cosa in riposo. I movimenti del capitale appaiono come azioni del singolo capitalista industriale, di guisa che questi operi come compratore di merci e di lavoro, come venditore di merci e come capitalista produttivo, dunque con la sua attività fa da mediatore del ciclo. Se il valore-capitale sociale subisce una rivoluzione di valore, può avvenire che il suo capitale individuale le soccomba e perisca, poiché non può adempiere le condizioni di questo movimento di valore. Quanto più acute e frequenti diventano le rivoluzioni di valore, tanto più il movimento del valore autonomizzato, automatico, operante con la violenza di un processo elementare di natura, si fa valere contro la previsione e il calcolo del singolo capitalista, tanto più il corso della produzione normale viene ad assoggettarsi alla speculazione anormale, tanto più grande diviene il pericolo per l’esistenza dei capitali singoli.
Il processo continua del tutto normalmente solo se i rapporti di valore restano costanti; esso continua di fatto, fintanto che le perturbazioni nella ripetizione del ciclo si compensano; quanto maggiori sono le perturbazioni, tanto maggiore capitale monetario deve possedere il capitalista industriale per essere in grado di attendere la compensazione; e poiché col procedere della produzione capitalistica si allarga la scala di ogni processo individuale di produzione e con essa la grandezza minima del capitale da anticipare, quella circostanza sì aggiunge alle altre che sempre più trasformano la funzione del capitalista industriale in un monopolio di grandi capitalisti monetari, isolati o associati. Entro il suo processo di circolazione, dove il capitale industriale opera o come denaro o come merce, il ciclo del capitale industriale, sia in quanto capitale mone-tarlo sia in quanto capitale-merce, si incrocia con la circolazione di merci dei più differenti modi sociali di produzione, purché insieme si tratti di produzione di merci.
È indifferente il carattere del processo di produzione dal quale provengono; come merci esse operano sul mercato, come merci entrano sia nel ciclo del capitale industriale, che nella circolazione del plusvalore in esso contenuto. È dunque il carattere onnilaterale della loro origine, l’esistenza del mercato come mercato mondiale che contrassegna il processo di circolazione del capitale industriale. Ciò che vale per merci straniere vale per denaro straniero; come il capitale-merce dì fronte a esso opera solo come merce, così di fronte a esso questo denaro opera solo come denaro; il denaro qui opera come moneta mondiale. Le merci che entrano nel processo di circolazione del capitale industriale (cui appartengono anche i mezzi necessari di sussistenza, nei quali si converte il capitale variabile dopo che è stato pagato ai lavoratori, al fine di riprodurre la forza-lavoro), qualunque sia la loro origine, la forma sociale del processo di produzione dal quale discendono, si trovano dinanzi al capitale industriale stesso già nella forma di capitale-merce, nella forma di capitale mercantile o commerciale; ma questo, per sua natura, abbraccia merci di tutti ì modi di produzione.
Il modo capitalistico di produzione presuppone come una produzione su vasta scala, così anche necessariamente una vendita su vasta scala; dunque vendita al commerciante, non al singolo consumatore. In quanto questo consumatore è anche consumatore produttivo, cioè capitalista industriale, cioè in quanto il capitale industriale di un ramo di produzione fornisce all’altro ramo mezzi di produzione, avviene (nella forma di ordinazione, ecc.) anche vendita diretta da parte di un capitalista industriale a molti altri. Ogni capitalista industriale in quanto venditore diretto, è commerciante di se stesso, ciò che, del resto, è anche
177

nella vendita al commerciante. Il commercio, in quanto funzione del capitale commerciale, è presupposto e si sviluppa sempre più con lo sviluppo della produzione capitalistica. Una delle peculiarità più tangibili del processo ciclico del capitale, industriale, dunque anche della produzione capitalistica, è la circostanza per cui, da un lato, gli elementi di formazione del capitale produttivo derivano dal mercato delle merci e devono essere costantemente rinnovati dallo stesso, essere comprati come merci; dall’altro, che il prodotto del processo di lavoro esce da esso come merce e deve essere costantemente venduto di nuovo come merce.
Conformemente a ciò, sono state contrapposte l’una all’altra economia naturale, economia monetaria ed economia creditizia, come le tre caratteristiche forme economiche di circolazione della produzione sociale. In primo luogo, queste tre forme non rappresentano fasi di sviluppo equivalenti. La cosiddetta economia creditizia non è altro che una forma dell’economia monetaria, in quanto ambedue le definizioni esprimono funzioni o modi dì circolazione tra i produttori stessi. Nella produzione capitalistica sviluppata, l’economia monetaria appare ormai soltanto come fondamento dell’economia creditizia. Economia monetaria ed economia creditizia corrispondono così soltanto a differenti gradi di sviluppo della produzione capitalistica, ma non sono per nulla forme differenti e autonome di circolazione, di fronte all’economia naturale. In secondo luogo, poiché nelle categorie economia monetaria, economia creditizia, è accentuato ed emerge come contrassegno distintivo non l’economia, cioè il processo di produzione stesso, ma il modo di circolazione, corrispondente all’economia, tra i differenti agenti di produzione o produttori, lo stesso dovrebbe avvenire per la prima categoria. Anziché economia naturale, dunque, economia di baratto. In terzo luogo, l’economia monetaria è comune ad ogni produzione di merci, e il prodotto appare come merce nei più differenti organismi sociali di produzione. A caratterizzare la produzione capitalistica sarebbe soltanto il volume in cui il prodotto viene prodotto come articolo di commercio, come merce, il volume in cui dunque anche ì suoi propri elementi di formazione devono di nuovo entrare come merci, come articoli di commercio, nell’economia da cui esso proviene.
Di fatto, la produzione capitalistica è la produzione di merci come forma generale della produzione, ma essa lo è, e lo diventa sempre più nel suo sviluppo, soltanto perché il lavoro stesso qui appare come merce, perché il lavoratore vende il lavoro, cioè la funzione della sua forza-lavoro, e lo vende, come noi presupponiamo, al suo valore determinato dai suoi costi di riproduzione. Nella misura in cui il lavoro diventa lavoro salariato, il produttore diventa capitalista industriale; perciò la produzione capitalistica (dunque anche la produzione di merci) appare nella sua intera estensione soltanto quando anche il produttore agricolo diretto è lavoratore salariato. Nel rapporto tra capitalista e lavoratore salariato, il rapporto monetario, il rapporto di compratore e venditore, diventa un rapporto immanente alla produzione stessa. Ma questo rapporto, riguardo alla base, si fonda sul carattere sociale della produzione, non del modo di circolazione; inversamente, questo scaturisce da quello. Del resto corrisponde all’orizzonte borghese, in cui il concludere affarucci occupa tutta la mente, di non vedere nel carattere del modo di produzione il fondamento del modo di circolazione ad esso corrispondente, ma viceversa.
Ma ciò che l’economia politica vede è ciò che appare, cioè l’azione del tempo di circolazione sul processo di valorizzazione del capitale in generale. Essa interpreta come positiva quest’azione negativa, perché le sue conseguenze sono positive. Tanto più strettamente essa si attacca a questa apparenza, in quanto essa sembra fornire la prova che il capitale possieda una fonte mistica di autovalorizzazione, indipendente dal suo processo di produzione e quindi dallo sfruttamento del lavoro, fonte che gli affluisce dalla sfera della circolazione. Questa apparenza viene rafforzata dal modo capitalistico di calcolare il profitto, in cui la causa negativa figura come positiva, poiché per capitali in sfere d’investimento differenti, in cui solo il tempo di circolazione sia differente, un tempo di circolazione più lungo agisce come causa del rialzo dei prezzi. Nella produzione di merci la circolazione è altrettanto necessaria che la produzione stessa, quindi gli agenti di circolazione altrettanto necessari che gli agenti di produzione. Il processo di riproduzione comprende ambedue le funzioni del capitale, quindi anche la necessità della rappresentanza di queste funzioni, sia attraverso il capitalista stesso, sia attraverso salariati, agenti di questo. Ma ciò non è un motivo per scambiare gli agenti della circolazione con gli agenti della produzione, come non lo è per scambiare le funzioni di capitale-merce e capitale monetario con quelle di capitale produttivo.
[C. III,4-5]
II.3.5. Il capitale fittizio e la speculazione
Nella forma del capitale produttivo d’interesse si palesa in modo evidente che il capitale si appropria senza lavoro dei frutti del lavoro altrui. Infatti esso appare qui in una forma in cui si è separato dal processo di produzione in quanto processo. L’economia volgare ritiene di essere tanto più semplice, naturale e utile, tanto più lontana da ogni sottigliezza teorica, quanto più si limita di fatto a tradurre le idee ordinarie in un linguaggio dottrinario. Quindi, quanto più estraniata è la forma in cui concepisce le configurazioni della
178

produzione capitalistica, tanto più si avvicina all’elemento della rappresentazione comune. Insomma, il denaro funziona qui soltanto contro la promessa scritta di pagare a un termine prestabilito. Noi possiamo, per amor di brevità, raggruppare queste “promesse di pagamento” nella categoria generale delle cambiali. Fino al giorno della loro scadenza e del loro pagamento queste cambiali circolano, a loro volta, come mezzo di pagamento; ed esse costituiscono il vero e proprio denaro del commercio. In quanto si annullano, compensando definitivamente debito e credito, esse funzionano integralmente come denaro, poiché in questo caso non ha luogo alla fine alcuna trasformazione in denaro. Precisamente come questi anticipi reciproci dei produttori e dei commercianti costituiscono la base reale del credito, così il loro strumento di circolazione, la cambiale, costituisce la base della effettiva moneta di credito, delle banconote, ecc. Queste non si fondano sulla circolazione monetaria, sia essa moneta metallica o moneta cartacea statale, ma sulla circolazione delle cambiali.
“Questa enorme sovrastruttura di cambiali poggia (!) su una base costituita dall’ammontare delle banconote e dell’oro; e se nel corso degli avvenimenti questa base si restringe troppo, la sua solidità e la sua esistenza stessa si trovano in pericolo. Delle cambiali può essere legalmente richiesto il cambio in oro. Come faccio a trovare l’importo in oro per soddisfare questa richiesta? Le cambiali non possono essere poste sotto controllo a meno che non si impedisca l’eccedenza di denaro o il basso tasso di interesse o di sconto, che le provoca in parte, incoraggiando questa larga e pericolosa espansione. È impossibile precisare in quale misura queste cambiali provengano da transazioni reali, ossia da vendite e da acquisti effettivi, e in quale misura esse siano create artificialmente (fictitious) e non siano altro che cambiali di comodo; ciò accade quando si emette una cambiale per ritrarne una in corso prima della scadenza e creare così il capitale fittizio mediante l’emissione di puri e semplici mezzi di circolazione” [cfr. William Leatham, Letters on the Currency]. In seguito a questo commercio di denaro si sviluppa l’altro aspetto della natura del credito, l’amministrazione del capitale produttivo d’interesse, o del capitale monetario come funzione particolare dei commercianti di denaro. Il prendere a prestito e il dare a prestito denaro costituisce il loro affare particolare. Essi servono da intermediari tra chi effettivamente prende a prestito e chi effettivamente dà a prestito capitale monetario. Espressa in termini generali, l’attività del banchiere sotto questo aspetto consiste nel concentrare nelle sue mani e in grandi masse il capitale monetario disponibile per il prestito, così che di fronte ai capitalisti industriali e commerciali, in luogo del singolo individuo che dà denaro a prestito, si trovano i banchieri, come rappresentanti di tutti coloro che dànno denaro a prestito. Essi diventano gli amministratori generali del capitale monetario.
D’altro lato essi rappresentano, di fronte a tutti coloro che dànno a prestito, la figura di chi prende a prestito, poiché essi prendono a prestito per tutto quanto il mondo commerciale. Una banca rappresenta da un lato la concentrazione del capitale monetario, cioè di coloro che dànno a prestito, d’altro lato la concentrazione di quelli che prendono a prestito. Il suo profitto consiste generalmente nel fatto che essa prende a prestito a un tasso meno elevato di quello con cui dà a prestito. Se non fosse stato concesso questo credito (era in circolazione un’ingente quantità di cambiali emesse da speculatori su intermediari) il prezzo della merce sarebbe notevolmente diminuito; e ciò varrebbe anche per gli anticipi su cambiali emesse per tutti gli altri prodotti. Le cambiali emesse su una ditta sono vendute altrove e con il ricavato sono acquistate altre cambiali rispedite alla ditta di provenienza per permetterle di pagare le prime cambiali emesse: con questo solo affare sono messe in circolazione cambiali per tre volte l’importo originario. Quale che sia il numero delle transazioni successive, il capitale del debito pubblico rimane un capitale puramente fittizio, e il giorno in cui questi titoli diventassero invendibili svanirebbe anche l’apparenza di questo capitale. Con lo sviluppo del commercio e della produzione capitalistica, che produce unicamente in vista della circolazione, la base naturale del sistema creditizio si amplia, si generalizza, si perfeziona. Di tutte queste forme, il feticcio più completo è il capitale produttivo d’interesse. Qui abbiamo il punto di partenza originario del capitale – il denaro – e la formula “denaro-merce-denaro valorizzato” ridotta ai suoi due estremi, “denaro-denaro valorizzato”, denaro che crea più denaro: è la formula originaria e generale del capitale ridotta a un riassunto privo di senso. La completa reificazione, il rovesciamento e la follia del capitale come capitale produttivo d’interesse – in cui tuttavia non fa che manifestarsi l’intima natura della produzione capitalistica, la sua follia, nella forma più tangibile – è il capitale in quanto portatore di interesse composto, quando appare come un Moloch che pretende il mondo.
Nel debito pubblico appare come capitale una grandezza negativa e, com’è in generale per il capitale produttivo d’interesse, ciò genera le concezioni più insensate, al punto che i banchieri giungono a concepire i debiti come merci. Questo ritorno del capitale al suo punto di partenza riceve nel capitale produttivo d’inte-resse una figura del tutto esteriore, separata dal movimento reale di cui è forma. Lo spostamento del denaro, quando è prestato come capitale e quindi non viene trasformato in capitale ma entra come capitale nella spe-culazione, non esprime altro che un trasferimento del medesimo denaro da una mano all’altra. Per il prestatore resta capitale anche quando non lo presta all’industriale ma al dissipatore, o quando lo presta a un lavoratore che non è in grado di pagare l’affitto (a es., tutta la questione dei “monti di pietà”). La
179

trasformazione in capitale è un’operazione che sta al di là di quella che si svolge tra colui che presta e colui che prende a prestito. Questa mediazione è cancellata, non vi è, visibilmente, immediatamente inclusa. Invece della trasformazione reale del denaro in capitale, qui appare solo la forma priva di contenuto di tale trasformazione. Il valore d’uso del denaro qui diventa quello di creare valore di scambio, un valore di scambio maggiore di quello in esso contenuto. È prestato come valore che valorizza se stesso.
Il capitalista monetario in realtà ottiene la sua parte di plusvalore solo in quanto è il proprietario del capitale, mentre rimane al di fuori del processo di produzione; il prezzo del capitale – vale a dire del mero titolo di proprietà sul capitale – è quotato sul mercato monetario nel tasso di interesse; i singoli capitalisti truffano i compratori e i venditori di merci con un diverso grado di fortuna e scaltrezza, ed è naturale che a essi – siano o no proprietari del capitale che si trova nel processo – l’interesse appaia come dovuto al capitale in quanto tale. Mentre dunque l’interesse e il capitale produttivo d’interesse esprimono unicamente l’antitesi tra la ricchezza oggettiva e il lavoro, e quindi la sua esistenza come capitale, nella rappresentazione si ha l’esatto capovolgimento di ciò, in quanto il fenomeno, prima facie, mostra che il capitale monetario non ha alcun rapporto con il lavoratore salariato, ma solo con altri capitalisti. Di qui la bella frase di alcuni “economisti volgari”: se il capitalista industriale oltre all’interesse non ricavasse un profitto, presterebbe a interesse il suo capitale e vivrebbe di rendita. Cosicché tutti i capitalisti cesserebbero di produrre e tutto il capitale cesserebbe di fungere come capitale e tuttavia si potrebbe vivere dei suoi interessi. In questa opinione volgare si ha un capovolgimento.
La formazione del capitale fittizio la si chiama “capitalizzazione”. Si capitalizza ogni reddito regolare e periodico, considerandolo in base al tasso medio dell’interesse come provento che verrebbe ricavato da un capitale dato in prestito a questo tasso d’interesse; svanisce così anche l’ultima traccia di qualsiasi rapporto con l’effettivo processo di valorizzazione del capitale e si consolida l’idea che rappresenta il capitale come automa che si valorizza di per se stesso. Anche in quei casi in cui l’obbligazione – il titolo di credito – non rappresenta, come si verifica per il debito pubblico, un capitale puramente illusorio, il valore-capitale di questo titolo è puramente illusorio. Le azioni delle società ferroviarie, minerarie e di navigazione ecc. rappresentano capitale effettivo, il che tuttavia non esclude affatto che esse possano anche rappresentare delle semplici truffe. Ma questo capitale non ha una duplice esistenza, una volta di valore-capitale dei titoli di proprietà, delle azioni, un’altra di capitale effettivamente investito o da investire in queste imprese. Esso esiste unicamente sotto quest’ultima forma e l’azione non è altro che un titolo di proprietà, in proporzione al plusvalore che verrà realizzato da questo capitale.
A può vendere questo titolo a B e B cederlo a C. Queste transazioni non mutano per nulla la sostanza della cosa. A, oppure B, ha in tal caso convertito il suo titolo in capitale, ma C da parte sua ha convertito il suo capitale in un semplice titolo di proprietà sul plusvalore che ci si attende dal capitale azionario. Il movimento autonomo del valore di questi titoli di proprietà, non soltanto dei valori di stato, ma anche delle azioni, consolida l’apparenza che essi costituiscano un capitale reale accanto al capitale o al diritto sul capitale di cui essi sono eventualmente titolo giuridico. Essi si trasformano difatti in merci, il cui prezzo ha un movimento e un modo di fissarsi suoi propri. Il loro valore di mercato differisce dal loro valore nominale, indipendentemente dal cambiamento di valore del capitale effettivo (sebbene in connessione col cambiamento della sua valorizzazione); il loro valore di mercato oscilla in relazione all’ammontare e alla sicurezza dei proventi ai quali questi titoli danno diritto.
Se il valore nominale di una azione si accresce, essa rappresenta ora un capitale fittizio; e anche colui che l’acquista ritrae da questo investimento di capitale un reddito. Il contrario si verifica quando gli utili dell’im-presa diminuiscono. Il valore di mercato di questi titoli è in parte speculativo, essendo determinato non dal provento reale ma dal provento previsto, calcolato in anticipo. In periodi di difficoltà per il mercato monetario, questi titoli quindi subiranno una duplice riduzione di prezzo; innanzitutto perché il tasso dell’interesse aumenta, e in secondo luogo perché essi vengono gettati sul mercato in massa, per essere convertiti in denaro. Non appena la burrasca è passata questi titoli riprendono il loro valore precedente, eccettuato il caso in cui si tratti di imprese sfortunate o di bassa speculazione. Il loro deprezzamento durante la crisi agisce come mezzo efficace per l’accentramento dei patrimoni monetari. In quanto la diminuzione o l’aumento di valore di questi titoli sono indipendenti dal movimento di valore del capitale reale che essi rappresentano, la ricchezza di una nazione non varia in conseguenza di tale diminuzione o aumento. In quanto la loro svalorizzazione non esprime un effettivo arresto della produzione, la nazione non risulta impoverita di un centesimo in seguito allo scoppio di queste bolle di sapone di capitale monetario nominale. Tutti tali titoli non sono in realtà che un’accumulazione di diritti, titoli giuridici, sulla produzione futura, e il loro valore monetario non costituisce capitale, come a esempio nel caso del debito pubblico, oppure è determinato in modo completamente indipendente dal valore del capitale reale che essi rappresentano. In tutti i paesi a produzione capitalistica esiste una massa enorme di cosiddetto capitale produttivo d’interesse o di capitale monetario sotto questa forma. E per accumulazione del capitale monetario si deve intendere in gran
180

parte esclusivamente l’accumulazione di questi diritti sulla produzione, l’accumulazione del prezzo di mercato del valore-capitale illusorio di questi diritti.
La maggior parte del capitale del banchiere è dunque puramente fittizia e consiste in titoli di credito (cambiali), titoli di stato (che rappresentano capitale consumato), e azioni (buoni sui proventi futuri). E non si deve qui dimenticare che il valore monetario del capitale rappresentato da queste carte che giacciono nelle casseforti dei banchieri è puramente fittizio e che esso viene regolato indipendentemente dal valore del capitale effettivo che questi titoli, almeno in parte, rappresentano; e quando questi titoli non rappresentano del capitale ma soltanto dei semplici diritti sui proventi, il diritto su uno stesso provento si esprime in capitale monetario fittizio soggetto a continue modificazioni. A ciò si aggiunge ancora che il capitale fittizio del banchiere rappresenta per la maggior parte non il suo proprio capitale, ma quello del pubblico che l’ha depositato presso di lui, con o senza interessi. “E come gli stessi pezzi di denaro possono servire a rendere possibili prestiti diversi per un ammontare corrispondente a tre o anche a trenta volte il loro valore, essi possono allo stesso modo servire successivamente come mezzo del rimborso” [Adam Smith], a meno che non si verifichi un assalto generale alle banche per ritirare i depositi. Poiché la medesima moneta può servire, secondo la velocità della sua circolazione, a diversi acquisti, essa può parimenti servire a diversi prestiti, poiché gli acquisti la portano da una mano all’altra, e il prestito non è che un trasferimento da una mano all’altra senza l’intermediario dell’acquisto. Nel prestito in denaro senza la mediazione degli acquisti, lo stesso denaro non rappresenterebbe tre capitali, ma uno soltanto, soltanto un valore-capitale; il numero dei capitali che esso rappresenta effettivamente dipende dal numero delle volte in cui esso opera come forma di valore di capitali-merce diversi.
Gli agenti di borsa conducono i loro vastissimi affari senza avere nessuna riserva contante; essi si basano sugli incassi delle loro cambiali che vengono di volta in volta a scadenza o, in caso di bisogno, sulla loro facoltà di ottenere degli anticipi dalla Banca [centrale] contro deposito delle cambiali da essi scontate. Durante la crisi, e in generale durante periodi di ristagno degli affari, il capitale fittizio perde in gran parte la sua proprietà di rappresentare capitale monetario potenziale. Il loro prezzo diminuisce con l’aumento dell’interesse. Esso diminuisce inoltre a causa della mancanza generale di credito, che costringe il loro proprietario a svendere tali titoli in massa sul mercato per procurarsi denaro e, in parte, perché le imprese che essi rappresentano hanno troppo spesso carattere fittizio. Questo capitale monetario fittizio durante le crisi risulta fortemente ridotto e quindi diminuisce anche la possibilità per il proprietario di venderlo per procurarsi denaro. In quanto la Banca emette dei biglietti che non sono coperti dalla riserva metallica nei suoi forzieri, essa crea segni di valore che costituiscono non solo mezzi di circolazione, ma anche capitale addizionale – sia pure fittizio – corrispondente all’ammontare nominale di questi biglietti senza copertura. Di qui, con piena coerenza, viene la dottrina moderna che un popolo diventa tanto più ricco quanto più a fondo s’indebita. Il credito pubblico diventa il credo del capitale.
E col sorgere dell’indebitamento dello stato, al peccato contro lo spirito santo, che è quello che non trova perdono, subentra il mancar di fede al debito pubblico. Il debito pubblico diventa una delle leve più energiche dell’accumulazione originaria: come con un colpo di bacchetta magica, esso conferisce al denaro, che è improduttivo, la facoltà di procreare, e così lo trasforma in capitale, senza che il denaro abbia bisogno di assoggettarsi alla fatica e al rischio inseparabili dall’investimento industriale e anche da quello usurario. In realtà i creditori dello stato non dànno niente, poiché la somma prestata viene trasformata in obbligazioni facilmente trasferibili, che in loro mano continuano a funzionare proprio come se fossero tanto denaro in contanti. Ma anche fatta astrazione dalla classe di gente oziosa, vivente di rendita, che viene cosi creata, e dalla ricchezza improvvisata dei finanzieri che fanno da intermediari tra governo e nazione, e fatta astrazione anche da quella degli appaltatori delle imposte, dei commercianti, dei fabbricanti privati, ai quali una buona parte di ogni prestito dello stato fa il servizio di un capitale piovuto dal cielo, il debito pubblico ha fatto nascere le società per azioni, il commercio di effetti negoziabili di ogni specie, l’aggiotaggio: in una parola, ha fatto nascere il gioco di borsa e la bancocrazia moderna.
[TP. q.XV, pp.891ss.; C. I.24]
II.4. Eccesso di sovraproduzione
II.4.1. L’arresto dell’accumulazione e la crisi
Se si suppone che il graduale cambiamento della composizione del capitale non avvenga soltanto in alcune isolale sfere di produzione ma, in maggiore o minor misura, in tutte o almeno in quelle di maggiore importanza; se tale cambiamento modifica quindi la composizione media organica del capitale complessivo appartenente a una determinata società, questo graduale incremento, del capitale costante in rapporto al
181

variabile deve necessariamente avere per risultato una graduale diminuzione del tasso generale del profitto, fermi restando il tasso del plusvalore o il grado dì sfruttamento del lavoro per mezzo del capitale. Questa progressiva diminuzione relativa del capitale variabile in rapporto al capitale costante, e per conseguenza al capitale complessivo, è identica al progressivo elevarsi della composizione organica del capitale complessivo considerato nella sua media. Del pari, essa non è altro che una nuova espressione del progressivo sviluppo della produttività sociale del lavoro, che si dimostra per l’appunto nel fatto che, per mezzo dell’impiego crescente di macchinario e di capitale fisso in generale, una maggiore quantità di materie prime e ausiliarie vengono trasformale in prodotto da un eguale numero di lavoratori nello stesso tempo, cioè con un lavoro minore. La progressiva tendenza alla diminuzione del tasso generale del profitto è dunque solo un’espressione peculiare al modo di produzione capitalistico per lo sviluppo progressivo della produttività sociale del lavoro. Ciò non vuol dire che il tasso del profitto non possa temporaneamente diminuire anche per altre ragioni, ma significa che, in conseguenza della natura stessa della produzione capitalistica, e come una necessità logica del suo sviluppo, il tasso generale medio del plusvalore deve esprimersi in una diminuzione del tasso generale del profitto. Per quanto la legge appaia semplice dopo le illustrazioni fin qui date, l’economia non è finora riuscita a scoprirla. Essa ha constatato l’esistenza del fenomeno e si è affaticata a spiegarlo in tentativi contraddittori. Data la grande importanza che questa legge ha per la produzione capitalistica, si può dire che essa costituisce il mistero a svelare il quale tutta l’economia politica si è adoperala dal tempo di Adamo Smith; la differenza fra le varie scuole da Smith in poi consiste nei diversi tentativi per giungere a tale soluzione.
La legge del tasso decrescente del profitto, che si esprime con lo stesso tasso del plusvalore o anche con un tasso crescente, dice in altre parole: data una qualsiasi determinata quantità di capitale medio sociale, vi è un aumento continuo della parte di esso rappresentata dai mezzi di lavoro, e una continua diminuzione della parte rappresentata dal lavoro vivo. Dato che la massa complessiva di lavoro vivo aggiunto ai mezzi di produzione diminuisce in proporzione al valore di essi, anche il lavoro non pagato e la parte di valore che lo rappresenta diminuiscono in rapporto al valore del capitale complessivo anticipato. Ovvero: una parte sempre più piccola del capitale complessivo impiegato si converte in lavoro vivo, e quindi il capitale complessivo assorbe, in proporzione alla sua entità, un’aliquota sempre più piccola di pluslavoro, benché il rapporto tra la parte non pagata e quella pagata del lavoro impiegato possa aumentare al medesimo tempo. La diminuzione proporzionale del capitale variabile e l’aumento proporzionale del capitale costante, sebbene in senso assoluto essi crescano entrambi, è, come è già stato detto, solo una diversa espressione dell’aumentata produttività del lavoro.
La caduta tendenziale del tasso del profitto è collegata con un aumento tendenziale del tasso del plusvalore, ossia del grado di sfruttamento del lavoro. Nulla di più assurdo, allora, che spiegare la diminuzione del tasso del profitto con l’aumento del tasso dei salari, quantunque anche questo fatto possa presentarsi in via eccezionale. La statistica sarà in grado di intraprendere una vera analisi sul tasso dei salari per diverse epoche e per diversi paesi solo quando abbia compreso i rapporti che determinano il tasso del profitto. Esso diminuisce non perché il lavoro diviene meno produttivo, ma perché la sua produttività aumenta. L’aumento del tasso del plusvalore e la diminuzione del tasso del profitto non sono che forme particolari che costituiscono l’espressione capitalistica della crescente produttività del lavoro. Caduta del tasso del profitto e acceleramento della accumulazione sono semplicemente diverse espressioni di uno stesso processo, ambedue esprimendo lo sviluppo della forza produttiva. L’accumulazione accelera la caduta del tasso del profitto, in quanto determina la concentrazione del lavoro su ampia scala e di conseguenza una composizione superiore del capitale. D’altro lato la diminuzione del tasso del profitto accelera a sua volta, la concentrazione di capitale e la sua centralizzazione mediante l’espropriazione di piccoli capitalisti, degli ultimi produttori diretti sopravvissuti, presso i quali vi è ancora qualche cosa da espropriare. L’accumulazione in quanto massa viene con ciò accelerata, mentre il tasso di accumulazione diminuisce unitamente al tasso del profitto.
D’altro lato in quanto il tasso di valorizzazione del capitale complessivo – il tasso del prefitto – è lo stimolo della produzione capitalistica (come la valorizzazione del capitale ne costituisce l’unico scopo), la sua caduta rallenta la formazione di nuovi capitali indipendenti ed appare come una minaccia per lo sviluppo del processo capitalistico di produzione; favorisce infatti la sovraproduzione, la speculazione, le crisi, un eccesso di capitale contemporaneamente a un eccesso di popolazione. Gli economisti che, come Ricardo, considerano come assoluto il modo capitalistico di produzione, si rendono conto a questo punto che tale modo di produzione si crea esso stesso dei limiti, ed attribuiscono questi limiti non alla produzione ma alla natura (nella teoria della rendita). L’horror che essi provano di fronte alla tendenza a decrescere del tasso del profitto, è ispirato soprattutto dal fatto che il modo capitalistico di produzione trova nello sviluppo delle forze produttive un limite il quale non ha nulla a che vedere con la produzione della ricchezza come tale; e questo particolare limite attesta il carattere ristretto, semplicemente storico, passeggero del modo capitalistico di produzione; prova che esso non rappresenta affatto l’unico modo di produzione che possa
182

produrre la ricchezza, ma al contrario, giunto a una certa fase, entra in conflitto con il suo stesso ulteriore sviluppo.
La legge della progressiva diminuzione del tasso del profitto o della relativa diminuzione del pluslavoro acquisito in confronto alla massa di lavoro oggettivato messa in movimento dal lavoro vivo non esclude affatto che aumenti la massa assoluta del lavoro messa in movimento e sfruttata dal capitale sociale, e quindi anche la massa assoluta del pluslavoro che esso si appropria; e tanto meno esclude che i capitali a disposizione dei singoli capitalisti comandino una massa crescente di lavoro, e quindi di pluslavoro, anche se non cresce il numero dei lavoratori che da essi dipendono. II modificarsi della proporzione non è dovuto alla diminuzione della massa di lavoro vivo, bensì all’aumento della massa di lavoro già oggettivato da essa posto in movimento. La diminuzione è relativa, non assoluta, e non ha in realtà nulla a che vedere con la grandezza assoluta del lavoro e del pluslavoro messo in movimento. La caduta del tasso del profitto non deriva da una diminuzione assoluta, ma soltanto da una diminuzione relativa dell’elemento variabile del capitale complessivo, dalla diminuzione di esso in confronto all’elemento costante. Il numero dei lavoratori impiegati dal capitale, dunque la massa assoluta di lavoro che esso mette in movimento, quindi la massa assoluta di pluslavoro che assorbe, e perciò la massa di plusvalore e la massa assoluta del profitto che produce possono quindi aumentare, anche progressivamente, nonostante la progressiva diminuzione del tasso del profitto. Ciò non solo può, ma deve accadere – eccettuate le oscillazioni temporanee – sulla base della produzione capitalistica. Le stesse leggi producono quindi per il capitale sociale un aumento della massa assoluta del profitto e una diminuzione del tasso del profitto. In quale forma deve ora esprimersi questa legge a doppio taglio della diminuzione del tasso del profitto e del contemporaneo aumento della massa assoluta del profitto, fenomeni aventi le medesime cause? Tale legge è fondata sul fatto che la massa acquisita del pluslavoro, e quindi del plusvalore, cresce nelle condizioni date.
Riappare qui la legge già precedentemente analizzata, per la quale, con la relativa diminuzione del capitale variabile e quindi con l’evoluzione della produttività sociale del lavoro, una massa sempre crescente di capitale complessivo è necessaria per mettere in movimento la stessa quantità di forza-lavoro e assorbire la stessa massa di pluslavoro. La possibilità di un relativo eccesso di popolazione lavoratrice si sviluppa, quindi nella stessa proporzione in cui si sviluppa la produzione capitalistica; e ciò non perché la forza produttiva del lavoro sociale diminuisce, ma perché aumenta: non a causa di una sproporzione assoluta tra il lavoro e i mezzi di sussistenza o i mezzi di produzione di essi, bensì di una sproporzione derivante dallo sfruttamento capitalistico del lavoro, cioè a causa della sproporzione tra il crescente aumento del capitale e il suo bisogno relativamente minore di una crescente popolazione lavoratrice. Anche se la massa di popolazione lavoratrice sfruttata rimanesse costante e aumentassero soltanto durata e intensità della giornata lavorativa, la massa del capitale impiegato dovrebbe aumentare, in quanto ciò è necessario anche per poter impiegare, con una diversa composizione di capitale, la stessa massa di lavoro alle precedenti condizioni di sfruttamento.
La stesso sviluppo della produttività sociale del lavoro ai esprime quindi, nel progresso del modo capitalistico di produzione, da un lato in una tendenza alla diminuzione progressiva del tasso del profitto, e dall’altro in un incremento costante della massa assoluta del plusvalore acquisito o del profitto; di modo che alla relativa diminuzione del capitale variabile e del profitto corrisponda, nel complesso, un aumento assoluto di entrambi. Come abbiamo già dimostrato, questo effetto bilaterale può essere rappresentato soltanto dal fatto che il capitale complessivo aumenta in progressione più rapida di quella in cui il tasso del profitto diminuisce. Abbiamo dimostrato che le stesse cause che producono una caduta tendenziale del tasso generale del profitto, comportano una più rapida accumulazione del capitale e quindi un incremento della grandezza assoluta o della massa del pluslavoro (plusvalore, profitto) che quel capitale si appropria. Nella concorrenza, e quindi anche nella coscienza dei suoi agenti, tutto si presenta alla rovescia: ciò avviene anche per questa legge, ossia per questa ultima e necessaria relazione tra due fatti che sono apparentemente in contrasto. È evidente che, entro le proporzioni precedentemente illustrate, un capitalista che disponga di grandi capitali ricava una massa di profitto maggiore che non un piccolo capitalista i cui profitti sono in apparenza elevati. Il più superficiale esame della concorrenza mostra inoltre che in determinate circostanze, quando il capitalista più forte vuol farsi largo sul mercato e soppiantare i più deboli, come nei periodi di crisi, si vale in pratica di questo principio, cioè diminuisce deliberatamente il suo tasso del profitto per battere i suoi concorrenti minori.
Ciò dimostra una volta di più come nel modo capitalistico dì produzione sia importante considerare la singola merce o il prodotto-merce di un periodo qualsiasi non isolatamente, come semplice mercanzia, ma come prodotto del capitale anticipato ed in rapporto al capitale complessivo che questa mercanzia produce. Pur dovendosi il tasso del profitto calcolare misurando la massa del plusvalore prodotto e realizzato non solo sulla parte di capitale che è stata consumata e che riappare nelle merci, ma su questa parte più l’altra che non è stata consumata ma impiegata e che continua a funzionare nella produzione, è evidente che la massa del profitto non può essere uguale che alla massa del profitto o del plusvalore contenuta nelle merci stesse e
183

realizzabile mediante la loro vendita. Quando aumenta la produttività dell’industria diminuisce il prezzo delle singole merci; esse contengono una minore quantità di lavoro pagato e non pagato. Teoricamente parlando, la diminuzione di prezzo del singolo prodotto in seguito ad un aumento della forza produttiva ed a un contemporaneo aumento del numero di questi prodotti a miglior mercato, può lasciare invariato il tasso del profitto, nel caso ad es. che l’aumento della forza produttiva agisca simultaneamente ed in misura uguale su tutti gli elementi del prodotto di modo che il suo prezzo complessivo diminuisca nella stessa proporzione in cui è aumentata la produttività del lavoro, e d’altro lato il reciproco rapporto dei diversi elementi che costituiscono il prezzo del prodotto rimanga invariato. Il tasso del profitto potrebbe persino elevarsi, qualora l’aumento del tasso del plusvalore fosse connesso con una notevole diminuzione dei valori degli elementi del capitale costante e soprattutto del capitale fisso. Ma in realtà, come si è già visto, il tasso del profitto finirà per cadere con l’andar del tempo. La sola diminuzione di prezzo della singola merce non permette in nessun caso di giungere ad una conclusione sul tasso del profitto. Tutto dipende dalla somma complessiva del capitale impiegato nella sua produzione.
Il capitalista che applichi dei metodi di produzione perfezionati, ma non ancora generalizzati, vende al di sotto del prezzo di mercato ma al dì sopra del proprio prezzo individuale di produzione; il tasso del profitto aumenta per lui finché la concorrenza non ristabilisce l’equilibrio; durante questo periodo di livellamento del profitto si verifica il secondo requisito, l’aumento del capitale impiegato, ed appunto dall’entità di questo aumento dipende se il capitalista sarà in grado nelle nuove condizioni dì impiegare un numero inferiore, eguale o addirittura maggiore di lavoratori rispetto al periodo precedente, e di produrre quindi una massa di profitto uguale o più elevata. Il fenomeno derivante dalla natura stessa della produzione capitalistica, vale a dire che aumentando la produttività del lavoro diminuisca il prezzo della singola merce o di una determinata aliquota di merci, che il numero delle merci aumenta, e che la massa del profitto sulla singola merce e il tasso del profitto sulla somma delle merci diminuiscono, mentre aumenta la massa del profitto sulla somma complessiva – questo fenomeno presenta alla superficie queste sole caratteristiche: diminuzione della massa del profitto per la singola merce, diminuzione del suo prezzo, incremento della massa di profitto sul maggior quantitativo delle merci prodotte dal capitale complessivo sociale o dal singolo capitalista. Da questo fatto viene comunemente dedotto che è il capitalista stesso a gravare a sua libera discrezione il singolo prodotto di una percentuale minore di profitto, coprendosi della perdila mediante la produzione di un maggior quantitativo di merci: concezione che si fonda sull’idea di profitto derivante dalla vendita (profit upon alienation) che a sua volta proviene dalla concezione del capitale commerciale.
Poiché nella concorrenza tutto si presenta sotto un aspetto errato e precisamente capovolto, il singolo capitalista può immaginarsi: 1) che diminuendo il prezzo egli riduce il suo profitto per unità di prodotto ma accresce il suo profitto complessivo mediante la vendita di un quantitativo maggiore di prodotto; 2) che egli determina il prezzo del singolo prodotto e ottiene il prezzo della produzione complessiva mediante una moltiplicazione, mentre la prima operazione da fare è una divisione e la moltiplicazione è giusta solo come secondo stadio, sulla premessa di tale divisione. L’economista volgare non fa altro in pratica che tradurre in una lingua in apparenza più teorica e più generale le bizzarre idee dei capitalisti impegnati nella concorrenza, affaticandosi per dimostrare l’esattezza di queste idee. Qualora si confronti l’imponente sviluppo delle forze produttive del lavoro sociale quale si presenta anche solo negli ultimi trenta anni, con la produttività di tutti i periodi precedenti, qualora soprattutto si consideri l’enorme massa di capitale fisso che in aggiunta al macchinario propriamente detto entra nel processo della produzione sociale nel suo insieme, si comprende come la difficoltà, che ha costituito finora oggetto d’indagine da parte degli economisti, di spiegare la diminuzione del tasso del profitto, venga ora sostituita dalla difficoltà opposta, consistente nello spiegare le cause per cui questa diminuzione non è stata più forte o più rapida. Devono qui giocare delle influenze antagonistiche, che contrastano o neutralizzano l’azione della legge generale, dandole il carattere di una semplice tendenza; motivo questo per cui la caduta del tasso generale del profitto è stata da noi chiamata una caduta tendenziale. Le più generali di queste cause cono le seguenti:
I. Aumento del grado di sfruttamento del lavoro.Il grado di sfruttamento del lavoro e l’appropriazione del pluslavoro e del plusvalore vengono soprattutto
accresciuti mediante il prolungamento della giornata lavorativa e l’intensificazione del lavoro stesso. Queste sono le tendenze antagonistiche che, mentre spingono verso un aumento del tasso del plusvalore, influiscono al tempo stesso nel senso della diminuzione della massa del plusvalore prodotto da un capitale determinato e quindi nel senso della diminuzione del tasso del profitto. Potrebbe qui sorgere la domanda, se tra le cause che in un primo tempo ostacolano ma in ultima analisi accelerano sempre la caduta del tasso del profitto, siano da comprendere gli aumenti del plusvalore temporanei ma che si riproducono continuamente al di sopra del livello generale, ora in questo ora in quel ramo di produzione, a favore di quel capitalista che sfrutti invenzioni ecc. prima che esse siano divenute di dominio pubblico. La risposta non può essere che affermativa.
184

II. Riduzione del salario al di sotto dal suo valore .Questo fattore viene ricordato semplicemente a titolo empirico perché in realtà, unitamente a molti altri
che dovrebbero essere qui menzionali, non ha nulla a che vedere con l’analisi generale del capitale, ma appartiene allo studio della concorrenza, di cui non ci occupiamo in questa opera. Esso rappresenta per altro una delle cause più importanti che frenano la tendenza alla caduta del tasso del profitto.
III. Diminuzione di prezzo degli elementi del capitale costante.Tutto quanto è stato detto sulle cause che aumentano il tasso del profitto pur rimanendo costante il tasso
del plusvalore o anche indipendentemente da esso, trova qui applicazione, e soprattutto il fatto che, dal punto di vista del capitale complessivo, il valore del capitale costante non si accresce nella stessa proporzione del suo volume materiale. Il medesimo fenomeno ai riscontra per le macchine e per tutto il capitale fisso. In breve, la stessa evoluzione, che porta all’aumento della massa del capitale costante rispetto al variabile, tende a far diminuire, in seguito alla crescente produttività del lavoro, il valore degli elementi che lo costituiscono ed impedisce di conseguenza che il valore del capitale costante (per quanto in continuo aumento) si accresca nella stessa proporzione della sua massa materiale, cioè della massa materiale dei mezzi di produzione messi in opera da una stessa quantità di forza-lavoro. In alcuni casi particolari può anche accadere che la massa degli elementì del capitale costante si accresca mentre il suo valore rimane invariato od anche diminuisce. Queste considerazioni hanno valore anche per quanto riguarda la svalorizzazione del capitale esistente, ossia degli elementi materiali che lo costituiscono, derivante dallo sviluppo dell’industria.
IV. La sovrapopolazione relativa.Lo sviluppo della produttività del lavoro, che si esprime in una diminuzione del tasso del profitto, crea
necessariamente ed accelera condizioni di relativa sovrapopolazione che assume manifestazioni tanto più evidenti quanto più sviluppato è il modo capitalistico di produzione dì un paese. Il capitale variabile assume una notevole importanza rispetto al capitale complessivo ed il salario rimane al dì sotto della media, cosicché tanto il tasso quanto la massa del plusvalore risultano eccezionalmente elevati.
V. Il commercio estero.Il commercio estero, in quanto fa diminuire di prezzo sia gli elementi del capitale costante che i mezzi di
sussistenza necessari nei quali si converte il capitale variabile, tende ad accrescere il tasso del profitto, aumentando il tasso del plusvalore e diminuendo il valore del capitale costante. Esercita in generale un’azione in questo senso perché rende possibile un ampliamento della scala di produzione. Parimenti, l’ampliamento del commercio estero che costituiva la base della produzione capitalistica durante la sua infanzia, ne diventa un prodotto quando essa comincia a svilupparsi, in conseguenza della necessità intrinseca di questo modo di produzione, del suo bisogno di un mercato sempre più esteso. Si mostra qui ancora una volta la stessa contraddittorietà dell’azione esercitata. I capitali investiti nel commercio estero possono offrire un tasso del profitto più elevato soprattutto perché in tal caso fanno concorrenza a merci che vengono prodotte da altri paesi a condizioni meno favorevoli; i capitali investiti nelle colonie, ecc., possono offrire un tasso del profitto superiore sia perché di regola il tasso del profitto è più elevato in questi paesi a causa dell’insufficiente sviluppo della produzione, sia perché il lavoro viene sfruttato più intensamente. Ma lo stesso commercio estero, sviluppando all’interno il modo capitalistico di produzione e con ciò provocando la diminuzione del capitale variabile rispetto al costante, e dando luogo d’altro lato a una sovraproduzione in rapporto alla domanda estera, produce a sua volta alla lunga l’effetto opposto. E così si è visto, in generale, che le medesime cause che determinano la caduta del tasso del profitto, dànno origine a forze antagonistiche che ostacolano, rallentano e parzialmente paralizzano questa caduta. E se non fosse per questa azione contrastante non sarebbe la caduta del tasso del profitto ad essere incomprensibile, ma al contrario la relativa lentezza di questa caduta. In tal modo la legge si riduce ad una semplice tendenza, là cui efficacia si manifesta in modo convincente solo in condizioni determinate e nel corso di lunghi periodi di tempo.
VI. L’accrescimento del capitale azionario.A misura che la produzione capitalistica che va di pari passo con l’accumulazione accelerata si sviluppa,
una parte del capitale viene calcolata ed impiegata unicamente come capitale produttivo di interessi: nel senso che questi capitali, quantunque investiti in grandi imprese industriali, come per es. le ferrovie, una volta dedotti tutti i costi, rendono semplicemente degli interessi più o meno considerevoli, i cosiddetti dividendi. Questi capitali non entrano nel livellamento del tasso generale del profitto, dando essi un tasso del profitto inferiore alla media: qualora vi entrassero questo tasso diminuirebbe in misura ben maggiore. Da un punto di vista teorico si potrebbe tenerne conto e si otterrebbe allora un tasso del profitto minore di quello che esiste in apparenza e che fa in realtà decidere i capitalisti, poiché è precisamente in queste imprese che il capitale costante è più grande in rapporto al variabile.
[C. III, 13-14]
185

II.4.2. La sovraproduzione e lo sviluppo della crisi
L’intero processo dell’accumulazione si risolve in sovraproduzione, che corrisponde da un lato alla crescita naturale della popolazione, dall’altro forma una base immanente ai fenomeni, che si mostrano nelle crisi. La misura di questa sovraproduzione è lo stesso capitale, la scala esistente delle condizioni di produzione e lo smisurato anelito all’arricchimento e alla capitalizzazione dei capitalisti, non il consumo, che è limitato a priori perché la maggior parte della popolazione, la popolazione lavoratrice, può ampliare solo entro limiti molto ristretti il suo consumo, e d’altra parte nella stessa misura in cui il capitalismo si sviluppa, la domanda di lavoro diminuisce relativamente benché essa aumenti assolutamente. L’idea (propriamente appartenente a James Mill) di quell’insulso di Say (su cui ritorneremo nella critica di questo miserabile), adottata da Ricardo, che non sia possibile alcuna sovraproduzione o almeno nessuna strozzatura generale nel mercato [no general glut of the market], poggia sulla tesi che prodotti vengono scambiati contro prodotti o, come aveva detto Mill, sull’“equilibrio metafisico fra venditori e compratori”, il che fu ulteriormente sviluppato nella tesi che la domanda fosse determinata solo dalla produzione o anche dell’ identità tra domanda e offerta. Poiché Ricardo si richiama a Say, criticheremo in seguito le tesi di Say in questa ciarlataneria. Qui provvisoriamente facciamo notare soltanto quanto segue: nella riproduzione, al pari che nell’accumulazione di capitale, non si tratta solo di ricostituire la stessa massa di valori d’uso di cui consta il capitale, alla loro vecchia scala o su una allargata (con l’accumulazione), ma di ricostituire il valore del capitale anticipato con il tasso di profitto consueto (plusvalore).
Il termine overproduction induce in sé in errore. Finché i bisogni più urgenti di una gran parte della società non sono soddisfatti o lo sono solo i suoi bisogni immediati, naturalmente non si può assolutamente parlate di una sovraproduzione di prodotti – nel senso che la massa dei prodotti sarebbe sovrabbondante in rapporto ai bisogni di essi. Si deve dire al contrario che in base alla produzione capitalistica si sottoproduce, in questo senso, continuamente. Il limite della produzione è il profitto dei capitalisti, in nessun modo il bisogno dei produttori. Ma sovraproduzione di prodotti e sovraproduzione di merci sono due cose del tutto diverse. Non va mai dimenticato che nella produzione capitalistica non si tratta direttamente del valore d’uso, ma del valore di scambio e specialmente dell’aumento del plusvalore. Questo è il motivo motore della produzione capitalistica ed è una bella concezione quella che, per abolire le contraddizioni della produzione capitalistica, fa astrazione dalla sua base e la rende una produzione indirizzata al consumo immediato dei produttori. Quando si parla di distruzione dì capitale attraverso le crisi, bisogna fare una duplice distinzione. In quanto il processo di riproduzione si arresta, il processo lavorativo viene limitato o talvolta interamente arrestato, viene distrutto capitale reale. Il macchinario che non viene usato, non è capitale. Il lavoro che non viene sfruttato equivale a produzione perduta. Materia prima che giace inutilizzata non è capitale. Costruzioni che restano inutilizzate (altrettanto quanto nuovo macchinario costruito) o restano incompiute, merci che marciscono nel magazzino, tutto ciò è distruzione di capitale. Tutto ciò si limita all’arresto del processo di riproduzione e al fatto che le condizioni di produzione esistenti non operano realmente come condizioni di produzione, non vengono messe in funzione. Il loro valore d’uso e il loro valore di scambio vanno con ciò al diavolo.
In secondo luogo, però, distruzione del capitale attraverso le crisi significa un deprezzamento di masse di valore che impedisce loro dì rinnovare più tardi il loro processo di riproduzione come capitale sulla stessa scala. È la caduta rovinosa dei prezzi delle merci. Con ciò non viene distrutto nessun valore d’uso. Ciò che perde l’uno, guadagna l’altro. Alle masse di valore operanti come capitali viene impedito di rinnovarsi come capitale nella stessa mano. I vecchi capitalisti fanno bancarotta. Una gran parte del capitale nominale della società, cioè del valore di scambio del capitale esistente, è distrutta una volta per tutte, benché proprio questa distruzione, poiché essa non tocca il valore d’uso, possa favorire molto la nuova riproduzione, È questa al tempo stesso un’epoca in cui l’interesse monetario si arricchisce a spese dell’interesse industriale. Ora, per ciò che concerne la caduta di capitale semplicemente fittizio, titoli di stato, azioni ecc. – nella misura in cui essa non porta alla bancarotta dello stato e della società per azioni e cosi non viene in generale rallentata la riproduzione, in quanto il credito dei capitalisti industriali che detengono tali titoli ne viene scosso – si tratta di un semplice trasferimento della ricchezza da una mano a un’altra e in complesso agirà favorevolmente sulla riproduzione, in quanto i nuovi ricchi nelle cui mani queste azioni o titoli cadono a buon mercato, per lo più sono più intraprendenti dei vecchi possessori.
Nelle crisi del mercato mondiale le contraddizioni e le antitesi della produzione borghese vengono ad esplosione. Ora, anziché indagare in che cosa consistano gli elementi contraddittori che esplodono nella catastrofe, gli apologeti si accontentano di negare la catastrofe stessa e di insistere, di fronte alla loro periodicità regolare, sul fatto che se la produzione si conformasse ai libri scolastici non si arriverebbe mai alla crisi. L’apologetica consiste allora nella falsificazione dei più semplici rapporti economici e specialmente nel tener ferma l’unità di fronte all’antitesi. Se, per esempio, compra e vendita – ossia il
186

movimento di metamorfosi della merce – rappresenta l’unità di due processi o meglio il corso di un processo attraverso due fasi contrapposte, quindi è essenzialmente l’unità di ambedue le fasi, essa è altrettanto essenzialmente la separazione di esse e il loro farsi indipendenti l’una di fronte all’altra. Ora, tuttavia, poiché esse sono congiunte, il farsi indipendenti di momenti congiunti può manifestarsi solo violentemente come processo distruttivo. È appunto la crisi in cui si realizza la loro unità, l’unità dei distinti. L’indipendenza che i momenti appartenenti l’uno all’altro e completantisi assumono l’uno rispetto all’altro, viene violentemente distrutta. La crisi, dunque, manifesta l’unità di momenti fattisi indipendenti l’uno di fronte all’altro. Nessuna crisi avrebbe luogo senza questa interna unità dei due momenti apparentemente indifferenti l’uno all’altro. Ma no, dice l’economista apologeta. Siccome ha luogo l’unità, non può aver luogo nessuna crisi. Il che a sua volta nient’altro significa se non che l’unità di opposti esclude l’antitesi. Le frasi apologetiche per negare la crisi, intanto sono importanti, in quanto esse dimostrano sempre il contrario di ciò che vogliono dimostrare. Esse – per negare la crisi – affermano unità dove esiste antitesi e contraddizione. Dunque, intanto sono importanti in quanto si può dire: esse dimostrano che, se di fatto le contraddizioni da esse eliminate con la fantasia non esistessero, non esisterebbe neanche la crisi. Ma di fatto la crisi esiste, perché esistono quelle contraddizioni. Ogni motivo che esse adducono contro la crisi, è una contraddizione eliminata con la fantasia, quindi una contraddizione reale, quindi un motivo della crisi. Il voler eliminare con la fantasia le contraddizioni è contemporaneamente l’espressione di contraddizioni realmente esistenti che secondo il pio desiderio non devono esistere.
Nella parola “prodotto” l’essenza della merce e la contraddizione insita in essa vengono soppresse. Anche il denaro viene allora conseguentemente concepito come semplice intermediario dello scambio di prodotti, non come una forma di esistenza essenziale e necessaria della merce, che deve rappresentarsi come valore di scambio – lavoro sociale generale. Cancellando, con la trasformazione della merce in semplice valore d’uso (prodotto), l’essenza del valore di scambio, si può o meglio si deve altrettanto facilmente negare il denaro come una forma essenziale della merce e, nel processo di metamorfosi, indipendente rispetto alla forma originaria della merce. Qui dunque le crisi vengono eliminate mediante un ragionamento che dimentica o nega i primi presupposti della produzione capitalistica, l’esistenza del prodotto come merce, lo sdoppiamento della merce in merce e denaro, i momenti da ciò risultanti della separazione nello scambio di merci, infine il rapporto fra il denaro o la merce e il lavoro salariato. Non migliori sono del resto gli economisti (come J.S, Mill, per esempio) che vogliono spiegare le crisi da queste semplici possibilità della crisi contenute nella metamorfosi delle merci – come la separazione di compra e vendita. Queste determinazioni che spiegano la possibilità della crisi, sono ben lontane dallo spiegare la sua realtà, non spiegano ancora perché le fasi del processo entrano in tale conflitto che solo mediante una crisi, mediante un processo violento, può farsi valere la loro interna unità, Questa separazione si manifesta nella crisi; è la forma elementare di essa. Spiegare la crisi da questa sua forma elementare è come spiegare l’esistenza della crisi esprimendo la sua esistenza nella sua forma più astratta, quindi spiegare la crisi mediante la crisi.
Quale bonaria proclamazione dei rapporti borghesi! Ricardo dimentica perfino che uno può vendere per pagare e che queste vendite forzate giocano un ruolo molto importante nelle crisi. Il fine più prossimo del capitalista nel vendere è di ritrasformare la sua merce o meglio il suo capitale-merci in capitale-denaro e di realizzare con questo il suo guadagno. Il consumo – il reddito – non è qui affatto un punto guida per questo processo, cosa che certo è per colui il quale vende merci semplicemente per trasformarle in mezzi di sussistenza. Questa, però, non è la produzione capitalistica nella quale il reddito appare come un risultato, non come uno scopo determinante. Ognuno vende anzitutto per vendere, cioè per trasformare merce in denaro. Del resto si comprende da sé nell’intero esame: non si può negare che in singole sfere si può sovraprodurre e perciò in altre si può produrre troppo poco; possono quindi scaturire crisi parziali da produzione spropor-zionata (ma la produzione proporzionata è sempre soltanto il risultato della produzione sproporzionata in base alla concorrenza) e una forma generale di questa produzione sproporzionata può essere sovraproduzione di capitale fisso o d’altra parte sovraproduzione di capitale circolante. Ciò non pertanto noi non parliamo qui della crisi in quanto poggia su una produzione sproporzionata, cioè su una sproporzione della divisione del lavoro sociale fra le singole sfere di produzione. Se ne può parlare solo in quanto si parla della concorrenza dei capitali.
Questa spiegazione della sovraproduzione da un lato mediante la sottoproduzione dall’altro, non significa dunque altro che: se avesse luogo una produzione proporzionata, non avrebbe luogo alcuna sovraproduzione. Parimenti, se domanda e offerta si corrispondessero. Parimenti se tutte le sfere includessero le stesse possibilità della produzione capitalistica e del suo allargamento – divisione del lavoro, macchinario, esportazione in mercati lontani, ecc, produzione in massa –, se tutti i paesi che commerciano l’uno con l’altro possedessero uguale capacità di produzione (e precisamente una produzione diversa e integrantesi). Dunque ha luogo una sovraproduzione perché tutti questi pii desideri non hanno luogo. O ancor più astrattamente: non avrebbe luogo nessuna sovraproduzione da una parte, se avesse luogo uniformemente da tutte le parti una sovraproduzione. Ma il capitale non è sufficientemente grande da sovraprodurre così universalmente, e
187

perciò ha luogo una sovraproduzione parziale. Il fatto che solo particolari, non tutti i generi di merci possano formare una “strozzatura” [glut] del mercato, che perciò la sovraproduzione possa essere sempre soltanto parziale, è un meschino espediente. Anzitutto se si considera semplicemente la natura della merce, nulla osta che tutte le merci siano presenti in eccedenza sul mercato e perciò che tutte cadano al di sotto del loro prezzo. Si tratta qui proprio solo del momento della crisi. Vale a dire che tutte le merci, tranne il denaro, possono esservi in eccedenza. Il fatto che esista per la merce la necessità di rappresentarsi come denaro, significa solo che la necessità esiste per tutte le merci. E come esiste per una singola merce la difficoltà di attraversare questa metamorfosi, così essa può esistere per tutte.
L’offerta di tutte le merci può, in un dato momento, essere maggiore della domanda di tutte le merci, essendo la domanda della merce generale – il denaro – il valore di scambio, maggiore della domanda di tutte le merci particolari. Perché una crisi (quindi anche la sovraproduzione) sia generale, basta che essa afferri gli articoli di commercio dominanti. Attraverso la separazione del processo di produzione (immediato) e del processo di circolazione è di nuovo e ulteriormente sviluppata la possibilità della crisi che si mostrava nella semplice metamorfosi della merce. Appena essi non trapassano l’uno nell’altro fluidamente, ma si fanno indipendenti l’uno di fronte all’altro, c’è la crisi. Nella produzione di merci la trasformazione del prodotto in denaro, la vendita, è conditio sine qua non. La produzione immediata per il bisogno proprio viene a cessare. Con la non vendita esiste una crisi. La difficoltà di trasformare la merce – il prodotto particolare di lavoro individuale – in denaro, il suo opposto, in lavoro astrattamente generale, sociale, sta nel fatto che il denaro non appare come prodotto particolare di lavoro individuale, nel fatto che colui il quale ha venduto e quindi possiede la merce nella forma del denaro, non è costretto a ricomprare subito, a trasformare di nuovo il denaro in un prodotto particolare di lavoro individuale. Nel baratto non c’è questa antitesi.
Possibilità generale, astratta della crisi – nient’altro significa che la forma più astratta della crisi, senza contenuto, senza un movente significativo della medesima. Vendita e compra possono separarsi. Esse sono quindi una crisi potentia e il loro coincidere resta sempre un momento critico per la merce. Ma esse possono trapassare l’una nell’altra fluidamente. Resta dunque che la forma più astratta della crisi (e quindi la possibilità formale della crisi) è la stessa metamorfosi della merce in cui è contenuta, solo come movimento sviluppato, la contraddizione, inclusa nell’unità della merce, fra valore di scambio e valore d’uso e fra denaro e merce. Ma la via attraverso la quale questa possibilità della crisi diventa crisi, non è contenuta in questa forma stessa; vi è contenuto solo che esiste la forma per una crisi. E questo è l’importante nell’esame dell’economia borghese. Le crisi del mercato mondiale devono essere concepite come la concentrazione reale e la compensazione violenta di tutte le contraddizioni dell’economia borghese. Si può dunque dire: la crisi nella sua prima forma è la stessa metamorfosi della merce, la separazione di compra e vendita.
La crisi nella sua seconda forma è la funzione del denaro come mezzo di pagamento, dove il denaro figura in due momenti diversi, separati nel tempo, in due diverse funzioni. Queste due forme sono ancora del tutto astratte, benché la seconda sia più concreta della prima. La possibilità generale delle crisi nel processo della metamorfosi del capitale stesso è data, e invero doppiamente: in quanto il denaro funge da mezzo di circolazione – separazione di compra e vendita; in quanto funge da mezzo di pagamento, dove_esso opera in due momenti differenti come misura dei valori e come realizzazione del valore. Ambedue questi momenti si separano. Se il valore è cambiato nell’intervallo, se la merce nel momento della sua vendita non vale quanto essa valeva nel momento in cui il denaro funzionava come misura dei valori e quindi delle reciproche obbligazioni, allora l’obbligazione non può essere adempiuta col ricavato della merce e quindi non può essere saldata l’intera serie di transazioni che dipendono regressivamente da questa ultima. Anche se la merce non può essere venduta che in un determinato spazio di tempo, anche se il suo valore non cambiasse il denaro non può funzionare come mezzo di pagamento, perché deve funzionare come tale in un tempo determinato, presupposto. Ma poiché qui la stessa somma di denaro funziona per una serie di transazioni e di obbligazioni reciproche, sopravviene qui un’incapacità di pagamento non solo in uno, ma in molti punti, di qui la crisi. Queste sono le possibilità formali della crisi. La prima è possibile senza la seconda – cioè crisi senza credito, senza che il denaro funzioni come mezzo di pagamento. La seconda però non è possibile senza la prima, senza cioè che compra e vendita si separino. Ma nell’ultimo caso la crisi sopravviene non solo perché una merce è invendibile, ma perché non è vendibile in un determinato spazio di tempo, e la crisi nasce e deriva il suo carattere non solo dall’invendibilità della merce, ma anche dalla non realizzazione di un’intera serie di pagamenti che poggiano sulla vendita di questa determinata merce in questo determinato tempo. Questa è la forma vera e propria delle crisi monetarie.
Dunque, se sopravviene una crisi perché compra e vendita si separano, essa allora si sviluppa come crisi monetaria, non appena il denaro è sviluppato come mezzo di pagamento, e questa seconda forma delle crisi s’intende da sé non appena sopravviene la prima. Nella ricerca del perché la possibilità generale della crisi diventi realtà, nella ricerca delle condizioni della crisi è dunque assolutamente superfluo curarsi della forma delle crisi che scaturiscono dallo sviluppo del denaro come mezzo di pagamento. Appunto perciò gli economisti amano addurre a pretesto questa forma ovvia come causa delle crisi. Ma non è ancora un
188

contenuto fondato. La circolazione semplice del denaro e anche la circolazione del denaro come mezzo di pagamento –e ambedue compaiono molto prima della produzione capitalistica, senza che compaiano crisi – sono possibili e reali senza crisi. Perché dunque queste forme mettano in mostra il loro lato critico, perché la contraddizione in esse contenuta potentia si manifesti actu come tale, non si può spiegare con queste forme soltanto. Dunque si vede l’enorme insulsaggine degli economisti i quali, poiché non potevano più negare con i loro ragionamenti il fenomeno della sovrapproduzione e delle crisi, si tranquillizzano col fatto che in quelle forme è data solo la possibilità che sopravvengano crisi, è quindi casuale che esse non sopravvengano e con ciò che il loro sopravvenire stesso appare come un semplice caso. Le contraddizioni sviluppate nella circolazione delle merci, e più ampiamente nella circolazione del denaro — con ciò le possibilità della crisi — si riproducono da sé nel capitale, poiché di fatto solo sulla base del capitale ha luogo una sviluppata circolazione di merci e di denaro. Ora però si tratta di seguire lo sviluppo ulteriore della crisi potentia – la crisi reale può essere rappresentata solo dal movimento reale della produzione capitalistica, concorrenza e credito – in quanto essa risulta dalle determinazioni formali del capitale che gli sono peculiari come capitale e non sono incluse nella sua semplice esistenza come merce e denaro.
Il semplice processo di produzione (immediato) del capitale non può in sé aggiungere qui niente di nuovo. Affinché esso in generale esista, le sue condizioni sono supposte. Perciò nella prima sezione, sul capitale – sul processo immediato di produzione – non sopravviene nessun nuovo elemento della crisi. Vi è contenuto in sé, perché il processo di produzione è appropriazione e perciò produzione di plusvalore. Ma nel processo stesso di produzione questo non può manifestarsi, perché in esso non si tratta della realizzazione del valore non soltanto riprodotto, ma di plusvalore. La cosa può farsi manifesta solo nel processo di circolazione, che in sé e per sé è contemporaneamente processo di riproduzione. Il processo complessivo di circolazione o il processo complessivo di riproduzione del capitale è l’unità della sua fase di produzione e della sua fase di circolazione, un processo che si svolge attraverso i due processi in quanto sue fasi. In questo è insita una possibilità ulteriormente sviluppata o forma astratta della crisi. Gli economisti che negano la crisi si attengono quindi solo all’unità di ambedue queste fasi. Se esse fossero solo separate, senza essere una sola cosa, allora non sarebbe possibile appunto nessun ristabilimento violento della loro unita, nessuna crisi. Se esse fossero solo una cosa sola, senza essere separate, allora non sarebbe possibile nessuna separazione violenta, il che è di nuovo la crisi. Essa è il violento ristabilimento dell’unità fra momenti indipendenti e il violento farsi indipendenti di momenti che essenzialmente sono una cosa sola.
La possibilità generale delle crisi è la metamorfosi formale del capitale stesso, la separazione temporale e spaziale di compra e vendita. Ma questa non è mai la causa della crisi. Perché non è altro che la forma più generale della crisi, quindi la crisi stessa nella sua espressione più generale. Non si può però dire che la forma astratta della crisi sia la causa della crisi. Se si cerca la sua causa, si vuole appunto sapere perché la sua forma astratta, la forma della sua possibilità, da possibilità diventa realtà. Una crisi può risultare: 1. nella riconversione in capitale produttivo; 2. da variazioni di valore negli elementi del capitale produttivo, specialmente della materia prima, per esempio se il suo valore sale. Dunque, il valore della materia prima sale, la sua massa diminuisce o il rapporto in cui il denaro si dovrebbe ritrasformare nelle diverse parti costitutive del capitale per continuare la produzione alla vecchia scala, è turbato. Si deve spendere di più in materia prima, resta meno per lavoro e non può essere assorbita la stessa massa di lavoro come finora. La riproduzione non può essere ripetuta sulla stessa scala. Una parte del capitale fisso sta ferma, una parte di lavoratori viene gettata sul lastrico. Il tasso di profitto cade, perché il valore del capitale costante è diminuito rispetto a quello variabile e viene impiegato meno capitale variabile. Le spese fisse – interesse, rendita – che sono anticipate a parità di tasso del profitto e di sfruttamento del lavoro, restano le stesse, in parte non possono essere pagate. Di qui una crisi. Crisi di lavoro e crisi di capitale.
È questa quindi una perturbazione del processo di riproduzione per opera di un aumento di valore della parte del capitale costante che va sostituita col valore del prodotto. Inoltre ha luogo, benché il tasso di profitto si abbassi, un rincaro del prodotto. Se questo prodotto entra come mezzo di produzione in altre sfere di produzione, il suo rincaro causa qui la stessa perturbazione [dérangement] nella riproduzione. Crisi che risultano da perturbazioni della prima fase della riproduzione; quindi trasformazione perturbata delle merci in denaro o perturbazione della vendita. Con le crisi del primo genere [che nascono da un rincaro delle materie prime], la crisi risulta da perturbazioni nel movimento retrogrado degli elementi del capitale produttivo. Nel processo di produzione abbiamo visto che tutto l’anelito della produzione capitalistica consiste nell’ accaparrare il massimo di pluslavoro, quindi di materializzare il massimo di tempo di lavoro immediato con un dato capitale, sia mediante prolungamento del tempo di lavoro, sia mediante accorciamento del tempo di lavoro necessario, mediante lo sviluppo delle forze produttive del lavoro, impiego di cooperazione, divisione del lavoro, macchinano, ecc.; per farla breve mediante una produzione su scala maggiore, quindi mediante una produzione in massa. Nell’essenza della produzione capitalistica è insita quindi una produzione senza riguardo ai limiti del mercato.
189

Nella riproduzione viene anzitutto presupposto che il modo di produzione resti lo stesso, e questo resta tale per qualche tempo nell’allargamento della produzione. Qui la massa delle merci prodotte viene aumentata, perché viene impiegato più capitale, non perché esso venga impiegato più produttivamente. Ma il semplice aumento quantitativo del capitale implica contemporaneamente che la forza produttiva del medesimo venga aumentata. Se il suo aumento quantitativo è una conseguenza dello sviluppo della forza produttiva, questa allora a sua volta inversamente si sviluppa sul presupposto di un fondamento capitalistico più largo, allargato. Ha luogo qui un’interazione. La riproduzione su base più larga, l’accumulazione, se essa si rappresenta originariamente solo come un ampliamento quantitativo della produzione – con più capitale nelle stesse condizioni di produzione –, si rappresenta perciò a un certo punto sempre anche qualitativamente come maggiore fertilità delle condizioni nelle quali procede la riproduzione. Perciò un aumento della massa di prodotti è aaccresciuto non solo nel rapporto semplice, come il capitale nella riproduzione allargata, nell’accumulazione.
Se si volesse rispondere che la produzione sempre allargantesi (che si allarga annualmente per due motivi; in primo luogo perché il capitale investito nella produzione cresce continuamente; in secondo luogo perché viene impiegato continuamente in modo più produttivo; durante la riproduzione e l’accumulazione si ammucchiano continuamente piccoli miglioramenti che alla fine hanno modificato l’intera scala della produzione: ha luogo un ammucchiamento di miglioramenti, uno sviluppo accatastantesi delle forze produttive) ha bisogno di un mercato sempre allargato e che la produzione si allarga più rapidamente del mercato, si è solo diversamente espresso il fenomeno che va spiegato, anziché nella sua forma astratta lo si è espresso nella sua forma reale. Il mercato si allarga più lentamente della produzione ovvero nel ciclo che il capitale percorre durante la sua riproduzione – un ciclo in cui esso non si riproduce semplicemente, bensì su scala allargata, non descrive un circolo, ma una spirale – sopraggiunge un momento in cui il mercato appare troppo stretto per la produzione. Questo è alla fine del ciclo. Ma ciò significa semplicemente: il mercato è “strozzato” La sovraproduzione è manifesta. Se l’allargamento del mercato avesse tenuto il passo con l’allargamento della produzione, non ci sarebbe nessuna strozzatura dei mercati [no glut of markets], nessuna sovraproduzione.
Tuttavia con la semplice ammissione che il mercato si deve allargare con la produzione, sarebbe già data d’altro canto anche la possibilità di una sovraproduzione, poiché il mercato è geograficamente circoscritto esternamente, il mercato interno appare come limitato di fronte ad un mercato che è interno ed esterno, e quest’ultimo a sua volta è limitato rispetto al mercato mondiale il quale però, in ogni istante, è a sua volta limitato, pur essendo capace in sé di allargamento. Se perciò è ammesso che il mercato deve allargarsi, che nessuna sovraproduzione deve avere luogo, è anche ammesso che possa aver luogo una sovraproduzione, perché è possibile allora, in quanto mercato e produzione sono due momenti indifferenti l’uno rispetto all’altro, che l’allargamento dell’uno non corrisponda all’allargamento dell’altro, che i limiti del mercato non si allarghino abbastanza rapidamente per la produzione oppure che nuovi mercati – nuovi allargamenti del mercato – possano essere rapidamente superati dalla produzione, così che ora il mercato allargato appaia come un limite, tanto quanto prima quello più stretto: che cosa significa dunque sovraproduzione di capitale? Sovraproduzione delle masse di valore che sono destinate a generare plusvalore (o, considerata secondo il contenuto materiale, sovraproduzione di merci che sono destinate alla riproduzione) – quindi riproduzione su scala troppo grande, il che equivale a sovraproduzione semplicemente.
Definito più da vicino, ciò non significa altro se non che si produce troppo al fine dell’arricchimento o che una parte troppo grande del prodotto è destinata non ad essere consumata come reddito, ma a fare più denaro (ad essere accumulata) non a soddisfare i bisogni privati del suo possessore, ma a creargli la ricchezza sociale astratta, denaro e più potere sul lavoro altrui, a creare capitale – o ad accrescere questo potere. Poc’anzi è stato negato il denaro per rappresentare come inesistente la separazione fra compra e vendita. Qui si nega il capitale per trasformare i capitalisti in gente che compie la semplice operazione M-D-M e che produce per il consumo individuale, non come capitalisti, con lo scopo dell’arricchimento, con lo scopo di ritrasformare una parte del plusvalore in capitale. Ma la frase che c’è troppo capitale non significa certo altro se non che viene consumato troppo poco come reddito e che può essere consumato solo in condizioni date [Sismondi]. Tutte le contraddizioni della produzione borghese vengono collettivamente ad esplosione nelle crisi mondiali generali, nelle crisi particolari (particolari secondo il contenuto e l’estensione) solo in maniera dispersa, isolata, unilaterale. La sovraproduzione in modo speciale ha per condizione la legge generale di produzione del capitale, di produrre nella misura delle forze produttive (cioè della possibilità di sfruttare, con una data massa di capitale, una massa di lavoro la più grande possibile) senza riguardo per i limiti del mercato esistenti o per i bisogni solvibili, e di realizzare questo per mezzo di un continuo allargamento della riproduzione e dell’accumulazione, quindi una continua ritrasformazione di reddito in capitale, mentre d’altro canto la massa dei produttori resta limitata alla misura media di bisogni e deve restare limitata secondo l’organizzazione della produzione capitalistica.
[TP. 17]
190

II.4.3. Gli ostacoli al processo di produzione
Ora invece compaiono ostacoli al processo stesso. Anzitutto, da un punto di vista del tutto superficiale, la merce è valore di scambio solo nella misura in cui è al tempo stesso valore d’uso, vale a dire oggetto di consumo (di che tipo di consumo, per ora è ancora indifferente); essa cessa di essere valore di scambio quando cessa di essere valore d’uso (giacché non esiste ancora di nuovo come denaro, ma in un modo determinato che coincide con la sua qualità naturale). Il suo primo ostacolo dunque è il consumo stesso – il bisogno che se ne ha (in base alle premesse finora poste non è ancora assolutamente possibile parlare di un bisogno insolvibile, ossia di un bisogno di una merce il quale non abbia da dare in cambio anch’esso una merce o denaro). In secondo luogo però deve esserci un equivalente per essa; ma poiché all’origine si è premesso che la circolazione fosse una grandezza fissa – di un volume determinato – e d’altra parte il capitale nel processo di produzione ha creato un nuovo valore, sembra in realtà che per quest’ultimo non possa esserci alcun equivalente. Sicché quando il capitale esce dal processo di produzione per rientrare di nuovo in circolazione, sembra che esso: a) trovi, come produzione, un ostacolo nella grandezza esistente del consumo, o della capacità di consumo; b) ma come nuovo valore e valore in generale sembra che esso trovi un ostacolo nel volume degli equivalenti esistenti, e anzitutto del denaro, inteso non come mezzo di circolazione ma come denaro. Il plusvalore (evidentemente, quello relativo al valore originario) richiede un equivalente supplementare. Ed è questo ora il secondo ostacolo.
Queste, dunque, le contraddizioni che si offrono spontaneamente ad un esame puramente oggettivo e imparziale. In che modo poi nella produzione capitalistica esse vengano continuamente superate ma anche continuamente riprodotte – e superate soltanto violentemente (quantunque questo superamento si presenti fino ad un certo punto semplicemente come una pacifica conciliazione) – questo è un altro problema. L’importante è anzitutto constatare l’esistenza di queste contraddizioni. Tutte le contraddizioni della circolazione rivivono in una nuova forma. Il prodotto come valore d’uso è in contraddizione con se stesso come valore; cioè, finché esso esiste in una determinata qualità, come una cosa specifica, come un prodotto di determinate proprietà naturali, come sostanza del bisogno in contraddizione con la sua sostanza che esso come valore possiede esclusivamente nel lavoro oggettivato. Questa volta però questa contraddizione non è più posta, come nella circolazione, soltanto in modo da essere una differenza puramente formale; qui invece l’esser misurato dal valore d’uso è rigorosamente determinato come un esser misurato dal bisogno globale che coloro che scambiano hanno di tale prodotto – vale a dire dalla quantità del consumo globale. Questo consumo globale qui si presenta come la misura del prodotto in quanto valore d’uso e perciò anche in quanto valore di scambio. Nella circolazione semplice non restava altro. D’altra parte la precedente contraddizione, per cui il denaro per sé stante doveva passare a scambiarsi col lavoro vivo, risulta ora ancor più macroscopica, in quanto il denaro in più per essere tale, ovvero il plusvalore, deve scambiarsi con plusvalore. Come valore quindi esso ha il suo ostacolo nella produzione altrui tanto quanto come valore d’uso ha il suo ostacolo nel consumo altrui; qui ha la sua misura nella quantità del bisogno dello specifico prodotto, là nella quantità di lavoro oggettivato esistente in circolazione. L’indifferenza del valore in quanto tale nei confronti del valore d’uso è con ciò messa nella stessa posizione falsa in cui si trovano d’altra parte la sostanza e la misura del valore come valore oggettivato in generale .
Non è ancora possibile passare al rapporto tra domanda, offerta e prezzi, i quali nel loro sviluppo specifico presuppongono il capitale. Finché domanda e offerta sono categorie astratte, e non esprimono ancora determinati rapporti economici, non vanno forse prese in considerazione già al momento della circolazione o della produzione semplice? Precedentemente, a proposito del processo di valorizzazione del capitale, abbiamo visto come esso presupponesse già lo sviluppo del processo di produzione semplice. Allo stesso modo con la domanda e l’offerta accadrà che nello scambio semplice si presuppone un bisogno del prodotto. Il bisogno proprio del produttore (diretto) come bisogno di domanda altrui. In questo stesso sviluppo ciò che deve essergli presupposto deve presentarsi come un risultato (e tutto questo in séguito va messo dunque nei primi capitoli).
Il plusvalore creato in un punto esige la creazione di plusvalore in un altro punto, col quale possa entrare in scambio, anche se in un primo momento si tratti soltanto della produzione di più oro e argento, di più denaro; in tal modo, se il plusvalore non può ridiventare immediatamente capitale, sotto forma di denaro ha tuttavia la possibilità di diventare nuovo capitale. Una condizione della produzione basata sul capitale è perciò la produzione di un circolo della circolazione continuamente allargato, o direttamente, oppure creando in esso più punti di produzione. Se dapprima la circolazione si presentava come grandezza fissa, qui ora essa si presenta come grandezza variabile, che si espande attraverso la produzione stessa. Per conseguenza, la circolazione si presenta essa stessa come un momento della produzione. Il capitale perciò, se per un verso ha la tendenza a creare perennemente più pluslavoro, per l’altro ha la tendenza supplementare a
191

creare più punti di scambio; ossia qui, dal punto di vista del plusvalore o del pluslavoro assoluto, la tendenza ad attirare a sé, in via supplementare, maggior pluslavoro; au fond la tendenza a propagare la produzione basata sul capitale o il modo di produzione a esso corrispondente; a subordinare anzitutto ogni momento della produzione stessa allo scambio, e di sopprimere la produzione di valori d’uso immediati che non rientrino nello scambio, ossia appunto di sostituire una produzione basata sul capitale ai modi di produzione precedenti e, dal suo punto di vista, primitivi. La tendenza a creare il mercato mondiale è data immediatamente nel concetto stesso di capitale. Ogni limite si presenta qui come un ostacolo da superare.
Di qui l’enorme influenza civilizzatrice del capitale; la sua creazione di un livello sociale rispetto a cui tutti quelli precedenti si presentano semplicemente come sviluppi locali dell’umanità e come idolatria della natura. Soltanto col capitale la natura diventa un puro oggetto per l’uomo, un puro oggetto di utilità, e cessa di essere riconosciuta come forza per sé; e la stessa conoscenza teoretica delle sue leggi autonome si presenta semplicemente come astuzia capace di subordinarla ai bisogni umani sia come oggetto di consumo sia come mezzo di produzione. In virtù di questa sua tendenza, il capitale spinge a superare sia le barriere e i pregiudizi nazionali, sia l’idolatria della natura, la soddisfazione tradizionale, orgogliosamente ristretta entro angusti limiti, dei bisogni esistenti, e la riproduzione del vecchio modo di vivere. Nei riguardi di tutto questo il capitale opera distruttivamente, attua una rivoluzione permanente, abbatte tutti gli ostacoli che frenano lo sviluppo delle forze produttive, la dilatazione dei bisogni, la varietà della produzione e lo sfruttamento e lo scambio delle forze della natura e dello spirito. Ma dal fatto che il capitale pone ciascuno di questi limiti come un ostacolo e perciò idealmente lo ha superato, non ne deriva affatto che esso lo abbia superato realmente, e poiché ciascuno di tali ostacoli contraddice alla sua destinazione, la sua produzione si muove tra contraddizioni continuamente superate ma altrettanto continuamente poste. E c’è di più.
In questo senso gli economisti che, come Ricardo, identificano immediatamente la produzione con l’auto -valorizzazione del capitale – e che quindi, incuranti sia degli ostacoli del consumo sia degli ostacoli oggettivi della circolazione stessa finché questa deve offrire su tutti i punti degli equivalenti, guardano soltanto allo sviluppo delle forze produttive e all’aumento della popolazione industriale, all’offerta senza riguardo per la domanda – costoro, dicevamo, hanno compreso la natura positiva del capitale in maniera molto più esatta e più profonda di quanto abbiano fatto coloro i quali, come Sismondi, sottolineano gli ostacoli del consumo e della sfera esistente degli equivalenti, sebbene quest’ultimo abbia compreso più profondamente la limitatezza della produzione basata sul capitale, la sua unilateralità negativa. Il primo ha compreso di più la sua tendenza universale, il secondo, la sua limitatezza particolare. Tutta la polemica sulla possibilità e necessità della sovraproduzione al livello del capitale, verte sul problema se il processo di valorizzazione del capitale nella produzione implichi immediatamente la sua valorizzazione nella circolazione; se cioè la sua valorizzazione nel processo di produzione è la sua valorizzazione reale.
I tentativi operati dal punto di vista economico ortodosso di negare una sovraproduzione generale in un dato momento, sono in realtà puerili. Per salvare la produzione basata sul capitale, o si prescinde da tutte le sue caratteristiche specifiche, dalle sue determinazioni concettuali, e la si concepisce viceversa come una produzione semplice indirizzata al valore d’uso immediato; ossia si astrae totalmente dai rapporti sostanziali e, per purificarla dalle contraddizioni, si finisce in effetti col sopprimerla e negarla addirittura – ed è la posizione di MacCulloch. Oppure si afferma che domanda e offerta sono identiche e perciò debbono corrispondersi – ed è la posizione più sottile di Mill (imitato dall’insulso Say). L’offerta cioè sarebbe una domanda misurata dalla sua propria quantità. Ma qui si fa una gran confusione: ciò che il capitale produttivo esige non è un determinato valore d’uso, ma il valore per sé, ossia denaro – denaro non nella determinazione di mezzo di circolazione, ma come forma generale della ricchezza, o forma della realizzazione del capitale, da un lato, e ritorno alla sua originaria condizione statica dall’altro. Ma affermare che venga prodotto meno denaro, in effetti non significa altro che affermare che la produzione non coincide con la valorizzazione, e che quindi essa è sovraproduzione, o, che è lo stesso, che essa non è una produzione trasformabile in denaro, in valore, non è cioè una produzione che si conferma nella circolazione. Di qui l’illusione dei teorici della circolazione artificiosa (e anche di Proudhon ecc.), per i quali, quando ci si trovi di fronte ad un difetto di mezzi di circolazione – causato dagli alti costi del denaro – occorre creare più denaro artificiosamente. Gran parte del consumo non è consumo per il valore d’uso immediato, ma consumo nel processo di produzione, p. es. consumo di macchinario, di carbone, di olio, dei fabbricati occorrenti, ecc. Questo consumo non è affatto identico ai consumo di cui qui si tratta.
Il consumo dei lavoratori non è affatto un consumo in sé soddisfacente per il capitalista. Qui insomma si espunge completamente il momento della valorizzazione e si pongono immediatamente sullo stesso piano produzione e consumo, presupponendo cioè una produzione direttamente basata sul valore d’uso, non sul capitale. Qui non si considera né il lavoro come lavoro salariato, né il capitale come capitale. Per un verso cioè si assumono i risultati della produzione basata sul capitale; per l’altro si negano il presupposto e la condizione di questi risultati: il lavoro necessario come lavoro posto dal e per il pluslavoro. Ma a prescindere dal fatto che questa necessità dell’equilibrio presuppone già la disuguaglianza, la disarmonia e
192

perciò la contraddizione – nella crisi generale di sovraproduzione la contraddizione non è tra le diverse specie di capitale produttivo, ma tra capitale industriale e capitale di prestito, ossia tra il capitale direttamente coinvolto nel processo di produzione e il capitale che compare in forma (relativamente) autonoma come denaro al di fuori di esso. Ma porre l’esigenza di allargare la produzione simultaneamente nella medesima proporzione significa porre al capitale esigenze estrinseche che non derivano affatto dalla sua natura. Se in un tipo di produzione si abbandona la proporzione data, ciò spinge tutti gli altri ad abbandonarla simultaneamente. Ma non abbiamo ancora finito. La contraddizione tra produzione e valorizzazione – la cui unità è il capitale secondo il suo concetto – deve essere concepita in maniera ancora più immanente, anziché come mero fenomeno indifferente, apparentemente indipendente, dei singoli momenti del processo, o piuttosto della totalità di processi reciprocamente opposti.
Per essere più precisi: esiste anzitutto un limite, non inerente alla produzione in generale ma alla produzione basata sul capitale. Questo limite è duplice, o piuttosto è un medesimo limite considerato secondo due direzioni. È sufficiente qui mostrare che il capitale implica una particolare limitazione della produzione – che contraddice alla sua tendenza generale a sormontare ogni ostacolo posto alla produzione – per scoprire il fondamento della sovraproduzione, la contraddizione fondamentale del capitale sviluppato; per scoprire soprattutto che esso non è, come pensano gli economisti, la forma assoluta per lo sviluppo delle forze produttive – forma assoluta per questo sviluppo, come anche forma della ricchezza che coinciderebbe assolutamente con lo sviluppo delle forze produttive. Questi limiti immanenti devono coincidere con la natura del capitale, con le sue categorie essenziali. Questi limiti necessari sono:
1. il lavoro necessario come limite del valore di scambio della forza-lavoro viva o del salario della popolazione industriale;
2. il plusvalore come limite del tempo di lavoro supplementare; e, in relazione al tempo di lavoro supplementare relativo, come ostacolo allo sviluppo delle forze produttive;
3. che è la stessa cosa, la trasformazione in denaro, il valore di scambio in generale come limite della produzione; ovvero, lo scambio basato sul valore, oppure il valore basato sullo scambio, come limite della produzione;
4. il che equivale a sua volta ad una limitazione della produzione di valori d’uso mediante il valore di scambio; oppure, che la ricchezza reale, per diventare in generale oggetto della produzione, deve assumere una forma determinata, distinta da essa medesima, ossia non assolutamente identica ad essa.
Donde la sovraproduzione: ossia l’improvviso riaffiorare di tutti questi momenti necessari della produzione basata sul capitale; donde una svalutazione generale come conseguenza della loro dimenticanza. Ma, nello stesso tempo, il compito che si impone al capitale di ricominciare da capo il suo tentativo partendo da un superiore grado di sviluppo delle forze produttive ecc., con la prospettiva di un collasso sempre più grave in quanto capitale. È evidente perciò che quanto più alto è lo sviluppo del capitale, tanto più esso si presenta come ostacolo alla produzione – e quindi anche al consumo – a prescindere dalle altre contraddizioni che lo fanno apparire come un pesante ostacolo alla produzione e al commercio. L’intero sistema del credito, e il commercio speculativo, la superspeculazione ecc. ad esso connessi, si basano sulla necessità di allargare e scavalcare i limiti ristretti della circolazione e della sfera dello scambio – fenomeno che appare più colossale, più classico se riferito ai popoli piuttosto che agli individui. La produzione crea in realtà essa stessa la domanda in quanto occupa più lavoratori in una medesima branca di produzione e crea nuove branche di produzione, nelle quali nuovi capitalisti occupano a loro volta nuovi lavoratori e nello stesso tempo diventano vicendevolmente mercato per le vecchie branche di produzione; ma la domanda creata dal lavoratore produttivo stesso non può mai essere una domanda adeguata, perché non si estende a tutta la gamma della sua produzione. Se cosi fosse non ci sarebbe profitto e conseguentemente non ci sarebbe motivo di occuparlo. Qui non si tratta ancora, naturalmente, di analizzare dettagliatamente la sovraproduzione, ma soltanto la tendenza alla sovraproduzione quale è già implicita primitivamente nel rapporto del capitale.
Ad eccezione dei suoi propri lavoratori, per ciascun capitalista la massa complessiva di tutti gli altri lavoratori non è una massa di lavoratori, ma una massa di consumatori, di possessori di valori di scambio (salario), di denaro, che essi scambiano con la sua merce. Essi sono altrettanti centri di circolazione dai quali parte l’atto di scambio e viene conservato il valore di scambio del capitale. Essi costituiscono una parte proporzionalmente molto grande – sebbene non tanto grande quanto comunemente si immagina, se si considera il vero e proprio operaio industriale – dei consumatori. Quanto più grande è il loro numero – il numero della popolazione industriale – e la massa di denaro di cui possono disporre, tanto più grande è la sfera di scambio per il capitale. La tendenza del capitale, lo abbiamo visto, è di aumentare il più possibile la massa della popolazione industriale. A dire il vero in questa sede il rapporto tra un capitalista e i lavoratori degli altri capitalisti ancora non ci interessa affatto. Esso rivela soltanto l’illusione di ciascun capitalista, ma non modifica per nulla il rapporto generale tra capitale e lavoro. Riguardo al suo lavoratore ciascun capitalista sa bene che egli non gli sta di fronte come produttore a consumatore, e perciò desidera restringere
193

il più possibile il suo consumo, vale a dire la sua capacità di scambio, il suo salario. Egli si augura naturalmente che i lavoratori degli altri capitalisti siano il più possibile grandi consumatori della sua merce. Ma il rapporto di ciascun capitalista rispetto ai suoi lavoratori è il rapporto generale tra capitale e lavoro, che è il rapporto essenziale. Ma l’illusione – vera per il singolo capitalista distinto da tutti gli altri – per cui al di fuori dei suoi lavoratori tutto il resto della classe operaia gli stia di fronte in veste di consumatore e di soggetto di scambio, cioè di spenditore di denaro, non come lavoratore – questa illusione, dicevamo, nasce appunto da questo; e perciò la domanda di questo stesso lavoratore non può mai essere una domanda adeguata. Poiché una produzione ne mette in movimento un’altra e perciò si procura dei consumatori nei lavoratori del capitale altrui, ecco che per ogni singolo capitale la domanda della classe operaia, che è creata attraverso la produzione stessa, figura come “domanda adeguata”.
Il capitale stesso considera allora la domanda da parte dei lavoratori – ossia il pagamento del salario, su cui questa domanda poggia – non come un guadagno, ma come una perdita. In altri termini, il rapporto immanente tra capitale e lavoro impone i suoi diritti. Qui è di nuovo la concorrenza tra i capitali, la loro indifferenza e autonomia reciproche, che conduce il singolo capitale a riferirsi ai lavoratori del restante capitale totale non in quanto lavoratori: donde la tendenza a scavalcare la giusta proporzione. Accade esattamente la stessa cosa con la domanda, generata dalla produzione stessa, dì materia prima, semilavorati, macchinari, mezzi di comunicazione, e di materie ausiliarie usate nella produzione, come coloranti, carbone, talco, sapone, ecc. Questa domanda che implica pagamento, che crea valore di scambio, è adeguata e sufficiente fintantoché i produttori scambiano fra di loro. La sua inadeguatezza si rivela non appena il prodotto finale trova il suo limite nel consumo immediato e finale. Anzitutto: il capitale costringe i lavoratori a superare il limite del lavoro necessario per effettuare un pluslavoro. Solo così esso si valorizza e crea plusvalore. Ma d’altra parte esso pone il lavoro necessario solo in quanto e nella misura in cui è pluslavoro e questo a sua volta è realizzabile come plusvalore. Esso pone dunque il pluslavoro come condizione del lavoro necessario, e il plusvalore come limite del lavoro oggettivato, del valore in generale. Finché non può porre quest’ultimo, esso non pone nemmeno il primo; né può farlo che sulla base di quello. Esso dunque limita – con un ostacolo artificiale (un artificial check, come dicono gli inglesi) – il lavoro e la creazione di valore, e lo fa per la stessa ragione e nella misura in cui esso crea pluslavoro e plusvalore. Esso dunque pone, per sua natura, un ostacolo al lavoro e alla creazione di valore, il quale contraddice la sua tendenza ad espanderli oltre ogni limite. Ma proprio perché da una parte esso pone un suo specifico ostacolo, e dall’altra tende a superare ogni ostacolo, esso è la contraddizione vivente.
Poiché il valore costituisce la base del capitale, e questo esiste necessariamente solo in quanto attua uno scambio con un equivalente, esso deve necessariamente procedere ad un movimento di repulsione da se stesso. Un capitale universale che non abbia di fronte a sé altri capitali con cui scambiare – e dall’attuale punto di vista esso non ha di fronte a sé altro che il lavoro salariato o se stesso – è perciò un assurdo. La repulsione reciproca dei capitali è già implicita nel capitale in quanto valore di scambio realizzato. È altrettanto essenziale per esso circoscrivere il consumo del lavoratore a ciò che è necessario per riprodurre la sua capacità di lavoro — trasformare cioè il valore che esprime il lavoro necessario in un ostacolo alla valorizzazione della capacità di lavoro e perciò della capacità di scambio del lavoratore, e cercare di ridurre al minimo il rapporto tra questo lavoro necessario e il pluslavoro. Ma nella stessa misura in cui aumenta la massa dei prodotti, aumenta la difficoltà di valorizzare il tempo di lavoro in essi contenuto – perché aumenta la richiesta di consumo. Qui noi abbiamo ancora a che fare soltanto con questo problema: in che modo il processo di valorizzazione del capitale sia al tempo stesso un suo processo di svalutazione. La sovraproduzione ha luogo esclusivamente in rapporto alla valorizzazione.
Proudhon, che sente suonare le campane ma non sa mai dove, deduce la sovraproduzione dal fatto che “l’operaio non può ricomprare il suo prodotto”. In pratica, nel commercio, il capitalista A può truffare il capitalista B, e allora quel che l’uno intasca di più, l’altro se lo trova in meno. Ma, facendo l’addizione, la somma del loro scambio è = alla somma del tempo di lavoro in essa oggettivato, tranne che il capitalista A ha intascato, rispetto a B, più di quanto gli spettasse. Orbene, se da tutti i profitti che il capitale o tutti i capitalisti insieme realizzano, deduciamo 1) la parte costante del capitale, 2) il salario o tempo di lavoro oggettivato, necessario a riprodurre la forza-lavoro viva, essi non possono dunque spartirsi altro che il plusvalore. Le proporzioni – giuste o ingiuste – in cui essi distribuiscono tra loro questo plusvalore, non modificano assolutamente nulla nello scambio e nel rapporto di scambio tra capitale e lavoro. L’accumulazione della riserva (chiamiamola ancora provvisoriamente cosi) è una caratteristica specifica del capitale. Giacché non ha senso, come avremo modo di vedere meglio, considerare come carattere specifico del capitale l’esistenza necessaria delle condizioni oggettive del lavoro vivo, siano esse fornite dalla natura o prodotte dalla storia.
Questi anticipi specifici che il capitale fa, non significano altro se non che esso valorizza il pluslavoro oggettivato – plusprodotto – trasformandolo in nuovo pluslavoro vivo, invece di investirlo (leggi: sperperarlo) in piramidi ecc. come facevano i re egiziani o le caste sacerdotali etrusche. Nella determinazione
194

del prezzo (e lo vedremo anche a proposito del profitto) si aggiunge poi l’ inganno, la truffa reciproca. Nello scambio l’uno può guadagnare ciò che l’altro perde; ma essi – il capitale come classe – possono spartirsi tra loro soltanto il plusvalore. Tuttavia le proporzioni in cui avviene la spartizione lasciano campo libero alla soverchieria individuale ecc. (a prescindere dalla domanda e dall’offerta), che con la determinazione del valore in quanto tale non ha nulla a che fare. La produzione di lusso che si riscontra presso gli antichi è tuttavia un risultato del rapporto schiavistico. Non si tratta di sovraproduzione, ma di sovraconsumo e di consumo irrazionale, che sfociando in manifestazioni mostruose e bizzarre, segna il tramonto del sistema politico antico. Una volta uscito dal processo di produzione come prodotto, il capitale deve essere di nuovo convertito in denaro. Il denaro, che prima si presentava soltanto come merce realizzata ecc., ora si presenta come capitale realizzato, oppure il capitale realizzato si presenta come denaro. Questa è una determinazione del denaro (non meno che del capitale).
[LF. q.IV, ff.16-32]
II.4.4. I limiti del capitale: credito e scala di produzione
Se il credito appare come la leva principale della sovrapproduzione e della sovraspeculazione nel commercio, ciò avviene soltanto perché il processo di produzione, che per sua natura è elastico, viene qui spinto al suo estremo limite, e vi viene spinto proprio perché una gran parte del capitale sociale viene impiegato da quelli che non ne sono proprietari, i quali quindi agiscono in tutt’altra maniera dai proprietari, i quali, quando operano personalmente, hanno paura di superare i limiti del proprio capitale privalo. Da ciò risulta chiaro soltanto che la valorizzazione del capitale, fondata sul carattere antagonistico della produzione capitalistica, permette l’effettivo, libero sviluppo soltanto fino a un certo punto, quindi costituisce di fatto una catena e un limite immanente della produzione, che viene costantemente spezzato dal sistema creditizio. Il sistema creditizio affretta quindi lo sviluppo materiale delle forze produttive e la formazione del mercato mondiale, che il sistema capitalistico di produzione ha il compito storico di costituire, fino a un certo grado, come fondamento materiale della nuova forma di produzione. Il credito affretta al tempo stesso le eruzioni violente di questa contraddizione, ossia le crisi e quindi gli elementi di disfacimento del vecchio sistema di produzione. Ecco i due caratteri immanenti al credito: da un lato esso sviluppa la molla della produzione capitalistica, cioè l’arricchimento mediante lo sfruttamento del lavoro altrui, fino a farla diventare il più colossale sistema di gioco e d’imbroglio, limitando sempre più il numero di quei pochi che sfruttano la ricchezza sociale; dall’altro lato esso costituisce la forma di transizione verso un nuovo sistema di produzione. Le osservazioni generali, che abbiamo avuto occasione di fare finora trattando del credito, sono le seguenti:
I. Formazione necessaria del credito come mezzo per attuare il livellamento del tasso del profitto, oppure il movimento di questo livellamento, su cui si fonda l’intera produzione capitalistica.
II. Riduzione dei costi di circolazione.1. Uno dei principali costi di circolazione è rappresentato dal denaro stesso, come valore in sé. Esso
viene economizzato, mediante il credito, in triplice maniera.A. Perché viene completamente reso superfluo in una gran parte delle transazioni.B. Perché si accelera la circolazione del medio circolante .C. Sostituzione della moneta aurea con la carta.2. II credito accelera le diverse fasi della circolazione o della metamorfosi delle merci, ossia della
metamorfosi del capitale e quindi accelera il processo della riproduzione in generale. (D’altro lato il credito permette di distanziare ancora di più le operazioni di compera e di vendita e serve quindi di base alla speculazione).
III. Formazione di società per azioni. Donde un ampliamento enorme della scala della produzione e delle imprese quale non sarebbe stato possibile con capitali individuali. Al tempo stesso tali imprese, che precedentemente erano governative, divengono ora sociali.
Il capitale, che si fonda per se stesso su un modo di produzione sociale e presuppone una concentrazione sociale dei mezzi di produzione e delle forze-lavoro, acquista qui direttamente la forma di capitale sociale (capitale di individui direttamente associati) contrapposto al capitale privato, e le sue imprese si presentano come imprese sociali contrapposte alle imprese private. È la soppressione del capitale come proprietà privata nell’ambito del modo di produzione capitalistico stesso.
3. Trasformazione del capitalista realmente operante in semplice dirigente, amministratore di capitale altrui, e dei proprietari di capitale in puri e semplici proprietari, puri e semplici capitalisti monetari. Anche quando i dividendi che essi ricevono comprendono l’interesse e il guadagno d’imprenditore, ossia il profitto totale (poiché lo stipendio del dirigente è o dovrebbe essere semplice salario di un certo tipo di lavoro
195

qualificato, il cui prezzo sul mercato del lavoro è regolato come quello di qualsiasi altro lavoro), questo profitto totale è intascato unicamente a titolo d’interesse, ossia come un semplice indennizzo della proprietà del capitale, proprietà che ora, nel reale processo di riproduzione, così è separata dalla funzione del capitale come, nella persona del dirigente, questa funzione è separata dalla proprietà del capitale.
Nelle società per azioni la funzione è separata dalla proprietà del capitale, e per conseguenza anche il lavoro è completamente separato dalla proprietà dei mezzi di produzione e dal plusvalore. Questo risultato del massimo sviluppo della produzione capitalistica è un momento necessario di transizione per la ritrasformazione del capitale in proprietà dei produttori, non più però come proprietà privata di singoli produttori, ma come proprietà di essi in quanto associati, come proprietà sociale immediata. E inoltre è momento di transizione per la trasformazione di tutte le funzioni che nel processo di riproduzione sono ancora connesse con la proprietà del capitale, in semplici funzioni dei produttori associati, in funzioni sociali. Questo significa la soppressione del modo di produzione capitalistico nell’àmbito dello stesso modo di produzione capitalistico, quindi è una contraddizione che si distrugge da se stessa, che prima facie si presenta come semplice momento di transizione verso una nuova forma di produzione. Essa si presenta poi come tale anche all’apparenza. In certe sfere stabilisce il monopolio e richiede quindi l’intervento dello stato. Ricostituisce una nuova aristocrazia finanziaria, una nuova categoria di parassiti nella forma di escogitatori di progetti, di fondatori e di direttori che sono tali semplicemente di nome; tutto un sistema di frodi e di imbrogli che ha per oggetto la fondazione di società, l’emissione e il commercio di azioni. È produzione privata senza il controllo della proprietà privata.
IV. Facendo astrazione dalle società per azioni – che sono l’annullamento dell’industria privata capitalistica sulla base del sistema capitalistico stesso, e distruggono l’industria privata a misura che esse si ingrandiscono e invadono nuove sfere di produzione – il credito permette al singolo capitalista, o a colui che è tenuto in conto di capitalista, di disporre completamente, entro certi limiti, del capitale e della proprietà altrui, e per conseguenza del lavoro altrui. La possibilità di disporre del capitale sociale che non gli appartiene gli permette di disporre del lavoro sociale. Il capitale stesso che si possiede in realtà oppure nell’opinione del pubblico, diventa soltanto la base per la sovrastruttura creditizia. Altrettanto assurda è la frase fatta che fa derivare il capitale dal risparmio, perché ciò che lo speculatore pretende, è proprio che altri risparmino per lui. Il suo lusso poi, che ora diventa anch’esso un mezzo per ottenere credito, fa a pugni con l’altra frase fatta, che fa derivare il capitale dalla rinuncia. Concezioni che in una produzione capitalistica meno sviluppata hanno ancora un senso, qui lo perdono completamente. Il successo e l’insuccesso portano qui egualmente all’accentramento dei capitali e quindi all’espropriazione sulla scala più vasta.
L’espropriazione si estende qui dai produttori diretti agli stessi capitalisti piccoli e medi. Tale espropriazione costituisce il punto di partenza del modo di produzione capitalistico, e allo stesso tempo il suo scopo, che è, in quella analisi, quello di espropriare i singoli individui dei mezzi di produzione, che con lo sviluppo della produzione sociale cessano di essere mezzi della produzione privata e prodotti della produzione privata, e che possono essere ancora soltanto mezzi di produzione nelle mani dei produttori associati, quindi loro proprietà sociale, cosi come sono loro prodotto sociale. Ma nel sistema capitalistico questa espropriazione riveste l’aspetto opposto, si presenta come appropriazione della proprietà sociale da parte di pochi individui, e il credito attribuisce a questi pochi sempre più il carattere di puri e semplici “cavalieri di ventura”. Poiché la proprietà esiste qui sotto forma di azioni, il suo movimento ed il suo trasferimento non sono che il puro e semplice risultalo del gioco di borsa dove i piccoli pesci sono divorati dagli squali e le pecore dai lupi di borsa. Nel sistema azionario è già presente il contrasto con la vecchia forma nella quale i mezzi di produzione sociale appaiono come proprietà individuale; ma la trasformazione in azioni rimane ancora chiusa entro le barriere capitalistiche; in luogo di annullare il contrasto fra il carattere sociale ed il carattere privato della ricchezza, essa non fa che darle una nuova forma.
Le fabbriche cooperative degli stessi lavoratori sono, entro la vecchia forma, il primo segno di rottura della vecchia forma, sebbene esse dappertutto riflettano e debbano riflettere, nella loro organizzazione effettiva, tutti i difetti del sistema vigente. Ma l’antagonismo tra capitale e lavoro è abolito all’interno di esse, anche se dapprima soltanto nel senso che i lavoratori, come associazione, sono capitalisti di se stessi, cioè impiegano i mezzi di produzione per la valorizzazione del proprio lavoro. Queste fabbriche cooperative dimostrano come, a un certo grado di sviluppo delle forze produttive materiali e delle forme di produzione sociali ad esse corrispondenti, si forma e si sviluppa naturalmente da un modo di produzione un nuovo modo di produzione. Senza il sistema di fabbrica, che nasce dal modo di produzione capitalistico, e così pure senza il sistema creditizio, che nasce dallo stesso modo di produzione, non si potrebbe sviluppare la fabbrica cooperativa. Il sistema creditizio, come forma la base principale per la graduale trasformazione delle imprese private capitalistiche in società per azioni capitalistiche, così offre il mezzo per la graduale estensione delle imprese cooperative su scala più o meno nazionale. Le imprese azionarie capitalistiche sono da considerarsi, al pari delle fabbriche cooperative, come forme di passaggio dal modo di produzione capitalistico a quello
196

associato, con l’unica differenza che nelle prime l’antagonismo è stato eliminato in modo negativo, nelle seconde in modo positivo.
Abbiamo visto che il processo di produzione capitalistico è una forma storicamente determinata del processo di produzione sociale in generale. Quest’ultimo è al tempo stesso il processo di produzione delle condizioni materiali della vita umana e un processo che si sviluppa entro specifici rapporti di produzione storico-economici, producendo e riproducendo questi rapporti stessi di produzione e in conseguenza i rappresentanti di questo processo, le loro condizioni materiali di esistenza e i loro rapporti reciproci, ossia la loro determinata forma economica sociale. Difatti, il complesso di questi rapporti in cui i rappresentanti di questa produzione stanno con la natura e fra di loro, in cui producono, costituisce precisamente la società, considerata nella sua struttura economica. Al pari di tutti quelli che lo hanno preceduto, il processo di produzione capitalistico si svolge in condizioni materiali determinate, che sono al tempo stesso depositarie di determinati rapporti sociali, in cui gli individui entrano nel processo di riproduzione della loro vita. Queste condizioni, come questi rapporti, sono da un lato i presupposti e dall’altro risultati e creazioni del processo di produzione capitalistico; essi sono prodotti e riprodotti da esso. Abbiamo visto inoltre: il capitale – e il capitalista è soltanto il capitale personificato, agisce nel processo di produzione soltanto come depositario del capitale – spreme nel processo di produzione sociale che gli corrisponde una certa quantità di pluslavoro dai produttori diretti, o lavoratori. Pluslavoro che il capitale ricava senza equivalente e che rimane sempre, in sostanza, lavoro forzato, nonostante che possa apparire il risultalo di un libero accordo contrattuale. Questo pluslavoro è rappresentato da un plusvalore, e questo plusvalore esiste in un plusprodotto. Pluslavoro in generale, inteso come lavoro eccedente la misura dei bisogni dati, deve sempre continuare a sussistere. Nel sistema capitalistico come in quello schiavistico, ecc., assume semplicemente una forma antagonistica ed è completato dall’ozio assoluto di una parte della società.
Una determinata quantità di pluslavoro è necessaria per l’assicurazione contro le disgrazie, per il necessario e progressivo ampliamento del processo di riproduzione corrispondente allo sviluppo dei bisogni ed all’incremento della popolazione, che dal punto di vista capitalistico si chiama accumulazione. Uno degli aspetti in cui si manifesta la funzione civilizzatrice del capitale è quello di estorcere questo pluslavoro in un modo e sotto condizioni che sono più favorevoli allo sviluppo delle forze produttive, dei rapporti sociali, e alla creazione degli elementi per una nuova e più elevata formazione, di quanto non avvenga nelle forme pre-cedenti della schiavitù, della servitù della gleba, ecc. Ciò porta ad uno stadio, in cui da un lato sono eliminate la costrizione e la monopolizzazione dello sviluppo sociale (compresi i suoi vantaggi materiali e intellettuali) esercitale da una parte della società a spese dell’altra; d’altro lato questo stadio crea i mezzi materiali e l’em-brione di rapporti che rendono possibile combinare questo pluslavoro di una più elevata forma di società con una riduzione maggiore del tempo dedicato al lavoro materiale. L’effettiva ricchezza della società e la possibilità di un continuo allargamento del suo processo di riproduzione non dipende quindi dalla durata del pluslavoro, ma dalla sua produttività e dalle condizioni di produzione più o meno ampie nelle quali è eseguito.
Di fatto, il regno della libertà comincia soltanto là dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla finalità esterna; si trova quindi per sua natura oltre la sfera della produzione materiale vera e propria. Come il selvaggio deve lottare con la natura per soddisfare i suoi bisogni, per conservare e per riprodurre la sua vita, così deve fare anche l’uomo civile, e lo deve fare in tutte le forme della società e sotto tutti i possibili modi di produzione. A mano a mano che egli si sviluppa, il regno delle necessità naturali si espande, perché si espandono i suoi bisogni, ma al tempo stesso si espandono le forze produttive che soddisfano questi bisogni. La libertà in questo campo può consistere soltanto in ciò: che l’uomo socializzato, cioè i produttori associati, regolano razionalmente questo loro ricambio organico con la natura, lo portano sotto il loro comune controllo, invece di essere da esso dominati come da una forza cieca; che essi eseguono il loro compito con il minore possibile impiego di energia e nelle condizioni più adeguate alla loro natura umana e più degne di essa. Ma questo rimane sempre un regno della necessità. Al di là di esso comincia lo sviluppo delle capacità umane, che è fine a se stesso, il vero regno della libertà, che tuttavia può fiorire soltanto sulle basi di quel regno della necessità. Condizione fondamentale di tutto ciò è la riduzione della giornata lavorativa. Abbiamo già dimostrato a proposito delle più semplici categorie del modo di produzione capitalistico, e anche della produzione mercantile, la merce e il denaro, il carattere mistificante che trasforma i rapporti sociali, ai quali gli elementi materiali della ricchezza servono da depositari nella produzione, in proprietà di queste cose stesse (merce) e ancora in modo più accentuato il rapporto di produzione stesso in una cosa (denaro). Questo travisamento è comune a tutte le forme di società, in quanto giungono alla produzione mercantile e alla circolazione monetaria. Ma nel modo di produzione capitalistico e nel caso del capitale, che è la sua categoria dominante, il suo rapporto di produzione determinante, questo mondo stregato e capovolto si sviluppa ancora molto di più.
In capitale-profitto, o ancora meglio in capitale-interesse, terra-rendita fondiaria, lavoro-salario, in questa trinità economica collegante le parti costitutive del valore e della ricchezza in generale con le sue fonti, la
197

mistificazione del modo di produzione capitalistico, la materializzazione dei rapporti sociali, la diretta fusione dei rapporti di produzione materiali con la loro forma storico-sociale è completa: il mondo stregato, deformato e capovolto in cui si aggirano i fantasmi di Monsieur le Capital e Madame la Terre, come caratteri sociali e insieme direttamente come pure e semplici cose. Il grande merito dell’economia classica consiste nell’aver dissipato questa falsa apparenza e illusione, questa autonomizzazione e solidificazione dei diversi elementi sociali della ricchezza, questa personificazione delle cose e oggettivazione dei rapporti di produzione, questa religione della vita quotidiana. È invece d’altra parte altrettanto naturale che gli agenti effettivi della produzione in queste forme estraniate e irrazionali di capitale-interesse, terra-rendita, lavoro-salario si sentano completamente a loro agio, poiché sono appunto le forme dell’apparenza nella quale essi si muovono e con la quale hanno a che fare ogni giorno. È quindi altrettanto naturale che l’economia volgare, che non è altro che una traduzione didattica, più o meno dottrinaria, delle idee quotidiane degli agenti effettivi della produzione, e che reca in mezzo ad esse un certo ordine ragionevole, proprio in questa trinità in cui è cancellato tutto l’intimo nesso trovi una base naturale e incontestabile della sua superficiale millanteria. Questa formula corrisponde al tempo stesso all’interesse delle classi dominanti, in quanto essa proclama la necessità naturale e l’eterna giustezza delle loro fonti di entrata e le eleva a dogma.
È innanzi lutto una falsa astrazione considerare una nazione, il cui modo dì produzione è fondato sul valore, e per di più organizzata capitalisticamente, come un corpo collettivo che lavora unicamente per i bisogni nazionali. In secondo luogo, dopo che si è eliminato il modo di produzione capitalistico, conservando però la produzione sociale, la determinazione di valore continua a dominare, nel senso che la regolazione del tempo di lavoro e la distribuzione del lavoro sociale fra i diversi gruppi di produzione, e infine la contabilità a ciò relativa, diventano più importanti che mai. E poiché una forma di produzione non corrispondente al modo di produzione capitalistico può essere ricondotta – e fino a un certo punto correttamente – alle forme di reddito di quest’ultimo, si rafforza l’illusione secondo cui i rapporti capitalistici sarebbero rapporti naturali di ogni modo di produzione. Tuttavia, se riconduciamo il salario alla sua base generale, precisamente a quella parte del prodotto di lavoro del lavoratore che passa nel suo consumo individuale; se liberiamo questa parte dai limiti capitalistici e la estendiamo al volume del consumo consentito da un lato dalla forza produttiva esistente della società (cioè dalla forza produttiva sociale del suo lavoro considerato come lavoro effettivamente sociale), e richiesto d’altro lato dal pieno sviluppo della personalità; se riduciamo inoltre il pluslavoro e il plusprodotto alla misura che è richiesta nelle date condizioni di produzione della società, da un lato per la costituzione di un fondo di assicurazione e di riserva, dall’altro per l’allargamento continuo della riproduzione nella misura determinata dai bisogni sociali; se comprendiamo infine nel lavoro necessario e nel pluslavoro, la quantità di lavoro che i membri della società in grado di lavorare devono sempre effettuare, per coloro che non possono ancora o non possono più lavorare, in altre parole, se spogliamo sia il salario che il plusvalore, sia il lavoro necessario che il pluslavoro, del loro specifico carattere capitalistico, non abbiamo più queste forme, ma semplicemente i loro fondamenti, che sono comuni a tutti i modi di produzione sociali.
I cosiddetti rapporti di distribuzione corrispondono, quindi, a forme storicamente determinate, specificamente sociali, del processo di produzione e dei rapporti in cui gli uomini entrano nel processo di riproduzione della loro vita e derivano da queste forme. Il carattere storico di questi rapporti di distribuzione è il carattere storico dei rapporti di produzione, dei quali essi esprimono soltanto un aspetto. La distribuzione capitalistica è distinta dalle forme di distribuzione che derivano da altri modi di produzione, e ogni forma di distribuzione scompare insieme con la forma di produzione determinata a cui essa corrisponde e da cui deriva. La concezione che considera storicamente solo i rapporti di distribuzione, ma non i rapporti di produzione è una critica iniziale, ancora timida, dell’economia borghese. D’altro lato essa si fonda sulla confusione e sulla identificazione del processo sociale di produzione, con il processo lavorativo semplice, che deve compiere anche un uomo artificiosamente isolato, senza alcun aiuto sociale. In quanto il processo lavorativo è soltanto un processo fra l’uomo e la natura, i suoi elementi semplici rimangono identici in tutte le forme dell’evoluzione sociale. Ma ogni determinata forma storica di questo processo ne sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando è raggiunto un certo grado di maturità, la formo storica determinata vien lasciata cadere e cede il posto ad un’altra più elevata. Si riconosce che è giunto il momento di una tale crisi quando guadagnano in ampiezza e in profondità la contraddizione e il contrasto tra i rapporti di distribuzione e quindi anche la forma storica determinata dei rapporti di produzione ad essi corrispondenti, da un lato, e le forze produttive, capacità produttiva e sviluppo dei loro fattori dall’altro. Subentra allora un conflitto fra lo sviluppo materiale della produzione e la sua forma sociale .
[C. III,.27,48-51]
II.4.5. Le tendenze del capitate: concorrenza e socializzazione
198

Le tre caratteristiche fondamentali della produzione capitalistica sono:1. La concentrazione in poche mani dei mezzi di produzione, che cesssano perciò di apparire come
proprietà dei lavoratori diretti e si trasformano in potenze sociali della produzione, anche se in un primo tempo nella forma di proprietà privata dei capitalisti. Questi ultimi sono dei mandatari della società borghese, ma intascano tutti gli utili di tale mandato.
2. L’organizzazione sociale del lavoro mediante la cooperazione, la divisione del lavoro e l’unione del lavoro con le scienze naturali. In seguito alla concentratone dei mezzi di produzione e alla organizzazione sociale del lavoro, il modo capitalistico di produzione sopprime, sia pure in forme contrastanti, e la proprietà individuale e il lavoro privato.
3. La creazione del mercato mondiale. L’enorme forza produttiva in relazione alla popolazione, quale si sviluppa in seno al modo capitalistico di produzione e, quantunque non nella stessa misura, l’aumento dei valori-capitale (non solamente dei loro elementi materiali) che si accrescono molto più rapidamente della popolazione, si trovano in contrasto e con la base per cui lavora questa enorme forza produttiva, che relativamente all’accrescimento della ricchezza diventa sempre più angusta, e con le condizioni di valorizzazione di questo capitale crescente. Da questo contrasto hanno origine le crisi.
[C. III,15]
La concorrenza, poiché si presenta storicamente come dissoluzione di obblighi corporativi, disposizioni governative, dazi interni e simili nell’àmbito di un paese, e come soppressione di barriere, proibizioni o protezioni sul mercato mondiale – e insomma si presenta, storicamente, come negazione dei limiti e degli ostacoli propri dei livelli di produzione che precedono il capitale; poiché storicamente è stata definita del tutto giustamente e caldeggiata dai fisiocratici come laissez faire, laissez passer, essa non è stata mai considerata anche da questo lato puramente negativo, da questo suo lato puramente storico, e d’altra parte è stata ancor più scioccamente considerata come la collisione degli individui emancipati, determinati soltanto dai loro interessi egoistici – come attrazione e repulsione degli individui liberi nella loro relazione reciproca, e quindi come la forma assoluta di esistenza della libera individualità nella sfera della produzione e dello scambio. Niente di più falso. Se la libera concorrenza ha dissolto gli ostacoli dei precedenti modi e rapporti di produzione, occorre d’altra parte anzitutto considerare che quelli che per essa sono ostacoli, per i precedenti modi di produzione furono limiti immanenti, entro i quali essi si svilupparono e si mossero naturalmente. Questi limiti diventano ostacoli solo dopo che le forze produttive e i rapporti di circolazione si sono sviluppati in maniera sufficiente da consentire al capitale come tale di cominciare a presentarsi come principio regolatore della produzione. I limiti che esso ha abbattuto a costituivano degli ostacoli per il suo movimento, sviluppo e realizzazione. Con ciò esso non soppresse né tutti i limiti né tutti gli ostacoli; bensì solo quei limiti ad esso non corrispondenti, che per esso costituivano ostacoli. Nell’àmbito dei suoi limiti proprii – per quanto da un punto di vista più alto essi si presentino come ostacoli alla produzione e come tali vengano posti dal suo stesso sviluppo storico – esso si sente libero, senza ostacoli, limitato soltanto da se stesso e dalle sue stesse condizioni di vita: proprio come l’industria corporativa all’epoca della sua fioritura trovò nell’organizzazione corporativa tutta la libertà di cui aveva bisogno, ossia i suoi corrispondenti rapporti di produzione.
Fu essa stessa anzi a partorirli dal suo grembo e a svilupparli come sue condizioni immanenti, non dunque come ostacoli esterni e restrittivi. Il lato storico della negazione del sistema corporativo ecc. da parte del capitale mediante la libera concorrenza, non significa poi nient’altro che questo: che il capitale divenuto sufficientemente forte, ha abbattuto col sistema di relazioni che gli è adeguato gli ostacoli storici che impacciavano e ostacolavano il movimento che gli è adeguato. Ma la concorrenza è ben lungi dall’avere questo mero significato storico o dall’essere questo mero elemento negativo. La libera concorrenza è la relazione del capitale con se medesimo in quanto altro capitale, ossia la condizione reale del capitale in quanto capitale. Le leggi interne del capitale – che nei primi livelli storici del suo sviluppo si presentano come semplici tendenze – giungono a porsi come léggi; la produzione basata sul capitale si pone nelle sue forme adeguate solo in quanto e nella misura in cui si sviluppa la libera concorrenza, giacché questa è il libero sviluppo del modo di produzione basato sul capitale; il libero sviluppo delle sue condizioni e di esso in quanto processo di riproduzione perenne di queste condizioni. Non gli individui, ma il capitale è posto in condizioni di libertà nella libera concorrenza. Fin quando la produzione che poggia sul capitale è la forma necessaria e perciò più adeguata per lo sviluppo della produttività sociale, il movimento degli individui nell’àmbito delle pure condizioni del capitale si presenta come loro libertà; la quale però poi viene anche dogmaticamente assicurata, in quanto tale, da una costante riflessione sugli ostacoli abbattuti dalla libera concorrenza. La libera concorrenza è lo sviluppo reale del capitale.
Essa impone come necessità esterna per il singolo capitale ciò che corrisponde alla natura del capitale, al modo di produzione basato sul capitale, al concetto di capitale. La coercizione reciproca che in essa esercitano i capitali, l’uno sull’altro, sul lavoro. ecc. (la concorrenza reciproca tra i lavoratori non è che una
199

forma diversa della concorrenza tra i capitali), è il libero e al tempo stesso reale sviluppo della ricchezza in quanto capitale. Ciò è tanto vero che i più profondi pensatori dell’economia, come p. es. Ricardo, presuppongono il dominio assoluto della libera concorrenza per poter adeguatamente studiare e formulare le leggi del capitale – le quali si presentano nello stesso tempo come le tendenze vitali che lo dominano. Ma la libera concorrenza è la forma adeguata del processo produttivo del capitale. Quanto più essa è sviluppata, tanto più pure risultano le forme del movimento del capitale. Ciò che con questo Ricardo, per esempio, ha ammesso malgré lui, è la natura storica del capitale e il carattere limitato della libera concorrenza, la quale appunto non è altro che il libero movimento dei capitali, ossia il loro movimento nell’àmbito di condizioni che non appartengono a precedenti livelli dissolti, ma sono piuttosto condizioni proprie del capitale. Il dominio del capitale è il presupposto della libera concorrenza, proprio come il dispotismo imperiale romano fu il presupposto del libero “diritto privato” romano. Fin quando il capitale è debole, esso si aggrappa alle grucce dei modi di produzione tramontati o che tramontano al suo apparire. Ma non appena si sente forte, esso getta via le grucce e si muove secondo le sue proprie leggi. Non appena comincia ad avere la sensazione e la consapevolezza di essere esso stesso un ostacolo allo sviluppo, subito cerca scampo verso forme le quali, mentre danno l’illusione di perfezionare il dominio del capitale imbrigliando la libera concorrenza, annunciano nello stesso tempo la dissoluzione sua e del modo di produzione che su di esso si fonda. Ciò che è implicito nella natura del capitale viene solo reso realmente esplicito, come una necessità esterna; e il mezzo è la concorrenza, la quale poi non è altro che questo: che i molti capitali si impongono reciprocamente e impongono a se stessi le determinazioni immanenti del capitale.
Nessuna categoria dell’economia borghese, nemmeno la prima, per esempio la determinazione del valore, giunge perciò ad essere reale attraverso la libera concorrenza – vale a dire attraverso il processo reale del capitale, che si presenta come azione reciproca dei capitali e di tutti gli altri rapporti di produzione e di circolazione determinati dal capitale. Di qui, d’altra parte, l’insulsaggine di considerare la libera concorrenza quale ultimo sviluppo della libertà umana; e la negazione della libera concorrenza equivale alla negazione della libertà individuale e della produzione sociale basata sulla libertà individuale. Si tratta appunto solamente dello sviluppo libero su una base limitata – sulla base del dominio del capitale. Questo genere di libertà individuale è perciò al tempo stesso la più completa soppressione di ogni libertà individuale e il più completo soggiogamento dell’individualità alle condizioni sociali, le quali assumono la forma di poteri oggettivi, anzi di oggetti prepotenti – la forma delle cose indipendenti dagli stessi individui e dalle loro relazioni. Sviluppare ciò che la libera concorrenza è, costituisce l’unica risposta razionale ai profeti della middle class che la osannano e ai socialisti che la maledicono. Quando si dice che nell’àmbito della libera concorrenza gli individui, seguendo il loro puro interesse privato, realizzano l’interesse comune o piuttosto generale, non si dice altro se non che essi si comprimono reciprocamente entro le condizioni della produzione capitalistica, e che perciò il loro stesso urto reciproco non è altro che la riproduzione delle condizioni entro le quali si verifica questa azione reciproca. Non appena del resto l’illusione sulla concorrenza quale presunta forma assoluta della libera individualità svanisce, ecco la prova che le condizioni della concorrenza, ossia della produzione basata sul capitale, vengono già avvertite e pensate come ostacoli, e quindi già lo sono e lo diventano sempre più. L’asserzione che la libera concorrenza equivale all’ultima forma di sviluppo delle forze produttive e quindi della libertà umana, non significa altro se non che il dominio della middle class è il termine ultimo della storia mondiale – un’idea senza dubbio allettante per i parvenus dell’altro ieri.
Nella concorrenza questa tendenza interna del capitale si presenta come una costrizione che gli viene fatta dal capitale altrui e che lo spinge permanentemente ad andare oltre la giusta proporzione con un incessante marche, marche! La libera concorrenza, come ha ben fiutato il signor Wakley nel suo commento a Smith, non è stata ancora mai analizzata da parte degli economisti, quantunque se ne cianci tanto e sia la base del -l’intera produzione borghese basata sul capitale. Essa è stata intesa soltanto negativamente: ossia come negazione dei monopoli, della corporazione, delle regolamentazioni giuridiche ecc; insomma, come negazione della produzione feudale. Ma essa deve pur essere qualcosa di per sé, visto che un puro 0 è una vuota negazione, un astrarre da un ostacolo che per es. rispunta immediatamente sotto forma di monopolio, di monopoli naturali ecc. Concettualmente la concorrenza non è altro che la natura interna del capitale, la sua determinazione essenziale che si presenta e si realizza come azione e reazione di una molteplicità di capitali l’uno sull’altro, la tendenza interna come necessità esterna. Il capitale esiste e può esistere soltanto come molteplicità di capitali, e perciò la sua autodeterminazione si presenta come loro azione e reazione reciproca.
[LF. q.VI, f.30; q.IV, f.21]
L’opposto della concorrenza è il monopolio. Il monopolio fu il grido di guerra dei mercantilisti, la concorrenza il grido di battaglia degli economisti liberali. È facile avvedersi come questa opposizione sia assolutamente vuota. Ciascuno dei concorrenti non può non augurarsi di avere il monopolio, sia egli
200

lavoratore, capitalista o proprietario fondiario. Ogni piccolo gruppo di concorrenti deve desiderare il monopolio contro tutti gli altri. La concorrenza si fonda sull’interesse, e l’interesse genera, a sua volta, il monopolio; in breve, la concorrenza trapassa nel monopolio. Dall’altra parte il monopolio non può arrestare il flusso della concorrenza, anzi la genera esso stesso, come a esempio il divieto di importazione o alte tariffe doganali generano addirittura la concorrenza del contrabbando. La contraddizione dalla concorrenza è del tutto identica alla contraddizione della proprietà privata. È interesse di ogni singolo possedere ogni cosa, ma è interesse della comunità che ciascuno possieda nella stessa misura. L’interesse generale e l’interesse individuale sono dunque diametralmente opposti. La contraddizione della concorrenza sta in ciò, che ciascuno deve desiderare il monopolio, mentre la comunità in quanto tale viene danneggiata dal monopolio e quindi deve eliminarlo. La concorrenza presuppone anzi il monopolio, ossia il monopolio della proprietà – e qui si manifesta ancora una volta l’ipocrisia dei liberali – e finché sussiste il monopolio della proprietà, la proprietà del monopolio è parimenti legittimata. Infatti anche il monopolio, una volta che esista, è proprietà. Quale pietosa meschinità è quindi quella di attaccare i piccoli monopoli lasciando sussistere il monopolio fondamentale. E se a questo proposito facciamo ancora ricorso al principio dell’economista, al quale abbiamo prima fatto cenno, che nulla ha valore se non può essere monopolizzato e che dunque quel che non ammette questa monopolizzazione non può entrare nell’arena della concorrenza, risulta completamente giustificata la nostra asserzione che la concorrenza presuppone il monopolio.
La legge della concorrenza è che la domanda e l’offerta si integrano sempre e che, proprio perciò, non si integrano mai. Entrambi i lati vengono di nuovo separati e trasformati in opposti inconciliabili. Questo processo va avanti così indefinitamente, senza mai pervenire ad una condizione di sanità ma in una continua alternanza di eccitazione e di infiacchimento, senza mai giungere alla meta. Questa legge, con la sua costante compensazione, per cui quel che qui viene perduto viene riguadagnato altrove, incanta l’economista. Tutto ciò ne costituisce la gloria principale ed egli non è mai stanco di contemplarla, ma la considera in tutti i suoi rapporti, siano essi possibili o impossibili. Eppure è d’un’evidenza tangibile che questa legge è una legge di natura e non una legge dello spirito. È una legge che genera la rivoluzione. L’economista vi si fa incontro con la sua bella teoria della domanda e dell’offerta, vi dimostra che “non si può mai produrre troppo”; la prassi replica con le crisi commerciali, che ritornano con la stessa regolarità delle comete. Naturalmente questi sconvolgimenti del commercio confermano la légge, la confermano compiutamente, ma in maniera diversa da quella che l’economista vorrebbe farci credere. Che si dovrebbe pensare d’una légge che può affermarsi soltanto attraverso rivoluzioni periodiche? Si tratta appunto d’una legge di natura che si fonda sulla mancanza di coscienza di quanti sono coinvolti nel processo. Se i produttori conoscessero l’entità dei bisogni dei consumatori potrebbero organizzare la produzione, potrebbero ripartirsela fra loro, in modo che sarebbe resa impossibile l’ostinazione della concorrenza e la sua tendenza alla crisi. Se produrrete consapevolmente, da uomini, e non da atomi dispersi e privi della coscienza del genere, avrete superato tutte queste opposizioni artificiose e insostenibili. Ma finché continuerete a produrre nella maniera attuale, inconsapevole, dissennata, dominata dal caso, le crisi commerciali non cesseranno, anzi ogni crisi sarà più ampia, e dunque più grave della precedente, ridurrà in miseria una quantità maggiore di piccoli capitalisti e accrescerà in proporzione crescente il numero degli appartenenti alla classe di coloro che vivono del solo lavoro. La concorrenza oppone dunque capitale a capitale, lavoro a lavoro, proprietà fondiaria a proprietà fondiaria, e ciascuno di questi elementi a tutti gli altri. Nella lotta prevale il più forte.
La libera concorrenza, che è la battuta con la quale per lo più esordiscono i nostri economisti alla moda, è impossibile. Il monopolio aveva almeno l’intenzione, pur non avendo potuto realizzarla, di tutelare il consumatore dalla frode. Ma l’abolizione del monopolio spalanca porte e finestre alla frode. Voi dite che la concorrenza ha in se stessa, il rimedio contro la frode, dite che nessuno acquisterà degli articoli scadenti, e cioè presupponete che ognuno sia un esperto di ogni articolo, il che è impossibile, donde la necessità del monopolio che si mostra anche in molti articoli. Le farmacie ecc. debbono avere un monopolio, e l’articolo più importante, il denaro, necessita più d’ogni altro del monopolio. Il mezzo circolante ha dato luogo ad una crisi commerciale tutte le volte che ha cessato d’essere monopolio dello stato, e gli economisti inglesi, fra gli altri il dottor Wade, ammettono anche la necessità di questo monopolio. Ma il monopolio è impotente contro il denaro falsificato. Qualunque sia il lato dell’alternativa che si sceglie, ciascuno dà luogo a difficoltà gravi quanto l’altro, il monopolio genera la libera concorrenza e questa ancora il monopolio; perciò entrambe le cose devono essere eliminate e questa difficoltà dovrà essere rimossa eliminando il principio che la genera.
[LCEP]
************************************************************************
FONTI BIBLIOGRAFICHE GENERALI E ACRONIMI
201

Charles Babbage, Economia delle macchine e della manifattura [EM] (1832), Pomba Utet, Torino 1889Nikolaj Bukharin, Economia del periodo di trasformazione (1920) [EPT], Jaca book, Milano 1971Nikolaj Bukharin, L’imperialismo e l’economia mondiale (1915) [IEM], Samonà, Roma 1968Maurice Dobb, Problemi di storia del capitalismo (1946) [PSC], Riuniti, Roma 1958Friedrich Engels, Lineamenti di una critica dell’economia politica (1844) [LCEP]Henryk Grossmann, La legge dell’accumulazione e il crollo del capitalismo (1928) [LACC], Jaca book, 1977Rudolph Hilferding, Il capitale finanziario (1910) [CF], Feltrinelli, Milano 1961 Eric Hobsbawn, La rivoluzione industriale e l’impero [RI] (1968), Einaudi, Torino 1967 John A. Hobson, L’imperialismo [IM] (1903), Isedi, Milano 1982John Maynard Keynes, Teoria generale (1936), [TG], Utet, Torino 1986Vladimir Ilič Lenin, L’imperialismo, fase suprema del capitalismo (1916) [IFSC] Karl Marx, Il capitale [C] (1867)Karl Marx, Il capitale: VI capitolo inedito [VI]Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica [LF] (1857-58)Karl Marx, Manoscritti del 1861-63 [MC] (1861-63)Karl Marx, Teorie sul plusvalore (1862-63) [TP]David Ricardo, Princìpi di economia politica [PEP] (1821), Isedi, Milano 1976Joseph Schumpeter, Il processo capitalistico: i cicli economici (1939) [PCCE] Adam Smith, La ricchezza delle nazioni [RN] (1776), Isedi, Milano 1982Frederick W. Taylor, L’organizzazione scientifica del lavoro [OSL] (1903-11), Etas, Milano 1967Andrew Ure, Filosofia delle manifatture [FM] (1835), Pomba Utet, Torino 1889
Le citazioni specifiche sono le seguenti, come partitamente indicato nel testo (ma nell’ordine originario del primo corso annuale dell’ordinamento quadriennale, ordine in parte poi via via modificato negli anni successivi per il testo qui riorganizzato; si è ritenuto che comunque anche l’indicazione originale dei luoghi precisi dai quali i frammenti del testo sono stati tratti possa approssimativamente risultare utile per identificare le pagine fotocopiate e tagliate per il montaggio, ancorché disomogenee e in una sequenza abbastanza accidentata e lasciate sotto in un ordine un po’ diverso da quello presente; i testi originali e gli acronimi usati sono quelli indicati qui nella bibliografia generale e riportate in calce ai frammenti montati per il presente testo):
(Eric Hobsbawn, RI. cap.1-6)(Maurice Dobb, PSC. pref.; cap.1,4,7,8; poscritto)(Karl Marx, LF. quad.m,iv,v)(Karl Marx, C. III, cap.20)(Adam Smith, RN. II, cap.1; III,ca p.1)(Karl Marx, C. I, cap.24)(Karl Marx, VI. I, §10-13)(Karl Marx, C. I, cap.5)(Karl Marx, VI. I, §4-5)(Adam Smith, RN. I, cap.1)(Karl Marx, C. I, cap.12)(Karl Marx, C. I, cap.11,15,8,17-19)(Frederick W. Taylor, OSL. cap.I, § 1; cap.II, § 1)(Karl Marx, C. I, cap.14; TP.I, app.4)(Karl Marx, C. II, cap.6; III,cap.17)(Karl Marx, VI. I, §14)(Charles Babbage, EM. passim)(Andrew Ure, FM. passim)(David Ricardo, PEP. cap.XXXI)(Karl Marx, MC. quad.XIX)(Karl Marx, C. I, cap.15)(Karl Marx, MC. quad.V)(Karl Marx, C. I, cap.15)(Karl Marx, TP. II, cap.17)(Karl Marx, MC. quad.XX)(Karl Marx, LF. quad.VI,VII)
202

(Karl Marx, VI. I, § 15)(Karl Marx, LF. quad.IV, 16-39)(Karl Marx, C. III, cap.10) (Karl Marx, VI. III)(Karl Marx, TP, XIV, 807)(Karl Marx, LF. quad.VII)(Karl Marx, MC. quad.XX)(Karl Marx, C. I, cap.21,22,23)(Joseph A. Schumpeter, PCCE. parte I, cap.1,3)(Karl Marx, C. I, cap.23)(Karl Marx, LF. quad.VI)(Karl Marx, C. II, cap.1-5)(Karl Marx, C. III, cap.15)(Karl Marx, TP. II, cap.17)(Nikolaj Bukharin, EPT. cap.I)(Nikolaj Bukharin, IEM. cap.I,II,IV,VIII)(Henryk Grossmann, LACC. cap.3, parte II, concl.)(Rudolf Hilferding, CF. cap.XI,XIII,XIV,XV,XXII)(Vladimir I. Lenin, IFSC. passim)(Karl Marx, C. III, cap.15)(Karl Marx, LF. quad.VI)(Friedrich Engels, LCEP. passim)(John M. Keynes, TG. cap.24)(Karl Marx, C. III, cap.13,14)(Karl Marx, C. III, cap.27,48-51)(John A. Hobson, IM. I, cap.2-7; II, cap.1,3,5,6,8)(Karl Marx, C. I, cap.1)(Karl Marx, TP. III, cap.21)(Karl Marx, C. I, cap.4)(Karl Marx, TP. II, q.XV)(Karl Marx, C. I, cap.24](Adam Smith, RN. I, cap.5-6)(David Ricardo, PEP. cap.I)(Karl Marx, C. I, cap.1,5,6,8,10)(Karl Marx, C. I, cap.1-4)(Karl Marx, C. III, cap.50)
************************************************************************
{l’ultima versione del corso base triennale 2011 era intitolata Critica dell’economia politica, nella quale è compreso tutto il materiale classico del corso precedente
e in più è stato incluso il paragrafo III.7. La merce: aliquota del prodotto del capitale totale}{analogamente anche nella “presentazione” qui riprodotta è stato aggiunto il paragrafo della prefazione
intitolato 2010: le contraddizioni del capitale-merce}{per la copertina del corso è stata scelta la seguente immagine}
203

Schizzo per il “Giudizio finale” (1503 ca.) di Hieronymus Bosch
{gli anni precedenti il corso base triennale 2006 era intitolato Relazioni economiche internazionali}{per la copertina del corso era stata scelta la seguente immagine }
Gravitazioni (1952) disegno a matita di Maurits Cornelis Escher
{l’ultima versione del corso specialistico biennale 2010 si dovette chiamare Sviluppo e crisinella quale è compreso tutto il materiale classico del corso precedente di Accumulazione e crisi
(laddove compariva però la corretta dizione marxiana di “Accumulazione” anziché quella di “Sviluppo”);a quest’ultima versione è stato aggiunto il paragrafo 3.5. Il capitale fittizio e la speculazione}
{analogamente anche nella “presentazione” qui riprodotta è stato aggiunto il paragrafo della prefazioneintitolato La maschera dei derivati – speculazione}
{per la copertina del corso è stata scelta la seguente immagine}
204

Skrik (1893) [Urlo o Grido] - dipinto di Edward Münch
{per la copertina del precedente corso 2009 di Accumulazione e crisi era stata scelta la seguente immagine}
Paul Klee, La dea serpente e la sua nemica (1940) [disegno]
{il corso unico quadriennale 1991\2003 era denominato Economia industriale, e comprendeva quasi tutti i materiali qui racchiusi}
205

{per la copertina del corso era stata usata la seguente immagine}
Paul Klee, Il battello a vapore attraversa il giardino botanico (1921)
{per il corso stesso era riprodotto anche il disegno di Chumy Chumez}
“Ammetto che ai suoi tempi, nel Quattrocento, le teorie di Marxavessero una qualche giustificazione, ma adesso nel secolo XXI ...!”
206