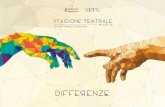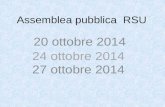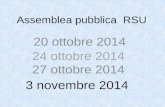121026 - Ottobre
description
Transcript of 121026 - Ottobre

ma discussione che ne è seguita (inparticolare da parte di delegati del-l’area latina), tuttavia senza che adessi sia stata data troppa importanzada parte dei relatori. La spiegazionemi pare di trovarla nelle parole dimons. Morerod, che aveva insistitosull’importanza della fede personalee dell’esperienza della bontà di Dio,limitando invece ad un piano inferio-re l’importanza delle strutture e per-fino dei problemi morali. Questo mifa pensare che, nella strategia dellagiornata, abbia avuto un suo pesol’intenzione esplicita di evitare (igno-rare?) i temi e i problemi che suscita-no dissenso o semplicemente discus-sione nella Chiesa di oggi.
L’Appello dei VescovisvizzeriLa stessa strategia di fondo trovo neltesto dell’Appello che i Vescovi sviz-zeri hanno rivolto ai fedeli e che, co-me ho già detto, è stato consegnatoin copia a tutte le diocesi e si va oradiffondendo nelle parrocchie (il PeLlo ha opportunamente pubblicatoper esteso nel nr. del 19 ottobre). Laprima parte dell’Appello contieneuna sommaria ma molto chiara in-formazione storica sulle caratteristi-che del Concilio Vaticano II, che saràpreziosa non solo per i giovani maper tutti coloro che non hanno me-moria di quell'evento. Segue poi l’in-vito alla rilettura dei principali testi
del Concilio e un elenco delle princi-pali acquisizioni: elenco che non vor-rei qui ripetere, ma che mi sembracomunque non completo: nessuncenno al tema della collegialità epi-scopale con il papa, il tema dellaBibbia solo sfiorato e limitatamenteal campo liturgico, il tema della posi-zione dei laici esposto nel più purolinguaggio “ecclesialese”.L’ultima parte dell’Appello è un sa-lutare invito ai cattolici perché siconfrontino con i testi del Concilioe con i grandi problemi che sonomessi in luce. Molto azzeccato misembra l’invito a tutti i cristiani per-ché “diano una mano”; nulla inve-ce sulle attese che sono, in variamisura, così diffuse circa le struttu-re della Chiesa e la parte che laChiesa istituzionale dovrebbe averenel superare quell'eccesso di rigori-smo, di cui pure si parla nel testo.Non posso nascondere l’impressio-ne che il testo dei Vescovi sia statofortemente influenzato dalla diffici-le situazione che la Chiesa attraver-sa nella Svizzera tedesca, e nellostesso tempo (ciò che è del tuttocomprensibile) rifletta anche la dif-ficile posizione, quasi tra incudine emartello, dei nostri Vescovi le cuiattese di carattere pastorale nonsembrano trovare molto ascoltonella curia romana.
Giorgio Zappa
La Chiesa che è in Svizzera si ap-presta a rispondere all’invito del pa-pa che ha proclamato un Anno dellafede (2012-2013) e lo fa mettendol’accento su una rinnovata attenzio-ne al Concilio Vaticano II, nel mo-mento in cui si celebra il cinquante-simo anniversario di questo eventoecclesiale.Già fin dallo scorso agosto, nella let-tera pastorale “Credo, Signore, matu accresci la mia fede”, il nostro Ve-scovo, mons. Pier Giacomo Grampa,aveva reso noti i termini e le scadenzepreviste per queste due iniziative traloro intrecciate. Si tratta in sostanza,come la stampa ha largamente riferi-to (per il PeL si veda il nr. del 12 otto-bre scorso, p. 20) dell’invito a riflette-re sul tema “Scoprire la fede” rivoltoalla comunità cattolica che vive nelnostro Paese, articolato su un perio-do di tre anni pastorali, dal 2012 al2015: a partire dunque dal momentoin cui ricorre il cinquantesimo anni-versario dell’inizio del Concilio (che,come si sa, è stato aperto a Romal’11 ottobre del 1962).Per presentare e avviare questo com-plesso di iniziative, la Conferenza deiVescovi svizzeri ha organizzato loscorso 11 ottobre una giornata par-ticolare a Berna, alla quale hannopartecipato rappresentanti di tutte lediocesi svizzere. La giornata è inizia-ta con una Santa Messa solenne intre lingue, presieduta dal Presidentedei Vescovi svizzeri, mons. NorbertoBrunner (concelebrata dal Nunzio,da altri undici Vescovi e da molti sa-cerdoti) nella chiesa della SS. Trinità.Dalle mani del celebrante, due dele-gati per ogni diocesi hanno ricevutocopia del Messaggio che i Vescovisvizzeri, in questa occasione hanno
rivolto ai cattolici del nostro paese.
L’evento di riflessioneIl pomeriggio è stato dedicato aduna seduta di rievocazione definitacome un “evento accademico”, sultema “Il Concilio - ieri e oggi”, cheprevedeva nella prima parte le rela-zioni di tre Vescovi e nella secondaparte una tavola rotonda (limitatissi-ma la partecipazione dei laici: duepersone, di cui una relegata al com-pito di moderatore!).Le tre relazioni iniziali sono state in-teressanti e diversissime tra loro.Mons. Peter Henrici ha offerto unospaccato della sua esperienza roma-na come “esterno” nel periodo delConcilio, non senza penetranti giu-dizi: il Concilio ha chiuso la fase an-timodernista della Chiesa, ha contri-buito a creare una collegialità effetti-va e affettiva fra i Vescovi delle varienazioni, Paolo VI è stato il primo pa-pa veramente moderno, occorre ri-cuperare la gioia e l'entusiasmo diquei giorni.Mons. Amedeo Grab ha rievocatoinvece l’esperienza del Sinodo sviz-zero (1972-1975), da lui vissuto inprima persona in Ticino e a livello fe-derale: l’avvenimento più importan-te per la Chiesa svizzera nel ventesi-mo secolo. Ha ricordato anche il NOdella Curia romana ad una (una so-la?) delle proposte del Sinodo.Infine mons. Charles Morerod hasvolto una densa lezione di taglioteologico, insistendo particolarmen-te sull’importanza della riscopertadel concetto di Chiesa come comu-nione e sul fondamento cristocentri-co della fede. Un elemento mi èsembrato comune alle relazioni deitre Vescovi: tutte hanno accurata-mente evitato di toccare i problemisorti nella fase della recezione delConcilio e in particolare i punti pro-blematici nei quali esiste nella comu-nità cristiana un dissenso (sia teolo-gico, sia sommerso).Questi aspetti del problema sonoemersi solo durante la tavola roton-da e più ancora durante la brevissi-
PegasoI n s e r t o d i c u l t u r a p o l i t i c a e d i p o l i t i c a c u l t u r a l e
PrincipiaLa Chiesa nel mondo contemporaneoPagina III
PersonaggiIl cardinale Martiniarcivescovo di MilanoPagina IV
ConcilioQuale presenza del laicatocattolico nella Chiesa futuraPagina VI-VII
PegasoInserto mensile diPopolo e Libertà
no. 76 - 26 ottobre
PoliticaRiflessione sui cattolici attivinel mondo politicoPagina II
Primo piano
La Chiesa svizzera e il giubileo del Concilio

Politica
Riflessioni sui cattoliciattivi nel mondo politicoLa coscienza cristiana è determinante
Pegaso Venerdì 26 ottobre 2012II
Sul numero di settembre di Pe-gaso (Popolo e Libertà del 21 set-tembre), un testo di Franco Mona-co, già presidente dell’Azione cat-tolica milanese ai tempi del cardi-nale Martini e attualmente senato-re del Partito democratico italiano,esprime alcune considerazioni sullapartecipazione dei cattolici alla po-litica, partendo dall’affermazione diMino Martinazzoli (l’ultimo segre-tario del Partito popolare - già de-mocrazia cristiana: vedi il profilo inPegaso del 15 giugno 2012), se-condo il quale “L’aggettivo cattoli-co non è un aggettivo del politico”.Constatazione evidente, già soste-nuta da don Luigi Sturzo al primocongresso del Partito popolare ita-liano, in opposizione a padre Ge-melli, del resto in Ticino (ma noncosì in diversi Cantoni svizzeri), l’ag-gettivo cattolico, e neppure quellocristiano, non ha mai fatto partedella denominazione ufficiale del-l’attuale Partito popolare democra-tico ticinese e dei suoi “predecesso-ri”. E tuttavia, spesso, giornalisti in-colti attribuiscono l’aggettivo catto-lico a politiche e politici, anche senon dispongono né del metro nédel termometro relativi (che non cisono!) per verificarlo.Nel sopracitato articolo, Monaco,oltre a contestare la opportunità diun “partito cattolico”, fonte di ricor-renti “confusione ed equivoci”, ri-corda come i cattolici, anche italiani,ormai da tempo partecipano e vota-no per partiti diversi, realizzando an-che un insegnamento del Conciliovaticano II, per cui le scelte politichesono di competenza del laicato enon dei vescovi o del clero.
Agire sempre da cristianiMa la possibilità di scelta in campopolitico (o meglio tra i diversi par-titi in competizione in una demo-crazia), merita a mio parere qual-che riserva, o meglio precisazione.La più fondamentale è del resto in-dicata dallo stesso Monaco, quan-do scrive, ricordando la distinzionedi Maritain, tra “agire in quantocristiani” e “agire da cristiani, inquanto cittadini, senza impegnarela Chiesa come tale. Cioè coeren-
ti con la loro coscienza cristia-na” (la sottolineatura è mia). Quin-di, liberi i cattolici nelle loro sceltepolitiche perché non impegnano laChiesa, a patto che rispettino la lo-ro coscienza cristiana. Un teologo(vedi Spighe, ottobre 2012) alladomanda se si può essere cattolicie leghisti, “invita tutti noi credentia fare un serio esame di coscien-za”. Personalmente mi è difficilecapire come una coscienza cristia-na possa accettare di partecipare aun partito fascista (che non rispet-ta la dignità delle persone e usa si-stematicamente l’insulto e il dis-prezzo come “arma” politica), op-pure come un cattolico (che signi-fica anche “universale”!) possa incoscienza dare il voto o un soste-gno ad una Lega razzista, xenofo-ba e maschilista (che così ignora lacomune fratellanza di tutti gli uo-mini, donne comprese!). Poi c’è l’i-gnoranza invincibile che mandatutti in Paradiso!Fatta questa premessa fondamen-tale, per partecipare a qualsiasi livel-lo alla politica (semplice votante omilitante o dirigente) sono indispen-sabili almeno due scelte preliminari,
perché sia una partecipazione re-sponsabile e, per quanto possibile,efficace, cioè degna di una persona(e quindi anche di un cristiano).
Altre scelte necessarieLa prima riguarda i temi concreta-mente presenti in campo politico:tra i molti problemi che la politicadeve affrontare, occorre stabilirequali sono i più urgenti per la rea-lizzazione del bene comune, scopounico della politica. Qui ancora la“sensibilità cristiana” (e anche leindicazioni dell’insegnamento so-ciale ) sono determinanti: personal-mente penso che oggi, nel conte-sto politico sociale occidentale, lescelte fondamentali devono privile-giare la solidarietà e la giustizia trale persone (“la scelta preferenzialedei poveri”) e la tutela dell’am-biente, a garanzia delle future ge-nerazioni. Fissate le priorità, seguela scelta dello strumento più ade-guato, cioè del partito che le privi-legia (o almeno non le trascura),ed ha concrete possibilità di realiz-zarle. È infatti contraddittorio e, al-la fine, anche scoraggiante, soste-nere un partito dal programma
giudicato più valido, se poi il suopeso elettorale e le sue capacitàrealizzatrici non danno alcuna ga-ranzia (o almeno speranza) di con-crete attuazioni. Le scelte politicheper ogni cittadino (e quindi ancheper un cristiano) possono esserequasi infinite, ma quelle ragionevolisono forzatamente limitate, perchéoccorre partecipare e sostenere unpartito che abbia concrete possibilitàdi incidere nelle scelte politiche. Sicomprende così perché per megliorealizzare certi valori, gruppi di cat-tolici si sono riuniti, in passato e an-cora oggi, in partiti che possono de-finirsi di “ispirazione cristiana” (ledenominazioni sono state diverse,come ben sanno gli storici delmondo cattolico). Ma l’affermazio-ne dei valori scelti (“irrinunciabili”o meno…) è forzatamente condi-zionata in democrazia dalla neces-sità di trovare un consenso almenomaggioritario. Così nessun valore oproposta di attuazione difficilmentepotrà avere una attuazione piena esoddisfacente, ma sarà sempre unarealizzazione parziale, e ciò non si-gnifica che si rinunci a sollecitarne oprepararne una più completa realiz-zazione futura. La cosiddetta “me-diazione in politica” non significa in-fatti un “compromesso al ribasso”,ma l’accettazione della realtà dellapolitica, senza rinunciare ad affer-mare la preferenza e l’impegno perrealizzazioni più soddisfacenti. Al-do Moro parlò di “non soddisfaci-mento della politica”; Martinazzolidiede ad un suo libro quale titolo“I limiti della politica” (Morcellia-na, 1985). La realtà politica pone cioè forza-tamente limitazioni alle aspettativee alle preferenze, e quindi le sceltespesso non sono pienamente soddi-sfacenti: come quelle che è costrettoa fare oggi in Italia l’amico senatoreMonaco, sicuri che (discepolo delcard. Martini) cercherà di restare fe-dele alla sua coscienza cristiana, purmilitando in un partito che mai igiornalisti definiranno “cattolico”(ma basta che sia umano!).
Alberto Lepori
www.sxc.hu

Principia
Dalla Gaudium et SpesCostituzione “La Chiesa nel mondo contemporaneo”, Concilio Vaticano II, 7 dicembre 1965
Venerdì 26 ottobre 2012 Pegaso III
PER UNA VERA VITA UMANA
Occorre che siano rese accessibili all’uomo tutte quellecose che sono necessarie a condurre una vita vera-mente umana, come il vitto, il vestito, l’abitazione, il
diritto a scegliere liberamente lo stato di vita e a fon-dare una famiglia, all’educazione, al lavoro, al buonnome, al rispetto, alla necessaria informazione, allapossibilità di agire secondo il retto dettato della suacoscienza, alla salvaguardia della vita privata e alla
giusta libertà anche in campo religioso (“Chiesa nel mondo”, n. 26).
VALORI PER PARTECIPARE
Bisogna stimolare la volontà di tutti ad assumersi lapropria parte nelle comuni imprese. È poi da lodarsi ilmodo di agire di quelle nazioni nelle quali la maggio-
ranza dei cittadini è fatta partecipe della gestione dellacosa pubblica in un clima di vera libertà. Affinché tutti i
cittadini siano aperti a partecipare alla vita dei varigruppi, di cui si compone il corpo sociale, è necessarioche trovino in questi gruppi dei valori capaci di attirarli
e di disporli al servizio degli altri. Legittimamente sipuò pensare che il futuro dell’umanità sia riposto nellemani di coloro che sono capaci di trasmettere alle ge-
nerazioni di domani ragioni di vita e di speranza(“Chiesa nel mondo”, n. 31).
DIRITTO E DOVERE DEL VOTO
È pienamente conforme alla natura umana che si trovinostrutture politico-giuridiche che sempre meglio offrano a
tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, la possibilitàeffettiva di partecipare liberamente e attivamente alla ela-borazione dei fondamenti giuridici della comunità politica,sia al governo della cosa pubblica, sia alla determinazionedel campo d’azione e dei limiti dei differenti organismi, siaalla elezione dei governanti. Si ricordino perciò tutti i citta-dini del diritto, che è anche dovere, di usare il proprio libe-ro voto per la promozione del bene comune. La Chiesa sti-ma degno di lode e di considerazione l’opera di coloro cheper servire gli uomini si dedicano al bene della cosa pub-
blica e assumono il peso delle relative responsabilità(“Chiesa nel mondo”, n. 75).
RESPONSABILITÀ LAICALE
Ai laici spettano propriamente, anche se non esclusivamen-te, gli impegni e le attività temporali (…). Spetta alla loro
coscienza (di laici) già convenientemente formati di iscrive-re la legge divina nella vita della città terrena. Dai sacerdo-ti i laici si aspettino luce e forza spirituale. Non pensino pe-
rò che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto chead ogni nuovo problema (…) essi possano avere pronta
una soluzione concreta e che proprio a questo li chiami laloro missione: assumano invece essi, piuttosto, la loro re-
sponsabilità, alla luce della sapienza umana, e facendo at-tenzione rispettosa alla dottrina del Magistero
(”Chiesa nel mondo, n.43).

Personaggi
Il cardinale Martini arcivescovo di Milano Torino, 15 febbraio 1927 - Gallarate, 31 agosto 2012Nel pomeriggio del 31 agosto
è morto il cardinale Carlo MariaMartini, all’età di 85 anni; da di-versi anni soffriva del morbo diParkinson. Nato a Torino il 15febbraio 1927, entrò nell’Ordinedei gesuiti e fu ordinato pretenel 1952. Rettore dell’Istituto bi-blico di Roma dal 1969, e dal1978 rettore dell’Università Gre-goriana, fu nominato da Paolo VIarcivescovo di Milano nel 1980,carica che ricoprì fino al 2002.Cardinale dal 1983, ha presiedutola Conferenza dei vescovi euro-pei e la prima Assemblea ecume-nica europea di Basilea (1989).Ritiratosi a Gerusalemme percontinuare i suoi studi biblici, ri-tornò in Italia presso la casa dicura dei gesuiti di Gallarate, do-ve è morto. È stato sepolto nelDuomo di Milano. Pur non aven-do partecipato al Concilio Vatica-no II, ne è stato uno degli inter-preti più autorevoli e fedeli, ripe-tutamente manifestando le sueopinioni di apertura e di miseri-cordia. (a.l.)
Sarà solo la storia che potrà giudica-re globalmente i ventidue anni diepiscopato milanese del cardinaleCarlo Maria Martini. E, si sa, l’occhiodei posteri guarda spesso in mododifforme, rispetto a quello dei con-temporanei, cogliendo sfumature eorizzonti che solo la distanza tempo-rale fa scoprire. Ma oggi noi dobbia-mo celebrare con ammirazione la fi-gura di questo dotto gesuita, che èriuscito a farsi amare da persone esettori sociali lontani dalla Chiesacattolica (anzi, si può dire, che siastato amato più dai “lontani” cheda certi cattolici). Martini esce allagrande dalla scena e la sua gran-dezza è resa ancora più evidentedal pauroso vuoto che rimane sulpalcoscenico: da tempo, da troppotempo, la metropoli lombarda nonriesce a esprimere politici, ammini-stratori, imprenditori, intellettualicapaci di essere anche guide mora-li e civili di un’intera società. (...)Nel corso degli anni il card. Martinisi è inserito con una propria specifi-ca identità in una storia già scandi-
ta da predecessori di rango, qualiAndrea Cario Ferrari, IldefonsoSchuster e Giovanni Battista Monti-ni (peraltro rimasto a Milano menodi un decennio). Come loro ha sa-puto conquistarsi l’affetto dei dio-cesani grazie ad una inesausta pas-sione pastorale; più di loro ha po-tuto irrobustire la sua azione conun'eccezionale cultura biblica, cosache lo ha aiutato nello sforzo diuscire dal “ghetto” cattolico e dientrare in quegli stessi mondi che -decenni prima - avevano irriso l’u-mile Ferrari e avversato l'ascetico erigido Schuster. Se però l’azione diMartini è stata comunque anzituttoeducativa e culturale (nel senso piùampio e completo delle parole), ciòrende ancor più difficile il giudizioodierno, perché i frutti si potrannocogliere solo nel futuro. Questa sua pazienza di seminatore siè manifestata attraverso mille propo-ste e mille segni di straordinaria in-tensità: non alludo solo alla tantocelebrata “Cattedra dei non creden-ti”, ma soprattutto alle molteplici“scuole della Parola”, agli interventisvolti nel corso delle ripetute visitepastorali, alla sua vicinanza ai giova-ni preti, con proposte di grande re-spiro come il pellegrinaggio con loroad Auschwitz, e così via. Il seme gettato ha dovuto fare i con-ti con terreni diversi. E tutto da veri-ficare, per esempio, l’impatto delCardinale (e di conseguenza anche ilrilievo della Sua azione pratica di“governo”) con le strutture della cu-ria, delle parrocchie, delle innumere-voli istituzioni diocesane. Che sia esi-stito un laicato, un clero e una curia“martiniani”, è cosa abbastanza evi-dente; ma che ciò possa essere as-sunto come piena assimilazione daparte della diocesi del suo messag-gio, è tutto da dimostrare. Resisten-ze ci sono state e talvolta sono sta-te pure personificate da preti mila-nesi divenuti presuli altrove (Biffi,Maggiolini); più ancora, forse, ci so-no state resistenze sotterranee e psi-cologiche, più difficili da percepire evincere. Ricordo personalmente ilsorriso dell’arcivescovo, allorché glifu raccontato di quel prevostone ti-picamente ambrosiano che era sbot-
tato in una frase di questo tipo: “Macosa crede, l’Arcivescovo, di risolveretutto con la Parola di Dio?”. In politica Martini ha saputo gestirecon grande equilibrio la fase ditransizione seguita alla scomparsadella DC, anche se portato - se val-gono mille piccoli segnali - ad unamaggiore vicinanza verso il centro-si-nistra che non verso Berlusconi e isuoi. Su questo terreno sono indi-menticabili tanti interventi pronun-ciati in occasione della festività di S.Ambrogio. Ma andranno esaminaticon cura anche gli insuccessi, comeper esempio l’effimera parabola del-le scuole diocesane di formazione al-l’impegno sociale e politico (nate,peraltro, ancora con l’idea di prepa-rare uomini da immettere nella DC,proprio mentre quel partito si anda-va disfacendo). Rimane forte pure il ricordo dellastraordinaria personalità del Cardina-le. Anche per diretta esperienza per-sonale posso confermare il giudiziocorrente sulla sua inconsueta capaci-ta di rispetto dell’interlocutore, diascolto, di stimolo a sviscerare tutti iproblemi, anche in modo critico e in-novativo. In qualche modo, si po-trebbe dire, Martini ha saputo coniu-gare nel proprio personalissimo stilel'anima popolare e cordiale di uncard. Ferrari, e il distacco maestoso -creatore di spontaneo rispetto - diun card. Schuster. Un episodio è ri-
velatore e risale ai primi mesi del suoministero milanese: invitato a saluta-re delle coppie di giovani fidanzatiriuniti per una “due giorni” di spiri-tualità dall’Azione Cattolica, si intrat-tenne poco con i responsabili e congli assistenti, e preferì passare granparte del suo tempo a confessare efornire un po’ di direzione spiritualea chi lo desiderava. È inutile dire chefuori dalla porta della sua stanza siformò subito una coda di giovani. Adistanza di tanto tempo, ripensandoa quel giorno, mi pare di poter sco-prire in esso una utile chiave inter-pretativa di un intero episcopato.
Giorgio Vecchio
Giorgio Vecchio, già dirigente dell’A-zione cattolica milanese, è ordina-rio di storia contemporanea pressol'Università degli Studi di Parma eautore di numerose pubblicazioni,specie sul Movimento cattolico. In-numerevoli i libri che propongonol'insegnamento del cardinale Mar-tini. Segnaliamo almeno il volume"Parola alla Chiesa, Parola alla Cit-tà", edizioni dehoniane Bologna,che raccoglie tutte le lettere ed iprogrammi pastorali diocesani,nonché tutti i discorsi indirizzati al-la città di Milano in occasione dellasolennità di S. Ambrogio.
Pegaso Venerdì 26 ottobre 2012IV
World Economic Forum

Il testamento spirituale:cosa puoi fare tu per la Chiesa?Intervista al cardinale Martini rilasciata nell’agosto di quest’anno
Come vede lei la situazionedella Chiesa? La Chiesa è stanca, nell’Europa delbenessere e in America. La nostracultura è invecchiata, le nostre Chie-se sono grandi, le nostre case reli-giose sono vuote e l’apparato buro-cratico della Chiesa lievita, i nostri ri-ti e i nostri abiti sono pomposi. Que-ste cose però esprimono quello chenoi siamo oggi? (...) Il benessere pe-sa. Noi ci troviamo come il giovanericco che triste se ne andò via quan-do Gesù lo chiamò per farlo diventa-re suo discepolo. Lo so che non pos-siamo lasciare tutto con facilità.Quanto meno però potremmo cer-care uomini che siano liberi e più vi-cini al prossimo. Come lo sono statiil vescovo Romero e i martiri gesuitidi El Salvador. Dove sono da noi glieroi a cui ispirarci? Per nessuna ra-gione dobbiamo limitarli con i vincolidell’istituzione.
Chi può aiutare la Chiesa oggi?Padre Karl Rahner usava volentieril’immagine della brace che si na-sconde sotto la cenere. lo vedo nellaChiesa di oggi così tanta cenere so-pra la brace che spesso mi assale unsenso di impotenza. Come si può li-berare la brace dalla cenere in mododa far rinvigorire la fiamma dell'a-more? Per prima cosa dobbiamo ri-cercare questa brace. Dove sono lesingole persone piene di generositàcome il buon samaritano? Che han-no fede come il centurione romano?Che sono entusiaste come GiovanniBattista? Che osano il nuovo comePaolo? Che sono fedeli come Mariadi Magdala? lo consiglio al papa e aivescovi di cercare dodici personefuori dalle righe per i posti direzio-nali. Uomini che siano vicini ai piùpoveri e che siano circondati da gio-vani e che sperimentino cose nuove.Abbiamo bisogno del confronto conuomini che ardono in modo che lospirito possa diffondersi ovunque.
Che strumenti consiglia contro lastanchezza della Chiesa? Ne consiglio tre molto forti. Il primoè la conversione: la Chiesa deve rico-noscere i propri errori e deve percor-rere un cammino radicale di cambia-
mento, cominciando dal Papa e daivescovi. Gli scandali della pedofilia cispingono a intraprendere un cam-mino di conversione. Le domandesulla sessualità e su tutti i temi checoinvolgono il corpo ne sono unesempio. Questi sono importantiper ognuno e a volte forse sono an-che troppo importanti. Dobbiamochiederci se la gente ascolta ancorai consigli della Chiesa in materiasessuale. La Chiesa è ancora in que-sto campo un’autorità di riferimen-to o solo una caricatura nei media?Il secondo è la Parola di Dio. Il Con-cilio Vaticano II ha restituito la Bib-bia ai cattolici. (...) Solo chi percepi-sce nel suo cuore questa Parola puòfar parte di coloro che aiuteranno ilrinnovamento della Chiesa e sa-pranno rispondere alle domandepersonali con una giusta scelta. LaParola di Dio è semplice e cerca co-me compagno un cuore che ascolti(...). Né il clero, né il Diritto eccle-siale possono sostituirsi all'interiori-tà dell’uomo. Tutte le regole ester-ne, le leggi, i dogmi ci sono datiper chiarire la voce interna e per ildiscernimento degli spiriti. Per chisono i sacramenti? Questi sono ilterzo strumento di guarigione. I sa-cramenti non sono uno strumentoper la disciplina, ma un aiuto per gliuomini nei momenti del cammino enelle debolezze della vita. Portiamoi sacramenti agli uomini che neces-sitano una nuova forza? lo penso atutti i divorziati e alle coppie rispo-sate, alle famiglie allargate. Questihanno bisogno di una protezionespeciale. La Chiesa sostiene l’indis-solubilità del matrimonio. È unagrazia quando un matrimonio e unafamiglia riescono. (...) L’atteggiamento che teniamoverso le famiglie allargate determi-nerà l’avvicinamento alla Chiesadella generazione dei figli. Unadonna è stata abbandonata dal ma-rito e trova un nuovo compagnoche si occupa di lei e dei suoi tre fi-gli. Il secondo amore riesce. Se que-sta famiglia viene discriminata, vie-ne tagliata fuori non solo la madrema anche i suoi figli. Se i genitori sisentono esterni alla Chiesa o nonne sentono il sostegno, la Chiesa
perderà la generazione futura. Pri-ma della Comunione noi preghia-mo: “Signore non sono degno”.Noi sappiamo di non essere degni(...). L’amore è grazia. L’amore è undono. La domanda se i divorziatipossano fare la Comunione dovreb-be essere capovolta. Come può laChiesa arrivare in aiuto con la forzadei sacramenti a chi ha situazionifamiliari complesse?
Lei cosa fa personalmente? La Chiesa è rimasta indietro di 200anni. Come mai non si scuote? Ab-biamo paura? Paura invece di corag-gio? Comunque la fede è il fonda-mento della Chiesa. La fede, la fidu-
cia, il coraggio. lo sono vecchio emalato e dipendo dall’aiuto degli al-tri. Le persone buone intorno a memi fanno sentire l’amore. Questoamore è più forte del sentimento disfiducia che ogni tanto percepisconei confronti della Chiesa in Europa.Solo l’amore vince la stanchezza.Dio è Amore. lo ho ancora una do-manda per te: che cosa puoi fare tuper la Chiesa?
Intervista rilasciata dal cardinaleCarlo Maria Martini l’8 agosto2012, pubblicata dal “Corrieredella Sera”, dopo la sua morte.Testo ripreso da ADISTA del 15settembre 2012
Venerdì 26 ottobre 2012 Pegaso V
www.sxc.hu



Pegaso Venerdì 26 ottobre 2012VIII
www.sxc.hu
Nella prima prospettiva - quella che fariferimento al territorio - occorre nondimenticare che la Chiesa, proprio peril suo radicamento nella storia, è sem-pre locale, fa costante riferimento auno specifico luogo, all’interno delquale vivono e sono chiamati a santifi-carsi i cristiani. È questo, tuttavia, unradicamento messo in discussione dal-la postmodernità, dato che, grazie al-le moderne tecniche di comunicazio-ne, il mondo si va popolando di “turi-sti” e “vagabondi” (in senso cultura-le), e cioè di persone che non solo sispostano sempre più spesso fisica-mente, ma anche mentalmente, sino astabilire rapporti di qualche “intimità”con i “lontani”, dimenticando del tut-to il rapporto con i “vicini”. In altre pa-role, si è ovunque senza essere da nes-suna parte. Anche i cristiani, in-seriti in questa socie-tà, subiscono la ten-tazione dello sradi-camento e non di ra-do dimenticano l’es-senziale radicamen-to nel territorio enella storia che è ti-pico del cristianesi-mo sin dalle sue origini, a partire dalladomanda centrale su chi è il proprioprossimo. L’altro non è un interlocuto-re anonimo e lontano, ma un voltocon il quale incontrarsi e stabilire undialogo, reso oggi difficile dalla socie-tà postmoderna, ma non impossibileper chi abbia la preoccupazione di cu-rare e valorizzare la prossimità. Ciònon implica che, data la limitatezzadell’essere umano, tutti possano esse-re incontrati e che si possano stabilirerelazioni amicali con chiunque; ma esi-ge che lo si possa fare almeno con al-cuni volti, almeno con i più vicini. Lo sforzo di realizzare, sul territorio,rapporti amicali e diretti non è tuttaviasufficiente: occorre nello stesso tempo
- data la natura sociale dell’uomo -preoccuparsi di creare istituzioni giu-ste. È questa la forma “pubblica”dell’amore per il prossimo e dell’e-sercizio della carità, banco di prova,come ricorda nel suo Vangelo l’apo-stolo Giovanni (13, 35), sul qualeciascuno sarà giudicato. È questocostante riferimento alla necessità dicostruire istituzioni giuste e insiemedi dare corpo e sostanza all’amoreper il prossimo che legittima l’impe-gno dei credenti nella città, a partiredal territorio fino a un contesto piùampio e universalistico, quale è quel-lo che si configura in un mondo avvia-to ormai alla globalizzazione. Si colloca, in questa prospettiva, laparticolare testimonianza affidataall’impegno politico come forma
eminente di servizioal prossimo e con-creto impegno perla giustizia (Campa-nini 2010). Attraver-so la politica, il laicocristiano non è chia-mato direttamente acostruire la Chiesama a servire l’uomo,nella consapevolez-
za, posta al centro del magistero diGiovanni Paolo II, che l’uomo, nellapiena verità dell’esistenza, (...) è la pri-ma e fondamentale via della Chiesa,via tracciata da Cristo stesso (Redemp-tor Hominis, 14) . Solo apparentemen-te le vie della politica divergono daquelle dell’evangelizzazione propria-mente detta: vi è un annunzio del Van-gelo che passa attraverso la testimo-nianza della parola e l’esercizio dell'o-peroso e diretto amore per il prossimo;ma vi è anche un altro annuncio chepassa attraverso la via della “costru-zione della città dell’uomo e a misurad’uomo” (Lazzati, 1984). In questosenso l’impegno politico è il banco diprova dell’autentica laicità del creden-
te, chiamato a rispettare le leggi inter-ne della politica e a non cedere mai al-la tentazione di un suo uso strumen-tale, sia pure nell’illusione di serviremeglio la Chiesa stessa, in piena fe-deltà al principio, originariamenteevangelico, della distinzione tra “re-gno di Dio” e “regno di Cesare”. La prestazione di questo severo edesigente servizio che è la politica ri-chiede forti e mature coscienze cri-stiane, capaci di sottrarsi alla tenta-zione del potere, del prestigio, del-l’arricchimento per operare semprein spirito di servizio. La formazione dirette coscienze occupa, in questaprospettiva, un ruolo determinante,così come il costante collegamentocon comunità cristiane che non do-vrebbero mai considerare i credentiimpegnati in politi-ca una sorta di cor-po estraneo ma do-vrebbero sentirli, eaccoglierli, comecompagni di stradache per altre vie co-struiscono la stessaChiesa nella quale siimpegnano, dall’in-terno, coloro chepiù direttamente si dedicano al com-pito dell’evangelizzazione. Perché si apra l’auspicata nuova sta-gione di impegno politico dei creden-ti sarà tuttavia necessario che il mes-saggio evangelico sia riproposto intutti gli ambiti ecclesiali nella sua inte-gralità, e cioè tanto nella sua dimen-sione trascendente quanto nella suavalenza storica: solo in questo modo sicostruirà una Chiesa capace - secondol’indicazione conciliare - di condividere“le gioie e le speranze” degli uomini dioggi (Gaudium et Spes, Proemio), nel-la linea di quella passione per l’uomoche sta alla base di ogni responsabileimpegno tanto nella Chiesa quantonella società.
Conclusione Vi è una profonda relazione fra l’im-pegno per l’uomo e il diretto impe-gno, nella Chiesa, per l’evangelizza-zione. È una parola, sempre la stessa,che risuona in modo differenziatonelle singole situazioni e alla luce del-le diverse vocazioni del laico cristiano,al quale si apre un vasto e complessoscenario all’interno del quale compie-re le proprie responsabili scelte di vi-ta. È anche possibile che in una fasedella vita si segua l’una, e in altre fa-si l’altra via, sempre all’interno di unacoerente vita cristiana. Si pone qui ilfondamentale problema della voca-zione. Come scrisse Giuseppe Dos-setti (2005): Non si deve dire agli uo-mini quale via debbono percorrere.Perché c’è una via in cui si serve Dio
con lo studio eun’altra con la pre-ghiera, una col di-giuno e l’altra man-giando. Ognuno de-ve guardare attenta-mente su quale vialo spinge il cuore, epoi quella sceglierecon tutte le forze(...). A un certo pun-
to bisogna porre fine alle ‘esperien-ze’, scegliere e impegnarsi, con unadecisione forte e definitiva. Si tratta dunque di scegliere con fortesenso di responsabilità il proprio speci-fico campo di impegno, in una gene-rosa attitudine al servizio e nel rispettodella voce dello Spirito. Ma sarebbepovera, e zoppa, una comunità cristia-na nella quale i credenti fossero capa-ci di servire la Chiesa, ma non altret-tanto disponibili al non meno impor-tante e necessario servizio al mondo.
Giorgio CampaniniRipreso con l’autorizzazione
dell’autore (con qualche riduzione)da “Aggiornamenti sociali”, Milano.
VieSolo apparentemente
le vie della politica divergono da quelle
dell’evangelizzazione propriamente detta
ComunitàSarebbe povera e zoppa una
comunità cristiana nellaquale i credenti fossero
capaci a servire la Chiesama non il mondo
www.sxc.hu

Venerdì 26 ottobre 2012 Pegaso IX
Nuovi media
Un cinguettio fa una notizia?La comunicazione e il giornalismo al tempo di Twitter. Prime riflessioni su un fenomeno in continua ascesaDa qualche tempo anche la reda-
zione di Pegaso segue con interes-se la crescita dei cosiddetti nuovimedia. Il campo di discussione èparticolarmente vasto e, scegliendodi lanciare il dibattito anche dallepagine del nostro inserto, in questepoche righe proporremo alcune pri-me riflessioni sul mezzo del mo-mento: Twitter. Di cosa si tratta?Twitter - dall’inglese to tweet ovve-ro cinguettare - è un social net-work che permette agli utenti regi-strati di pubblicare i propri messag-gi (per una lunghezza massima di140 caratteri ciascuno), immagini ofilmati e di leggere quelli degli al-tri. Il sistema è semplice: l’utentecrea un proprio account e decidechi seguire. Non è necessario chedue utenti si accettino reciproca-mente (come avviene, per esempio,in Facebook). Dal momento che unutente è registrato chiunque puòseguirlo e leggere i suoi commenti.In estrema sintesi, tramite Twitterviene realizzato uno dei principifondamentali dell'informazione: ioti seguo perché tu mi offri qualco-sa che mi interessa. Detto in meta-fora, una sorta di agenzia telegrafi-ca globale dove tutti possono direla loro ed aggiornarsi sui temi chegli interessano.
Un oceanodi informazioniDal suo lancio nel 2006 Twitter èlentamente entrato nella vita quoti-diana di milioni di persone. Unnuovo modo di co-municare che ha ri-chiesto a molti ad-detti ai lavori diadeguarsi.Dagli Stati Uniti,passando per laPrimavera Araba,fino ad arrivare alnostro Ticino ogginon c’è notizia chenon venga cinguettata. Esempiconcreti? Si pensi alla campagnaper il rinnovo della Casa Bianca.Entrambi i candidati dispongono distaff e addetti alla comunicazioneche si occupano esclusivamente didiffondere le notizie tramite Twit-
ter. L’indice di gradimento degliamericani su Obama e Romney du-rante e dopo le rispettive conven-tion è stato misurato non solo tra-mite i metodi “tradizionali”, maanche per il tramite del numero ditweet effettuati in tempo reale du-rante i loro discorsi. Ma non finiscequi. Attraverso Twitter gli addettialla comunicazione analizzano leopinioni dei cittadini, le tematiche,i commenti degli elettori e anche su
questi elementi co-struiscono le strate-gie elettorali. Dal-l’altra parte, chil'informazione lacerca trova di fron-te a sé un oceanodi notizie. Clamo-rose, banali, inte-ressanti, noiose.Vere e false. Non
senza correre rischi, come peresempio quello di trovarsi di frontea notizie costruite ad arte.
Senza andaretroppo lontanoNon dobbiamo volgere lo sguardo
lontano per vedere come Twitterdiventi sempre più un mezzo utiliz-zato anche dai media di casa no-stra. Nel nostro piccolo prendiamoun esempio politico recente. L’ele-zione del presidente PLRT. Sabato22 settembre non sono mancati itweet dal Mercato Coperto diMendrisio. Dall’arrivo dei delegati(con foto della sala), agli stralci deidiscorsi di chi si è susseguito alpulpito, ai commenti sul look deicandidati, su su fi-no al voto, alloscrutinio e al fatidi-co “the winneris...”. Il nome delprescelto, ovvero lanotizia in sensostretto, la appren-do sul mio tabletalle ore 12.38quando a Mendri-sio, forse, non è nemmeno ancorainiziato l’applauso della sala. L’in-formazione che ci interessava l’ab-biamo ottenuta. Negli spazi infor-mativi più tradizionali potremo ap-profondirla in tutte le sue sfaccetta-ture. Ma saremo ancora in molti?
Giornalista“cinguettatore”Se Twitter permette - e in un certosenso impone - al giornalista di fa-re il suo mestiere in modo nuovonon mancano gli aspetti sui cui ri-flettere. Prima di tutto sul ruolostesso del giornalista. Il web in ge-nerale e Twitter in particolare sonouna fonte continua di informazioni.Verificarne la veridicità - un princi-pio sancito in Svizzera nella Dichia-razione dei doveri e dei diritti delgiornalista - e sfuggire al rischio diincappare in una cosiddetta “bufa-la” risulta talvolta un compito com-plesso. Ma non è l’unico. In alcuneoccasioni, in Twitter si assiste ilgiornalista in bilico su quella sottilelinea che separa la notizia dal com-mento. Nelle Direttive relative allasopra menzionata Dichiarazione siindica esplicitamente che “il gior-nalista deve mettere il pubblico nel-le condizioni di distinguere il fattodalla valutazione o dal commentodel fatto medesimo”. Se nei mediatradizionali a questo principio vieneriservata particolare attenzione, ècosì anche in Twitter? Nello specifi-co, come capire quando il giornali-sta - che di norma usa il suo profi-lo privato e non quello dell'organoper cui lavora - si esprime a titolopersonale o sta facendo il suo la-voro condividendo un'informazio-ne? Se lo stesso giornalista mentredà questa notizia va oltre la crona-ca spicciola con un suo commentopersonale, introducendo dell'ironia
o facendo degliapprezzamenti, staagendo in modocorretto? Dove si-tuare il limite fral’espressione per-sonale e quellaprofessionale? Do-mande che restanoaperte e che sa-ranno sempre più
oggetto di riflessione anche in fu-turo con la crescente influenza chei social networks stanno assumen-do nel modus operandi del giorna-lista, ma non solo.
Nathalie Ghiggi Imperatori
RischiChi cerca trova: il web offreun oceano di informazioni.Non senza correre il rischiodi trovarsi di fronte a notizie
costruite ad arte
RuoliI nuovi media ridefiniscono il
mestiere del giornalista.Dove si situa il limite fral’espressione personale e
quella professionale?

Ricerche storiche
Pegaso Venerdì 26 ottobre 2012X
Dal declino delle cristianità temporali al rinnovo delle comunitàBrest, un convegno sulla storia religiosa europea dal 1950 ad oggi
L’Università di Brest, la città portualedella Bretagna (Francia) interamentericostruita dopo il bombardamento te-desco che ha subito alla fine della se-conda guerra mondiale, ha ospitato loscorso giugno un affascinante conve-gno sulla storia dellecristianità occidentalidal 1950 ad oggi. Unconvegno che ha ri-unito, in uno spiritodi ricerca, una venti-na di storici e sociolo-gi provenienti da tut-ta Europa e da oltreoceano. Tra loro stu-diosi affermati come ifrancesi Yvon Tranvouez e ChristianSorrel, il belga Jan De Mayer, il cana-dese Martin Meunier, lo svizzero Fran-cis Python, professore di storia con-temporanea a Friburgo, e l’italianodon Maurilio Guasco, professore distoria del pensiero politico a Torino,ma anche giovani ricercatori. Attraver-so l’incrocio degli sguardi della storia edella sociologia si è tentato di com-prendere le trasformazioni avvenutenelle società occidentali confrontatealla secolarizzazione.Negli anni 1950 queste società coinci-dono ancora con quelle “cristianitàtemporali” che il canonico FernandBoulard, pioniere della sociologia delcattolicesimo, in-travvede laddove ilprimato della Chie-sa rappresenta l’i-dentità sociale fon-damentale. L’evolu-zione della società -misurata attraversoindicatori quali lapratica domenicale,il ritmo delle stagio-ni, il rispetto della morale, l’autoritàdi un clero numeroso e visibile, rive-la, che a partire dagli anni 1960 -mutazioni significative intervengononelle frontiere dell’identità culturale.Roccaforti del cattolicesimo quali laBretagna, l’Italia del Nord, i Cantonidi Friburgo e del Vallese, senza di-menticare il Québec, sono travolti dauna “rivoluzione silenziosa” che tra-sforma, profondamente, il rapportoall’istituzione ecclesiastica. Eloquen-te è l’esempio dei Paesi Baschi dove,
negli anni cinquanta, l’azione collet-tiva del clero, incanala il nazionali-smo in senso moderato, attraversola cultura e le cooperative, mentrenei decenni seguenti la laicizzazioneporta alla nascita dell’ETA come mo-
vimento laico.L’identità delle “cri-stianità temporali”muta quindi radical-mente. Come cam-biano il ruolo delladonna, con la suaemancipazionenella società, e del-le generazioni, conil passaggio da
un’epoca all’altra di militanti, coin-volti dai media, da personalità epi-scopali, ma soprattutto dai Papi chesi succedono alla guida della Chiesa.Anche nel clero si osserva una fron-tiera generazionale tra il registro del-la rivendicazione dominante neglianni 1960, e quello del ritorno allatradizione che trionferà in seguito.Mentre durante il convegno i termi-ni di “decostruzione” e “decompo-sizione” delle cristianità temporali(ma non del cattolicesimo, ben inte-so!) ritornano con una certa fre-quenza nelle appassionanti confe-renze, un esempio controcorrente ciha colpiti grazie alla scoperta della
chiesa di Saint-Louis a Brest. Que-sta “basilica nava-le”, come è chia-mata per la sua for-ma ma anche per-ché la città è la se-de della Marina mi-litare, è stata rico-struita dopo il bom-bardamento e
maestosa, con i suoi cinquemila po-sti, sembra toccare il cielo. Parteci-pando alla Messa, con una liturgiamoderna ma solenne, colpisce la fol-la di ragazzi che ogni giorno animae canta, mentre all’uscita della chie-sa il giovane vicario spiega come ri-cercare le sue celebrazioni su inter-net. Un segno di “ricomposizione”,o meglio di una Chiesa ancora capa-ce di rinnovarsi?
Lorenzo Planzi
Segnalazioni
BRESCIA, 27-28 ottobre, Centro Paolo VI, “Il Regno di Dio è vicino”,5° convegno promosso da “Il Vangelo che abbiamo ricevuto”, per conti-nuare l’esperienza di comunione e dialogo.
VERONA, 9-10 novembre, Biblioteca civica, “Chiesa e società a Vero-na. A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II”. Venerdì pomeriggio: Giovan-ni Miccoli, Chiesa e mondo, da Pio XII a Giovanni XXIII; Giovanni Vian, LeChiese locali venete di fronte al Concilio; Enrico Baruzzo, Laicato cattoli-co, rinnovamento conciliare e società veneta. Sabato mattina: Rino Cona,Il vescovo Carraro e la novità del Concilio vaticano II; Concilio e postcon-cilio: testimonianze e bilanci; Riflessioni conclusive di Ilvo Diamanti.
MENDRISIO, 12 e 14 novembre, dalle ore 20.00 alle 21.50, Museod’arte, “Capire e vivere le frontiere. La Svizzera italiana fra passato e fu-turo”, serate organizzate da Coscienza svizzera, con relazioni di RemigioRatti, Claudio Ferrata, Marco Marcacci, Orazio Martinetti, Sergio Roic,Oscar Mazzoleni e dibattito.
FRIBURGO, 30 novembre -1 dicembre, Università di Friburgo, Conve-gno su “Una storia religiosa transnazionale”, organizzato dalla Rivistasvizzera di storia religiosa e culturale, diretta dal prof. Mariano Delgato.Informazioni e iscrizioni a Dr. Franziska Metzger, Università Misericorde,Büro 5120, Av. De l’Europe 20, 1700 Friburgo (www.unifr.ch/szrkg).
IdentitàL’identità delle “cristianità
temporali” mutaradicalmente, come cambiano
il ruolo della donna con la sua emancipazione
TerminiDurante il convegno sonotornati spesso i termini“decostruzione” e
“decomposizione” dellacristianità
ww
w.s
xc.h
u

Riviste
Rivista delle rivisteAECM, Bollettino dell’Amicizia ebraico cristiana di Firenze, Casellapostale 282, 50123 Firenze.Nel numero 1-2 del 2012, una intervista all’archeologo ebreo Dan Bahat sulla lo-calizzazione del sepolcro di Cristo a Gerusalemme.
APPUNTI DI CULTURA E DI POLITICA, mensile, Largo Corsia dei Servi 4,20122 Milano.Nel numero 4-2012 (luglio-agosto), due analisi senza sconti sulla situazione(la“irrilevanza”) dei cattolici italiani, da parte di mons. Giudici, vescovo di Pavia(e presidente di Pax Christi italiana) e di Angelo Bertani, giornalista, già segreta-rio della già Commissione italiana Giustizia e Pace. Sandro Antoniazzi, sindacali-sta, discute del lavoro moderno; Giovanni Bianchi, già presidente ACLI, affrontail tema della crisi della democrazia italiana, partendo dal “pragmatismo svizze-ro” che trasforma la politica in amministrazione!
BOLLETTINO STORICO DELLA SVIZZERA ITALIANA, Archivio di Statodel canton Ticino, Edizioni Salvioni, Bellinzona.Nel fascicolo 1-2012 Fabrizio Panzera pubblica i nomi dei membri del Piccolo Con-siglio, poi Consiglio di Stato del Cantone Ticino, dal 1803 al 1855. La rubrica “Be-ni culturali” informa sui restauri eseguiti nel Cantone negli anni 2008-2009, conuna nota introduttiva e le schede degli edifici considerati. Tra essi la cattedrale diSan Lorenzo di Lugano.
CARTA BIANCA, Periodico di approfondimento interculturale, Missio-ne Betlemme-Immensee, Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona.Il numero di giugno 2012 è dedicato a “la mia Africa”, con testi di Silvano Toppi, En-zo Ritter, Pietro Veglio, Domenico Patassini, Jean-Luc Farine, Luca e Silvana Buzzi. Ilnumero di settembre è dedicato alle “Donne forti” e introduce una campagna dellaMissione di Betlemme che sviluppa il tema della salute sessuale e riproduttiva.
LA CIVILTÀ CATTOLICA, rivista quindicinale di cultura, via di Porta pin-ciana 1, 00187 Roma.Nel numero 3893, lo storico Giovanni Sale ricostruisce la stesura del Discorso diapertura del Concilio vaticano II di Giovanni XXIII (“Gaudet Mater Ecclesia”) el’eco che ne ebbe nella stampa.
CHOISIR, rivista culturale dei gesuiti, rue Jacques-Dalphin 18, 1227Carouge - Ginevra.Sul numero 633 (settembre 2012) Albert Rouet, già arcivescovo di Poitiers, ri-chiama l’importanza dello “spirito del Concilio”, mentre uno statunitense fa l’e-logio della contestazione nella Chiesa cattolica e un economista critica l’econo-mia mondiale “ a due velocità”.
MESSAGGERO, trimestrale di formazione e spiritualità francescana,Convento dei cappuccini, Salita dei Frati 4, 6900 Lugano.Il fascicolo di luglio-settembre conclude la storia della Chiesa cattolica attra-verso i concili, e introduce alla celebrazione del Vaticano II, al quale sarannodedicati i prossimi numeri. Una intervista all’architetto Buletti informa sui re-centi restauri alla chiesa della Madonna del Sasso di Locarno.
IL MARGINE, mensile dell’Associazione culturale Oscar Romero, C.P.359, 38100 Trento.Nel numero 5-2012 (maggio) tre redattori fanno un bilancio della situazionepolitica italiana (“Tutto vacilla”) e il milanese Giovanni Colombo si interrogasulla gestione finanziaria della diocesi del cardinale Scola: per il fondo per lefamiglie in difficoltà, in tre anni sono stati raccolti 14 milioni di euro, e per larecente visita del Papa ne sono stati spesi 10. Nei primi anni novanta, l’8 permille fruttava alla Chiesa italiana 410 milioni, mentre l’ultimo dato disponibi-le è di un miliardo e 100 milioni; grazie al marchingegno concordato con Cra-xi, la Chiesa cattolica riceve l’85% del totale, anche se meno del 50% deicontribuenti la indica come beneficiaria. Non sarebbe il caso di ridiscuterne,mentre si cerca una soluzione per gli “esodati”? Nel numero 6-2012, FulvioDe Giorgi affronta il tema della “pienezza ecclesiale” dei divorziati risposate,auspicando una “via veramente cattolica”, che posa condurre in casi partico-lari alla piena partecipazione anche eucaristica.
Venerdì 26 ottobre 2012 Pegaso XI
NONVIOLENZA, trimestrale d’informazione su pace, non violenza, di-ritti umani e servizio civile, casella postale 1303, 6501 Bellinzona.Il numero 7 - 2012 (giugno) si apre con la denuncia del “colonialismo vio-lento delle multinazionali svizzere”; diversi servizi documentano lo scandalodel commercio delle armi, aumentato anche da parte della Svizzera nel 2011(+36 %). Nel n.8 (settembre) diversi articoli si occupano del servizio civile (daestendere alle donne o nella scuola?); viene denunciato l’accaparramento del-le terre in Africa, a scapito delle popolazioni locali (67 milioni di ettari, pari a17 volte la Svizzera!).
IL REGNO, quindicinale di attualità e documenti, Via Nosadella 6,Bologna.Nel numero del 15 luglio, il teologo Dianich, commentando il documento pre-paratorio del Sinodo sull’evangelizzazione, ripropone la sua tesi di un ostaco-lo culturale tra la Chiesa cattolica e la cultura occidentale contemporanea, in-dicando quale soluzione una riforma della Chiesa con la povertà evangelica,che: “è amore della semplicità e austerità di vita, ma lo è anche nelle formeche qualificano il proprio atteggiamento di fronte agli uomini”. Il numero1120 del 15 settembre dedica quattro testi al cardinale Martini, indicato “pa-dre della Chiesa”.
RIVISTA DELLA DIOCESI DI LUGANO, Curia vescovile, 6901 Lugano.Nel numero di giugno, mons. Sandro Vitalini insegna (con un testo dedicatoall’eutrapelia…) “ad avere uno sguardo ottimista e sereno sulla globalità del-la vita, con particolare attenzione al divertimento, al giuoco, alle passeggiate,alla musica, al canto, all’attività sportiva”. Nel fascicolo luglio-agosto, il reso-conto finanziario della diocesi di Lugano. Il conto economico chiude con undisavanzo di franchi 182’253,45, coperto interamente dalla partecipazionedelle parrocchie; tra le voci passive principali, oltre 950’000 franchi per le“strutture diocesane” (Facoltà di teologia fr. 550’000; Collegio Pio XII fr.168’000, Giornale del Popolo fr. 164’000), e fr. 750’000 per la “pastorale dio-cesana” (Azione cattolica, Pastorale giovanile, Pastorale familiare, ecc., com-presi “aiuti a parrocchie povere” con oltre fr. 194’000 per “sovvenzione sa-cerdoti”). Pubblicato anche il risultato delle collette nella singole parrocchienel 2011, tuttavia senza l’indicazione del totale diocesano (che sarebbe un in-teressante indicatore delle sensibilità dei “praticanti”).
RIVISTA LASALLIANA, trimestrale di cultura e formazione pedago-gica, via Aurelia 476, 00165 Roma.Il n.3-2012 (luglio-settembre) è dedicato alla “nuova evangelizzazione”, constudi su “evangelizzazione, catechesi, educazione”, “evangelizzazione e fami-glia”, “nuovo linguaggio ed evangelizzazione” .
IL TETTO, bimensile di religione, politica e cultura, Piazzetta Caria-ti 2, 80132 Napoli.Il numero doppio di marzo-giugno 2012 dedica due articoli al pensiero e all’a-micizia di padre Ernesto Balducci, nel ventesimo della morte; viene ricordato,con una lunga recensione, il contributo di Giuseppe Dossetti al tema conciliare“Chiesa dei poveri per i poveri”; la cronaca del XXXIII Incontro nazionale delleComunità di Base italiane riassume preoccupazioni e speranze per la Chiesa.Completano riflessioni e rilievi critici sulla politica del governo Monti.
VERS UN DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE, mensile della Dichiarazionedi Berna, rue de Genève 52, 1004 Losanna.Il n. 222 (giugno 2012) denuncia lo sfruttamento del lavoro (in Macedonia,meno di 70 centesimi all’ora alle operaie delle confezioni!) di cui usufruisco-no i commercianti di uniformi ed abiti di lavoro; circa 2 milioni di svizzeri liportano (militari, poliziotti, conduttori di mezzi pubblici, operai dell’edilizia,medici e impiegati negli ospedali ecc.) e molti sono acquistati (e cioè sotto-pagati) con soldi pubblici.