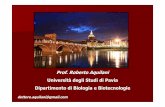Žižek - La Fragilita Dell'Assoluto (Ovvero Perché Vale La Pena Combattere Per Le Nostre Radici...
-
Upload
isto-poiesi -
Category
Documents
-
view
141 -
download
1
Transcript of Žižek - La Fragilita Dell'Assoluto (Ovvero Perché Vale La Pena Combattere Per Le Nostre Radici...
-
http://cultura-non-a-pagamento.blogspot.it/
Slavoj iek
LA FRAGILITA DELLASSOLUTO (ovvero perch vale la pena combattere
per le nostre radici cristiane)
Con questo articolato ed energico contributo al dibattito filosofico e politico contemporaneo, Slavoj Zizek - attraverso una prosa elettrica e vivace, contraddistinta dai suoi proverbiali e numerosissimi riferimenti alla cultura popolare e al cinema - si scaglia contro le banalizzazioni con cui oggi giorno si guarda ai fenomeni sociali e culturali, recuperando in chiave emancipatrice uno dei punti qualificanti della nostra tradizione culturale occidentale: il cristianesimo. Grazie a una riconsiderazione del messaggio di san Paolo, riletto anche nella prospettiva di Alain Badiou, Zizek cerca di ricapitolare i momenti di "fragilit" che attraversano la nostra esperienza, quando questa si converte a una forma di desiderio inteso come atteggiamento positivo verso la realt e la sua verit, al di l di ogni possibile mistificazione. Zizek sorprende il lettore a ogni riga perch si scaglia contro ogni conformismo intellettuale, contro ogni convenzionalit interpretativa, e contro ogni posizione politicamente corretta. Questo libro ne un esempio perfetto. Ricominciare a parlare della radicalit sovversiva del
-
pensiero cristiano, recuperando - attraverso il grimaldello della psicanalisi, da Freud a Lacan - il filo rosso che lo lega al marxismo, un gesto che pu fornire strumenti di analisi pi aderenti alla complessit del tempo che abitiamo.
-
LA REALT UMANA
Collana diretta da Pierpaolo Antonello e Giuseppe Fornari
Direzione editoriale
Giulio Milani
2007 PIER VITTORIO E ASSOCIATI, TRANSEUROPA, MASSA
WWW.TRANSEUROPALIBRI.IT
ISBN 88-7580-020-0
IN COPERTINA: RITRATTO DI SLAVOJ IEK, VERSO
-
Slavoj iek
LA FRAGILITA DELLASSOLUTO
(ovvero perch vale la pena combattere per le nostre radici cristiane)
TRANSEUROPA
-
TITOLO ORIGINALE:
The Fragile Absolute or, why is the Christian legacy worth fighting for?
Traduzione di Barbara Amali
2000 VERSO, LONDON 2000 SLAVOY IEK
2007 PIER VITTORIO E ASSOCIATI, TRANSEUROPA, MASSA
WWW.TRANSEUROPALIBRI.IT
ISBN 88-7580-020-0
-
PREFAZIONE Per nessuno e per niente Uno degli aspetti pi deplorevoli dellera post-moderna e del suo cosiddetto pensiero il ritorno della dimensione religiosa in tutte le sue diverse forme: da quello cristiano ad altri tipi di fondamentalismo, passando attraverso la moltitudine dei nuovi spiritualismi New Age, fino ad arrivare a una nuova sensibilit religiosa che sta emergendo allinterno del decostruzionismo stesso (il cosiddetto pensiero post-secolare). Come pu un marxista, per definizione un materialista militante (Lenin), fronteggiare questo massiccio attacco di oscurantismo? Lovvia risposta sembra essere non solo quella di contrastare queste tendenze con determinazione, ma anche di denunciare senza piet i residui delleredit religiosa allinterno dello stesso marxismo. Contro la vecchia calunnia liberale che poggia sul parallelismo fra la nozione messianica di storia nel cristianesimo e nel marxismo come processo di liberazione finale del fedele (il noto tema i partiti comunisti sono sette religiose secolarizzate), non si dovrebbe forse mettere in rilievo che questo funziona solo per il marxismo dogmatico ossificato e non per la sua vera essenza emancipante? Sulle orme dellinnovativo libro su san Paolo di Alain Badiou,1 la nostra premessa qui esattamente lopposto: invece di adottare una tale posizione difensiva, dando al nemico la possibilit di
-
definire il campo di battaglia, ci che si dovrebbe fare rovesciare la strategia avallando in pieno quello di cui si accusati: s, c una parentela in linea retta fra cristianesimo e marxismo; s, cristianesimo e marxismo dovrebbero combattere dalla stessa parte della barricata lattacco degli emergenti spiritualismi lautentica eredit cristiana troppo preziosa per essere lasciata a degli eccentrici fondamentalisti. Anche quelli che riconoscono questaffinit in linea retta dal cristianesimo al marxismo, tuttavia, di solito feticizzano i primi autentici seguaci di Cristo contro la Chiesa istituzionalizzata rappresentata dal nome di san Paolo: s al messaggio originale autentico di Cristo, no alla sua trasformazione nel corpo degli insegnamenti che legittimano la Chiesa come istituzione sociale. Quanto fanno i seguaci del motto s a Cristo, no a san Paolo coloro che, come afferm Nietzsche, hanno effettivamente inventato il cristianesimo in stretta relazione con la posizione di quei marxisti umanisti della met del XX secolo il cui motto era s al primo Marx autentico, no alla sua ossificazione leninista. E in entrambi i casi si dovrebbe controargomentare che una tale difesa dellautentico il modo pi subdolo di tradirlo: non c Cristo al di fuori di san Paolo; esattamente allo stesso modo, non c Marx autentico che possa essere affrontato direttamente, scavalcando Lenin. NOTE 1. Alain Badiou, San Paolo. Fondazione delluniversalismo, Napoli, Cronopio, 1999.
-
I RINUNCIARE AL FANTASMA DEI BALCANI
Forse il modo migliore di esprimere lessenza di unepoca metterne a fuoco non solo le caratteristiche esplicite che definiscono le sue costruzioni sociali e ideologiche, ma anche i rinnegati fantasmi che la tormentano, indugiando in una misteriosa regione di entit non-esistenti, che tuttavia persistono, che tuttavia continuano a esperire la loro efficacia. Essendo io originario della Slovenia, parte della ex Yugoslavia, sembro predestinato a parlare oggi di questi fantasmi: non forse noto clich che i Balcani siano quella parte dellEuropa perseguitata dai famigerati fantasmi del passato, incapaci di dimenticare e dimparare, ancora l a combattere battaglie vecchie di secoli, mentre il resto dEuropa muove grandi passi verso la globalizzazione? Qui, tuttavia, gi cimbattiamo nel primo paradosso dei Balcani: come se i Balcani stessi rivestissero, agli occhi dellEuropa, lo stato peculiare di un fantasma che ancora lassilla non sono forse i Balcani post Yugoslavia, questo vortice di passioni etniche (auto)distruttive, lesatto opposto, quasi il negativo, della tollerante coesistenza di etnie diverse, una sorta di sogno multiculturale trasformatosi in incubo? Lindeterminata e cangiante linea di confine dei Balcani non ci parla forse del loro stato spettrale? come se non ci
-
fosse una risposta definitiva alla domanda Dove iniziano i Balcani? I Balcani sono sempre da qualche altra parte, un po pi a sud-est Per i Serbi, iniziano laggi, in Kosovo o in Bosnia, e difendono la civilt cristiana dallAltro di questEuropa; per i Croati, iniziano nella Serbia ortodossa, dispotica e bizantina, contro la quale la Croazia si erge a difesa dei valori democratici dellOccidente; per gli Sloveni, iniziano in Croazia, e noi siamo lultimo baluardo della pacifica Mitteleuropa; per molti Italiani e Austriaci iniziano in Slovenia, avamposto occidentale delle orde slave; per molti Tedeschi, lAustria stessa, per via dei suoi legami storici, gi infettata dalla corruzione e inefficienza balcaniche; per molti Tedeschi del Nord, la Baviera, con il suo cattolico stile provinciale, non esente dalla contaminazione balcanica; molti tracotanti Francesi associano la stessa Germania a una brutalit da Balcani orientali totalmente estranea alla loro finesse; e siamo cos arrivati fino allultimo anello della catena: ad alcuni Inglesi conservatori contrari allUnione Europea, per i quali almeno implicitamente lintera Europa continentale rappresenta oggi una moderna versione dellImpero Turco balcanico, dove Bruxelles sarebbe la nuova Istanbul, un vorace centro dispotico che minaccia la libert e la sovranit inglesi2 Non forse lidentificare la stessa Europa continentale con i Balcani, il suo Altro barbarico, la segreta verit dietro a tutto questo muoversi dei loro confini, per cos dire, itineranti? Questo enigmatico spostamento multiplo delle frontiere dimostra chiaramente che nel caso dei Balcani non abbiamo a che fare con la geografia pura e semplice, ma con una cartografia immaginaria che proietta sul paesaggio reale i suoi oscuri, spesso ripudiati, antagonismi ideologici, proprio come Freud affermava che la localizzazione dei sintomi di
-
conversione dellisterico proietta nel suo corpo fisico la mappa di unaltra immaginaria anatomia. Comunque, i Balcani non fungono solo da fantasma dellEuropa, ci che resta in maniera persistente del suo rinnegato passato; lulteriore e forse pi importante punto da articolare che precisamente nella misura in cui I Balcani funzionano da siffatta entit spettrale, il riferimento a loro ci permette di distinguere, in una sorta di analisi degli spettri, i differenti modi del razzismo di oggi. In primo luogo, c limperterrito rifiuto vecchia maniera dellAltro balcanico (dispotico, barbaro, ortodosso, musulmano, corrotto, orientale) al posto dei valori autentici (occidentali, civilizzati, democratici, cristiani). Quindi, c un razzismo riflessivo politicamente corretto: una percezione multiculturalista dei Balcani come terreno di intolleranza e orrori etnici, di primitive e irrazionali passioni di guerra, da contrapporre al processo liberal-democratico post stato-nazione di risoluzione dei conflitti attraverso razionali negoziazioni, il compromesso e il rispetto reciproco. Qui il razzismo , per cos dire, elevato al quadrato: attribuito allAltro, mentre noi occupiamo la conveniente posizione del benevolo osservatore neutrale, legittimamente sgomento dinnanzi agli orrori della guerra in atto laggi. Infine, c un razzismo alla rovescia che celebra lesotica autenticit dellAltro balcanico, come nellidea di Serbo, che in contrasto con gli inibiti e anemici europei occidentali, mostra ancora una prodigiosa sete di vita questultima forma di razzismo gioca un ruolo centrale per il successo dei film di Emir Kusturica in occidente. Lesempio di Kusturica ci d altres la possibilit di individuare unaltra caratteristica della percezione che gli Occidentali hanno dei Balcani: la logica del displaced racism,3 del razzismo dislocato. Dal momento che i Balcani fanno
-
parte della geografia dellEuropa, popolata dai bianchi, i clich razzisti che nessuno al giorno doggi, nei tempi del politicamente corretto, oserebbe affibbiare alle popolazioni asiatiche o africane, possono essere liberamente attribuiti alle popolazioni dei Balcani: le lotte politiche nei Balcani sono paragonate a ridicole trame da operetta; Ceausescu viene presentato come la reincarnazione del Conte Dracula Per di pi, come se, nella regione balcanica, la Slovenia fosse la parte pi esposta a questa forma di displaced racism, dal momento che la pi vicina allEuropa occidentale: quando, intervistato per il film Underground, Kusturica ha liquidato gli Sloveni come una nazione di stallieri al servizio degli austriaci, non c stata la bench minima reazione a una tale affermazione apertamente razzista tutto bene dal momento che un autentico artista esotico della parte meno sviluppata della ex Yugoslavia inveiva contro la sua parte pi sviluppata I Balcani costituiscono un luogo di eccezione, un porto franco in riferimento al quale il multiculturalista tollerante ha il permesso di esprimere il suo razzismo represso. In ci sta la principale lezione ideologica de I Balcani: quando teorici come Anthony Giddens o Ulrich Beck definiscono la societ contemporanea come la societ del rischio caratterizzata dalla riflessivit globale, il riferimento a I Balcani ci permette di integrare la loro analisi evidenziando come, oggi, il razzismo stesso stia diventando riflessivo. Questo ci porta a un altro tratto chiave del razzismo riflesso: esso ruota principalmente intorno alla distinzione fra semplice disprezzo culturale dellAltro e schietto razzismo. Di solito, il razzismo considerato la versione pi forte, pi radicale del (di)sprezzo culturale: si ha a che fare con il razzismo quando il semplice disprezzo per la cultura altrui elevato allidea che laltro gruppo etnico sia per intrinseche ragioni (biologiche o culturali) inferiore al nostro. Il
-
razzismo riflesso dei nostri tempi, tuttavia, paradossalmente in grado di articolarsi in termini di esplicito rispetto per la cultura degli altri: la ragione ufficiale dellapartheid in Sud Africa non era forse che la cultura nera doveva essere preservata nella sua unicit, non doveva scomparire nel melting-pot occidentale? Persino oggi i razzisti europei come Le Pen, non ribadiscono forse che ci che chiedono semplicemente lo stesso diritto alla propria identit culturale che gli Africani e altre minoranze rivendicano per se stessi? troppo semplice licenziare questi argomenti affermando che in questi casi, il rispetto per laltro solo ipocrita: il meccanismo operante , piuttosto, quello del disconoscimento caratteristico della scissione feticista [fetishistic split]: So benissimo che la cultura dellAltro degna di rispetto tanto quanto la mia: ci nonostante (li disprezzo appassionatamente). I meccanismi di questo razzismo riflessivo sono chiaramente distinguibili anche nella cultura popolare contemporanea ad esempio, ne La Minaccia Fantasma, il primo episodio del tanto atteso prequel alla trilogia di Guerre Stellari di George Lucas. La solita critica della sinistra secondo cui il gran numero di specie aliene esotiche (extra-umane) in Guerre Stellari rappresenti, in codice, le differenze etniche inter-umane, riducendole a livello di comuni stereotipi razzisti (i malvagi membri dellavida Federazione dei Mercanti sono unevidente caricatura dei similformichine mercanti cinesi), manca in qualche modo il punto: questi riferimenti a clich etnici non sono un crittogramma da decifrare attraverso unardua analisi teoretica; vi si fa diretta allusione, la loro identificazione , per cos dire, parte del gioco. E per di pi i due membri del popolo subacqueo di Naboo, il comico Jar Jar e il pomposo e prepotente governatore dei Gungans, fanno piuttosto ovviamente riferimento al modo caricaturale in cui
-
la Hollywood classica ha da sempre rappresentato i personaggi non-Europei (leggi non-bianchi) del servo e del padrone: Jar Jar un suddito buono di cuore, di un ridicolo accattivante, un servo dai modi infantili che brontola sempre senza mai farsi sentire veramente (proprio come il proverbiale Messicano che blatera di continuo e si lamenta preoccupato e ansioso a ogni pi sospinto), laddove il governatore, a sua volta, mostra una dignit fasulla, pomposa fino al ridicolo, tipica del padrone non-Europeo (di nuovo, come i signorotti messicani locali nei vecchi film di Hollywood, con il loro esasperato senso di orgoglio e dignit); il punto cruciale qui che entrambe le figure non sono recitate da veri attori, ma sono pure creazioni digitali e come tali non si riferiscono solamente a dei clich; piuttosto sono direttamente presentati, messi in scena, come niente altro che clich animati. Per questo motivo sono, in qualche modo, piatti, privi dello spessore di un vero personaggio, di una personalit ben definita: le smorfie delle loro facce dalle infinite possibilit plastiche, danno espressione immediata e diretta ai loro stati danimo pi intimi e ai loro sentimenti (rabbia, paura, desiderio, orgoglio), in totale trasparenza. Il punto pi generale da fare qui la lezione hegeliana secondo cui la riflessivizzazione/mediatizzazione globale genera la sua propria brutale immediatezza, la cui sintesi stata meglio catturata dalla nozione di eccessiva crudelt non-funzionale di Etienne Balibar come caratteristica della vita contemporanea:4 una crudelt le cui espressioni spaziano dal massacro fondamentalista a sfondo razzista e/o religioso a insensati scoppi di violenza da parte degli adolescenti e dei senza tetto delle nostre megalopoli, una violenza che si tentati di chiamare Es-Male, una violenza che non trova fondamento in alcuna causa utilitaria n ideologica. Tutti i nostri discorsi sugli stranieri che ci rubano il lavoro, o sulla
-
minaccia che essi rappresentano per i valori occidentali, non dovrebbero ingannarci: ad un pi attento esame, diventa subito chiaro che tali discorsi offrono una razionalizzazione di seconda mano piuttosto superficiale. Fondamentalmente la risposta che otteniamo da uno skinhead che picchiare gli stranieri lo fa sentire bene, che la loro presenza lo disturba Ci che qui abbiamo di fronte davvero lEs-Male, e cio il Male strutturato e motivato dal pi elementare squilibrio nella relazione fra Io e jouissance, dalla tensione fra piacere e corpo estraneo della jouissance nel suo stesso cuore. LEs-Io, allora, mette in scena il pi elementare corto circuito nella relazione del soggetto con il primordiale oggetto-causa mancante del suo desiderio: ci che ci d noia nellaltro (sia esso ebreo, giapponese, africano, turco) che lui sembra godere di una posizione privilegiata in relazione alloggetto laltro o possiede loggetto-tesoro dopo averlo strappato via a noi (ed per questo che noi non ce labbiamo) o rappresenta una minaccia al nostro possesso delloggetto.5 Ci che dovremmo proporre qui il giudizio infinito hegeliano che asserisce lidentit speculativa di queste inutili ed eccessive esplosioni di immediatezza violenta, che nulla mostrano se non un odio nudo e crudo (non-sublimato) nei confronti dellAltro, con la globale riflessivizzazione della societ; forse il migliore esempio di tale coincidenza il destino dellinterpretazione psicanalitica. Oggi, le formazioni dellinconscio (dai sogni ai sintomi isterici) hanno decisamente perso la loro innocenza e sono profondamente riflessivizzate: le libere associazioni di una persona di media educazione in analisi consistono per lo pi in tentativi di fornire una spiegazione psicanalitica ai propri disturbi, in modo che si del tutto giustificati quando si dice che non ci sono solo interpretazioni jungiane, kleiniane, lacaniane dei sintomi, ma sintomi che sono essi stessi jungiani, kleiniani, lacaniani la cui realt comporta il riferimento implicito a
-
qualche teoria psicanalitica. Linfelice risultato di questa riflessivizzazione globale dellinterpretazione (tutto diventa interpretazione; linconscio interpreta se stesso) che la stessa interpretazione da parte dellanalista perde la sua efficienza simbolica performativa, lasciando il sintomo intatto nellimmediatezza della sua idiot(ic)a jouissance. Quello che succede nella terapia psicanalitica strettamente analogo alla risposta del neo naziskin che, quando viene seriamente interrogato sui motivi della sua violenza, improvvisamente inizia a parlare come un assistente sociale, un sociologo o uno psicologo della mutua, citando la diminuita mobilit sociale, il crescente senso di insicurezza, la distruzione dellautorit della figura paterna, la carenza damore materno nei primi anni della propria infanzia luniformit della prassi e la sua intrinseca legittim(izz)azione ideologica si disintegra in cruda violenza e la sua impotente e inefficiente interpretazione. Questa incapacit dinterpretazione allo stesso tempo uno degli elementi complementari necessari della riflessivit universalizzata acclamata dai teorici della societ del rischio: come se il nostro potere riflessivo potesse prosperare solo nella misura in cui deriva la sua forza da e si poggia su qualche supporto sostanziale minimo pre-riflessivo che elude la sua presa, in modo tale che la sua universalizzazione si raggiunge al prezzo dellinefficienza, cio, il paradossale ri-emergere del bruto Reale di violenza irrazionale, impermeabile e insensibile alla interpretazione riflessiva. Quindi pi i sociologi contemporanei proclamano la fine della Natura e/o della Tradizione e lascesa della societ del rischio, pi il riferimento implicito alla natura pervade i nostri discorsi quotidiani: anche quando non menzioniamo la fine della storia, non trasmettiamo forse lo stesso
-
messaggio quando affermiamo di star entrando in unera pragmatica post-ideologica, il che un altro modo di dire che stiamo entrando in un ordine post-politico nel quale i soli conflitti legittimi sono quelli etnico-culturali? Nel dibattito politico e critico contemporaneo, il termine operaio generalmente scomparso, soppiantato e/o cancellato da immigrato [lavoratori immigrati: algerini in Francia, turchi in Germania, messicani negli Stati Uniti] in questo modo, la problematica di classe dello sfruttamento dei lavoratori viene trasformata nella problematica multiculturalista dellintolleranza dellAltro, e cos via, e leccessivo impegno dei liberali multiculturalisti nel proteggere i diritti etnici degli immigrati, chiaramente trae la sua forza dalla dimensione repressa della categoria. Sebbene la tesi di Francis Fukuyama sulla fine della storia sia velocemente caduta in disgrazia, tacitamente ancora presumiamo che lordine globale capitalista liberaldemocratico sia in qualche modo il regime sociale naturale finalmente (ri)trovato: implicitamente concepiamo ancora i conflitti nei Paesi del Terzo Mondo come una subcategoria delle vere e proprie catastrofi naturali, come sfoghi di brutali passioni quasi-naturali, o come conflitti basati sulla fanatica idenificazione con le proprie radici etniche (e cos etnico, anche in questo caso, se non una parola in codice per natura?). E, ancora, il punto chiave che questa rinaturalizzazione totalmente pervasiva strettamente correlata alla riflessivizzazione globale della nostra vita di tutti i giorni. Per questo motivo, di fronte allodio etnico e alla violenza, bisognerebbe senza indugio rigettare la tipica idea multiculturalista che, per combattere lintolleranza etnica, si debba imparare a rispettare e convivere con la Diversit dellAltro, a sviluppare una tolleranza per i diversi modi di vivere, e cos via il vero modo di sconfiggere lodio etnico non passa attraverso la sua immediata controparte, la tolleranza etnica; al contrario, quello di cui abbiamo bisogno
-
ancor pi odio, ma un pi appropriato odio politico: un odio diretto al comune nemico politico. NOTE 2. Vesna Goldsworthy, Inventing Ruritania, New Haven, London, Yale University Press, 1998. 3. Ibidem 4. Etienne Balibar, La paura delle masse: politica e filosofia prima e dopo Marx, Milano, Mimesis, 2001. 5. Per uno sviluppo pi dettagliato si veda: Slavoj iek, The Metastases of Enjoyment, London and New York, Verso, 1995; e dello stesso autore, Il soggetto scabroso. Trattato di ontologia politica,Milano, Raffaello Cortina, 2003.
-
II LO SPETTRO DEL CAPITALE
Quindi, a che punto siamo noi oggi con i nostri fantasmi? Il primo paradosso che ci colpisce, ovviamente, che questo stesso processo di riflessivizzazione globale che implacabilmente deride e scaccia i fantasmi del passato, non solo genera la sua propria immediatezza, ma anche i suoi propri fantasmi, la sua propria spettralit. Il fantasma pi celebre, che andato vagando per gli ultimi centocinquantanni, non un fantasma del passato, ma lo spettro del futuro (rivoluzionario) lo spettro, ovviamente, della prima frase del Manifesto del Partito Comunista. La reazione automatica del liberale illuminato che oggi legge il Manifesto : non forse il testo semplicemente sbagliato sotto molteplici aspetti empirici con riferimento e al suo ritratto della situazione sociale e alla prospettiva rivoluzionaria che sostiene e diffonde? C mai stato un manifesto politico pi chiaramente confutato dalla successiva realt storica? Non il Manifesto, nel caso migliore, lesagerata estrapolazione di certe tendenze riconoscibili nel diciannovesimo secolo? Andiamo allora ad approcciare il Manifesto dallestremo opposto: dove viviamo oggi, nella nostra societ post (post-moderna, postindustriale)? Lo slogan che si sta imponendo sempre di pi globalizzazione: la brutale imposizione del mercato globale unificato che minaccia ogni tradizione etnica
-
locale, inclusa anche la forma dello stato-nazione. E alla luce di tale situazione, la descrizione dellimpatto sociale della borghesia nel Manifesto non forse pi pertinente che mai? La borghesia non pu esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione, i rapporti di produzione, dunque tutti i rapporti sociali. Prima condizione di esistenza di tutte le classi industriali precedenti era invece limmutato mantenimento del vecchio sistema di produzione. Il continuo rivoluzionamento della produzione, lininterrotto scuotimento di tutte le situazioni sociali, lincertezza e il movimento eterni contraddistinguono lepoca dei borghesi fra tutte le epoche precedenti. Si dissolvono tutti i rapporti stabili e irrigiditi, con il loro seguito di idee e concetti antichi e venerandi, e tutte le idee e i concetti nuovi invecchiano prima di potersi fissare. Si volatilizza tutto ci che vi era di corporativo e di stabile, viene profanata ogni cosa sacra, e gli uomini sono finalmente costretti a guardare con occhio disincantato la propria posizione e i propri reciproci rapporti. Il bisogno di uno smercio sempre pi esteso per i suoi prodotti sospinge la borghesia a percorrere tutto il globo terrestre. Dappertutto deve annodarsi, dappertutto deve costruire le sue basi, dappertutto deve creare relazioni. Con lo sfruttamento del mercato mondiale la borghesia ha dato unimpronta cosmopolita alla produzione e al consumo di tutti i paesi. Ha tolto di sotto i piedi allindustria il suo terreno nazionale, con grande rammarico dei reazionari. Le antichissime industrie nazionali sono state distrutte, e ancora adesso vengono distrutte ogni giorno. Vengono soppiantate da industrie nuove, la cui introduzione diventa questione di vita o di morte per tutte le nazioni civili, da industrie che non lavorano pi soltanto le materie prime del luogo, ma delle zone pi remote, e i cui prodotti non vengono
-
consumati solo nel paese stesso, ma anche in tutte le altre parti del mondo. Ai vecchi bisogni, soddisfatti con i prodotti del paese, subentrano bisogni nuovi, che per essere soddisfatti esigono i prodotti dei paesi e dei climi pi lontani. Allantica autosufficienza e allantico isolamento locali e nazionali subentra uno scambio universale, uninterdipendenza universale fra le nazioni. E come per la produzione materiale, cos per quella intellettuale. I prodotti intellettuali delle singole nazioni divengono bene comune. Luniteralit e la ristrettezza nazionali diventano sempre pi impossibili, e dalle molte letterature nazionali e locali si forma una letteratura mondiale.6 Non forse questa oggi, pi che mai, la nostra realt? I telefonini Ericsson non sono pi svedesi, le Toyota sono prodotte per il 60% negli Stati Uniti, la cultura di Hollywood ha invaso le pi remote parti del globo E inoltre, non funziona allo stesso modo anche per le diverse forme didentit sessuale ed etniche? Non dovremmo integrare la descrizione di Marx in tal senso, aggiungendo anche che lunilateralit e la ristrettezza di vedute in ambito sessuale diventano sempre pi impossibili; che anche relativamente alle pratiche sessuali si volatilizza tutto ci che vi era di stabile, viene profanata ogni cosa sacra, cosicch il capitalismo tende a sostituire la tipica e normale sessualit etero con la proliferazione di identit sessuali instabili e/o orientamenti in continuo mutamento? Di tanto in tanto lo stesso Marx sottostima la capacit delluniverso capitalista di incorporare limpulso trasgressivo che sembrava minacciarlo; nella sua analisi della guerra civile americana allora in atto, per esempio, afferma che, poich lindustria tessile inglese, colonna portante del sistema industriale, non poteva sopravvivere senza le forniture di cotone a basso costo provenienti dagli Stati sudisti, circostanza possibile solo grazie
-
al lavoro degli schiavi, lInghilterra sarebbe stata costretta a intervenire direttamente per prevenire labolizione della schiavit. E quindi s, il dinamismo globale descritto da Marx, che volatizza tutto ci che stabile, la nostra realt a condizione che non dimentichiamo di integrare questimmagine del Manifesto con il suo intrinseco opposto dialettico, la spiritualizzazione dello stesso processo materiale di produzione. Se il capitalismo sospende il potere dei vecchi fantasmi della tradizione, allo stesso tempo ne genera di nuovi, suoi propri, e mostruosi. Vale a dire: da un lato, il capitalismo comporta una radicale secolarizzazione della vita sociale straccia senza piet ogni aura di autentica nobilt, senso del sacro, dellonore e cos via: [La borghesia] ha affogato nellacqua gelida del calcolo egoistico i sacri brividi dellesaltazione devota, dellentusiasmo cavalleresco, della malinconia filistea. Ha dissolto la dignit personale nel valore di scambio e al posto delle innumerevoli libert patentate e onestamente conquistate, ha messo, unica, la libert di commercio priva di scrupoli. In una parola: ha messo lo sfruttamento aperto, diretto e arido al posto dello sfruttamento mascherato dillusioni religiose e politiche.7 Tuttavia, la lezione fondamentale della critica delleconomia politica elaborata da un Marx pi maturo negli anni successivi al Manifesto, che la riduzione di tutte queste chimere celesti alla brutale realt economica genera una spettralit tutta sua. Quando Marx descrive la folle circolazione del capitale che si autoalimenta, il cui solipsistico cammino di autofecondazione raggiunge il suo apogeo nelle attuali speculazioni meta-riflessive sul futuro, troppo semplicistico affermare che lo spettro di questo mostro che
-
crea se stesso proseguendo il suo cammino senza preoccuparsi minimamente n dellambiente n delluomo, unastrazione ideologica, e che non si dovrebbe mai dimenticare che dietro questa astrazione ci sono persone reali e oggetti naturali sulle cui capacit produttive e risorse si basa la circolazione del capitale, e di cui il capitale si alimenta come un gigante parassita. Il problema che questa astrazione non esiste solo nella nostra (dello speculatore finanziario) concezione distorta della realt sociale; reale nel preciso senso di determinare proprio la struttura dei processi sociali materiali: il destino dinteri strati della popolazione, e a volte di Paesi interi, pu essere deciso dalla danza speculativa solipsistica del capitale, che insegue il suo obiettivo di profitto con beata indifferenza rispetto a come questo movimento incider sulla realt sociale. Questa la fondamentale violenza sistemica del capitalismo, che molto pi misteriosa della diretta violenza socioideologica pre-capitalista: questa violenza non pi attribuibile a individui in carne e ossa e alle loro cattive intenzioni; puramente oggettiva, sistemica, anonima. Qui incontriamo la differenza lacaniana fra realt e Reale: realt la realt sociale delle persone reali che interagiscono e sono coinvolte nel processo produttivo; mentre il Reale la logica spettrale astratta, inesorabile del capitale che determina cosa succede nella societ reale. Questo scarto tangibile nel modo in cui, al giorno doggi, la situazione economica di un Paese considerata buona e stabile dagli esperti di finanza internazionale anche quando la maggior parte della sua popolazione ha uno standard di vita inferiore a quello che aveva prima la realt non importa, ci che conta la situazione del Capitale E, di nuovo, non forse questo oggi pi vero che mai? I fenomeni solitamente descritti come capitalismo virtuale (progetti di operazioni commerciali e simili speculazioni finanziarie astratte) non sono forse indicativi di un regno di reale astrazione allo stato
-
pi puro, molto pi radicale di quanto non lo fosse ai tempi di Marx? In breve, la pi alta forma dideologia non sta nel rimanere invischiati nella spettralit ideologica, dimenticando le persone reali e il loro interagire su cui lidelogia si fonda, ma precisamente nellignorare questo Reale della spettralit, e fingere di riferirsi alla gente reale e alle loro preoccupazioni reali. Chi visita la borsa di Londra riceve gratuitamente un opuscolo che spiega come il mercato finanziario non sia il risultato di misteriose fluttuazioni, ma effettivamente costituito da persone in carne e ossa e da ci che esse producono questa ideologia allo stato puro. E, allora, vuol questo dire che la critica delleconomia politica marxista fornisce una spiegazione adeguata al processo di globalizzazione capitalista? Pi precisamente: dove stiamo oggi rispetto allopposizione fra lanalisi marxista classica del capitalismo come concreta formazione sociale e i tentativi da Heidegger ad Adorno e Horkheimer che vedono la folle danza capitalista, della produttivit che si autoincrementa, come lespressione di un principio ontologico-trascendentale pi fondamentale (volont di potenza, ragione strumentale) riconoscibile anche nei tentativi del comunismo di sconfiggere il capitalismo, in modo che come dice Heidegger americanismo e comunismo finiscono con lessere metafisicamente la stessa cosa? Dal punto di vista marxista classico, la ricerca di un qualche principio ontologico-trascendentale oscura la concreta struttura socioeconomica che sostiene la produttivit capitalista; laddove dal lato opposto, lapproccio marxista classico non vede come leccesso capitalista non si possa spiegare a livello ontico di una particolare organizzazione sociale. A questo punto si tentati di affermare che, in un certo senso, entrambi i punti di vista sono sbagliati. Proprio come
-
marxisti, per il bene della nostra fedelt al lavoro di Marx, dovremmo riconoscere il suo sbaglio: egli intu come il capitalismo scatenasse le dinamiche mozzafiato della produttivit che si autoincrementa si vedano le sue incantate descrizioni di come, nel capitalismo, tutto ci che stabile si volatilizza, o di come il capitalismo sia la pi grande rivoluzione nellintera storia dellumanit; daltro lato, ha anche chiaramente intuito come le dinamiche capitaliste siano mosse da un loro proprio ostacolo o antagonismo interno il limite ultimo del capitalismo (della produttivit auto-propellente capitalista) il capitale stesso, e cio, lo sviluppo incessante e in continua evoluzione delle condizioni materiali proprie del capitalismo: la folle danza della spirale incondizionata della produttivit, alla fin fine, altro non che un disperato volo in avanti per sfuggire alla propria debilitante contraddizione intrinseca Lo sbaglio fondamentale di Marx stato quello di concludere, da queste osservazioni, che un ordine sociale nuovo, superiore (il comunismo) fosse possible, un ordine che non avrebbe semplicemente mantenuto ma persino innalzato ad un livello pi alto il potenziale della spirale autoincrementante della produttivit, dandogli veramente libero sfogo, potenziale che nel capitalismo, a causa del suo ostacolo/contraddizione interni, veniva inibito da ripetute crisi economiche socialmente distruttive. In breve, ci che Marx ha trascurato che per dirla in termini derridiani questo ostacolo/antagonismo intrinseco come condizione dimpossibilit del pieno dispiegamento delle forze produttive allo stesso tempo la sua condizione di possibilit: se eliminiamo lostacolo, la contraddizione intrinseca del capitalismo, non otteniamo una spinta alla produttivit completamente sciolta e finalmente liberata dal suo impedimento, infatti perdiamo proprio quella produttivit
-
che sembrava essere generata e simultanemente frustrata dal capitalismo se rimuoviamo lostacolo, lo stesso potenziale dallostacolo inibito si dissipa (qui si potrebbe prevedere la possibilit di una critica lacaniana a Marx, concentrata sul sovrapporsi ambiguo di plusvalore e plusgodere). Quindi, in un certo senso, le critiche al comunismo erano corrette nellaffermare che il comunismo marxista fosse una fantasia impossibile ci che a esse sfuggito che il comunismo marxista, questidea di una societ di pura e sfrenata produttivit al di fuori della cornice del capitale, era una fantasia intrinseca al capitalismo stesso, la trasgressione capitalista intrinseca allo stato puro, la fantasia rigorosamente ideologica di mantenere la spinta alla produttivit generata dal capitalismo, liberandosi allo stesso tempo dagli ostacoli e dagli antagonismi che erano come dimostra la triste esperienza del capitalismo realmente esistente lunica cornice possibile per leffetiva esistenza materiale di una societ in cui la produttivit si autoalimenta allinfinito. Possiamo ora anche capire, perch la summenzionata prassi di sostituire lanalisi marxista relativamente a qualche fondamento trascendentale-ideologico (il tipico modo in cui i marxisti occidentali cercano di rispondere alla crisi del marxismo) sia inadeguata: ci di cui oggi abbiamo bisogno non il passaggio dalla critica delleconomia politica alla critica della ragione strumentale ontologico-trascendentale, ma un ritorno alla critica delleconomia politica che ci rivelerebbe perch il progetto comunista fosse utopistico esattamente nella misura in cui non era abbastanza radicale nella misura in cui sopravviveva in esso la fondamentale spinta capitalista della produttivit senza freni, privata delle sue concrete condizioni contradditorie di esistenza. Linadeguatezza di Heidegger, Adorno e Horkheimer, e cos via, sta nel loro abbandono di una concreta analisi sociale del
-
capitalismo: quando criticano Marx o persino quando vanno oltre i suoi insegnamenti, in un certo senso ripetono il suo errore come Marx vedono la produttivit a briglia sciolta come qualcosa che , in ultima analisi, indipendente dalla concreta formazione sociale capitalista. Capitalismo e comunismo non sono due diverse realizzazioni storiche, due specie, di ragione strumentale la ragione strumentale in quanto tale capitalista, fondata su relazioni di tipo capitalista; e il socialismo realmente esistente fall perch alla fin fine era una sottospecie del capitalismo, un tentativo ideologico di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, di rompere con il capitalismo preservando il suo ingrediente chiave. La nostra risposta alla comune critica filosofica di Marx (le sue descrizioni delle dinamiche del capitalismo dovrebbero essere respinte, dal momento che hanno senso solo sullo sfondo di una nozione di comunismo come societ totalmente trasparente in cui il processo di produzione direttamente subordinato alla ragione generale della pianificazione collettiva) dunque che, pur accettando nella sostanza questargomentazione, si deve fare un riflessivo passo indietro e rendersi conto che la nozione marxista di societ comunista essa stessa la fantasia immanente del capitalismo uno scenario fantasmatico per risolvere lantagonismo del capitalismo che lui stesso aveva cos abilmente descritto. In altre parole, la nostra premessa che se anche togliamo di mezzo la nozione teleologica di comunismo (la societ della produttivit totalmente senza freni) come criterio implicito secondo il quale Marx, per cos dire, misura lalienazione della societ esistente, il pi della sua critica delleconomia politica, le sue osservazioni sul circolo vizioso autopropellente della (ri)produzione capitalista, sopravvive. Il compito del pensiero contemporaneo allora duplice: da una parte, ripetere la critica delleconomia politica marxista
-
senza il concetto utopistico-ideologico di comunismo quale suo criterio intrinseco; dallaltra, immaginare la vera e propria rottura dellorizzonte capitalista senza cadere nella trappola di ritornare alla nozione eminentemente premoderna di societ equilibrata e auto-controllata (la tentazione pre-cartesiana a cui soccombe oggi la maggior parte dellecologia contemporanea). Allora dove, precisamente, ha sbagliato Marx con riferimento al plusvalore? Si tentati di cercare una risposta nella distinzione chiave lacaniana fra loggetto del desiderio e il plusgodere come sua causa. Henry Krips8 richiama il simpatico esempio dellaccompagnatrice nello schema della seduzione: la chaperon una donna vecchia e brutta che ufficialmente lostacolo frapposto alloggetto-obiettivo diretto (la donna che il pretendente sta corteggiando); ma esattamente in quanto tale lei il momento chiave intermedio che rende la donna amata effettivamente desiderabile senza di lei lintera economia del gioco della seduzione crollerebbe.9 O prendiamo un altro esempio su di un piano diverso: il ricciolo di capelli biondi, quel dettaglio fatale di Madeleine in La donna che visse due volte (Vertigo) di Hitchcock. Quando, nella scena damore nella stalla verso la fine del film, Scottie abbraccia appassionatamente Judy, trasformata nella defunta Madeleine, durante il famoso bacio a 360 gradi, lui smette di baciarla e si scosta giusto abbastanza da rubare uno sguardo ai suoi nuovi capelli biondi, come per rassicurarsi che quella particolare caratteristica che la trasforma nel suo oggetto del desiderio sia ancora l Cruciale qui lopposizione fra il vortice che rischia di travolgere Scottie (la vertigine del titolo del film, la Cosa mortale) e il ricciolo biondo che imita la vertigine della Cosa, ma su scala ridotta, ingentilita. Questo ricciolo il petit objet a che condensa la Cosa
-
impossibile-mortale, agendo da suo sostituto e quindi permettendoci di intrattenere una relazione sopportabile con esso, senza venirne inghiottiti. Come dicono i bambini ebrei quando fanno giochetti pi o meno fisicamente violenti: Per favore, mordimi, ma non troppo forte Questa la differenza fra repressione sessuale normale e feticismo: nella sessualit normale noi pensiamo che la caratteristica-dettaglio che funge da causa del desiderio sia soltanto un ostacolo secondario che ci impedisce di accedere direttamente alla Cosa cio, ignoriamo il suo ruolo chiave; mentre, nel feticismo, noi semplicemente facciamo della causa del desiderio direttamente loggetto del nostro desiderio: a un feticista, ne La donna che visse due volte, non interesserebbe Madeleine, ma concentrerebbe il suo desiderio direttamente sul ricciolo di capelli; un pretendente feticista sintratterrebbe direttamente con la chaperon e si dimenticherebbe della donna che ufficialmente loggetto dei suoi sforzi. Quindi c sempre uno scarto fra loggetto del desiderio in s e la sua causa, la caratteristica che media o lelemento che rende loggetto desiderabile. Quando siamo melanconici perch otteniamo loggetto del desiderio privato della sua causa. Per il melanconico, loggetto l a portata di mano, ma ci che manca la specifica caratteristica intermedia che lo rende desiderabile.10 Per questo motivo, c sempre almeno una traccia di melanconia in ogni vero amore: in amore loggetto non privato della sua causa; piuttosto succede che la stessa distanza fra oggetto e causa collassa. Proprio questo distingue lamore dal desiderio: nel desiderio, come abbiamo appena visto, causa e oggetto sono distinti: mentre in amore i due inspiegabilmente coincidono come per magia io amo il mio innamorato per se stesso, trovando in lui il vero elemento che lo rende per me meritevole del mio amore. E se, per ritornare a Marx, il suo errore fosse stato anche quello di assumere che loggetto del desiderio (una produttivit in
-
espansione senza fine) sarebbe sopravvissuto anche privo della sua causa propellente (plusvalore)? NOTE 6. K. Marx, F. Engels, Manifesto del Partito Comunista (1848), Torino, Einaudi, 1948, pp. 10-11. 7. Ivi, p. 9. 8. Vedi Henry Krips, Fetish. An Erotics of Culture, Ithaca, Cornell University Press, 1999. 9. E non funziona allo stesso modo molto spesso anche con i genitori? Ricordiamo il proverbiale pretendente che, per far colpo sul futuro suocero, simpegna in una tale intensa conversazione con lui che ad un certo punto la povera fidanzata esplode: Cosa centro io in tutto questo? Mi sento come un elemento di disturbo perch voi due non ve ne andate e vi dimenticate completamente di me? 10. Ad esempio, negli ultimi anni del comunismo in Europa dellEst, la democrazia era desiderabile, ma attraverso lintermediazione delle restrizioni poste dal comunismo quando questo ostacolo intermedio cadde, si ottenuto loggetto desiderato, ma privato della sua causa.
-
III COCA COLA COME OBJET PETIT A
Da una prospettiva psicanalitica, ci che qui cruciale il legame fra le dinamiche capitalistiche del plusvalore e le dinamiche libidiche del plusgodere. Elaboriamo questo punto a proposito della Coca Cola come perfetto prodotto capitalista e, in quanto tale, come materializzazione del plusgodere. Non un mistero che la Coca Cola sia stata dapprima introdotta sul mercato come medicina il suo sapore strano non sembra offrire nessuna particolare soddisfazione; non propriamente piacevole n amabile; tuttavia proprio in quanto tale, come trascendente ogni immediato valore duso (diversamente da acqua, birra e vino, che effettiavamente sedano la nostra sete o producono il desiderato effetto dellappagamento), che la Coca Cola funziona come la diretta sostanziazione dellIt: del puro surplus di godimento sulla normale soddisfazione, del misterioso ed elusivo elemento x di cui tutti siamo alla ricerca attraverso il nostro consumo compulsivo di beni. Il risultato inaspettato di questa caratteristica non che, dal momento che la Coca Cola non soddisfa alcun bisogno concreto, la beviamo solo come supplemento, in aggiunta a qualche altra bevanda che ha in effetti soddisfatto il nostro bisogno piuttosto, proprio questo carattere superfluo che rende la nostra sete di Coca Cola ancor pi insaziabile: come dice molto succintamente Jacques-Alain Miller, la Coca Cola
-
ha la paradossale caratteristica per cui pi la bevi e pi ti viene sete e quindi pi grande diventa il tuo bisogno di berla con quello strano sapore dolce-amaro la nostra sete non viene mai interamente soddisfatta.11 Perci, quando, qualche anno fa, lo slogan pubblicitario della Coca Cola era Coke is it!/Coke thats it-[Coca Cola, ecco tutto], avremmo dovuto prestare attenzione alla sua profonda ambiguit: thats it esattamente nella misura in cui non mai in realt tutto, esattamente nella misura in cui ogni sorso/soddisfazione apre uno spazio (di) vuoto per dire Ne voglio ancora di pi!. Il paradosso, dunque, che la Coca Cola non una merce ordinaria onde il suo valore duso si transsostanzia in unespressione della (o integrato con la) dimensione auratica del puro Valore (di scambio), ma una merce il cui peculiare valore duso esso stesso gi una diretta realizzazione dellaura soprasensibile dellineffabile surplus spirituale, una merce le cui propriet materiali stesse sono gi quelle di una merce. Questo circolo si chiude con la Coca Cola light decaffeinata perch? Beviamo Coca Cola o qualsiasi altra bibita per due motivi: per i suoi valori nutrizionali o per la sua efficacia dissetante, e per il suo sapore. Nel caso della Coca Cola light decaffeinata, il suo valore nutrizionale sospeso e anche la caffeina, ingrediente chiave del suo sapore, altrettanto eliminata tutto ci che resta una pura somiglianza, la promessa artificiale di una sostanza che mai si materializza. Non vero che in questo senso, nel caso della Coca Cola light decaffeinata, letteralmente quasi non beviamo nulla sottoforma di qualcosa? Ci a cui facciamo implicito riferimento qui, ovviamente, la classica opposizione di Nietzsche fra volere niente (nel senso di Non voglio niente) e la posizione nichilista di volere attivamente il Niente in s; seguendo il percorso di Nietzsche, Lacan sottolinea come nel caso
-
dellanoressia, il soggetto non che semplicemente non mangi nulla piuttosto, vuole attivamente mangiare il Nulla (il Vuoto) che di per se stesso loggettocausa finale del desiderio. (Al pari dicasi riguardo al famoso paziente di Ernst Kris che si sentiva colpevole di furto, anche se in realt non rubava nulla: ci che rubava era il Niente stesso.) Quindi sulla stessa linea, nel caso della Coca Cola light decaffeinata, noi beviamo il Niente stesso, la pura sembianza di una qualit che in effetti il mero involucro di un vuoto. Questo esempio ci permette di realizzare lintrinseco legame fra le tre nozioni: quella marxista di plusvalore, quella lacaniana dellobjet petit a come plusgodere (il concetto elaborato da Lacan in diretto riferimento al plusvalore marxista), e il paradosso del Super-io, colto molto tempo fa da Freud: pi Coca Cola bevi e pi hai sete; pi profitto fai e pi ne vuoi; pi obbedisci al comando del Super-io, e pi sei colpevole in tutti e tre i casi, la logica di uno scambio bilanciato disturbata in favore di una logica eccessiva di pi dai (pi paghi i tuoi debiti) pi devi (o pi hai ci che ardentemente desideri, pi ti manca e pi disperatamente lo desideri, o nella versione consumistica pi compri, pi devi spendere): cio, del paradosso che proprio lopposto del paradosso dellamore dove, come lo espresse Giulietta nelle sue immortali parole a Romeo, pi do a te e pi ho per me. La spiegazione di questa interferenza , ovviamente, il plusgodere, lobjet petit a, che esiste (o meglio insiste) in una sorta di spazio curvo in modo che pi ti avvicini, pi elude la tua presa (pi lo possiedi, pi ti manca).12 Forse la differenza tra i sessi entra qui in gioco in modo inaspettato: la ragione per cui il Super-io pi forte negli uomini che nelle donne che sono gli uomini, non le donne, a essere in intensa relazione con questo eccesso di plusgodere sulla funzione pacificante della Legge simbolica. In termini di
-
funzione paterna, lopposizione fra Legge simbolica pacificante e ingiunzione eccessiva del Super-io , ovviamente, quella fra il Nome-del-Padre (lautorit paterna simbolica) e il padre primordiale a cui concesso di godere di tutte le donne; ed cruciale qui ricordare che questo padre primordiale violentatore una fantasia maschile (ossessiva), non una femminile (isterica): proprio gli uomini sono in grado di sopportare la loro integrazione nellordine simbolico solo quando questa integrazione sostenuta da qualche riferimento nascosto alla fantasia di uno sfrenato godimento eccessivo materializzata nellincondizionata ingiunzione superegoica a godere, ad andare allestremo, a trasgredire e forzare costantemente i limiti. In breve, negli uomini che lintegrazione nellordine simbolico sostenuta dalleccezione superegoica. Questo paradosso del Super-io ci permette anche di gettare una nuova luce sul funzionamento della scena artistica attuale. La sua caratteristica fondamentale non solo il tanto deprecato fenomeno della mercificazione della cultura (oggetti darte prodotti per il mercato), ma anche il meno noto e forse persino pi critico fenomeno opposto: la crescente culturalizzazione delleconomica di mercato. Con lo spostamento verso leconomia del terziario (servizi, beni culturali), la cultura sempre meno un campo specifico avulso dal mercato, e sempre pi non solo una delle sfere del mercato, ma la sua componente centrale (dallindustria dei software per il divertimento ad altre produzioni per i media). Quello che questo corto circuito fra mercato e cultura comporta il declino della vecchia logica della provocazione propria dellavanguardia modernista, quella di scioccare lestablishment. Oggi sempre pi lo stesso apparato economico-culturale, al fine di riprodursi in condizioni di mercato competitive, non solo deve tollerare, ma
-
direttamente provocare effetti sempre pi scioccanti. Si pensi solo alle recenti tendenze nelle arti visive: andati sono in tempi in cui bastavano statue pure e semplici o dipinti nelle loro cornici ci che abbiamo oggi sono mostre di cornici senza dipinti, di mucche morte e dei loro escrementi, di riprese video del corpo umano al suo interno (gastroscopie e colonscopie), effetti olfattivi inclusi, e cos via.13 Qui di nuovo, come nellambito della sessualit, la perversione non pi sovversiva: tali eccessi scioccanti sono integrati nel sistema stesso; il sistema si ciba di essi al fine di riprodursi. Forse questa una possibile definizione di postmoderno in contrapposizione allarte moderna: nel post-modernismo, leccesso trasgressivo perde il suo valore scioccante e viene completamente integrato nel mercato artistico ufficiale.14 Un altro modo di giungere alla medesima conclusione potrebbe essere quello di evidenziare come, nellarte contemporanea, il vuoto che separa lo spazio sacro della bellezza sublime dallo spazio escrementizio della spazzatura (gli avanzi) si stia gradualmente restringendo, fino a una paradossale idenit degli opposti: gli oggetti dellarte moderna non sono forse sempre pi oggetti-escrementi, spazzatura (spesso proprio nel senso piuttosto letterale del termine: feci, corpi in decomposizione) messi in mostra nel fatti per occupare, riempire il luogo sacro della Cosa? E questa identit non in un certo senso la verit nascosta dellintero movimento? Ogni elemento che rivendica il diritto di occupare il luogo sacro della Cosa non per definizione un oggetto escrementizio, spazzatura che non pu mai essere allaltezza del proprio incarico? Questidentit di opposte determinazioni (lelusivo oggetto sublime e/o rifiuto escrementizio) con la minaccia sempre presente che luno scivoli nellaltro, che il sublime Graal si riveli essere niente altro che un pezzo di merda iscritta nello stesso nucleo del
-
lacaniano objet petit a. Nella sua dimensione pi radicale, questa limpasse che agisce sul processo di sublimazione non nel comune senso per cui la produzione artistica oggi non pi in grado di generare oggetti veramente sublimi, ma in un senso molto pi radicale: proprio la matrice fondamentale della sublimazione, quella del Vuoto centrale, lo spazio (sacro) vuoto della Cosa esente dal circuito delleconomia quotidiana, che allora riempito da un oggetto positivo che in questo modo viene elevato alla dignit della Cosa (definizione lacaniana di sublimazione), sembra essere minacciata sempre di pi; ci che minacciato proprio lo scarto fra il Luogo vuoto e lelemento (positivo) che lo riempie. Se, allora, il problema dellarte tradizionale (premoderna) era quello di riempire il Vuoto sublime della Cosa (il Luogo puro) con un oggetto adeguatamente bello come riuscire a elevare un oggetto ordinario alla dignit della Cosa il problema dellarte moderna , in un certo senso, lopposto (e molto pi disperato): non si pu pi contare sullesserci di questo Vuoto del Luogo (Sacro), che si presti a essere occupato dalle creazioni delluomo, quindi il compito quello di sostenere il Luogo in quanto tale, per assicurarsi che questo stesso Luogo avr luogo in altre parole, il problema non pi quello dellhorror vacui, di riempire il Vuoto, ma, piuttosto, quello di creare il Vuoto in prima istanza. Allora la codipendenza fra un luogo vuoto, inoccupato, e un oggetto sfuggente e in rapido movimento, un occupante senza un luogo, cruciale.15 La questione non semplicemente leccedenza di un elemento sui luoghi a disposizione nella struttura, o leccedenza di un luogo che non ha elementi per riempirlo un luogo vuoto nella struttura continuerebbe a sostenere lillusione che un elemento spunter fuori a colmare questo luogo; un elemento di troppo sprovvisto del suo luogo continuerebbe a sostenere
-
lillusione che ci sia un luogo tuttavia ancora ignoto che lo sta aspettando. Il punto piuttosto che il luogo vuoto nella struttura in s correlativo allelemento errante che manca del suo luogo: non sono due diverse entit, ma il dritto e il rovescio della unica e medesima entit e cio, lunica e medesima entit iscritta nelle due superfici del nastro di Moebius. In altre parole, il paradosso sta nel fatto che solo un elemento totalmente fuori luogo (un escremento, dei rifiuti o degli avanzi) pu sostenere il vuoto di uno luogo vuoto, cio, la situazione mallarmiana in cui rien naura eu lieu que le lieu (niente avr avuto luogo se non il luogo stesso) nel momento in cui questo elemento in eccesso avr trovato il suo luogo, non c pi alcun Luogo puro, distinto dagli elementi che lo riempiono.16 Unaltra via per affrontare questa tensione fra lOggetto e il Vuoto potrebbe passare attraverso i diversi modi del suicidio. Per primo c, ovviamente, il suicidio come atto portatore di un messaggio (di protesta contro il disappunto politico, sessuale e via dicendo), ed , in quanto tale indirizzato allAltro (ne sono un esempio i suicidi politici dove il suicida si brucia vivo in pubblico, che hanno la funzione di scioccare e risvegliare lindifferenza della gente). Bench tocchi la dimensione del Simbolico questo tipo di suicidio , essenzialmente, immaginario per il semplice motivo che il soggetto che lo compie in esso sostenuto dalla scena che lui simmagina delleffetto del suo atto sui posteri, su chi era presente, sul pubblico, su quelli che ne verranno a sapere; la soddisfazione narcisistica data da questa immagine ovvia Quindi, c il suicidio nel Reale: il violento passage lacte, la piena e diretta identificazione del soggetto con loggetto. Vale a dire, per Lacan, il soggetto ($ il soggetto vuoto, barrato) e loggetto-causa del suo desiderio (gli avanzi che icarnano la mancanza che il soggetto) sono in stretta corrispondenza:
-
c un soggetto solamente in quanto c una qualche macchia materiale/un avanzo che resiste alla soggettivizzazione, uneccedenza in cui, precisamente, il soggetto non pu riconoscersi. In altre parole, il paradosso del soggetto che esiste solo attraverso la propria radicale impossibilit, attraverso un osso in gola che sempre gli impedir di raggiungere la propria piena identit ontologica. Quindi abbiamo qui la struttura del nastro di Moebius: il soggetto correlativo alloggetto, ma in negativo soggetto e oggetto non possono incontrarsi mai; sono nello stesso luogo, ma su lati opposti del nastro di Moebius. O per usare termini filosofici soggetto e oggetto sono identici nel senso hegeliano della coincidenza/identit speculativa degli opposti: quando Hegel loda la verit speculativa della popolare tesi materialista della frenologia lo spirito un osso, il suo punto non che lo spirito pu veramente essere ridotto alla forma del cranio, ma che c uno spirito (soggetto) solo nella misura in cui c qualche osso (qualche inerte resto/avanzo materiale non spirituale) che resiste la sua sublazione-appropriazione-mediazione spirituale. Soggetto e oggetto allora non sono semplicemente esterni: loggetto non il limite esterno rispetto al quale il soggetto definisce la sua identit, esso determinato in relazione al soggetto, il suo limite interno cio, la barra stessa che impedisce la piena realizzazione del soggetto. Quello che accade nel passage lacte suicida, tuttavia, precisamente la diretta identificazione del soggetto con loggetto: loggetto non pi identico al soggetto nel senso hegeliano di identit speculativa del processo dialettico, con lostacolo che sostiene questo processo essi coincidono direttamente, si ritrovano sullo stesso lato del nastro di Moebius. Questo significa che il soggetto non pi il puro Vuoto di Negativit ($), il desiderio infinito, il Vuoto alla
-
ricerca delloggetto assente, ma cade nelloggetto direttamente, diventa loggetto; e viceversa loggetto (causa del desiderio) non pi la materializzazione del Vuoto, una presenza spettrale che d meramente corpo alla mancanza che sostiene il desiderio del soggetto, ma acquista unesistenza positiva diretta e una consistenza ontologica. O, per usare i termini dello scarto minimo fra Oggetto e il suo Luogo, il Vuoto/Apertura insito nelloggetto appare: ci che accade nel passage lacte suicida non che loggetto cade fuori dalla sua cornice, cosicch ci restano solo una cornice-vuoto liberi (di modo che, per esempio, niente altro che il luogo stesso ha luogo); quello che accade piuttosto lesatto opposto loggetto ancora l; il Vuoto-Luogo a scomparire; la cornice che cade in ci che incornicia, cosicch accade uneclisse dellapertura simbolica, la totale chiusura del Reale. Come tale, il passage lacte suicida non solo non la pi alta espressione della pulsione di morte, piuttosto, ne lesatto contrario. Per Lacan, la sublimazione creativa e la pulsione di morte sono strettamente correlate: la pulsione di morte svuota il Luogo (sacro), crea lApertura, il Vuoto, la Struttura, che viene quindi riempita dalloggetto elevato alla dignit della Cosa. Qui troviamo il terzo tipo di suicidio: il suicidio che definisce la pulsione di morte, il suicidio simbolico non nel senso di non morire per davvero, ma solo simbolicamente, ma nel pi preciso senso di cancellare il reticolo simbolico che definisce lidentit del soggetto, di tagliare tutti i legami che ancorano il soggetto alla sua sostanza simbolica. Qui, il soggetto si ritrova completamente spogliato della sua identit simbolica, gettato nella notte del mondo in cui il suo unico corrispondente il minimo di avanzo escrementizio, un pezzo di spazzatura, un granello di polvere nellocchio, un quasi-niente che sostiene il puro
-
Luogo-Struttura-Vuoto, in modo tale che qui, finalmente, nientaltro che il luogo stesso ha luogo. Quindi la logica di esporre un oggetto escrementizio nel Luogo sublime simile al modo in cui funziona il giudizio infinito hegeliano lo spirito un osso: la nostra prima reazione a lo spirito un osso di Hegel ma questa una affermazione senza senso lo spirito, il suo assoluto, la negativit autoreferenziale lesatto opposto dellinerzia di un teschio, questoggetto morto! tuttavia, proprio questa consapevolezza della profonda incongruenza fra lo spirito e losso lo Spirito, la sua radicale negativit Sulla stessa linea, la nostra prima reazione al vedere delle feci nel Luogo sublime, chiedere indignati: E questa sarebbe arte? ma esattamente questa reazione negativa, questesperienza di radicale incongruenza fra loggetto e il Luogo che occupa, che ci rende consapevoli della specificit di questo Luogo. E, in effetti, come suggerisce Gerard Wajcman nel suo libro degno di nota Lobject du sicle,17 non il grande sforzo dellarte moderna concentrato su come mantenere la struttura minima di sublimazione, lo scarto minimo fra il Luogo e lelemento che lo riempie? Non forse per questo che Black Square on White Surface di Kasimir Malevich esprime il tentativo artistico al suo stadio pi elementare, ridotto alla pura distinzione fra il Vuoto (lo sfondo/superficie bianchi) e lelemento (la pesante macchia materiale del quadrato)? Vale a dire, dovremmo sempre ricordarci che proprio il tempo [futur anterieur] del famoso motto di Mallarm rien naura eu lieu que le lieu, chiarisce che abbiamo a che fare con una condizione utopica che, per ragioni strutturali a priori, non pu mai venire realizzata nel tempo presente (non ci sar mai un tempo presente in cui solo il luogo stesso avr luogo). Non semplicemente che il Luogo che occupa conferisce a un oggetto la dignit sublime, ma anche che solo la presenza di questo oggetto sostiene il Vuoto del Luogo Sacro, in modo tale
-
che il Luogo stesso non ha mai luogo, ma sempre qualcosa che, retroattivamente, avr avuto luogo dopo essere stato disturbato da un elemento positivo. In altre parole, se sottraiamo al Vuoto lelemento positivo, quel frammento di realt, la macchia in eccesso che disturba il suo equilibrio, non otteniamo il puro Vuoto in equilibrio in quanto tale piuttosto, il Vuoto stesso scompare, non pi l. Perci il motivo per cui gli escrementi sono elevati a opera darte, usati per riempire il Vuoto della Cosa, non semplicemente dimostrare che qualsiasi cosa va bene, che loggetto in definitiva irrilevante, dal momento che qualsiasi oggetto pu essere elevato a occupare il Luogo della Cosa; questo ricorso agli escrementi testimonia, piuttosto, una misura disperata per accertarsi che il Luogo sia ancora l. Il problema che oggi, nel doppio movimento della progressiva mercificazione dellestetica e dellestetizzazione delluniverso delle merci, un oggetto bello (esteticamente piacevole) sempre meno in grado di sostenere il Vuoto della Cosa cos come se, paradossalmente, lunico modo di sostenere il Luogo (Sacro) fosse quello di riempirlo di spazzatura, di riempirlo con un vile oggetto escrementizio. In altre parole, sono gli artisti contemporanei che mettono in mostra questi oggetti escrementizi come oggetti darte che, lungi dal minare la logica della sublimazione, tentano disperatamente di salvarla. E le conseguenze della caduta dellelemento nel Vuoto del Luogo stesso sono potenzialmente catastrofiche: senza lo scarto minimo fra lelemento e il suo Luogo, semplicemente non c ordine simbolico. Il che equivale a dire che rimaniamo allinterno dellordine simbolico solo nella misura in cui ogni presenza appare contro lo sfondo della sua possible assenza (questo ci cui mira Lacan con il concetto di significante fallico come significante della castrazione: questo significante il
-
significante puro, il significante in quanto tale, nella sua forma pi elementare, in quanto proprio la sua presenza significa, evoca la sua possibile assenza/mancanza). Forse la pi concisa definizione di rottura modernista in ambito artistico quindi che, attraverso essa, la tensione fra lOggetto (arte) e il Luogo che occupa viene riflessivamente presa in considerazione: ci che rende un oggetto unopera darte non sono semplicemente le sue immediate qualit materiali, ma il luogo che esso occupa, il Luogo (sacro) del Vuoto della Cosa. In altre parole, con larte moderna una certa innocenza andata perduta per sempre: non possiamo pi fingere di produrre direttamente degli oggetti che, per via delle loro caratteristiche cio, indipendentemente dal luogo che occupano sono opere darte. Per questo motivo, larte moderna per sempre divisa fra due estremi rappresentati proprio alle sue origini da Malevich e da Marcel Duchamp: da un lato, il puro segno formale dello scarto che separa lOggetto dal suo Luogo (Black Square), dallaltro, la presentazione di un comune oggetto di uso quotidiano prodotto in serie (una bicicletta) come opera darte, per provare che ci che costituisce arte dipende non dalle qualit delloggetto artistico, ma esclusivamente dal Luogo che questo oggetto occupa, cosicch qualsiasi cosa, persino la merda, pu essere unopera darte se si trova nel giusto Luogo. E qualsiasi cosa si faccia dopo la rottura modernista, anche se si tratta di un ritorno al falso neoclassicismo la Arno Brekker, gi comunque mediata da questa rottura. Prendiamo un realista del ventesimo secolo come Edward Hopper: (almeno) tre caratteristiche del suo lavoro stanno a testimoniare questa mediazione. In primo luogo, la ben nota tendenza di Hopper a dipingere uomini e donne di notte, soli in luoghi eccessivamente illuminati, visti da fuori, attraverso (la cornice del)la finestra anche se non ci fosse la
-
finestra a fare da cornice, limmagine tracciata in un modo tale che chi la guarda comunque spinto a immaginare uninvisibile cornice immateriale che lo separa dagli oggetti dipinti. In secondo luogo, il modo in cui le opere di Hopper, proprio per liperrealismo da cui sono connotate, producono in chi le guarda un effetto di derealizzazione, come se si avesse a che fare con cose rarefatte, spettrali, di sogno, non comuni cose materiali (ad esempio i prati bianchi dei suoi paesaggi campestri). In terzo luogo, il fatto che, nella serie di ritratti a sua moglie, rappresentata da sola, seduta in una stanza illuminata da una forte luce solare, a fissare un punto impreciso fuori della finestra aperta, si percepisca la scena come lo sbilanciato frammento di una scena pi complessa, che richiede unintegrazione, facendo riferimento a un invisibile spazio fuoricampo, come il fermo immagine di un film girato senza il suo complemento (in effetti si pu anche dire che i quadri di Hopper sono addirittura gi mediati dallesperienza cinematografica). Proprio in questo senso, si tentati di ribadire la contemporaneit del modernismo in campo artistico con lo stalinismo in politica: nellelevazione del leader saggio operata dallo stalinismo, lo scarto che separa loggetto dal suo luogo viene ugualmente portato a un estremo e cos, in qualche modo, preso in considerazione riflessivamente. Nel suo saggio chiave On the problem of the Beautiful in Soviet Art (1950), il critico sovietico G. Nedoshivin afferm: Fra tutto il bel materiale della vita, il primo posto dovrebbe essere occupato dalle immagini dei nostri grandi leader La sublime bellezza dei leader la base per la coincidenza del bello e del vero nellarte del socialismo realista.18 Ma come facciamo noi a capire questa logica che, per ridicolo che possa sembrare, funziona anche oggi, nella Corea di Kim Yong Il?19 Queste caratterizzazioni non si riferiscono
-
alle reali caratteristiche del leader qui ritroviamo la stessa logica dellamore cortese dove alla Donna, come evidenziato da Lacan, ci si rivolge come a un Ideale astratto, in modo che gli scrittori hanno notato che tutti i poeti sembrano parlare alla medesima persona In questo campo poetico loggetto femminile svuotato di ogni sua reale sostanza.20 Questo carattere astratto della Donna rivela lastrazione propria di un partner freddo, distaccato e inumano questa Donna non per niente il tipocompagna affettuoso, compassionevole e comprensivo: Per mezzo di una forma di sublimazione specifica allarte, la creazione poetica consiste nel porre un oggetto che io posso solo descrivere come terrificante, un partner inumano. La Donna non viene mai caratterizzata per alcuna delle sue reali e concrete virt, per la sua saggezza, per la sua prudenza, n tantomeno per la sua competenza. Se viene descritta come saggia, soltanto perch impersona una saggezza immateriale o perch rappresenta le sue funzioni pi di quanto non le eserciti. Al contrario, quanto pi possibile capricciosa nelle prove che impone al suo sevitore.21 E non vale forse lo stesso discorso per il Leader stalinista? Allo stesso modo, quando acclamato come sublime e saggio, non rappresenta queste funzioni pi di quanto non le eserciti? Nessuno potrebbe sostenere che Malenkov, Beria e Khrushchev fossero modelli di bellezza maschile il punto che semplicemente rappresentano la funzione di bellezza (In contrasto con il Leader stalinista, lo psicanalista oggettivamente brutto anche se in realt una persona fisicamente bella o sessualmente attraente: nella misura in cui occupa il luogo impossibile delloggetto abietto, della rimanenza escrementizia dellordine simbolico, egli rappresenta la funzione della bruttezza.) In questo senso, la
-
definizione del Leader stalinista come sublime deve essere presa letteralmente, in senso stretto lacaniano: la sua celebrata saggezza, la generosit, il calore umano e cos via, sono pure rappresentazioni impersonificate dal Leader che possiamo solo descrivere come terrificante, un partner inumano non unautorit simbolica che obbedisce alla Legge, ma una Cosa volubile che quanto pi possible capricciosa nelle prove che impone ai suoi servitori. Di conseguenza il prezzo che il Leader stalinista paga per essere elevato a sublime oggetto di bellezza la sua radicale alienazione: come la Donna dellamore cortese, la persona reale viene trattata effettivamente come un appendice della celebrata e feticizzata Immagine pubblica. Non c da meravigliarsi che la prassi di fare dei ritocchi alle fotografie ufficiali fosse largamente diffusa, con interventi talvolta cos grossolani e palesi che difficilmente si pu credere non fossero intenzionali come per (di)mostrare che la persona reale, con tutte le sue idiosincrasie, veniva sostituita in toto con unimmagine estranea e inespressiva. (Corre voce che Kim Yong Il sia in realt morto in un incidente dauto un paio danni fa e che recentemente un sosia labbia sostituito nelle sue rare apparizioni in pubblico, in modo che la folla possa scorgere durante queste fugaci apparizioni loggetto della propria venerazione quale miglior conferma possiamo allora trovare del fatto che la reale persona(lit) del Leader stalinista sia totalmente irrilevante, un oggetto tranquillamente sostituibile, dal momento che non importa se quello che vediamo il Leader vero o il suo sosia, il quale ultimo non ha nessun potere effettivo?) E questa prassi di elevare una comune figura volgare allideale di Bellezza di ridurre la bellezza a unidea puramente funzionale non forse strettamente collegata alloperazione, attuata dallarte moderna, di elevare un oggetto quotidiano escrementizio a opera darte?22
-
Un modo per gettar maggior chiarezza sulla collocazione del momento di rottura fra arte moderna e arte tradizionale potrebbe passare attraverso il riferimento al quadro che in effetti occupa il posto del mediatore evanescente fra le due: il famoso/famigerato Lorigine du monde di Gustave Courbet, raffigurante il busto di una donna privo testa, esposto senza pudore, nudo ed eccitato, con lattenzione puntata sugli organi genitali. Questo quadro, che letteramente scomparve per quasi un secolo, fu finalmente ritrovato e in modo alquanto opportuno fra i beni di Lacan dopo la sua morte.23 Lorigine esprime il punto morto della pittura realista tradizionale, il cui obiettivo finale mai direttamente rivelato, ma sempre alluso, presente come una sorta di sottinteso punto di riferimento, almeno a partire dal Verwisung di Albrecht Drer era, ovviamente, il corpo femminile nudo e totalmente sessualizzato come oggetto ultimo del desiderio e dello sguardo maschili. Qui il corpo femminile scoperto funziona in modo simile ai riferimenti sessuali sottintesi nei (film) classici di Hollywood, come magistralmente descritto nelle indicazioni del magnate cinematografico Monroe Stahr ai suoi sceneggiatori ne Gli ultimi fuochi (1976), trasposizione cinematografica dellomonimo romanzo di F. S. Fitzgerald: Sempre, in ogni momento in cui appare sullo schermo al nostro sguardo, lei deveessere posseduta dal desiderio di dormire con Ken Willard Qualsiasi cosa faccia, lo fa in luogo di dormire con Ken Willard: se cammina per la strada, sta camminando per andare a dormire con Ken Willard, se mangia qualcosa lo fa per avere la forza di dormire con Ken Willard; ma mai, mai in nessun momento dovr dare limpressione di considerare anche lontanamente lipotesi di dormire con lui senza essere ufficialmente legittimati a farlo.24
-
Quindi questo corpo femminile messo a nudo loggetto impossibile che, proprio perch non rappresentabile, funge da orizzonte ultimo della rappresentazione la cui rivelazione posticipata allinfinito in breve, funge da Cosa incestuosa lacaniana. La sua assenza, il Vuoto della Cosa, viene allora riempito dalle immagini sublimate di corpi femminili bellissimi ma non completamente scoperti da corpi che mantengono sempre una certa distanza da Quello. Ma il punto cruciale (o, piuttosto, la sottostante illusione) della pittura tradizionale che il vero corpo nudo incestuoso tuttavia l ad aspettare di essere scoperto in breve, lillusione del realismo tradizionale non sta nella resa fedele degli oggetti rappresentati; sta piuttosto nel credere che dietro agli oggetti direttamente rappresentati ci sia la Cosa assoluta che potrebbe essere posseduta se solo fossimo capaci di eliminare gli ostacoli o le proibizioni che ci impediscono di accedervi. Ci che Courbet qui mette a segno un gesto di radicale desublimazione: si assunto il rischio e semplicemente andato fino in fondo dipingendo direttamente ci a cui i pittori realisti prima di lui avevano semplicemente accennato come punto di riferimento rimosso ovviamente, il risultato di questoperazione stato, per usare le parole di Kristevan, il rovesciamento delloggetto sublime in oggetto vile, in un viscido e nauseabondo pezzo di escremento. (Pi precisamente, Courbet magistralmente ancora indugiava sullimpreciso limite che separa il sublime dallescrementizio: il corpo della donna nellOrigine mantiene tutta la sua carica erotica, ma allo stesso tempo diventa ripugnante precisamente a causa di questa carica attrattiva.) Il gesto di Courbet pertanto un vicolo cieco, il punto morto della pittura realista tradizionale ma esattamente in quanto tale, un agente intermedio necessario fra larte tradizionale e larte moderna vale a dire, rappresenta un gesto che doveva
-
essere compiuto per sgomberare il campo allemergente arte astratta moderna. Con Courbet, finisce il gioco dei riferimenti alloggetto incestuoso ma sempre assente nellarte realista, crolla la struttura della sublimazione e limpresa dellarte moderna ri-stabilire la matrice della sublimazione (lo scarto minimo che separa il Vuoto della Cosa dalloggetto che lo riempie) al di fuori delle restrizioni realiste, cio, al di l di credere nella reale presenza della Cosa incestuosa dietro alla superficie ingannevole del dipinto. In altre parole, con Courbet, impariamo che non c alcuna Cosa dietro alla sua sublime apparenza che, se ci forziamo la strada attraverso la sublime apparenza fino alla Cosa stessa, tutto quello che otteniamo il soffocante disgusto per loggetto abietto; quindi, lunico modo di ri-stabilire la struttura minima della sublimazione di mettere in scena direttamente il Vuoto stesso, la Cosa come Vuoto-Luogo-Cornice, senza lillusione che il Vuoto sia sostenuto da qualche incestuoso Oggetto nascosto.25 Possiamo capire a questo punto in quale modo precisamente e per paradossale che possa sembrare Black Square di Malevich, come quadro pionieristico dellarte moderna, sia il vero contrappunto di Lorigine: con Courbet, abbiamo la Cosa incestuosa stessa che minaccia di far implodere lApertura/Radura, il Vuoto in cui gli oggetti (sublimi) (possono apparire) appaiono; mentre con Malevich, ci che abbiamo lesatto opposto, la matrice della sublimazione al suo stato pi elementare, ridotta a nudo segno della distanza fra primo piano e sfondo, fra un oggetto interamente astratto (il quadrato) e il Luogo che lo contiene. Lastrazione della pittura moderna dovrebbe quindi essere vista come una reazione allaperta presenza delloggetto concreto, la Cosa incestuosa, che diventa un abietto oggetto disgustoso vale a dire, trasforma il sublime in un eccesso escrementizio.26
-
E il compito dellanalisi storica materialista qui quello di collocare queste determinazioni tutte troppo formali, nel loro concreto contesto storico. In primo luogo c, ovviamente, lestetizzazione delluniverso delle merci summenzionata: il suo risultato ultimo che per dirla in termini in qualche modo patetici oggi, veri e propri pezzi di spazzatura sono i begli oggetti da cui siamo bombardati su tutti i fronti; di conseguenza, lunico modo di sfuggire alla spazzatura di mettere la spazzatura stessa nel luogo sacro del Vuoto. Tuttavia, la situazione pi complicata. Da un lato, c lesperienza di catastrofi globali (reali o immaginarie) dalle catastrofi naturali o nucleari allolocausto il cui impatto traumatico cos potente da non poter essere pi concepite come semplici eventi che hanno luogo allinterno dellorizzonte/apertura sorretto dal Vuoto della Cosa in esse, la Cosa stessa a non essere pi assente, cio, presente come Vuoto, come lo sfondo di eventi reali, ma minaccia di diventare direttamente presente, di realizzarsi nella realt e perci di provocare un collasso psicotico dello spazio simbolico. Dallaltro, la prospettiva di una catastrofe globale non era propria al ventesimo secolo allora perch ha avuto un tale impatto proprio in quel secolo e non prima? Ancora, la risposta sta nel progressivo sovrapporsi di estetica (lo spazio della bellezza sublime esente dallo scambio sociale) e mercificazione (il terreno stesso dello scambio): questo sovrapporsi e il suo risultato, lesaurimento della capacit stessa di sublimare, che trasforma ogni incontro con la Cosa in una dirompente catastrofe globale, la fine del mondo. Non c da stupirsi, allora, che nelle opere di Andy Warhol loggetto di uso quotidiano prodotto in serie trovatosi a occupare il luogo sublime dellopera darte altro non fosse che una fila di bottiglie di Coca Cola.
-
NOTE 11. Non succede forse qualcosa di analogo, su di un altro piano, con gli aiuti del Fondo Monetario Internazionale ai paesi in via di sviluppo del Terzo Mondo? Non forse vero che pi questi Paesi accettano laiuto e obbediscono alle condizioni o seguono i consigli del FMI pi ne hanno bisogno? 12. Le famose armi di distruzione di massa irachene offrono un altro esempio di objet petit a: sono unentit dai contorni vaghi, mai veramente specificati, una sorta di MacGuffin hitchcockiano. Ci si aspetta che siano nascoste nei posti pi disparati e impossibili, dal deserto (supposizione piuttosto logica) alla cantina del palazzo presidenziale (leggermente irrazionale dal momento che, se il palazzo venisse bombardato, Saddam e tutto il suo entourage sarebbero automaticamente avvelenati); si presume che siano presenti in grandi quantit, tuttavia sembra che vengano spostate in giro come per magia dagli operai tutto il tempo; e pi vengono distrutte, pi ; sono onnipresenti e onnipotenti nella minaccia che rappresentano, quasi che la rimozione della maggior parte di esse facesse magicamente aumentare il potere distruttivo di ci che rimane come tali per definizione non possono mai essere trovate, e perci sono ancor pi pericolose 13. Questa tendenza spesso porta a una confusione quasi comica per cui unopera darte viene scambiata per un oggetto di uso quotidiano o viceversa. Recentemente a Berlino, in Postadamerplatz, il pi grande sito in costruzione della citt, stato orchestrato tutto un movimento coordinato di dozzine di gru gigantesche come rappresentazione artistica senza dubbio stato per percepito da molti dei passanti, che non erano a conoscenza delloperazione, semplicemente come parte di unintensa attivit lavorativa Io stesso ho commesso il medesimo grossolano errore, ma al contrario, sempre a Ber
-
lino, durante uno dei miei viaggi: ho notato diversi tubi e condutture piuttosto grandi che correvano lungo e sopra le strade principali, come se lintricata ragnatela di tubature dellacqua, cavi del telefono e dellelettricit e cos via non fosse pi nascosta sotto terra, ma esposta al pubblico. Ovviamente ho pensato che fosse probabilmente unaltra di quelle performance postmoderne il cui scopo era, questa volta, quello di rivelare lintestino della citt, la sua nascosta macchina interiore, un sorta di equivalente di quei video che mostrano le contrazioni del nostro stomaco o dei nostri polmoni tuttavia i miei amici mi dissero subito che mi stavo sbagliando, che avevo visto semplicemente parte della normale attivit di manutenzione e riparazione della rete sotterranea della citt. 14. Vale la pena di notare che la teoria lacaniana, con la sua relazione fra plusvalore e plusgodimento, che offre la migliore struttura teoretica per afferrare questa nuova tendenza, rispetto al fatto che uno dei classici punti di critica a Lacan che la sua teoria sia astratta e proto-kantiana, trattando con un sistema simbolico astorico e ignorando le concrete condizioni storicosociali del suo oggetto. Possiamo vedere da questo esempio come, chiaramente in contrasto con questa critica, i Cultural Studies, che celebrano nuove e plurime forme perverse di produzione artistica, non prendano in sufficiente considerazione il fatto che questi fenomeni siano fondati sul capitalismo globale e sulla sua costante accelerazione verso la mercificazione la teoria lacaniana che ci permette di concettualizzare completamente questa relazione, di ristoricizzare effettivamente le materie degli studi culturali. 15. Gilles Deleuze, Logica del senso, Milano, Feltrinelli, 2005. 16. Forse un modo dimmaginare questidea del niente altro se non il luogo che ha luogo pu essere spiegata
-
dallesperienza di vedere che il foglio sputato dal fax vuoto: questo vuoto sta a significare che la macchina non ha funzionato bene, che il testo scritto sul foglio dallaltra parte del cavo non stato trasmesso o che la persona dallaltra parte (con tutta probabilit per errore) ha infilato nel fax un foglio bianco (o inserito il foglio dal lato sbagliato)? Non troviamo qui una copia meccanica della distinzione nietzscheana fra non volere niente e [attivamente] volere il niente in s? Il foglio bianco potrebbe voler dire che il messaggio non arrivato oppure che la pagina bianca che vediamo effettivamente il messaggio che chi lha spedito voleva trasmettere. Come decidiamo? Guardando attentamente il foglio: se ci sono solo piccole macchie di colore vuol dire che lo spazio vuoto il messaggio, e cio, che niente altro che il luogo ha avuto luogo non che niente ha avuto luogo dal momento che, in un certo senso, lo stesso spazio vuoto ha avuto luogo 17. Cfr. Gerard Wajcman, Lobjet du sicle, Lagrasse, Verdier, 1998. 18. Citato da Julia Hell, Post-Fascist Fantasies, Durham, Duke University Press, 1997, p. 32 ( liberamente tradotto, N.d.T.). 19. Kim Yong Il salutato dalla propaganda ufficiale come brillante e poetico ecco un esempio della sua poesia: Come i girasoli fioriscono e prosperano solo se guardano in alto il sole, il popolo pu prosperare solo se alza uno sguardo ammirato al proprio leader! 20. Jacques Lacan, Seminario VII: Letica della psicanalisi, Torino, Einaudi, 1994. 21. Ibidem. 22. Su queste premesse si dovrebbero valutare i primi lavori di Komar e Melamid. Prendiamo ad esempio Stalin e le Muse: nello stesso quadro essi combinano due nozioni incompatibili di bellezza: la bellezza reale la nozione
-
classica di bellezza dellantica grecia come perduto ideale dInnocenza (le Muse) e la bellezza funzionale del leader comunista. Leffetto ironicamente sovversivo non dato solamente dal contrasto grottesco e dallincongruit fra i due livelli, ma, e probabilmente persino di pi, dal sospetto che la bellezza dellantica grecia non era forse poi cos naturale come ci aspetteremmo, bens probabilmente a sua volta condizionata da una certa struttura funzionale di contorno. 23. In questo riferimento a Courbet, mi rifaccio ampiamente a Charity Scribner, Working Memory: Mourning and Melancholia in Postindustrial Europe, New York, Columbia University Press, 2000. 24. Francis S. Fitzgerald, Gli ultimi fuochi, Milano, Mondadori, 1974. 25. Un altro modo di vedere il punto morto dellarte premoderna forse rappresentato dal movimento dei pre-raffaelliti: la sublime bellezza dei loro dipinti pericolosamente vicina al kitsch, per cos dire, minata al suo interno da uneccessiva importanza data al dettaglio leffetto iniziale di sublime ed eterea bellezza inizia a disintegrarsi a mano a mano che si acquista consa pevolezza dei potenti dettagli che sembrano vivere di vita propria e perci in qualche modo introducono una nota volgare di eccessiva sensualit alleffetto del quadro nel suo complesso. 26. Il passaggio dallespressione diretta delloggetto incestuoso divenuto abietto all astrazione pi evidente nello sviluppo artistico del lavoro di Mark Rothko, i cui quadri astratti, famosi per i loro colori intensi, furono preceduti da una serie di ritratti della madre. Si tentati di pensare i suoi successivi quadri astratti come una sorta di trasposizione a colori di Black Square di Malevich: le coordinate spaziali di base sono le stesse (un quadrato al centro di uno sfondo), la differenza che nellopera di Rothko il colore non sfuma i contorni degli oggetti disegnati, ma piuttosto funge
-
direttamente da mezzo del disegno, della presentazione di questi colori Rothko non colora delle forme disegnate, ma direttamente disegna (vedi, modella) le forme con i colori.
-
IV DAL TRAGICO AL TRAGI-COMICO
Le conseguenze intersoggettive di questo processo non sono meno decisive. Poich concentrato sul surplus dellobjet petit a, il capitalismo non pi il regno indiscusso del discorso del Padrone [Master]. qui che subentra Lacan e parafrasa con parole sue il vecchio tema marxista, tratto dal Manifesto, di come il capitalismo dissolva qualsiasi legame e tradizione stabili; di come, sotto i suoi colpi, tutto ci che solido si volatilizza. Lo stesso Marx ha chiarito che questo tutto ci che solido non si riferisce solo e principalmente ai prodotti materiali, ma anche alla stabilit dellordine simbolico che fornisce unidentificazione definitiva ai soggetti. Quindi, da un lato, invece di prodotti stabili destinati a durare per generazioni, il capitalismo introduce delle dinamiche di obsolescenza mozzafiato: siamo bombardati da prodotti sempre pi nuovi che talvolta diventano obsoleti ancora prima di venire pienamente utilizzati i computer devono essere cambiati ogni anno per stare al passo con il vicino di casa; i dischi in vinile sono stati seguiti dai CD e ora dai DVD. La conseguenza di questa innovazione costante, , ovviamente, la produzione permanente di pile su pile di rifituti di scarto: La principale produzione dellindustria moderna e postmoderna capitalista sono precisamente i rifiuti. Siamo
-
esseri postmoderni perch realizziamo che tutti i prodotti di consumo per noi esteticamente attraenti, faranno la fine dei rifiuti, al punto che trasformeranno la terra in una landa desolata. Si perde il senso del tragico, si percepisce il progresso come ridicolo.27 Laspe
![download Žižek - La Fragilita Dell'Assoluto (Ovvero Perché Vale La Pena Combattere Per Le Nostre Radici Cristiane) [Ladri Di Biblioteche]](https://fdocumenti.com/public/t1/desktop/images/details/download-thumbnail.png)