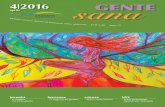Wired_Marzo 2016.pdf
-
Upload
matia-campora -
Category
Documents
-
view
60 -
download
1
Transcript of Wired_Marzo 2016.pdf

N U M E R O
76
P R E Z Z O
5 , 0 0 E U R O
ANN O
2 0 1 6
D O V E
I L U O G H I C H E S T A N N O C A M B I A N D O I L M O N D O
E D I Z I O N E
P R I M A V E R A
AT L A N T E D E L L’ I N N O VA Z I O N E
Senza titolo-2.indd 2 22/03/16 12:49

Senza titolo-2.indd 3 22/03/16 12:49

Senza titolo-2.indd 4 22/03/16 11:55

Senza titolo-2.indd 5 22/03/16 11:55

Senza titolo-2.indd 6 22/03/16 11:55




P R EFA Z IO N E / F E D E R IC O F E R R A Z Z A
5
T M

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
uesto volume di Wired nasce da una frase che ho sentito pronunciare da Fabiola Gia-
notti qualche mese fa. Lei è la direttrice del Cern di Ginevra, il centro di ricerca in cui
nel 2012 è stata provata l’esistenza del Bosone di Higgs (più conosciuto come “Parti-
cella di Dio”) e dove 21 anni prima, nel 1991, venne inventato il web dal fisico inglese
Tim Berners-Lee. La frase, dicevo: «La passione per la conoscenza è un valore univer-
sale che non conosce passaporti».
Non è un caso che a dirla sia stata Gianotti. Il Cern è infatti il più grande laboratorio di fisica del
mondo: lì ci lavorano circa tremila scienziati provenienti da tutto il pianeta, anche da paesi che sono
in guerra tra loro o che neanche si riconoscono. Eppure collaborano proficuamente tutti i giorni, an-
che se la materia del loro studio non è priva di criticità, visto che l’applicazione della ricerca nucleare
ha portato − nel secolo scorso − alla bomba atomica.
Di luoghi come il Cern ne esistono fortunatamente tanti. Non hanno in comune la fisica delle
particelle ma la passione per la conoscenza, per l’innovazione. In altre parole hanno in comune la
passione per un mondo migliore abbinata a quella sana ambizione personale di fare qualcosa di si-
gnificativo per la società.
L’obiettivo di questo numero di Wired è conoscere questi posti. Abbiamo così viaggiato in tutti
i continenti, raccontando laboratori scientifici, luoghi dove stanno nascendo nuove forme di intratte-
nimento e aziende che cambieranno per sempre l’economia e i nostri consumi. Tutte immagini di un
pianeta in costante comunicazione grazie a Internet, come racconta il fondatore di Wikipedia Jimmy
Wales nel prologo.
Il risultato è un “Atlante dell’Innovazione”. Una guida che mette insieme una scienziata dive-
nuta la prima presidentessa di una nazione africana di poco più di un milione di abitanti e un astro-
nauta italiano che ha passato sei mesi nello spazio e che ora si allena nelle profondità dell’Oceano
Atlantico; un laboratorio di un’università australiana che studia il preservativo del futuro e un mate-
matico laureato alla Scuola Normale di Pisa che sfrutta le onde del mare per soddisfare (parte) della
nostra necessità energetica.
In questa avventura abbiamo segnato oltre 50 puntini sul mappamondo, storie che racconta-
no un mondo in rapida trasformazione. Che dimostrano − ancora una volta − che l’innovazione e il
progresso scientifico non sono da temere ma da supportare. Perché se oggi viviamo indubbiamente
in un mondo migliore del passato (dalle qualità e durata della vita al livello culturale medio, fino alle
condizioni economiche), lo dobbiamo soprattutto alle persone con la passione per la conoscenza.
Buona lettura. E buon viaggio
Q
F E D E R I C O F E R R A Z Z A




I N D E X
0
1
2
0 0 5
0 1 9
0 5 6
0 6 6
0 7 0
0 6 8
0 7 1
0 6 9
0 7 2
C O R U Ñ O , S P A G N A SP O RT
L O N D R A , R E G N O U N I T O M U SICA
W E R L T E , G E R M A N I A EN ER GIA
C O P E N A G H E N , D A N I M A R C A A R C HI T E T T U R A
M O N A C O D I B A V I E R A , G E R M A N I A HI-T EC H
G I N E V R A , S V I Z Z E R A S CIEN Z A
0 3 2
0 4 0
0 4 6
0 4 3
0 4 9
0 4 1
0 4 7
0 4 4
0 4 2
0 4 8
0 4 5
A L T A M U R A ( B A ) A R C HI T E T T U R A
B U D R I O ( B O ) SP O RT
G U A S T A L L A ( R E ) A R C HI T E T T U R A
P I S A S CIEN Z A
C I T T À D E L V A T I C A N O S CIEN Z A
V A R E S E VID EO G A ME
V I C E N Z A HI-T EC H
F A V A R A ( A G ) S O CIE TÀ
L O D I FO O D
T R A L’ A Q U I L A E T E R A M O S CIEN Z A
art: F E L I X P E T R U Š K A
Disegnatore con una passione non troppo velata per l’animazione
foto: B A R B A R A O I Z M U D
Fotografa e tatuatrice con una laurea in scenografia
foto: M A T T I A B A L S A M I N I
Nato a Pordenone nel 1987, da anni è un fidato fotografo per Wired
testo: J I M M Y W A L E S
Fondatore di Wikipedia, presiede Wikimedia e The People’s Operator,
gestore telefonico che dedica parte dei ricavi a cause sociali
testo: M A R C O M A L V A L D I
Chimico e scrittore pisano. In libreria c’è il suo ultimo
volume, L’infinito tra parentesi (Rizzoli editore)
testo: M A U R I Z I O P E S C E
Caposervizio di Wired, si occupa di tecnologia e social media. Nel 2015 ha raccontato in esclusiva l’arrivo di Netflix in Italia
testo: F E D E R I C O F E R R A Z Z A
direttore di Wired
EUROPAA . I . L I K E
P A R I G I , F R A N C I A
0 7 3
0 7 4
0 7 5
M O S C A , R U S S I A
B R A Y , R E G N O U N I T O
M O N S , B E L G I O
S O CIE TÀ
FO O D
S O CIE TÀ
P R E F A Z I O N E
P R O L O G O
ITALIAM O T O P E R P E T U O
M A R I N A D I P I S A ( P I )

3
4
1 3 2
1 4 0
1 3 6
1 3 4
1 3 8
1 3 5
1 3 9
H A R G E I S A , S O M A L I L A N D
N A I R O B I , K E N Y A
N A I R O B I , K E N Y A
L A G O S , N I G E R I A
S I N T H I A N , S E N E G A L
A D D I S A B E B A , E T I O P I A
J O H A N N E S B U R G , S U D A F R I C A
0 9 4
1 2 0
foto: A L E S S A N D R O I M B R I A C O
Salernitano, conta più di 30 mostre, tra personali e collettive
testo: L U C A P A R M I T A N O
Astronauta Esa e tenente colonnello dell’Aeronautica.
È stato il primo italiano a fare una passeggiata nello Spazio
testo: S I L V I A B E N C I V E L L I
È scrittrice, autrice tv e conduttrice radiofonica. Fa parte dell’associazione di giornalisti
scientifici italiani Swim
AMERICA
L’ A C Q U A R I O S P A Z I A L E
K E Y L A R G O , F L O R I D A , U S A
1 0 2
1 0 9
1 0 6
1 0 4
1 1 0
1 0 7
1 0 5
1 1 1
1 1 2
1 0 8
F O R E S T A A M A Z Z O N I C A , B R A S I L E
P A L O A L T O , U S A
R I O D E J A N E I R O , B R A S I L E
B O S T O N , U S A
N O R T H L A S V E G A S , U S A
N E W Y O R K , U S A
A R I Z O N A , U S A
T O R O N T O , C A N A D A
M A U N A L O A , H A W A I I , U S A
A L T O S D E C A Z U C Á , C O L O M B I A
A M BIEN T E
T R ASP O RT I
SP O RT
CINEM A
FO O D
S O CIE TÀ
SCIEN Z A
AM BIEN T E
SCIEN Z A
AR CHI T E T T U R A
SCIEN Z A
AR CHI T E T T U R A
AFRICAI L P R E S I D E N T E B O T A N I C O
P O R T L O U I S , M A U R I T I U S
T R ASP O RT I
SCIEN Z A
HI-T EC H
T R ASP O RT I
SP O RT
D E S E R T O D E L M O J A V E , U S A
R I F L E S S I S O L A R I 0 8 2
foto: J A M E Y S T I L L I N G S
Nella sua trentennale carriera, ha girato documentari e scattato foto per la pubblicità, per giornali e riviste di tutto il mondo

testo: C L I V E T H O M P S O N
Canadese classe 1968, è firma storica ed editorialista di Wired Us e del magazine settimanale
del New York Times
1 8 6
1 8 9
1 9 0
1 8 7
1 8 8
I S O L E T O N G A S O CIE TÀ
A N T A R T I D E S CIEN Z A
I S O L E K I R I B A T I A M BIEN T E
N E W P L Y M O U T H , N U O V A Z E L A N D A A R C HI T E T T U R A J A M E S T O W N , A U S T R A L I A EN ER GIA
1 7 6
N I C H O L A S D A V I D A L T E A
— si occupa di musica e social
D A N I E L E B E L L E R I
— ricercatore e designer
F E D E R I C O B O N A
— scrittore e giornalista
D O N A T A C O L U M B R O
— blogger amante dell’Africa
M A R C O C O S E N Z A
— giornalista tecnologico
E M I L I O C O Z Z I
— impallinato di videogame
P H I L I P D I S A L V O
— esperto di nuovi media
G I A N L U C A D O T T I
— giornalista scientifico
A N D R E A G E N T I L E
— caposervizio di Wired
F R A N C E S C O L I P A R I
— architetto
G A B R I E L E L I P P I
— cronista sportivo
V A L E R I O M I L L E F O G L I E
— scrittore e musicista
J A C O P O P A S O T T I
— giornalista ambientale
M A R I N A P I E R R I
— esperta di cinema e serie tv
F I L I P P O P I V A
— si occupa di lifestyle
M I C H E L E P R I M I
— scrittore e giornalista
S T E F A N I A V I T I
— appassionata di Giappone
foto: P E T R I N A H I C K S
La sua arte mixa un’estetica da still life e contenuti
provocatori
art: L A T I G R E
Le mappe dell’Atlante dell’Innovazione sono state
disegnate da La Tigre, studio creativo di Milano
testo: A L I C E P A C E
Vive tra Milano e Trieste ed è una giornalista scientifica. Per Wired.it si è occupata, tra l’altro, del caso Stamina
Il carattere tipografico “guest” di questo numero è l’Atlas
di Commercial Type, disegnato da Susana Carvalho, Kai Bernau
e Christian Schwartz
C O N T R I B U T O R S
6
5
foto: Z A C H A R Y B A K O
Vive a Los Angeles e scatta soprattutto ritratti e reportage
1 4 8
1 6 8
1 6 3
1 7 0
1 6 4
1 6 6
1 7 1
1 6 5
1 6 7
1 6 2
T O K Y O , G I A P P O N E AG RIC OLT U R A
B A I K O N U R , K A Z A K I S T A N S CIEN Z A
A M M A N , G I O R D A N I A HI-T EC H
H A T Z E V A , I S R A E L E A M BIEN T E
B A N G A L O R E , I N D I A HI-T EC H
T E L A V I V , I S R A E L E HI-T EC H
H E N G D I A N , C I N A CIN EM A
S A G A R M A T H A N A T I O N A L P A R K , N E P A L S CIEN Z A
S U Z H O U , C I N A A R C HI T E T T U R A
OCEANIAA P R O V A D ’ O R G A S M O
W O L L O N G O N G , A U S T R A L I A
A T L A S
ASIAL A S I L I C O N V A L L E Y D ’ O R I E N T E
G U A N G Z H O U , C I N A





PRIMAVERA 2016 - N°76 - ANNO 7
Direttore ResponsabileFEDERICO FERRAZZA
Art Director MASSIMO PITIS (Pitis e Associati)
Caporedattore Centrale OMAR SCHILLACI
Redazione GAIA BERRUTO (vicecaposervizio), ANDREA GENTILE (caposervizio), ALBERTO GRANDI, MAURIZIO PESCE (caposervizio), STEFANO PRIOLO (caposervizio)
Photo Editor FRANCESCA MOROSINI
Ufficio Grafico PITIS E ASSOCIATI
Segreteria di Redazione e Produzione PAOLA BONVINI (responsabile)
Hanno collaborato a questo numero: FABRIZIO AIMAR, NICHOLAS DAVID ALTEA, DANIELE BELLERI, SILVIA BENCIVELLI, FEDERICO BONA, FABIO CIARAVELLA,
DONATA COLUMBRO, MARCO COSENZA, EMILIO COZZI, PHILIP DI SALVO, GIANLUCA DOTTI, CLAUDIO FABBRO, GIAN MARIA FATTORE, FRANCESCO LIPARI, GABRIELE LIPPI, MARCO MALVALDI, FEDERICA MARZIALE IADEVAIA,
ALESSANDRO MELIS, VALERIO MILLEFOGLIE, ALESSANDRO ORSINI, ALICE PACE, LUCA PARMITANO, JACOPO PASOTTI, MARINA PIERRI, FILIPPO PIVA, MICHELE PRIMI, ALDO SOLLAZZO, CLIVE THOMPSON,
VITTORIO VITERBO, STEFANIA VITI, JIMMY WALES
Creative Consultant DAVID MORETTI
Fotografi ZACHARY BAKO, MATTIA BALSAMINI, MARCELLO BONFANTI, ALESSIO GUARINO, ERIK HERSMAN, PETRINA HICKS, ALESSANDRO IMBRIACO, BARBARA OIZMUD, JAMEY STILLINGS
Agenzie ALAMY/OLYCOM, GETTY IMAGES
Illustratori LA TIGRE, FELIX PETRUŠKATraduzioni MICHELE PRIMI
wwDirettore Editoriale FRANCA SOZZANI
Divisione GQ, L’UOMO VOGUE, WIRED, AD, TRAVELLERDirettore STEFANIA VISMARA
Advertising Manager NICOLÒ CAMILLO VANNUCCINI, EMMELINE ELIANTONIOMarketing Manager ANNALISA PROCOPIO
Special Projects Manager MARCO BERNARDINI
Direttore Vendite GIANCARLO ROPA
Agenzie e Centri Media Off Line: FRANCESCA GUICCIARDI, ALESSANDRA MANENTI, RAFFAELLA SPREAFICO, MARCO ZERBINI. Digital
Advertising e Grandi Mercati: ELIA BLEI Direttore. Centri Media Digital Lombardia: CARLO CARRETTONI Responsabile, MANUELA BONDIOLI, SIMONA DI LIDDO, LETIZIA MORELLI, GIOVANNI SCIBETTA, LISA SFORZINI. Grandi Mercati: GIOVANNI AZZIMONTI Responsabile, ELENA FAVETTO, SIMONA FEZZARDI, GIOVANNI LOMBARDI, LAURA MILANO, MASSIMO PALMARIELLO, SILVIA VIETRI, JESSICA ZOLLA Digital, PIETRO GIMMELLI Barter, MANUELA MIGLIOSI Responsabile Commerciale Eventi. Moda e Oggetti Personali: MATTIA MONDANI Direttore. ALESSANDRA ACTIS, MATTEO BARTOLUCCI, DANIELA DAL POZZO, ANGELA D’AMORE, ANTONIO D’ANGELO, GIORGIA GUAGLIUMI, SILVIA MONTESSORI, PIERLUIGI PASTRES, LUIGI PUGLIESE, SERGIO RUFFO. Beauty: MARCO RAVASI Direttore, MARGHERITA BOTTAZZI, LAURA GIOVANNOZZI, GIORGIA PONTIGGIA, ARIANNA RUBINI. Condé Nast Studio: ELIA BLEI Direttore Commerciale, FABIO LA MOTTA, FRANCESCA MAPELLI. Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta: MATTIA MONDANI Area Manager, SABRINA BADALAMENTI, ELIANA MONTICONE. Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia: SABRINA GRIMALDI Area Manager, PAOLA BANDINI, GABRIELE CURATO, GIULIA GHIDONI, ROSA LO CASCIO, RICCARDO MARCASSA, LARA MORASSUTTI. Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria: GIANCARLO ROPA Area Manager. Emilia Romagna, Marche: DANILA ZOPPO MARTELLINI Coordinatore, DANIELA CALLEGARI, ENRICO CARFÌ, CATERINA CAVALLINI, RITA PADOVANO, ALESSANDRA ROSSI. Toscana, Umbria: ANTONINO ACANFORA Area Manager, SERENA MIAZZO, GIULIANA MONTAGNONI, VALERIA VICEDOMINI. Lazio e Sud Italia: ANTONELLA BASILE Area Manager, SILVIA BOCHICCHIO, CARLA LEVA, MARILENA LOFFREDO, PAOLA MAZZA, PAOLO STERMIERI, BARBARA VANNI, SALVATORE FASOLO (Na) CELL. 320 6219168, MARIA ROSARIA VECCHIONI (Na) CELL. 335 6450505, ANNA CAVALLO (Ba) CELL. 334 1699896, FRANCESCO SEMERARO (Ba) CELL. 348 3212118. Uffici Pubblicità Estero - Parigi/Londra: ANGELA NEUMANN, ADELINE ENCONTRE. New York: ALESSANDRO CREMONA. Barcellona: SILVIA FAURÒ. Monaco: FILIPPO LAMI.
Digital Marketing: MANUELA MUZZA. Social Media: ROBERTA CIANETTI.
EDIZIONI CONDÉ NAST S.p.A.
Presidente e Amministratore Delegato GIAMPAOLO GRANDIDirettore Generale FEDELE USAI
Vicedirettore Generale DOMENICO NOCCO
Vice Presidente GIUSEPPE MONDANI, Direttore Business Development MICHELE RIDOLFO, Direttore Digital MARCO FORMENTODirettore Comunicazione LAURA PIVA, Direttore di Produzione BRUNO MORONA, Direttore Circulation ALBERTO CAVARA
Direttore Risorse Umane CRISTINA LIPPI, Direttore Amministrativo ORNELLA PAINI, Controller LUCA ROLDIDirettore Tecnologie GIUSEPPE SERRECCHIA, Direttore Prodotti Digitali BARBARA CORTI, Direttore CN Studio ROBERTA LA SELVA
Direttore Creativo CN Studio CRISTINA BACCELLI, Direttore Branded Content RAFFAELLA BUDA
Sede: 20121 Milano, piazza Castello 27 - tel. 0285611 - telegr. NASTIT - fax 028055716. Padova, via degli Zabarella 113, tel. 0498455777 - fax 0498455700. Bologna, via Carlo Farini 13, Palazzo Zambeccari, tel. 0512750147 - fax 051222099 - Firenze, via Jacopo Nardi 6, tel. 0552638789 - fax 0552009540. Roma, via C. Monteverdi 20, tel. 0684046415 - fax 068079249. Parigi/Londra, 4 place du Palais Bourbon 75007 Paris - tel. 0033144117885 fax 0033145569213. New York, 125 Park avenue suite 2511 - New York NY 10017 - tel. 2123808236 - fax 2127867572. Barcellona, Passeig de Gràcia 8/10, 3° 1a - 08007 Barcelona - tel. 0034932160161 - fax 0034933427041. Monaco di Baviera, Eierwiese 5b - 82031 Grünwald - Deutschland - tel. 00498921578970 fax 00498921578973. Istanbul, Yenimahalle Tayyareci Fethi Sok. 28/7 Bakırkoy - 34142 Istanbul - Turkey - Cell: 0090-532-2614343 - email: [email protected]
Redazione: 20121 MILANO - Piazza Castello 21 - tel. 0285611 - 0285612377

Molto più di un display curvo.
Molto più di uno Smartphone.

D O V E
S A N F R A N C I S C O , U S A
C O O R D I N A T E
3 7 . 7 8 6 9 9 4 N , 1 2 2 . 3 9 9 6 1 7 O
A R T
F E L I X P E T R U Š K A
T E S T O R A C C O L T O D A
P H I L I P D I S A L V O
T E S T O D I
J I M M Y W A L E S
I N T E R N E T R I D I S E G N A I C O N F I N I G L O B A L I
P R O L O G O

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
è una vibrante scena tecnologica alla periferia della città di Yaba, un sobbor-
go di Lagos, in Nigeria, fatta di spazi di co-creazione, laboratori e startup dove molti
giovani lavorano allo sviluppo di progetti interessanti. Non è l’unico posto che si po-
trebbe citare, ma è certo un eccellente esempio per dire che la prossima Silicon Valley
potrebbe essere africana.
La connessione globale a internet consentirà a molti luoghi del pianeta di vede-
re la nascita di idee innovative, specialmente nei paesi in via di sviluppo. Sta già succedendo proprio
a Yaba − dove questo fermento ha non a caso assunto il nome di “Yabacon Valley” − e in altre parti del
mondo. Una volta che le persone sono online, per creare cose e far sì che diventino davvero grandi
e globali, a loro serve poco, nient’altro che un piccolo team di volenterosi. Credo sia assolutamente
plausibile immaginare che la prossima Instagram, oppure qualsiasi altra nuova invenzione dal suc-
cesso planetario, possa venire da zone di questo tipo.
Internet, che è riuscita a connettere quasi tutto il pianeta e ad accorciarne le distanze, è ormai
diventata il medium globale per eccellenza. Anche se il percorso verso una connessione universale
non è del tutto compiuto. Negli anni a venire vedremo andare online un miliardo (magari anche due)
di nuove persone, più rapidamente di quanto avremmo potuto aspettarci e grazie soprattutto ai di-
spositivi mobile. Siamo ancora ben lontani dall’aver connesso il mondo intero, insomma, però sono
certo che ci arriveremo molto presto.
I principali ostacoli tecnici alla costruzione di questa fondamentale connessione globale sono
già stati risolti. I segnali che vanno in questa direzione sono molti: nel giro di breve tempo verranno
lanciati smartphone ancora più economici e in grado di raggiungere utenti che, ora, si trovano molto
in basso nella scala economica. Lo stesso vale anche per le infrastrutture in tutto il mondo: servono
più cavi di fibra ottica che partano da zone del pianeta già ben connesse e più internet in mobilità e
telefonia mobile. Non ci sono però più limitazioni specifiche, in questo senso, e mi sembra ovvio che il
processo possa concludersi al massimo entro i prossimi cinque o dieci anni.
A parte gli aspetti tecnici, prima di poter garantire un vero accesso globale a internet dobbia-
mo comunque finire di superare alcune questioni sociali e politiche. Sappiamo fin troppo bene come
i governi di diversi paesi cerchino di far passare leggi che mirano a cancellare le garanzie di accesso
libero al web. La censura, per esempio, continua a porre dei problemi seri: se vogliamo assicurarci
questa connessione realmente planetaria, dobbiamo riuscire a risolverli. La mia speranza? È che si
stia andando verso un futuro con meno sanzioni sulla rete. Però dobbiamo essere consapevoli che i
pericoli non mancano. Nemmeno nelle democrazie più compiute.
C’


W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
Il Parlamento europeo dovrebbe rivedere il “diritto all’oblio” − la garanzia che prevede la non
diffondibilità e la rimozione di contenuti pregiudizievoli dagli indici dei motori di ricerca − dato che
dal punto di vista giuridico, essendo stato delineato in base a principi che esistevano ben prima della
nascita di Google, prevede insufficienti garanzie. Sono convinto, però, che gli estensori non abbiano
mai pensato o affermato che questa salvaguardia fosse da usare contro i giornali o le enciclopedie.
A proposito di enciclopedie, quest’anno festeggiamo il quindicesimo compleanno di Wikipe-
dia. L’obiettivo che ci siamo posti sin dall’inizio è intrinsecamente globale: da sempre invitiamo a
unirsi a noi persone di tutto il mondo e che parlano ogni lingua. La nostra missione è consistita e con-
siste nel fornire un’enciclopedia a tutti e nella loro lingua madre: oggi siamo un progetto che parla
più di 300 idiomi. Nel perseguire questo obiettivo abbiamo costantemente tenuto un approccio dav-
vero planetario, ma non l’abbiamo ancora raggiunto. Dobbiamo iniziare a pensare a lungo termine e
per questo stiamo per lanciare una nuova campagna mirata alla creazione di un Endowment Fund, un
“Fondo di dotazione”. Noi consideriamo Wikipedia un’istituzione culturale al pari di un’università o
di una biblioteca: perciò vogliamo raccogliere finanziamenti ulteriori da destinare a una governance
separata, per salvaguardarne il futuro e far sì che sopravviva per i prossimi cento anni.
Perché, per esempio, ci sono lingue che non abbiamo per ora coinvolto. Dobbiamo farlo, se vo-
gliamo essere davvero una rappresentazione globale della conoscenza. Al mondo esistono 330 idiomi
che vengono parlati da almeno una persona; su Wikipedia alcuni non sono per il momento del tutto
disponibili oppure hanno un numero di lemmi davvero ridotto. Dobbiamo quindi fare ancora tanto,
soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Infine, solo il 15% dei contenuti è in inglese. Credo si tratti di
un particolare molto significativo ed emblematico: la stessa internet, nella sua interezza, sarà sempre
meno inglese-centrica e dipendente dalle nazioni occidentali.
Anche se la maggior parte del web è oggi un territorio commercializzato, esiste ancora molto
spazio per progetti come Wikipedia. Noi abbiamo attivamente contribuito a costruire un’internet
diversificata, credo, e dobbiamo impegnarci a preservarla. Per riuscirci, abbiamo bisogno di persone
giovani che creino nuove cose basate sulla medesima etica. In questo modo, la geografia del web e
dell’innovazione verrà completamente riscritta.








Marina di Pisa (Pi)
I T A L I A
1
pag. 40
pag. 32
pag. 45
pag. 41
pag. 46
pag. 42
pag. 47
pag. 43
pag. 48
pag. 49
pag. 44
Altamura (Ba)
Città del Vaticano
Guastalla (Re)
Vicenza
Budrio (Bo)
Varese
Pisa
Favara (Ag)
Lodi
Tra L’Aquila e Teramo
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1


L U O G O
M A R I N A D I P I S A ( P I )
C O O R D I N A T E G P S
4 3 . 6 6 9 9 6 2 N , 1 0 . 2 7 5 2 7 2 E
F O T O D I
B A R B A R A O I Z M U D
T E S T O D I
M A R C O M A L V A L D I
C A P I T O L O 1
I T A L I A
Q U A D R A N T E M A P P A
K4

M O T O P E R P E T U O
LE ONDE DEL MARE,
UNA FONTE INFINITA
DI ENERGIA CHE NESSUNO
AVEVA MAI CAPITO COME
SFRUTTARE. FINCHÉ UN
MATEMATICO NON SI
È INVENTATO UNA MACCHINA
PER TRASFORMARLE
IN ELETTRICITÀ
MIC
HE
LE
GR
AS
SI,
45
AN
NI,
HA
FO
ND
AT
O L
A S
TA
RT
UP
40
SO
UT
H
EN
ER
GY
NE
L 2
00
8.
L’A
ZIE
ND
A O
GG
I
DÀ
LA
VO
RO
A 2
5 D
IPE
ND
EN
TI
E H
A
SE
DI
IN I
TA
LIA
E I
N I
NG
HIL
TE
RR
A

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
isa, estate 2014. Ho da poco installato un meraviglioso impianto solare da 3 kiloWatt,
e ne vado molto orgoglioso. C’è solo un piccolo particolare: piove ininterrottamente
da un mese. Una volta avevo letto che la forma di energia più efficiente da convertire è
quella idrica: certo, necessita di grandi altezze (l’energia va come il quadrato dell’al-
tezza da cui casca l’acqua), ma in molti casi si riesce a convertire in elettricità circa
metà della potenza del moto. Se il risultato vi pare scarso, tenete conto che qualsiasi
conversione di energia termica al massimo può raggiungere il 33%, e che la vostra automobile a ben-
zina ha un rendimento di circa il 25%.
Per cui, per distrarmi, provo a calcolare quanta energia riuscirei a estrarre dalla pioggia, se
riuscissi a raccoglierla sul tetto e la facessi scorrere dalle grondaie da un’altezza di 10 metri. Il ri-
sultato non è troppo confortante: con un tetto da 100 metri quadrati, posto a un’altezza di 10 metri,
supponendo una pioggia da 30 millimetri all’ora (cioè, un nubifragio) ottengo in un giorno più o meno
l’energia necessaria per caricare il cellulare.
La quantità di energia portata dall’acqua dipende, è vero, dall’altezza da cui casca; ma dipen-
de, ancora di più, dalla sua densità. Ora, anche il più violento dei nubifragi ha una densità ridicola
rispetto all’acqua come sostanza pura. Con l’energia della pioggia non si va molto lontano, quindi.
Bisognerebbe sfruttare l’energia del mare. Delle maree, per esempio, o delle onde.
La stessa cosa che è venuta in mente, circa dieci anni fa, a Michele Grassi, matematico laureato
alla Scuola Normale Superiore di Pisa, osservando il rollio di una barca al largo. È un peccato che tut-
ta quell’energia, l’energia delle onde, vada sprecata. Ci deve essere un modo per sfruttarla, e Grassi
lo individua. Un’onda, a livello sottomarino, si traduce in una differenza di pressione: detto in parole
povere, un’onda è più alta del livello del mare davanti e dietro a sé, e quindi contiene più acqua. La
colonna d’acqua sotto l’onda ha un peso maggiore, e questo causa una pressione sottomarina.
Sfruttando l’effetto di questa pressione su un meccanismo mobile, si può pensare di convertire
l’energia meccanica in energia elettrica. Niente di difficile, e non c’è nemmeno da cercare troppo lon-
tano: il principio della dinamo è stato inventato proprio qui, dal fisico Antonio Pacinotti, all’incirca
un secolo e mezzo fa.
P

C A P. 1 / I TA L I A
3 5
3 4
uello che succede dopo, in Italia, ha dell’incredibile. Grassi rinuncia al caro vecchio po-
sto fisso (all’Università di Pisa, non in fonderia) e si butta cervello e corpo nell’impre-
sa. Fonda una società, fabbrica prototipi, cerca collaborazioni. La prima arriverà con
Enel Green Power, che contribuirà a una parte delle risorse finanziarie necessarie per
l’installazione di un prototipo di R115 al largo di Punta Righini, vicino a Castiglioncel-
lo. La macchina necessita di un fondale profondo almeno 40 metri, e produce 100 kW
di potenza – il fabbisogno di 80 famiglie, detto in termini umani.
La cosa è migliorabile? Pare di sì. La prima macchina di Grassi, la R115, sfrutta la pressione
delle onde di alto fondale per produrre un moto circolare. Per questo, il dispositivo ha bisogno di una
profondità maggiore di quaranta metri. Ma una differenza di pressione come quella causata dall’on-
da, in basso fondale causa una spinta prevalentemente orizzontale: l’acqua sotto l’onda ha una di-
versa densità rispetto a quella davanti o dietro all’onda. Nasce così H24, un modulo lungo fino a ven-
tiquattro metri provvisto di una sorta di vela che l’onda di pressione sottomarina fa scorrere su un
binario. All’interno del modulo, dei meccanismi appositi trasformano l’energia cinetica (il moto della
vela) in energia elettrica. Tutto questo fornisce 50 kW di potenza a sei metri di profondità.
Sei metri è molto molto meno di quaranta. Più facile da installare (un piccolo pontone e una
coppia di sub lo posano in un paio d’ore) e soprattutto, più facile trovare posti in cui installarlo. La
potenzialità di questo modulo sta infatti nella sua estrema versatilità: H24 si può installare a poca
distanza dalla costa. Ora, l’Italia ha più di settemila chilometri di coste.
Supponendo di posare uno di questi oggetti ogni trentacinque metri (in realtà è possibile met-
terli parecchio più vicini senza interazioni) questi produrrebbero l’ammontare di circa 10 gigawatt di
energia. Dieci centrali nucleari di medio cabotaggio, più o meno. Appurate le possibilità, passiamo al
costo: un aspetto che quando si parla di energia non va troppo sottovalutato. La potenza nominale di
questo impianto è di 50 megawatt, e il suo costo al momento è di circa 200.000 euro (installato, chiavi
in mano), il che significa che ogni watt di potenza ha un costo di installazione di circa 4 euro. Un po’
meno dell’eolico domestico (6 €/W) ma parecchio di più rispetto al grande eolico a terra (i grandi
parchi eolici producono al costo di 1,5 €/W) e al solare.
Q

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
Parliamo di potenza nominale, ovvero la massima potenza che l’apparato sprigiona in condi-
zioni di funzionamento ideale. Quello che bisogna considerare, però, è la potenza media. Un parco eo-
lico funziona quando c’è vento: duemila ore l’anno, nelle zone più sfigate d’Italia, cioè circa un quarto
del tempo. Peggio ancora il solare: l’efficienza media del pannello solare è circa del 16%.
Con le onde, invece, va meglio. Le fluttuazioni marine in grado di muovere l’apparecchio sono
molto più frequenti di quelle ventose, e non c’è bisogno di sole per riscaldarle e renderle pronte allo
sforzo. Si calcola che l’efficienza media del dispositivo sia circa del 30%, e se ho capito bene è una sti-
ma prudenziale. Paragonando i costi di installazione in euro per watt medio, un watt H24 verrebbe
prodotto al costo di installazione di 12 euro, mentre quello di un grande eolico ne costa 6 e quello di
un solare 8. Per non parlare dell’eolico domestico, che ne è costato 24.
L’eolico a terra è più conveniente, certo. Però un dispositivo come quello di Grassi si può in-
stallare ovunque. Non si vede e non ha impatto ambientale (è di vetroresina, ha lo stesso impatto di
una barca, anzi meno: ci sono varie certificazioni comprovanti, come vedremo). Un po’ meglio degli
ecomostri eolici, quindi.
iccome sono un rompicoglioni, e la cosa mi sembrava troppo bella per essere vera, ho
fatto a Grassi alcune domande. La prima domanda è semplice: questi oggetti sono sot-
tomarini, il che significa corrosione e arrugginimento. Di quanta manutenzione han-
no bisogno questi oggetti? Secondo Grassi, non molta. Il problema della corrosione si
ha in realtà quando un oggetto (tipicamente, un oggetto di metallo) viene continua-
mente immerso in acqua e tirato fuori. L’azione elettrolitica dell’acqua e quella chi-
mica dell’ossigeno, combinate, possono fare danni. Il modulo è fatto invece di fibra di vetro, che non
conduce e non arrugginisce, e sulla quale gli organismi marini sono in grado di allignare e crescere.
Da chimico, mi tocca dargli ragione. Uno a zero per lui.
La seconda domanda è un pochino più bastarda: un essere umano, un sub, o un povero delfino,
una di quelle tenere creature del cui destino ci preoccupiamo mentre trangugiamo un bel filetto di
S

C A P. 1 / I TA L I A
3 7
3 6
LA
MA
CC
HIN
A H
24
SI
AD
AG
IA S
UL
FO
ND
AL
E M
AR
INO
A 6
ME
TR
I D
I
PR
OF
ON
DIT
À E
RIC
AV
A E
NE
RG
IA
PU
LIT
A D
AL
MO
TO
DE
LL
E O
ND
E

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
MIC
HE
LE
GR
AS
SI
CO
NT
A D
I
INS
TA
LL
AR
E A
MA
RIN
A D
I P
ISA
QU
AN
TE
PIÙ
MA
CC
HIN
E H
24
,
FIN
AN
ZIA
ND
OL
E C
ON
UN
A C
AM
PA
GN
A
DI
EQ
UIT
Y C
RO
WD
FU
ND
ING

C A P. 1 / I TA L I A
3 9
3 8
tonno, potrebbero rimanerci impigliati o incastrati, e lasciarci le penne. Anche qui, no. E non solo
secondo Grassi, visto che l’analisi dei rischi posti dal modulo ha ricevuto la certificazione Rina (Regi-
stro Italiano Navale), un ente noto per la sua particolare severità. Qui, da chimico, mi tocca fidarmi.
La terza domanda è fetente: in Portogallo pochi anni fa hanno costruito un oggetto simile, il
Pelamis Energy Wave Converter. Un mostro in grado di generare 750 kW. Sono falliti in pochi anni.
Certo che sono falliti, risponde Grassi. Pelamis era un mostro che solo di installazione costava 5,6
milioni di dollari. Il nostro modulo costa venti volte meno. È una spesa affrontabile da una piccola
comunità. Piccola comunità? Sì, la scommessa ulteriore di Grassi è questa.
l coronamento ideale del progetto di Grassi, che propone la possibilità di formare una
smart community, in cui una piccola realtà (come un paese di provincia, per esempio:
pare che in Italia abbondino) si fornisca di una serie di elementi per produrre da sola
la propria energia esclusivamente da fonti rinnovabili, coinvolgendo gli abitanti, i tu-
risti, gli utenti del porto tramite il crowdfunding. Se volete la mia opinione, questo è
un vero progetto.
Un progetto organizzativo, ma basato su solide innovazioni tecnologiche, non la solita aria frit-
ta in cui si presenta un progetto in cui si mescolano le due o tre cose che sappiamo fare con quelle che
sa fare il tizio che ci siamo trovati accanto a cena due sere prima, e speriamo che funzioni.
È solo la mia opinione. Spero di non confondere la speranza con la convinzione, ma sono con-
vinto che in questo ambito la mia opinione abbia qualche valore.
I

C A P I T O L O 1
I T A L I A I M U R I D E L S U O N O
F A B I O C I A R A V E L L A ,
F R A N C E S C O L I P A R I
C A T E G O R I A
A R C H I T E T T U R A
P A R O L E C H I A V E
“ I L S E M E D E L T E M P O ” , K I N G C R I M S O N , P R O G R E S S I V E R O C K , S T U D I O G G - L O O P
C O O R D I N A T E G P S
4 0 . 8 2 2 3 9 1 N , 1 6 . 5 5 7 7 3 7 E
L U O G O
A L T A M U R A ( B A )
Cosa ci fa ad Altamura,
in provincia di Bari,
un edificio ispirato a
quella pietra miliare del
“progressive rock” che è
l’album − del 1969 − In the
Court of the Crimson King
dei King Crimson?
I cittadini se lo chiedono
ogni giorno attraverso
un dibattito sul rapporto
tra le rassicurazioni del
passato e il dovere di
immaginare la forma (e il
colore) del futuro. Questa
innovativa ristrutturazione
di un edificio d’angolo si
chiama The Seed of Time
(il seme del tempo) ed è
una recente (ottobre 2015)
realizzazione dello studio
italo-olandese GG-loop,
guidato da Giacomo
Graziano (classe 1981).
Il rosso cremisi e la
facciata hi-tech, combinati
in un “cappotto di design”
fatto di prismi
in bassorilievo, fanno
di The Seed of Time una
casa-museo con spazio
sculturale che richiama
il ritmo complesso di
quell’album dei King
Crimson (che nel ’69
contribuì a definire
la musica progressiva).
La sua architettura, infatti,
alterna momenti in cui
le superfici sono plastiche,
per richiamare
il succedersi asincrono
della batteria, e lisce,
quasi a evocare il suono
di chitarre elettriche
e melodie dolci.
L’edificio si divide in due
“movimenti”, come li
definisce lo stesso autore,
Giacomo Graziano:
«L’esterno si chiama
Gentle Genius e l’interno
The Infection». Il primo
comunica protezione,
il secondo richiama
la cura degli interni.
Questi due elementi
sembrano scontrarsi alla
ricerca di un equilibrio
− conscio e inconscio,
percezione e pensiero −
e ricordano la prospettiva
semiotica di Rudolf
Arnheim, nella quale «non
c’è alcuna differenza
tra quando una persona
osserva direttamente il
mondo e quando invece
siede con gli occhi chiusi
e pensa».
Dalle cene della borghesia
fino ai bar della periferia,
l’intera comunità
altamurana si è divisa
su un nuovo modo di
immaginare la città,
alimentando la propria
consapevolezza sulle
potenzialità innovative
anche dei luoghi quotidiani:
come quello in cui appunto
sorge l’edificio di GG-loop.
The Seed of Time
− e la filosofia che sottende
a questo progetto − ha
soprattutto un merito,
per i cittadini è diventato
un nuovo monito su uno
dei punti più deboli
e meno risolti della cultura
contemporanea nel
nostro paese: il rapporto
con l’innovazione e la
responsabilità dei singoli
nella definizione del futuro.
Costretta a prendere
posizione sull’opportunità
dell’intervento, la comunità
ha dovuto necessariamente
confrontarsi sia con
il contesto sia con
l’identità urbana; ma anche
occuparsi del rapporto
con la tradizione e la sua
possibilità di evoluzione.
Questo corollario è reso
ancor più significativo
e forte da un particolare
tutt’altro che trascurabile:
che tutto questo avviene
nel Meridione, in Puglia,
dove una provincia capace
di sentire il ritmo delle
forme si sta chiedendo
cosa sia il progresso.

C A P I T O L O 1
I T A L I A
Q U A D R A N T E M A P P A
L6
Q U A D R A N T E M A P P A
O6
P A R O L E C H I A V E
A R T E , C O N S E R V A Z I O N E , G A L I L E O G A L I L E I
A L I C E P A C E
C O O R D I N A T E G P S
4 1 . 9 0 3 3 0 0 N , 1 2 . 4 5 3 3 0 0 E
L U O G O
C I T T À D E L V A T I C A N O
C A T E G O R I A
S C I E N Z A
L A S T O R I A S A LVATA D A L G R A F E N E
Siamo nel sottosuolo
del Cortile della Pigna,
nell’Archivio Segreto
Vaticano. Attorno a noi,
85 chilometri quadrati
di scaffali dove, catalogati
a uno a uno, poggiano
i registri, le buste, i faldoni
e le pergamene con
impresse le tappe fondanti
della nostra storia.
I più importanti sono
blindati in un bunker
a temperatura e umidità
regolate per mantenere
intatte le chiavi della
nostra cultura, come
i preziosi documenti
del processo a Galileo.
Eppure anche lì sotto,
secoli di parole, leggi
e decisioni rischiano
di sfaldarsi riducendo
in polvere i simboli del
nostro sapere. A tentare
di bloccare le lancette
dell’orologio sono alcuni
scienziati che, camice
bianco e dispositivi per
analisi portatili, si aggirano
per le sale. Una delle idee
più promettenti è venuta
a GraN Hub, startup che
intende fermare il tempo
usando un materiale
da Nobel: il grafene.
Questo elemento a base
di carbonio, sottile quanto
un atomo, ha dimostrato
di potersi comportare
come una spugna che
assorbe e neutralizza
gli inquinanti dannosi
per documenti e opere
d’arte. Grazie a piccoli
adattamenti chimici,
può persino essere
ingegnerizzato ad hoc per
intervenire su ogni singolo
tallone d’Achille, sia esso
una patina salina, un’alga
o il residuo tossico di
un restauro precedente.
Oltre a “curare”, potrebbe
funzionare da anti-aging,
cioè da trattamento
preventivo contro
l’invecchiamento di beni
storici e artistici.
Dopo aver restaurato
con il nanomateriale la
Chartula di San Francesco,
uno dei simboli più antichi
della dottrina francescana
e riportato alla luce
alcune pitture murali di
Ercolano, ora gli scienziati
sono impegnati in una
partnership con il Vaticano
per salvare manoscritti
autografati nientemeno
che dallo stesso Galileo
Galilei. Anche le vie della
scienza sono infinite.
©MICHAEL SIEBER

C A P I T O L O 1
I T A L I A
Q U A D R A N T E M A P P A
K3
Ha vinto il premio speciale
di Legambiente, che
valorizza esperienze
e idee per generare nuova
bellezza: il Nido d’infanzia
Guastalla è oggi il fiore
all’occhiello dell’edilizia
scolastica italiana grazie
a un uso intelligente delle
tecniche costruttive in
legno e a un moderno
utilizzo degli spazi
didattici.
Il tutto all’interno di
un’architettura che si ispira
al ventre della balena
di Pinocchio.
È il 20 maggio 2012
quando l’Emilia viene
colpita duramente dalla
violenza di un sisma che,
nel silenzio della notte,
uccide 27 persone.
I danni interessano ben
59 Comuni e sono così
ingenti da modificare la
quotidianità di oltre un
milione di cittadini.
Nella sola Provincia
di Reggio Emilia viene
dichiarato inagibile il 13%
delle scuole, tra le quali
i due asili nidi comunali
dell’infanzia di Guastalla,
Pollicino e La Rondine,
che la nuova “balena”
ha adesso sostituito.
Nata dalla creatività dello
studio bolognese Mario
Cucinella Architects (Mca),
vincitore di una gara ad
evidenza pubblica indetta
dal Comune, la nuova
struttura educativa è
frutto di una progettazione
partecipata che ha incluso
anche pedagogiste ed
educatrici insieme ai
genitori dei bambini.
Richieste e consigli
legati all’esercizio della
quotidianità, infatti,
si sono tramutati nella
forma flessuosa degli
interni, nell’organizzazione
spaziale, nella scelta dei
materiali e nell’insieme
delle percezioni sensoriali
legate alla luce.
Progettato per valorizzare
al meglio l’aspetto
educativo e creativo, il
Nido, capace di accogliere
fino a 120 bambini da 0
a 3 anni, presenta soluzioni
tecnologiche e strutturali
di eccellenza che puntano
sull’utilizzo del legno
lamellare e su tecniche
di recupero energetico.
La configurazione
geometrica dell’asilo
si presenta come un
parallelepipedo a un piano
fuori terra lungo 78 metri
e profondo 18, scandito
da 50 telai portanti in
legno di abete − di forma
irregolare ed eseguiti
con macchine a controllo
numerico − che poggiano
su una fondazione a platea
“nervata” in calcestruzzo
armato. La coibentazione
dei fronti opachi nord, est e
ovest, abbinata all’impiego
di un vetrocamera ad alte
prestazioni sul fronte sud
e al recupero dell’acqua
piovana a fini scolastici,
nonché all’installazione in
copertura di un impianto
fotovoltaico, hanno
limitato il ricorso a sistemi
meccanici per soddisfare
il fabbisogno energetico
del Nido, consentendo
così all’edificio di essere
certificato in classe
energetica A.
U N N I D O A F O R M A D I B A L E N A
C O O R D I N A T E G P S
4 4 . 9 1 6 7 2 4 N , 1 0 . 6 6 6 7 1 2 E
P A R O L E C H I A V E
I N F A N Z I A , L E G N O , S O S T E N I B I L I T À
L U O G O
G U A S T A L L A ( R E )
F A B R I Z I O A I M A R ,
F R A N C E S C O L I P A R I
C A T E G O R I A
A R C H I T E T T U R A
©MORENO MAGGI

C A P I T O L O 1
I T A L I A
Q U A D R A N T E M A P P A
L2
F I L I P P O P I V A
che prevede la fusione
di strati di polvere
per realizzare oggetti
tridimensionali) ottenuta
attraverso un processo di
atomizzazione delle leghe
metalliche.
Si tratta, in sostanza,
di microsfere d’argento,
di bronzo e soprattutto
d’oro giallo o bianco, a 18
carati, totalmente nichel
free. Vengono distribuite
a strati dalla stampante,
che poi fonde con un laser
solo e solamente le parti
necessarie alla creazione
del gioiello stesso.
«È un processo in continuo
miglioramento, applicabile
a una miriade di progetti
differenti», aggiunge
Andrea Friso.
«Abbiamo ricostruito
per esempio l’antico
“Gioiello di Vicenza”,
una riproduzione in scala
del centro cittadino
del 1578 che era andata
distrutta in epoca
napoleonica».
Il gioiello di circa 58
centimetri di diametro,
per un totale di 15 chili
di argento, è stato ricreato
in digitale, quindi stampato
in ogni sua parte
e riassemblato.
È stato esposto anche
a Expo, come prova delle
grandissime potenzialità
di questa tecnologia.
Dalla piccola bottega
artigianale alla grande
industria, nella zona di
Vicenza sono circa un
migliaio le aziende che,
in qualche modo, vedono
la propria attività legata
al mondo della gioielleria.
Per questo la città veneta
è conosciuta come uno
dei tre principali distretti
italiani dell’oro, insieme
a Valenza Po e Arezzo.
La sua fiera annuale,
“VicenzaOro”, è tra
gli appuntamenti più
importanti del settore
a livello internazionale:
il dominio è ancora
saldamente italiano in
quanto a stile e tendenze,
come del resto nel campo
dell’innovazione.
Perché la bellezza di
un gioiello potrà anche
essere eterna ma gli studi
su materiali e metodi
di produzione sono in
continua evoluzione.
La stampa in 3D, per
esempio, è una soluzione
molto interessante che
potrebbe facilmente
aggirare buona parte
dei limiti cui i processi
produttivi ancora oggi
utilizzati devono continuare
a sottostare. Si pensi alla
fusione a cera persa, che
porta alla costruzione di
uno stampo dentro cui
versare il metallo fuso:
è un metodo in uso sin
dalla notte dei tempi,
eppure ha ancora i suoi
vantaggi...
Ma quando si guarda alla
personalizzazione di un
prodotto? «È impensabile
creare uno stampo
differente per ogni minima
variazione», spiega Andrea
Friso, division product
manager di Legor Group,
azienda specializzata in
chimica e metallurgia.
«Al contrario, sarebbe
facilissimo modificare un
progetto digitale realizzato
con Cad o software
analoghi, quindi stampare
il tutto apportando le
modifiche desiderate».
Per questo Legor Group
ha investito nella ricerca
di soluzioni per
perfezionare la stampa in
3D dei gioielli e ha lanciato
sul mercato Powmet,
una polvere metallica per
additive manufacturing
(un processo produttivo
1 8 C A R AT I I N 3 D
C A T E G O R I A
H I - T E C H
P A R O L E C H I A V E
G I O I E L L I , M I C R O S F E R E , O R E F I C E R I A .
C O O R D I N A T E G P S
4 5 . 5 4 6 7 2 0 N , 1 1 . 5 4 7 5 0 0 E
L U O G O
V I C E N Z A

C A P I T O L O 1
I T A L I A
A poco più di 20 chilometri
a est di Bologna c’è un
luogo in cui le persone
che hanno subito
un’amputazione tornano
a camminare. Non solo,
qualche volta riescono
ad andare così veloci che
finiscono per qualificarsi
ai Giochi olimpici.
Il polo Arte Ortopedica
di Budrio, infatti, raccoglie
alcuni dei centri più
importanti d’Italia per
le protesi e segue atleti
di altissimo profilo.
Qui, per esempio,
hanno trovato il modo
di restituire a Beatrice
Vio il suo fioretto.
Colpita da meningite acuta
quando aveva 12 anni,
la giovanissima
campionessa paralimpica
è oggi la prima persona
al mondo a tirare
di scherma, nonostante
le amputazioni alle gambe
e degli avambracci.
La protesi che glielo
permette si innesta sul
moncone con una cuffia
imbottita e con un perno
di ancoraggio; inoltre ha
un’invasatura in cui si
inserisce direttamente
il fioretto.
Beatrice detta Bebe
è così forte che, quando
aveva appena 15 anni,
le sue rivali internazionali
hanno provato a fermarla:
sostenevano che quella
stessa protesi
le concedesse un
vantaggio nella presa
sull’arma e chiedevano
− ma senza successo −
che venisse inserita nella
categoria C, quella in cui
competono le persone con
invalidità meno gravi.
A 19 anni ha già vinto tutto:
un campionato mondiale,
un europeo e ogni singola
competizione disputata
nel 2015. Ora punta decisa
all’oro paralimpico.
Accanto a lei, Arte
Ortopedica segue anche
altri ragazzi del team
di Art4Sport, la onlus
fondata dai genitori
di Bebe per permettere
a bambini e ragazzi
con disabilità di svolgere
attività sportiva:
fra l’altro, finanzia
carrozzine e protesi
che non sono passate
dalla mutua. Tra loro c’è
anche Veronica Plebani,
canoista e snowboarder
di vent’anni che, dopo
aver partecipato ai Giochi
invernali di Sochi 2014
in Russia, ora è pronta a
partire per quelli estivi
di Rio 2016.
Punta al podio più alto
anche Martina Caironi,
venticinquenne di Alzano
Lombardo amputata
all’altezza del femore
sinistro dopo un incidente
stradale e seguita dal
Centro Inail di Vigorso
di Budrio; già oro nei 100
metri T42 alla Paralimpiade
P R O T E S I D A R E C O R D
P A R O L E C H I A V E
G I O C H I O L I M P I C I , O R T O P E D I A , P A R A L I M P I A D I , P E R S O N A L I Z Z A Z I O N E
C A T E G O R I A
S P O R T
L U O G O
B U D R I O ( B O )
C O O R D I N A T E G P S
4 4 . 5 3 7 7 5 5 N , 1 1 . 5 3 4 5 7 3 E

C A P I T O L O 1
I T A L I A
Q U A D R A N T E M A P P A
I2
Q U A D R A N T E M A P P A
L3
Ma veramente l’industria
dei videogame in Italia
è pressoché inesistente
e le poche realtà che la
rappresentano sono un
esempio dell’arretratezza
economica e digitale del
paese? A guardar bene
sorgono dei dubbi.
Studi come Milestone,
Ovosonico, Forge Reply
e Digital Tales oggi
aumentano organici
e produzione. L’Università
Statale di Milano inaugura
il terzo anno di laurea
magistrale in Game
Design. Da citare poi
il finanziamento privato
(1,44 milioni) di Digital
Bros a Ovosonico, che
consentirà allo studio
varesino di annunciare,
quest’anno, il successore
del videogame Murasaki
Baby e gestire più progetti
mantenendo l’autonomia
creativa.
Il pessimismo della stampa
spesso delinea un quadro
negativo ma dimentica per
esempio i tutorial musicali
dei nostri sviluppatori in
cui si distruggono città
come Tonzilla di Krur;
o i simulatori di rivolte
che sono osservatori
antropologici quale Riot,
di Leonard Menchiari,
pronto per questa estate.
Accanto a Milestone,
che può permettersi
di (far) giocare insieme
a Valentino Rossi
attraverso il suo videogioco
ufficiale, spuntano
manifesti “extra-ludici”
come Progetto Ustica,
simulazione
in realtà virtuale del volo
IH870. Finanziato in
crowdfunding e sviluppato
in collaborazione con
l’Associazione Parenti delle
Vittime della Strage di
Ustica, è la testimonianza
di come il gioco possa farsi
strumento di impegno
civile e di memoria.
Chiaro, della maggior
parte di tanti progetti
è impossibile prevedere
il successo, di alcuni è
difficile anche garantire
l’uscita. Ma sull’impegno
di tutti ad accrescere
l’industria del Game in
Italy, oggi si può giurare.
di Londra e al Mondiale
di Doha 2015, è tuttora
detentrice del record del
mondo nei 100 e nei 200.
Insieme a lei, oltre agli
undicimila pazienti trattati
ogni anno dal Centro,
ci sono anche altri atleti
che puntano
alle Paralimpiadi.
Come il “lunghista”
Roberto La Barbera
(già argento del salto
in lungo ad Atene 2004
e pronto a una nuova
avventura a 49 anni),
Claudio De Vivo (argento
italiano nei 60, 200
e 400 metri) e Monica
Contrafatto, soldatessa
che nel 2012 ha perso
una gamba in un attentato
in Afghanistan e che ora
sogna di staccare il pass
paralimpico nei 100 metri
dopo aver corso la finale
mondiale a Doha accanto
a Martina Caironi.
Grazie ai sofisticati
dispositivi brevettati
e costruiti dalle
multinazionali del settore
come Ottobock e Össur
(anch’esse presenti
a Budrio con le rispettive
sedi italiane) i centri
sviluppano soluzioni
personali e su misura.
E i risultati − sempre
più esaltanti per lo sport
italiano − si vedono.
E M I L I O C O Z Z I
P A R O L E C H I A V E
I N D U S T R I A , U N I V E R S I T À , U S T I C A
C O O R D I N A T E G P S
4 5 . 8 1 9 4 4 5 N , 8 . 8 2 2 4 1 2 E
C A T E G O R I A
V I D E O G A M E
L U O G O
V A R E S E
G I O C A N D O I N C A S A
G A B R I E L E L I P P I

C A P I T O L O 1
I T A L I A
Q U A D R A N T E M A P P A
K4R O B O T, M A N I E T E N TA C O L I
Libri di fantascienza a
parte, replicare ciò che
esiste in natura è un’arte:
un’arte che si impara
alla Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, a
contatto con i progetti
di replica più evoluti del
mondo. Dove neanche
il gesto più scontato, sotto
quest’ottica, resta privo
di complessità e
meraviglia. Per esempio,
chi sa quanta scienza
bisogna scomodare per
riprodurre artificialmente
una stretta di mano?
Perché proprio la mano,
qui, è la protagonista
indiscussa, visto che
l’obiettivo è realizzarne
la replica perfetta,
nell’aspetto e nelle
capacità, per quanti hanno
subito un’amputazione.
In questi laboratori c’è
tutta la storia che ha
portato a dita artificiali
sempre più flessibili
e libere di muoversi,
a prese sempre più
calibrate, a materiali
sempre più leggeri e,
negli ultimi anni, a mani
robotiche comandate
dal pensiero. Non solo.
Nei modelli recenti è
presente anche il senso
del tatto: chi li indossa
può percepire forma e
consistenza di ciò che
stringe. Nuovi software
in grado di codificare in
modo sempre più raffinato
le sensazioni permettono
di distinguere la ruvidità
delle superfici che toccano
e classificarne il materiale,
siano esse lisce o irregolari,
di vetro oppure velluto.
Non è solo l’essere umano
la creatura da replicare.
L’ultima frontiera dello
sviluppo, alla Sant’Anna,
si ispira a organismi meno
antropomorfi: come i
molluschi, privi di scheletro
e con motilità lontana dalla
nostra. È il mantra della
soft robotics, la robotica
morbida che attraverso
materiali elastici, gommosi
e deformabili converte in
nuove tecnologie i principi
fondamentali della natura
e scardina le regole in
un processo che, per
creatività, fa nuovamente
pensare all’arte.
L’ultimo prototipo è un
grosso polpo animato
in silicone, realizzato dopo
mesi trascorsi a studiare
tentacoli e ventose dei
nostri cefalopodi:
un essere, tra i più
sofisticati mai progettati
finora, che farà forse
da apripista a una
nuova specie di creature
subacquee in grado
di esplorare fondali,
recuperare oggetti,
prestare soccorso quando
per l’uomo è impossibile.
E che, perché no, presterà
uno dei tentacoli alla
medicina fino a evolversi
in uno strumento
chirurgico più delicato,
intuitivo e sicuro di
quelli tradizionali.
A L I C E P A C E
C A T E G O R I A
S C I E N Z A
L U O G O
P I S A
C O O R D I N A T E G P S
4 3 . 7 2 1 4 3 9 N , 1 0 . 4 0 2 4 3 2 E
P A R O L E C H I A V E
P O L I P O , S A N T ’ A N N A , S E N S I B I L I T À , T A T T O
©PRENSILIA.COM

C A P I T O L O 1
I T A L I A
Q U A D R A N T E M A P P A
M9
P A R O L E C H I A V E
A R T E , C E N T R O S O C I A L E , T U R I S M O , U T O P I A
C A T E G O R I A
S O C I E T À
L U O G O
F A V A R A ( A G )
F R A N C E S C O L I P A R I
I L F U T U R O P A R T E D A S E T T E C O R T I L I
C O O R D I N A T E G P S
3 7 . 3 1 3 5 0 4 N , 1 3 . 6 5 8 1 7 6 E
Il 25 giugno 2010 sulla
cittadina di Favara, a pochi
minuti dalla meravigliosa
Valle dei Templi di
Agrigento, si abbatte
il progetto “Farm Cultural
Park”. Una “deflagrazione
buona”: in appena
duemila giorni produrrà
un cambiamento così
intenso, all’interno di
uno dei contesti siciliani
più dilaniati da cemento
e mafia, da essere
paragonato alla somma
delle metamorfosi
avvenute nell’intera
provincia in un ventennio.
Farm Cultural Park è
l’innovazione territoriale
del notaio Andrea Bartoli
e della moglie Florinda
Saieva, che decidono di
acquistare alcune casette
fatiscenti nel centro storico
e costruirci un sogno.
Stanca di attendere
che le promesse altrui
si realizzassero, la coppia
siciliana ha deciso di non
trasferirsi in una capitale
europea, ma di restare
e donare la loro visione
a 32mila fortunati cittadini,
realizzando tra i vicoli
di matrice araba della città
il loro pezzo di mondo
nuovo. Una scelta in
apparenza folle che,
in realtà, porta i due
visionari a realizzare
un’utopia: trasformare
il centro storico della città
nella prima attrazione
turistica contemporanea
dell’intera Sicilia.
La Farm, come ormai tutti
la chiamano, ha ristabilito
nei suoi abitanti quello che
in un progetto chiamato
“La Città Emozionale”
è stato definito “Status
Emotivo Minimo” (Sem):
la condizione minima
(e necessaria) affinché
i cittadini possano sentirsi
sicuri in un personale
recinto abitativo.
Negli anni, il progetto Farm
Cultural Park si è allargato
− da piccolo centro
culturale di appena 300
metri quadri, racchiuso
in sette cortili −
a complessa e
articolata unità minima
di urbanizzazione di
1700 metri quadrati,
consentendo a Favara di
passare da zero visitatori
a quasi 40mila turisti.
All’interno, si susseguono
mostre inedite, workshop
su cibo e tecnologia,
talk e presentazioni,
concorsi e installazioni
d’arte e architettura
contemporanea. Nei suoi
spazi si sono avvicendati
artisti, architetti, creativi
e innovatori di tutto il
mondo che insieme
– e lavorando con chi del
progetto ne consente
la reale sopravvivenza,
cioè i vecchi residenti
dei sette cortili – stanno
contribuendo a definire
un nuovo ecosistema
territoriale di riferimento
per i centri storici
di un’intera regione.
©FARM CULTURAL PARK

C A P I T O L O 1
I T A L I A
Q U A D R A N T E M A P P A
J2
F I L I P P O P I V A
P A R O L E C H I A V E
B I O T E C N O L O G I A , D N A , O G M , P T P
C A T E G O R I A
F O O D
I L P A R C O H I -T E C H D E L L’A G R I C O LT U R A
C O O R D I N A T E G P S
4 5 . 3 0 3 5 7 2 N , 9 . 4 7 8 7 0 5 E
L U O G O
L O D I
L’autunno del 2005 ha
visto a Lodi la nascita del
Parco Tecnologico Padano:
una realtà interamente
dedicata a ricerca e
innovazione, all’interno
della quale si guarda al
futuro dell’agroalimentare,
della bioeconomia e delle
scienze della vita, con un
particolare focus sui temi
dell’alimentazione e della
produzione di cibo.
«Il tema del food, ai nostri
giorni, è diventato un perno
fondamentale attorno a cui
gira una serie di tematiche
importantissime», spiega
il direttore generale del
Parco Gianluca Carenzo.
«Quelle economiche, certo,
ma anche altre legate alla
salvaguardia dell’ambiente,
al rapporto tra cibo e
salute, alla prevenzione
delle malattie». Legate a
doppio filo alla genomica
e alle tecnologie inerenti,
esse animano le attività
quotidiane dei 9mila metri
quadrati del complesso
lodigiano, che oltre ai
laboratori del Cnr e
dell’Università degli Studi
di Milano ospita alcune tra
le più innovative startup
italiane del settore.
«Il Ptp si muove
sostanzialmente su tre
linee: la prima è la ricerca
applicata a temi che
spaziano dalla genetica
vegetale al riciclo, fino alle
agroenergie. La seconda
è quella dei servizi b2b,
business-to-business,
con progetti pensati per
le imprese che si trovano
ad affrontare nuove sfide
legate alla tecnologia
alimentare, dai prodotti
Ogm alla tracciabilità del
cibo. Infine c’è la nostra
attività di incubatore di
impresa, attraverso cui
forniamo spazi, consulenza
e supporto alle startup
legate all’agro-bio-food».
Così trova spazio per
esempio Italbugs,
la prima azienda italiana
specializzata in processi
di allevamento di insetti
per l’alimentazione.
Non basta. Tra i successi
del Parco Tecnologico
Padano ci sono anche un
progetto di coordinamento
delle ricerche internazionali
sull’evoluzione del dna
delle capre in relazione
alle condizioni
geoclimatiche del loro
habitat (presentato al
G8 dell’agricoltura di
Washington lo scorso
aprile con il nome di Goat
AdaptMap); e il più recente
DemoField, che durante
il periodo dell’Expo ha
trasformato un ettaro
di terreno, nelle immediate
adiacenze del parco,
in un laboratorio a cielo
aperto per sperimentare
e illustrare le più recenti
innovazioni agrotecniche
nell’uso efficiente
dell’acqua e nella gestione
integrata delle colture.
«Guardando al futuro
del cibo, la parola chiave
non può che essere
sostenibilità: sia per
i prodotti sia per i processi
produttivi».
«Per questo, al Parco
Tecnologico Padano
crediamo nell’importanza
assoluta della ricerca su
biotecnologie, bioeconomia
ed economia circolare,
con l’obiettivo di coniugare
le produzioni e il rispetto
per il territorio».

C A P I T O L O 1
I T A L I A
Q U A D R A N T E M A P P A
M5
G I A N L U C A D O T T I
I Laboratori Nazionali
del Gran Sasso sono un
centro di ricerca costruito
per trovare e studiare
l’inafferrabile. Per questo
è sepolto nelle viscere
della montagna a 1400
metri di profondità, dove
persino i raggi cosmici ad
altissima energia riescono
a malapena a penetrare.
Ideati più di trent’anni
fa e gestiti dall’Istituto
Nazionale di Fisica
Nucleare, i Laboratori
si raggiungono solo
percorrendo il traforo
autostradale che attraversa
il più grande massiccio
montuoso dell’Italia
centro-meridionale.
La temperatura naturale
è di 6 gradi; per tutto l’anno
l’umidità sfiora il 100%.
Lì sotto oggi lavorano circa
750 scienziati, impegnati
in una quindicina di
esperimenti che indagano
i meccanismi di produzione
di energia nelle stelle
e i decadimenti rari.
Ma, soprattutto, la fisica
dei neutrini e la ricerca
dell’elusiva materia oscura.
Anche se ogni secondo
il nostro corpo è
attraversato da miliardi
di neutrini, lo studio
di queste particelle è
sempre stato complicato
dalla scarsa capacità
di interagire con la materia.
Sull’esistenza non ci sono
più dubbi, né sul fatto
che possiedano una massa
piccola ma misurabile:
il risultato ha meritato
il premio Nobel per la
fisica 2015, assegnato
per la dimostrazione
sperimentale della
cosiddetta “oscillazione
del neutrino”, ossia quella
peculiare capacità di
cambiare identità.
Al successo hanno
contribuito anche
i Laboratori del Gran Sasso
con gli esperimenti
Gallex, Macro e Opera.
Ma la ricerca non è finita:
in fase di assemblaggio
c’è il rivelatore Cuore
(Cryogenic Underground
Observatory for Rare
Events). Ha l’ambizioso
obiettivo di stabilire se
le particelle abbiano
le proprietà previste
da Paul Dirac o quelle
teorizzate 80 anni fa da
Ettore Majorana, secondo
cui il neutrino potrebbe
spiegare perché l’universo
è costituito quasi tutto
di materia e le tracce
di antimateria sono così
sfuggenti. I fisici
sperano di osservare
un rarissimo decadimento
nucleare del tellurio,
il doppio-beta senza
emissione di neutrini.
Darebbe ragione a
Majorana ma richiede
temperature più basse
del punto più freddo
dell’universo e una
schermatura con piombo
antico ottenuto dalle
mattonelle di una nave
di epoca romana
affondata duemila
anni fa. In un’altra sala
si va invece a caccia
di materia oscura con
un rivelatore di xenon
liquido da sette tonnellate:
i primi risultati sono attesi
per questa primavera.
C A T E G O R I A
S C I E N Z A
P A R O L E C H I A V E
G R A N S A S S O , F I S I C A N U C L E A R E , M A J O R A N A
L U O G O
T R A L ’ A Q U I L A E T E R A M O
C O O R D I N A T E G P S
4 2 . 4 1 9 7 7 5 N , 1 3 . 5 1 6 8 7 4 E
D E N T R O L A M O N TA G N A D E I N E U T R I N I
©KAI FREUND/UNIVERSITY OF TÜBINGEN



Ci accontentiamo semplicemente del meglio e creiamo i migliori prodotti editoriali. Per questo abbiamo Vanity Fair,
il settimanale leader in Italia, L’Uomo Vogue il mensile più autorevole e GQ il mensile maschile più letto. Per questo
siamo l’editore italiano più seguito sui social. Per questo ogni mese oltre 6 milioni di uomini scelgono i nostri siti.
Tradotto in una parola, Qualità. In due parole, Condé Nast.
#CONDENASTQUALITY



Parigi
E U R O P A
1
pag. 66
pag. 56
pag. 72
pag. 68
pag. 73
pag. 69
pag. 74
pag. 70
pag. 75
pag. 71
Coruño
Copenaghen
Werlte
Ginevra
Londra
Monaco di Baviera
Mosca
Bray
Mons
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0

A
I
L I K E
LUOGO
PARIGI, FRANCIA
COORDINATE GPS
48.883527 N, 2.302269 E
FOTO DI
MATTIA BALSAMINI
TESTO DI
MAURIZIO PESCE
CAPITOLO 2
EUROPA
QUADRANTE MAPPA
G6

5 7
5 6
IN UN ANONIMO UFFICIO
FACEBOOK STA INSEGNANDO
AI COMPUTER COME
PREVEDERE I BISOGNI
DEGLI UTENTI.
SIAMO ENTRATI PER PRIMI
E VI SVELIAMO I SEGRETI
DELL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE DESTINATA
A RIVOLUZIONARE
I SOCIAL NETWORK

W I R E D / N. 2 / P R I M AV E R A 2 01 6

C A P. 2 / E U R O PA
5 9
5 8
utti gli operatori sono occupati, attendere in linea per non perdere la priorità acqui-
sita. Lo sappiamo perfettamente com’è stare al telefono per minuti e minuti nell’at-
tesa di poter ascoltare una voce amica e accedere al servizio richiesto. Presto tutta
questa inutile perdita di tempo, energie e soldi sarà un lontano ricordo. Non appena
Facebook avrà finito la fase di sperimentazione di M, il suo nuovo assistente virtuale
integrato nella chat Messenger. A M si potrà chiedere aiuto per organizzare una cena
di compleanno, per trovare l’auto sotto casa o per prenotare un tavolo al ristorante. Immaginate di
chattare con un amico e di parlare di uno show musicale: durante la conversazione M sarà in grado di
chiedervi se volete acquistare un biglietto o di proporvi quali altri concerti ci sono nella stessa sera.
All’inizio gli assistenti virtuali avevano funzioni limitate, ed erano in grado di rispondere solo
a poche richieste precise: che tempo farà oggi? Quali sono le ultime notizie? Mostrami le indicazioni
stradali per tornare a casa. Tutto è cambiato quando hanno cominciato a comprendere il linguaggio
naturale, integrandosi ai servizi e offrendo assistenza anche per acquisti e prenotazioni. A fare la
differenza oggi è un tocco più “umano”, quell’abilità di utilizzare tutte le informazioni disponibili
per suggerire diverse soluzioni. Per rendere a portata di smartphone questo livello di complessità,
però, serviranno ancora anni di ricerca e sviluppo degli algoritmi dell’intelligenza artificiale. Una
ricerca già iniziata: decine di scienziati infatti sono in questo momento al lavoro dentro il Facebook
Artificial Intelligence Research (Fair).
entro, il Fair non è molto diverso da un ufficio qualsiasi: non ci sono ologrammi, robot
che si aggirano né gente che smanaccia comandi gestuali in aria o che indossa visori.
Solo scrivanie piene di computer che si susseguono negli open space. Il progetto che si
porta avanti qui è invisibile, concentrato sull’obiettivo di dare alle macchine l’abilità
di apprendere senza essere state esplicitamente programmate per farlo. Nessuno ha
un mandato per lavorare su un’area specifica: si studia il riconoscimento del linguag-
gio naturale, la comprensione e interpretazione di immagini e video e, in ultima battuta, l’apprendi-
mento automatico delle macchine. Si guarda al futuro a 10 anni da oggi, anche se capita spesso che gli
avanzamenti vengano testati e utilizzati nei prodotti strada facendo.
L’ufficio parigino di Facebook è piccolo, troppo piccolo per ospitare un laboratorio di ricerca
importante come quello dedicato all’intelligenza artificiale: a 9 mesi dalla sua inaugurazione, nel
giugno dell’anno scorso, ci lavorano già 15 persone provenienti da tutta Europa e altre sono attese
nei prossimi mesi. La sede locale del Fair è stata aperta lo scorso giugno per rispondere alla necessità
di allargare il team senza rinunciare a quei ricercatori che non volevano trasferirsi negli Stati Uniti,
a Menlo Park o New York. La scelta di Parigi è stata facile, dicono in Facebook, perché gli scienziati
francesi sono riconosciuti tra i migliori del mondo e perché qui è stato possibile fare un accordo con
l’Inria, l’Istituto Nazionale di Ricerca in Informatica e Automatica francese, che garantirà una serie
di opportunità a ricercatori e studenti coinvolti nel programma di Facebook. Dopo l’estate si uniran-
no al team altri ricercatori, compresi tre provenienti dalla Russia, dal Senegal e dall’Italia.
I risultati della ricerca condotta fin qui hanno già avuto impatto su Moments, l’applicazione di
Facebook per le foto: ora riconosce le facce degli amici nella galleria fotografica dello smartphone, in FL
OR
EN
T P
ER
RO
NN
IN È
A C
AP
O
DE
L L
AB
OR
AT
OR
IO P
AR
IGIN
O
SU
LL
’AI
DI
FA
CE
BO
OK
DA
MA
GG
IO
20
15.
È U
NO
DE
I 5
0 I
NN
OV
AT
OR
I
PIÙ
IM
PO
RT
AN
TI
DE
LL
A F
RA
NC
IA
T
D

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
base alla geolocalizzazione le raccoglie in album dedicati a singoli eventi e permette di condividerle
automaticamente sul social network solo con i contatti presenti nella foto stessa. L’altro prodotto che
utilizza intelligenza artificiale, come abbiamo detto, è M: in questo caso, la chat è portata avanti dagli
algoritmi, assistiti da un team dedicato al dialogo che insegna a comprendere la conversazione, aiuta
a rispondere alle domande degli utenti e suggerisce come sviluppare ulteriormente il discorso in base
agli interessi manifestati dalle persone proprio su Facebook.
E poi, ovviamente, c’è la timeline: fin dal suo lancio del 2006, l’algoritmo è stato interamente
basato sull’intelligenza artificiale, per stabilire quali delle decine di aggiornamenti delle centinaia di
contatti mostrare di volta in volta. Per esempio, maggiore è il numero di interazioni con una persona,
maggiore è la probabilità di vedere un suo post nel News Feed, così come di vedere più foto o più video
se si dimostra interesse verso un particolare tipo di format. Il prossimo passo sarà spingere l’analisi
del contenuto fin dentro le immagini, per arrivare a raffinare le proposte anche in base al loro conte-
nuto. Non solo genericamente foto o video, ma foto e video di qualcosa in particolare: gatti, bambini,
sport, cibo o altro ancora. «La cosa che più mi colpisce è la velocità di sviluppo della ricerca sull’intel-
ligenza artificiale», dice Florent Perronnin, direttore del Fair di Parigi. «Non solo oggi siamo arrivati
a un punto impensabile solo pochi anni fa, ma ormai bastano appena due settimane da quando otte-
niamo un risultato per vederlo integrato nei prodotti».
n altro progetto che Facebook sta sviluppando si chiama “Embed the world” (includi
il mondo) e punta a migliorare al massimo i suggerimenti di amici da aggiungere o
contenuti da visualizzare a seconda delle interazioni con tutti i post passati in timeli-
ne: like, foto e video. È una sfida enorme che richiede tutta la potenza di calcolo dei tre
centri di ricerca per essere realizzata al meglio. Si basa contemporaneamente su rico-
noscimento testuale, logica computazionale e computer vision. Basti pensare che ogni
giorno vengono processati i dati di 800 milioni di nuove foto caricate sulla piattaforma e 2 miliardi di
video riprodotti dagli utenti di tutto il mondo.
L’obiettivo del social network è garantire la serendipità: non quindi usare l’intelligenza arti-
ficiale per segnalarti quello che già ti interessa, ma sfruttarla per predire e raccomandare qualcosa
che è probabile che ti piacerà nel futuro. «Uno dei progetti che stiamo sviluppando a New York punta
a modificare i suggerimenti che Facebook ti dà rispetto alle storie che leggi o condividi, proponendo
non altre fonti della stessa notizia, ma diversi punti di vista per approfondirla», racconta Perronnin.
I protocolli su cui si basano le raccomandazioni attuali sono basati sul cosiddetto reinforced
learning e sono solo la ciliegina sulla torta dell’intelligenza artificiale: gustosi, ma del tutto margina-
li. I ricercatori sono già al lavoro sulla glassa, che rappresenta il supervised learning, mentre la torta
vera e propria l’avremo quando le macchine saranno in grado di apprendere ed evolversi in perfetta
autonomia, anche se c’è più di qualche timore per un futuro governato dai computer. Secondo un son-
daggio realizzato lo scorso dicembre dall’Ifop, l’Istituto Francese per l’Opinione Pubblica, il 65% dei
cittadini è preoccupato dalla crescente autonomia delle macchine.
Calma. «Innanzitutto, siamo lontani diversi decenni dal costruire macchine davvero intelli-
genti: ci sono principi basilari dell’apprendimento autonomo che ancora non abbiamo capito. E poi
non abbiamo computer abbastanza potenti per la quantità di calcolo che andrebbe processata, quindi
U

C A P. 2 / E U R O PA
6 1
6 0
dobbiamo comunque aspettare un miglioramento della tecnologia per poter proseguire», dice Yann
LeCun, da due anni alla guida del programma Fair. Informatico, ha pubblicato contribuiti su machine
learning, computer vision, robotica e neuroscienze computazionali, è docente alla New York Universi-
ty e da quest’anno anche al Collège de France. «Creare macchine intelligenti è troppo complicato per
gli ingegneri, quindi non possiamo far altro che programmarle per imparare e poi trovare il metodo
migliore per insegnare loro a studiare da sole», aggiunge.
L’apprendimento supervisionato è simile a quello che si tenta con i bambini piccoli quando si
fanno vedere immagini di cose o animali pronunciandone il nome. Le macchine sono come i bambi-
ni. Si mostrano loro migliaia di foto e si lascia che l’intelligenza artificiale sistemi i parametri fino
a produrre la risposta corretta. «Questa parte funziona molto bene ed è efficace per riconoscere e
organizzare immagini: su Facebook viene utilizzata per proporti il tipo di foto a cui hai mostrato più
interesse nel News Feed. È l’approccio che usano anche altre aziende, come Google, Flickr, Microsoft
e Ibm». L’algoritmo utilizzato è in giro da diversi anni: viene usato per il riconoscimento automatico
di oggetti, facce e loghi e per l’analisi di documenti. È la stessa tecnica su cui LeCun ha sviluppato un
modello di apprendimento grazie al quale oggi oltre l’80% degli assegni degli Stati Uniti sono proces-
sati automaticamente. Il problema è che per sfruttare questo metodo c’è bisogno di tanti dati, perché
la macchina imparerà solo quello che le mostri ed è quindi obbligatorio elaborare singolarmente tutte
le informazioni necessarie.
n altro tipo di apprendimento è quello rinforzato e assomiglia agli addestramenti degli
animali da circo, che vengono premiati quando rispondono a uno stimolo nel modo
corretto», spiega Perronnin. «In questo caso, le macchine sono costruite per massi-
mizzare la ricompensa e quindi tenteranno risposte diverse per capire quale sia la ri-
sposta più appropriata quando si dovesse ripetere quella situazione». Questo genere
di insegnamento è molto lento, richiede diversi tentativi e funziona bene con i giochi,
perché la macchina può avere un quadro completo di tutte le opzioni disponibili entro poche ore. Un
buon esempio è Deep Blue, il computer di Ibm che nel 1996 vinse la prima partita di scacchi contro il
campione del mondo in carica, Garry Kasparov. Qualche settimana fa, DeepMind è stata la prima mac-
china in grado di battere un campione a Go, antico gioco orientale simile agli scacchi. Per program-
marla, i risultati dell’apprendimento supervisionato sono stati raffinati con l’apprendimento rinfor-
zato, raggiungendo un livello insperato solo due anni fa, quando si era ipotizzato servissero ancora
una decina d’anni di ricerca per arrivare a una vittoria del computer contro un umano.
Poi c’è l’apprendimento non supervisionato, che è quello che fa più paura, perché suona come
se le macchine, senza controllo, potessero decidere di conquistare il mondo. «In realtà si tratta di un
metodo simile a quello con cui gli umani capiscono come funziona il mondo semplicemente osservan-
dolo», se la ride LeCun. «Ti basta guardare per sapere che un libro in bilico su una scrivania cadrà se
qualcuno urterà la scrivania. Non abbiamo ancora davvero capito come applicare questo ragionamen-
to alle macchine. Qui a Parigi stiamo provando con la programmazione neurolinguistica, che funzio-
na abbastanza bene: sottoponiamo pezzi di testo alle macchine e chiediamo cosa succederà dopo».
Ma questo metodo non funziona con i video.
Lo stato delle macchine, oggi, è come quello di un neonato che riconosce le immagini, ma ha
«U

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
L’APPRENDIMENTO DELLE
MACCHINE OGGI È COME
QUELLO DI UN NEONATO:
SE UN OGGETTO ESCE
DAL CAMPO VISIVO,
SMETTE DI ESISTERE “G
ING
ER
& F
RE
D”,
“W
ILL
IAM
& K
AT
E”:
LE
SA
LE
RIU
NIO
NE
DE
LL
A
SE
DE
PA
RIG
INA
DI
FA
CE
BO
OK
SO
NO
DE
DIC
AT
E A
CO
PP
IE F
AM
OS
E,
MA
IL
TE
AM
DI
SV
ILU
PP
O
DE
LL
’AI
OR
MA
I N
ON
CI
ST
A P
IÙ
E S
I R
IUN
ISC
E S
OL
O I
N C
UC
INA

C A P. 2 / E U R O PA
6 3
62
un’esperienza limitata. Così come per i bambini quello che non vedono non esiste (ed ecco perché si
divertono tanto a fare “bubu settete”), anche i computer non sono in grado di considerare elementi
diversi da quelli del calcolo a cui stanno lavorando. «Dopo pochi mesi l’uomo è perfettamente in grado
di capire che, se una persona lascia la stanza, continua a esistere al di fuori di essa. Una macchina non
lo sa ancora». Se un computer analizzasse il video di un oggetto in movimento, nel momento in cui
passasse dietro un altro oggetto più grande verrebbe considerato assente anziché nascosto. Questa
analisi è importante anche per insegnare alle macchine la dimensione del tempo, anche se ancora
non è stato trovato un metodo adatto per farlo. «Al momento non sappiamo nemmeno come porre il
problema correttamente: potrebbero volerci anni, decenni», ammette LeCun.
ppure il timore di un’intelligenza artificiale cattiva è già reale, tanto che il fisico Ste-
phen Hawking, il co-fondatore di Apple Steve Wozniak e il boss di Tesla e SpaceX Elon
Musk si sono uniti a centinaia di altri esperti nel firmare una lettera aperta che chiede
lo sviluppo dell’intelligenza artificiale solo a fin di bene e di bandirne l’utilizzo bellico.
«Le macchine sono specializzate, sono costruite per uno scopo e miglioreranno da sole
solo per il compito per cui sono programmate: se è stata creata per guidare guiderà,
non avrà mai l’idea di ribellarsi e investire passanti», dice il capo del programma Fair. Ci vengono
in mente Person of Interest e la battaglia tra Samaritan e The Machine: è possibile un futuro in cui
due intelligenze artificiali combatteranno tra loro? «È possibile, come già oggi ci sono già macchine
che combattono contro altre macchine: hacking scripts e virus da una parte, crittografia e antivirus
dall’altra. Ma è comunque sempre l’uomo a manovrarle. Chiedersi se l’intelligenza artificiale avrà i
nostri stessi valori morali è una domanda filosofica: l’etica delle macchine è lontana ancora diversi
decenni, ma è qualcosa a cui dobbiamo cominciare a pensare oggi, così come ci siamo interrogati per
tempo sull’etica della biologia o sul dna».
E

W I R E D / N. 2 / P R I M AV E R A 2 01 6

C A P. 2 / E U R O PA
6 5
6 4
YA
NN
LE
CU
N,
INF
OR
MA
TIC
O.
DA
L 2
01
3 È
DIR
ET
TO
RE
DE
LL
A
RIC
ER
CA
SU
LL
’AI
DI
FA
CE
BO
OK
.
INS
EG
NA
AL
LA
NE
W Y
OR
K U
NIV
ER
SIT
Y
E A
L C
OL
LÈ
GE
DE
FR
AN
CE

©ELCHINO POMARES

C A P I T O L O 2
E U R O P A
Q U A D R A N T E M A P P A
E8
G A B R I E L E L I P P I
P A R O L E C H I A V E
E V E N T I , R I Q U A L I F I C A Z I O N I U R B A N E , S K A T E B O A R D
C A T E G O R I A
S P O R T
C O O R D I N A T E G P S
4 3 . 4 2 4 1 8 6 N , 5 . 8 3 3 3 9 6 O
L U O G O
C O R U Ñ O , S P A G N A
L O S K AT E P A R K I N C H I E S A
La chiamano la chiesa
maledetta, ma nessuno ci
ha mai visto o sentito un
demone. Sotto le sue volte
si aggirano solo
fuoriclasse dello
skateboard. Il fenomeno
più paranormale cui si
possa assistere è qualche
trick di difficile esecuzione.
A Coruño, vicino a Oviedo,
in Spagna, una chiesa
sconsacrata è diventata
skatepark. Sulle volte e sui
muri non ci sono affreschi,
ma graffiti dai colori
fluorescenti. L’abside non
ospita un altare, ma una
rampa, e piegarsi sulle
ginocchia non è un gesto
volontario di chi intende
pregare, ma il principio
di un dolore molto fisico
e poco spirituale.
Questa bizzarra
trasformazione
è solo l’ultimo atto
di una storia nata più
di cento anni fa.
Finita di costruire nel
1912, la chiesa doveva
essere inclusa nella
cittadella riservata agli
operai della fabbrica
di polvere da sparo Santa
Bárbara. Durante la Guerra
civile, ossia tra il 1936 e
il 1939, fu occupata dai
franchisti che piazzarono
un loro cecchino sulla torre
campanaria. E per questo
fu bombardata. Negli
anni Sessanta l’intero
villaggio fu acquistato
da una società privata,
che trasformò l’area in un
poligono industriale. Tutti
gli edifici precedenti furono
abbattuti, tranne la chiesa,
che fu però abbandonata al
suo destino. Fino al 2007,
quando fu comprata da
un’impresa familiare. L’idea
era farne una struttura
polivalente, con uffici
e negozi da affittare, ma
il sopraggiungere della
crisi fece finire in soffitta
il progetto. È stato a
quel punto che Jernest,
agente commerciale con
la passione dello skate, ha
avuto una brillante idea:
trasformare la struttura in
uno skatepark e fondare
la Church Brigade, la
crew di skateboarder
che ora si occupa della
gestione autofinanziandosi,
nell’attesa che qualche
grossa marca del settore
si accorga del potenziale
dello spazio e decida
di sponsorizzarlo.
Dal 2012 la chiesa ospita
eventi, feste, concerti,
piccole competizioni.
Partiti con una rampa,
e costantemente alle prese
con i controlli
di polizia e comune,
gli organizzatori sono
riusciti a trasformare
l’edificio in uno skatepark
sempre più attrezzato,
anche grazie alla
collaborazione di alcuni
sponsor. Ora la navata
centrale è occupata da
una grande rampa che
fa compagnia a quella
più piccola presente
nell’abside. E non è ancora
finita: perché l’idea è quella
di migliorare ulteriormente
le strutture. Chiunque può
entrare a curiosare
e fare un po’ di skate.
Basta cercare su Facebook
La Iglesia Skate e prendere
un appuntamento.

C A P I T O L O 2
E U R O P A
P A R O L E C H I A V E
C A N C R O , N O R D A R C H I T E C T S , S A N I T À , V E R D E
F R A N C E S C O L I P A R I
C A T E G O R I A
A R C H I T E T T U R A
C O O R D I N A T E G P S
5 5 . 6 9 5 6 7 2 N , 1 2 . 5 6 1 2 5 7 E
L U O G O
C O P E N A G H E N , D A N I M A R C A
U N O S P E D A L E I N I N C O G N I T O
In che modo l’architettura
può influire positivamente
sulla degenza dei pazienti
di un ospedale? Come
trasformare un luogo di
sofferenza in uno spazio
che invogli le persone
a condividere esperienze?
Sono le domande da cui
sono partiti gli architetti
dello studio Nord
Architects progettando
il Centre for Cancer
and Health (Cch) di
Copenaghen.
Concepito sul modello
dei britannici Maggie’s
Centres, innovativi centri
di supporto per i malati
di tumore che tra le
loro strutture sanitarie
annoverano anche un
progetto di Zaha Hadid,
il Centre for Cancer and
Health pone al centro della
sua architettura la nuova
identità che il paziente
inevitabilmente acquisisce
a causa della malattia
che lo ha colpito. Il centro
danese riesce a dimostrare
come una efficace scelta
di materiali, spazi, colori
e profumi possa produrre
effetti positivi sulla
capacità del degente
di combattere la malattia
e avere così più possibilità
di sconfiggerla.
«Se vogliamo che i
pazienti stiano meglio,
è necessario che la
struttura sanitaria sia
accogliente e soprattutto
de-istituzionalizzata»,
sostengono i progettisti,
«che sia un luogo dove
stai meglio, diventi
consapevole della tua
condizione e, per quanto
possibile, ti diverti pure».
L’edificio ha una struttura
in calcestruzzo e legno
e facciate di metallo
bianco. È diviso in piccole
case indipendenti, dove
vivono i pazienti e i loro
famigliari, collegate fra loro
da un tetto che richiama
la tradizione giapponese
degli origami di carta.
«Spacchettando l’edificio
in unità più piccole
creiamo una struttura più
invitante. Volevamo che
l’effetto fosse quello di una
casa in cui ci si può sentire
a proprio agio», spiegano
gli architetti.
Secondo un dettame
tipico dell’architettura
scandinava, il centro
è concepito come
unione di due luoghi
apparentemente opposti:
l’ospedale e la casa.
La semplice combinazione
di funzioni e spazi, uniti
a un’altissima cura del
verde, permette a questo
complesso ospedaliero
di appena 2250 metri
quadrati di diventare
un’area altamente
confortevole e familiare,
che concede la giusta
riservatezza, grazie alla
suddivisione in casette con
balconi separate, ma
facilita la socializzazione,
in virtù del cortile e delle
sale comuni. Una grande
cucina è stata pensata
per imparare a preparare
insieme cibi sani, mentre
alcune aree sono state
riservate a coloro che non
vogliono rinunciare a un
po’ di sport e all’orticoltura.
Una caffetteria permette
di non isolare i pazienti dal
resto della città.
Anzi: gli incontri con
gli psicologi sono aperti
a tutta la cittadinanza.
Anche gli interni,
in cui si trovano mobili
contemporanei, opere
d’arte e tanta vegetazione,
sono stati oggetto di cure
particolari da parte
dei progettisti.
«All’interno del Centre
for Cancer and Health
di Copenaghen, il paziente
è il baricentro di un
insieme di spazi concepiti
attorno a lui», ribadiscono
gli architetti.
Insomma, se è vero
che avere un giardino
terapeutico fa comodo
a tutti, pare proprio che
sia ancora meglio se di
terapeutico c’è l’intera
architettura.

C A P I T O L O 2
E U R O P A
Q U A D R A N T E M A P P A
H5
Q U A D R A N T E M A P P A
H4
P A R O L E C H I A V E
A U T O E L E T T R I C H E , E C O L O G I A , G A S
C A T E G O R I A
E N E R G I A
I L C O M B U S T I B I L E D E L F U T U R O
C O O R D I N A T E G P S
5 2 . 8 5 6 1 0 0 N , 7 . 6 9 3 9 0 0 E
L U O G O
W E R L T E , G E R M A N I A
M I C H E L E P R I M I
In un paese della Bassa
Sassonia si sta realizzando
il combustibile del futuro.
È la rivoluzione energetica
portata avanti da Audi
nello stabilimento di Werlte
ed è basata su un processo
che, mettendo insieme
acqua, diossido di carbonio
ed energia elettrica “verde”
proveniente da fonti
rinnovabili (in questo caso
le pale eoliche), produce
un composto di idrogeno
e metano sintetico
chiamato e-tron. Così la
casa automobilistica da
consumatrice diventa
produttrice di energia,
inventando un sistema
chiamato Power-to-Gas:
ogni impianto industriale
è in grado di scomporre
l’acqua tramite elettrolisi
e produrre idrogeno che
potrebbe alimentare
le future autovetture
ecologiche. A Werlte
si fa anche un processo
chiamato “metanazione”,
ovvero la reazione
dell’idrogeno con l’anidride
carbonica per creare
un metano sintetico che
funzioni sulle automobili
a gas. Non solo, il calore
residuo sviluppato durante
il processo viene usato
per alimentare l’impianto
di biogas che fornisce
l’anidride carbonica.
Un circolo produttivo in
cui non si butta via niente
e che non si ferma mai.
©ADAM MØRK

C A P I T O L O 2
E U R O P A
Q U A D R A N T E M A P P A
G7
P A R O L E C H I A V E
B O S O N E , F I S I C A , F A B I O L A G I A N O T T I
G I A N L U C A D O T T I
L A M A C C H I N A D E L C E R N
C O O R D I N A T E G P S
4 6 . 2 3 4 9 8 8 N , 6 . 0 5 6 3 6 9 E
L U O G O
G I N E V R A , S V I Z Z E R A
C A T E G O R I A
S C I E N Z A
A guidare il Cern di
Ginevra, dall’inizio
dell’anno, è una donna
italiana. Il testimone
di direttore generale è
passato a Fabiola Gianotti
dopo 14 mesi dalla
nomina formale e, per
la terza volta, a capo del
laboratorio internazionale
di fisica delle particelle c’è
uno scienziato del nostro
paese: prima di lei avevano
già ricoperto lo stesso
ruolo il premio Nobel Carlo
Rubbia e Luciano Maiani.
Poco dopo lo storico
annuncio della scoperta del
bosone di Higgs, arrivata
nel luglio del 2012, il Cern
ha sospeso per due anni
le collisioni ad altissima
energia, per affrontare un
ulteriore potenziamento
dell’acceleratore Large
Hadron Collider (Lhc).
E ne ha approfittato per
battere qualche record,
come quello del campo
magnetico più intenso
mai creato dall’uomo,
di 16,2 tesla. L’energia
a cui ciascun protone viene
accelerato lungo l’anello
di 27 chilometri è
passata dai vecchi 3,5
Teraelettronvolt agli
attuali 6,5: ciò significa
che ora è possibile far
scontrare fasci a 13 TeV
e quindi andare a caccia
di particelle ancora
più pesanti. L’attesa
riaccensione di Lhc
è arrivata nell’aprile 2015
dopo qualche piccolo
intoppo ai supermagneti
che devono curvare i fasci
di particelle. Questa volta,
però, non si tratta di un
risveglio qualunque: il Cern
ora è come una nave che
salpa senza nemmeno
saperequale sarà la sua
rotta. Qualche risultato
è già arrivato: la scoperta
di una particella esotica
mai individuata prima e
composta di cinque quark.
Ma c’è grande attesa
per gli esperimenti che
ripartono a marzo, dopo
il tradizionale letargo
invernale. I quasi 15mila
scienziati al lavoro si
aspettano di fare ulteriore
luce sul meccanismo di
Higgs, ma anche di svelare
alcuni grandi misteri della
fisica moderna: la vera
natura della materia oscura
che, seppur così sfuggente,
rappresenterebbe il 90%
della massa dell’universo,
e dell’energia oscura,
l’origine di quella
forza di repulsione
che giustificherebbe
l’espansione sempre più
rapida del cosmo.
Si tratta insomma di
indagare quelle aree
grigie della fisica che
il modello standard non
riesce ancora a spiegare,
come l’antimateria,
o quelle teorie alternative
come la supersimmetria,
secondo cui a ogni
particella conosciuta
corrisponderebbe una
particella partner, che però
nessuno ha mai visto.
Non sappiamo quali
sorprese ci riserverà il
nuovo Lhc, ma basterebbe
una sola risposta per
giustificare l’investimento
di quasi un miliardo
di euro all’anno e per
dare lavoro alle nuove
generazioni di fisici.
©MICHAEL HOCH/CERN

C A P I T O L O 2
E U R O P A
Q U A D R A N T E M A P P A
F5
P A R O L E C H I A V E
N A V E , S A L A D I R E G I S T R A Z I O N E
N I C H O L A S D A V I D A L T E A
C A T E G O R I A
M U S I C A
Q U A N D O L O S T U D I O È I N B A R C A
C O O R D I N A T E G P S
5 1 . 5 0 8 4 5 3 N , 0 . 0 0 9 1 5 1 O
L U O G O
L O N D R A , R E G N O U N I T O
Ben Phillips, ingegnere
londinese, non riusciva a
trovare uno spazio adatto
per creare il suo studio di
registrazione. Gli serviva
un edificio diverso, in forte
contrasto con ciò che
già esisteva. L’aveva
cercato per quattro
anni, senza successo.
Mettici la difficoltà
di trovare ampi spazi
a Londra a prezzi umani,
le infinite limitazioni
imposte da progettisti
e autorità e tutto era
ancora più difficile.
Sarebbe potuto sorgere
in una vecchia sede di una
casa d’aste, in un obitorio
del diciannovesimo secolo
o in una chiesa. Nulla di
tutto questo. Il colpo di
fulmine avvenne, nel 2006,
per una rossa avvenente
di 550 tonnellate, che se
ne stava lì, attraccata e
inutilizzata sulle rive del
fiume Medway, nel Kent.
Si chiamava Lightship95
ed era una nave-faro
d’acciaio rivettato del 1939,
resistente a qualunque
condizione atmosferica.
Gli ampi spazi erano quelli
di cui Ben necessitava.
I lavori per la conversione
sono durati quasi due
anni e sono stati eseguiti
principalmente mentre
la nave era attraccata
sul Medway. Uno dei
primi provvedimenti
è stato rimuovere oltre
20 tonnellate di ferro
che avrebbero reso la
progettazione degli spazi
difficoltosa. Quella che
è diventata la control room,
ossia la regia dello studio,
ampia 28 metri quadrati
e dotata di luce naturale,
era in precedenza un
serbatoio con fondo piatto
che ospitava passerelle,
tubazioni e il motore
che comandava l’argano
idraulico. Dove una volta
c’era la sala macchine,
sorge ora la sala per la
registrazione, grande
più di 46 metri quadrati,
con camere di riverbero
e una cabina di isolamento.
Il pavimento è fluttuante,
le pareti sono sostenute
tutto intorno da supporti
in neoprene che si
uniscono alle costole
della nave, con
risultati eccellenti per
l’abbattimento delle
vibrazioni sia meccaniche
sia di risonanza.
Il ponte superiore
è destinato alle aree
ricreative, relax e cucina,
oltre ad avere uno
spazio all’aperto
sul ponte esterno.
C’è la possibilità di salire
sul faro e ammirare
la splendida visuale
portuale circostante
sul Tamigi, oppure,
tramite un ponte levatoio,
scendere sulla terraferma
e visitare l’area di Trinity
Buoy Wharf, zona dell’ex
stabilimento Trinity House
nel borgo Tower Hamlets
(East London), dove
il canale Bow Creek si tuffa
nel Tamigi. Senza questo
intervento ingegneristico,
la Lightship95 sarebbe
diventata una delle tante
navi-museo. Invece,
adesso, è uno degli studi
di registrazione più
richiesti di Londra.

Q U A D R A N T E M A P P A
I6
C A P I T O L O 2
E U R O P A
P A R O L E C H I A V E
A I , I B M , S U P E R C O M P U T E R
M I C H E L E P R I M I
C A T E G O R I A
H I - T E C H
C O O R D I N A T E G P S
4 8 . 1 3 5 1 2 5 N , 1 1 . 5 8 1 9 8 1 E
L A C A S A D I W AT S O N
L U O G O
M O N A C O D I B A V I E R A , G E R M A N I A
Le chiamano le HighLight
Towers, sono due torri
gemelle di 32 e 27 piani
e, dal dicembre scorso,
ospitano la nuova casa del
supercervellone Watson.
Lì dentro mille persone,
fra ricercatori, sviluppatori
e designer, aiutano
il computer a diventare
sempre più potente,
portando avanti diversi
progetti di Internet
delle cose di Ibm.
La promessa è stupire
ancora, dopo aver lasciato
tutti a bocca aperta cinque
anni fa, quando Watson
partecipò al quiz
televisivo Jeopardy.
Usando 200 milioni
di pagine di informazioni,
3mila chip, 16 terabyte
di memoria
e 6 milioni di regole
logiche, il computer
sconfisse gli umani in gara.
Era la sfida definitiva dopo
la vittoria del computer
Deep Blue sul campione
di scacchi Garry Kasparov
nel 1997. Le implicazioni
filosofiche sono molteplici:
in molti si sono chiesti se
Watson sia effettivamente
in grado di pensare o solo
di manipolare dei simboli
senza comprenderne
il significato. Ma al di
là di questo, l’obiettivo
principale del progetto
resta quello di avere
un computer in grado
di interagire con gli
umani e fornire risposte
in un linguaggio a loro
comprensibile. Per poi
agire in modo significativo
in tutti i settori in cui
è necessario gestire
grandi quantità di dati:
il cervellone è stato testato
nelle telecomunicazioni,
nei servizi finanziari e nella
sanità. Per questo il passo
successivo non poteva che
essere l’Internet delle cose.
Dopo la vittoria a Jeopardy,
Watson è rimasto in
silenzio per tre anni,
durante i quali ha imparato
il giapponese, l’arabo,
lo spagnolo e il portoghese
(a breve si butterà anche
sull’italiano) e ad applicare
i suoi algoritmi a 17 settori,
dalle automobili alle
assicurazioni, ai beni
di consumo elettronici.
Il quartier generale
di Monaco di Baviera
funziona come
un acceleratore
dell’intelligenza artificiale,
con lo scopo di stare dietro
attraverso il suo “sistema
cognitivo” e le sue 28
nuove Api (interfacce di
programmazione) ai dati
prodotti dalla tecnologia
e alla trasformazione della
società moderna
in un insieme sterminato
di codici software: 100
milioni per un’automobile,
14 milioni per un Boeing
747, 4,7 milioni per un
semplice lettore dvd.
In pratica Watson non
vuole solo generare
risposte a problemi
numerici, ma vuole
interagire, ragionare
su ipotesi e opzioni ed
estrarre conoscenza dal
mare dei dati (che presto
arriveranno per il 90%
dall’Internet delle cose).
Ma soprattutto vuole
continuare a imparare.

C A P I T O L O 2
E U R O P A
Q U A D R A N T E M A P P A
N4
P A R O L E C H I A V E
E V E N T I , R E M K O O L H A A S , S T R E L K A , S P A Z I C O M U N I
D A N I E L E B E L L E R I
Le città europee si fondano
su un’idea precisa: quella
di bene comune.
Ma nella Mosca
post-sovietica, reduce
da oltre mezzo secolo
di lavaggio del cervello
sui valori collettivi,
quel concetto era dato
per morto.
Così negli anni Novanta
e Duemila, la capitale russa
si era presa la sbornia
opposta, trasformandosi
in uno spaventoso
monumento all’egoismo
e alla ferocia urbana.
Le strade gigantesche
del comunismo si erano
riempite di aggressivi
fuoristrada dai vetri
oscurati, di commercio
abusivo e di crimine
e corruzione a ogni livello.
L’istituto Strelka è
arrivato nel 2009 con
l’obiettivo di riconsegnare
la capitale russa a una
nuova dimensione di
vivibilità, condivisione dello
spazio pubblico e spirito
cosmopolita. La definizione
ufficiale è quella di istituto
di ricerca multidisciplinare,
ospitato in un’ex fabbrica
di cioccolato su un’isola
fluviale nel cuore della
metropoli. Ma per
i moscoviti il nome Strelka
evoca soprattutto uno
spazio di straordinario
successo, culturale
e mondano. Sin dalla
sua apertura, Strelka ha
organizzato centinaia
di conferenze e incontri,
gratis e senza selezione
all’ingresso (scelte
rivoluzionarie, al tempo),
da cui è transitato il gotha
del mondo del progetto.
In parallelo, il bar
dell’istituto è diventato
uno dei locali più alla
moda, anche grazie al suo
spettacolare affaccio sulla
Moscova, che quando
non è trasformata in una
distesa di ghiaccio è
attraversata da assurde
navi-discoteche.
L’attività didattica, gestita
per qualche anno dallo
studio d’architettura Oma
di Rem Koolhaas e oggi
centrata su un programma
che indaga i legami
tra tecnologie digitali
e condizione urbana,
consiste di un master
annuale in inglese, con una
quarantina di studenti che
arrivano da tutto il mondo.
Architetti e designer
lavorano insieme
a programmatori,
giornalisti, sociologi, artisti,
geografi, economisti.
A sette anni dalla sua
nascita, si può dire che
Strelka sia riuscito nel suo
obiettivo di cambiare
il panorama fisico
e culturale delle città
russe? Per quanto la
nazione abbia preso, dal
2013 in poi, una direzione
politica conservatrice,
Mosca svela oggi un’anima
più accogliente che mai.
I casi di successo ci sono:
il parco Gorky, il museo
Garage, fino al futuro
parco Zaryadye dietro
al Cremlino. Sotto questi
e molti altri esempi (come
lo straordinario padiglione
Fair Enough alla Biennale
di Venezia del 2014)
c’è lo zampino, diretto
o indiretto, di Strelka.
La prossima avventura
è ancora più ambiziosa:
questa volta il focus si
allarga alle metropoli
instabili dei paesi in via
di sviluppo, includendo
anche Cina, Sudafrica,
India. Contesti lontani tra
loro ma pure con qualcosa
in comune: un dinamismo
che rende la vita in quei
luoghi allo stesso tempo
frenetica, difficile
e avventurosa.
C A T E G O R I A
S O C I E T À
L U O G O
M O S C A , R U S S I A
C O O R D I N A T E G P S
5 5 . 7 4 2 5 2 3 N , 3 7 . 6 0 9 1 1 6 E
L E Z I O N I D I A C C O G L I E N Z A

C A P I T O L O 2
E U R O P A
Q U A D R A N T E M A P P A
F5
P A R O L E C H I A V E
AZOTO, CUCINA MOLECOLARE, THE FAT DUCK
F I L I P P O P I V A
C O O R D I N A T E G P S
5 1 . 5 0 7 8 1 5 N , 0 . 7 0 1 8 0 7 O
A C E N A C O N L A M U S I C A
C A T E G O R I A
F O O D
L U O G O
B R A Y , R E G N O U N I T O
Gli ospiti del ristorante
The Fat Duck lo sanno
bene: nel locale di Bray,
a una cinquantina di
chilometri da Londra,
non si prenota soltanto
una cena, ma un viaggio
stravagante, fatto di piatti
accompagnati da auricolari
per la musica, caramelle
frizzanti, azoto liquido e
gelato con crostacei.
Dietro a un menù
composto da alcuni dei
piatti più divertenti che
il mondo culinario abbia
mai visto, c’è la mente
creativa di Heston
Blumenthal, riconosciuto
a livello internazionale
come uno dei principali
esponenti della cucina
molecolare. Nato nel
1966 nella contea del
Buckinghamshire,
Blumenthal arriva fino
alla terza stella Michelin
partendo da autodidatta:
un percorso lungo e
tortuoso, il suo, fatto
di lavoretti saltuari tra
i quali incastrare lezioni
di gastronomia e tentativi
ai fornelli. Poi l’incontro
con il libro che gli cambia
la vita, Il cibo e la cucina.
Scienza e cultura degli
alimenti di Harold McGee,
e l’apertura del suo locale
nel 1995. La location?
Un pub fatiscente che
lo chef rimette a nuovo
e ribattezza The Fat Duck,
l’anatra grassa. Il bistrot
inizia da subito a proporre
piatti sofisticati che
sembrano voler giocare
con la fisica e la tecnologia,
tutti improntati alla
multisensorialità.
La prima portata
a suscitare lo scalpore
della critica è un gelato
al granchio, servito con
un risotto ai crostacei.
Il responso dubbioso dei
clienti si trasforma in
ovazione, quando lo chef
decide di mettere in pratica
un piccolo trucchetto:
cambiare il nome alla
pietanza. Così il gelato
si trasforma sulla carta
in una bisque (brodo)
e conquista anche i palati
più difficili: un esempio
dello stretto legame
tra sensi e psicologia
che Blumenthal ha
ampiamente esplorato
durante la sua carriera.
Qualche anno più tardi,
nel 2004, lo chef crea
la Delizia di Cioccolato,
includendo nel dolce
minuscole caramelle
frizzanti e fornendo
a ogni cliente una coppia
di auricolari. Obiettivo:
far sentire a ogni boccone
il suono amplificato delle
piccole esplosioni di gusto
nella bocca.
Il rapporto tra sapori
e udito ritorna anche
in una delle sue creazioni
più celebri, il piatto Sound
of the Sea: tre pezzi di
sashimi serviti su un letto
di sabbia fatta con tapioca
e anguille fritte, ricoperti
di schiuma preparata con
brodo di alghe. Il tutto,
ovviamente, si gusta
mentre si ascoltano
i rumori del mare, le onde
che si infrangono contro
gli scogli e i gabbiani che
stridono in lontananza.
Dopo un trasferimento
temporaneo a Melbourne,
causa ristrutturazione
necessaria, The Fat Duck
riapre i battenti a Bray
alla fine dello scorso
anno, con una proposta
totalmente rinnovata.
Il menù si trasforma
quasi in un itinerario:
ogni piatto diventa un
appuntamento, una tappa
enogastronomica alla
scoperta del Paese delle
Meraviglie dei sapori.
A partire da un cocktail
in camicia, trasformato
in meringa ghiacciata con
l’ausilio dell’azoto liquido.

C A P I T O L O 2
E U R O P A
Q U A D R A N T E M A P P A
G6
V A L E R I O M I L L E F O G L I E
C A T E G O R I A
S O C I E T À
P A R O L E C H I A V E
A R C H I V I O , F O T O , L I B R I , W E B A N A L O G I C O
G O O G L E D I C A R TA
C O O R D I N A T E G P S
5 0 . 4 5 7 1 8 2 N , 3 . 9 5 6 7 1 5 E
L U O G O
M O N S , B E L G I O
Nel 1934 un biografo
belga di nome Paul Otlet
pubblica il Trattato di
documentazione.
La sua idea è questa:
ogni cosa creata dall’uomo
può essere archiviata
in appositi schedari.
Con Henri La Fontaine,
premio Nobel per la
pace nel 1913, immagina
un’immensa città archivio,
la Città Mondiale.
Già dal 1918, i due studiosi
raccolgono documenti
di ogni tipo e creano
12 milioni di schede,
classificate secondo uno
specifico sistema inventato
da Otlet. Questa mole
fisica d’informazioni trova
una prima sistemazione
a Bruxelles, in quello
che chiamano il Palazzo
Mondiale. Le foto
dell’epoca mostrano
ambienti in bianco e nero,
lunghi corridoi e sale in
cui altissimi schedari di
legno, austeri e imponenti,
raggiungono il soffitto,
togliendo la vista a ogni
finestra. In ogni scomparto
sono custoditi e classificati
scampoli di umanità:
siamo davanti al Repertorio
Bibliografico Universale.
Il Palazzo Mondiale viene
smantellato durante
l’occupazione tedesca
agli inizi degli anni
Quaranta per far posto
a un’esposizione sull’arte
del terzo Reich. Quello che
rimane oggi di ciò che è
stato ribattezzato il Google
de papier si trova a Mons,
a circa settanta chilometri
da Bruxelles, e prende
il nome di Mundaneum.
Un museo dove si può
trascorrere un’intera
giornata navigando sul
web analogico: mettendo
in fila tutti i documenti
si camminerebbe per
sei chilometri. Tre i temi
dominanti: pacifismo,
anarchia e femminismo.
Si potrebbe entrare la
mattina e cominciare
leggendo la posta, magari
la lettera della moglie
di Otlet all’architetto
Le Corbusier, che era
rimasto folgorato dal
progetto di archiviazione.
Poi si potrebbe continuare
guardando le foto della
riunione dell’esecutivo
del Consiglio
internazionale delle
donne nel 1913. Più tardi
si potrebbero leggere
i documenti del Congresso
universale della Pace di
Ginevra, concludendo
la visita sfogliando le
foto profilo di donne
americane del 1902.
Insomma, trovereste la
memoria di un bel pezzo
di umanità, archiviata
secondo la volontà dello
studioso belga. Paul Otlet
muore, sconosciuto ai
più, nel 1944. In una foto
dell’ultimo periodo di vita
è ritratto con le braccia
conserte in maniera
impacciata, la barba
lunga bianca, un paio
di occhialini tondi che
lo fanno lontanamente
somigliare a Freud.
L’epitaffio sulla sua lapide
recita: “Non sarebbe stato
nulla senza il Mundaneum”.
©MUNDANEUM-FÉDÉRATION WALLONIE/BRUXELLES

C O N N E C T E D W E L L N E S S : L A R I V O L U Z I O N E D I T E C H N O G Y M
-
Technogym App
Per vivere
un’esperienza di
wellness on the
go: tiene traccia
del movimento
giornaliero,
organizza gli
obiettivi, offre
programmi
personalizzati
e integra
l’allenamento in
palestra con quello
outdoor.
MyWellness
La prima
piattaforma
cloud aperta
del settore, che
mette in contatto
operatori e clienti.
Aiuta a preparare
l’allenamento,
monitora i progressi
e permette di
creare schede
personalizzate.
Unity
L’interfaccia
interattiva più
avanzata sul
mercato.
Il touchscreen
consente di
modificare e
organizzare in
maniera intuitiva
il programma
di allenamento,
unendo
motivazione e
divertimento.
MyRun
Il tapis roulant
interattivo
che migliora
la corsa, fornendo
continui feedback
all’utente.
Si integra con
il tablet e
seleziona le
migliori canzoni
dalla playlist in
base al ritmo
della corsa.
Il wellness ci accompagna in ogni momento della nostra vita, grazie all’ecosistema per il lifestyle management di Technogym, che sa
sfruttare al meglio l’innovazione tecnologica. L’azienda offre da sempre la più ampia gamma di attrezzi professionali per l’allenamento
in palestra, ma anche una serie di soluzioni di design per tenersi in forma a casa. Ora, grazie alla Technogym App e alla piattaforma cloud,
possiamo coordinare le nostre attività in qualsiasi istante della giornata e in ogni luogo: l’app permette di pianificare e gestire anche
l’allenamento outdoor, grazie al GPS e all’accelerometro dello smartphone. Inoltre ci segue in viaggio o al lavoro, fornendo consigli,
programmi e contenuti per l’esercizio, lo sport, l’alimentazione e la salute. Una vera e propria agenda del wellness, utile anche
quando andiamo dal medico, che può facilmente valutare il nostro stile vita.

T E C H N O G Y M V I L L A G E :I L C U O R E D E L L’ I N N O V A Z I O N E
-
La sede di un’azienda spesso ci racconta molto della filosofia e della mission di un brand.
Il Technogym Village è l’incarnazione del “Connected Wellness”, il luogo dove le idee più innovative
prendono vita e un punto di riferimento globale per il settore.
Ecco un breve tour alla scoperta del quartier generale di Technogym.
P E R T E C H N O G Y M
T-Wellness CentreTM
Un laboratorio progettato per testare prodotti e programmi e per formare esperti
nel campo del wellness.
T-Wellness Store & Showroom
Uno spazio in cui scoprire e provare i
prodotti Technogym, con la possibilità di
avere una consulenza professionale su
misura.
T-Wellness Science Centre
In questa struttura i più recenti
risultati scientifici si trasformano in
soluzioni concrete per il wellness.
T-Research & Development
In quest’area l’innovazione non si
ferma mai: Technogym cerca sempre di superare i limiti
attuali del design e dell’ergonomia dei
prodotti.
Technogym University
Offre corsi di formazione online e
offline, con l’obiettivo di condividere idee, progetti e scoperte
scientifiche.
T-Factory
Tutti i processi produttivi sono
concentrati qui per ottimizzare costi,
efficienza energetica, qualità e affidabilità
dei prodotti.
T-Wellness Garden
Un’area all’aperto dedicata ai
collaboratori, che possono praticare
i loro sport e le loro attività fisiche
preferite.
Ristorante T-Wellness
Offre un menù a base di prodotti locali,
dando importanza alla relazione tra attività
fisica e alimentazione.
www.technogym.com

timberland.it/sensorflex
Tim
be
rla
nd
, a
nd
Se
nso
rFle
x a
re t
rad
em
ark
s o
f T
BL
Lic
en
sin
g L
LC
. ©
20
16 T
BL
Lic
en
sin
g L
LC
. A
ll r
igh
ts r
ese
rve
d.


Deserto del Mojave
A M E R I C A
1
pag. 94
pag. 82
pag. 107
pag. 102
pag. 108
pag. 104
pag. 109
pag. 105
pag. 110
pag. 106
pag. 111
pag. 112
Key Largo
Foresta Amazzonica
North Las Vegas
Rio de Janeiro
Arizona
Palo Alto
New York
Boston
Toronto
Mauna Loa
Altos de Cazucá
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2



8 3
82

R I F L E S S I S O L A R I
L U O G O
D E S E R T O D E L M O J AV E, U S A
C O O R D I N A T E G P S
3 5.5 6 2 2 5 4 N, 1 1 5.4 7 2 9 0 8 O
F O T O D I
J A M E Y S T I L L I N G S
P A R O L E C H I A V E
4 0 0 M E G A W AT T, E L I O S TAT I, S P E C C H I
C A P I T O L O 3
A M E R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
G 2

Mai visto nulla di simile. La centrale termica a concentrazione solare
più grande del mondo − l’Ivanpah Solar Electric Generating System −
è a 65 chilometri da Las Vegas, nell’area più rovente del deserto del
Mojave. Occupa 14 km quadrati, è composta da 173.500 eliostati con
347mila specchi che seguono il Sole e ne riflettono i raggi su tre enormi
caldaie poste in cima ad altrettante torri alte 140 metri. Produce qua-
si 400 megawatt di energia (cioè soddisfa i bisogni di 140mila case) e
risparmia alla Terra 400mila tonnellate di anidride carbonica. Di pro-
prietà di BrightSource, Bechtel e Google, è costata circa 2,2 miliardi di
dollari. Il fotografo americano Jamey Stillings le ha dedicato due pro-
getti, Evolution of Ivanpah Solar I e II, in cui documenta la costruzione
e lo sviluppo della centrale dal 2010 a oggi.
M


8 7
8 6


8 9
8 8


9 1
9 0


9 3
9 2


9 5
9 4
LUOGO
KEY LARGO, FLORIDA, USA
COORDINATE GPS
24.950118 N, 80.453422 O
CAPITOLO 3
AMERICA
QUADRANTE MAPPA
K3

RACCOLTO DA
ANDREA GENTILE
FOTO PER GENTILE CONCESSIONE DI
NASA
TESTO DI
LUCA PARMITANO

9 7
9 6
AL LARGO DELLA FLORIDA
C’È UN LABORATORIO
DI RICERCA ANCORATO
AL FONDALE MARINO.
PER 14 GIORNI È
DIVENTATO LA PALESTRA
DELL’ASTRONAUTA
DELL’AGENZIA SPAZIALE
EUROPEA LUCA PARMITANO
E DEI SUOI COLLEGHI.
OBIETTIVO: PREPARARSI
A UN FUTURO STELLARE
QU
I S
OT
TO
(E
NE
LL
E P
AG
INE
PR
EC
ED
EN
TI)
,
LU
CA
PA
RM
ITA
NO
, A
ST
RO
NA
UT
A I
TA
LIA
NO
CH
E N
EL
20
13 H
A P
AS
SA
TO
6 M
ES
I N
EL
LO
SP
AZ
IO,
È I
L P
RIM
O A
SIN
IST
RA
E P
OS
A
INS
IEM
E A
GL
I A
CQ
UA
NA
UT
I D
EL
LA
MIS
SIO
NE
NE
EM
O 2
0:
SE
RE
NA
AU
ÑÓ
N,
DA
VID
CO
AN
E N
OR
ISH
IGE
KA
NA
I
L’A C Q U A R I O S P A Z I A L E

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
quasi dieci chilometri dalla costa di Key Largo, in Florida, quattro acquanauti pron-
ti all’immersione galleggiano vicino alla barca di supporto dentro alle mute bianche.
Insieme a me, ci sono altri due astronauti, Serena Auñón dell’Agenzia spaziale sta-
tunitense e Norishige Kanai di quella giapponese. Ad accompagnarci nell’avventura
anche un ingegnere, David Coan, esperto di attività extraveicolare (Eva) per la Nasa.
Attendono il mio segnale per scendere in profondità. Faccio loro un cenno e mi immer-
go, fermandomi dopo qualche metro, per controllare che tutti stiano procedendo senza difficoltà. La
visibilità non è ottima ma riesco a intuire il laboratorio sottomarino, un’informe massa giallastra.
Ecco come è cominciata, il 20 luglio 2015, la ventesima missione del programma Nasa Extreme Envi-
ronment Mission Operations, più conosciuta come Neemo 20.
È un ambiente che la Nasa conosce bene: da oltre 15 anni gli astronauti si immergono nelle ac-
que a largo delle isole Keys per testare nuove apparecchiature ideate per lo spazio, simulare ambienti
estremi e addestrarsi in condizione di assenza di peso. Per 14 giorni l’Aquarius Reef Base, un labora-
torio di ricerca gestito dalla Florida International University e ancorato sul fondale marino a dician-
nove metri di profondità, è diventato la nostra casa. L’Aquarius è un grande cilindro di tre metri di
diametro, lungo 14 metri e diviso in più compartimenti. L’entrata all’habitat avviene dal wet porch,
un compartimento pressurizzato che non fa parte della struttura ma è un cubo bullonato al cilindro
principale, una specie di camera stagna che funziona da ingresso e uscita. Lì ci sono i nostri caschi e
le mute, l’equivalente delle tute spaziali, da indossare prima di immergerci attraversando l’apertura
posta sul pavimento. Il wet porch non è ventilato e la sua temperatura dipende da quella dell’Oceano:
a luglio fa un caldo tropicale e l’umidità sfiora il 100%.
Da lì si passa all’entry lock, la prima sezione del cilindro principale della base, dove per for-
tuna abbiamo ventilazione e aria condizionata. Le pareti curve e gli oblò spessissimi ci ricordano
all’istante dove ci troviamo: a diversi metri di profondità. È qui che hanno installato la stazione di
comunicazione radio e i computer per tenerci in contatto con la superficie, oltre al necessario per
fare esperimenti e controllare il funzionamento della base. Superata una porta a tenuta stagna, ecco
invece il main dock, il cuore dell’Aquarius: ci sono un tavolo, diventato subito il punto di raccolta
dell’equipaggio, un lavello con l’acqua calda per preparare il cibo liofilizzato, la cambusa, un frigo. E
un enorme, ipnotico oblò che si apre sul mondo sottomarino. Attraverso una tenda si passa nell’ulti-
mo compartimento, la sleep zone, che contiene sei minuscoli letti. Grandi (o piuttosto piccoli) come
quelli del vagone letto di un vecchio treno notturno.
La struttura della base Aquarius ricorda molto le stazioni spaziali russe degli anni Settanta
e Ottanta, come la Salyut o i primi componenti della Mir. In effetti sono molti gli aspetti della vita
sottomarina che fanno pensare a quella in orbita, tanto che la Stazione spaziale internazionale (Iss)
e l’Aquarius Reef Base vengono considerati “analoghi” dalla Nasa: tra loro sono molto diversi, ma le
somiglianze consentono di migliorare l’addestramento degli astronauti come me. Per questo motivo
andiamo sott’acqua con le spedizioni Neemo.
La tipica giornata nella base Aquarius comincia con un primo contatto remoto: in realtà, noi
non parliamo direttamente con i nostri controllori che stanno all’asciutto, ma simuliamo di essere
a venti minuti di distanza radio dal centro di controllo. È come se noi acquanauti fossimo su Marte,
e il controllo fosse invece qui, sulla Terra. Nei messaggi registrati ci vengono descritti i compiti di
giornata e le eventuali variazioni al programma. Dopo la colazione, comincia la fase di lavoro vero
e proprio: due membri dell’equipaggio si preparano alle escursioni sottomarine esterne alla base
A

C A P. 3 / A M E R IC A
9 9
9 8
L
(Eva), mentre gli altri due hanno un ruolo di supporto, leggono le procedure agli acquanauti in im-
mersione, gestiscono le comunicazioni con il Mission Control Center e pilotano il minisottomarino.
Oppure svolgono una serie di esperimenti all’interno della base. Le Eva ci impegnano fino al primo
pomeriggio; tra vestizione e svestizione occupano un totale di circa sei ore. Il resto della giornata è
dedicato al debriefing: parliamo dell’esecuzione dei vari compiti, commentiamo l’efficacia degli stru-
menti su cui abbiamo lavorato all’esterno e ci prepariamo alla giornata successiva e a una nuova at-
tività extraveicolare.
a più grande differenza tra il lavoro in orbita e quello nell’Aquarius riguarda il peso: a
bordo della Iss gli astronauti sono liberi dagli effetti gravitazionali, dentro e fuori dal-
la stazione. Stare in assenza di peso significa aggiungere una dimensione al normale
modo di vivere e cambiare la nostra abituale prospettiva: il fatto di potersi spostare in
tutte le direzioni ti fa vedere il mondo in modo diverso. Questo fattore manca all’inter-
no di Aquarius, un ambiente puramente gravitazionale: abbiamo un pavimento, delle
pareti, spazi molto ristretti che sfruttiamo seguendo le nostre abitudini. Eppure uscendo dalla base
sottomarina tutto cambia, perché possiamo riprodurre una gravità parziale o una microgravità.
Durante le immersioni non è come essere in orbita ma allo stesso tempo l’esperienza è molto
diversa dalle esercitazioni nel Neutral Buoyancy Lab di Houston, la grande piscina dove gli astronau-
ti si allenano con l’assenza di peso. Gestire il proprio corpo in tale situazione non è affatto sempli-
ce; soprattutto perché molti degli attrezzi di lavoro, agganciati a un’imbracatura con moschettoni,
non sono stati progettati per essere usati nelle profondità marine. Eppure uscire dall’Aquarius per le
esercitazioni può aiutarci a simulare le attività sulla superficie di vari corpi celesti, a sperimentare
come spostarci, ancorarci e lavorare su di essi.
Nel secondo giorno di missione, per esempio, abbiamo fatto finta di trovarci su un asteroide
posizionato da un’ipotetica missione robotica in orbita cislunare (che è al di qua della Luna, rispetto
alla Terra, quindi praticamente senza ritardi nelle comunicazioni). Un asteroide è un ambiente in mi-
crogravità, senza appigli naturali da usare per esplorare la superficie. Per facilitare la ricognizione,
quindi, saranno necessari strumenti che non esistono ancora. Bisogna inventarli e, una volta creati,
servono test per capire come modificarli perché funzionino al meglio.
Qui entrano in gioco gli acquanauti. Approfittando dell’ambiente sottomarino, abbiamo prova-
to a raccogliere campioni di suolo e rocce in assenza di peso, sfruttando prima un mini braccio robo-
tico, poi un body restraint tether (un arto articolato simile a quello delle tute spaziali Emu della Nasa)
e infine il Microspine, uno strumento inventato per aggrapparsi alle rocce e rimanere fermi. Per i
campionamenti abbiamo usato altri apparecchi ancora, creati apposta e mai sperimentati prima.
Microspine, per esempio, era stato pensato per ancorare dei piccoli oggetti ma abbiamo verifi-
cato che non è in grado di resistere alle forze generate da un uomo adulto: durante l’esercitazione, s’è
staccato all’improvviso (mentre io ero ancora agganciato). Se fossi stato nello spazio, su un asteroide,
mi sarei perso in modo irrecuperabile: cioè l’incubo peggiore di chi fa il mio mestiere. Ecco perché
sperimentiamo, proviamo e riproviamo.
Per questo l’Aquarius Reef Base è così importante. Si tratta dell’unico habitat sottomarino
permanente che esista al mondo. Realizzato nel 1993, è utilizzato dalla Nasa per le missioni di adde-


C A P. 3 / A M E R IC A
1 0 1
10 0
stramento in ambienti estremi dal 2001. Ma non è utile solo agli astronauti. Trovandosi nel mezzo
del Florida Keys National Marine Sanctuary, infatti, è una base sempre attiva per studiare la salute
dell’ambiente marino. Ricercatori e acquanauti possono rimanere in profondità anche per un mese:
l’Aquarius, infatti, ha un’enorme boa di supporto che pompa aria e riscaldamento sott’acqua, permet-
tendo inoltre collegamenti internet, radio e telefonici.
È il vantaggio di trovarsi sulla Terra, perché in orbita tutto deve essere contenuto all’interno
della Stazione spaziale: riserve di acqua, di aria, sistemi di miscelazione, quelli per eliminare l’ani-
dride carbonica… Dentro Aquarius, invece, possiamo avere tutta l’aria che vogliamo, perché viene
pompata dalla superficie. Dobbiamo solo preoccuparci di eliminare l’eccesso di anidride carbonica,
grazie ai filtri ad assorbimento che poi vengono regolarmente sostituiti.
a non è solo questa la ragione che rende l’Aquarius così importante. Tutte le volte che
ci immergiamo sott’acqua, infatti, andiamo incontro alla saturazione dell’azoto, un
gas contenuto nell’aria che respiriamo e che di solito non ci dà alcun problema. A causa
della maggiore pressione subacquea, però, questo gas si dissolve nel sangue e nei tes-
suti, pronto a trasformarsi in bollicine nel momento della risalita. Come all’apertura
di una bottiglia di acqua frizzante, queste bolle si espandono nel corpo umano quando
la pressione diminuisce, con il rischio di embolie molto dolorose o addirittura mortali. Per passare
molto tempo sott’acqua, quindi, durante la risalita si devono prendere precauzioni allungando enor-
memente i tempi di ritorno in superficie.
Per questo motivo i subacquei di solito portano con sé tabelle che indicano esattamente quanto
devono impiegare a risalire, a seconda della profondità e del tempo trascorso. Aquarius, invece, per-
mette di rimanere in immersione e tornare all’asciutto restando alla stessa profondità ed evitando
tutte queste limitazioni. L’unica accortezza che dobbiamo avere è una lunga decompressione di circa
17 ore l’ultimo giorno, così da eliminare tutto l’azoto con l’espirazione prima di risalire.
È proprio ciò facciamo l’ultimo giorno della missione Neemo 20, il 2 agosto, al termine della no-
stra avventura sottomarina. E l’ultima sera, prima di risalire, ho voluto lasciare il mio saluto a questo
straordinario ambiente, scrivendo queste parole: «Siamo venuti qui nell’Aquarius per studiare il fu-
turo, per cambiarlo, per migliorarlo. Con mente e cuore aperti, pronti a essere trasformati dall’espe-
rienza. Siamo arrivati da stranieri, viandanti temporanei, costretti ogni sera nel nostro rifugio me-
tallico. Ma le mute che ci ricoprono non sono riuscite a tenere lontana la salsedine dalla nostra pelle.
L’acqua che ci circonda non è dissimile da quella che anima le nostre cellule, dove la chimica
della vita si rigenera e si annienta. Persino i nostri pensieri nuotano da un neurone all’altro, attraver-
so gli elettroliti sciolti nell’acqua in cui sono immersi. Il liquido amniotico dove nuotiamo nell’oscu-
rità dei primi mesi del nostro viaggio terreno altro non è che un nostro personalissimo mare, di cui
ricordiamo per sempre il respiro, il battito, il calore. Il mare scorre nelle nostre vene, il nostro cuore
batte al ritmo delle sue onde. Siamo venuti qui, nel mare, ma dal mare non siamo mai andati via».
© ESA/Luca Parmitano
PA
RM
ITA
NO
, C
ON
IL
NU
ME
RO
2 S
UL
CA
SC
O E
IL
TR
ICO
LO
RE
SU
LL
A S
PA
LL
A,
MO
NT
A I
L B
RA
CC
IO M
EC
CA
NIC
O A
CU
I
SI
AG
GA
NC
IAN
O G
LI
AS
TR
ON
AU
TI
IN M
ISS
ION
E A
LL
’ES
TE
RN
O
M

©JÜRGEN KESSELMEIER

C A P I T O L O 3
A M E R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
N7
3 2 5 M E T R I S O P R A L A F O R E S TA
P A R O L E C H I A V E
C I C L O D E L L ’ A C Q U A , E F F E T T O S E R R A , M E T E O R O L O G I A
L U O G O
F O R E S T A A M A Z Z O N I C A , B R A S I L E
G I A N L U C A D O T T I
Più alta della torre Eiffel
ma costruita nel cuore
della foresta amazzonica,
tra serpenti, giaguari e
alberi giganti, la torre
climatica del progetto
Atto (Amazon Tall Tower
Observatory) è stata
concepita per tenere sotto
controllo i cambiamenti
chimici dell’atmosfera
in uno dei luoghi più
inaccessibili del pianeta
e meno contaminati
dall’attività umana.
Non poteva esserci
collocazione migliore che
al centro del polmone
terrestre, dove viene
prodotta più della metà
dell’ossigeno mondiale
e dove possono essere
studiati direttamente
il trasporto delle masse
d’aria, la formazione delle
nubi, la stratificazione
dell’atmosfera, il ciclo
dell’acqua e i cambiamenti
climatici. Letteralmente
da una prospettiva nuova
e unica al mondo.
Inaugurata nell’agosto
del 2015 dopo un anno di
lavori, la torre con il suo
imponente telaio metallico
svetta nel cielo sopra
la giungla e sostituisce
le vecchie torrette alte
appena 80 metri, che in tre
anni avevano permesso
le indagini preliminari.
Con i suoi 325 metri di
altezza, è la costruzione
più alta di tutto il Sud
America ed è in grado
di captare il respiro della
foresta, raccogliendo dati
su gas serra, sostanze
inquinanti e condizioni
meteo su un’area di cento
chilometri quadrati di
foresta pluviale tropicale.
La base della nuova
costruzione è quadrata
con lati di appena tre
metri, è sorretta da 26
chilometri di cavi d’acciaio
e ha installati decine di
sensori all’avanguardia per
misurare con precisione le
concentrazioni di metano,
ossidi di azoto e anidride
carbonica. L’impianto di
raccolta dati registra anche
la temperatura del suolo
e della foresta, la
luminosità, i venti in
quota e i profili di umidità
dell’aria, a dimostrazione
dell’enorme quantità di
informazioni necessarie
per migliorare i modelli
di evoluzione climatica.
A gestire il progetto,
nato nel 2009, è una
collaborazione tra Brasile
e Germania, che hanno
anche equamente diviso
l’investimento di circa
otto milioni di euro.
Ricercatori dell’università
di Manaus e dell’Istituto
nazionale brasiliano per la
ricerca amazzonica (Inpa)
affrontano spedizioni
nella foresta alla Indiana
Jones e le altezze dei
1500 elementi metallici
prefabbricati della torre,
insieme ai colleghi
tedeschi degli istituti Max
Planck per la chimica
e la meteorologia. Gli
stessi che ormai da dieci
anni studiano il clima
anche da un altro punto
di vista estremo: quello
della taiga siberiana.
Alla base delle analisi
c’è la necessità di
comprendere più a fondo
quei meccanismi che solo
nell’ultimo decennio hanno
portato il Brasile a dover
fare i conti con due pesanti
inondazioni e altrettante
gravi siccità, responsabili
di un perenne stato di
emergenza che
ha coinvolto oltre
300mila persone.
È però un progetto di
interesse mondiale, che
affronta concretamente
il problema globale del
cambiamento climatico
indotto dall’attività umana,
e che tocca temi come
la deforestazione, la
biodiversità e il rilascio
di grandi quantità
di energia da parte
dell’atmosfera, tramite
eventi meteorologici
sempre più violenti.
C O O R D I N A T E G P S
2 . 1 4 6 0 0 1 S , 5 9 . 0 0 5 6 5 0 O
C A T E G O R I A
A M B I E N T E

C A P I T O L O 3
A M E R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
F2
M A R C O C O S E N Z A
C A T E G O R I A
T R A S P O R T I
P A R O L E C H I A V E
E L O N M U S K , H Y P E R L O O P , S U P E R S U O N O
Elon Musk è una specie
di re Mida della tecnologia:
ovunque metta mano,
da PayPal a Tesla,
fino a SpaceX, sgorga
innovazione. Anche nel
deserto, non ultimo quello
del Nevada, dove una
startup californiana (Ht),
ispirata dalle idee del
magnate sudafricano,
ha deciso di posare le
fondamenta, o meglio
i tubi, della sua ultima
trovata: Hyperloop.
È un treno supersonico,
privo di rotaie, che
promette di collegare
San Francisco e Los
Angeles (o Roma e Milano
se preferite) in soli 30
minuti. I 600 chilometri
che le separano verrebbero
percorsi nella metà del
tempo di un volo aereo,
bypassando tra l’altro il
problema del traffico, degli
scali lontani dal centro
o dei costi (8 miliardi di
dollari quelli previsti per
la tratta, solo 20 per il
prezzo del biglietto).
Come è possibile?
Attraverso un tubo
“sottovuoto” in cui capsule
a levitazione magnetica
da 6-8 passeggeri partono
ogni 30 secondi e vengono
sparate a destinazione
come proiettili. La velocità
massima attesa è di 1200
km/h e la sensazione
quella di sentirsi su un’auto
più che sulle montagne
russe, assicurano i
progettisti. Il sistema
funziona grazie a pannelli
fotovoltaici incaricati
di raccogliere energia
lungo tutto il percorso,
il resto lo fa la mancanza
di attrito. La struttura
si reggerebbe inoltre
su pilastri antisismici
oppure potrebbe correre
sottoterra, riducendo
i problemi di sicurezza
e minimizzando l’impatto
in termini di traffico e
occupazione del suolo.
Convinta del potenziale
rivoluzionario per i
trasporti di domani è anche
un’altra compagnia (Htt),
che sta sperimentando la
tecnologia a Quay Valley,
a nord di Los Angeles.
Il loro prototipo, 8
chilometri di pista in scala
naturale costruita lungo
l’autostrada I5, sarà pronto
nel giro di 3 anni. Nel 2020,
Hyperloop potrebbe quindi
tramutarsi da visione
in realtà, cambiando
per sempre i concetti di
pendolarismo, mobilità
e urbanizzazione. Ne è
convinto il vicepresidente
della società, l’italiano
Gabriele “Bibop” Gresta,
così come lo sono gli
studenti di ingegneria di
Pisa che hanno preso parte
alla SpaceX Hyperloop Pod
Competition, il concorso
indetto per la realizzazione
del design delle capsule.
Tra oltre mille partecipanti,
il progetto della Scuola
superiore Sant’Anna è
entrato in finale, sostenuto
da super-sospensioni
attive capaci di adattarsi
al tracciato: un aspetto
fondamentale, viste le
velocità vertiginose.
Intanto l’area di test
in Nevada punta al
collaudo su un tracciato
di 5 chilometri all’interno
dell’Apex Industrial Center,
15 miglia a nord-est di
Las Vegas, già entro fine
anno, per raggiungere poi
la piena operatività nel
2017. C’è chi lo definisce
un azzardo, ma esiste
forse luogo migliore della
capitale dei casinò per
smentire gli scettici?
L U O G O
N O R T H L A S V E G A S , U S A
C O O R D I N A T E G P S
3 6 . 2 4 5 0 2 1 N , 1 1 5 . 0 7 2 4 1 7 O
I L T R E N O S O T T O V U O T O
©HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES

C A P I T O L O 3
A M E R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
P10
C O O R D I N A T E G P S
2 2 . 9 0 8 2 5 3 S , 4 3 . 2 1 9 6 1 0 O
P A R O L E C H I A V E
L A B O R A T O R I O A N T I D O P I N G , O L I M P I A D I , W A D A
C A T E G O R I A
S P O R T
L U O G O
R I O D E J A N E I R O , B R A S I L E
G I O C A R E P U L I T O
G A B R I E L E L I P P I
Stadi, palazzi dello sport,
piscine olimpiche. La corsa
del Brasile ai giochi di Rio
2016 è stata caratterizzata
da una lunga lista di
impianti da realizzare.
Ma tra arene da 60mila
posti e infrastrutture, una
delle sfide più impegnative
riguarda un edificio che
pochi turisti vedranno ma
che sarà fondamentale per
la riuscita dell’Olimpiade.
Il laboratorio antidoping
di Rio de Janeiro − nella
cittadella dell’università
federale sull’isola artificiale
di Fundão, a due passi
dall’aeroporto Galeão −
è costato 30 milioni di euro
ed è il fiore all’occhiello
della candidatura
brasiliana ai Giochi.
Realizzarlo in modo
che soddisfacesse tutti
gli standard fissati dalla
Wada (World Anti Doping
Agency) è stata una corsa
contro il tempo. Il vecchio
centro analisi della città
brasiliana, ormai non più
in grado di sostenere i
nuovi controllie e privo
dei fondi per aggiungere
personale e attrezzature,
ha perso l’accreditamento
nel 2013: durante il
Mondiale di calcio del
2014, il Brasile ha dovuto
infatti spedire a Losanna,
in Svizzera, i campioni
prelevati agli atleti, perché
venissero testati.
Reggere un’Olimpiade
in quel modo sarebbe
stato impensabile. Così
il governo ha deciso di
dar fondo alla cassa e
costruire un nuovo centro
in grado di competere
con i migliori al mondo.
Lo staff è stato ampliato
e conta un centinaio
di impiegati, le
apparecchiature sono
state aggiornate e,
dopo un periodo di
assestamento di nove
mesi, a maggio 2015
è arrivato l’accreditamento
da parte della Wada.
Ma non basta. Durante
i Giochi occorrerà eseguire
almeno sei mila diversi
test per identificare
dieci classi di sostanze
proibite: il lavoro di un anno
concentrato in 20 giorni.
Quindi serve un ulteriore
sforzo: il personale sarà
rafforzato da 60 volontari
brasiliani addestrati e da
100 specialisti di calibro
internazionale, tra cui
anche dieci italiani richiesti
dal comitato organizzatore
alla nostra Federazione
medico sportiva.
Dopo lo scandalo che
ha coinvolto l’atletica
russa, oltre ai sospetti
su Francia e Spagna
sollevati dalla Wada,
i fari saranno puntati
ancora di più sui risultati
dei test di Rio 2016.
Pass di sicurezza e
controlli biometrici
agli accessi serviranno
a evitare il rischio di
intrusione da parte
di esterni, mentre sono
stati varati nuovi test per
intercettare i casi di doping
del sangue come auto
ed etero emotrasfusioni.
Riuscirà Rio de Janeiro a
vincere la sua sfida pulita?
GENTILE CONCESSIONE DEL MINISTERO DELLO SPORT BRASILIANO

C A P I T O L O 3
A M E R I C A
P A R O L E C H I A V E
A R C O L O G I A , A R C O S A N T I , G E O R G E L U C A S , P A O L O S O L E R I
Immaginate l’utopia di
una città interamente
autosostenuta, creata per
avere il minore impatto
possibile sulle risorse del
pianeta e ospitare 5mila
persone su circa 350 ettari
di deserto sovrastati da
edifici che sembra siano
stati partoriti dal più
visionario dei romanzi di
fantascienza. Immaginate
una città avveniristica,
costruita dalla comunità
che la abita e che essa a
sua volta nutre e riscalda
grazie a un’intricata rete
di riciclaggio energetico.
Ecco, quella città esiste.
È Arcosanti, esperimento
dell’architetto torinese
Paolo Soleri − il cui illustre
mentore era stato Frank
Lloyd Wright − che non
si è limitato a coniare il
concetto di “arcologia”
(una crasi tra architettura
ed ecologia) ma è anche
riuscito a trasformarlo
in realtà. Una realtà
imperfetta, certo, però
funzionale e funzionante.
Fondata negli anni ‘70
e rimasta incompiuta
(fatta eccezione per
alcune abitazioni, un
anfiteatro, una panetteria,
una caffetteria, una
piscina e una fonderia
dedicata alla creazione
di campane di bronzo),
Arcosanti rappresenta
un’avanguardia vittima
della sua stessa ambizione.
Una vittima, tuttavia, che
non si lascia macinare
da condizioni così
difficili e resta straniante
per chiunque desideri
sperimentare lo stile di vita
frugale che essa impone.
Perché è vero che, nel
2016, l’arcologia è abitata
da soli sessanta ricercatori
e sognatori (assai meno
di quanto sognava Soleri,
scomparso tre anni fa);
ma è anche vero che quella
presenza nel selvaggio
deserto di Sonora è stata
sufficiente affinché
George Lucas, regista
e creatore della saga
Star Wars, con una delle
sue intuizioni immaginasse
due dei luoghi popolati
dai cittadini del suo
universo mitologico: il
pianeta Tatooine dove
sono cresciuti Anakin e
Luke Skywalker (visti negli
episodi I e IV della serie)
e la luna di Endor, che
avrebbe fatto da casa
ai pelosi guerrieri Ewok.
C O O R D I N A T E G P S
3 4 . 3 4 3 1 0 9 N , 1 1 2 . 1 0 2 5 7 5 O
C A T E G O R I A
C I N E M A
L U O G O
A R I Z O N A , U S A
U N S O G N O I TA L I A N O N E L D E S E R T O D I S TA R W A R S

C A P I T O L O 3
A M E R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
F2
Q U A D R A N T E M A P P A
G3
P A R O L E C H I A V E
J E F F B E Z O S , P I Z Z E R I A , M A R K Z U C K E R B E R G
C A T E G O R I A
F O O D
C O O R D I N A T E G P S
3 7 . 4 2 6 0 6 5 S , 1 2 2 . 1 4 5 5 0 7 O
L U O G O
P A L O A L T O , U S A
F I L I P P O P I V A
«Se apri un ristorante a Los
Angeles, è facile che entri
qualche attore famoso.
Nella Silicon Valley è lo
stesso ma le star sono
dell’hi-tech: magari capita
un cliente che ti dice di
aver appena inaugurato
una startup e nel giro di
qualche mese lo ritrovi su
Forbes». A parlare è Maico
Campilongo, imprenditore
Made in Calabria che ha
portato a Palo Alto la vera
pizza napoletana.
Con il fratello Franco e il
socio Kristyan D’Angelo,
è il proprietario di Terún,
rifugio per tecnoleggende
in crisi d’astinenza da
mozzarella e pomodoro.
«Prima facevo il cameriere
al Caffè del Doge, un locale
di Palo Alto. Tra i colleghi
c’era un ragazzo gentile,
gran lavoratore ma con la
testa sempre fra le nuvole:
si chiamava Kevin Systrom,
nel 2010 ha fondato
Instagram». Maico intanto
apre Terún e inizia a servire
al gotha della Silicon Valley
la migliore pizza della
zona. «Una volta è passato
Mark Zuckerberg, che di
solito preferisce un vicino
ristorante messicano:
ama più i tacos della
pizza», ride Campilongo.
«È venuto anche il
co-fondatore di Google
Larry Page, amico di una
nostra cliente: adora
la pizza napoletana».
L’album del locale è una
raccolta di aneddoti sugli
imprenditori informatici
più celebri del mondo.
«Anche Jeff Bezos,
il fondatore di Amazon,
ha mangiato qui.
Non l’avevo riconosciuto,
gli ho solo chiesto se era
un fan della bicicletta».
Poi gli italiani dell’hi-tech,
che hanno lasciato cuore
e palato al paese. Come
Pierluigi Zappacosta,
uno dei fondatori di
Logitech; o Federico
Faggin, capoprogetto
dell’Intel 4004, il primo
microprocessore della
storia. «Quando Federico
parla dei suoi progetti
è illuminante. Beve un
espresso e ti spiega
perché un computer
non potrà sostituire
l’uomo. Sembra banale:
ma se a dirlo è l’inventore
del microprocessore,
vi assicuro che assume
tutto un altro spessore».
L’ I N N O VA Z I O N E È U N A P I Z Z A
M A R I N A P I E R R I
Basta dare un’occhiata ai
suoi grandi archi, del resto,
per restarne affascinati
e voler trascorrere almeno
qualche giorno in una
delle case (i prezzi vanno
dai 50 ai 100 dollari
a notte) che guardano
le distese sconfinate
di sabbia e cactus, in
modo da vivere la magia
extraterrestre del luogo.
E avere la sensazione
che forse, con il passare
del tempo e il progredire
della scienza applicata
a tecniche sostenibili
− al momento i cittadini
di Arcosanti sono costretti
a ricevere provviste da
un supermercato, per
esempio − il sogno di
Soleri e dei suoi seguaci
potrebbe ancora
concretizzarsi.

C A P I T O L O 3
A M E R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
L2
N I C H O L A S D A V I D A L T E A
P A R O L E C H I A V E
A R T E , C I B E R N E T I C A , N E I L H A R B I S S O N , M U L T I S E N S O R I
I L C I R C O L O D E I C Y B O R G
C O O R D I N A T E G P S
4 0 . 7 4 7 3 2 0 N , 7 3 . 9 8 8 1 8 4 O
C A T E G O R I A
S O C I E T À
L U O G O
N E W Y O R K , U S A
L’uomo da sempre cerca
di spingersi oltre i propri
limiti fisici, di superarli
migliorando le prestazioni
e raggiungendo nuovi
obiettivi. È il caso della
Cyborg Foundation.
Perché l’organizzazione
no-profit nasce proprio
da un limite, o meglio,
dal deficit che affligge il
fondatore Neil Harbisson,
da quando a 11 anni gli
è stata diagnosticata
l’acromatopsia. Questa
totale incapacità di vedere
i colori e di guardare
il mondo in bianco e
nero (e in tutte le possibili
scale di grigio) per 21 anni
gli ha reso la vita meno
piacevole di quella degli
altri. Ma ha anche spinto
l’artista, nato a Belfast ma
spagnolo d’adozione,
a sviluppare un modo
per esaltare le proprie
doti da compositore,
pittore e fotografo.
L’incontro con Adam
Montandon nell’ottobre
del 2003 a una conferenza
sulla cibernetica al
Dartington College of
Arts di Dublino, è stato
l’inizio della creazione e
della sperimentazione
dell’eyeborg: l’antenna
dotata di occhio
elettronico, montata
sulla testa di Neil per
captare i colori, convertire
ciascuno in un suono
diverso e ben riconoscibile,
e inviarli al suo cervello
tramite la conduzione
ossea del cranio.
Dal 2004 in poi, questa
cibernetica estensione
sensoriale è stata
perfezionata. Nel 2007,
con l’aiuto del
programmatore sloveno
Peter Kese, è migliorato
il riconoscimento anche
delle tonalità. Poi, nel
2009, Matias Lizana,
uno studente spagnolo,
è riuscito a diminuirne
l’ingombro, riducendo il
congegno a un semplice
chip in grado persino di
percepire un’ampia fascia
di colori invisibili all’occhio
umano, dall’infrarosso
all’ultravioletto.
Dopo i primi mesi, quando
il software e il cervello
erano ormai perfettamente
sintonizzati, l’apparecchio
è diventato parte del suo
corpo, non più semplice
estensione dei sensi.
In quel momento Neil
Harbisson si è sentito a
tutti gli effetti un cyborg
(è riuscito anche a ottenere
un passaporto con una foto
in cui indossa l’eyeborg).
Insieme alla coreografa
e attivista cyborg Moon
Ribas, nel 2010 ha fondato
la Cyborg Foundation con
sede al Tecnocampus,
parco scientifico di
Mataró, in provincia di
Barcellona (oggi è a New
York). L’obiettivo? Aiutare
le persone a diventare
cyborg ampliando i
propri sensi con questi
particolari dispositivi. C’è
poi un risvolto sociale non
indifferente: difendere
i diritti dei cyborg,
diffondendo sempre più
questo movimento artistico
e di ricerca tecnologica.
Non esiste solo l’eyeborg,
infatti è possibile cercare
di capire la velocità degli
oggetti con lo speedborg
e ristabilire la sensibilità
tattile con il fingerborg.
Insomma, L’uomo da sei
milioni di dollari non è solo
una vecchia serie tv.
©DAVID VINTINER/GETTYIMAGES

C A P I T O L O 3
A M E R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
L1
P A R O L E C H I A V E
C H A R L E S S T A R K D R A P E R , I N T E R D I S C I P L I N A R I T À , M I T
A L I C E P A C E
Proprio a due passi
dall’edificio centrale del
Massachusetts Institute of
Technology (Mit), negli anni
Trenta, il professor Charles
Stark Draper allestiva un
piccolo laboratorio per
consentire agli studenti
di familiarizzare con
l’aeronautica, in particolare
con gli strumenti per guida
avanzata e navigazione.
Le occasioni di fare le cose
in grande si presentarono
subito: grazie alla
collaborazione sia con il
dipartimento della Difesa,
che con la Nasa. I ragazzi
di “Doc Draper”, infatti, da
una parte misero le mani
sui missili sottomarini
più precisi di quell’epoca,
dall’altra progettarono
e realizzarono l’Apollo
Guidance Computer,
il sistema di guida
spaziale che portò i
primi astronauti della
missione Apollo sulla Luna
e che poi li ricondusse
sani e salvi sulla Terra.
Oggi, a proposito di
organizzazione per la
ricerca e lo sviluppo,
il Draper Laboratory pensa
ancora più in grande:
«Pionieri nell’applicazione
di scienza e tecnologia
nell’interesse nazionale»,
è il loro slogan. Si va dalla
micro-elettronica alla
salute, dall’osservazione
spaziale alla sicurezza
per scavalcare, a colpi di
ingegneria, i principali
limiti tecnologici del
pianeta, con uno sguardo a
360 gradi tra le discipline.
Anche dal punto
di vista dello spazio, gli
ingegneri percorrono le
scale nanometriche come
gli anni luce, ragionano
sulle profondità del mondo
sottomarino e sugli aerei
ad alta quota e progettano
soluzioni in orbita,
lontanissime dalla terra.
Il Draper Lab è un
crocevia di conoscenze
cui hanno attinto (e ancora
attingono) grandi industrie,
importanti accademie
e governi: una sorta di
base d’appoggio per chi si
muove tra le tappe di quasi
un secolo di tecnologia e
da lì prova a immaginare
il futuro. Un domani i
farmaci non saranno
più semplici compresse,
bensì minuscole capsule
intelligenti in grado di
colpire in modo selettivo
i bersagli all’interno
del nostro corpo.
E magari le malattie
neuropsichiatriche
potranno essere curate
direttamente nel cervello,
attraverso lo stimolo di
micro-dispositivi elettronici
sempre più avanzati.
Un futuro, cioè, in cui
il cyberterrorismo sarà
stato annientato da
software sempre più
blindati; un tempo in
cui, per ragionare sulle
policy, sarà fondamentale
comprendere le culture
e i popoli (perché no?)
sfruttando anche i dati
raccolti dai satelliti.
C O O R D I N A T E G P S
4 2 . 3 6 4 5 4 3 N , 7 1 . 0 9 0 5 2 2 O
L U O G O
B O S T O N , U S A
C A T E G O R I A
S C I E N Z A
D O C D R A P E R E I T E C N O P I O N I E R I
©MIT MUSEUM

C A P I T O L O 3
A M E R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
K1
P A R O L E C H I A V E
C L I M A , C A P A C I T À D I R I P R E S A
D A N I E L E B E L L E R I
Prima che l’uragano Sandy
mettesse k.o. Manhattan,
nell’autunno 2012, pochi
conoscevano il termine
“resilienza” applicato alla
vita urbana. Da allora, però,
è diventato uno dei criteri
con cui valutare la qualità
della vita nelle metropoli,
in base a uno standard che
considera gli interessi di
tutti i cittadini e non solo
di piccoli gruppi
privilegiati. Resilienza
è la capacità di una città
di scongiurare gli eventi
negativi e, soprattutto,
di rimettersi in piedi dopo
di essi: considera variabili
climatiche, economiche,
demografiche e di
coesione sociale.
Secondo uno studio
del 2014 di Grosvenor,
multinazionale
dell’immobiliare, sono
all’avanguardia i centri
del Nord America.
In particolare il Canada,
che conquista l’intero
podio delle metropoli
mondiali più resilienti
con Toronto, Vancouver,
e Calgary.
Visto il testo dell’accordo
internazionale per limitare
gli effetti del cambiamento
climatico, firmato a Parigi
a fine 2015, la prima spicca
come modello per qualsiasi
amministratore pubblico.
Sebbene protetta da una
conformazione geografica
favorevole (distante dal
mare e a basso rischio
sismico), il capoluogo
dell’Ontario non è immune
da episodi drammatici:
a partire dall’uragano Hazel
(1954) fino alle tempeste di
neve e blackout nel 1998,
2003 e 2013, passando
attraverso i frequenti
straripamenti del fiume
Don, senza dimenticare
però varie minacce globali
come la sindrome SARS,
nel 2003. Ma, nel corso
dei decenni, Toronto ha
imparato a fare i conti
con la propria vulnerabilità,
anche in previsione di
estati sempre più calde
e di una popolazione
sempre più vecchia.
Si è così sviluppata
una solida capacità
di adattamento che
scaturisce da molti
livelli: da istituzioni
capaci di investire sulle
infrastrutture e, allo stesso
tempo, di avviare un
rapporto di fiducia con
i cittadini, da un costante
progresso tecnico (ricerca
universitaria e utilizzo
dei big data), da una
pianificazione puntuale
e dalla cruciale capacità
di attrarre fondi (ogni
catastrofe ambientale
è anche una colossale
operazione assicurativa).
Toronto si fa apprezzare
ancora di più se
paragonata ad altre città
del mondo: per esempio
a Londra, dove a turbare
l’equilibrio sociale è la
scarsità di alloggi a prezzi
accessibili, oppure alle
metropoli di Africa, Sud
America e Asia, dove
la crescita demografica
sarà maggiore nei prossimi
decenni. Tutti luoghi
che soffrono di livelli di
resilienza pericolosamente
bassi.
Q U E S T I O N E D I R E S I L I E N Z A
C O O R D I N A T E G P S
4 3 . 7 1 6 6 4 3 N , 7 9 . 3 4 0 5 7 9 O
C A T E G O R I A
A M B I E N T E
L U O G O
T O R O N T O , C A N A D A

C A P I T O L O 3
A M E R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
B5
P A R O L E C H I A V E
D E S E R T O , M I S S I O N E H I - S E A S I V , N A S A
L U O G O
M A U N A L O A , H A W A I I , U S A
M A R C O C O S E N Z A
«Non fosse per il cielo
azzurro invece che rosso
o blu, lo scenario è molto
“marziano”», spiega Kim
Binsted, professoressa
dell’università delle
Hawaii che studia il
comportamento umano
in missioni spaziali di
lunga durata: «È un luogo
talmente isolato...».
Non è un caso se la Nasa
ha scelto quelle isole degli
Stati Uniti come palestra di
allenamento per l’arrivo su
Marte. Proprio l’isolamento
le rende particolarmente
adatte all’analisi delle
reazioni e delle dinamiche
tipiche dei viaggi nello
spazio. Qui infatti, pacifico
come l’Oceano che lo
circonda, un equipaggio
− tre uomini e tre donne −
simula avvicinamento ed
esplorazione del “Pianeta
Rosso” per 365 giorni.
La missione Hi-Seas IV
(Hawaii Space Exploration
Analog and Simulation)
si concluderà nell’estate
2016. Nel frattempo un
esobiologo francese,
una fisica tedesca
e i loro quattro colleghi
statunitensi (una geologa,
un pilota, un architetto,
una neuroscienziata-
giornalista) continueranno
a dividersi spazi e compiti
all’interno di una speciale
struttura: un modulo a
cupola con diametro di
11 metri, altezza di 6 e una
superficie a disposizione
di circa 90 metri quadrati,
da cui possono uscire
solo occasionalmente
ma indossando la propria
regolare tuta spaziale.
Dodici mesi avari d’aria
fresca, di cibi freschi
e privacy, con una dispensa
piena di alimenti in scatola
o in polvere, nonché di
un segnale Internet che
viaggia in costante ritardo
di 20 minuti, come se si
trovassero davvero nei
pressi di Marte.
Lo stress, fisico e mentale,
può essere elevato perché
si creano situazioni in cui
vengono testate a fondo
le capacità di cooperazione
e resistenza dei singoli,
ma anche dell’intero
gruppo. Il periodo
d’addestramento
è doppio, rispetto ai
semestri standard delle
missioni sulla Stazione
Spaziale Internazionale;
ma la durata di una vera
spedizione su Marte è
stimata in un periodo
compreso tra uno e tre
anni, quindi fare altrimenti
era difficile.
Il programma Hi-Seas
è finanziato dalla Nasa
con 1,2 milioni di dollari
e nei prossimi anni prevede
altri due camp da 8 mesi
ciascuno. «L’investimento
può sembrare ingente
ma è molto, molto più
economico della spesa
necessaria a condurre una
ricerca simile nello spazio»,
assicura Binsted.
L’obiettivo è di raggiungere
Marte nel 2035, quando
al posto del robot
Curiosity potrebbe esserci
un equipaggio di veri
astronauti. Addestrati
alle Hawaii, naturalmente.
C O O R D I N A T E G P S
1 9 . 4 7 3 2 5 6 N , 1 5 5 . 5 9 0 8 5 3 O
C A T E G O R I A
S C I E N Z A
S U L P A C I F I C O M A R T E
©CYPRIEN VERSEUX

C A P I T O L O 3
A M E R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
L6
L U O G O
A L T O S D E C A Z U C Á , C O L O M B I A
P A R O L E C H I A V E
A L B E R I , G I A N C A R L O M A Z Z A N T I , S H A K I R A
I B O S C H I D E L L A S P E R A N Z A
C A T E G O R I A
A R C H I T E T T U R A
C O O R D I N A T E G P S
4 . 5 8 7 2 4 4 N , 7 4 . 1 8 5 6 7 4 O
F R A N C E S C O L I P A R I ,
A L E S S A N D R O O R S I N I
Innovare è sicuramente
un fatto complesso.
Soprattutto in un momento
storico come l’attuale,
in cui gli architetti sono
concentrati sull’uso degli
strumenti digitali come
unico veicolo creativo.
Alcuni professionisti,
per fortuna, all’uso
smodato della tecnologia,
preferiscono un approccio
olistico in cui gli elementi
che compongono lo spazio
si trovano in simbiosi,
non scissi come atomi
di materia. Tra loro
c’è Giancarlo Mazzanti,
architetto colombiano
di nascita ma italiano
di formazione, avvenuta
per la precisione a Firenze.
La sua filosofia ha come
oggetto l’umanità
e il miglioramento della
condizione sociale in cui
il progetto opera (spesso si
tratta di territori e tessuti
urbani disconnessi).
Cioè, «un’architettura
da vivere e non solo
da osservare». Tra le sue
opere più riuscite c’è
“Bosque de la Esperanza”
(Bosco della speranza):
un centro sportivo
realizzato in Colombia,
nel distretto di Soacha
− alla periferia di Bogotá
− chiamato Altos de
Cazucá, un’area depressa
che accoglie persone
fuggite da fame e guerra.
A renderlo possibile è
stata la “Fundación Pies
Descalzos”, organizzazione
no profit − fondata dalla
cantante Shakira − che
si occupa di bambini
maltrattati provenienti
da famiglie poverissime,
insieme all’Ong spagnola
“Ayuda en Acción”.
Il centro sportivo Bosque
de la Esperanza occupa
una superficie orizzontale
di 1744 metri quadrati
con una copertura
tridimensionale di 700.
Quest’ultima, realizzata
con pilastri in acciaio
a inclinazioni variabili
ed elementi modulari
poliedrici rivestiti da mesh,
è l’assoluta protagonista
del progetto: quasi uno
shadescape, o “paesaggio
d’ombra”. Con i suoi
moduli colorati di verde
evoca gli alberi locali
contribuendo a formare
uno spazio calmo,
dinamico. Per gli abitanti
di Altos de Cazucá
rappresenta un simbolo
di unione e speranza.
L’approccio progettuale
di Giancarlo Mazzanti
aspira a ciò che
l’architettura sa produrre
quando è contestualizzata
e inserita con sapienza
nei tessuti urbani in cui
opera, quando cioè riesce
a configurarsi come
elemento di cucitura
ma anche di coesione
dell’ambiente, fisico e
sociale, circostante.


Automatic.
Libera l’ambiente
da odori, sostanze
inquinanti ed
eccessi di umidità.
Monitora la
temperatura
e regola il flusso
di aria in uscita
in maniera
automatica.
“ C o n q u e s t o p r o g e t t o
v o g l i a m o a p r i r c i
a l l ’ e r a d e l l ’ I n t e r n e t
o f T h i n g s p o r t a n d o
i l n o s t r o k n o w - h o w n e l
t r a t t a m e n t o d e l l ’ a r i a . ”
F r a n c e s c o C a s o l i ,
P r e s i d e n t e d i E l i c a

P E R E L I C A
S N A P B Y E L I C A : O R A L A Q U A L I T À D E L L ’ A R I A S I C O N T R O L L A C O N U N ’ A P P .
La qualità dell’aria che respiriamo è un tema sempre rilevante, ma
tutta l’attenzione è spesso concentrata sull’inquinamento esterno.
Recenti studi hanno invece dimostrato che in ambienti chiusi
non adeguatamente ventilati l’aria può essere fino a 5 volte più
inquinata di quella esterna. Per aiutarci a vivere in un ambiente
sano, è nato Snap, il primo Air Quality Balancer, creato da Elica
con la collaborazione di IBM e Vodafone. La storica azienda
italiana prosegue così il suo percorso di specialista del trattamento
dell’aria e si apre all’Internet of Things, con un prodotto che unisce
innovazione e connettività a un design di altissimo livello.
Adatto
per ogni
ambiente
della casa.
Controllo
ovunque sei
grazie all’app
dedicata.
Design
Fabrizio Crisà.
Disponibile a
299 euro (WI-FI) o a
399 euro (WI-FI + SIM).
Manual.
L’utente è libero
di ventilare
l’ambiente
secondo le
proprie necessità.
Detox.
Si concentra sulla
qualità dell’aria,
eliminando
odori e sostanze
inquinanti.
Dry.
Determina
un corretto
riciclo dell’aria,
riducendo la
possibilità di
formazione di
muffe ed evitando
l’odore di chiuso.
Link.
Libera l’ambiente,
dialoga con le
informazioni
ricevute dalle
cappe Sense di
Elica e interviene
per potenziare
l’efficacia di
aspirazione in
cucina.
Aria sempre
nuova grazie
a 3 sensori.
Riduce la presenza
di odori, agenti
inquinanti ed
eccessi di vapori in
soli 30 minuti*.
Massima
autonomia.
Aggiornamento
firmware costante.
*per
un
am
bie
nte
di 25
mq
www.elica.com
www.snap.elica.com



Port Louis
A F R I C A
1
pag. 132
pag. 120
pag. 139
pag. 134
pag. 140
pag. 135
pag. 136
pag. 138
Hargeisa
Sinthian
Nairobi
Johannesburg
Nairobi
Addis Abeba
Lagos
2
3
4
5
6
7
8


W I R E D / N. 2 / P R I M AV E R A 2 01 6

I L P R E S I D E N T E B O TA N I C O
L U O G O
P O R T L O U I S , R E P . D I M A U R I T I U S
C O O R D I N A T E G P S
2 0 . 1 6 6 6 6 7 S , 5 7 . 5 1 6 6 6 7 E
F O T O D I
A L E S S A N D R O I M B R I A C O
T E S T O D I
S I L V I A B E N C I V E L L I
C A P I T O L O 4
A F R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
M9
AMEENAH GURIB-FAKIM,
PRIMO CAPO DI STATO DONNA
DI MAURITIUS E SCIENZIATA
CHE STUDIA LA BIODIVERSITÀ,
STA CAMBIANDO LA NATURA
DEL SUO PAESE.
E DELL’INTERO CONTINENTE

W I R E D / N. 2 / P R I M AV E R A 2 01 6

C A P. 4 / A F R IC A
1 2 3
1 2 2

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
Mauritius, anzi la Repubblica di Mauritius, è uno Stato grande una
volta e mezzo il Comune di Roma, che si trova su un’isola dell’Oceano
Indiano 550 chilometri a est del Madagascar. Altri 550 più a est, la
piccola isola vulcanica di Rodrigues segna il punto più orientale del
continente africano. Mauritius, insomma, è un frammento di Africa
che sa di Asia ma un po’ anche d’Europa. Gli abitanti (circa un milione
e trecentomila) sono di origine indiana, africana, francese, cinese:
una metà è induista, un terzo è cristiano, gli altri musulmani.
Abitano qui (o meglio vanno e vengono da qui) dall’inizio del Sette-
cento, cioè da quando l’isola divenne possedimento francese. Era nota
da secoli ad arabi e malesi. Nel corso del Cinquecento e del Seicento
erano arrivati anche portoghesi e olandesi. Ma tutti l’avevano tro-
vata inospitale e se n’erano andati in fretta, senza grossi rimpianti.
Nessun rimpianto nutrivano certo per il dodo, l’uccello columbiforme
che qui si è estinto per cause umane intorno al 1681.
Dopo i francesi sono arrivati gli inglesi, che sono stati proprietari
dell’isola fino all’indipendenza, concessa nel 1968. Da allora la Repub-
M

C A P. 4 / A F R IC A
1 2 5
1 24
blica di Mauritius è una repubblica, appunto, e una tra le più stabili
di tutta l’Africa. Vive di agricoltura, industria e turismo, ha il secon-
do reddito pro-capite del continente. Un’unica autostrada la taglia da
nordovest a sudest; più o meno a un terzo si trova la settecentesca
residenza presidenziale di Réduit con il grande parco che, da mag-
gio dell’anno scorso, ha un angolo profumato, coltivato a giardino di
piante rare e medicinali. A piantarlo è stata la nuova presidentessa
della Repubblica, Ameenah Gurib-Fakim.
Scienziata, musulmana, 56 anni, Gurib-Fakim il 5 giugno 2015 si è
sentita proporre dal Parlamento di sostituire il dimissionario Kaila-
sh Purryag. Ha accettato e, proprio nella residenza di Réduit, in uno
studio con le pareti blu e grandi porte-finestre aperte sul giardino,
ha incontrato Wired e spiegato perché la protezione della biodiversi-
tà sarà il motore dello sviluppo del piccolo Paese africano, perché il
dodo è il passato e perchè quel giardino profumato è il futuro.
Un futuro da costruire nel rispetto della scienza, dell’innovazione
e di un’approfondita conoscenza dell’ecologia.
A D
ES
TR
A,
IL R
ITR
AT
TO
DI
UN
DO
DO
(UN
GR
OS
SO
PIC
CIO
NE
ES
TIN
TO
NE
L 1
68
1) E
SP
OS
TO
AL
NA
TU
RA
L
HIS
TO
RY
MU
SE
UM
DI
PO
RT
LO
UIS
,
LA
CA
PIT
AL
E.
IN A
PE
RT
UR
A,
PIA
NT
E
OS
PIT
I N
EL
PA
RC
O D
I R
ÉD
UIT
: IL
60
%
DE
LL
E S
PE
CIE
VE
GE
TA
LI
È E
ND
EM
ICO

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
o cominciato a coltivare l’interesse per la scienza fin da piccola, e credo di esservi stata
indirizzata in particolare da alcuni eventi. Prima di tutto a scuola, ho incontrato pro-
fessori molto motivati, in grado di mostrare a noi alunni che la scienza è dappertutto
e che è materia viva. Ma c’è stato anche l’allunaggio del 20 luglio 1969, che qui a Mau-
ritius abbiamo potuto vedere in diretta tv. E più tardi la nascita di Louise Brown, la
prima bambina concepita grazie alla fecondazione artificiale. Tutti avvenimenti che
mi hanno fatto capire che la scienza ci cambia davvero la vita.
Quindi, appena ho finito le scuole, sono partita per studiare Chimica organica all’Università del
Surrey, in Gran Bretagna. Una delle ragioni per cui ho scelto quella contea è che dava la possibilità di
fare uno stage in azienda: quell’esperienza l’ho fatta all’interno di una grande compagnia chimica,
nel dipartimento in cui si faceva ricerca sui pesticidi – a partire soprattutto da sostanze naturali.
Poi ho preso il dottorato in Chimica organica all’Università di Exeter, lavorando sempre su molecole
naturali. A quel punto, ero pronta a partire per gli Stati Uniti, dove avrei fatto un master di specializ-
zazione. Ma i miei genitori mi hanno convinta a tornare a Mauritius ed eccomi di nuovo qua.
Ho ottenuto un posto all’università. Be’, mi sono subito resa conto della differenza. A Mauritius
non potevi fare ricerca come in Gran Bretagna, perché non c’erano mezzi né strutture. Ma siccome
avevo ancora una grande passione per la chimica, cui non volevo assolutamente rinunciare, sono
“caduta nel pentolone delle piante”! Cioè, ho cominciato a conciliare chimica e botanica. Perché le
piante? Perché Mauritius è un punto di riferimento per la biodiversità planetaria. Ma anche perché
quando sei un accademico hai bisogno di pubblicare ricerche scientifiche originali. Così ho capito che,
se volevo cominciare a studiare le piante, ero nel posto ideale per trovare molecole nuove.
Sono partita da un progetto della Commission de l’Océan Indien sullo studio delle piante offi-
cinali, grazie al quale, dal 1990 al 1995, ho lavorato all’inventario delle specie aromatiche e medici-
nali di Mauritius e Rodrigues: quando l’ho completato, mi sono resa conto che ci sono molte verità in
quello che dicevano le vecchie “maghe” di paese. Perciò ho cominciato a riorientare i miei studi sulla
validazione scientifica dei dati tradizionali: cioè a prendere le “ricette”, a studiarle, a verificare se
fossero davvero efficaci e per quali ragioni. Considerate che, negli anni in cui facevo l’università, que-
sti temi venivano percepiti come estremamente marginali, quasi delle stregonerie. Ma le cose sono
cambiate: l’anno scorso, il Nobel per la medicina è andato alla cinese Tu Youyou, che ha fatto tesoro di
«H
A D
ES
TR
A L
O C
HÂ
TE
AU
DE
RÉ
DU
IT,
OG
GI
RE
SID
EN
ZA
DE
L P
RE
SID
EN
TE
DE
LL
A R
EP
UB
BL
ICA
DI
MA
UR
ITIU
S.
DO
PP
IA P
AG
INA
SE
GU
EN
TE
: A
ME
EN
AH
GU
RIB
-FA
KIM
NE
L P
AR
CO
IN
CU
I H
A
CR
EA
TO
UN
GIA
RD
INO
PR
OF
UM
AT
O
CO
N P
IAN
TE
RA
RE
E M
ED
ICIN
AL
I

C A P. 4 / A F R IC A
1 2 7
1 2 6
M
informazioni tradizionali sulla cura della malaria e, con quelle, ha prodotto il farmaco che ha deciso
la guerra del Vietnam, l’artemisinina.
Intanto io, nel 2001, vincevo la cattedra di Chimica organica e diventavo la prima insegnante
donna dell’Università di Mauritius. Nel 2004 sono stata nominata preside della facoltà di Scienze e
prorettore dell’ateneo. Nel 2007 ho ricevuto il premio “L’Oréal-Unesco per le Donne e la Scienza”. Poi
ho cambiato strada. Nel 2009 sono diventata amministratore delegato del Cidp (Centre International
de Développement Pharmaceutique) Research & Innovation, perché nel mondo accademico non c’e-
rano mezzi per tradurre la ricerca in business, ma di molecole naturali per l’industria farmaceutica e
cosmetica c’è gran richiesta. Insomma: sono diventata imprenditrice. Per me è un esempio di come la
protezione della biodiversità dia anche vantaggi economici a una regione e di quanto sia necessario
che, come stabilito da molte convenzioni internazionali, i paesi regnino sovrani sulla propria.
a facciamo un passo indietro. Nelle società arcaiche l’uomo si considerava parte in-
tegrante dell’ambiente. In alcune di quelle asiatiche, ai tempi dei faraoni, quando si
andava nella foresta a tagliare un albero si chiedeva il permesso alla natura. Oppure
agli spiriti. Poi l’uomo ha avuto la pretesa di diventare un dominatore, di sfruttare le
altre specie e ha perso il rispetto per le cose. Solo che questo non può durare a lungo.
Anzi, proprio adesso serve un cambiamento rapido del modo di pensare, una presa di
coscienza del fatto che è dalla biodiversità che dipende la nostra vita: per biodiversità non intendo
soltanto le piante, ma anche i microbi terrestri e marini, gli animali e le interazioni tra tutti loro.
È una vera questione di sopravvivenza, sia chiaro. Qui siamo oltre l’aspetto morale, etico e
anche economico. Adesso è la sopravvivenza dell’umanità che dipende dalla sopravvivenza della bio-
diversità. Prima ci comportavamo come se dovessimo fare un favore alla natura difendendola, adesso
invece sappiamo che si tratta del contrario: è lei che difende noi, che per evitare il peggio dobbiamo
leggere i sintomi del suo malessere. Parlo di fenomeni come le tempeste di neve negli Stati Uniti, le
inondazioni in Gran Bretagna, l’acqua che si alza nelle città costiere. Come per esempio nella vostra
Venezia. O qui, nelle nostre isole: Mauritius è classificata fra le zone ad alto rischio del World Risk Re-

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6

C A P. 4 / A F R IC A
1 2 9
1 2 8

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
port e le Maldive sono direttamente minacciate dall’innalzamento dei mari. Si tratta di cambiamenti
brutali dell’ambiente; i più evidenti sono gli estremi climatici sempre più frequenti.
Non solo: dobbiamo anche capire che è giunta l’ora di superare le divisioni fittizie tra nord e sud
del mondo. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. E se è vero che le nazioni del nord del pianeta hanno
più colpe etiche, morali, sociali, economiche di quelle del sud, ora è tempo di superare anche questo.
Continuare a parlare di responsabilità serve a poco, soprattutto ai paesi africani che presto inizie-
ranno a soffrire delle conseguenze dei cambiamenti climatici. È già il momento di agire.
Ci saranno sempre più “rifugiati climatici”, grandi movimenti di popolazioni che fuggono da
carestie, siccità. Ma anche più problemi di salute, per tutti. Il virus Zika oggi ce lo sta dimostrando:
era diffuso solo in Uganda, dove la gente ci convive da lustri, poi ha cambiato territorio. Ma tante altre
malattie cambieranno distribuzione: prima fra tutte la malaria, che si sta spostando dai paesi caldi
e umidi del sud verso quelli del nord. Ci saranno impatti enormi anche sulla sicurezza alimentare:
l’Africa possiede il 60% delle terre agricole del pianeta e molte sono occupate da colture di base, come
il mais. Ma nel 2030 il 40% di queste aree potrebbe non essere più coltivabile visto che il continente
sarà diventato iperurbanizzato. Che conseguenze avrà tutto ciò per la nostra alimentazione? Riu-
sciremo a trasferire nei paesi africani le tecnologie per la cosiddetta “smart agricolture” ed evitare
di perdere quest’immensa risorsa? Insomma: bisogna guardare al problema con un occhio globale,
senza più pensare a un pianeta diviso.
uanto a noi, Mauritius è considerato uno degli hotspot della biodiversità terrestre. Su
tutto il pianeta ne esistono una trentina: coprono solo l’1,4% della superficie totale del-
la Terra ma contengono il 35% delle specie di piante. Per questo ci stiamo spendendo
tanto – forse molto più degli altri – per la salvaguardia del nostro ambiente. Il 60%
delle specie vegetali che si trovano qua è esclusivo del posto. Quindi ci tengo a dire
che più che l’isola del dodo vogliamo essere l’isola del gheppio: il gheppio di Mauritius,
un piccolo falco che siamo riusciti a salvare dall’estinzione una ventina di anni fa. A questo punto, il
ruolo della scienza è evidente. In Africa abbiamo bisogno di scienza, ma anche di scienziati: invece
Q

C A P. 4 / A F R IC A
1 3 1
13 0
ogni anno perdiamo un gran numero di laureati, che emigra verso i paesi ricchi. Non amo parlare di
“fuga dei cervelli”: preferisco usare il termine “circolazione dei cervelli”. Guardiamo a nazioni come
Cina, Corea, India e Brasile, che sono riuscite a emergere fino a diventare vere potenze. Eppure anche
loro hanno sofferto la diaspora degli scienziati ma sono riusciti, poi, a farli rientrare. E ci sono riusciti
non solo dando loro i necessari mezzi tecnici e tecnologici, ma anche creando ambienti favorevoli alla
ricerca. I salari per gli scienziati sono secondari, rispetto alla possibilità di lavorare bene. Bisogna
fare uno sforzo in questo senso, sapendo che è uno sforzo che viene ripagato presto. Adesso è arrivato
il momento che ci si metta anche l’Africa.
Attenzione però: l’Africa non è un paese, è un continente. Infatti fra gli argomenti che sono oggi
in discussione nell’Unione africana c’è proprio questo: ogni singolo Stato deve assumersi l’impegno
di investire una certa percentuale del Pil in strutture da dedicare alla scienza. Consideriamo che
l’Africa ha un vantaggio sul resto del mondo: è l’unico continente “giovane”, quello in cui l’età media
è più bassa (23 anni!). Significa che abbiamo un vivaio di talenti da allevare. Che abbiamo una nuova
collettività che si sta mettendo all’opera. Come dico spesso: il potenziale dell’Africa non si limita alle
risorse minerarie, è soprattutto nel capitale umano.
L’Africa però ha anche uno svantaggio: da quando è stata colonizzata, si è scelto di formare am-
ministratori senza pensare di investire nell’educazione degli scienziati. Ma anche in questo campo
sta a poco a poco avvenendo una presa di coscienza, perché si è capito che servono persone capaci di
dirigere le imprese, per esempio. Anche i politici hanno cominciato a capire che, se bisogna prendere
decisioni basate su dati credibili, è sulla credibilità scientifica che si deve puntare.
Anche perché, all’inizio, le priorità politiche sono sempre spinte dai bisogni. Ma non si può
pensare di fronteggiare solamente le emergenze: bisogna comunque guardare al futuro. In Africa
abbiamo investito tanto sulla salute, sulle malattie – soprattutto quelle trasmissibili. E ci sono sta-
ti molti finanziamenti dall’estero, come quelli della fondazione Gates o della Wellcome Trust. Se si
guardano le università africane, infatti, si vede benissimo che le tematiche sanitarie sono state pri-
vilegiate rispetto alle altre. Ma i bisogni sono e saranno sempre di più legati all’agricoltura e alla
sicurezza alimentare come l’acqua, lo sviluppo energetico pulito. Si dovrà investire, più in generale,
sulla produzione di conoscenza, perché non possiamo più continuare a dipendere dalla conoscenza
prodotta altrove. Insomma: bisognerà puntare sempre di più sull’innovazione».
AM
EE
NA
H G
UR
IB-F
AK
IM A
RÉ
DU
IT
CO
N I
L C
AP
O C
ER
IMO
NIE
RE
E D
UE
GU
AR
DIE
DE
L C
OR
PO
. L
AU
RE
AT
A
AL
L’U
NIV
ER
SIT
À D
EL
SU
RR
EY
, È
ST
AT
A L
A P
RIM
A D
ON
NA
A O
TT
EN
ER
E
UN
A C
AT
TE
DR
A (
QU
EL
LA
DI
CH
IMIC
A
OR
GA
NIC
A)
A M
AU
RIT
IUS

©ALAMY/OLYCOM

C A P I T O L O 4
A F R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
J5
M A R C O C O S E N Z A
La scarsità d’acqua è una
piaga e, se combinata con
la crescita costante della
popolazione, può avere
effetti drammatici.
Al punto che la
sopravvivenza stessa
diventa a rischio. Se infatti,
come indicano le stime,
si superassero i 9 miliardi
e mezzo di individui nel
2050, per rispondere alla
domanda globale di cibo
la produzione agricola
dovrebbe crescere del
60% entro la metà del
secolo. Il tutto complicato
dal fatto che l’apporto
di nascite maggiore
verrebbe dall’Africa, dove la
malnutrizione è già oggi
un problema concreto.
Questo significherebbe
quindi non solo
intensificare o modificare
geneticamente alcune
colture, ma anche essere
in grado di sfruttare ogni
centimetro di terreno
disponibile. Anche quello
più arido o impervio.
All’identikit risponde
sicuramente il Somaliland:
una lingua di terra che
si stende a sud del Golfo
di Aden, una delle zone più
calde del pianeta e un’area
semi-desertica in cui
abbonda l’acqua salata
ma scarseggia quella
dolce. Per questo la
compagnia britannica
Seawater Green house,
in collaborazione
con i ricercatori della
Aston University di
Birming ham e della
locale Gollis University
di Hargeisa, ha sviluppato
delle serre-oasi capaci di
“riciclare” l’acqua marina
per alimentare l’agricoltura.
«Il principale problema
del Corno d’Africa è
che l’evaporazione
supera di gran lunga
le precipitazioni»,
spiega Charlie Paton,
l’amministratore delegato
di Seawater Greenhouse.
«La nostra tecnologia
supera lo scoglio
utilizzando l’acqua
del mare per produrre
aria più pura e fresca».
Il contributo decisivo
arriva da altri due elementi
di cui la zona è ricca: sole
e vento. Il primo scalda
i pannelli fotovoltaici
che producono l’energia
necessaria a pompare
l’acqua e il secondo la
incanala in particolari
strutture reticolate.
Così, desalinizzata
attraverso un processo
di osmosi inversa, l’acqua
viene usata sia per irrigare
i campi sia per creare una
brezza umida che riduce
la traspirazione delle
piante. Il sale e le alghe
estratti possono essere
utilizzati il primo per
cucinare e conservare i
cibi, mentre le seconde
come fertilizzanti.
Nulla, insomma, va
sprecato. E non potrebbe
essere altrimenti in una
regione in cui solo l’1,5%
dei terreni è adatto alla
coltivazione. La media
è di 0,5 tonnellate di
raccolto per ettaro ogni
anno, rispetto alle 300
delle serre ad acqua
marina (e alle 700
di quelle classiche):
un incremento che
estenderebbe la sicurezza
economica e alimentare
al 75% degli abitanti.
Il progetto, finanziato
dal Dipartimento per
lo Sviluppo Internazionale
del governo inglese e dal
fondo Agri-Tech Catalyst
di Innovate Uk, ha raccolto
700mila sterline che gli
assicureranno almeno
una durata triennale.
L E S E R R E C H E S F I D A N O I L D E S E R T O
C A T E G O R I A
S C I E N Z A
P A R O L E C H I A V E
A C Q U A , A G R I C O L T U R A , D E S A L I N I Z Z A Z I O N E , E N E R G I A S O L A R E
C O O R D I N A T E G P S
9 . 5 6 2 0 6 0 N , 4 4 . 0 3 8 3 9 2 E
L U O G O
H A R G E I S A , S O M A L I L A N D

C A P I T O L O 4
A F R I C A
P A R O L E C H I A V E
A R T E , C O M U N I T À , T H R E A D C E N T E R
C O O R D I N A T E G P S
1 5 . 5 1 0 5 6 9 N , 1 3 . 2 6 8 7 5 9 O
C A T E G O R I A
A R C H I T E T T U R A
U N A R E S I D E N Z A P E R A R T I S T I
L U O G O
S I N T H I A N , S E N E G A L
La routine uccide la
creatività. Ecco perché
se sei un artista dovresti
provare a vivere qualche
mese nel Thread Center
a Sinthian, un villaggio
remoto del Senegal al
confine con il Mali, nella
regione di Tambacounda.
Nel mondo dell’arte, da
molti anni esiste una
pratica di residency
istituzionalizzata, per
permettere agli artisti
di essere ospitati in
luoghi destinati a dare
impulso alle ricerche e alla
creazione di opere. Con un
doppio scopo: fuggire dalla
frenesia della quotidianità
e ritrovare l’ispirazione in
contesti diversi dal proprio,
lasciandosi contaminare
dall’ambiente circostante.
Questa è stata l’idea
alla base dell’iniziativa
culturale lanciata e gestita
dalla Fondazione Josef
e Anni Albers, una non
profit con sede negli Stati
Uniti che mira a diffondere
nel mondo una visione
umanistica legata all’arte
e al progresso sociale.
Il direttore Nicholas Fox
Weber si è interessato
al Senegal nel 2003,
dopo un incontro con un
dottore franco-senegalese,
Magueye Ba, che da Dakar
si era trasferito nell’area di
Tambacounda per portare
aiuti alla popolazione
locale, realizzando un
centro medico. Weber
ha fondato la non profit
American Friends of
Le Korsa per aiutare
Ba a sostenere le sue
attività e ha cominciato
ad approfondire la sua
conoscenza della regione.
Da lì il sogno e la visione
di un luogo che potesse
aiutare gli artisti a ritrovare
il senso del servizio alla
comunità, attraverso le
loro opere ma anche la loro
presenza in loco.
Il progetto, selezionato
anche alla Biennale
di Venezia 2014,
è stato affidato allo
studio dell’architetto
newyorchese Toshiko
Mori, che ha realizzato
il centro insieme ai suoi
studenti di Harvard,
con l’obiettivo di costruire
una struttura residenziale
ma anche di uso pubblico.
Thread ha aperto un anno
fa, nel marzo del 2015,
ospitando i primi gruppi

C A P I T O L O 4
A F R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
I6
Q U A D R A N T E M A P P A
B 4
D O N A T A C O L U M B R O
di artisti, tra cui danzatori,
coreografi, designer
e fotografi selezionati
dalla Fondazione, in
collaborazione con il
curatore d’arte Koyo
Kouoh, che vive a Dakar.
La struttura è disegnata
in modo tale da poter
essere sfruttata non
solo durante i periodi
di residency, ma tutto
l’anno. La popolazione
locale, infatti, la usa come
luogo di mercato, sede
di corsi di lingua e riunioni.
Si è cercato di coinvolgere
la popolazione fin
dall’inizio: la mediazione
del dottor Ba ha aiutato
gli abitanti di Sinthian
a capire il tipo di struttura
che stava nascendo
nel loro villaggio e come
dare il proprio contributo
per costruirla, e ha anche
accompagnato l’architetto
Mori nella progettazione,
tenendo conto della
dimensione, del contesto
e dei materiali disponibili.
Tra quelli usati: bambù,
paglia e terra battuta.
Merita attenzione
particolare la struttura
del tetto: è anche
un sistema di raccolta
di acqua piovana,
destinato a conservare
il 30 per cento del
fabbisogno di acqua
dell’intero villaggio.
L U O G O
N A I R O B I , K E N Y A
P A R O L E C H I A V E
G O O G L E M A P S , M A T A T U , S M A R T P H O N E
C O O R D I N A T E G P S
1 . 2 9 2 4 7 3 S , 3 6 . 8 2 6 1 6 6 E
C A T E G O R I A
T R A S P O R T I
I M I N I B U S C O N N E S S I
Prendi una città da 3
milioni e mezzo di abitanti,
riempila di centinaia
di minibus privati,
ciascuno con i propri,
imperscrutabili, percorsi
e fermate, e otterrai un
sistema di trasporto
regolato dal caos, eppure
utilizzato per spostarsi
dal 70% della popolazione.
Questa era Nairobi nel
2012 e il fatto che i matatu,
i minibus in questione,
sparassero musica a tutto
volume mista a colpi di
clacson e fossero decorati
con scintillanti palle a
specchi da discoteca,
contribuiva semplicemente
a rendere folcloristica
l’idea di caos.
A mettere fine a questa
situazione sono state
Sarah Williams e
Jacqueline Klopp, due
ricercatrici della Columbia
University, con l’aiuto di
Adam White, cofondatore
di Groupshot, società
specializzata in progetti
all’incrocio tra innovazione,
impegno sociale e sviluppo
globale. Nasce dal loro
impegno Digital Matatus,
il progetto grazie al quale
oggi 130 percorsi di
minibus e 3000 fermate
sono disponibili su Google
Maps, consultabili da tutti
con il cellulare e stampati
in una mappa cartacea
precisa e coloratissima,
che non ha nulla da
invidiare a quella delle
reti di trasporti pubblici
di Londra o Parigi.
Realizzarla non è stato
facile: il comune aveva sì
notizie su circa il 75% dei
tragitti, ma si limitavano
ai punti di partenza e
arrivo. La soluzione? Dieci
studenti universitari locali,
dotati di smartphone e
di una speciale app per
annotare nome, luogo e
coordinate gps di ogni
percorso e di ogni stop,
si sono imbarcati per mesi
sui matatu. O, nei quartieri
più pericolosi, a bordo di
auto che seguivano i bus.
Una volta raccolti, i dati
sono stati aggregati in
un formato compatibile
con Google Maps e gli
ingegneri di Mountain
View hanno adattato
i propri standard a un
sistema continuamente
variabile di orari, tragitti
e fermate.
F E D E R I C O B O N A


C A P I T O L O 4
A F R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
H10
P A R O L E C H I A V E
A N T R O P O L O G I A , A R C H E O L O G I A , H O M O N A L E D I , T O M B E
G I A N L U C A D O T T I
Dai primi ritrovamenti
fossili del 2013 fino
all’annuncio ufficiale
arrivato nel settembre
2015, la cosiddetta Culla
dell’umanità − in Sudafrica,
vicino a Johannesburg,
patrimonio dell’Unesco
− ci ha riservato un’altra
sorpresa: una nuova specie
del genere Homo. La
grande famiglia dell’essere
umano si è allargata con
Homo naledi, che deve il
nome alla Camera delle
stelle sotterranea (Dinaledi
nella lingua locale) in cui
erano conservati i suoi
resti fossili. Il gruppo
di scienziati guidato da Lee
R. Berger dell’università
di Witwatersrand a
Johannesburg è riuscito
a riportare alla luce i resti
di quasi una ventina di
individui, tra bambini,
adulti e anziani. Si tratta
di una delle più importanti
scoperte scientifiche
dell’anno scorso e
probabilmente della più
rilevante del secolo in
antropologia, dal momento
che gli oltre mille fossili
recuperati sono un tesoro
senza eguali per ricostruire
un’immagine completa
di una specie di ominide.
Sull’età di questo nostro
antenato sappiamo per
ora pochissimo, tanto
che potrebbe risalire
a 3 milioni di anni fa ma
anche avere 100mila
anni. Una difficoltà nella
datazione che non potrà
essere risolta prima del
2017, causata sia dalla
mancanza di resti animali
nella caverna, sia dal
gran numero di reperti
di epoche differenti
ritrovati nello stesso luogo.
La posizione dei resti,
nella zona più remota
della caverna e a trenta
metri di profondità nel
sottosuolo, ha indotto
diversi antropologi
a pensare che questi
ominidi lasciassero
i morti in aree volutamente
poco accessibili.
Nonostante la sua età
incerta, di Homo naledi
abbiamo già un identikit
piuttosto preciso:
il maschio adulto era
alto circa un metro
e mezzo e particolarmente
snello (arrivava a stento
a 45 chilogrammi);
il suo cervello aveva
una forma poco evoluta
e dalle caratteristiche
primitive, grande appena
la metà rispetto a quello
dell’essere umano
moderno. Le mani
somigliavano a quelle
dell’Homo habilis ed erano
molto ricurve, suggerendo
che il nostro antenato
avesse eccezionali abilità
da arrampicatore ma anche
la capacità consolidata di
utilizzare degli strumenti.
Le altre caratteristiche
sono una singolare
mescolanza di tratti
primitivi e moderni:
la forma delle spalle
e le ossa del bacino,
per esempio, ricordano
quelli di scimmie
e australopitechi e hanno
un aspetto poco evoluto,
mentre le mascelle e i piedi
sono identici a quelli della
nostra specie e dimostrano
che Homo naledi era quasi
sicuramente in grado
di reggersi in piedi sulle
sue gambe affusolate.
E forse anche in grado
di camminare in posizione
eretta per lunghe distanze.
C O O R D I N A T E G P S
2 5 . 9 2 9 4 7 5 S , 2 7 . 7 6 7 1 3 3 E
C A T E G O R I A
S C I E N Z A
L U O G O
J O H A N N E S B U R G , S U D A F R I C A
L A C U L L A D E L L’ U M A N I TÀ

C A P I T O L O 4
A F R I C A
P A R O L E C H I A V E
B R C K , E N E R G I A S O L A R E , I N T E R N E T , R O U T E R , S C U O L A , W I - F I
L U O G O
N A I R O B I , K E N Y A
I L K I T C H E C O N N E T T E L’A F R I C A
C A T E G O R I A
H I - T E C H
C O O R D I N A T E G P S
1 . 2 9 8 7 5 2 S , 3 6 . 7 9 0 7 5 2 E
“Connettere l’Africa”.
Dove l’abbiamo già
sentito? È uno dei progetti
più ambiziosi di Mark
Zuckerberg, che con
l’iniziativa Internet.org
vuole portare online − con
servizi di base che passano
dal suo social network − i
due terzi del mondo che
ancora sono offline. Attivo
già in alcuni paesi africani
come Zambia, Kenya e
Tanzania, lo scorso anno
è stato lanciato anche
in India. Poi c’è Google,
con il suo Project Loon,
progetto di ricerca e
sviluppo per portare la rete
in zone remote del pianeta
grazie all’uso di palloni
aerostatici. Ma “connettere
l’Africa” è anche l’idea che
sta alla base di un progetto
molto più piccolo e non
per questo meno
efficace: è Brck, modem
e router wi-fi senza fili
che può connettere fino
a 20 dispositivi, con
un’autonomia di 8 ore
senza essere collegato
alla corrente elettrica.
Lo hanno inventato in
Kenya alcuni membri
del team di Ushahidi,
l’applicazione di
crowdmapping più usata
al mondo, che ha sede
nell’iHub di Nairobi,
incubatore di startup
e spazio di coworking con
più di 16mila iscritti, cuore
pulsante dell’innovazione
tecnologica del continente
africano. Proprio negli
uffici di iHub, al fondatore
di Brck Erik Hersman, è
venuta l’idea di realizzare
un gadget che potesse
garantire la connessione
a internet in mancanza
di energia elettrica. In
un paese come il Kenya,
anche nella capitale, le
interruzioni di corrente
sono frequenti e, per chi
lavora nel mondo della
tecnologia, questo può
diventare un incubo. In
più, al di fuori delle aree
urbane le infrastrutture
per la rete veloce non sono
garantite, quando invece
l’accesso a internet può
essere proprio un punto
di forza e rilancio per
l’economia e l’occupazione.
Brck si pronuncia “brick”,
come mattone in inglese,
perché lo è sia dal punto
di vista del design che
della concezione: può far
parte di un sistema più
complesso, per esempio
diventando un mini
server quando connesso
a un computerino come
Raspberry Pi. Può
funzionare ovunque
ci sia una rete mobile,
essere ricaricato tramite
pannelli solari e ha fino
a 16 gigabyte di spazio,
utili per i backup di rete.
Dal 2013 a oggi sono più
di 2500 i pezzi venduti
in 54 paesi del mondo.
Brck è nato grazie a una
campagna di crowdfunding

C A P I T O L O 4
A F R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
I5
Q U A D R A N T E M A P P A
I6
F E D E R I C O B O N A
D O N A T A C O L U M B R O
F . E R I K H E R S M A N
che ha raccolto 172mila
dollari da più di mille
donatori, ma può vantare
anche un investimento
di 3 milioni di dollari,
che lo mette nella top 5
delle startup africane più
amate dagli investitori.
A settembre, il team di
Erik Hersman e Juliana
Rotich, anche lei tra le
fondatrici di Ushahidi e
membro del consiglio di
amministrazione di iHub,
ha lanciato Brck Education:
un kit dedicato alle scuole
che contiene il modem
Brck, 40 tablet super
resistenti all’acqua e agli
urti, già pieni di ebook
e materiali di formazione
cui si può accedere
tramite una rete locale
installata offline e un
caricatore a pannelli solari.
Tutto questo permette a
qualsiasi insegnante
di creare una classe
digitale in pochi minuti.
Da una sperimentazione
in una prima scuola di
Nairobi, ora il kit Brck
Education è arrivato
in Tanzania, e, con l’aiuto di
fondazioni come la African
Wildlife Foundation,
il progetto sbarcherà
anche nelle scuole delle
aree rurali di Etiopia,
Repubblica democratica
del Congo e Uganda.
P A R O L E C H I A V E
E N E R G I A , M A D E I N C H I N A , T R A F F I C O
R I V I N C I TA M E T R O P O L I TA N A
C O O R D I N A T E G P S
8 . 9 8 0 8 6 6 N , 3 8 . 7 5 7 7 3 7 E
C A T E G O R I A
T R A S P O R T I
L U O G O
A D D I S A B E B A , E T I O P I A
Trentaquattro chilometri
e duecentocinquanta metri:
tanta è la distanza coperta
dalla nuova metropolitana
leggera di Addis Abeba,
la prima di tutta l’Africa
sub-sahariana. Composta
da 39 stazioni è stata
realizzata in appena 3 anni.
È divisa in due linee: la blu,
inaugurata il 20 settembre
2015, che collega zona
industriale del sud della
città a piazza Menelik II,
al centro, e la verde, che
ha debuttato il 9 novembre
2015 e corre da est (Ayat)
a ovest (Tor Hailoch). Un
capolavoro di tecnologia
ed efficienza, reso possibile
dalla combinazione tra
un’economia, quella etiope,
che corre a tassi di crescita
intorno al 10% ormai
da quasi un decennio,
e grandi investimenti
cinesi. L’intera opera,
infatti, è stata realizzata
dalla China Railway
Engineering Corporation
e i 475 milioni di dollari
necessari sono stati
garantiti per l’85% dalla
Export-Import Bank of
China. Anche la gestione
delle linee e dei servizi,
per i primi tre anni e
mezzo, sarà tutta cinese:
la Shenzhen Metro Group
ha già inviato il proprio
personale, che avrà il
compito, durante questo
periodo, di istruire
e addestrare manager
e tecnici locali.
La sfida tecnologica più
importante? Garantire
i 160 megawatt di energia
elettrica necessari al
servizio, grazie a una
rete dedicata che
prevede quattro snodi
agli estremi delle linee.
Non per niente,
l’Etiopia sta lavorando
intensamente per
integrare le proprie risorse
energetiche e, dopo
il parco eolico di Adama,
inaugurato l’anno scorso,
è stato il turno della
centrale idroelettrica
Gibe III, che ha quasi
raddoppiato la potenza
disponibile per il
paese. L’impatto della
metropolitana è stato
positivo: nel primo mese,
circa 200mila passeggeri
al giorno sono saliti su
uno dei 41 treni, pagando
un biglietto che costa
6 birre (circa 0,26 euro)
e decongestionando
il traffico.

C A P I T O L O 4
A F R I C A
Q U A D R A N T E M A P P A
D5
P A R O L E C H I A V E
A K O N , C A L C I O , E N E R G I A C I N E T I C A , S H E L L
G A B R I E L E L I P P I
Provate a far rotolare un
pallone e vedrete che la
gente gli correrà dietro.
Pensate ora di poter
utilizzare tutto quello
sforzo per illuminare
un campo, una strada,
magari un intero quartiere.
Ora lasciate da parte la
fantasia, perché qualcosa
del genere esiste già.
Si trova in Nigeria,
all’interno del Federal
College of Education di
Akoka, a Lagos, ed è un
campo da calcio che riesce
a combinare l’energia
solare a quella cinetica.
In tre hanno contribuito
alla sua realizzazione:
il gigante energetico
Shell, la star dell’hip hop
Akon (americano ma
di origini senegalesi) e
Pavegen, una startup
britannica non nuova a
questo genere di imprese,
che già nel 2012 riuscì a
garantire l’illuminazione
di un marciapiede a
Londra attraverso l’energia
prodotta da chi
ci camminava sopra.
Agli ormai tradizionali
pannelli solari si
aggiungono un centinaio
di piastrelle posizionate
sotto il manto erboso,
piazzate nelle zone
strategiche in cui è più
frequente il passaggio
dei giocatori in azione,
capaci di trasformare i
movimenti dei calciatori
in corrente elettrica,
producendo fino a 7
watt per ogni passo.
Il risultato è un campo
in grado di garantire
l’illuminazione stradale per
24 ore o immagazzinare
energia per usi futuri.
La scelta del luogo non
è stata casuale, ma
mirata alla realizzazione
di un progetto sociale.
La comunità di Akoka,
infatti, non ha luce né
luoghi di aggregazione e
socializzazione notturna.
Si tratta solo di un primo
passo, perché se il risultato
su un campo da calcio può
sembrare straordinario,
non è difficile immaginare
l’efficacia che la stessa
tecnologia potrebbe avere
se applicata ai marciapiedi
e ai pavimenti di scuole
e centri commerciali
delle metropoli.
L’Unione africana ha già
previsto investimenti da
venti milioni di dollari per
le energie rinnovabili nel
prossimo decennio e lo
sviluppo di questa nuova
tecnologia potrebbe
rappresentare un ulteriore
passo avanti. «Il progetto
mostra come il futuro delle
rinnovabili sia combinare
il potere dell’energia
cinetica e di quella solare»,
ha spiegato il fondatore
di Pavegen, Laurence
Kemball‑Cook.
L’iniziativa ha però
sollevato diversi dubbi:
la quantità di elettricità
prodotta sarà sufficiente
a compensare i costi della
tecnologia utilizzata?
E quelli per il suo trasporto
sul luogo? Non è forse
meglio puntare su energie
rinnovabili già collaudate
e avanzate come il solare
e l’eolico? La startup
inglese ha già risposto
ad alcune delle critiche,
affermando che il prezzo
delle piastrelle è già stato
abbassato notevolmente,
e se prima era il 500% in
più rispetto a quello del
normale pavimento di
un centro commerciale
africano, ora è superiore
di appena il 20%. Un
investimento che, dunque,
potrebbe davvero avere
un senso.
L U O G O
L A G O S , N I G E R I A
C O O R D I N A T E G P S
6 . 5 1 6 3 8 9 N , 3 . 3 9 0 2 2 9 E
U N C A M P O C H E P R O D U C E E N E R G I A
C A T E G O R I A
S P O R T

BEVI DIPLOMATICO RESPONSABILMENTE
IMPORTATO DA COMPAGNIA DEI CARAIBI

Non è solo un’altra stampante laser monocromatica:
Maggiori possibilità, maggiori profitti. Documenti di alta qualità, bassi
costi di manutenzione e una velocità di stampa e scansione che arriva a 50 pagine per minuto: la nuova gamma professionale Brother di
stampanti laser monocromatiche apre opportunità enterprise prima
impensabili. Brother, da sempre all’avanguardia nel mercato delle
laser monocromatiche, ha progettato la linea secondo un nuovo modo
di pensare il business delle aziende: abbassare i costi mantenendo volumi elevati di stampa e qualità senza compromessi, e rendendo
ogni operazione facilmente gestibile dai gruppi di lavoro. Per fare
della stampante, la spina dorsale degli uffici di grandi dimensioni,
uno strumento in grado di generare nuovi profitti. Sono tredici i modelli della gamma, tutti dotati delle soluzioni tecnologiche Brother
più avanzate in fatto di stampa, scansione, copia e fax. L’affidabilità certificata e la possibilità di creare soluzioni di stampa esclusive, grazie a una piattaforma software a interfaccia aperta, rendono possibile
una maggiore produttività e un controllo totale sul flusso di lavoro. Brother non produce solo stampanti, ma si propone come partner
per sviluppare progetti e soluzioni ad hoc e fornire servizi di assistenza
tecnica, garantendo un supporto completo alle aziende per una
migliore gestione dei processi di stampa.
è un nuovo modo di pensare.
AFFIDABILITÀ A LUNGO TERMINE
Le nuove laser
mono, dalla
qualità costruttiva
ancora migliorata,
sono garantite
per prestazioni
ottimali più
durature, con un
volume di stampa
mensile massimo
di 150.000 pagine.
STAMPA MOBILE
PrintSmart Mobile, soluzione basata su
cloud, offre la possibilità
di stampare da qualsiasi
dispositivo mobile in modo
rapido e sicuro, un sistema
ideale per le aziende con
personale in movimento.
NFC, utilizzabile anche
per la stampa diretta da
dispositivi mobile Android
compatibili.
www.brother.it
FACILITÀ D’USO
I nuovi pannelli
touch a colori
da 12,3 pollici
aumentano
le possibilità
di controllo
dei processi
di stampa.
L’interfaccia BSI (una novità in
questa classe
di stampanti)
permette
una facile
implementazione
di software
su misura e la
distribuzione
su una ampia
gamma di
dispositivi. E la
tecnologia NFC,
solitamente
impiegata per
uffici di livello superiore, è ora
alla portata di
tutti.
ALTA PRODUTTIVITÀ
Il nuovo
processore
Cortex-A9 a
800 MHz, con
memoria da 1
GB, permette un
tempo di stampa
della prima pagina
inferiore ai 7,5
secondi e una
elevata velocità di
stampa fino a 50 pagine al minuto.
La capacità di
carta in ingresso
arriva a 2650 fogli
e quella in uscita
a 1050, grazie
all’unità mailbox
opzionale.
SICUREZZA
Per soddisfare le
esigenze aziendali
sui massimi livelli
di sicurezza,
Brother ha
integrato i sistemi
Active Directory,
Secure Function Lock 3.0 e Internet
Protocol, oltre
alla connettività
NFC per
l’autenticazione e
l’accesso sicuro
degli utenti.
FLUSSO DI LAVORO MIGLIORE
I gruppi di lavoro dagli
elevati volumi di attività
possono trarre vantaggio
dal supporto ai diversi
formati, dalla scansione
fronte-retro ad alta velocità,
dalla connessione ai
servizi basati su cloud
(Microsoft SharePoint) e dai report professionali e
personalizzabili.
COSTO DI GESTIONE CONVENIENTE
La nuova gamma
Brother lavora
con toner ad
altissima capacità
(20.000 pagine),
tamburo da
50.000 pagine e
fusore da 200.000
pagine. Il software
PrintSmart offre
una visibilità
completa del
comportamento
degli utenti
aziendali, per il
contenimento
dei costi e una
migliore efficienza operativa.

Con Brother al vostro fianco, le possibilità sono infinite.
P E R B R O T H E R



Guangzhou
A S I A
1
pag. 162
pag. 148
pag. 167
pag. 163
pag. 168
pag. 164
pag. 170
pag. 165
pag. 171
pag. 166
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
Tel Aviv
Sagarmatha National Park
Hengdian
Suzhou
Tokyo
Amman
Hatzeva
Baikonur
Bangalore


W I R E D / N. 2 / P R I M AV E R A 2 01 6
LA
SI
LI
CO
N V
AL
LE
Y
D’
OR
IE
NT
E
DA
VID
LI:
NE
L 2
010
HA
CO
FO
ND
AT
O
XIN
CH
EJI
AN
, IL
PR
IMO
HA
CK
ER
SP
AC
E
CIN
ES
E,
US
AT
O O
RM
AI
DA
MIG
LIA
IA
DI
IMP
RE
ND
ITO
RI
E C
RE
AT
IVI

TESTO DI
CLIVE THOMPSON
CAPITOLO 5
ASIA
QUADRANTE MAPPA
M8
BASTA IMITARE L’OCCIDENTE: IN CINA DECINE
DI MIGLIAIA DI GIOVANI INNOVATORI
E IMPRENDITORI NON CERCANO PIÙ LAVORO
IN GOOGLE O APPLE MA VOGLIONO CREARE
LA PROSSIMA GOOGLE E LA NUOVA APPLE
LUOGO
GUANGZHOU, CINA
COORDINATE GPS
23.141117 N, 113.275889 E
TRADUZIONE DI
MICHELE PRIMI
FOTO DI
ZACHARY BAKO

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
IL G
IOV
AN
E P
RO
GR
AM
MA
TO
RE
DI
YY
, M
O W
EN
GA
NG
, H
A L
AN
CIA
TO
UN
IN
NO
VA
TIV
O −
E P
RO
FIC
UO
−
SE
RV
IZIO
DI
DA
TIN
G I
N S
TR
EA
MIN
G

C A P. 5 / A S I A
1 5 1
15 0
o Wengang, un giovane programmatore, ha un’idea e tutti pensano che sia matto. Ap-
pena uscito dal college, ha trovato lavoro a Guangzhou, l’enorme città sul delta del
Fiume delle Perle, in una società chiamata YY: vanta oltre cento milioni di utenti che,
ogni mese, trasmettono in streaming o seguono le trasmissioni di altri mentre canta-
no, giocano ai videogame e conducono talk show dai loro appartamenti di Pechino. Il
pubblico interagisce con messaggi vocali o scritti.
Anche se YY funziona bene, Mo pensa che sia il momento di provare qualcosa di nuovo, di usa-
re quell’efficiente tecnologia streaming per un servizio di dating. Dovrà funzionare come uno show
televisivo: il conduttore crea un salotto virtuale poi invita dei single e li convince a scambiarsi infor-
mazioni per trovare, forse, un partner. I suoi superiori sono dubbiosi: «L’amministratore delegato ha
quasi cestinato l’idea», dice il chief financial officer Eric Ho nel suo ufficio nella sede della YY, un edifi-
cio a tre piani pieno di ingegneri e designer che digitano furiosamente codici su codici. «Sei sicuro di
volerlo fare?», chiede al ragazzo. «A me pare una cosa stupida, non credo che alla gente piacerà». Mo
Wengang però è convinto e insistente, quindi gli dicono di provare.
In Cina, fino a dieci anni fa, impiegati così non esistevano. Gli osservatori tecnologici, non a
caso, lamentavano nel Paese la mancanza di innovatori coraggiosi. C’erano società che facevano otti-
mi profitti, com’è ovvio, ma raramente osavano correre rischi e provavano a essere creativi. Si limi-
tavano a imitare la Silicon Valley: Baidu era una copia di Google, Tencent di Yahoo, JD una versione
cinese di Amazon. La preparazione e le capacità dei programmatori cinesi non erano seconde a quelle
di alcuno, ma nessuno aveva la spinta innovativa di un Mark Zuckerberg o di uno Steve Jobs. Quel
mantra così West Coast, «sbaglia in fretta e sbaglia spesso», che li aveva guidati nella creazione di
prodotti sempre migliori, era del tutto estraneo e considerato un gravissimo pericolo da intere ge-
nerazioni di giovani formati in un rigido sistema educativo, basato su apprendimento mnemonico e
punizione severa degli errori.
laureati cinesi aspiravano a un posto di lavoro in una grande, solida azienda. Il loro
obiettivo era la stabilità. Le città erano appena uscite da decenni di povertà e la cam-
pagna perlopiù doveva ancora farlo. Meglio tenere la testa bassa, non rischiare. Un
atteggiamento che oggi sta cambiando, spazzato via da un aumento della prosperi-
tà che ha alzato il livello di consapevolezza e coraggio tra i giovani urbani esperti di
tecnologia. Nel 2000, solo il 4% dei cinesi apparteneva alla classe media (cioè con un
reddito annuo compreso tra 9 e 34mila dollari); nel 2012 la percentuale è salita a due terzi della popo-
lazione. Anche l’istruzione di livello secondario è cresciuta al ritmo di 7 milioni di diplomati all’anno.
Risultato: è emersa una generazione creativa e allo stesso tempo pronta a correre dei rischi.
«Ci sono ragazzi di appena vent’anni che fondano aziende. Alcuni sono appena usciti dal college, altri
nemmeno hanno completato gli studi», dice il venture capitalist Kai-Fu Lee, un veterano di Apple,
Microsoft e Google che nel corso dell’ultimo decennio ha attraversato il Paese in lungo e in largo per
sostenere le giovani imprese. Oggi le maggiori città della Cina sono piene di ambiziosi innovatori e
imprenditori che si riuniscono negli hackerspace e negli acceleratori. Giovani che non cercano più
lavoro da Google o Apple: vogliono creare la prossima Google e la prossima Apple. Chiunque abbia
un’idea promettente e un po’ di esperienza, trova i fondi necessari a realizzarla. L’anno scorso nelle
M
I

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
startup cinesi è stata pompata la cifra record di 15,5 miliardi di dollari; gli imprenditori sono lette-
ralmente coperti di denaro, mentoring e consigli da parte di investitori milionari (anche se è solo
una piccola fetta della torta del venture capital americano, arrivata nel 2014 a 48 miliardi di dollari,
a essere destinata alla Cina).
Persino il governo di Pechino, molto diffidente verso la rete e a capo di un vasto apparato di
censura online, ha creato un fondo di 6,5 miliardi per le startup; visto il rallentamento della crescita
economica dopo quasi due decenni di espansione vertiginosa, il Partito cerca opportunità per creare
nuovi posti di lavoro. Il settore tecnologico serve perfettamente il bisogno. Il nuovo boom comprende
sia i servizi online che la produzione di hardware. Recenti successi come Xiaomi, la compagnia tele-
fonica mobile della capitale, o WeChat, l’app di social networking di Tencent che sta conquistando il
mondo, funzionano da apripista. Le società cinesi godono di vantaggi evidenti rispetto a quelle stra-
niere, quali la familiarità con i gusti e le abitudini locali, per esempio; o la possibilità di collegamento
a un sistema produttivo di primo livello (creato per soddisfare proprio le esigenze delle compagnie
occidentali) e la vicinanza con i mercati che nel mondo crescono più velocemente, come l’India e il Sud
Est asiatico. Questa combinazione di fattori le mette in condizione di battere l’Occidente sul suo stes-
so campo. Non a caso, l’anno scorso Xiaomi è stata la compagnia di telefonia mobile che ha venduto di
più al mondo, subito dopo Samsung, Apple e Huawei.
er YY, tollerare l’intraprendenza del giovane programmatore è stata una decisione
azzeccata. Il servizio di dating, lanciato nel corso del 2014, è stato un sorprendente
successo e produce notevoli profitti. Il colosso di Guangzhou non ha pubblicità, genera
entrate solo quando gli utenti comprano oggetti virtuali (pagati con soldi veri) da re-
galare ai broadcaster che mettono in streaming la loro vita: i più celebri guadagnano
veramente tanto, al punto di riuscire a mantenersi grazie a YY che, da parte sua, si
tiene il 60% di ogni acquisto e versa al beneficiario il resto in contanti.
Osservo il laptop di Eric Ho e vedo come si sviluppa un incontro. I soldi volano, mentre l’uomo
e la donna si scambiano regali virtuali: anelli (1 dollaro e 55 centesimi), baci (16 centesimi) e lettere
d’amore (5 centesimi). Ci sono anche doni più costosi: per circa mille dollari puoi regalare a qualcuno
una Lamborghini virtuale. Nei primi nove mesi, nelle casse di YY sono entrati 16 milioni di dollari,
somma che cresce rapidamente. L’intera società ha guadagnato 580 milioni, e tre anni dopo essere
stata quotata al Nasdaq il valore di mercato supera i 3 miliardi, nonostante gli sbalzi subiti dal mer-
cato nel corso del 2015. La prossima Silicon Valley è arrivata, e si trova in Oriente.
Il boom tecnologico di fine anni ’90 ha regalato alla Cina il suo web 1.0: motori di ricerca, stru-
menti per la comunicazione via email e blog, nuovi portali e l’enorme sito di ecommerce Alibaba. A
quel tempo, Pechino aveva bisogno di creare copie pressoché esatte delle grandi società america-
ne perché per le aziende straniere operare nel paese era tutt’altro che facile, visto che il governo
bloccava i siti esteri usando un complesso sistema di filtri noto come “Il Grande Firewall cinese”. Le
imprese locali, inoltre, avevano un vantaggio: comprendevano le particolari esigenze dei “digerati”
(digital+literati, termine con cui John Brockman, nel libro omonimo, indica l’élite della computer in-
dustry e delle online community, ndr) cinesi dei primi anni del terzo millennio, quando l’accesso alla
rete era ancora scarso.
P

C A P. 5 / A S I A
1 5 3
152
Un esempio: dieci anni fa eBay ha provato a conquistare la Cina e ha fallito, anche perché molte
attività locali (che in altri paesi avrebbero usato eBay per vendere nel mondo) non avevano la con-
nessione a internet. Nemmeno un computer, a volte. Il fondatore di Alibaba, Jack Ma, l’ha capito e ha
creato una forza vendita sparsa su tutto il territorio per insegnare a ogni singolo venditore come con-
nettersi; poi ha surclassato il sistema PayPal, usato da eBay, con il suo Alipay, che tiene il pagamento
in garanzia finché il compratore non ha ricevuto la merce e si è dichiarato soddisfatto. Mossa che ha
contribuito a creare fiducia nel sistema degli acquisti online.
Cavalcando l’onda, Baidu e Alibaba sono diventati i “grandi dragoni” cinesi e hanno creato una
miriade di milionari, come già aveva fatto Microsoft negli Anni ’90. Poi, dal 2000 in poi, il successo
delle aziende-fotocopia ha aperto la strada ai “piccoli dragoni”, società creative del web 2.0 venute
fuori dal nulla. Le prime, dunque, hanno fornito un modello di riferimento e, più importante, hanno
costruito le infrastrutture cruciali per il boom tecnologico, tra cui i servizi di cloud che permettono a
qualsiasi ventenne di lanciare un’attività da un giorno all’altro e iniziare subito a fatturare.
eituan è fra le realtà di maggior successo di questa seconda ondata. È diventata un
gigante dell’ecommerce perché ha saputo dare ai piccoli commercianti − se registrati
sul suo sito o attraverso una app mobile − la possibilità di mandare offerte ai compra-
tori più vicini. Il quartier generale di Pechino sembra una foresta tropicale, con gran-
di piante verdi fra le postazioni di lavoro e condizionatori che muovono lentamente
nuvole d’aria umida. C’è un profondo silenzio, girano tanti soldi. Sulla testa di decine
di programmatori, uno schermo grande come un tavolo segna 8309, cioè il numero di affari conclusi
solo oggi. Nei primi cinque anni di vita, le statistiche di Meituan sono balzate alle stelle: nel 2014 ha
processato transazioni del valore di 7 miliardi di dollari per i suoi 900mila partner, ed entro la fine
del 2015 conta di raggiungere quota 18,5 miliardi.
Wang Xing, il cordiale ed elegante amministratore delegato, è un imprenditore esperto che ha
seguito da vicino il cambiamento creativo delle startup cinesi. Aveva già lavorato alla realizzazione
di cloni di Facebook e Twitter, poi nel 2008 ha notato l’ascesa rapida di Groupon: «Ci ha influenzato,
senza dubbio», ammette. Era già abbastanza esperto da notare i difetti di quel modello di business,
che tratteneva per sé larga parte del ricavo di ogni transazione, lasciando insoddisfatti i venditori: a
ragione, visto che perdevano soldi a ogni offerta. Ma stringevano i denti sperando – perlopiù invano
– che il sistema procurasse loro clienti fissi. A Wang, invece, interessava che Meituan diventasse per i
piccoli commercianti il modo più facile per trarre profitto dai clienti e rimanere in contatto con loro;
quindi ha fissato la percentuale di profitto al 5%, in modo che comunque guadagnassero.
Ha anche iniziato a sviluppare una tecnologia proprietaria per l’ecommerce; sul cellulare, mi
mostra alcuni esempi. I suoi uomini hanno raggiunto i cinema di tutto il paese e collegato a Meituan il
sistema di prenotazione dei biglietti; oggi il pubblico può non solo comprarli sul sito della società, ma
anche scegliersi il posto. Clicca su Lo Hobbit: «Non devi aspettare in coda, non sei costretto a parlare
con qualcuno: ti avvicini alla macchina e scansioni il codice». Elegante, semplice. Oggi un terzo di
tutti i biglietti vengono acquistati su Meituan, pari al 10% del fatturato 2014.
Una mossa astuta, visto che oggi la classe media cinese ha crescenti necessità di servizi e ri-
sparmio. Sono persone, vestite all’ultima moda europea, che estraggono costosi cellulari per fare
M

W I R E D / N. 2 / P R I M AV E R A 2 01 6

C A P. 5 / A S I A
1 5 5
15 4
GL
I U
FF
ICI
DI
YY
A G
UA
NG
ZH
OU
:
IL S
OC
IAL
NE
TW
OR
K,
NA
TO
NE
L 2
00
5,
È Q
UO
TA
TO
AL
NA
SD
AQ
E I
L S
UO
VA
LO
RE
DI
ME
RC
AT
O S
UP
ER
A
I 3
MIL
IAR
DI
DI
DO
LL
AR
I

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
IN A
LT
O,
LA
PR
OV
A D
I U
N S
EN
SO
RE
DA
GO
LF
NE
LL
A S
ED
E D
I Z
EP
P L
AB
S A
PE
CH
INO
. S
OT
TO
, IM
PIE
GA
TI
E O
PE
RA
I
DE
LL
A S
TA
RT
UP
, F
INA
NZ
IAT
A C
ON
1,5
MIL
ION
I D
I D
OL
LA
RI

C A P. 5 / A S I A
1 5 7
15 6
praticamente qualsiasi cosa: pagare con Alipay il taxi fino a un festa in una zona bohémienne della
periferia di Pechino, indicare su WeChat la propria posizione in modo che gli amici possano raggiun-
gerli, postare selfie su Meitu, un servizio di condivisione foto con filtri di bellezza incorporati. Nel
2013, questa borghesia ha destinato ai servizi il 44% delle proprie spese annuali, quota che secondo
gli esperti di McKinsey salirà al 50 entro il 2022.
I giovani abitanti delle città useranno i telefonini per fare spese folli e comprare qualsiasi cosa,
dai massaggi al cibo a domicilio, dalle sedute dal parrucchiere a quelle nei beauty salon. Anche il crol-
lo di mercato del 2015 non sembra aver frenato i consumi. A ottobre durante la festa nazionale della
“Settimana d’oro”, in cui i cinesi per tradizione vanno tutti in vacanza, le prenotazioni sono salite del
70% rispetto all’anno precedente e a parere degli analisti di Merrill Lynch e Bank of America i viaggi
all’estero sono aumentati del 36,6.
ecommerce, già piuttosto forte in Cina, ha possibilità di crescita impressionanti, an-
che perché un numero enorme di servizi non è ancora in rete. Un esempio? Solo un
quinto delle stanze d’albergo viene prenotato online. La gente desidera l’ecommerce
non solo per la convenienza, ma anche perché è più trasparente e meno corrotto delle
attività legate a strutture aziendali fisiche. Kai-Fu Lee sottolinea che queste ultime
sono, per gli standard americani, infestate dall’inefficienza e da una politica di vendita
da imbonitori d’assalto: «Negli Stati Uniti, secoli di concorrenza leale hanno dato vita a un sistema di
commercio onesto, limpido», ma in Cina non è così. «Se vuoi vendere una proprietà immobiliare non
c’è trasparenza. Se vuoi comprare un’auto di seconda mano, non trovi consulenti come Ralph Nader
o servizi come Consumer Report...». Eliminando gli intermediari e creando un sistema basato sulla
reputazione, le aziende di ecommerce rendono le transazioni più sicure: «E una soluzione basata sulla
tecnologia mobile sarebbe addirittura migliore», aggiunge Lee.
La corruzione è solo una delle grandi sfide che la Cina deve affrontare e vincere. Gli investitori
sono costretti a vedersela anche con un sistema bancario non trasparente, con garanti delle leggi cor-
rotti, con un inquinamento dilagante, un recente giro di vite sul dibattito politico e una popolazione
rurale desiderosa di trovare lavoro in città. Il Partito comunista sarà in grado di risolvere tutti questi
problemi? Non è chiaro a tutt’oggi. Nel breve periodo, comunque, la febbre dell’oro tecnologico ha
creato una competitività feroce: appena si inaugura una nuova categoria di prodotti, l’offerta si spar-
ge a macchia d’olio e istantaneamente fra decine − spesso centinaia − di imprenditori. In confronto,
quella in America è minima. Un esempio? Ci sono solo due società, Uber e Lyft, che fanno a botte per
contendersi il settore dell’autonoleggio.
Lee stima che Meituan abbia dovuto combattere contro almeno tremila concorrenti sparsi per
tutto il paese: chi riesce a rimanere in piedi, come Wang, diventa più agguerrito. A metà strada fra
la vecchia e la nuova guardia, si è trasformato anche lui in un investitore alla ricerca di giovani con
idee coraggiose da trasformare in nuovi “piccoli dragoni”. Una delle società su cui sta investendo si
chiama eDaijia: è un servizio che consente di trovare qualcuno che guidi la tua auto quando hai bevu-
to troppo. «Sono già una potenza qui da noi e l’anno scorso si sono allargati a Seoul», mi dice con una
risata. «Pare sia la città al mondo in cui la gente si ubriaca di più». La Cina dunque vive un notevole
boom dei servizi via web, ed è in vantaggio rispetto all’America anche dal punto di vista dell’hardwa-
L’

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
re. Negli ultimi 30 anni è diventata il centro manifatturiero del mondo: oggi città della costa come
Shenzhen e Guangzhou traboccano di attività legate all’elettronica, dai piccoli negozi gestiti da tre
persone allo stabilimento Foxconn, in cui 30mila dipendenti producono gli iPhone. Gli imprenditori
locali hanno una profonda competenza sulla realizzazione di oggetti di ogni tipo, conoscono il mer-
cato dell’elettronica e vivono vicino alle fabbriche: sono i primi a scoprire nuovi trend. Per esempio,
se è in arrivo un sensore che permette di raccogliere diversi tipi di dati o se il costo di un altro crolla
fino a un centesimo, finendo per spargersi ovunque come polvere.
n Cina è più facile che altrove perché c’è Shenzhen», mi dice Robin Han, co-fondatore
di Zepp Labs. È una startup di Pechino adorata dagli sportivi. Produce un sensore che
traccia il vostro colpo (di mazza da golf e da baseball o di racchetta da tennis), poi usa
un’app dell’iPhone che vi consente di migliorarlo.
La febbre dell’imprenditoria l’ha conquistato cinque anni fa mentre, termina-
to il dottorato di ricerca, lavorava alla sede di Microsoft nella capitale. La vita nelle
grandi aziende è sicura e stabile, ma rischi di passare anno dopo anno a elaborare e a perfezionare
progetti che potrebbero non diventare mai dei prodotti. «Il successo è comunque fuori dalla tua pos-
sibilità di controllo», mi dice, mentre dietro a lui due dozzine di programmatori e designer digitano
sulle tastiere. Han aveva previsto che i giroscopi usati nei telefoni Htc e Hp, oltre che nelle console
Nintendo Wii, sarebbero scesi di prezzo dato che le grandi aziende continuavano a inserirli nei loro
prodotti. Quindi ha intravisto un potenziale.
Lui e il suo amico Peter Ye (oggi capo del dipartimento ricerca e sviluppo della Zepp) sono ap-
passionati di sport e hanno subito pensato a un sensore con cui i giocatori fossero in grado di analiz-
zare i propri movimenti per confrontarli con quelli dei professionisti; e i trainer potessero esaminare
anche a distanza la preparazione di un’intera squadra. Hanno iniziato dal golf, immaginando che
i più incapaci sarebbero stati disposti a spendere molto per un sensore che consentisse loro di mi-
gliorare. Mi portano nel sotterraneo, dove hanno costruito una grande gabbia da pratica: «Qui sotto
abbiamo passato ore e ore a perfezionare i sensori e a fare pratica», dice Han. Le pareti sono costellate
dai segni dei colpi sbagliati.
Il prototipo funzionava talmente bene che ha attirato l’attenzione di un rappresentante di Ap-
ple che girava in lungo e in largo la Cina alla ricerca di nuovi prodotti. Per soddisfare i precisi canoni
estetici della casa di Cupertino, però, Han e Ye hanno dovuto raffinare il design e fare altri 14 proto-
tipi, ma alla fine lo sforzo è stato ripagato: da quando, nel 2012, sono usciti nell’Apple Store in tutto il
mondo, Zepp ne ha attivati circa 300mila.
Han e Ye hanno fatto partire Zepp Labs con un investimento di 1,5 milioni di dollari da parte
dell’investitore “informale” Xiao Wang e hanno sfruttato i loro contatti per scovare una buona fab-
brica in cui creare il prototipo e attivare la produzione di massa. Quest’ultimo passo − trovare un’in-
dustria al livello di Foxconn − in Cina è da sempre un problema; negli ultimi anni però la situazione
è migliorata grazie a una serie di intermediari che si sono attivati per chiudere il gap. Il programma
Highway1, per esempio, lanciato dal gigante manifatturiero Pch, sceglie in tutto il mondo i migliori
inventori di gadget e trova fabbriche di alto livello disposte ad assumersi il rischio di costruire i pro-
dotti creati da questi sconosciuti talenti emergenti.
«I

C A P. 5 / A S I A
1 5 9
15 8
Poi ci sono gli hackerspace. Il primo, chiamato XinCheJian, è nato a Shanghai nel 2010. L’im-
prenditore David Li l’ha fondato dopo che la riduzione dei prezzi degli strumenti di prototipazione
aveva permesso a tutti gli inventori amatoriali di creare campioni di qualità sempre più alta. Ora
arrivano da tutta la Cina e si mischiano con altri rientrati da esperienze all’estero. L’imprenditore
organizza anche visite nelle fabbriche per aiutarli a capire il funzionamento dell’ecosistema locale.
È come una palestra: i soci di XinCheJian pagano una quota mensile per avere accesso agli
strumenti dell’hackerspace e, cosa più importante, al network. «Mi piace incoraggiare le persone:
create il vostro prototipo in fretta, cercate dei produttori che entrino in società con voi e portate a
termine la campagna su Kickstarter», mi dice Li, seduto davanti a un frigorifero su cui campeggia
un adesivo con scritto: «Fate stronzate epiche». Le stanze di XinCheJian sono piene di torni per me-
tallo, parti elettriche e file di stampanti 3D. Le cuffie Wearhaus, che consentono di inviare musica in
streaming dal proprio cellulare ad amici, compagni di studio o colleghi, sono un prodotto di successo
emerso recentemente proprio da qui. La prima fornitura di tremila pezzi è andata esaurita, una se-
conda più consistente è già in produzione.
l vertice del boom del settore tecnologico cinese risiede in quattro torri di uffici alla
periferia di Pechino, che incombono su una distesa di condomini. È il quartier gene-
rale di Xiaomi, azienda fondata nel 2010 e diventata celebre per aver creato telefonini
comparabili all’iPhone (con processori molto veloci, schermi di grandi dimensioni e
un impeccabile sistema operativo chiamato Miui) che però costano la metà. È famosa
anche per aver scelto di vendere soprattutto online e per la crescita esplosiva: l’anno
scorso ha venduto 61 milioni di apparecchi e, per buona parte del 2015, è stato il marchio di telefonia
mobile leader in Cina. Secondo gli investitori, l’anno scorso valeva 45 miliardi di dollari.
È il perfetto esempio di azienda privata nata dall’esperienza di un imprenditore che dieci anni
fa ha potuto commettere i suoi primi errori e su quelli creare una fortuna. Lei Jun, amministratore
delegato di Xiaomi, aveva creato e poi venduto ad Amazon un rivenditore di libri online chiamato
Joyo; quindi è diventato un investitore e ha scommesso sulla prossima generazione di innovatori,
stringendo contatti con i più brillanti giovani designer e ingegneri del paese.
Nel 2010, quando già si era affermato un nuovo modello di vendita nel settore della telefonia
mobile, ha creato Xiaomi, ha arruolato un team di talenti, ha prodotto in breve tempo un bellissimo
sistema operativo e ad agosto l’ha messo in rete. Gli appassionati di tecnologia l’hanno subito amato,
ma solo i nerd avevano voglia di scaricare l’ennesimo sistema operativo, potenzialmente insidioso,
sui loro apparecchi: quindi Xiaomi ha capito di dover produrre e vendere i propri telefoni. Si è appog-
giato a Foxconn e nel frattempo ha messo a punto un sistema di vendita molto efficace: ogni nuovo
modello viene messo in vendita in quantità limitate, tipo 50mila unità, con una flash sale settimanale
sul sito dell’azienda. L’esclusività fa impazzire gli appassionati; i pochi fortunati che riescono a pro-
curarselo lo mostrano agli amici hipster invidiosi mentre Xiaomi ne ha già lanciato sul mercato un
altro, per soddisfare la domanda generale.
Il suo ufficio è luminoso e decorato con grandi quadri. C’è anche un cane randagio adottato dai
dipendenti, che dorme in una cuccia al primo piano. Una rampa di scale più in alto, gli operatori del
customer service cercano di risolvere i problemi di utenti sparsi in tutto il mondo. Perché il mercato
I

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
RO
BIN
HA
N,
32
AN
NI:
CO
N P
ET
ER
YE
,
DIR
ET
TO
RE
RIC
ER
CA
E S
VIL
UP
PO
, H
A
FO
ND
AT
O A
PE
CH
INO
LA
SO
CIE
TÀ
DI
HA
RD
WA
RE
PE
R L
O S
PO
RT
ZE
PP
LA
BS
XIAOMI, FONDATA NEL 2010, HA PRODOTTO
TELEFONINI COMPARABILI ALL’IPHONE. NEL 2015
HA VENDUTO 61 MILIONI DI PEZZI: SECONDO GLI
INVESTITORI, VALE 45 MILIARDI DI DOLLARI

C A P. 5 / A S I A
1 6 1
16 0
più importante di Xiaomi è la Cina, ma nel 2013 l’azienda ha assunto Hugo Barra, ex product manager
di Google e Android, per gestire l’espansione globale. «Questi sono i cellulari di una generazione che
non avrà mai accesso a un computer e che scopre internet attraverso il telefono», spiega. Il vantag-
gio di Xiaomi, aggiunge, consiste nel produrre in continuazione nuovi aggiornamenti. «Costruiamo
hardware con un approccio software e aggiorniamo il software ogni settimana». Per esempio ren-
dendo visibili i feedback dei fan più appassionati: ogni post lanciato dal team sui forum dell’azienda
può ricevere fino a 100mila risposte, con interminabili discussioni sulle ultime modifiche del sistema
operativo. La disponibilità a comunicare con i clienti è un fattore cruciale per capire le esigenze dei
più giovani e coltivarne la devozione maniacale.
Xiaomi, che vende i propri telefoni praticamente a prezzo di costo, guadagna grazie ad accesso-
ri come le cuffie, il contapassi da polso o le interfacce grafiche del sistema operativo vendute nell’app
store. La speranza è che altre entrate arrivino dalle transazioni di utenti che comprano qualsiasi
cosa, dai pasti ai biglietti aerei, ai vestiti. Ma per scoprire la visione del futuro dell’azienda bisogna
scendere al piano di sotto, nel sobrio ed elegante showroom pieno di gadget della internet of things,
tutti utilizzabili in remoto, che l’azienda immette sul mercato. Una piccola lampadina, una webcam
connessa, una bilancia, una televisione, una presa di corrente multipla e un depuratore d’aria, sem-
pre più fondamentale in una nazione dove l’inquinamento è fuori controllo. Se acquisti uno di questi
prodotti, dice Barra, comprerai anche gli altri, perché lavorano benissimo insieme. «Il gioco, in Cina,
è costruire giardini recintati e poi fare in modo che la gente venga nel tuo giardino».
Xiaomi non ha progettato e prodotto tutto questo hardware da sola. I dirigenti sono andati a
caccia delle startup più innovative del paese, hanno investito e richiesto che producessero con un
design al livello di quello di Apple. È sorprendente vedere come questo ecosistema si espanda: il ter-
mostato con telecamera incorporata Nest, primo tentativo di Google di entrare nella internet delle
cose, sembra di un’altra epoca. In altre parole: la nuova generazione di creativi cinesi ha dimostrato
di essere pronta a competere con i marchi più importanti. «Apple e Samsung fanno bene a essere
preoccupati», dice l’hacker Nunie Huang. Infatti la quota di Samsung nel mercato globale degli smar-
tphone è calata dal 32,2% del 2012 al 21,4 del secondo quarto del 2015.
uando si parla di hardware, gli inventori cinesi beneficiano della vicinanza con la base
di consumatori più grande del mondo, in rapida crescita. La prima espansione all’este-
ro di Xiaomi è stata verso l’India, più grande e più povera degli Usa: nella seconda par-
te del 2014 ha venduto un milione di telefoni. Se metti insieme Cina e India, hai un ter-
zo dell’intero pianeta e gli Stati Uniti, pieni di cellulari, sembrano un piccolo mercato.
La Cina, insomma, diventa la destinazione preferita da persone con idee. Come
la Silicon Valley, una generazione fa. L’ho visto con i miei occhi quando sono passato dall’hackerspace
XinCheJian di David Li, che stava incontrando una startup formata dall’italo-olandese Lionello Lu-
nesu, che vive in Cina da otto anni, e dal sudamericano Berni War. Esaminavano un prototipo appena
arrivato: un piccolo dispositivo che rimanda i messaggi dal computer o dal telefono, come un Apple
Watch che sta sulla scrivania invece che al polso. «Per David non siamo abbastanza veloci», dice Lu-
nesu. Li prende in mano il gadget e lo tocca ai lati: «Questa è la stessa plastica dell’iPhone 5c». I due
giovani imprenditori sorridono: non esistono opportunità simili negli States. Ecco perché sono qui.
Q

C A P I T O L O 5
A S I A
Q U A D R A N T E M A P P A
A6
F E D E R I C O B O N A
P A R O L E C H I A V E
BATTERIE, REALTÀ VIRTUALE, VIBER, WAZE
L A C A P I TA L E D E L L E S TA R T U P
C A T E G O R I A
H I - T E C H
C O O R D I N A T E G P S
3 2 . 0 8 5 5 6 8 N , 3 4 . 7 8 1 7 0 4 E
L U O G O
T E L A V I V , I S R A E L E
Israele si è guadagnata da
tempo il soprannome di
“Startup Nation” e la sua
capitale, in questo senso,
è senza dubbio Tel Aviv. Il
segreto? L’internazionalità:
ben 90 aziende israeliane
sono quotate al Nasdaq
di New York, per un valore
che supera i 40 miliardi
di dollari. Nel frattempo,
incubatori e acceleratori
si sono diffusi a macchia
d’olio: il primo risale al
2011, ora sono già oltre
200. Quindi Tel Aviv, con
una densità di startup che
viaggia intorno a una ogni
mille abitanti, in questa
categoria batte tutte le
nazioni europee.
Reti di comunicazione
e sicurezza sono
tradizionalmente la
specialità delle imprese
locali, grazie anche alla
collaborazione con le
forze armate, che in questi
ambiti sono sempre
all’avanguardia; ma la
scena sta cambiando
con rapidità e le nuove
scommesse promettono
soluzioni di ultima
generazione in moltissimi
settori. Sì, perché se Waze,
la app di navigazione
basata sulle informazioni
messe a disposizione
dai suoi stessi utenti
(nata nel 2009 sulla
base di una community
locale e acquistata da
Google nel 2013), oppure
Viber, la piattaforma
di instant messaging e
comunicazione, lanciata
nel 2010, sono già storia, la
lista dei debutti col botto
in Borsa è in continuo
aggiornamento: Wix, la
piattaforma cloud per
sviluppare siti web che
nel 2013 ha raccolto 750
milioni di dollari nel giorno
dell’esordio al Nasdaq, ne è
un buon esempio. Le nuove
società da tenere d’occhio?
StoreDot, per esempio,
che potrebbe risolvere d’un
colpo i problemi di “carica”
che affliggono smartphone
e auto elettriche visto che
promette batterie, basate
su molecole organiche
sintetizzate in laboratorio,
che si ricaricano a fondo in
30 secondi nel primo caso
e in 5 minuti nel secondo,
per un viaggio di oltre 450
chilometri.
Oppure Consumer Physics,
che ha costruito un
sensore poco più grande
di una chiavetta usb che,
grazie alla spettroscopia
molecolare, è in grado di
elencare la composizione
di qualsiasi oggetto verso
il quale viene puntata.
Dovrebbe debuttare sul
mercato quest’autunno, a
un prezzo compreso tra i
250 e i 300 euro, dopo aver
raccolto su Kickstarter ben
2 milioni 700mila dollari.
Ma non mancano realtà
che puntano sui big data.
Come Zebra Medical
Vision, che ha realizzato
un software in grado di
leggere e interpretare
radiografie e diversi tipi di
diagnostica per immagini.
Oppure, a proposito di
realtà virtuale, come Magic
Leap, che si è assicurata
un finanziamento da
542 milioni di dollari da
parte di Google e che
conta di rivoluzionare una
tecnologia ancora giovane
come questa con la sua
Cinematic Reality.
Perché il nuovo limite, a
Tel Aviv, è solo la fantasia.

C A P I T O L O 5
A S I A
Q U A D R A N T E M A P P A
I7
A L I C E P A C E
P A R O L E C H I A V E
C N R , E V O L U Z I O N E C L I M A T I C A , F I S I O L O G I A , O S S E R V A T O R I O
No, non è Parigi; no, non
è la piramide del Louvre.
Questa architettura in
vetro, acciaio e alluminio
è il Pyramid International
Laboratory, il laboratorio
scientifico più in alto di
tutto il pianeta – a 5050
metri di quota, sul versante
nepalese dell’Everest.
In funzione dal 1990,
è nato dalla volontà di
dare una “casa” a tutti gli
esploratori e ricercatori
che, pur di proseguire gli
studi legati all’altitudine,
erano costretti a lavorare
nel freddo delle proprie
tende, con generatori di
energia precari, scollegati
dalle comunicazioni e
spesso a rischio della
vita. Rappresenta un
solido rifugio per chi vuole
addentrarsi nell’ecosistema
dell’Himalaya e compiere
rilevamenti, indagare le
dinamiche dei ghiacciai,
raccogliere campioni
per l’analisi di rocce e
organismi; ma è anche e
soprattutto un luogo dove
assorbire e processare
nuove conoscenze sull’alta
montagna, direttamente in
situ e in tempo reale.
Costituisce anzitutto
un nodo essenziale per
il monitoraggio meteo,
dei livelli di ozono e
della composizione del
particolato atmosferico,
essenziale per arrivare
al cuore dell’evoluzione
climatica. Ma funziona
anche come osservatorio
a 360 gradi della natura
circostante, perché fa
perno (a dispetto delle
inevitabili difficoltà
logistiche) su una vasta
gamma di strumenti: da
semplici apparecchiature
per la geologia a una vera
e propria stazione sismica,
dai materiali necessari
all’analisi chimica a quelli
per biologia e biodiversità.
Non basta. In analogia
con la trasparenza
della costruzione, la
piramide non intende solo
indirizzare lo sguardo
verso l’esterno, ma anche
fornire un’autentica lente
d’ingrandimento degli
effetti sul corpo umano
dell’alta montagna. Per
questo, gli ospiti diventano
spesso protagonisti
di esperimenti sulla
fisiologia in alta quota,
dove gli sbalzi termici
e l’aria rarefatta alterano
la respirazione, l’apparato
cardio-circolatorio, il
metabolismo e addirittura
il sistema immunitario.
Infine la struttura in sé,
riscaldata e illuminata
esclusivamente attraverso
pannelli solari e del tutto
autosufficiente dal punto
di vista energetico: un
gioiello tecnologico che
è anche orgoglio italiano,
poiché − in collaborazione
con la Nepal Academy
of Science and Technology
− è gestito in larga parte
dall’Associazione
Ev-K2, che conta
sull’appoggio del Consiglio
nazionale delle ricerche.
C A T E G O R I A
S C I E N Z A
U N A P I R A M I D E S U L L’ E V E R E S T
C O O R D I N A T E G P S
2 7 . 8 8 3 0 3 7 N , 8 6 . 7 3 5 7 6 9 E
L U O G O
S A G A R M A T H A N A T I O N A L P A R K , N E P A L
©MARCO FERRAZZOLI/CNR

C A P I T O L O 5
A S I A
Q U A D R A N T E M A P P A
N7
M A R I N A P I E R R I
P A R O L E C H I A V E
J A C K I E C H A N , S T U D I O S , X U W E N R O N G
B E N V E N U T I A C H I N A W O O D
C A T E G O R I A
C I N E M A
C O O R D I N A T E G P S
2 9 . 1 5 1 3 1 3 N , 1 2 0 . 3 1 7 0 2 9 E
L U O G O
H E N G D I A N , C I N A
Lo studio cinematografico
più grande del mondo − più
della somma di Universal
e Paramount Studios −
non a caso si è meritato il
soprannome “Chinawood”.
Chi da Shanghai guida
per circa cinque ore in
direzione sudovest, inizia a
vedere in lontananza gli alti
e regali palazzi della Città
Proibita di Pechino alzarsi
all’orizzonte: a ospitarne
la riproduzione sono
proprio gli Hengdian World
Studios. Hanno eretto
quel gigantesco set per il
cinema orientale, in veloce
evoluzione, ma ormai funge
anche da monumento
alla splendida crescita
dell’industria di settore.
Estesi su oltre mille ettari
di terreno, gli studios
hanno prodotto più di 500
film e serie televisive: oltre
alla Città Proibita, infatti,
accolgono il più grande
Buddha (all’interno) del
mondo, cento abitazioni
fluviali della dinastia Ming
spedite dal sud del paese
e il palazzo imperiale della
dinastia Qin (visto in Hero
di Zhang Yimou). C’è anche
un vulcano che erutta
realmente e, per soli 23
dollari, offre un variopinto
spettacolo di danza. Né
mancano repliche di
strade di Hong Kong e
Guangzhou, un perfetto
delta del fiume Yangtze
e la Pure Moon Festival
Riverside Scenic Zone,
ricostruita su un dipinto
del pittore Zhang Zeduan
nel rispetto delle tradizioni
della dinastia Song.
Ma gli Hengdian World
Studios non si limitano
a fare da sfondo alle
più grandi produzioni
cinematografiche cinesi:
ormai fanno parte delle
istituzioni vitali del Paese.
Con sette milioni di turisti
all’anno, provenienti da
tutto il mondo, sono
divenuti l’arteria attraverso
cui passa il benessere sia
dell’economia nazionale
che di quella locale.
Come si apprende da
I Am Somebody, un
documentario del 2015,
la cittadina rurale di
Hengdian è passata in
pochi anni da 19 a 70mila
abitanti, attratti dalla
possibilità di un lavoro non
agricolo: i World Studios
impiegano circa tremila
comparse, che gravitano
attorno a un colossale
business creato proprio da
un ex contadino.
Xu Wenrong (oggi un
multimiliardario di 80
anni), possiede anche il
cosiddetto Vip Hotel, che
ospita stelle del calibro
di Jet Li e Jackie Chan.
Si tratta solo di uno dei
molti, lussuosi alberghi
ancorati agli Hengdian
World Studios, progettati
per ospitare ogni notte
ottomila persone, fra
quelle accorse nel
parco a tema (c’è anche
quello), che assicura ore
di divertimento in un
ambiente fantastico.

C A P I T O L O 5
A S I A
Q U A D R A N T E M A P P A
N6
M A R C O C O S E N Z A
P A R O L E C H I A V E
E C O L O G I A , L E G O , S T A M P A 3 D , W I N S U N
C A T E G O R I A
A R C H I T E T T U R A
C O O R D I N A T E G P S
3 1 . 3 0 4 0 8 0 N , 1 2 0 . 5 9 5 3 8 0 E
L U O G O
S U Z H O U , C I N A
U N A C A S A I N 2 4 O R E
Chiunque abbia giocato
con i mattoncini Lego
ha provato a costruire
una casa. Ma chiunque
abbia provato a costruire
una vera casa, sa che
impastare il calcestruzzo
non è semplice come
impilare mattoncini
colorati.
Tutto ciò era valido, però,
solo prima dell’avvento
della stampa 3D. L’azienda
cinese WinSun ha infatti
messo a punto una
particolare stampante
tridimensionale lunga 40
metri, larga 10 e alta 6,
in grado di completare
un’abitazione nel giro di
24 ore, utilizzando una
combinazione di materiali
riciclati e rifiuti industriali,
a base di cemento, di
acciaio e di fibra di vetro.
«Abbiamo acquistato gli
elementi della stampante
all’estero e l’abbiamo
assemblata in uno
stabilimento a Suzhou»,
spiega Ma Yihe, Ceo di
WinSun. «Le strutture
ottenute sono ecologiche
ed efficienti». I singoli
moduli sono realizzati in
fabbrica grazie a una pasta
a presa rapida simile a
dentifricio; poi vengono
montati sul posto per
ricomporre l’abitazione
come fosse una torta a più
strati, diminuendo scarti,
inquinamento e costi di
trasporto e manodopera.
A essere ridotti al minimo
sono anche i tempi: ciò
potrebbe renderla la
soluzione ideale in caso
di emergenze come
inondazioni e terremoti, o
di ambienti inospitali quali
per esempio le superfici
della Luna e di Marte.
L’idea originaria, in realtà,
è frutto di uno studio
approfondito dell’edilizia
cinese, divisa in due
tra una spinta costante
all’urbanizzazione e
l’ombra lunga di bolle
speculative che costellano
il mercato immobiliare e
ne drogano le quotazioni.
Grazie a simili soluzioni, i
costi sarebbero contenuti
e accessibili – non solo
per l’Asia, come dimostra
il recente accordo firmato
con il governo egiziano per
la costruzione di 20mila
unità abitative nel deserto.
L’evoluzione intanto non si
ferma. Nel 2014, l’azienda
con base a Shanghai ha
completato in un solo
giorno 10 abitazioni di
circa 200 metri quadrati
ciascuna, con una spesa
inferiore a 4500 euro per
ciascuna; nel 2015 invece
ha realizzato, all’interno
del Suzhou Industrial Park,
una palazzina di 5 piani
e una villa di 1100 metri
quadrati, ultimata da 8
operai in un mese, al costo
di 140mila euro (rispetto
alle 30 persone per 3 mesi
che servirebbero di norma).
Quest’anno, per superarsi,
WinSun ha in mente di
portare a termine i locali
degli uffici adiacenti
al prossimo Museo del
Futuro di Dubai − che verrà
inaugurato nel 2017 − con
una stima di costi inferiore
del 50-80% rispetto ai
metodi tradizionali e con
un calo degli scarti del
30-60. L’obiettivo per i
prossimi 5 anni è, infine,
l’espansione in venti paesi
e l’apertura di 100 nuovi
impianti in Cina.
Anche la Grande Muraglia,
d’altra parte, è stata eretta
una pietra alla volta.

C A P I T O L O 5
A S I A
P A R O L E C H I A V E
C H I L O M E T R O Z E R O , C O L T U R E S E N Z A S O L E , V I T A M I N E
“Zinnia L., 1759”, originaria
del Messico, ha aperto i
suoi petali color arancio lo
scorso 15 gennaio: così il
mondo ha potuto celebrare
l’eccezionale fioritura
di una pianta all’interno
della Stazione spaziale
internazionale.
Ma sono decenni che
gli scienziati studiano
lo sviluppo di vegetali
in assenza di terreno e
luce solare. «Pochi forse
sanno che il sistema
idroponico è nato una
ventina di anni fa come
esperimento per provare a
coltivare vegetazione nello
spazio», racconta Hiroyuki
Watanabe dell’Università
di Tamagawa, vicino a
Tokyo, uno dei massimi
centri di ricerca del
Giappone. «Poi però ci
siamo resi conto che
il peggioramento delle
condizioni del pianeta e
la costante diminuzione
della superficie coltivabile
imponevano una soluzione
immediata: il sistema
idroponico potrebbe
esserlo, e abbiamo iniziato
a svilupparlo a terra».
Da sempre il Giappone
deve affrontare gravi
problemi di densità di
popolazione nei grandi
centri urbani: non stupisce
che l’autosufficienza
alimentare di metropoli
come Tokyo o Osaka
rappresenti uno dei
principali casi da risolvere.
Lo stesso, ma in scala
minima, che gli scienziati
devono affrontare nella
stazione spaziale, che pure
potrebbe presto diventare
incredibilmente autonoma
anche dal punto di vista
alimentare.
«Le ultime ricerche si
basano sull’uso delle luci
led», continua Watanabe,
«con l’obiettivo di far
crescere verdura e piante
nutrienti. Ma anche buone,
belle e, soprattutto, senza
malattie». Ecco perché,
osservando fotografie di
ambienti in cui viene usato
il sistema idroponico,
notiamo quasi sempre
luci colorate. Sebbene
non esista una regola
generale, e non tutte le
piante reagiscano allo
stesso modo, si può dire
che i vegetali esposti al
colore blu sviluppano
antiossidanti e sono
ricchi di vitamine C, E e
A. Ponendoli invece sotto
una luce rossa, si stimola
la fotosintesi clorofilliana
e si velocizza la crescita.
C A T E G O R I A
A G R I C O L T U R A
C O O R D I N A T E G P S
3 5 . 5 6 7 0 3 5 N , 1 3 9 . 4 6 8 4 5 0 E
L U O G O
T O K Y O , G I A P P O N E
L’ I N S A L ATA D E L F U T U R O S A R À I D R O P O N I C A

C A P I T O L O 5
A S I A
Q U A D R A N T E M A P P A
A6
Q U A D R A N T E M A P P A
P6
S T E F A N I A V I T I
F . A L E S S I O G U A R I N O
F R A N C E S C O L I P A R I ,
A L D O S O L L A Z Z O
P A R O L E C H I A V E
A C C O G L I E N Z A , M E D I C I N A , S C U O L A
T E C N O L O G I A P E R R I F U G I AT I
Migliaia di disperati in fuga
da guerre e conflitti, finiti
in paesi poco ospitali o in
campi profughi: oggi la
startup giordana Refugee
Open Ware (Row) cerca
per loro un futuro migliore,
mettendo a disposizione
le ultime tecnologie e
consentendo a queste
comunità, intrappolate in
un limbo, di sentirsi ancora
una volta collegate alla
vita, di tornare a sperare.
Tra i tanti servizi offerti
ci sono stampa 3D,
fabbricazione digitale
e internet delle cose, che
si sommano all’assistenza
medica di base. Come nel
caso di Ahmad, un profugo
siriano cieco cui è stato
impiantato un dispositivo
di eco-localizzazione per
aiutarlo a individuare gli
ostacoli come muri e porte.
E Zain, yemenita di sei anni
che ha perso una mano, ora
ha una protesi stampata
in 3D progettata anche
per emulare Ben 10, il suo
supereroe preferito.
L’iniziativa mira a creare
una rete di centri per
l’innovazione in Medio
Oriente e in Europa, spazi
dotati dei macchinari
digitali più avanzati.
Secondo Row, offrire
un’educazione avanzata e
competenze legate a nuove
tecnologie − che creeranno
posti di lavoro − consentirà
a comunità locali, governi
e rifugiati di ritrovare
speranza e dignità.
Asem, rifugiato siriano
mutilato di guerra, ha
imparato a utilizzare
una stampante 3D
in tre settimane e
a programmare un
microprocessore Arduino
in tre giorni. Se un pezzo
di protesi si rompe,
lo sostituisce con uno
nuovo: in 20 minuti lo
progetta e in e ore lo
stampa in 3D, con una
riduzione dei costi del 95%.
Oggi Asem è un volontario
Row e aiuta le persone
che gli stanno intorno.
C A T E G O R I A
H I - T E C H
C O O R D I N A T E G P S
3 1 . 9 4 9 4 5 4 N , 3 5 . 9 3 2 9 1 3 E
L U O G O
A M M A N , G I O R D A N I A
L’utilizzo dello spettro
luminoso varia comunque
in base a numerosi fattori,
come la temperatura
e il tempo di esposizione.
Gli studi di Hiroyuki
Watanabe hanno varie
finalità, fra cui l’utilizzo
delle piante per scopi
medici – in particolare
l’abbassamento del
colesterolo. A sostenere
la ricerca, in Giappone,
concorrono anche grandi
gruppi privati come
Panasonic, Toshiba,
Nec, Fujitsu e Mitsubishi
Chemical Corporation,
che diversificano le proprie
attività investendo nella
ricerca e nello sviluppo
del sistema idroponico.
In alcuni casi, i centri di
studio sono stati ricavati
riconvertendo edifici
dismessi in “fabbriche
di piante”: è il caso della
Toshiba Clean Room Farm
Yokosuka, vicino a Tokyo,
dove si calcola siano stati
recuperati circa duemila
metri quadrati di spazio.
La prima ad aver destinato,
anni fa, una parte dei
propri edifici cittadini alla
coltura di vegetali è stata
Pasona, la più grande
azienda giapponese di
recruiting: in Giappone,
l’autosufficienza delle città
ottenuta sfruttando spazi
urbani − il futuro della
produzione a chilometro
zero – è quasi una realtà.

GENTILE CONCESSIONE DI NASA

C A P I T O L O 5
A S I A
Q U A D R A N T E M A P P A
F4
A L I C E P A C E
P A R O L E C H I A V E
C O S M O D R O M O , S A M A N T H A C R I S T O F O R E T T I , E X O M A R S , S O Y U Z
L U O G O
B A I K O N U R , K A Z A K I S T A N
C A T E G O R I A
S C I E N Z A
C O O R D I N A T E G P S
4 5 . 6 2 8 2 0 0 N , 6 3 . 3 0 4 6 0 0 E
Brulla, piatta, grigiastra.
Una steppa anonima
e deserta che sembra
immersa in un eterno
“dietro le quinte”, dove lo
spettacolo dura il bagliore
dell’accensione di qualche
razzo in partenza per lo
spazio, per poi tornare,
a riflettori spenti, nel
silenzio. È il cosmodromo
di Baikonur, da qualche
parte in Kazakistan,
la prima base di lancio
della storia. Oggi è gestito
dall’agenzia spaziale
russa Roscosmos e
la sua enorme ellisse,
che scalfisce la terra
per quasi 90 chilometri
da ovest a est e 85 da
nord a sud, è forse la
più grossa impronta
lasciata dalla Space
Race quando Baikonur
(Unione Sovietica) e Cape
Canaveral (Stati Uniti) si
contendevano la Luna,
Marte e il sistema solare.
Yuri Gagarin, il primo
essere umano a volare
in orbita, nell’aprile del
1961 partì da qui; come lui
anche Valentina Tereškova,
la prima donna ad andare
nello spazio, due anni
più tardi. Dopo di loro,
dalle stesse rampe sono
decollate generazioni di
cosmonauti russi, tutti gli
equipaggi (e i rifornimenti)
destinati alla Stazione
spaziale internazionale
e, appena qualche mese fa,
anche Luca Parmitano
e Samantha Cristoforetti.
Già: su questo palco sono
andate in scena pagine
tra le più importanti
dell’esplorazione spaziale.
Il copione per il futuro,
del resto, non è male.
Quest’anno salperà
da qui la prima sonda
dell’attesissima ExoMars,
la missione robotica che
porterà anche l’Europa a
caccia di vita su Marte,
in collaborazione con
l’agenzia spaziale russa.
Il razzo spingerà dentro
l’atmosfera del Pianeta
Rosso un rilevatore
orbitante, che avrà il
compito di “annusare”
le molecole lì disperse
per captare eventuali
tracce di metano, possibile
indizio della presenza
di organismi viventi.
Contemporaneamente,
recapiterà anche un
vero e proprio lander
sull’arida superficie del
pianeta, con l’obiettivo
di testare la dinamica di
atterraggio e soprattutto
per un sopralluogo in
attesa dell’arrivo del rover
definitivo: che, invece,
è in calendario per il 2018
e costituirà il vero cuore
dell’impresa scientifica.
Nel frattempo, da qui
sono previsti tutti i lanci
della capsula Soyuz e
dei vettori Proton, per il
dispiegamento attorno
alla Terra di nuovi satelliti,
con cadenza quasi mensile.
Basta pensare agli
enormi hangar dove i
razzi, assieme al proprio
“bagaglio”, vengono
custoditi, ai massicci
binari lungo i quali
vengono trasportati e alle
impalcature mobili che li
issano in verticale come
le lancette di un orologio,
per rendersi conto che
il countdown, in fondo, è
solo la scintilla di un’opera
davvero molto complessa.
E, se possibile, ancora più
affascinante.
I N P A R T E N Z A P E R L’ I N F I N I T O

C A P I T O L O 5
A S I A
Q U A D R A N T E M A P P A
A6
F I L I P P O P I V A
P A R O L E C H I A V E
A C Q U A S A L A T A , G A Z A , I R R I G A Z I O N E
Tutto nasce da una
necessità di base, trovare
il modo per coltivare riso,
patate e mais anche in
aree pressoché desertiche,
dove il clima è tutt’altro
che mite e le risorse idriche
scarseggiano: ecco la
genesi del progetto Oasis
− fortemente sostenuto dal
mecenate svizzero Sam
Josefowitz − poi confluito
nell’attuale progetto
Agrisol, che finirà nel 2017.
Protagonista della
ricerca è l’Università
Ben-Gurion del Negev,
al fianco di altre realtà
israeliane come l’ateneo
di Haifa e la Central and
Northern Arava Research
& Development; ma anche
del National Center for
Agricultural Research and
Extension della Giordania
e dell’Environmental
Protection and Research
Institute di Gaza.
La piantagione pilota
dello studio si trova nel
sud di Israele, non lontana
dalla Yair Experimental
Station di Hatzeva, nel
Wadi Araba. Qui le piogge
sono decisamente scarse,
la temperatura media ad
agosto sfiora i 40 gradi
e le uniche risorse idriche
nelle vicinanze, oltre al
Mar Morto, sono falde
acquifere salmastre
− dunque piuttosto salate −
a diverse centinaia di metri
di profondità.
«La sfida del nostro
progetto consiste proprio
in questo: riuscire a
utilizzare anche l’acqua
salmastra per irrigare
le coltivazioni nelle
zone aride», spiega
Rami Messalem, senior
research scientist dello
Zuckerberg Institute for
Water Research presso
l’Università Ben-Gurion
del Negev. «A tal fine
abbiamo sviluppato
e testato un sistema
di nanofiltrazione,
alimentato interamente
a energia solare: l’acqua
viene passata attraverso
una membrana che
trattiene la maggior parte
del sale, ma permette
di conservare una certa
quantità di magnesio,
di calcio e di tutte le altre
sostanze importanti per
lo sviluppo della pianta.
Si tratta di un sistema
innovativo che richiede
decisamente meno energia
di quello a osmosi inversa,
che per giunta toglie
all’acqua quasi tutto, anche
i minerali più utili».
Le prime sperimentazioni
hanno già dato i loro frutti,
in tutti i sensi. Così il
progetto si è ampliato fino
a coinvolgere un nuovo
terreno, questa volta nella
zona (sempre desertica)
di Neot HaKikar; presto
arriverà anche in Giordania,
con una nuova piantagione
che verrà realizzata nei
pressi della Karama
Agricultural Station.
«La crescente domanda
di cibo richiede ai sistemi
agricoli di essere più
efficienti nella gestione
delle risorse naturali,
come terra e acqua»,
dice Andrea Ghermandi
dell’Università di Haifa.
«In Medio Oriente, per
esempio, la mancanza di
acqua fresca costringe a
sfruttare i bacini di quella
salmastra ma, spesso,
questo utilizzo si dimostra
scarsamente sostenibile».
Il progetto Agrisol, invece,
sembra dimostrare che
una soluzione efficace,
efficiente e replicabile
al problema è possibile.
C A T E G O R I A
A M B I E N T E
C O LT I VA Z I O N I I M P O S S I B I L I
C O O R D I N A T E G P S
3 0 . 7 6 7 9 4 2 N , 3 5 . 2 7 8 4 9 8 E
L U O G O
H A T Z E V A , I S R A E L E

C A P I T O L O 5
A S I A
Q U A D R A N T E M A P P A
G9
F E D E R I C O B O N A
P A R O L E C H I A V E
P U B B L I C I T À I N T E R A T T I V A , S T A R T U P , V I D E O G A M E
O P E R A Z I O N E S O R P A S S O
C A T E G O R I A
H I - T E C H
C O O R D I N A T E G P S
1 2 . 9 8 3 3 4 3 N , 7 7 . 5 8 3 1 2 8 E
L U O G O
B A N G A L O R E , I N D I A
L’anno, non troppo lontano,
è il 2020: secondo i dati
in possesso di Srivatsa
Krishna, sottosegretario
all’Information Technology
del governo dello stato
indiano di Karnataka, in
quella data la capitale
Bangalore supererà la
Silicon Valley e diverrà il
luogo al mondo con il più
alto numero di lavoratori
nell’hi-tech. Due milioni.
Ma non è solo questione di
numeri assoluti. Qualcosa
sta cambiando anche nella
qualità del lavoro e delle
figure impiegate.
Fin dagli anni Ottanta,
infatti, a Bangalore è
esploso il settore dei
servizi informatici − noto
non certo per il tasso
di innovazione − e varie
multinazionali hanno
assunto centinaia di
migliaia di giovani tecnici
e ingegneri per le attività
in outsourcing. Ora, al
contrario, ad attrarre i
migliori studenti sono
proprio le aziende locali.
Alcune sono di livello
mondiale, a partire dalla
pionieristica Infosys,
con i suoi quasi 200mila
dipendenti; ma sono
moltissime le startup nate
e cresciute negli ultimi
anni. Secondo una recente
ricerca di Compass, quelle
attive nella zona sono
quasi 5mila.
La stessa indagine
rivela che l’età media
dei fondatori, 28 anni
e 6 mesi, è la più bassa
di tutto il mondo.
Fra l’abitudine a lavorare
nel settore, i capitali
attratti e il basso costo di
vita e lavoro, Bangalore
ha inaugurato una nuova
stagione fatta di idee e
capacità imprenditoriali.
Gli esempi migliori?
Il colosso dell’ecommerce
Flipkart, fondato nel 2007
con appena 8mila dollari
da due colleghi di Amazon
dallo stesso cognome,
Bansal, che da allora ha già
raccolto finanziamenti per
oltre 3,4 miliardi di dollari.
Oppure InMobi, nata
anch’essa nel 2007, la
piattaforma di pubblicità
“mobile” che ha superato
il miliardo di utenti al mese
ed è ormai la terza realtà
al mondo nel settore, dopo
Google e Facebook. L’anno
scorso InMobi ha lanciato
una nuova tecnologia,
chiamata Miip, pensata
per fornire pubblicità più
interattive, più divertenti
e, soprattutto, più adatte
al gusto e alle esigenze di
ogni singolo cliente.
Né mancano realtà più
recenti. Come Zovi, ideata
nel 2011 per vendere abiti
e accessori, che offre ai
clienti un camerino virtuale
e che, di recente, si è
allargata all’arredamento.
O come MadRat Games,
creata nel 2010 per
sviluppare giochi educativi
per bambini: con successo,
visto che ne ha venduti
oltre mezzo milione.
Forse è arrivato il tanto
atteso momento in cui
l’India spiccherà il volo.

FIRA, Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Artrite, è una ONLUS che, senza alcuno scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’obiettivo principale è quello di sostenere la ricerca medico-scientifica nel campo della cura e dello studio delle malattie reumatiche. Per raggiungere il suo scopo, che significa soprattutto maggiori possibilità di prevenzione, diagnosi sempre più precoci e cure più efficaci e meglio tollerate, FIRA ONLUS promuove la raccolta di fondi da destinare alla ricerca.
Codice Fiscale FIRA ONLUS: 97424570154.
ONLUS
per
DONA IL 5X1000 A FAVORE DELLE MALATTIE REUMATICHE.
CODICE FISCALE FIRA ONLUS: 97424570154.
Si ringrazia Carla Fracci per aver aderito all’iniziativa.
5X1000
fondamentale
quotidiano
1XTUTTIè un gesto
è un gesto
quest’anno
allaDONALO
contro
le malattie
reumatiche
Il tuo 5x1000
ricerca


Wollongong
O C E A N I A
1
pag. 186
pag. 176
pag. 187
pag. 188
pag. 189
pag. 190
2
3
4
5
6
Isole Tonga
Isole Kiribati
Antartide
New Plymouth
Jamestown


IL N
UO
VO
CO
ND
OM
SA
RÀ
FA
TT
O D
I
IDR
OG
EL
(U
NA
GE
LA
TIN
A A
BA
SE
DI
AC
QU
A),
CO
MP
OS
TO
DA
MIN
US
CO
LI
RE
TIC
OL
I T
RID
IME
NS
ION
AL
I
L U O G O
W O L L O N G O N G , A U S T R A L I A
C O O R D I N A T E G P S
3 4 . 4 2 8 0 6 8 S , 1 5 0 . 8 8 6 2 0 5 E
F O T O D I
P E T R I N A H I C K S
T E S T O D I
A L I C E P A C E
C A P I T O L O 6
O C E A N I A
Q U A D R A N T E M A P P A
I7

ROBUSTISSIMO EPPURE COSÌ
IMPALPABILE E PERFETTO
DA ESSERE PARTE DEL
PIACERE STESSO: NASCE
GELDOM, IL PROFILATTICO
A BASE DI ACQUA.
INDOSSARLO NON SARÀ
PIÙ SOLO UN DOVERE
A P R O V A D ’ O R G A S M O

W I R E D / N. 2 / P R I M AV E R A 2 01 6

C A P. 6 / O C E A N I A
17 9
178
L’I
NV
OL
UC
RO
DE
L G
EL
DO
M È
UN
A
PE
LL
ICO
LA
IN
GR
AD
O D
I A
SS
OR
BIR
E
EN
OR
MI
PR
ES
SIO
NI
E D
I R
ES
IST
ER
E
AG
LI
ST
RA
PP
I M
EG
LIO
DE
LL
A G
OM
MA

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
Qui si inventa il profilattico del futuro. Leggerissimo, invisibile, così
accogliente che verrà voglia di indossarlo. Così scivoloso da miglio-
rare il sesso. Così perfetto che usarlo sarà puro piacere. Irromperà a
breve sulla scena. Pronto a stravolgere le regole di oltre un secolo di
lattice. Ci sposterà dalla condizione di doverlo usare a un’altra del
tutto inedita: proveremo il desiderio di sentirlo addosso.
Il nome del progetto? Geldom, esplicita fusione tra “condom” e “gel”,
la sostanza bagnata, molle e trasparente con cui si intende plasmarlo.
La location? I laboratori dell’Università di Wollongong, in Australia,
nell’ambito di una collaborazione con la Bill & Melinda Gates Founda-
tion mirata a portare l’innovazione nella sfera del sesso e, in partico-
lare, promuovere l’adesione a quello protetto.
Il profilattico, d’altronde, è il protagonista indiscusso quando si parla
di protezione, prevenzione, controllo delle nascite. Ma è anche sino-
nimo di interruzione, pur solo per qualche secondo, di un momento in
cui chiediamo soltanto di non doverci frenare. Lo stesso lattice di cui
nella stragrande maggioranza dei casi è costituito non ha mai fatto
Q

C A P. 6 / O C E A N I A
1 8 1
1 8 0
breccia nei nostri sensi, che lo percepiscono gommoso, opaco, artifi-
ciale. Nonostante lo spessore sia più sottile di quello di un capello, la
mente lo associa spontaneamente a un possibile calo della sensibi-
lità, dell’attrito: di quelle sfumature, insomma, che ci fanno sentire
davvero completo il rapporto. Di fatto, per frenesia o per diffidenza,
la maggioranza delle volte finisce per rimanere in tasca oppure ab-
bandonato in un cassetto.
Certo, pure il condom del futuro ci ruberà qualche istante per essere
indossato, anch’esso impedirà il contatto diretto tra le carni e fun-
gerà da barriera fisica contro la trasmissione sia di germi che dello
sperma. Tuttavia, pur di uscire dal cassetto, proverà a far scattare gli
istinti primordiali del corpo e a smuovere un pretesto il più possibile
travolgente per essere indossato. Non farà leva, insomma, sul nostro
senso di responsabilità, bensì punterà diritto al fulcro del desiderio:
quell’incastro perfetto, il pieno contatto, la percezione del calore del
partner. In questo modo la protezione c’è ma rimane dietro le quinte
ed evita di rubare la scena al piacere.

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6
l punto di partenza? La materia prima, assolutamente. Niente più tentativi di assotti-
gliare, di elaborare il lattice o simili: stavolta gli scienziati hanno fatto punto e a capo,
a caccia dell’accordo perfetto fra molecole studiate a tavolino e le parti più delicate del
nostro corpo. «Ci siamo lasciati ispirare dai tessuti umani per provare a ricreare in
laboratorio qualcosa di altrettanto morbido, umido e viscoso», spiega Robert Gorkin,
ingegnere biomedico e leader del progetto.
Da subito, l’attenzione si è focalizzata sugli idrogel, letteralmente gel a base d’acqua: cioè mi-
croscopici reticoli tridimensionali in grado di inglobare e trattenere all’interno delle proprie maglie
quantitativi enormi di molecole del fluido. Fino al 99% del volume, o anche di più. Già presenti in molti
prodotti commerciali (un esempio su tutti: le lenti a contatto), non erano mai stati presi in considera-
zione per un potenziale ruolo di barriera biologica poiché, sebbene fortemente biocompatibili, sono
in genere molto fragili dal punto di vista meccanico.
È proprio qui che al team di scienziati di Gorkin è riuscito il salto di qualità. Hanno formulato
matrici di polimeri sempre nuove, hanno provato a trasformarle in film sempre più sottili, hanno
scartato via via le varianti meno resistenti: ed ecco, per la prima volta, una selezione di idrogel sì mor-
bidi e flessibili ma allo stesso tempo estremamente robusti, in grado di deformarsi e tendersi per ol-
tre mille volte la superficie iniziale. Degli involucri trasparenti, quando non addirittura invisibili, in
cui le molecole d’acqua sono talmente coese le une alle altre da non consentire il passaggio di alcuna
forma di materiale biologico, che si tratti di un getto di cellule spermatiche, di una colonia di batteri
o del più microscopico virus esistente. Una pellicola così impalpabile da non appiattire nemmeno le
più piccole pieghe naturali della pelle; ma, allo stesso tempo, una protezione pronta ad assorbire for-
tissime pressioni e più resistente agli strappi di una gomma. Nonché, al tatto, estremamente naturale
e simile al rivestimento delle superfici intime.
Ma come decidere qual è la formula perfetta? Niente di meglio che interrogare i nostri stessi re-
cettori sensoriali. Nell’ambito di una collaborazione con un gruppo di neuroscienziati dell’Università
di Swinburne, anch’essa in Australia, i ricercatori hanno perciò avviato una serie di test per la valu-
tazione di alcuni dei materiali sintetizzati utilizzando macchine in grado di fornire una mappatura in
tempo reale dell’attività nervosa. Quelle tipiche dei reparti di neurologia, per intenderci.
L’azione, in questo caso, consisteva nello scorrere le dita, bendati, su diversi campioni di idro-
gel e, per contrasto, di lattice, anche con gradi di lubrificazione differenti. «Le risposte raccolte fino-
ra, visibili attraverso set di elettroencefalogrammi, hanno confermato che il contatto con i nostri
idrogel suscita una sensazione più piacevole rispetto a quelli convenzionali», spiega Gorkin. In parti-
colare, testimoniano gli scienziati, solo con i nuovi materiali si è registrata un’attività elettrica molto
forte a carico della corteccia frontale del cervello, segno che potrebbero davvero riuscire a scatenare
reazioni nuove e inaspettate rispetto a quelli impiegati finora. Il prossimo passo, cui ora sono impe-
gnati i ricercatori, è lo sviluppo di prototipi, cioè di condom delle dimensioni e delle forme desiderate,
I

C A P. 6 / O C E A N I A
1 8 3
1 8 2
LE
MO
LE
CO
LE
D’A
CQ
UA
DE
L G
EL
DO
M
SO
NO
CO
SÌ
AD
ER
EN
TI
LE
UN
E A
LL
E
AL
TR
E D
A I
MP
ED
IRE
IL
PA
SS
AG
GIO
DI
AL
CU
N M
AT
ER
IAL
E B
IOL
OG
ICO

W I R E D / P R I M AV E R A 2 01 6

C A P. 6 / O C E A N I A
1 8 5
1 8 4
da mettere alla prova grazie a coppie campione − cioè persone disposte a indossarli durante i rapporti
sessuali e a fornire un feedback. Ma non basta.
Oltre a un miglioramento delle sensazioni, dai profilattici del Terzo Millennio ci si aspetta an-
cora qualcosa in più. Come per esempio i lubrificanti integrati da far sgorgare automaticamente, e
solo in caso di necessità, dalle maglie della matrice. Oppure altre sostanze che, una volta sprigionate
direttamente in loco, potrebbero rendere più sicuro, più prolungato o anche solo più piacevole il rap-
porto sessuale. Via libera, quindi, all’assorbimento di farmaci e altre molecole funzionali; magari
quelle che aiutano a mantenere l’erezione, i ritardanti, gli stimolanti.
a ricerca sul fronte dei profilattici, in ragione di un mercato globale di oltre cinque
miliardi di dollari l’anno, è certo un terreno molto vivace e pervaso, dal punto di vi-
sta tecnologico, di idee spesso visionarie: è in via di sviluppo un profilattico a base di
grafene, nanomateriale composto da un singolo strato di atomi di carbonio, di cui si
intende assimilare la resistenza estrema in vista di un sistema al 100% antirottura.
Ma si lavora anche a preservativi dotati di sistemi di srotolamento rapido, che siano in
grado di dispiegarsi e di avvolgere le superfici in una frazione di secondo. E ancora, a formule spray;
in tal caso lo strato protettivo si concretizza all’istante, con un semplice spruzzo.
È sempre più chiaro, comunque, che il limite cui ci si trova di fronte non è tutto tecnologico. Per
questo il team di ricercatori − che immagina il proprio condom sul mercato entro i prossimi tre, mas-
simo cinque anni − investe molto anche nella cooperazione con i sistemi e le organizzazioni sanitarie.
In particolare quelle di realtà in via di sviluppo, come le regioni dell’Africa subsahariana e del Sudest
Asiatico, oltre che con alcune comunità di immigrati. «Il nostro è anche un lavoro di educazione e cul-
tura sanitaria», spiega Gorkin. «Ma comprendere i gusti, addentrarsi nelle tradizioni che esistono in
luoghi completamente diversi del mondo, è una ricerca difficile quanto quella scientifica». Perché, di
fatto, il cuore della rivoluzione non è solo un prodotto chiamato Geldom, ma il nostro atteggiamento
nei suoi confronti. Il nuovo condom, insomma, dovrà funzionare prima di tutto nel cervello.
L
AL
TA
TT
O,
LA
PE
LL
ICO
LA
DE
L
GE
LD
OM
È Q
UA
SI
IMP
ER
CE
TT
IBIL
E E
SIM
ILE
AL
TE
SS
UT
O C
UT
AN
EO
DE
LL
E
PA
RT
I IN
TIM
E D
EL
L’U
OM
O

C A P I T O L O 6
O C E A N I A
P A R O L E C H I A V E
G E N D E R , O R I E N T A M E N T O S E S S U A L E , T R A D I Z I O N I , T R A N S
F A K A L E I T I , I L T E R Z O S E S S O
C A T E G O R I A
S O C I E T À
C O O R D I N A T E G P S
2 1 . 1 8 0 8 0 0 S , 1 7 5 . 1 9 5 8 3 0 O
L U O G O
I S O L E T O N G A
Si chiamano “fakaleiti”,
che tradotto letteralmente
significa “come una
donna” e, in un secolo che
mette l’identità di genere
al centro delle proprie
riflessioni, rappresentano
un’avanguardia dalle
origini antichissime.
Inedita, poco nota e
decisamente esemplare.
Sì, perché in uno Stato
monarchico estremamente
conservatore, anche perché
mai colonizzato da un’altra
nazione e sparpagliato su
oltre 170 isole nel mezzo
del Pacifico, nessuno ha
mai pensato di mettere
in relazione il loro sesso,
chiamiamolo così, “sociale”
con il loro orientamento
sessuale.
Un fakaleiti altri non è
che un bambino maschio
cresciuto come una
femmina da una famiglia
che non ha avuto bambine,
una decisione che viene
assunta come necessaria
e che è concessa
dalla cultura locale:
attualmente si contano
circa 300 fakaleiti su una
popolazione complessiva
di oltre 120mila persone.
In pratica, un fakaleiti
viene educato a rivestire
compiti tradizionalmente
femminili come cucinare,
fare le pulizie e prendersi
cura dei genitori anziani;
durante l’adolescenza può
stare in compagnia delle
ragazze, quando i maschi
non sono autorizzati
neppure ad avvicinarsi.
Veste indifferentemente,
e secondo preferenze
personali, abiti femminili,
maschili o neutri, salvo
nelle occasioni ufficiali
e cerimoniali, dove sono
richiesti vestiti da donna.
Nelle città, i fakaleiti adulti
svolgono professioni come
segretarie, domestiche,
parrucchiere dato che
in tutto e per tutto si
considerano − e vengono
considerati − donne.
Allo stesso tempo,
trattandosi di un genere
imposto socialmente
fin dalla nascita ma non
il frutto di una scelta
individuale, non esiste
una correlazione con
l’orientamento sessuale.
Certo, spesso accade che
i fakaleiti abbiano rapporti
sessuali e relazioni con
altri uomini che a loro volta,
e altrettanto logicamente,
non vengono considerati
omosessuali. Esistono però

C A P I T O L O 6
O C E A N I A
Q U A D R A N T E M A P P A
O1
Q U A D R A N T E M A P P A
O 4
P A R O L E C H I A V E
A T O L L I , G L O B A L W A R M I N G , M A R E E
J A C O P O P A S O T T I
F E D E R I C O B O N A
F . M A R C E L L O B O N F A N T I
C O O R D I N A T E G P S
1 . 3 2 7 8 7 5 N , 1 7 2 . 9 7 6 6 4 9 E
C A T E G O R I A
A M B I E N T E
L E I S O L E C H E S C O M P A I O N O
L U O G O
I S O L E K I R I B A T I
Una manciata di atolli
in mezzo all’oceano
Pacifico, 33 isolette,
perlopiù rappresentate
nelle carte da un punto,
giusto per segnalarne
l’esistenza. Intorno, la linea
del cambiamento di data
fa un’ansa di migliaia di
chilometri perché gli atolli
hanno deciso di mantenere
la stessa data della Nuova
Zelanda mentre invece
le Hawaii, poco a nord,
hanno quella degli Stati
Uniti: vicini di casa, ma
con un giorno di differenza.
È il classico arcipelago
tropicale, laguna, coralli,
palme, sole, mare
cristallino. Che sale anno
dopo anno, inesorabile.
Sì, perché a proposito del
cambiamento climatico
su una cosa gli scienziati
non hanno dubbi:
il livello marino sale,
e rapidamente. Secondo
l’Intergovernmental
Panel on Climate Change
(IPCC) si è alzato di
3,2 millimetri all’anno
durante l’ultimo decennio
ed entro fine secolo
potrebbe salire di 52-98
centimetri; riducendo
(e molto) le emissioni
globali crescerebbe tra
28 e 61. Quanto basta
a sommergere Kiribati,
100mila anime. La metà
dell’intera superficie non
raggiunge i due metri
sopra il livello marino.
Kiribati ha fatto notizia
anni fa quando il
cittadino Ioane Teitiota
ha chiesto asilo in Nuova
Zelanda. È stato il primo
rifugiato climatico della
storia. Il termine diverrà
comune anche se, per la
Convenzione per i Rifugiati
delle Nazioni Unite, quella
figura non esiste (ma si
inizia a parlarne). Teitiota
non intende tornare per
non mettere a rischio la
vita sua e della famiglia:
lì, dice, non c’è futuro.
Il 10% della popolazione
mondiale vive in regioni
costiere, a meno di 10
metri sul livello del mare.
Per loro l’aumento degli
eventi meteorici estremi,
l’erosione della costa,
la risalita del livello del
mare (e l’invasione delle
acque salate nelle falde
acquifere) sono una
minaccia seria: famiglie
e comunità intere
dovranno spostarsi.
fakaleiti che si sposano
con donne e hanno figli.
Com’è naturale, non
sempre le situazioni
sono così limpide,
specie sull’onda recente
dell’influsso dei costumi
e delle categorie del
mondo occidentale,
che per esempio hanno
forzato all’interno
di questa condizione
identità omosessuali
e transgender. Ma, in
linea di massima, i fakaleiti
restano un universo a sé,
che permette loro di essere
più spudorati di una donna,
alla quale si richiede
convenzionalmente
grande riservatezza,
e meno formali di un
uomo: stereotipi, entrambi,
messi in ridicolo durante
la tre giorni del concorso
di Miss Galaxy che,
ogni luglio nella capitale
Nuku’alofa, elegge
il fakaleiti dell’anno.

C A P I T O L O 6
O C E A N I A
Q U A D R A N T E M A P P A
F10
A L I C E P A C E
P A R O L E C H I A V E
A S T R O F I S I C A , A T M O S F E R A , G H I A C C I O
L U O G O
A N T A R T I D E
L A B A S E C O N I L P O L O I N T O R N O
C A T E G O R I A
S C I E N Z A
C O O R D I N A T E G P S
9 0 . 0 0 0 0 0 0 S , 1 3 9 . 2 6 6 6 6 7 O
Freddo, molto freddo.
Questa è una delle zone
più aride, ventose e
inospitali del mondo, dove
durante i mesi invernali
le temperature possono
sprofondare a -80 gradi
centigradi e, nel resto
dell’anno, innalzarsi fino
a un massimo di -20.
È l’Antartide, a pochi passi
dal Polo Sud, dove l’asse
terrestre buca, invisibile,
la superficie di questo
deserto di ghiaccio.
Proprio qui, a 2835 metri
di altitudine sul livello del
mare, sorge la Amundsen-
Scott South Pole Station.
Il laboratorio di
osservazione e ricerca
scientifica più meridionale
della terra, che prende
il nome dai primi
coraggiosi esploratori
giunti alla conquista del
Polo: il norvegese Roald
Amundsen nel 1911 e
l’inglese Robert Scott,
che vi giunse 33 giorni
dopo ma finì per perdervi
la vita. Incastonata in uno
spessore di ghiaccio di
migliaia e migliaia di metri
cubi in lentissimo − ma
inesorabile − slittamento,
avvolta da inarrestabili
raffiche di vento e bufere,
la base ha un’architettura
che rappresenta già di per
sé una sfida tecnologica
ai limiti del possibile.
Ciononostante la stazione,
il primo insediamento
permanente al Polo
Sud, può accogliere
contemporaneamente
al suo interno da 50 a 200
scienziati, impegnati
in varie discipline: biologia,
astrofisica, geologia,
scienze del clima.
Cosa li spinge laggiù?
Cosa c’è di così imperdibile
da investigare nel bel
mezzo di un'immensa,
desolante e desolata
distesa congelata?
Il ghiaccio, prima di tutto.
In profondità, sotto forma
di vecchie precipitazioni
e bolle d’aria, conserva
intrappolato, strato sotto
strato, un archivio di oltre
un milione di anni di storia
climatica del pianeta.
Poi l’atmosfera: è un
habitat così remoto e
scollegato dal resto del
mondo che vi si respira
l’aria più incontaminata
che si possa immaginare.
L’analisi della miscela di
molecole che la formano
fornisce un vero e proprio
bollettino dello stato di
salute della terra: non
solo per quanto riguarda
l’inquinamento ma anche
sul versante climatico,
dove il monitoraggio
costante delle condizioni
meteo integra in modo
sostanziale lo studio
del cambiamento e del
riscaldamento globale.
Non basta. Grazie alla
bassissima umidità e
all’atmosfera rarefatta,
il cuore dell’Antartide
è un luogo privilegiato
anche per l’astrofisica
e l’osservazione di
importanti fenomeni
elettromagnetici.
Si pensi alle aurore
visibili nell’oscurità
dell’interminabile notte
polare, oppure alle galassie
lontanissime che solo
il South Pole Telescope,
un radiotelescopio
sensibile alla radiazione
cosmica di fondo,
è in grado di vedere.
Ed è proprio qui, a una
manciata di metri dal
Polo Sud, che il rilevatore
IceCube è riuscito per
primo a captare i cosiddetti
neutrini, le particelle
subatomiche ad altissime
energie che potrebbero
un giorno contribuire
a svelarci i misteri più
profondi sui buchi neri
e, forse, sull’origine stessa
della materia oscura.
GENTILE CONCESSIONE DI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

C A P I T O L O 6
O C E A N I A
Q U A D R A N T E M A P P A
M7
F R A N C E S C O L I P A R I ,
A L E S S A N D R O M E L I S
P A R O L E C H I A V E
L E N L Y E , S O S T E N I B I L I T À , T R A D I Z I O N E P O L I N E S I A N A
Mentre la tradizione
edilizia oceanica, insieme
a quella della West Coast
americana, continua a
essere caratterizzata
soprattutto da sistemi
timber-frame (detti anche
a telaio in legno), un
nuovo trend celebra l’alta
tecnologia dell’industria
siderurgica locale
attraverso l’uso di strutture
inossidabili.
Fra queste architetture
il nuovo Len Lye Centre
di New Plymouth
nell’area del Taranaki
(in Nuova Zelanda) −
progettato da Patterson
Associated − offre al
territorio una prospettiva
nuova e internazionale:
è considerato un museo
unico e innovativo,
esattamente quanto lo
era stato Len Lye (1901-
1980), filmmaker e scultore
cinematico che l’edificio
vuole celebrare.
Commissionato dal
District Council di New
Plymouth e finanziato dal
governo neozelandese
con un'estesa raccolta
fondi, è concepito come
un tempio antropomorfo
della tradizione polinesiana
della Wharenui (la Casa
delle riunioni) e sfrutta
la massiccia scocca in
cemento armato per
contenere massa termica
utile al sostentamento
energetico. Il complesso
è la prova che strategie
passive a basso costo
e un design più cosciente
(quando le condizioni
climatiche lo consentono)
possono portare a risultati
migliori dell’impiego di
dispositivi tecnologici.
All’esterno, attraverso una
originale sovrapposizione
in facciata di setti a forma
di “S”, Patterson crea delle
sinuose aperture verticali
che consentono l’ingresso
della luce indiretta e
diffusa, permettendo in tal
modo a elementi altamente
performanti di diventare
la loro stessa matrice
estetica. Nonostante
i costi elevati, l’involucro
cromato assume una forza
comunicativa unica nel
panorama neozelandese;
è infatti diventato un
potente strumento di
marketing territoriale
della regione del Taranaki,
che fa dell’avanzato livello
tecnologico dell’industria
siderurgica uno dei suoi
grandi punti di forza.
La luce è ancora
protagonista nello spazio
interno, dove riesce
a ricreare un’esperienza
sensoriale tale da far
sentire il visitatore
all’interno di un vero
e proprio tempio religioso,
qui dedicato all’arte.
«Lye era affascinato
dai templi e noi abbiamo
progettato il suo museo
ispirandoci ai principi
del mondo classico
e alle forme polinesiane»,
ha spiegato Andrew
Patterson. «Dopotutto
il nostro committente,
indirettamente, era lui».
C O O R D I N A T E G P S
3 9 . 0 5 8 6 4 2 S , 1 7 4 . 0 7 0 2 6 6 E
C A T E G O R I A
A R C H I T E T T U R A
U N M U S E O I N O S S I D A B I L E
L U O G O
N E W P L Y M O U T H , N U O V A Z E L A N D A
©PATRICK REYNOLDS

C A P I T O L O 6
O C E A N I A
Q U A D R A N T E M A P P A
G6
P A R O L E C H I A V E
N A N O T E C N O L O G I E , P A N N E L L I S O L A R I
M A R C O C O S E N Z A
Quando nel 1840 i primi
coloni si stabilirono nel
Mid-North, al centro
dell’attuale distretto della
South Australia, il sole era
un problema. Coltivare
campi riarsi e muoversi
tra i cunicoli delle miniere
con 40 gradi all’ombra
è proibitivo sia per l’uomo
sia per animali e vegetali.
Oggi, a quasi due secoli
di distanza, i giacimenti
di rame non si sono ancora
esauriti e il sole continua
a battere imperterrito sui
vigneti, gli allevamenti di
pecore, le infinite distese
di grano e frumento
della regione. Con una
importante differenza:
quei raggi, da avversari,
si sono trasformati
in alleati. La società
specializzata in energie
rinnovabili Infratech
Industries Inc. ha infatti
sviluppato − insieme
al Dipartimento di
nanotecnologie della
Flinders University −
e installato a Jamestown,
129 miglia a nord di
Adelaide, un parco solare
dalle caratteristiche
uniche. Contrariamente
a quanto si potrebbe
pensare, «i pannelli solari
non danno il meglio
quando sono esposti ad
alte temperature», spiega
Felicia Whiting, direttrice
di Infratech. La soluzione?
Immergerli nell’acqua su
speciali zattere, unendo
l’impianto fotovoltaico a
quello di depurazione delle
acque reflue: in tal modo
i pannelli, galleggianti
e naturalmente refrigerati,
si sono rivelati del 57%
più efficienti rispetto ai
cugini da terra o da tetto.
Gli effetti positivi, inoltre,
comprendono anche la
riduzione degli sprechi.
«Questa tecnica, oltre
ad aumentare la longevità
degli apparecchi, migliora
la conservazione delle
acque», prosegue Whiting.
I pannelli infatti schermano
la luce, così limitando
sia la dispersione da
evaporazione (fino al 90%)
sia la fotosintesi, causa
della diffusione di alghe
nocive e cianobatteri.
Una speciale copertura
previene corrosione e usura
dei materiali: «Per ogni
stazione da un megawatt
si risparmiano 700mila
ettolitri d’acqua all’anno».
L’impianto − tre anni di
lavori e una spesa di 12
milioni di dollari − è il primo
completato in Australia;
ora la tecnologia si prepara
a sbarcare in una terra
caratterizzata dalle stesse
scarsità idrica e fame
di tecnologia: la California.
Dal quartier generale
di Sydney, Infratech
porterà entro fine 2016
a Holtville, a pochi passi
dal confine col Messico,
3576 pannelli, 276 zattere
e 12 pompe, per generare
più energia pulita e ridurre
l’impiego di sostanze
chimiche come il cloro.
Ma anche per “tagliare
le gambe” ai combustibili
fossili, alla siccità, alla
bolletta, e per traghettare
la California verso il target
del 50% di rinnovabili che
si è prefissata per il 2030.
Z AT T E R E C O N T R O L A S I C C I TÀ
C A T E G O R I A
E N E R G I A
C O O R D I N A T E G P S
3 3 . 3 0 9 6 5 7 S , 1 3 8 . 5 9 6 3 9 2 E
L U O G O
J A M E S T O W N , A U S T R A L I A
GENTILE CONCESSIONE DI INFRATECH INDUSTRIES

PER FAVORE RICICLA QUESTO MAGAZINE
Come trovarci REDAZIONE
Piazza Castello 27 – 20121 Milano
tel. 02/85611 mail: [email protected]
pubblicità: tel. 02/85614229
sito: www.wired.it
In the USA: Condé NastChairman Emeritus: S.I. Newhouse, Jr.
Chairman: Charles H. Townsend President & Chief Executive Officer: Robert A. Sauerberg, Jr.
Artistic Director: Anna Wintour
In other countries: Condé Nast InternationalChairman and Chief Executive: Jonathan Newhouse
President: Nicholas ColeridgeVice Presidents: Giampaolo Grandi, James Woolhouse, Moritz von Laffert, Elizabeth Schimel
Chief Digital Officer: Wolfgang BlauPresident, Asia-Pacific: James Woolhouse
President, New Markets and Editorial Director, Brand Development: Karina DobrotvorskayaDirector of Planning: Jason Miles
Director of Acquisitions and Investments: Moritz von Laffert
GlobalPresident, Condé Nast E-commerce: Franck Zayan
Executive Director, Condé Nast Global Development: Jamie Bill
The Condé Nast Group of Brands includes:US
Vogue, Vanity Fair, Glamour, Brides, Self, GQ, GQ Style, The New Yorker, Condé Nast Traveler, Allure, Architectural Digest, Bon Appétit, Epicurious, Wired, W,
Golf Digest, Teen Vogue, Ars Technica, Condé Nast Entertainment, The Scene, PitchforkUK
Vogue, House & Garden, Brides, Tatler, The World of Interiors, GQ, Vanity Fair, Condé Nast Traveller, Glamour, Condé Nast Johansens, GQ Style, Love, Wired,
Condé Nast College of Fashion & Design, Ars Technica France
Vogue, Vogue Hommes International, AD, Glamour, Vogue Collections, GQ, AD Collector, Vanity Fair, Vogue Travel in France, GQ Le Manuel du Style, Glamour Style
ItalyVogue, L’Uomo Vogue, Vogue Bambini, Glamour, Vogue Sposa,
AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vanity Fair, Wired, Vogue Accessory, La Cucina Italiana, CNLive
GermanyVogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style, Myself, Wired
SpainVogue, GQ, Vogue Novias, Vogue Niños, Condé Nast Traveler, Vogue Colecciones,
Vogue Belleza, Glamour, AD, Vanity FairJapan
Vogue, GQ, Vogue Girl, Wired, Vogue Wedding Taiwan
Vogue, GQMexico and Latin America
Vogue Mexico and Latin America, Glamour Mexico and Latin America, AD Mexico, GQ Mexico and Latin America, Vanity Fair Mexico
IndiaVogue, GQ, Condé Nast Traveller, AD
Published under Joint Venture:Brazil: Vogue, Casa Vogue, GQ, Glamour, GQ Style
Russia: Vogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style, Tatler, Condé Nast Traveller, Allure
Published under License or Copyright Cooperation:Australia: Vogue, Vogue Living, GQ
Bulgaria: GlamourChina: Vogue, Vogue Collections, Self, AD, Condé Nast Traveler, GQ, GQ Style,
Brides, Condé Nast Center of Fashion & DesignCzech Republic and Slovakia: La Cucina Italiana
Hungary: GlamourIceland: Glamour
Korea: Vogue, GQ, Allure, W, GQ StyleMiddle East: Condé Nast Traveller, AD, Vogue Café at The Dubai Mall, GQ Bar Dubai
Poland: GlamourPortugal: Vogue, GQRomania: Glamour
Russia: Vogue Café Moscow, Tatler Club MoscowSouth Africa: House & Garden, GQ, Glamour, House & Garden Gourmet, GQ Style
The Netherlands: Glamour, VogueThailand: Vogue, GQ, Vogue Lounge Bangkok
Turkey: Vogue, GQ, Condé Nast Traveller, La Cucina Italiana, GQ Style, GlamourUkraine: Vogue, Vogue Café Kiev
Diret tore Responsabi le: Feder ico Fer razza . Copyr ight © 2016 per le Ediz ioni Condé Nast . Registrazione del Tr ibunale di Milano n. 591 del 3-10-2008. La Edizioni Condé Nast S.p.A. è iscritta nel Registro degli Operatori di Comunicazione con il numero 6571. Tutti i diritti riservati. Distribuzione per l’Italia: SO.DI.P. «Angelo Patuzzi» S.p.A. via Bettola 18, 20092 Cinisello Balsamo (Mi), tel. 02660301, fax 026030320. Stampa: N.I.I.A.G. S.p.a. Bergamo - Printed in Italy • Numeri arretrati € 10,00. Inviare importo a IeO Informatica e Organizzazione Srl Ufficio Arretrati, a mezzo c/c postale n. 56427453, tel. 039.5983886 - fax 039.9991551 - e-mail: [email protected] t . Pe r s p e d i z i o n i a l l ’e s t e r o m a g g i o r a r e l ’ i m p o r t o d i € 2 , 5 0 p e r l e s p e s e p o s t a l i .
€ 135,00
€ 82,00
€ 35,00
€ 74,00
€ 157,00
€ 112,00
€ 38,00
€ 70,00
€ 49,00
€ 241,00
€ 130,00
Our Magazines are distributed abroad by: Speedimpex (USA, Australia); sole agent for distribution in the rest of the world: A.I.E. – Agenzia Italiana di Esportazione Srl - Via Manzoni, 12 – 20089 ROZZANO (MI) Italy - Tel. +39 02 5753911 – Fax. +39 02 57512606 e-mail: [email protected]
MAGAZINE ISSUESPER YEAR
EUROPE ANDMEDIT. COUNTRIES(ORDINARY MAIL)
AFRICA/AMERICAASIA/AUSTRALIA
(AIR MAIL)
AD GQ TRAVELLERGLAMOURVOGUE ITALIAL’UOMO VOGUEVOGUE ACCESSORYVOGUE BAMBINIVOGUE SPOSAVANITY FAIRLA CUCINA ITALIANA
11104111210464
4912
€ 80,00
€ 52,00
€ 25,00
€ 58,00
€ 87,00
€ 71,00
€ 23,00
€ 49,00
€ 32,00
€ 175,00
€ 88,00
Servizio Abbonamenti Per informazioni, reclami o per qualsiasi necessità, si prega di telefonare al n.199.133.199*, oppure inviare un fax al n.199.144.199. Indirizzo e-mail: [email protected]. * il costo della chiamata per i telefoni fissi da tutta Italia è di 11,88 centesimi di euro al minuto + IVA e senza scatto alla risposta. Per le chiamate da cellulare i costi sono legati all’operatore utilizzato.
Subscription rates abroad Subscription orders and payments from Foreign countries must be addressed to our worldwide subscription Distributor: Press-di S.r.l. c/o CMP Brescia, via Dalmazia 13 - 25197 Brescia (Italy). Subscribers can pay through Credit Card (American Express, Visa, Mastercard) or by cheque payable to Press-di S.r.l. Orders without payment will be refused. For further information, please contact our Subscription Service: phone +39 02 92961010 - fax +39.02.86882869. Prices are in Euro and are referred to 1- year subscription.


Senza titolo-2.indd 6 22/03/16 11:40

Senza titolo-2.indd 7 22/03/16 11:40

W I R E D
7 6
P R I M A V E R A
2 0 1 6
Cover [PT].indd 10001-10005Senza titolo-2.indd 9 22/03/16 12:50

CAPITOLI
6
MAPPE
PAGINA
ITALIA
029
EUROPA
053
AMERICA
079
AFRICA
117
ASIA
145
OCEANIA
173
WI
RE
D
76
Senza titolo-2.indd 10 22/03/16 12:51