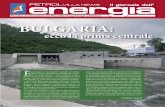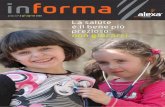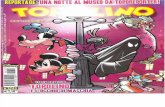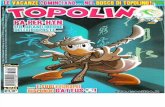Vita multiculturale _ giugno 2008
-
Upload
domenico-saggese -
Category
Documents
-
view
217 -
download
5
description
Transcript of Vita multiculturale _ giugno 2008
Introduzione, definizione e significato Pastore George Grant Ennin
Un teologo africano, John S. Mbiti, sostiene che gli africani siano
incurabilmente religiosi e che essi portino la religione all'interno di
tutte le sfere della loro vita, in casa, in comunità, al lavoro e a
scuola, in ambito pubblico e privato. La cerimonia dell'"out-
dooring" diventa significativa e apprezzabile solo se vista in tale
contesto. L'"out-dooring" è un rito che si esegue sui neonati e può
essere descritto come la presentazione pubblica del neonato,
con il fine di dargli/le il nome e il benvenuto all'interno della
famiglia e all'interno di una comunità più ampia della quale il
bambino entra a far parte. Il fenomeno dell'"out-dooring" fra gli
africani, e fra i ghanesi in particolare, è anche un'occasione
d'incontro, in forte crescita, non solo in Africa ma anche fra gli
africani residenti in molti paesi stranieri. In Africa, la nascita di un
bambino è considerata un evento sacro ed è messa in relazione
con il ciclo di vita umano all'interno del contesto culturale,
religioso e cosmologico africano. Come già detto in
precedenza, J.S. Mbiti, sostiene che per gli africani "la religione
precede l'uomo già prima della nascita, lo accompagna
attraverso le varie fasi della vita e lo segue dopo la partenza
fisica da questo mondo." Il ciclo di vita umano si articola in 5 fasi
che sono la nascita, la pubertà, il matrimonio, la morte e la
rigenerazione. È convinzione comune il fatto che nessuna di
queste fasi sia permanente poiché ciascuna porta a quella
successiva. Ad esempio, il bambino si distacca dalla fase della
nascita per affrontare la pubertà e l'età adulta; seguono il
matrimonio, la procreazione, l'età anziana e la morte, che porta
la persona verso l' "asamando" o mondo degli spiriti. Secondo
Kofi Asare Opoku, “per assicurare che non vi siano interruzioni fra
le diverse fasi, e che la transizione fra una fase e l'altra avvenga
in maniera dolce, vengono elaborati rituali religiosi" per ogni
singola fase. Questa, fra le altre, è una delle ragioni per le quali si
celebrano i rituali di "out-dooring" per i bambini africani al
momento della nascita, con tutta la gioia e le dinamiche
socioculturali ad esso associate.
Il rito dell' "out-dooring" nella cerimonia di attribuzione
del nome La generale visione del mondo degli africani concorre in larga
parte al concetto delle fasi di sviluppo del ciclo della vita.
Tuttavia, l'approccio all'osservanza e all'esecuzione dei rituali di
"out-dooring" varia in alcuni aspetti delle specifiche culture.
Generalizzando, potremmo dire che la caratteristica principale
di questo rituale è la cerimonia di attribuzione del nome che
varia a seconda delle regioni, tribù, clan e tradizioni in Africa.
Considereremo a questo punto quelle più significative.
LA CERIMONIA DELL'"OUT-DOORING"
NELLA CULTURA GHANESE
In questo numero
1 La cerimonia dell'Out-
dooring
4 Punto di vista multiculturale
7 Gruppo di
Accompagnamento
7 Visita del Presidente della
Chiesa Metodista del Ghana
8 Un invito a te che ci leggi…
8 No comment…
L'outdooring è la
presentazione pubblica
del neonato
Vita Multiculturale
Giugno 2008
Bollettino Semestrale di collegamento per la pastorale multiculturale delle chiese evangeliche valdesi e metodiste del II distretto
PAGINA 2 VITA MULTICULTURALE
I neonati sono tenuti isolati dal mondo
esterno per sette giorni e portati fuori
solo l'ottavo giorno.
Alcuni dei nomi dati
ricordano le circostanze
della nascita del
bambino
I Mendes (Sierra Leone) La cerimonia di attribuzione del nome viene eseguita nelle prime
ore del mattino e chi officia è dello stesso sesso del bambino al
quale si assegna il nome. La cerimonia viene chiamata con il suo
nome tradizionale "Kpua gita ya", che significa letteralmente
"presentazione alla strada e al pubblico". Se si tratta di una
bambina, l'officiante donna porta la bambina fuori dalla casa, la
rivolge al sole e pronuncia le seguenti parole: "Assomiglia a me,
per come sono e per come mi comporto, perché sono io che ti sto
dando il nome". Così facendo, l'officiante trasferisce le proprie
qualità alla bambina. Normalmente gli uomini non sono autorizzati
a eseguire tale rituale su una bambina poiché è credenza diffusa
fra i Mendes che, se ciò avvenisse, la bambina acquisirebbe
caratteristiche maschili durante l'età adulta. Alcuni dei nomi che
vengono dati possono richiamare delle circostanze della nascita
del bambino con riferimento in particolare alla stagione, ad un
evento eccezionale etc. Gli Yoruba (Nigeria) La nascita di un bambino è occasione di grande gioia. Tre giorni
dopo la nascita viene eseguita una cerimonia chiamata "Il primo
passo nel mondo". Questa è seguita da un'altra importante
cerimonia chiamata "I-komo-jade": si tratta della prima
presentazione pubblica del bambino, sette giorni dopo la nascita
per le femmine, nove giorni dopo per i maschi. Viene fatto un rito
di purificazione attraverso il quale l'officiante pronuncia il nome del
bambino seguito dalla presentazione di offerte, doni e auguri dai
membri della famiglia, della comunità e degli ospiti invitati. I Ga (Ghana) Per tradizione, i Ga tengono i neonati isolati dal mondo esterno per
sette giorni e li portano fuori solo l'ottavo per il rito dell'"out-dooring"
e dell'attribuzione del nome. Perché i giorni siano sette, come
spiega M.J. Field, è dovuto alla credenza Ga che i neonati, nei
primi sette giorni della loro vita, siano esposti a sette pericoli. Per
questo motivo, se il bambino sopravvive ai sette giorni può essere
considerato una persona adatta a far parte della famiglia e della
comunità. La cerimonia si svolge normalmente fra le 5 e le 6 del
mattino, alla presenza dei membri della famiglia e degli amici.
L'"out-dooring", chiamato in Ga “kpodziemo engages” avviene
alla presenza di undici officianti, otto dalla famiglia paterna e tre
da quella materna. L'officiante principale, normalmente un
anziano, scelto per la bontà del carattere, presiede per tutta la
cerimonia. Nel contesto tradizionale si prega e allo stesso tempo
vengono distribuite libagioni. Il testo della preghiera tradizionale
recita, come osservato da E.A. Ammah, così: "Che giorno è oggi?
Oggi è lunedì (o un altro giorno della settimana): Nonni di Lunedì,
oggi mostreremo l'estraneo (il bambino) che starà con noi fino
all'apparire della stella del mattino: che possa rispettare il mondo!
E voi (antenati), ricevete il vino e bevetene così da poterlo
benedire." Il rito viene eseguito subito dopo la preghiera: il
bambino viene posto per terra per tre volte, in un punto pulito
appena prima. La terza volta viene lasciato per terra. Viene
aspersa dell'acqua per tre volte. Il bambino è così introdotto alla
terra e alla pioggia per poi essere benedetto da parte
dell'officiante anziano per tre volte. L'anziano prende il neonato
da terra e il nome viene annunciato da parte dell'officiante
principale. Viene offerto del vino di grano e ogni persona presente
ripete il nome del bambino prima di berne. Seguono poi la festa,
gli auguri e la presentazione dei doni per il bimbo.
PAGINA 3 VITA MULTICULTURALE
Gli Akan (Ghana) Il rituale Akan per l'attribuzione del nome e per l'"out-dooring" si
chiama “Abadinto.” Normalmente questo rito viene eseguito da
una persona conosciuta per avere saldi principi morali e con un
carattere esemplare all'interno della famiglia e della comunità. Per
la cerimonia vengono forniti due contenitori, solitamente dei calici:
uno contiene dell'acqua, l'altro del vino di palma, acquavite o
vino locale. Tutto questo viene seguito da una preghiera,
dall'offerta agli invitati di libagioni varie e dal rito dell'attribuzione
del nome. Prima di pronunciare il nome del bambino, l'officiante
prende in braccio il bimbo, ne pronuncia il nome e immerge il
proprio dito destro nell'acqua per poi bagnare la lingua del
bambino per tre volte dicendo: “ ….se wose nsu a nsu!” (che
significa letteralmente: “se dici che questa è acqua, che quello
che stai bevendo sia acqua"). L'officiante immerge poi il dito nel
vino di palma e bagna la bocca del bambino dicendo: “…se
wose nsà a nsà!” che significa letteralmente: “se dici che questo è
vino di palma, che quello che stai bevendo sia vino di palma".
Inoltre l'officiante aggiunge le parole “se wose tuntum a tuntum!
Wose fitaa a fitaa,” che significano: "se dici che quello che stai
vedendo è nero, che sia nero, se è bianco, che sia bianco". Il
significato di queste parole è che il bambino dovrà, crescendo,
dire la verità e essere affidabile in qualunque circostanza della
vita. Come osserva Kofi Asare Opoku, gli Akan e i Ga vedono
l'occasione di dare un nome ai neonati come l'opportunità di dar
loro la prima lezione morale e ciò mette in evidenza quanto la
moralità sia tenuta in alta considerazione se si vuole far parte di
una famiglia o di una comunità in Africa. Kwesi Akhan sostiene
che, le parole che accompagnano il gesto dell'intingere e portare
alle labbra del bambino il dito, instillino nel neonato la
consapevolezza di che cosa sia la moralità e la necessità di vivere
sempre in armonia con la verità per tutta la vita. Le conseguenze
dell'onestà vanno sempre sostenute senza mai scendere a
compromessi, sia che lascino un sapore dolce in bocca (l'acqua)
sia che lascino un sapore amaro (il vino). L'acqua e il vino rimasti
vengono mescolati e dati simbolicamente ai genitori ad indicare
la loro partecipazione al rituale in unità e armonia con il bambino.
Kwesi Akhan afferma inoltre che i genitori confermano
l'importanza dell'insegnamento morale attraverso questi riti e
simboli. Allo stesso modo essi desiderano rafforzare la lezione
morale data al bambino e condurlo ad avere una vita adulta
responsabile.
Conclusione
Nella cosmologia africana, la stabilità della famiglia dipende
molto dalla stabilità della comunità ed è per questo che la
cerimonia dell'"out-dooring" prevede necessariamente non solo la
partecipazione dei genitori e dei parenti stretti ma anche di tutta
la comunità di amici e conoscenti. Alcune chiese in Ghana, nel
tentativo di affermare i valori religiosi, culturali, morali e sociali del
rito dell'"out-dooring", hanno sviluppato delle speciali liturgie che
ne prevedono una comprensione cristiana. Si tratta di una
innovazione contestuale che dà a tale rituale una prospettiva
cristiana che fa appello al senso cristiano della mortalità,
dell'integrità, dell'affidabilità, e del discepolato in campo pubblico
e privato o, in altre parole, in famiglia e nella società.
Il rituale viene eseguito
da una persona dai
sani principi morali
PAGINA 4 VITA MULTICULTURALE
Punto di vista… multiculturale Pastore Sergio Ribet
Oggi diremmo che la parola “multiculturale” può essere intesa solo
come “tolleranza”, mentre il termine “interculturale” può suggerire
più scambio, maggiore reciprocità di approccio. Ma siamo tutti
coscienti, credo, del fatto che nessuna ricetta è perfetta, né tanto
meno definitiva…
Siamo fatti così: una tematica, un problema, un fenomeno sociale
nasce … quando io me ne sono accorto. Ma appena
approfondiamo un poco l’argomento che ci sta a cuore
scopriamo di non essere stati i primi, al contrario: c’è una prassi e
una ricerca molto più lunga di quanto immaginavamo, piena di
errori, di intuizioni felici, di problemi risolti e di necessità urgenti mai
seriamente affrontate.
La mia esperienza e la mia riflessione si svolgono soprattutto nel
quadro della FCEI. Ma non sfuggo al vizio che ho appena
denunciato. Credo importanti gli avvenimenti a cui ho
partecipato. Non conosco, o conosco poco o male, gli
avvenimenti precedenti. Un esempio: ricordavo a mala pena un
opuscoletto di Pierluigi Jalla. Quando era stato scritto? L’ho
cercato e l’ho trovato: Pierluigi Jalla, “Quale emigrazione?” (Tip.
Subalpina,Torre Pellice, marzo 1969), prefazione di Mario Sbaffi,
presidente della FCEI e del Comitato italiano per le migrazioni.
Ovviamente, i migranti, allora, eravamo noi, gli italiani.
In secondo luogo cerco di sintetizzare qual è il mio punto di vista su
quanto sta avvenendo nelle chiese che fanno parte della FCEI. A
grandi linee, le chiese che hanno incontrato (o sono state
incontrate) da migranti si sono attrezzate, bene o male, per
l’accoglienza. Salvo qualche eccezione, tuttavia, non hanno
elaborato una riflessione profonda. Hanno svolto un compito
assistenziale (prima accoglienza, accompagnamento nelle
vicende burocratiche, appoggio per apprendere l’italiano, aiuto
per la ricerca di lavoro, casa, necessità primarie); lo hanno svolto,
e lo svolgono tuttora, o delegando questo compito non facile ad
un gruppo di lavoro, o ad alcune persone, o facendosene carico
a livello comunitario. C’è, di solito, la comprensione che le tappe
per una corretta integrazione sono diverse, non facili, che mentre
cominciamo a conoscere i migranti arrivati anni fa continuano a
giungere nuove migrazioni che ci sono sconosciute. Non
dimentichiamo che anche nelle nostre chiese ci sono posizioni
istintivamente contrarie all’afflusso di stranieri, e posizioni che
vorrebbero proporre agli stranieri semplicemente una assimilazione
alla cultura del paese dove giungono, al modo di vivere della
chiesa di cui sono “ospiti”. Ovviamente, le migrazioni portano
vantaggi, svantaggi, novità gradite e tensioni. Vi sono alcune linee
di tendenza simili ovunque e in ogni tempo, e specificità che si
trovano solo in quel luogo e in quel momento. La fase
“accoglienza”, la fase “assistenza”, i cammini di “integrazione” si
sovrappongono, ci sono sempre i “nuovi arrivati”, e un equilibrio
provvisorio che si era creato nel quadro sociale (e nella chiesa)
viene quotidianamente rimesso in gioco, va ricostruito ogni volta
che anche una sola persona parte o arriva. Quel che mi sta a
cuore oggi è lavorare perché quello che viviamo, persone
migranti e persone che sono nate nel luogo dove risiedono, possa
essere una convivenza non conflittuale o almeno in grado di
riconoscere le conflittualità reali e quindi individuare le possibili
soluzioni dei conflitti.
Le migrazioni portano
vantaggi e svantaggi,
novità gradite e tensioni
I migranti, allora,
eravamo noi, gli italiani
PAGINA 5 VITA MULTICULTURALE
Per raggiungere questo scopo, solo all’apparenza minimale,
occorre conoscere l’altro e conoscere anche di riflesso, se stesso;
comprendere che il rapporto non è unilaterale (io spiego, io do, io
comprendo, io insegno) ma bilaterale; che il migrante non parte
da una situazione di pari opportunità, e quindi è necessario quel
che in inglese si chiama “empowerment”. Che vuol dire? Fare in
modo che le capacità, le conoscenze, le forze dell’interlocutore
vengano riconosciute, non restino nascoste, vengano a galla, e
non siano solo delle potenzialità, ma diventino opportunità
realmente utilizzabili, per essere se stessi, se stesse, in modo pieno e
non con personalità mutilate. Lavorare per l’empowerment
dell’altro è anche lavorare per l’empowerment di me stesso.
Potremmo dirlo in molti modi, attivi o passivi:
Se non amo me stesso, come posso amare il mio prossimo?
Se imparo a conoscere l’altro imparo a conoscere me
stesso.
Se so ascoltare saprò anche parlare.
E via declinando. Tutto questo io lo chiamo “Essere chiesa
insieme”. Ma questo può portare ad equivoci. “Essere chiesa
insieme” è un gruppo di lavoro collegato con il Servizio Rifugiati e
Migranti della FCEI, è una formula che è usata in molte delle nostre
chiese, in ogni luogo con sfumature diverse. Non è una
organizzazione, una chiesa, né un modo di agire e pensare. Per il
momento, è una parola valigia in cui mettiamo il bagaglio che
riteniamo indispensabile, ma siamo ancora ben lontani dalla
comprensione di quanto è un “indispensabile” condiviso. Vorrei
che “essere chiesa insieme” fosse la meta di una chiesa dove
hanno spazio giovani e vecchi, donne e uomini, chi viene da
lontano e chi è sempre stato qui, chi ha una spiritualità come la
mia e chi è portatore di tutt’altra spiritualità, chi è uguale e chi è
diverso, … Terzo e ultimo punto. Che cosa succede nella chiesa
metodista di Bologna e Modena, nella quale svolgo il mio compito
pastorale dal 2005? Anche qui devo sintetizzare, una descrizione
esauriente sarebbe troppo ampia. Secondo i dati statistici della
Relazione al Sinodo 2007 la chiesa metodista di Bologna e
diaspora conta 173 membri comunicanti, e una popolazione
evangelica di 292 persone. La media di presenze al culto è di 78
persone. Ma dietro a questi numeri c’è una situazione in continuo
movimento. Non c’è domenica in cui non entrino nella nostra
chiesa persone nuove. Rispetto a dieci o quindici anni fa il gruppo
storico è diminuito (decessi, trasferimenti, persone anziane che no
possono venire in chiesa, ecc.), diversi italiani provenienti da altre
chiese o da contesti secolarizzati sono diventati membri di chiesa,
così come diversi non-italiani. Ci sono anche molti “simpatizzanti”,
alcuni saltuari, altri puntualmente presenti, ci sono nuovi
catecumeni adulti. Le persone che partecipano al culto non
rispecchiano le persone che risultano essere membri di chiesa. Tra
quanti vediamo in chiesa la domenica, vi sono rappresentanti di
almeno una dozzina di nazionalità. Almeno un terzo dei
partecipanti abituali è costituito da sorelle e fratelli africani, e un
buon numero da europei, sudamericani, asiatici. Nelle attività
della chiesa si ritrova una situazione analoga. Soprattutto nella
scuola domenicale e nel catechismo comincia ad essere
importante la componente di origine straniera.
Se non amo me stesso,
come posso amare il
prossimo?
Una situazione in
continuo movimento...
PAGINA 6 VITA MULTICULTURALE
Ma, oltre alla chiesa metodista, si ritrovano nei nostri locali altre
chiese. Con continuità, da anni, una delle chiese evangeliche
filippine della città (la prima in ordine cronologica: inizialmente
pluridenominazionale, ora soprattutto presbiteriana), e una chiesa
ucraina (che include anche russi e moldavi), di tendenza
pentecostale e battista. Con queste chiese, o parte di esse,
abbiamo incontri costanti, in particolare per il lavoro che
facciamo con i migranti. Abbiamo ospitato per un anno e più la
Chiesa avventista, quando erano in corso i lavori per la loro nuova
chiesa, e ci ritroviamo con gli avventisti in varie occasioni
ecumeniche. La diaspora luterana dell’Emilia Romagna ( e in
parte marchigiana), seguita dal pastore luterano di Firenze, utilizza
i nostri locali per alcuni dei suoi incontri, e abbiamo momenti di
culto in comune (Giornata della Riforma, periodo pasquale e
natalizio, incontri ecumenici). Un gruppo coreano presbiteriano ha
le sue prove di canto e i suoi studi biblici nella nostra sala. Ci viene
richiesto l’uso della chiesa per matrimoni, per esempio da chiese
protestanti eritree. In poche parole, le varie modalità accennate
da Alfonso Manocchio nell’articolo citato all’inizio le troviamo tutte
nella nostra chiesa bolognese:
vivere insieme nella stessa comunità
vita comunitaria saltuariamente insieme
vita comunitaria separata negli stessi locali (non però con
chiese unite nello stesso Sinodo).
Infine, nei locali della nostra diaspora a Modena viviamo una
situazione analoga. Negli stessi spazi si ritrova il gruppo metodista,
un gruppo avventista (prevalentemente italiano), una chiesa
ghanese parte dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
(UCEBI), e quindi a tutti gli effetti una delle “nostre chiese”. La
domanda che ci facciamo è: siamo attrezzati per far fronte alla
nuova situazione che si sta creando? Al momento abbiamo due
strumenti efficaci: una scuola di italiano per stranieri, attiva da
cinque anni, che da un centinaio di persone è giunta ora ad un
tetto di 420 iscritti (e non siamo in grado di ospitarne di più, al
momento, sia per gli spazi che per il rapporto numerico tra
insegnanti e allievi). Una iniziativa avviata da un nucleo di fratelli e
sorelle della nostra chiesa, che hanno anche trovato collaboratori,
amici, fondi necessari per questa attività. Altro strumento, un
gruppo locale “Essere chiesa insieme”, che lavora soprattutto per
accompagnare gli immigrati, prevalentemente delle nostre
chiese, per gli iter burocratici, e con il forte aiuto del nostro gruppo
africano, per la ricerca di casa e lavoro. Questo gruppo è in
contatto con il Servizio Rifugiati e Migranti della FCEI, e sta
promovendo incontri, dentro e fuori dalla nostra chiesa, sulle
tematiche della migrazione, e per azioni di solidarietà, contro ogni
forma di razzismo.
Vivere insieme nella
stessa comunità
Momento alla Scuola di
Italiano della chiesa di
Bologna
PAGINA 7 VITA MULTICULTURALE
Il giorno 14 giugno si è svolto a Parma, presso la chiesa metodista,
l'incontro del gruppo di accompagnamento per il progetto
Mezzano/Secondo Distretto. Il gruppo è presieduto dal pastore
Daniele Bouchard e ha il compito di monitorare, fornire
suggerimenti operativi e di impostazione del lavoro al pastore
Ennin, nel quadro del progetto della Cevaa. Dall'incontro sono
emersi molti spunti interessanti che potranno costituire nuovi ambiti
di lavoro per i prossimi mesi. La novità più importante è però l'arrivo
dal Ghana di un nuovo pastore, il quale dovrebbe essere
affiancato nel suo compito da un pastore italiano. I due sarebbero
impegnati nel portare avanti il progetto già iniziato dal pastore
Ennin, il quale lascia la chiesa di Mezzano per occuparsi a tempo
pieno della chiesa di Pordenone. George Ennin resterebbe però
nel gruppo di accompagnamento e continuerebbe a fornire il suo
prezioso aiuto ai due nuovi pastori incaricati del progetto
"Mezzano/Secondo Distretto". Il gruppo di accompagnamento è
stato inoltre allargato con l'arrivo di tre nuovi membri provenienti
dalla Lombardia e dal Veneto. Il prossimo incontro è previsto per il
27 di settembre a Parma.
Gruppo di Accompagnamento Costantino Sbacchi
Visita del presidente della chiesa
metodista del Ghana Lino Pigoni
Su invito dell’OPCEMI il President Bishop, Rev Dr. Robert Aboagye-
Mensah e il Lay President, Dr. James Alfred Abadoo Brew, hanno
visitato diverse comunità. Nel Nord-Est (2-3 febbraio) vi è stato
l’incontro con il Consiglio di Chiesa di Udine, con la Chiesa di
Pordenone e con il gruppo di Conegliano. Particolarmente
partecipato quello di Pordenone: oltre quattrocento fratelli e sorelle
molti dei quali provenienti da altre località del Triveneto e non solo.
Gli incontri sono stati occasione di confronto per valutare il
cammino di integrazione fatto dalle nostre comunità, per aiutare
nella comprensione delle differenze organizzative e per cercare di
superare malintesi e contrapposizioni dopo la visita del moderatore
della Chiesa Presbiteriana del Ghana. Il moderatore della Chiesa
Metodista del Ghana ha sottolineato in particolare i seguenti
aspetti:
viene ribadita, per quanto riguarda i membri ghanesi, la
necessità di non costituire gruppi o chiese autonome che
rispondano direttamente alle chiese-madri del Ghana ma
di condividere la propria fede con i fratelli e le sorelle della
Unione delle Chiese metodiste e valdesi.
L’appartenenza e l’inserimento attivo nelle nostre chiese
deve avvenire nella ricerca di una condivisione delle
diverse identità che ovviamente non si appiattiscono ma si
arricchiscono creando nuovi modi di ESSERE CHIESA
INSIEME.
Nella tradizione ghanese le attività dei gruppi sono
coordinate da leader che sebbene svolgano il loro ruolo in
modo proprio è necessario che trovino modalità di
raccordo con i Consigli di chiesa e questo almeno per la
prima generazione.
Un pastore ghanese e
uno italiano potrebbero
portare avanti il lavoro
iniziato dal pastore
George Ennin
Rev Dr. Robert
Aboagye Mensah
PAGINA 8 VITA MULTICULTURALE
Un invito a te che ci leggi
Caro lettore, come avrai notato leggendo queste pagine, il taglio editoriale di "Vita
Multiculturale" è leggermente cambiato. Come già annunciato, vorremmo inserire
qualche piccolo saggio, come quello in prima pagina firmato dal pastore Ennin, per
capire meglio la realtà multiculturale che si sta ormai consolidando nelle nostre chiese.
Per questo, ogni suggerimento è sempre il benvenuto.
Ti invitiamo a scrivere e ad eventualmente sottoporci un tuo articolo, al seguente
indirizzo:
Chi siamo…
La commissione per la Pastorale Multiculturale del 2º distretto è costituita da: past.
George Ennin, past. David Markay, Victoria Munsey, Past. Janique Perrin, Past. Sergio
Ribet, Costantino Sbacchi, Past. Jonathan Terino.
No comment…