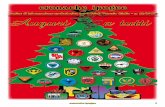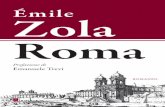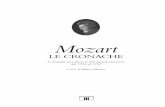VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO PREMESSA Classe I E A.S ... piani... · crescita anche se non mancano...
Transcript of VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO PREMESSA Classe I E A.S ... piani... · crescita anche se non mancano...
VERIFICA DEL PIANO DI LAVOROPREMESSA
Classe I E A.S. 20012-2013
La classe alla fine dell'anno conserva alcune delle fragilità di stampo logico-critico già sottolineate in relazione a singole discipline, ma nel complesso risulta maturata nella qualità degli interventi promossi in aula e nell'impegno metodologico applicato al materiale testuale e concettuale proposto dagli insegnanti. Il quadro d'insieme consegna pertanto un profilo di gruppo in crescita anche se non mancano al suo interno differenze talora importanti sia per quanto riguarda le motivazioni allo studio sia per quanto concerne il grado di conoscenze e competenze effettivamente raggiunte dai singoli.Sotto l'aspetto relazionale, la classe si conferma generalmente corretta e aperta al dialogo culturale con i docenti, solidale e unita nella componente discenti, in un atteggiamento di fondo che si può definire umanamente e scolasticamente costruttivo.Il progetto comune di inizio anno risulta pertanto interpretato con discreta efficacia, nel rispetto dei contenuti e della loro valenza educativa.
Nel corso dell'anno sono state promosse diverse attività aggiuntive e/o integrative dell'iter scolastico, sfruttando spazi orari interni al curricolo ma anche a questo esterni:
• Talk in English• “Adotta uno spettacolo”: Un marito ideale. O.Wilde• Giornate del F.A.I.;• Gadda Prize;• Visita guidata a Trento per la mostra “Homo sapiens”;• Visita guidata all'Immaginario scientifico a Trieste;• Visita guidata a Spilimbergo per la mostra “ I colori del sacro”;• Visita alla mostra di Pizzinato presso Museo Parco di Pordenone• V Convegno su Lucrezio;• Escursione presso Rampy-Park di Piancavallo;• Giornata della Poesia.
Come emerge dalla relazione degli studenti, tali occasioni di studio, approfondimento ed esercizio motorio, condotte in contesti diversi da quelli rigidamente scolastici, hanno trovato comune apprezzamento sia in ragione dei contenuti culturali sia per la veste “sociale” che hanno assunto.Un giudizio positivo è stato espresso dagli alunni anche in relazione al servizio sportelli attivato dalla scuola, la cui utilità è stata sottolineata con decisione.
Verifica del piano di lavoro
Italiano Docente: Maria Carolina Tedeschi Ore settimanali: 4 Manuali in adozione:- R. Luperini- L. Marchiani- P. Cataldi- F. Marchese, Il
nuovo La scrittura e l’interpretazione – G. B. Palumbo editore – voll.1 e 2
-Dante, Inferno – Purgatorio ( edizione libera) Riferimenti fondamentali per questo documento di programmazione sono stati:
il Piano dell’Offerta Formativa (P.O. F.), cui si rinvia per eventuali
delucidazioni;
la programmazione dipartimentale;
la situazione di partenza della classe.
Situazione finale della classe
La classe ha dimostrato per la materia sin dall’inizio curiosità e
motivazione spontanee( magari non sempre disciplinate), realizzando in più di un contesto indubbie e stimolanti occasioni di approfondimento.
Tuttavia,anche in seguito e a verifiche informali e formali e al test d’ingresso
concordato per le classi prime , erano state rilevate per un buon numero di studenti conoscenze inadeguate, approssimative di analisi del testo (in poesia e in prosa in eguale misura) dovute a ridotta sistematicità
nell’acquisizione delle necessarie, e imprescindibili per il triennio,
competenze testuali. Diversi studenti, inoltre, non erano in grado di esporre i contenuti appresi, talvolta non puntualmente, con il registro specifico della disciplina, forse per mancanza di abitudine alla produzione orale. Si riscontravano tuttavia, nella più parte degli alunni ,un indubbio senso critico, a volte sostenuto anche da accettabili argomentazioni, e una forte volontà di recupero; notevole e spiccata, inoltre,era l’attenzione all’attualità e a temi di grande interesse politico o culturale. Proprio per queste ultime caratteristiche è stato però possibile un notevole cambiamento ma anche si è rivelato necessario proporre, pur in itinere e compatibilmente con la programmazione e le sue necessità, attività laboratoriali per il recupero delle principali conoscenze di analisi testuale,
competenze che , data la buona disponibilità all’apprendimento, è stato
possibile recuperare, sebbene con esiti ad oggi diversificati, eterogenei, anche per potenzialità e abilità diverse degli studenti. La maggior parte di loro è ora infatti in grado di formulare adeguate conoscenze e di esprimersi con il
registro specifico, pur dovendo rilevare in alcuni casi uno studio superficiale, poco sistematico e critico. Nella produzione scritta, anche se con qualche limite per alcuni alunni, la classe ha acquisito una buona padronanza degli strumenti necessari per la stesura di un testo coerente e coeso, sì da affrontare con una certa disinvoltura le tipologie testuali ( A e B dell’Esame di Stato)proposte durante l’anno.
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è stato improntato a
collaborazione e disponibilità, accompagnate da impegno domestico però non sempre puntuale . La classe si è dimostrata comunque attenta, pronta a recepire gli stimoli offerti e a rispondervi anche con riflessioni valide.
Linee metodologiche
Modulo sulle competenze
La classe, come da accordo preso all’interno del Dipartimento, ha partecipato al Progetto Lucrezio per condurre un’esperienza didattica per competenze a livello interdisciplinare( italiano, latino, storia, filosofia, IRC,…).
L’intervento è stato perciò reso funzionale a sviluppare , in particolare, le
seguenti competenze chiave di cittadinanza: - Imparare ad imparare - Collaborare e partecipare - Risolvere problemi. È stato pertanto attuato un laboratorio didattico a microgruppi con compiti specifici assegnati dal docente per soddisfare le seguenti Competenze,
Abilità e Conoscenze, per un’ora a settimana e per un totale di 6 ore nel
mese di marzo su Petrarca e il suo Canzoniere. Competenze Abilità Conoscenze Saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi
Individuare nei testi gli elementi di continuità e di innovazione rispetto ai modelli di riferimento
Conoscere passi di autore attinenti al percorso
Saper esercitare in modo autonomo
l’analisi testuale
Individuare nei testi le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e contenutistiche.
Conoscere gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia
Obiettivi
Gli studenti hanno conseguito i seguenti obiettivi: Ambito linguistico-comunicativo a)Consolidamento/potenziamento delle capacità espositive ed argomentative, sia orali che scritte. b) Più nello specifico, ovviamente anche in vista della prima prova scritta
dell’Esame di Stato sono in grado di produrre:
- esempi di scrittura documentata, ovvero “ articolo” e “saggio breve”
(tipologia B della prima prova scritta dell’Esame di stato);
- analisi testuale (tipologia A della prima prova scritta dell’Esame di stato)
Ambito storico-letterario a) Conoscenza, approfondimento e rielaborazione dei contenuti proposti; nello specifico: - acquisizione di un bagaglio minimo di conoscenze relative ai movimenti, ai generi, agli autori e alle opere maggiori della letteratura italiana dalle origini della letteratura al Rinascimento ; - acquisizione di una certa familiarità con la lingua, lo stile e soprattutto il pensiero di Dante, mediante la lettura diretta di alcuni canti di Inferno e Purgatorio; b) maturazione della consapevolezza delle potenzialità della parola nonché delle caratteristiche e soprattutto della ricchezza e del valore dei testi letterari. Complessivamente si è puntato a : a) sviluppo delle capacità metacognitive: coscienza dei propri punti di forza e di debolezza, consapevolezza e gestione autonoma del metodo di studio, capacità di autovalutazione b) maturazione del senso di responsabilità e della capacità critica c) sviluppo di abilità di collegamenti inter e pluridisciplinare
Contenuti
1. AMBITO LINGUISTICO-COMUNICATIVO Scritto: introduzione e esercitazioni delle tipologie A e B richieste
dall’Esame di Stato in relazione a finalità, struttura, specificità di registro.
Orale: oltre alle consuete “interrogazioni” e a momenti informali di dialogo-discussione aperti a tutta la classe, ci sono state esposizioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi in occasione del Modulo su Petrarca. 2. AMBITO STORICO-LETTERARIO: dalle origini al Rinascimento.
È stata tracciata una panoramica sullo svolgimento della letteratura italiana dalle origini al Rinascimento, strutturata in moduli articolati per temi, movimenti, generi, autori e tempi. Sono state affrontate la lettura, l’interpretazione e il commento di un numero significativo di canti dell’ Inferno e del Purgatorio ( solo 2) di Dante Alighieri. Lo svolgimento ha avuto come punto di partenza il testo, letto e interpretato in funzione e della ricostruzione della poetica di un autore e della medesima panoramica storico – letteraria.
Dalle origini al Medioevo
- Introduzione al Medio Evo: la visione cristiana del mondo, la cultura medievale, la letteratura. - La nascita della letteratura in diverse lingue volgari: il contesto storico e socio-culturale in Francia, la lirica provenzale, la chanson de geste; il contesto storico e socio-culturale in Italia: la letteratura e la lirica religiosa, la Scuola Siciliana, il Dolce Stil Novo, la poesia “comica”, la prosa con la storiografia, le cronache di viaggio la narrativa e la novellistica. - Dante: la vita, le opere in volgare, le opere in latino.
- Gli intellettuali, l’immaginario, la cultura con l’affermazione degli Stati
regionali e nazionali. - G. Boccaccio: la vita, le opere minori, il Decameron. - F. Petrarca: la vita, il nuovo intellettuale, le opere in volgare, le opere in latino.
TESTI E AUTORI Canto dei bevitori, Carmina Burana La morte di Orlando, Chanson de Roland A. Cappellano, I comandamenti d’amore C. de Troyes, La notte d’amore fra Ginevra e Lancillotto G.d’Aquitania, Per la dolcezza della nuova stagione B. de Ventadorn, Quando vedo l’allodoletta muovere F. d’Assisi, Laudes creatura rum J. Da Todi, O iubelo de core- O Signor, per cortesia G. da Lentini, Meravigliosamente C. d’Alcamo,Contrasto G. d’Arezzo, Ahi lasso, or è stagion de doler tanto” G. Guinizzelli, Al cor gentile…; Lo vostro bel saluto…; Io voglio del
ver… G. Cavalcanti, Chi è questa …; Voi che per li occhi…; In un
boschetto…: Perch’i non spero… Dante Alighieri, Per chi udisse tossir la malfatata R. Filippi, O dolce mio marito Aldobrandino
C. Angiolieri, La mia donna…; S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo, Becchin’ amor.
M. Polo, Le pietre che ardono; i costumi sessuali e matrimoniali… Novellino, Il matrimonio del medico di Tolosa. Dante Alighieri:
Vita nuova: Proemio; il primo incontro con Beatrice; la donna schermo; il saluto di Beatrice; un nuovo pubblico e un nuovo tema; la lode di Beatrice; un sonetto con due inizi. Rime:Guido, i’ vorrei…; Per una ghirlandetta; Cos’ nel mio parlar…; Tre donne intorno al cor…;. Convivio: la scelta del volgare; Amor che nella mente mi ragiona. De vulgari eloquentia: la definizione del volgare modello Inferno, canti 1,2,5,6,10,13,26,33; Purgatorio, canti 1,2,3.
G. Boccaccio: Filocolo: l’innamoramento di Florio e Biancifiore. Ninfale fiesolano: le ninfe al bagno e l’inganno di Africo Decameron: Ser Ciappelletto; Andreuccio da Perugia; l’autodifesa dell’autore; Tancredi e Ghismunda; Elisabetta da Messina; Nastagio degli Onesti; Federigo degli Alberighi; Griselda; Chichibio e la gru; Frate Cipolla; la novella delle papere e quella del cuore mangiato.
F. Petrarca: Familiari: l’ ascensione al Monte Ventoso; lettera ai posteri. Secretum: l’amore per Laura sotto accusa. Canzoniere: Voi ch’ascoltate…; Era il giorno…; La gola e ‘l somno…; Quando fra l’altre donne …; Movesi il vecchierel…; L’oro et le perle…; Ne la stagion…; Erano i capei…; Chiare, fresche…; Fiamma del ciel…
Umanesimo e Rinascimento
- L’età delle corti: basi economiche e politiche del potere signorile, le
condizioni dell’intellettuale e la cultura, ideologie e immaginario degli
umanisti. - La letteratura umanistica: generi, opere, autori, dalla lirica al poema epico – cavalleresco, dal trattato al romanzo allegorico e pastorale, da Nord a Sud.
- La situazione economico-politico-culturale post conquista dell’America e
Concilio di Trento nell’immaginario del Cinquecento. ( Introduzione)
- I generi del Rinascimento: il trattato, la storiografia, la narrativa e la novellistica, la poesia lirica e quella burlesca.
- L. Ariosto: la vita, le opere minori, l’Orlando furioso.
- L. Pulci: la vita, le opere; il Morgante:fonti, personaggi, trama. - M. M. Boiardo: la vita, le opere, l’ambiente, gli Amorum libri e l’Orlando innamorato.
- L. Ariosto: la vita, le opere minori, l’Orlando furioso.
TESTI E AUTORI
Pico della Mirandola, La dignità dell’uomo e il libero arbitrio ( De
hominis dignitate) L. Battista Alberti, La difesa del volgare ( Della famiglia) Burchiello, “ Nominativi fritti e mappamondi” Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco A. Poliziano, “ I’ mi trovai,…”; “ Ben venga maggio”; Stanze per la
giostra (ottave 33-35, 37-38,43-54). L. Pulci, Morgante, Morgante incontra Margutte; Astarotte diavolo
teologo; il “ tegame” di Roncisvalle. M.M. Boiardo, Già vidi uscir…( Amorum libri); Orlando
innamorato:Esordio del poema; Angelica alla corte di Carlo Magno; Bradamante si rivela a Ruggiero.
L. Ariosto: Satire: il poeta e i cortigiani ( I, 1-138) Orlando furioso: proemio; il palazzo di Atlante; la pazzia di Orlando; Astolfo sulla luna.
NB: è stata rinviata al prossimo a.s. la trattazione di Machiavelli e Guicciardini, prevista nella Programmazione iniziale, data la mancanza di tempo utile per uno svolgimento adeguato di contenuti che richiedono anche maggiori e più solidi strumenti culturali.
Metodi
- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti interdisciplinari. - Esposizioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a singole parti o aspetti del programma - Lavori di gruppo e /o di approfondimento - Spettacolo teatrale “ Un marito ideale”, O. Wilde. - Concorso di scrittura “ Gadda Prize 2013” - Giornata della Poesia
Strumenti
- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) - Appunti - Lettura integrale di testi ( romanzi, commedie, tragedie) - Fotocopie integrative - Video lezioni
Verifica e valutazione
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non sono state solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi di testi, compiti in classe, poiché si è tenuto conto anche di interventi spontanei da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro.
Sono stati effettuati 3 compiti scritti per le tipologie previste per l’Esame
di Stato e 2/3 verifiche orali almeno per quadrimestre, utilizzando per queste anche forme scritte( test, questionari, recensioni). Nella valutazione sommativa sono stati considerati indicatori ulteriori - la presenza,- la partecipazione attiva alle lezioni, - la scrupolosità
nell’esecuzione del lavoro domestico, - la capacità di instaurare autonomi
collegamenti inter e multi disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di ciascuno. Per la definizione generale dei criteri di valutazione si rimanda al P.O.F..
Attività di recupero e/o di approfondimento
In fase di avvio dell’anno scolastico non si era ravvisata la necessità di
proporre attività di approfondimento, mentre quelle di recupero si sono svolte in itinere. Pordenone, 3 giugno 2013
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI LATINOClasse I E A.S. 2012-2013
La classe nel suo insieme si è dimostrata partecipe e impegnata nell'esercizio linguistico guidato, collaborativa e interessata allo sviluppo dei contenuti culturali passibili di dibattito e di confronto critico; nei lavori di gruppo si è mossa con spirito di iniziativa e discreta efficacia.Sul fronte delle specifiche abilità linguistiche, promosse ed esercitate dall'insegnante attraverso spazi teorici ed operativi di diverso profilo (traduzione guidata, illustrazione di testi d'autore, puntualizzazioni morfologico-sintattiche, osservazioni di ordine lessicale, presentazione ex novo di argomenti logico-grammaticali), la classe ha sfruttato diligentemente le possibilità di esercizio ma non lo ha sempre reinvestito con puntualità d'azione metodologica e sistematicità dei tempi d'applicazione negli spazi domestici individuali.Quanto agli argomenti di letteratura, hanno sortito discreto interesse e partecipazione in classe e sono stati “reinterpretati” nello studio individuale in modo adeguato.Il progetto iniziale risulta pertanto confermato nelle linee generali. Mancano alcuni passi in lingua originale, che avrebbero conferito maggiore unità e spessore ai percorsi tematici individuati, ma nell'insieme i contenuti culturali essenziali per l'anno in corso sono stati svolti.
La verifica relativa al lavoro disciplinare è stata condotta attraverso il confronto orale, la correzione dei lavori domestici, le verifiche in itinere (orali e scritte), ricerche e lavori di gruppo, formule combinate di quesiti a scelta multipla e trattazioni sintetiche di argomenti.
CONTENUTI del programma svolto di Latino
– Origini della letteratura latina e forme preletterarie.– Carmina, le forme embrionali di oratoria e storiografia.– La satira drammatica, la fabula atellana.– Il teatro di importazione greco e le soluzioni romane: cothurnata,
praetexta, palliata, togata.– Personaggi e situazioni tipiche della palliata.– Livio Andronico: la produzione teatrale, l'Odusia, il vertere latino.– Nevio: l'opera teatrale; Bellum Poenicum: il debito nei confronti della
poetica ellenistica, il tratto “antropologico” romano.Frammenti riportati in antologia.
– Ennio: le tragedie. Soggetti e stile.Annales: il poeta-filologo, struttura dell'opera, chiavi di interpretazione del poema (i proemi al libro I e al libro VII), il sogno simbolico e profetico (Ilia). La guerra: frammenti(tutta la serie riportata nella sezione antologica).Lo stile: espressionismo e “sonorità rappresentativa”.
– Catone: fisionomia politica e culturale.L'agricoltura come ideologia; De agricultura: praefatio.Orationi: Pro Rhodiensibus.
– Plauto: la trasmissione delle commedie. Agnizione,beffa, l'equivoco dei simillimi. Linguaggio iperbolico e metateatro. Deverbia e cantica. Cistellaria vv.206-228 (fotocopia)Miles gloriosus vv.1-78;vv.272-353;vv.481-595;vv.1137-1195;vv.1411-1422.Casina vv.217-278; vv.814-854; vv.856-1018 (fotocopia)Maenechmi vv.701-752; vv.910-956Amphitruo vv.1-152; vv.402-462Pseudolus vv.280-298;vv,340-369; vv.574-593; vv.667-687Curculio vv.462-486.Aulularia vv.79-119; 178-267; 727-777
– Terenzio e il teatro dell'impegno. La voce dell'autore nello spazio del prologo.Heautontimorumenos vv.53-168Hecyra vv. 577-606, 816-840.Adelphoe vv.26-77; vv.355-434; vv.540-591; vv.610-712; vv.713-762; vv.787-835; vv.855-881; vv.984-997
– Lucilio e il genere della satira: frammenti riportati nella sezione antologica.
– Cesare: la vita. I Commentarii e il genere storiografico.Il De bello Gallico e il De bello civili.De bello Gallico: I,1;V,55,2-4;56,1-2;VI,13,1-4,14,16,17,1-3 ,18,19,20,21,22; VII 77,12-16De bello civili : I,1-2;I,8; I,9-11;III,91,94,96.
– Lucrezio e il poema didascalico.De rerum natura I, 1-43; 62-79; 80-101; 130-148; 921-950
II, 1-22;216-229;262;342-370;1090-1179III, 324-930; 931-977;1053-1075IV,962-1029;1058-1140V, 925-1010VI, 1230-1246; 1272-1286
Approfondimenti linguistico-tematicia. I nemici di Roma: Cesare, De bello gallico V,55,2-4; 56,1-2; VII 77,12-16 Sallustio, Bellum Iugurthinum 5, 5-7; 6 Livio, Ab urbe condita XXI, 4; XXXV, 14,7-12b. Ritratti di donne: Sallustio,De coniuratione Catilinae 23,3-6; 25 (fotocopia)
Livio, Ab urbe condita libri I 48, 5-7; 57,7-9; II 13,6-11c. Caso e provvidenza nella concezione del tempo e della storia: Lucrezio, De rerum natura II 1090-1179;III 324-930;V 925-1010 Cicerone, De natura deorum II,21-22;62-63;66 Seneca, De beneficiis IV, 18,2-4
Sintassi
Sintassi dei casi: ripassoCompletive dichiarative, completive volitiveCongiuntivo indipendenteOratio obliqua
L'insegnantePaola Domini
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI GRECO La classe ha confermato una partecipazione vivace al dialogo educativo, accogliendo con autentico e diffuso entusiasmo gli stimoli culturali offerti e realizzando un clima disteso e collaborativo. Anche se l’interesse non si è sempre accompagnato ad un altrettanto intenso e regolare impegno di studio individuale per tutti gli studenti, il livello medio di apprendimento è sicuramente soddisfacente per la parte linguistica, discreto per la parte letteraria. Si sono registrati progressi anche nella esposizione orale, ma in alcuni casi dovrà essere curato maggiormente il lessico specifico sia della riflessione linguistica, sia della letteratura, per l’acquisizione sicura del mezzo espressivo. Maggiore precisione dovrà poi esserci nella memorizzazione dei paradigmi verbali e nell’analisi sintattica preliminare alla traduzione. In alcuni momenti dell’anno gli studenti hanno approfondito ed esposto a gruppi approfondimenti e rielaborazioni degli argomenti studiati con risultati discreti e con efficace utilizzo dei supporti multimediali. Gli obiettivi individuati all’inizio dell’anno, quindi, sono stati raggiunti in modo diversificato, ma generalmente soddisfacente per quasi tutti gli studenti. Gli obiettivi relativi alle conoscenze linguistiche e alle abilità di traduzione in italiano sono stati perseguiti attraverso un metodico lavoro di revisione e di completamento degli argomenti grammaticali e un esercizio costante in classe e a casa. Particolare cura è stata prestata all'utilizzo del manuale di teoria, sia in classe che a casa, per un inquadramento più sistematico delle conoscenze con un accostamento alla lingua anche in dimensione diacronica (elementi di storia della lingua). Nella prima parte dell’anno è stata tradotta integralmente un’orazione di Lisia (Per l’uccisione di Eratostene) per acquisire elementi sulla condizione della donna nel mondo antico in accordo con la docente di Latino e per confrontarsi con un testo autentico ed esemplare anche sul piano linguistico. Nella seconda parte dell’anno sono stati tradotti alcuni passi dalle Storie di Erodoto. Il lavoro di traduzione dei passi relativi al percorso tematico sul tempo è avvenuto perlopiù in classe attraverso il lavoro a gruppi guidato dall’insegnante. Lo studio della letteratura si è avvalso delle spiegazioni da parte dell’insegnante, della lettura e del commento dei testi antologici e del sussidio di saggi ed articoli scientifici proposti per l’approfondimento individuale di alcuni temi particolarmente interessanti anche a livello interdisciplinare. Dei principali autori della letteratura oggetto di studio sono stati proposti passi in lingua per il confronto diretto con le caratteristiche linguistiche, stilistiche e concettuali proprie delle loro opere. Particolare attenzione è stata dedicata all’apprendimento del lessico per radici o per campi semantici coerenti con le tipologie testuali presentate e alla
riflessione sull’etimologia e gli ampliamenti semantici utilizzando i testi adottati. Per quanto riguarda il tema "Lucrezio e il tempo", sulla base delle competenze di cittadinanza scelte e indicate nella Premessa, è stato proposto un laboratorio didattico di cui si prevede una verifica comune all’inizio del prossimo anno.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche scritte di traduzione sono state 5. Le verifiche orali, 2 per quadrimestre circa, hanno avuto lo scopo di accertare il livello di preparazione, le capacità espositive ed argomentative e la proprietà espressiva. Accanto alle prove orali vi sono state alcune verifiche scritte sotto forma di test, commenti, analisi testuali, in classe e per casa. I criteri di valutazione delle prove scritte e orali sono stati esplicitati e illustrati agli alunni. La valutazione complessiva terrà conto dell’impegno, dell’interesse, della cura nel perseguire gli obiettivi didattici proposti, della volontà di superare le eventuali difficoltà incontrate e, finalmente, del livello di apprendimento raggiunto. .
CONTENUTI
L’apofonia. Il perfetto attivo. Il perfetto medio-passivo. Gli aggettivi verbali. I pronomi. La funzione dei participi. L’aspetto verbale. I modo verbali nelle proposizioni indipendenti. I principali connettivi subordinanti. I poemi omerici tra storia e leggenda. Oralità e scrittura. Lo statuto dell'aedo. La questione omerica. La trasmissione dei testi antichi: geografia e storia della tradizione. La filologia moderna. Iliade: il proemio e la struttura del poema; il mondo degli dei e il mondo degli uomini; lo statuto dell’eroe omerico; la società omerica e le incongruenze con le conoscenze storiche dell’età micenea; le caratteristiche formali del poema (formularità, similitudini, ritmo narrativo). La lingua omerica. Lettura in italiano e commento dei passi antologici. Odissea: il proemio e la struttura del poema; l’eroizzazione di Odisseo e gli elementi folklorici; il ruolo degli dei; l’antropologia reale e fantastica del poema. Lettura in italiano e commento dei passi antologici. Esiodo e la poesia epico-didascalica. Lettura in italiano dei passi antologici dalla Teogonia e dalle Opere e giorni. I poemi ciclici. Gli inni omerici. Poesia burlesca e realistica. La poesia lirica: caratteristiche formali e tematiche. La lirica ionico-attica: Archiloco, Mimnermo, Solone, Ipponatte, Teognide e Anacreonte. Lettura dei frammenti antologici in italiano e confronto con il testo greco, quando presente. La lirica a Sparta: Tirteo e Alcmane. Lettura dei frammenti antologici in italiano. Traduzione integrale di Lisia, Per l’uccisione di Eratostene Traduzione da Omero, Iliade, 6, 119 - 236 (come le foglie…). Lettura in italiano da Esiodo, Opere e giorni, 132- 201 (il mito delle cinque età). Mimnermo, fr. 2 West (Noi, come le foglie…). Traduzione da Platone, Protagora 320c-322d (il mito di Prometeo e l’umanità primitiva).
RELAZIONE FINALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DISCIPLINARE DI STORIA E FILOSOFIA Docente: prof.ssa Daniela Floriduz 1) Situazione della classe Gli alunni hanno mantenuto, durante l'anno, un atteggiamento generalmente corretto e rispettoso dal punto di vista disciplinare e attentivo e hanno manifestato interesse e motivazione verso le tematiche filosofiche e i contenuti storici trattati durante l’anno. Gli studenti hanno tendenzialmente rispettato con puntualità le consegne ed i tempi della verifica. Sono stati notevolmente consolidati l’autonomia del metodo e l'organizzazione dei tempi di studio, anche se il lavoro domestico, in alcuni casi, è stato finalizzato esclusivamente alla verifica e non ha beneficiato di quella continuità e costanza di impegno che sarebbero necessarie per corroborare e consolidare la rielaborazione critica dei contenuti. In classe, gli alunni hanno saputo adeguatamente valorizzare i momenti dedicati al ripasso e all’approfondimento. Sono stati particolarmente apprezzati gli spazi riservati al dibattito e all’attualizzazione dei contenuti. 2) Competenze e obiettivi consolidati Gli studenti hanno acquisito una buona padronanza e comprensione dei contenuti fondamentali delle discipline di storia e filosofia, nonché gli strumenti per l'analisi del testo filosofico e dei documenti storici e storiografici. La padronanza del lessico di base di entrambe le discipline appare appropriata. In filosofia, gli studenti hanno iniziato a problematizzare ilpensiero degli autori, comprendendo le domande di fondo da cui esso deriva e a cui tenta di rispondere. Per quanto riguarda la storia, la classe ha imparato ad evidenziare ed analizzare i fattori di ordine economico, sociale, istituzionale e culturale che concorrono a descrivere ciascun periodo preso in considerazione. Particolare attenzione è stata riservata alla storia locale, attraverso uno specifico modulo dedicato alla cultura, l’arte e la storia di Pordenone nel XVI secolo. Sia per quanto riguarda storia che filosofia, la classe dovrà lavorare sulle abilità di argomentazione e rielaborazione critica, anche al fine di consolidare un’ottica interdisciplinare attraverso cui costruire globalmente il sapere e con l’obiettivo di confrontare criticamente modelli diversi di pensiero e rintracciare, nell’ambito dello sviluppo storico, le conseguenze di lungo periodo dei fenomeni analizzati. Per fare questo, sarà necessario evitare uno studio settoriale e rapsodico. Alcuni alunni dovranno imparare a contenere il livello d’ansia durante le verifiche, incrementando gli interventi e la partecipazione nel corso della fase di apprendimento e consolidamento dei contenuti.
3) Contenuti della programmazione curricolare Rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro, la programmazione curricolare di storia è stata rispettata, mentre la trattazione dei contenuti filosofici si è fermata al pensiero di Aristotele, dal momento che la fase iniziale di acquisizione di problemi, termini e concetti di base della filosofia ha richiesto più tempo del previsto. 4) Metodi didattici adottati E' stato privilegiato un metodo costruttivista, consistente nel coinvolgimento della classe durante la fase di acquisizione e apprendimento dei contenuti. Per storia, sono stati proposti alla classe degli schemi riassuntivi, proiettati attraverso il computer durante la spiegazione. In vista della verifica, in entrambe le discipline sono state effettuate attività di ripasso e approfondimento. 5) Indicazioni sulle verifiche Per quanto riguarda filosofia, sono state svolte tre interrogazioni orali e quattro prove scritte. In queste ultime, sono stati proposti questionari a risposte aperte, domande di analisi del testo, richiesta di costruzione di mappe concettuali, di definizioni sintetiche dei termini di base, l’ipotesi di costruzione di dialoghi filosofici al fine di applicare differenti strategie argomentative. In storia sono state effettuate quattro verifiche orali e tre questionari scritti, con domande a risposta aperta, richieste di definizioni, costruzione di mappe concettuali, argomentazione di interpretazioni storiografiche. In alcuni casi, sono stati svolti interventi di potenziamento e recupero in itinere. Anche i lavori domestici sono stati oggetto di valutazione. Pordenone, giugno 2013
INGLESE
La classe si è dimostrata partecipe e motivata rispetto a tutte le attività didattiche proposte. L’atteggiamento di sostanziale, anche se inizialmente dispersiva collaborazione, ha permesso di consolidare le conoscenze pregresse sul piano morfo-sintattico e di accostare l’ambito letterario senza particolari difficoltà. La vivacità degli studenti, unita ad una genuina curiosità, non ha impedito la ripresa ed il ripasso di alcune strutture morfo-sintattiche. Il livello di competenze raggiunto si attesta su livelli accettabili sia sul piano orale che scritto. Le varie modalità di approccio ai testi letterari, alle attività video o a quelle eminentemente linguistiche hanno consentito a tutti gli studenti di praticare le abilità di base spesso integrandole tra di loro- Per il periodo estivo si consiglia la lettura di un ‘graded reader’ tra quelli consigliati a fine anno scolastico ed il ripasso di strutture grammaticali e di arricchimento del lessico o nel testo acquistato ad inizio anno oppure avvalendosi degli esercizi proposti da siti quali: BBC, elllo, breakingnews, british council PROGRAMMA SVOLTO: Si fà riferimento ai testi in adozione così come indicati nel Piano di Lavoro di Classe. Nel testo in adozione e dal CD-ROM ad esso connesso sono stati affrontati i seguenti testi: FICTION: - Caline (by K. Chopin); - Eveline (by Joyce); - Paddy Clarke, ha, ha, ha (by R. Doyle); - The catcher in the rye’ (by Salinger); POETRY: - Love is, Galactic love poem (by Henri); - sonnets XVIII and CXXX (by Shakespeare); - The Canterbury Tales (by Chaucer): - lines from the General Prologue; - the wife of Bath; - the prioress; - the knight’s tale; - the merchant: - the friar.
DRAMA: - 2 passages from ‘The importance of being earnest’ (by Wilde); - alcuni passi da ‘An ideal husband’ di Wilde ( in connessione con il film recante lo stesso titolo, di cui si sono viste alcune sequenze in connessione al progetto ‘Adotta uno spettacolo’); HISTORY: - from the origins to the Renaissance (CD-ROM): Nel testo ‘Performer’ sono state svolte le prime 6 unità- Articoli letti: - Spelling: does it matter any more? (from Current, Sept. Oct. 2012);
Partecipazione ad un incontro sulle ballate medievali con prof. Dall’Armellina e conseguenti lavori di creazione di alcune ‘ballate di classe’, composte e musicate dagli studenti stessi. Pordenone, 8 giugno 2013. Prof. T. Del Bianco
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO MATEMATICA e FISICA
CLASSE 1^Ec A.S. 2012/2013
La classe ha risentito molto del passaggio dal biennio al triennio e questo ha avuto una ripercussione sul rendimento nelle mie discipline. Gli allievi si sono trovati molto spesso in difficoltà nella gestione autonoma dello studio, di frequente i compiti assegnati per casa non venivano svolti da un buon numero di allievi sia per mancanza di buona volontà, sia perché non erano in grado di gestire le loro difficoltà. Invece di provare a ragionare su quanto spiegato e seguire gli esempi svolti si arrendevano facilmente. Nell’impostazione del programma di Geometria Analitica consapevole delle difficoltà che presenta la risoluzione dei problemi, ho cercato di guidare gli allievi nelle singole fasi del processo di apprendimento, con particolare attenzione all’acquisizione di un adeguato metodo di studio che li rendesse in grado di operare autonomamente. Per affrontare i problemi di geometria analitica è necessario un lavoro costante sia nella memorizzazione delle varie regole che nell’applicazione.
Tenendo anche conto del quadro orario, ho cercato di lavorare molto durante le ore di lezione coinvolgendo il più possibile gli allievi in modo da rendere più leggero il lavoro per casa.Purtroppo, ad un lavoro in classe orientato a stimolare sia gli allievi più capaci che a seguire gli allievi più deboli, non è corrisposto un lavoro personale altrettanto interessato, dimostrando anzi poco apprezzamento per la disponibilità dell’insegnante.
Costantemente mi sono soffermata su quanto già spiegato preparando loro delle schede guidate e svolgendo molti esercizi in classe.Il programma di Geometria ha creato a qualcuno, non poche difficoltà in quanto veniva richiesto non solo l’applicazione delle regole , la correttezza nei calcoli e il procedimento logico seguito nella risoluzione del problema, ma soprattutto la rappresentazione grafica che doveva essere coerente con quanto calcolato.
Tutto questo ha richiesto un metodo di studio che puntasse soprattutto sul ragionamento logico e non solo sul calcolo algebrico e naturalmente su un impegno costante.
I problemi di geometria non si possono affrontare con uno studio affrettato dell’ultimo minuto. Prima d’ogni verifica,consapevole delle difficoltà da parte degli allievi nel gestire autonomamente il ripasso degli argomenti, venivano affrontati in classe quesiti ed esercizi in parte simili a quelli inseriti poi nelle richieste.Gli allievi in difficoltà ,in ogni modo sono stati in grado di riprendersi in
quest’ultimo periodo riuscendo a colmare le difficoltà incontrate. Le ultime verifiche hanno messo in evidenza come uno studio attento e puntuale dà i suoi frutti e che le capacità da sole non bastano.Comunque il lavoro in questa classe è stato reso faticoso, dalla poca disponibilità a seguire le indicazioni dell’insegnante in modo rigoroso, anche se alla fine sono riusciti a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissata.
Nella classe è da evidenziare la presenza d’allievi che si sono distinti per capacità, serietà e voglia di approfondire, che hanno raggiunto buoni e ottimi risultati .
Per quanto riguarda Fisica la classe ha mostrato un certo interesse. Anche le persone meno inclini alle discipline scientifiche si sono date da fare dimostrando in diverse situazioni capacità di formulare ipotesi e dedurre conseguenze .
Purtroppo questo interesse non sempre è stato seguito da uno studio sistematico volto a rielaborare gli argomenti trattati, soprattutto da parte di alcuni allievi, mentre un buon gruppo ha saputo approfondire e quindi applicare le varie leggi nella risoluzione di problemi. Gli obiettivi proposti si possono ritenere mediamente raggiunti seppure con le dovute diversificazioni. Per MatematicaAlla fine dell’anno gli allievi sono in grado di :
risolvere equazioni e disequazioni di 2^ grado(intere e frazionarie) risolvere un sistema di 1^ e 2^ grado sia algebricamente che graficamente risolvere Problemi con le coniche studiate
Per Fisica :1. conoscono le principali grandezze fisiche studiate e le loro unità di misura2. conoscono le leggi del moto (rettilineo uniforme,uniformemente accelerato,circolare uniforme , armonico)3. sanno operare con i vettori4. conoscono i principi della dinamica e li sanno applicare
PROGRAMMA DI MATEMATICA
DIVISIBILITA’ e SCOMPOSIZIONIdivisione di due polinomidivisione con resto la regola di Ruffini teorema del Resto scomposizione di un polinomio in fattori primi :
mediante raccoglimento a fattor comune e parzialemediante i prodotti notevolimediante la regola di Ruffini
scomposizione della differenza di due quadrati ,della somma e differenza di due cubiscomposizione del trinomio particolare
RELAZIONI E FUNZIONIDefinizione di relazione e funzione tra due insiemi.Dominio e codominio di una funzione.EQUAZIONI DI SECONDO GRADOequazione di 2° grado completa e incompletaformula risolutiva, formula ridottaequazioni di grado superiore al secondoequazione biquadraticaequazioni parametricherelazioni tra le radici e i coefficienti di una equazioneequazioni frazionarieDISEQUAZIONI DI II° GRADO il grafico della funzione f(x)=ax2+bx+cdisequazioni di secondo gradorisoluzione grafica con l’uso della paraboladisequazioni frazionariesistemi di disequazioni
GEOMETRIA ANALITICAPunto medio di un segmento. Distanza fra due punti. La retta nel piano cartesiano. Rette parallele e perpendicolari. Distanza punto retta.Problemi vari con la retta. Luoghi geometrici: asse di un segmento, bisettrice di un angolo LA CIRCONFERENZA La circonferenza come luogo geometrico. Posizione reciproca tra circonferenza e retta. Circonferenza per tre punti. Risoluzione di sistemi di tre equazioni in tre incognite:metodo di sostituzione, riduzione e confronto. Condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza. Tangenti ad una circonferenza. Applicazioni varie.
LA PARABOLA La parabola come luogo geometrico. Parabola con asse parallelo all'asse Y. Parabole in posizioni particolari. Posizione reciproca tra retta e parabola .Parabola per tre punti. Condizioni per determinare l'equazione di una parabola. Tangenti alla parabola. Problemi vari.
PROGRAMMA DI FISICA
IL PROBLEMA DELLA MISURAMetodo sperimentale. Grandezze fisiche e loro misura. Equivalenze.Ordine di grandezza. Misura ed errori. Errori assoluti e relativi. Relazioni tra grandezze: proporzionalità diretta, inversa, quadratica. Costruzione di tabelle e grafici.LAB Individuazione di leggi matematichedeformazioni elastichemoto pendolareLA VELOCITAPunto materiale in movimento. Sistemi di riferimento. Moto rettilineo.Velocità media. Grafico spazio-tempo. Moto rettilineo uniforme.L’ACCELERAZIONEMoto vario su una retta. Velocità istantanea. Accelerazione media. Grafico velocità-tempo. Moto uniformemente accelerato. Accelerazione istantanea.I VETTORIDefinizione di vettore. Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Operazioni con i vettori. Scomposizione di un vettore .I MOTI NEL PIANOVettore posizione e vettore spostamento. Vettore velocità. Vettore accelerazione. Moto circolare uniforme. Moto armonico.LE FORZE Le forze come grandezze vettoriali. Tipi di forze. Forza peso. Forza elastica. Forze di attrito. LAB Le forze sono vettoriEQUILIBRIO DEI CORPI E DEI FLUIDIL’equilibrio di un punto materiale. L’equilibrio su un piano inclinato. Equilibrio di un corpo rigido. I PRINCIPI DELLA DINAMICAPrimo principio della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. L’effetto delle forze. Secondo e terzo principio della dinamica. Che cosa è la massa.LE FORZE E IL MOVIMENTOCaduta libera. La forza-peso e la massa. La discesa lungo un piano inclinato moto. L’ENERGIA MECCANICAIl lavoro di una forza. La potenza. Energia cinetica. Energia potenziale gravitazionale. Energia potenziale elastica. La conservazione dell’energiaMeccanica. La conservazione dell’energia totale L’insegnante Rosa Ferraro Fano
SCIENZE (Chimica, biologia, scienze della terra)
Prof.ssa D. Messina
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Il lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico è stato molto intenso e impegnativo vista la quantità di argomenti che sono stati trattati in particolare di chimica ma anche di scienze della terra e biologia.
Si conferma quanto già detto nel piano di lavoro elaborato a inizio anno in merito alle difficoltà incontrate dai ragazzi nell’affrontare la mole di studio. Tuttora molti mancano della capacità di approfondire gli argomenti in modo autonomo e non hanno imparato a gestire efficacemente il lavoro domestico.
Tuttavia nel corso del secondo quadrimestre si sono riscontrati significativi e progressivi miglioramenti a livello generale.
Gli allievi sono in ogni caso sempre interessati e partecipativi alle lezioni. Non vi sono casi particolarmente difficili a livello di profitto.
Il rapporto docente-allievi si conferma buono sebbene durante l’anno sia stato necessario a volte discutere sui comportamenti della classe o di parte di essa in quanto non sempre consoni all’ambiente scolastico.
PROGRAMMA SVOLTO E OBIETTIVI
Competenze Abilità/capacità Conoscenze
Risolvere problemi
Utilizzare le principali regole di nomenclatura e scrivere le reazioni chimiche Determinare la quantità chimica in un campione di sostanza ed usare la costante di Avogadro
Nomenclatura chimica e reazioni di sintesi dei composti Moli e stechiometria, reagente limitante e in eccesso
2
Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni Classificare, formulare ipotesi,trarre conclusioni Reperire informazioni da varie fonti e utilizzarle in modo autonomo e coerente Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale Riconoscere il nesso tra struttura e funzione nell'uomo
Descrivere la struttura atomica e spiegare la distribuzione degli elettroni nei livelli energetici Spiegare la formazione delle molecole e dei composti ionici e le interazioni molecolari Comprendere il comportamento dei gas al variare di pressione, temperatura e volume Descrivere la struttura di rocce e minerali Spiegare le relazioni tra fenotipi e genotipi e comprendere i meccanismi che determinano le malattie ereditarie Descrivere il corpo umano, analizzando le interconnessioni tra struttura e funzione
Cenni sui modelli atomici e struttura atomica (modello atomico a strati, configurazione elettronica, modello a orbitali) Legami chimici (ionico, covalente, metallico), geometria molecolare, forze intermolecolari Stato gassoso (caratteristiche e leggi); Stato solido: minerali, rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche, ciclo litogenetico Genetica: leggi di Mendel e malattie ereditarie, evoluzione umana e genetica Tessuti, organi e apparati Anatomia e fisiologia del corpo umano: apparato respiratorio, cardiocircolatorio
ATTIVITA’ PRATICHE, VIDEO E VISITE GUIDATE
Uso di modelli molecolari
Analisi e costruzione di alberi genealogici
Osservazione di campioni di minerali e rocce
Visita alla mostra Homo sapiens di Trento
DVD: I misteri del corpo umano; La riproduzione (Viaggio nella scienza – Piero Angela)
3
MODALITA’ E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
Le metodologie usate dall’insegnante per favorire l’apprendimento sono state:
Lezioni frontali e lezioni dialogate
Lezioni in power point
Attività pratiche
Proposte di esercizi, grafici, problemi eseguiti anche a gruppi Gli strumenti utilizzati per applicare le metodologie indicate sono costituiti da libri di testo e non, mezzi informatici, materiale vario di laboratorio, fotocopie. ATTIVITA’ DI RECUPERO O DI APPROFONDIMENTO
L’attività di recupero per studenti in difficoltà è stata effettuata sia in itinere che attraverso uno sportello didattico tenuto dalla docente stessa (da gennaio a maggio). Agli studenti particolarmente motivati sono stati proposti problemi ed esercizi di chimica di livello più elevato. MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono state sia di tipo formativo che sommativo. Quelle formative sono state effettuate nel corso di ogni lezione e sono consistite in quesiti e esercizi proposti agli allievi. Con cadenza grossomodo mensile sono state somministrate verifiche sommative costituite da esercizi, problemi e prove strutturate (completamento, vero/falso ecc) e quesiti a risposta singola. Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto non solo dei risultati ottenuti nelle varie tipologie di verifica, ma anche dell’atteggiamento globale e dell’impegno dimostrato nonché del percorso di apprendimento di ciascuno. Pordenone 30/05/13 La docente Daniela Messina
STORIA DELL’ARTE – a.s. 2012-2013
Verifica PIANO DI LAVORO: 1^E LICEO CLASSICO
Il maggior numero di ore previsto dal nuovo ordinamento scolastico ha
consentito a docente e studenti un ritmo di lavoro più adeguato ed un
approfondimento di tecniche, temi e metodi. Sono state svolte 54 ore di
attività in classe su 66 previste.
La classe attenta, vivace, emotivamente partecipe risulta formata da elementi
assai diversi ma fortemente coinvolti per interessi e motivazione, il livello è
generalmente molto buono. Il gruppo ha seguito le attività e costruito il
bagaglio di conoscenze utili per il lavoro dei prossimi anni.
L’attività didattica si è svolta con regolarità, e con le metodologie indicate in
programmazione. L’articolazione delle lezioni, riferita al programma
Ministeriale sintetizzato nel POF, ha previsto la seguente scansione:
La lettura del testo visivo (settembre)
Preistoria, storia, archeologia e tecniche, civiltà fluviali e preelleniche (ottobre-novembre)
La civiltà greca (novembre, dicembre-gennaio)
L’elaborazione romana (febbraio-marzo-aprile)
Il Romanico (maggio)
Il linguaggio gotico (maggio)
Cultura e pittura alle origini del Rinascimento (giugno)
Laboratorio in aula informatica sui PRINCIPALI MUSEI ARCHEOLOGICI (ricerca online, cooperative learning, sintesi e produzione di power point).
Attività di approfondimento con visita alla Biblioteca e Archivio del Seminario di Pordenone in relazione al progetto FAI (15.11.2012).
Visita a TRENTO mostra HOMO SAPIENS e visita alla città con ‘Caccia al tesoro’ (8-01-2013).
Visita a Ravenna (09.04.2013) e mostra ‘Borderline’.
Visita a Spilimbergo (18.04.2013) e mostra ‘Aria’
Visita a Pordenone mostra ‘PIZZINATO’ (05.06.2013)
Predisposizione di testi e materiali riassuntivi delle attività svolte e delle uscite didattiche poi pubblicate sul sito della scuola.
Le verifiche e la valutazione hanno seguito i parametri indicati nel Piano di Lavoro iniziale. Prof.ssa C. Manganaro
RELAZIONE FINALE IRC A.S. 2012-13
Insegnamento Religione Cattolica
Prof.ssa Claudia Beacco
Della classe IEc sono stati 14 gli avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica, di cui 6 maschi e 8 femmine. La classe ha dimostrato interesse nei confronti della disciplina, applicandosi con costanza a tutte le iniziative che sono state proposte, e ha ottenuto complessivamente risultati buoni. L’attività didattica è stata svolta con lezioni frontali, discussioni in classe, lavori di gruppo, utilizzo di strumenti multimediali. Nella valutazione si è tenuto conto degli apprendimenti e delle competenze acquisiti, dell’interesse e della partecipazione degli studenti alle attività proposte, ai lavori di gruppo ed alle ricerche assegnate. Con la classe è stata effettuata la visita guidata alla mostra “I colori del sacro” e al Duomo di Spilimbergo. CONTENUTI SVOLTI
Sincretismo e indifferenza religiosa. I nuovi movimenti religiosi.
L'approccio dei nuovi movimenti religiosi in funzione dei bisogni dell'uomo.
Storie d'amore nella Bibbia.
Adamo ed Eva; Giacobbe e Rachele; Sansone e Dalila.
Tobia e Sara, ovvero il dominio dell'eros.
Gli elementi antropologici nascosti nelle storie d'amore della Bibbia analizzate.
Visione e analisi del film "Ogni cosa è illuminata", sul valore della memoria e della riconciliazione.
I vizi e le virtù, tra religione, arte e letteratura.
Le dimissioni di Benedetto XVI.
La Conversione come vocazione alla verità.
Da Gesù alla Chiesa, dalla Chiesa alle chiese.
Le divisioni nel cristianesimo e il cammino ecumenico per il riavvicinamento.
Realizzazione laboratoriale di un'informativa sulle realtà cristiane del territorio.
La santità: realizzare il “bello” che siamo, al meglio, per il “bene”.
Le figure di alcuni Santi di epoche e culture diverse.
Pordenone, 1 Giugno 2013