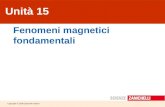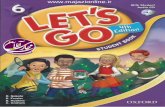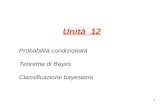Unità_31
Transcript of Unità_31

Un corso pratico di partimento
Giorgio Sanguinetti
Università di Roma - Tor Vergata
A.A. 2006/7
Unità 3: Cadenze
Definizione
Nella teoria del partimento il termine “cadenza” ha un duplice significato. Da
una parte, indica una formula grammaticale di cesura, che ha la funzione di
chiudere, più o meno stabilmente e definitivamente, il discorso musicale.
Questa accezione del termine è quella standard, ed è quella impiegata oggi
normalmente nella teoria della musica (sebbene la nomenclatura non coincida
con quella attuale). Nell’altra accezione, caratteristica della teoria napoletana
(non solo del partimento, ma anche del contrappunto) il termine cadenza indica
la minima struttura tonale possibile dotata di significato compiuto, composta
da una tonica di apertura, una dominante centrale, e una tonica di chiusura,
così come il relativo movimento del basso ① ⑤ ① 1. La definizione di Fenaroli si
riferisce appunto a quest'ultima accezione: «Le cadenze sono quel movimento
del basso, che dalla prima del tono va alla quinta, e dalla quinta ritorna alla
prima»2
La classificazione delle cadenze nella teoria napoletana non corrisponde a
quella in uso oggi nella terminologia standard internazionale. Delle tre cadenze
autentiche (I – V – I): semplice, doppia e composta, le ultime due vanno
pensate come successive elaborazioni della prima; la differenza più che nel
grado di chiusura risiede nella durata e nella posizione metrica.3
1 In questa seconda accezione, la cadenza ha lo stesso significato dalla
struttura elementare tonale della teoria schenkeriana, chiamata Ursatz. 2 Fedele Fenaroli, Regole musicali, §16. 3 La nomenclatura della cadenze è contraddittoria perfino all'interno della
tradizione napoletana. Per esempio, Fenaroli chiama "cadenza doppia" quella

Cadenze semplici
Le cadenze semplici utilizzano solo consonanze: quindi triadi, oppure triadi con
la "passata della settima" sul V.4 La terza su V è anche la sensibile: quindi deve
essere maggiore anche nel modo minore. La risoluzione della sensibile avviene
obbligatoriamente salendo di grado sull’ottava di ①; quando però la sensibile si
trova in una voce interna è ammesso che salti sulla quinta di I. La motivazione
di questa eccezione risiede nella condotta della voce superiore: quando questa
scende su 1, per esempio con una linea discendente ^3 ^2 ^1 , la
risoluzione normale della sensibile impedirebbe di avere la triade completa
sulla tonica di chiusura.
La "passata della settima minore"
La settima minore aggiunta alla triade di dominante è considerata una nota di
passaggio. L'accordo di settima può essere dato completo, oppure si può
sopprimere la quinta e raddoppiare il basso: la scelta dipende dalle posizioni e
dal movimento che si intende dare alla cadenza. Decisivo è comunque l'obbligo
della risoluzione discendente. Se si intende iniziare e terminare in seconda
posizione la voce superiore descriverà una figura di volta; se si scende sulla
prima posizione la settima sarà in posizione inferiore.
Posizioni
Le cadenze vanno esercitate in tutte le tre posizione: tuttavia non è
obbligatorio mantenere la posizione di apertura per tutta la cadenza. Al
contrario, una posizione più bassa della tonica di chiusura assicura una
conclusione più efficace. L’effetto di chiusura varia infatti a seconda della
posizione della tonica conclusiva: una tonica di chiusura in terza posizione (con
la quinta al soprano) è debolissima, anche perchè la voce superiore è statica
per tutta la cadenza; in seconda posizione l’effetto di chiusura esiste ma è
relativo; in prima posizione l’effetto di chiusura è il più forte. L'esempio 3.1
che per la maggioranza degli autori è la cadenza composta, e viceversa. 4 La teoria del partimento non considera dissonante la settima di passaggio
(vedi Unità 5).

mostra queste possibilità: a), b) e c) sono cadenze che iniziano e terminano
nella stessa posizione; d) inizia dalla seconda e termina sulla prima
(corrisponde alla cadenza autentica perfetta); e) scende dalla terza alla
seconda con la "passata della settima minore" (corrisponde alla cadenza
autentica imperfetta). In tutti i tre tipi di cadenza autentica (semplice, doppia,
composta) la quinta sulla tonica resta stazionaria per tutta la durata della
cadenza: se non in casi eccezionali, è dunque opportuno evitare la terza
posizione per le cadenze.
Da quanto detto ne consegue che nessuna cadenza con effetto di chiusura può
avere un andamento ascendente: in altre parole, la tonica di chiusura deve
trovarsi in una posizione uguale o inferiore a quella di apertura.
Cadenze doppie
La cadenza doppia utilizza un ritardo 4-3 sul V grado. Ciò significa che l’ottava
sul basso della tonica di apertura viene tenuta per un movimento sul basso
della dominante, diventando così una quarta; essendo un intervallo dissonante,
la quarta è costretta a risolvere scendendo di grado sulla terza di V, cioè sulla
sensibile, per poi risolvere come per la cadenza semplice. E' essenziale che le
altre voci dell'accordo di dominante, quelle che non hanno il ritardo, non
contengano la terza: il ritardo sarà dunque accompagnamento solo dall'ottava

e dalla quinta del basso (per una trattazione più completa sui ritardi vedi Unità
5). L'accordo risultante può essere cifrato 4-3 oppure 5/4-3
La presenza del ritardo comporta una differenza importante rispetto alla
cadenza semplice: il V grado della cadenza doppia richiede almeno due
movimenti, di cui il primo deve trovarsi sul tempo forte (cioè “in battere”).5
L'esempio 3.2 mostra la cadenza doppia nelle tre posizioni: in a) la tonica di
chiusura rimane nella stessa posizione di quella di apertura, mentre gli esempi
b) e c) scendono di posizione.
Cadenza doppia con doppio ritardo.
Una variante molto frequente della cadenza doppia presenta un doppio ritardo:
la voce che esegue il ritardo 4-3 viene accompagnato da una seconda voce che
esegue un ritardo 6-5 (esempio 3.2 d, e). L'accordo risultante è detto "quarta e
sesta di cadenza": quest'accordo ha una origine interamente contrappuntistica,
essendo il risultato di un movimento melodico, e non ha nulla a che vedere con
il secondo rivolto della triade di tonica, col quale viene spesso confuso.
Cadenze composte
La cadenza composta è la più elaborata delle cadenze autentiche. La
dominante richiede quattro movimenti: sul primo troviamo la triade di
dominante, sul secondo la terza e la quinta salgono rispettivamente sulla
5 Una caratteristica essenziale dei ritardi è che la dissonanza si trova sempre
sui tempi accentati.

quarta e la sesta; sul terzo movimento la sesta scende sulla quinta mentre la
quarta resta legata e produce l'accordo di 5/4; sul quarto movimento infine la
quarta risolve sulla terza (gli ultimi due movimenti sono identici alla cadenza
doppia). Si osservi la differenza tra l'accordo di quarta e sesta sul secondo
movimento e l'accordo di quarta e sesta di cadenza che troviamo nella variante
della cadenza doppia: quest'ultimo è prodotto da un doppio ritardo, mentre
nella cadenza composta da un doppio movimento di volta (^5 - ^6 - ^5 o ^3
- ^4 - ^3).
Cadenza di Durante
Si tratta di un'estensione della cadenza autentica in cui la tonica di apertura è
preceduta da un grado che prepara la dominante (in questo caso, il IV); si crea
così un'elementare successione cadenzale (devi § 3.6). Durante chiama questa
cadenza “cadenza semplice con la passata di 4a maggiore e 6a”. Questa
cadenza è composta da un nucleo che consiste in una cadenza doppia (con
ritardo 4-3), preceduto dal IV grado (con ④ che salta su ① ) collegato alla
triade di tonica tramite un accordo di 2/#4/6 con funzione di passaggio. Si noti
il comportamento anomalo dell’accordo di seconda che risolve di salto su una
triade e non per grado congiunto su un accordo di terza e sesta: questo si deve
al fatto che, mentre nella risoluzione normale il basso costituisce la nota di
passaggio, qui è l’intero accordo ad essere di passaggio. Questa cadenza si
pratica solo partendo in seconda posizione (con la terza al soprano): nelle altre
posizioni il movimento della voce superiore è insoddisfacente. Nel modo minore
si crea un intervallo di seconda aumentata nella voce superiore tra i primi due

accordi: quest'intervallo era normalmente evitato, ma a volte era utilizzato per
ragioni espressive.
Progressioni cadenzali
I tipi di cadenze che abbiamo studiato finora possono considerarsi come
l'ampliamento di una struttura elementare basata sulla successione I - V - I,
cioè tonica di apertura, dominante, e tonica di chiusura. In tutti gli ampliamenti
successivi alla cadenza semplice (cadenza doppia, composta, cadenza "di
Durante") tuttavia, il nucleo della cadenza è rimasto inalterato nella sua
successione I - V - I. Nelle progressioni cadenzali avviene qualcosa di nuovo:
uno o più gradi armonici s'inseriscono all'interno della struttura di base della
cadenza, separando la tonica di apertura dalla dominante: il risultato non è più
una semplice cadenza, ma una successione armonica più complessa che
prende il nome di progressione cadenzale. Il termine "progressione" non ha
nulla a che vedere con quel tipo di movimento regolare del basso che
chiameremo, più correttamente, "sequenza" (vedi unità 7); piuttosto indica una
successione accordale dotata di una forte direzionalità che cammina (cioè
"progredisce") in direzione della cadenza conclusiva.In questo paragrafo
studieremo alcune delle progressioni cadenzali più comuni, procedendo dalla
più semplice alla più complessa: si noti che le nuove note nel basso si vanno
sempre ad inserire tra la tonica di apertura e la dominante, "riempiendo"
progressivamente questo spazio.
a) con II5/6
① ④ ⑤ ①

Tra la tonica di apertura e la dominante si è inserita una nuova nota del basso:
④, che regge un accordo di quinta e sesta (in termini armonici, la successione è
I - II6/5 - V - I). La funzione di questa nota del basso (che rappresenta il II
grado armonico) è duplice: da una parte, permette di arrivare sulla dominante
in maniera più graduale; dall'altra, riempie lo spazio tra la tonica di apertura e
la dominante. A differenza dello spazio tra la dominante e la tonica di chiusura,
che è vincolato dalla necessità di preservare il salto cadenzale, lo spazio tra la
tonica di apertura e la dominante è aperto a una enorme varietà di possibili
riempimenti ed espansioni, di cui quella qui presentate costituisce il primo e
più elementare modello.
b) lo stesso, con l'alterazione del quarto grado del basso
① ④ #④ ⑤ ①
Un'ulteriore espansione della struttura cadenzale consiste nell'inserimento di ④
in una duplice versione: diatonica e subito dopo cromatica. L'uso dell'accordo
di quarta aumentata è analogo a quello nella cadenza "di Durante, mentre su
#④ si trova una settima diminuita. Questa cadenza si pratica partendo dalla
terza posizione e concludendo in prima.
c) con inizio sul terzo grado del basso (con I 6/3)

③ ④ ⑤ ①
Armonicamente basata sui gradi I6 - II 6/5 - V - I, questa successione divenne,
nella seconda metà del Settecento, la progressione cadenzale per eccellenza,
tanto che era sufficiente sentirne l'inizio per avere la certezza che la
conclusione di una frase o di una sezione era prossima. Pasquini (nel
frammento di Bologna) dà una regola molto semplice: ogni volta - dice - che nel
basso si trovano tre note ascendenti seguite da un salto di quinta discendente,
o di quarta discendente, bisogna usare questa successione.
d) con movimento di volta iniziale
① ⑦ ① ③④ ⑤ ①
La figura di volta inferiore nel basso costituisce il contrappunto inferiore alle
prime tre note della scala ascendente; ogni volta che lo si incontra va
considerata dunque la possibilità di accompagnarla con ^1 ^2 ^3 nel
soprano. Delle due crome la seconda va considerata di passaggio, e non va
armonizzata. Questa progressione è adatta a un inizio in prima posizione.
e) con riempimento completo dello spazio di quinta
Esempio
① ② ③ ④ ⑤ ①
In questo schema di successione cadenzale entra il secondo grado della scala:
grazie a questa nota, lo spazio tra la tonica di apertura e la dominante è
interamente riempito con note di passaggio. Le prime cinque prime note della
successione corrispondono alle prime cinque della Regola dell'Ottava, di cui
questa cadenza più considerarsi una preparazione. Nella seconda possibile è
opportuino sostituire l'accordo di sesta sulla seconda nota del basso con 3/4/6;
la terza posizione è piuttosto infelice.

“Cadenze finte”
Col nome di cadenza finta la teoria napoletana definiva qualsiasi cadenza in cui
la risoluzione su I fosse evitata o posticipata. Con questo nome dunque
troviamo le normali cadenze d’inganno (V-VI) quanto altri, e talora fantasiosi,
modelli di successioni accordali.
La prima, e più usata, delle "cadenze finte" è divisa in due parti: la prima parte
inizia come una normale successione cadenzale, ma al posto della tonica
conclusiva abbiamo inaspettatamente in VI grado; la seconda parte inizia come
la prima, e questa volta conclude con successo sulla tonica. Questa
successione può dunque essere intesa come un duplice tentativo di arrivare a
una conclusione cadenzale, in cui il primo tentativo fallisce e il secondo ha
successo.
Si osservi che:
1) Perchè la "cadenza finta" sia efficace è essenziale che nella "finta"
conclusione la voce superiore si comporti come se la conclusione fosse "vera":
cioè mimi una CAP (tonica al soprano).
2) le triadi su ⑤ e ⑥ si collegano per moto contrario in prima e terza posizione,
mentre in seconda posizione la voce superiore muove per decime col basso.
3) in terza posizione è raccomandabile collegare con una nota di passaggio il
salto di terza della voce superiore tra ⑤ e ⑥.
ESEMPIO
Cadenza finta
K. 466, I fine del tutti: bb. 72-77

Altra cadenza finta (Valente)
Questa versione della "cadenza finta", nonostante il basso sia identico, è molto
diversa dalla precedente: le cifre che cambiano su ④ ⑤ ⑥ non devono
ingannarci sul fatto che su queste note del basso l'armonia in realtà non
cambia, e che le battute 3-5 non sono che una espansione del II grado
armonico. Si noti il necessario scambio di voci 10-8-6 tra il basso e la voce
interna.
Semicadenze
Le regole del partimento non descrivono esplicitamente le semicadenze;
queste, quando compaiono, sono classificate sotto le terminazioni. Nei

partimenti le semicadenze presentano spesso un movimento del basso
discendente ⑥ ⑤ : il sesto grado nel basso deve avere la durata di due
movimenti che sono occupati da un ritardo 7-6 in una delle voci superiori.
Durante descrive una semicadenza di questo tipo che corrisponde al modello
della cadenza frigia (vedi esempio 2. 5 c).
ESERCIZI
Cadenze semplici
1. Suona sei cadenze semplici in modo maggiore e sei in modo minore, in tutte
le tre posizioni, concludendo sulla posizione di partenza
2. Suona quattro cadenze semplici in modo maggiore e quattro in modo
minore, in seconda e terza posizione, concludendo in prima (dalla seconda) e in
seconda (dalla terza).
Cadenze doppie
3. Suona sei cadenze doppie in modo maggiore e sei in modo minore, in tutte
le tre posizioni, concludendo sulla posizione di partenza
4. Suona quattro cadenze doppie in modo maggiore e quattro in modo minore,
in seconda e terza posizione, concludendo in prima (dalla seconda) e in
seconda (dalla terza).
Cadenze composte
5. Suona sei cadenze composte in modo maggiore e sei in modo minore, in
tutte le tre posizioni, concludendo sulla posizione di partenza
6. Suona quattro cadenze composte in modo maggiore e quattro in modo
minore, in seconda e terza posizione, concludendo in prima (dalla seconda) e in
seconda (dalla terza).
Cadenza di Durante
7. Accompagna le seguenti cadenze:

Progressioni cadenzali
8. accompagna le seguenti successioni cadenzali:
a) b) c) d)
"accadenze" (Cotumacci)
9. Accompagna le seguenti cadenze finte
Partimenti
Paisiello (2) Lezione c. 2.v
Fenaroli n. 1, 2, 3, 6