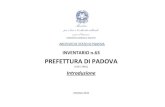UCID Padova - Introduzione anno 2011
-
Upload
ucid-nazionale -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of UCID Padova - Introduzione anno 2011

Introduzione all’argomento del Convegno UCID del 29 ottobre 2011 L'azzardo morale è nato nell’economia anglosassone, e si manifesta con diffusi comportamenti di opportunismo contrattuale, che può portare i contraenti, spesso più forti, a perseguire i propri interessi a spese della controparte, confidando nella impossibilità per quest'ultima di accedere a informazioni, e quindi verificare l’eventuale dolo o omissione. Si è manifestata al massimo con la crisi finanziaria del 2008, prevalentemente con i mutui sub-prime, prestiti stipulati con famiglie e persone che non sarebbero state in grado di sostenerne i costi in relazione all’evoluzione dell’economia e dei tassi di interesse. Questo atteggiamento è talmente diffuso da assumere un aspetto “generale”, in quanto, spesso, gli operatori economici trovano naturale assumere consapevolmente comportamenti eccessivamente rischiosi, contando sul fatto che i costi associati all’eventuale fallimento ricadano sulla collettività o su altre categorie di operatori. Tale, ad esempio, è il fenomeno degli investimenti in derivati realizzati anche da molte pubbliche amministrazioni. Il conflitto di interessi si manifesta quando una persona, politico, pubblico ufficiale, imprenditore, magistrato, detiene responsabilità singole o molteplici che possono entrare in conflitto con i propri interessi personali o professionali e con l'imparzialità richiesta da tali uffici. Anche se il diritto pubblico e civile dettano regole per coloro i quali si trovino in tale condizione, esse spesso non vengono di fatto osservate o fatte osservare, specie quando il conflitto si esplica ai più alti livelli di potere e di rappresentanza: l’esempio negativo di chi ricopre tali cariche, in tal caso, è distruttivo per la società. L’esistenza di un conflitto di interessi potenziale non costituisce di per sé prova che siano state commesse scorrettezze, ma può tuttavia costituire un'agevolazione nel caso in cui si cerchi di influenzare il risultato di una decisione per trarne un beneficio: l’elemento determinante è la condotta morale della persona, che tuttavia non può essere lasciata libera di decidere o meno. Il conflitto esiste sempre, a prescindere dal fatto che la persona segua una condotta impropria o meno. La società italiana – e tutte le società moderne - sono permeate dall’azzardo morale e dal conflitto di interessi ad ogni livello, talchè non vengono più neppure presi in considerazione come comportamenti moralmente riprovevoli. Essi, viceversa, minano il valore stesso della convivenza sociale, in misura tale da limitare la fiducia tra i soggetti, la loro volontà di negoziare “liberamente” e quindi la crescita stessa delle economie. La corruzione è la condotta propria del pubblico ufficiale che riceve, per sé o per altri, denaro od altre utilità che non gli sono dovute. I partecipanti, col tempo, si abituano alla corruzione al punto di considerarla come una consuetudine. Questo sistema tende ad isolare ed estromettere gli «onesti», perché questi, non avendo niente da rischiare da eventuali indagini, potrebbero danneggiare tutti gli altri. La concussione, opposto della corruzione, si verifica quando il pubblico ufficiale sfrutta la propria posizione di potere per costringere o indurre un terzo a corrispondere denaro o altre utilità. In Italia, la “corruzione percepita” da parte dei cittadini si colloca ai livelli più alti tra i paesi sviluppati, quasi uguale a quella di molti paesi del terzo mondo, dall’Africa al Sudamerica. La semplice elencazione di questi fenomeni – di cui si parla molto poco nei dibattiti, e spesso si tacciono – basta da sola ad evidenziare la condizione di disagio in cui la società italiana vive oramai da molti anni. Il punto 411 del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, indica che “Tra le deformazioni del sistema democratico, la corruzione politica è una delle più gravi, perché tradisce al tempo stesso i principi della morale e le norme della giustizia sociale”. Essa compromette il corretto funzionamento dello Stato, influendo negativamente sul rapporto tra governanti e governati; introduce una crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche, causando una progressiva

disaffezione dei cittadini nei confronti della politica e dei suoi rappresentanti, con il conseguente indebolimento delle istituzioni. La corruzione distorce alla radice il ruolo delle istituzioni rappresentative, perché le usa come terreno di scambio politico tra richieste clientelari e prestazioni dei governanti. In tal modo, le scelte politiche favoriscono gli obiettivi ristretti di quanti possiedono i mezzi per influenzarle e impediscono la realizzazione del bene comune di tutti i cittadini. Il punto 412 ricorda che “La pubblica amministrazione, a qualsiasi livello — nazionale, regionale, comunale —, quale strumento dello Stato, ha come finalità quella di servire i cittadini”. Per la Costituzione, sia l’impresa privata che la pubblica amministrazione, sono poste “al servizio dei cittadini”. La corruzione e l'illegalità sono purtroppo presenti sia nel comportamento di soggetti economici e politici dei Paesi ricchi, vecchi e nuovi, sia negli stessi Paesi poveri. A non rispettare i diritti umani dei lavoratori sono a volte grandi imprese transnazionali e anche gruppi di produzione locale (Caritas In Veritate, p.22). L’insieme di questi comportamenti, azzardo morale, conflitto di interessi e corruzione/concussione, come si è detto, viene considerata con indulgenza e spesso con indifferenza, anzi, in qualche caso la reazione morale è “bollata” come veteromoralità e bigottismo, mentre attiene alle fondamente stesse della convivenza civile. Tale situazione appare frutto di un progressivo inselvatichirsi della società, di una scarsa propensione all’educazione e alla moralità. L’aspetto paradossale è che la Dottrina Sociale della Chiesa ci insegna l’opposto, cioè la giustizia innanzitutto, e ci chiede la carità. “Ubi societas, ibi ius” (CIV, p.6): ogni società elabora un proprio sistema di giustizia. La carità eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del “mio” all'altro; ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all'altro ciò che è “suo”, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Non posso «donare» all'altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, non solo non è una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia è «inseparabile dalla carità », intrinseca ad essa. La giustizia è la prima via della carità o, com'ebbe a dire Paolo VI, «la misura minima» di essa, parte integrante di quell'amore «coi fatti e nella verità» (1 Gv 3,18), a cui esorta l'apostolo Giovanni. Da una parte, la carità esige la giustizia: il riconoscimento e il rispetto dei legittimi diritti degli individui e dei popoli. Essa s'adopera per la costruzione della “città dell'uomo” secondo diritto e giustizia. Dall'altra, la carità supera la giustizia e la completa nella logica del dono e del perdono. La Chiesa ritiene da sempre che l'agire economico non sia da considerare antisociale. Il mercato non è, e non deve perciò diventare, di per sé il luogo della sopraffazione del forte sul debole. La società non deve proteggersi dal mercato, come se lo sviluppo di quest'ultimo comportasse ipso facto la morte dei rapporti autenticamente umani. Non va dimenticato che il mercato non esiste allo stato puro. Esso trae forma dalle configurazioni culturali che lo specificano e lo orientano. Infatti, l'economia e la finanza, in quanto strumenti, possono esser mal utilizzati quando chi li gestisce ha solo riferimenti egoistici. Così si può riuscire a trasformare strumenti di per sé buoni in strumenti dannosi. Ma è la ragione oscurata dell'uomo a produrre queste conseguenze, non lo strumento di per sé stesso. Perciò non è lo strumento a dover essere chiamato in causa ma l'uomo, la sua coscienza morale e la sua responsabilità personale e sociale. Rispondere alle esigenze morali più profonde della persona ha anche importanti e benefiche ricadute sul piano economico. L'economia infatti ha bisogno dell'etica per il suo corretto funzionamento; non di un'etica qualsiasi, bensì di un'etica amica della persona. Padova, 15 settembre 2011



![· UCID - Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti ... Per maggiori informazioni su Europass: hW]/europass.cedefop.eu.int - htW](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5c6909d509d3f242168c6809/-ucid-unione-cristiana-imprenditori-e-dirigenti-per-maggiori-informazioni.jpg)