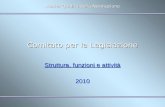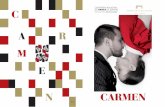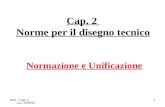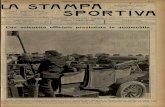U&C CND 27/12/10 17:29 Paa AA LA RIVISTADELLA...
-
Upload
trinhtuyen -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of U&C CND 27/12/10 17:29 Paa AA LA RIVISTADELLA...
LA RIVISTADELLA NORMAZIONE TECNICA
10Novembre/Dicembre 2010
Anno LV
10Novembre/Dicembre 2010
Anno LV
L’Assemblea Generale dell’ISO 2010
A L'Aquila esperti a confronto sul restauro dei beni culturali
Responsabilità sociale: una novità assoluta nel panorama delle norme ISO
L’Assemblea Generale dell’ISO 2010
A L'Aquila esperti a confronto sul restauro dei beni culturali
Responsabilità sociale: una novità assoluta nel panorama delle norme ISO
DOSSIER:GESTIONE RIFIUTI
DOSSIER:GESTIONE RIFIUTI
Poste
Ita
liane-S
pa S
ped.
in a
.p.
D.L
. 353/2
003 (
conv.
in L
.27/0
2/2
004 n
°46)
art
. 1 c
om
ma 1
-DC
B M
ilano -
In c
aso d
i m
ancato
recapito s
i re
stitu
isca a
l C
MP
Roserio p
er
la c
onsegna a
l m
itte
nte
che s
i im
pegna a
pagare
la r
ela
tiva t
assa
U&C_CoverNovDic_progetto 27/12/10 17:29 Pagina AA
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
U&C_CoverNovDic_progetto 27/12/10 17:29 Pagina AB
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
edito
riale
U&C n.10 novembre/dicembre 2010 1
La normazione tecnicaa supporto dell’innovazione edella competitività sostenibileThe technical standards to supportinnovation and sustainablecompetitiveness
in considerazione all'interno del processo.Il riferimento è alle "societal stakeholders"che rappresentano la salute, la sicurezza, iconsumatori e l'ambiente. Esse devono poterpartecipare ai lavori, esprimere le loro posi-zioni e cercare di creare il consenso sulle loroopinioni, ma la decisione dello standard deverestare essenzialmente del settore privato.La Relazione di iniziativa del Parlamento Euro-peo pone l'attenzione sulla "effettiva partecipa-zione" delle societal stakeholders negli organi-smi europei, che è un concetto molto più im-portante rispetto a quello del "voto simbolico",proposto inizialmente da alcuni gruppi politici.Un altro aspetto importante riguarda la parte-cipazione delle PMI.In primo luogo, trattare le societal stakehol-ders e le PMI allo stesso modo non sembravala soluzione migliore, come si prospettava inuna prima stesura della relazione.La recente Relazione Monti, sul futuro delmercato interno europeo, sottolinea conmolta enfasi la necessità di intervenire perrendere il clima imprenditoriale più consonoper le PMI.Afferma anche che "la standardizzazione è lachiave di volta della governance del mercatounico", esortando a riesaminare il processo distandardizzazione a livello europeo, conser-vando i vantaggi del sistema attuale e trovan-do al tempo stesso il giusto equilibrio tra di-mensione europea e dimensione nazionale.Le PMI, sebbene siano parte del settore pri-vato e non rappresentino un interesse pubbli-co, sono parte essenziale del mercato euro-
I tre principi, quello della delegazione nazio-nale, della natura privata e volontaria del si-stema devono restare alla base del sistemadi standardizzazione, come lo sviluppo di unnuovo standard dovrebbe avere luogo solo difronte a un reale beneficio che possa esseredimostrato.In particolare, il principio della delegazionenazionale assicura il buon funzionamento delsistema, consentendo l’accesso e la parteci-pazione a livello nazionale a tutti gli stakehol-ders interessati. É quindi un pilastro importan-te del sistema non solo perché consente lapartecipazione di esperti nazionali, ma ancheperché assicura l’armonizzazione tecnica inEuropa, attraverso l’adozione a livello internodegli standard europei e, di conseguenza, l’e-liminazione degli standard nazionali non in li-nea con quelli europei.Ciò avviene in 31 paesi membri (più 19 mem-bri affiliati) ed è quindi indiscutibile l’apportoalla creazione di un mercato unico più con-solidato.Lo stesso apprezzamento è rivolto anche alcarattere volontario e privato del sistema.Gli standard sono individuati con il fine di ri-spondere alle esigenze delle compagnie pri-vate interessate che supportano il 95% delcosto dell’intero sistema (mentre il restante5% è coperto da fondi pubblici di cui il 2% dal-la Commissione Europea ed EFTA).Il carattere privato quindi rispetta l’approccioascendente, cd. "bottom up approach" e con-sente l’incontro dei bisogni delle industrie.Rebus sic stantibus, il sistema deve restaredunque privato, ma ciò non toglie che è im-portante che gli interessi pubblici siano presi
La Commissione Europea ha dato l'avvio ai la-vori che porteranno alla pubblicazione della
proposta di revisione del sistema di standardiz-zazione europea, prevista per aprile 2011.In questo ambito, assume particolare impor-tanza la Relazione di iniziativa che il Parla-mento Europeo ha adottato sul tema il 21 otto-bre u.s.Il Parlamento, infatti, ha voluto anticipare ilavori della Commissione, inviandole dei sug-gerimenti e delle proposte, in vista della revi-sione.In qualità di Vice Presidente della Commissio-ne Mercato Interno, ho lavorato molto sullaRelazione di iniziativa, in qualità di RelatoreOmbra per il Gruppo politico del PPE.La piena realizzazione del mercato interno habisogno della standardizzazione.Il passaggio dal vecchio al “nuovo approc-cio”, l’alleanza cioè tra legislazione comunita-ria e normazione, si è rivelata decisiva per lalibera circolazione delle merci e ha contribuitoall’eliminazione delle barriere per il liberocommercio, all’interno del mercato unico eu-ropeo, armonizzando le norme tecniche.Sebbene la Commissione Europea riferiscaogni due anni sui risultati dell’applicazionedella direttiva 98/34/CE, la revisione del siste-ma oggi acquista particolare importanza allaluce dell’attuale crisi economica e in vistadell’elaborazione della Strategia EU 2020.Il sistema europeo di standardizzazione oggideve essere all'altezza dei bisogni economicie sociali dell'Europa e, allo stesso tempo, as-sicurare innovazione, crescita e competitività.Il sistema attuale funziona abbastanza bene enon necessita di grandi trasformazioni. continua a pag. 4
Lara ComiVice Presidente della Commissioneper il mercato interno e la protezionedei consumatori
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
2
sommario
U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Spedizione in A.P. 45% - Art 2 comma 20/b legge 662/96Filiale di Milano
Prezzi di vendita per l’Italia: una copia €8,00, copia arretrata €15,50,abbonamento annuo (10 numeri) €70,00
per l’estero: una copia €14,00, abbonamento annuo €130,00Gli abbonamenti iniziano dal primo numero raggiungibile.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario su c/cintestato a Mediavalue srl
IBAN IT33N0569634070000002372X67L’IVA è a carico dell’editore.
Tiratura del num. 10 novembre/dicembre 2010: 15.000 copie.Finito di stampare nel mese di dicembre 2010.
Tutti i diritti di riproduzione degli articoli e/o delle foto sono riservati.
Direttore responsabile
Alessandro Santoro
Comitato scientifico
Corrado Bertelli, Sergio Bracco, Giancarlo Coccia,
Giacomo Elias, Domenico Pierucci, Marco Fabio Sartori,
Piero Torretta, Ugo Tramutoli
Comitato di redazione
Silvia Berri, Elio Bianchi, Fabio Galbiati,
Alberto Galeotto, Ruggero Lensi, Carlo Masetti,
Alberto Monteverdi, Gian Luca Salerio, Stefano Sibilio
Segreteria di redazione
Valentina Pompa, Sara Rossetti
Direzione e redazione
UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Via Sannio, 2 - 20137 Milano
tel. 02 700241 - fax 02 70024474
Editore
Mediavalue srl
Via Domenichino, 19 - 20149 Milano
tel. 02 89459725 - fax 02 89459753
[email protected] - www.mediavalue.it
Grafica e impaginazione
Mediavalue srl
Abbonamenti
Pubblicità
Stampatore
Italgrafica Srl - Novara
Autorizzazione del tribunale di Milano nº 3574 del 1 dicembre 1954Il Direttore responsabile e l’Editore declinano
ogni responsabilità in merito agli articoli pubblicati,per i quali rispondono i singoli Autori.
ISSN 0394-9605
Ai sensi del D.lgs 196/2003 l’Editore garantiscela massima riservatezza nell’utilizzo della propria banca dati
con finalità di invio del presente periodico e/o di comunicazionipromozionali.
Ai sensi dell’art. 7 ai suddetti destinatariè stata data facoltà di esercitare il diritto di cancellazione
o rettifica dei dati a essi riferiti.
UNIEnte Nazionale Italiano di UnificazioneVia Sannio, 2 - 20137 Milano
CEIComitato Elettrotecnico ItalianoVia Saccardo 9 - 20134 Milano
La normazione tecnica a supporto dell’innovazione edella competitività sostenibileThe technical standards to support innovation andsustainable competitivenessL. Comi
Notizie e avvenimentiNews and events
L’Assemblea Generale dell’ISO 2010ISO General Assembly 2010
Volontaria, privata, nazionale ...Voluntary, private, national...
Made in Italy alimentare, il ruolo di ACCREDIAThe agrofood made in Italy, the role of ACCREDIA
A L’Aquila esperti a confronto sul restauro dei beniculturaliExperts debate at L'Aquila on the restoration of culturalheritageG. Alessandrini
Responsabilità sociale: una novità assoluta nelpanorama delle norme ISOSocial responsibility: an important news through the ISOstandardsS. Sibilio
Sicurezza dei giocattoli: le norme internazionali pergiocare e divertirsi senza rischiISO toughens toy safety for hazard-free and fun play
La sicurezza funzionale: la nuova edizione della IEC61508Functional safety: the new edition of IEC 61508F. Andreolli, A. Brunelli, E. Ciapessoni
1
4
6
8
10
13
17
21
22
pag. 17
editoriale
attualità
articoli
pag. 10
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
3U&C n.10 novembre/dicembre 2010
sommario
Formazione al servizio delle nuove figure professionaliTIS: una nuova sede per i corsi CEI a Bolzano
Ci aiutano le norme a mantenere sani denti e gengiveSimboli per comandi, indicatori e spie: quando ilcruscotto è a norma
Collana Costruzioni: in CD-Rom le raccolte di normeUNI per l’ediliziaNuova edizione della Guida tecnica CEI 82-25: novitàper il settore fotovoltaico
Le nuove norme più importanti
tutte le norme
formazione
recensioni
dossierGESTIONE DEI RIFIUTIWASTE MANAGEMENTA cura di Stefano Sibilio – ResponsabileDivisione Organizzazione, processi,servizi e società UNI
La normativa CEN su contenitorie servizi: un contributo italianoG. Baiano
Il lavoro di normazione nelCEN/TC183 Waste management:un vantaggio competitivo nellosviluppo dei prodottiF. Mondini
La standardizzazione dei colori edegli elementi visivi per laraccolta differenziata dei rifiutiG. Bragadina
Revisione della norma UNI 10802alla luce dei nuovi rapportitecnici del CENS. Balzamo
Una norma nazionale per lagestione dei veicoli fuori usoC. Dozio
Dal waste management allenorme tecniche per il recuperoE. A. Savi
27
46
47
48
49
focus norma
vita quotidiana
pag. 4
pag. 21
29
30
31
33
37
39
42
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
4 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Valutazione ambientaledi siti e organizzazioniL’UNI ha recentemente recepito, per ora inlingua inglese, una importante norma sullavalutazione ambientale di siti e di organiz-zazioni.Si tratta della UNI EN ISO 14015:2010 chefornisce una guida su come condurre ap-punto una valutazione ambientale di siti e diorganizzazioni (attività anche conosciutacon l’acronimo inglese di EASO, Environ-mental Assessment of Sites And Organiza-tions) tramite un processo sistematico diidentificazione degli aspetti e delle questioniambientali.E’ una attività che, per quanto riguardaun’impresa, può essere effettuata in partico-lari momenti - nel caso di acquisizioni o ces-sioni, ad esempio - o rientrare in una norma-le verifica periodica.La norma si occupa, nel particolare, di defi-nire i ruoli e le responsabilità delle parti co-involte nella valutazione (cliente, valutatore,rappresentante del valutato) nonché le fasi
del processo di valutazione (pianificazione,raccolta e validazione delle informazioni, va-lutazione e rendicontazione).La norma non si occupa di altre tipologie divalutazione ambientale quali le analisi am-bientali iniziali, gli audit ambientali, le valu-tazioni di impatto ambientale o le valutazionidelle prestazioni ambientali.E’ stata inoltre pubblicata, in lingua inglesee francese come recepimento della normaeuropea, la nuova edizione della UNI EN ISO14050 che definisce i termini e i concetti fon-damentali relativi alla gestione ambientalepubblicati nelle norme della serie ISO 14000.Avere un linguaggio comune e principi per-fettamente condivisi può aiutare una più ef-ficace e puntuale applicazione dei sistemi digestione ambientale a livello europeo e in-ternazionale.Entrambe le norme sono state elaborate inseno al comitato ISO/TC 207, Environmen-tal management. In ambito UNI i lavori so-no stati seguiti dalla Commissione tecnica“Ambiente”.
Prestazioni delle barriere disicurezza stradaliL’aumento del traffico diventa sempre più unasfida per la sicurezza stradale. Nel solo 2009l’Europa ha contato 1.150.000 incidenti, 35.000decessi e 1,5 milioni di feriti. Un costo per lasocietà europea di circa 160 miliardi di euro, il10% delle risorse stanziate in campo medico-sanitario. Infrastrutture stradali inadeguatepossono poi peggiorare ulteriormente la situa-zione, rivelando l’impatto con le barriere di si-curezza stradali (RRS-Road Restraint Systems)ancor più pericoloso.A questo proposito, sono state pubblicate lenuove edizioni delle parti 1, 2 e 3 della normaUNI EN 1317 “Barriere di sicurezza stradali” lacui applicazione promuove una maggiore si-curezza - in caso di impatto - per gli utenti piùvulnerabili della strada come passeggeri, mo-tociclisti e ciclisti.La Parte 1 fornisce disposizioni per la misura-zione della prestazione dei prodotti per barrie-re di sicurezza stradali sottoposti a urto e livellidi severità di urto. La norma include i dati delluogo di prova, le definizioni delle barriere disicurezza stradali, le specifiche del veicolo (in-clusi i requisiti di carico) per i veicoli utilizzatinelle prove d’urto, la strumentazione dei vei-coli, le procedure di calcolo e i metodi di regi-strazione dei dati della prova d’urto, inclusi i li-velli di severità d’urto e l’indice di deformazio-ne dell’abitacolo del veicolo (VCDI).La Parte 2 specifica i requisiti riguardanti laprestazione all’urto delle barriere di sicurezzainclusi i parapetti veicolari, le classi di conte-nimento, la larghezza operativa, l’intrusionedel veicolo e i livelli di severità dell’urto.Infine, la Parte 3 descrive i requisiti per la pre-stazione di attenuatori d’urto sottoposti ad im-patto da parte di veicoli, le classi di prestazionee i criteri di accettabilità per prove di impatto.Si informa che, come da Circolare del Mi-nistero delle Infrastrutture e dei Trasportidel 5 ottobre 2010 pubblicata sul sitowww.mit.gov.it, è necessario un formaleatto, da parte di tale Ministero, affinché leparti 1, 2 e 3 (edizione agosto 2010) dellaUNI EN 1317 entrino in vigore nel quadroregolamentare nazionale.
acura
della
Comunicazione
UNIattu
alità
peo e meritano di essere incoraggiate e sup-portate all'interno del processo, ma non ne-cessariamente con lo stesso trattamento ri-servato alle organizzazioni rappresentative diinteressi pubblici.Data la loro natura di imprese di piccola e me-dia dimensione e considerati i problemi da es-si incontrati che dipendono molto dal settoredi appartenenza e dall'area geografica dovesi trovano a operare, il migliore livello per loroè quello nazionale, nei comitati tecnici.La Commissione Europea può quindi interveni-re e supportare finanziariamente il loro acces-so e la loro partecipazione a livello nazionale.Inoltre, è altresì importante preservare la di-versità degli organismi nazionali di standardiz-zazione e diffondere le migliori prassi per far sìche le organizzazioni meno efficienti possano
continua da pag. 1 migliorarsi. In particolare, l'Italia ha un ottimosistema interno di standardizzazione che puósenza dubbio rappresentare un modello.Per quanto riguarda, invece, l'introduzione dinuove procedure per l'adozione degli stan-dard, è importante che la Commissione Euro-pea valuti attentamente questa possibilità congli organismi europei CEN e CENELEC.Infine, vale la pena porre l'accento sul link es-senziale tra normazione da una parte e inno-vazione e competitività sostenibile dall'altra,che deve assolutamente essere rafforzato eche sarà preso in debita considerazione nellaprossima revisione.
Onorevole Lara ComiDeputato al Parlamento EuropeoVice Presidente della Commissioneper il mercato interno e la protezionedei consumatori
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
5U&C n.10 novembre/dicembre 2010
re esistenti. La norma ISO 13822:2010 “Basesfor design of structures - Assessment of exi-sting structures” è stata elaborata come unaguida pratica per gli ingegneri strutturali e i lo-ro clienti. Giunta alla sua seconda edizione, laISO 13822 comprende ora specifiche racco-mandazioni sulla valutazione delle costruzioniche costituiscono il patrimonio artistico di unterritorio.I requisiti e le procedure formulate nella ISO13822 si basano sui principi di affidabilità strut-turale e delle conseguenze derivanti da un ce-dimento. Applicabile a ogni tipo di strutturaesistente, la norma sarà utile per:• anticipare i cambiamenti, in termini di utilizzoo di ampliamento, di una costruzione;
• effettuare dei controlli di affidabilità (in rap-porto ad azioni come i terremoti o l’aumentodel traffico, per esempio) come richiesti dal-le autorità, dalle compagnie di assicurazio-ne, dai proprietari, ecc.;
• valutare il deterioramento strutturale causa-to da azioni dipendenti dal tempo (la corro-sione, la fatica);
• verificare il danno strutturale risultante dal-l’azione accidentale (per es., un incendio).
A conferma della sua rilevanza, anche a livelloeuropeo ci si sta occupando della tematica.Infatti, il CEN/TC 250 “Structural Eurocodes”ha recentamente attivato un apposito WorkingGroup su “Assessment and retrofitting of exi-sting structures”, con l'obiettivo di pervenirealla pubblicazione di uno specifico Eurocodice.
Prodotti ortofrutticoli freschiper il consumoCon il termine “IV Gamma” si indicano tutti glialimenti vegetali freschi (orticoli e frutticoli)sottoposti a minime lavorazioni che, mante-nendo invariate le caratteristiche sensoriali,consentono di ottenere un prodotto pronto alconsumo e semplice da utilizzare.Questi prodotti, che troviamo nei banchi refri-gerati già tagliati, lavati, asciugati e imballatiin buste o vaschette di plastica, sono oggettodella norma UNI 11350 “Prodotti ortofrutticolifreschi pronti per il consumo (IV Gamma) –Definizione, requisiti e principi generali”, chefornisce gli elementi per delineare il proces-so produttivo, dall’accettazione della materiaprima alla cessione all’utilizzatore finale.I prodotti ortofrutticoli freschi pronti per ilconsumo costituiscono una delle novità piùrilevanti degli ultimi anni e rappresentano unsignificativo sviluppo nel mercato ortofrutti-colo perché incontrano le esigenze dei con-sumatori che hanno sempre meno tempo dadedicare alla lavorazione delle materie prime.Il mondo scientifico, i tecnici e gli operatoridel settore, dal canto loro, concordano sulfatto che il successo di mercato degli orto-frutticoli di IV Gamma nonché la soddisfazio-ne dei consumatori non possano prescinderedalla presenza di indicazioni univoche e pre-cise in merito alle procedure che conduconodalla materia prima al prodotto finale.
Industrie del petrolio e del gasnaturale e interventi d’urgenzaL’emergenza ambientale dello scorso aprile,generata a seguito dell’esplosione di una piat-taforma petrolifera al largo delle coste dellaLouisiana, ha causato un disastro ambientale -ed economico - senza precedenti.L’ampia diffusione degli impianti in mare aper-to per la ricerca e l’estrazione di idrocarburiha portato a uno sviluppo tecnologico innova-tivo e all’avanguardia nell'ingegneria offshore.E nell’eventualità di una emergenza? Tutti i si-stemi di sicurezza devono fornire una efficacerisposta: da qui la necessità della messa a
Mettiamo ordinenei nano materialiDalle nuove applicazioni mediche agli ultimi ri-trovati per il mercato e i consumatori, le nano-tecnologie sembrano spingere sempre piùavanti i limiti di quanto pensavamo fosse possi-bile. Ma per fare in modo che questa tecnolo-gia dispieghi appieno le sue potenzialità – e sisviluppi meglio e più velocemente – è neces-saria un’opera di razionalizzazione e di classifi-cazione logica dei nanomateriali.A presentare una possibile soluzione a questoproblema ci ha pensato l’ISO che, mediante unrapporto tecnico pubblicato recentemente, of-fre ora una metodologia di classificazionecomplessiva dei nanomateriali. Si tratta del do-cumento ISO/TR 11360:2010 “Nanotechnolo-gies – Methodology for the classification andcategorization of nanomaterials”.Maggiori informazioni sono disponibili sul sitoUNI www.uni.com
L’edificio è affidabile? Rispondeuna norma internazionaleCatastrofi naturali, danni accidentali, modificheo deterioramenti come la corrosione, possonomettere a dura prova, nel corso della loro esi-stenza, edifici, ponti e altre strutture.Per accertarsi che queste costruzioni rimanga-no affidabili con il passare del tempo, l’ISO hapubblicato una norma internazionale per verifi-care la sicurezza e la funzionalità delle struttu-
punto di un sistema di gestione per coprire gliaspetti di salute e sicurezza nelle attività diestrazione.La norma UNI EN ISO 15544:2010 “Industriedel petrolio e del gas naturale - Impianti diproduzione offshore - Requisiti e linee guidaper la risposta alle emergenze” descrive gliobiettivi, i requisiti funzionali e le linee guidaper le misure di risposta alle emergenze (ER)su strutture utilizzate per lo sviluppo di risor-se di idrocarburi offshore. Il documento siapplica a strutture offshore fisse o a sistemigalleggianti di produzione, stoccaggio e tra-sporto.
acura
della
Comunicazione
UNI attu
alità
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
Anche quest’anno, a settembre, precisamente nella setti-mana dal 13 al 18, si è rinnovato l’appuntamento che ve-
de riunirsi tutti i Membri della grande “famiglia” ISO per la loroannuale Assemblea Generale, in uno scenario che, dopo qual-che tempo, é tornato a noi più familiare perché nella vecchia Europa.E’ stata, infatti, la Norvegia, patria del Premio Nobel per la Pace e no-ta per la magia dei suoi fiordi, ad ospitare, ad Oslo, questa affollatissi-ma manifestazione, di cui la normazione e chi la realizza sono i prota-gonisti assoluti.Anzi, come sottolineato, in apertura dei lavori, dal Ministro dell’Indu-stria e del Commercio norvegese, Trond Giske, la normazione interna-zionale ha e deve continuare ad avere un ruolo vitale ed un respiroglobale e rappresentare un potenziale di cambiamento e di migliora-mento a beneficio e a vantaggio dell’intera umanità.Un pensiero, questo, condiviso anche dal Presidente dell’ISO, l’au-straliano Alan Morrison, che ha mostrato grande fiducia nel poteredella normazione e nella capacità di quest’ultima di adeguarsi ai bi-sogni, dichiarando che “….omissis …il primo passo comincia con unbisogno. Un mercato ha un bisogno, un consumatore ha un bisogno,un regolatore ha un bisogno.Tali bisogni prendono voce attraverso i Membri dell’ISO, rappresen-tanti di oltre il 97% della popolazione mondiale”.
E’ la stessa fiducia che traspare anche nelle parole di Rob Steele,l’attuale Segretario Generale, che punta sul concetto di globalità intermini di soluzioni, processi e risultati che si possono ottenere soloattraverso l’utilizzo delle norme, tanto più in quelle aree in cui le sfidesono più urgenti, dal cambiamento climatico all’efficienza energetica,dalle nanotecnologie all’uso dell’IT.Non a caso, proprio a quest’ultimo argomento era dedicata l’OpenSession di quest’anno, la giornata volutamente posta tra i due giornidi riunione dell’AG, al fine di approfondire una tematica di specificointeresse.In questo caso il “focus” era l’applicazione dell’IT in alcuni settori dirilevanza sociale, da quello sanitario - esaminato sia negli aspetti di
gestione amministrativa che in quelli legati all’industria degliapparecchi medicali - , a quello dell’edilizia.In quest’ultimo ambito, citando l’esempio concreto del MuseoNazionale di Oslo, si è parlato dell’utilizzo innovativo di ciòche è noto come BIM (Open Building Information Modelling),
ovvero uno strumento che consente la visualizzazione di modelli, ilcalcolo delle emissioni, l’eventuale dispendio energetico in eccesso,allo scopo ultimo di garantire ad un campo primario ed indispensabilecome quello delle costruzioni un più alto livello qualitativo ed un mag-giore rispetto dell’ambiente.Anche nel cosiddetto “IT@Green”, infatti, il ricorso all’IT si sta rive-lando di grande efficacia, per esempio nel settore delle fonti di ener-gia rinnovabile - idrica e solare in particolare -, così come in quellodelle “smart grids”, utili al comune cittadino per una misurazione edun’informazione più attendibili del consumo energetico della propriaabitazione, allo scopo, in ultima analisi, di assicurare un impatto me-no dannoso sull’ambiente anche da parte del singolo.L’invito che è stato esplicitamente rivolto all’ISO non è solo quello diprocedere in questa direzione, ma di continuare sempre più nell’ope-ra di supporto ai paesi in via di sviluppo, quelli in cui l’uso dell’IT è an-cora meno diffuso, ma per i quali è potenzialmente ancora più auspi-cabile.Tornando, invece, ai temi trattati nell’AG, due sono stati i punti dimaggiore interesse.
Da sinistra: Robert Steele - Segretario Generale ISO, Alan Morrison - Presidente ISO, Trond Giske - Ministro dei Trasporti e dell’Industria Norvegese,Trine Tveter - Direttore Gestionale Standards Norway, Jan A. Oksum - Presidente Standards Norway.
L’Assemblea Generaledell’ISO 2010
artic
oli
U&C n.10 novembre/dicembre 20106
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
Il primo è certamente l’approvazione del Pia-no Strategico ISO 2011-2015, che ha visto ungrande lavoro di preparazione da parte delSegretario Generale, ma anche di coinvolgi-mento diretto di tutti i membri, chiamati aduna consultazione su tutti i punti che costi-tuiscono il Piano.Molti e variegati sono stati i commenti rac-colti, debitamente presi in considerazionedalla Segreteria Centrale di Ginevra, fino allamessa a punto della versione attuale che, aseguito di un’accurata valutazione da partedei Membri di Consiglio, compreso il nostrorappresentante, il Presidente UNI, ha otte-nuto il benestare anche di tutti i membri.L’altro aspetto significativo riguarda la rivisi-tazione del documento relativo all’uso e allaprotezione del marchio ISO.La diffusione dei sistemi informatici, dellenuove piattaforme e dei social networks hareso più forte la necessità di salvaguardareil marchio e la proprietà intellettuale dell’I-SO, rendendo più restrittive le clausole deldocumento già in vigore, in particolare sul-l’utilizzo a titolo gratuito di norme o parti dinorme, un rischio, questo, da cui salvaguar-darsi, visto che le norme sono e restano un
“patrimonio” dell’Organizzazione.L’ultima parte dell’AG, invece, come da copione ormai consolidato, èstata dedicata alle questioni più istituzionali, ovvero la nomina deinuovi Membri di Consiglio e quella del Presidente.Durante il biennio 2011-2012 faranno parte del Consiglio il Sudafrica,l’Arabia Saudita, la Turchia e la Colombia, che, in fase di votazione,cosa quasi del tutto inedita, é giunta ex-aequo con la Nuova Zelanda.Quest’ultima, tuttavia, quando i membri già si apprestavano ad unanuova votazione, ha deciso di lasciare cavallerescamente il posto alpaese sudamericano, per consentire anche a quest’area del mondo diessere rappresentata nell’organo decisionale più importante dell’ISO.L’AG ha chiuso il sipario con due tributi: il primo al Presidente uscen-te, l’australiano Alan Morrison, ringraziato per l’apporto fornito inquesti due anni, che sarà sostituito, per i prossimi due, dal russo Bo-ris Aleshin ed il secondo all’SN, l’ente norvegese, per l’efficienza e laprofessionalità con cui ha ospitato l’evento.Nel 2011, invece, la vecchia Europa verrà abbandonata di nuovo, afavore di un grande paese in via di sviluppo, l’India, che, per la primavolta, a New Delhi, la sua capitale, farà da padrone di casa ad unamanifestazione che, ormai, ha acquisito il buon sapore della tradizio-ne e di un auspicato arrivederci tra coloro che vi partecipano.
Ufficio Programmi Internazionali
La delegazione UNI da sinistra: Alessandro Santoro - Direttore Generale, Fulvia Petrini - UfficioSegreteria di Presidenza e Direzione Generale
Il tavolo dei relatori
ISO GENERAL ASSEMBLY 2010
This year again, in September, in the week from 13 to 18, the ISO AG2010 took place, hosted by the Norwegian Standards Body, SN, in Oslo.Great emphasis was placed, even by the Norwegian Trade andIndustry Minister, Trond Giske, on the vital role that the internationalstandardization is expected and willing to play, in order to be apotential factor, at global level, for changes and improvements for thewhole humanity's benefit. Let’s see more details in this article.
L’Assem
blea
Generaledell’ISO2010artic
oli
U&C n.10 novembre/dicembre 2010 7
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
8 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Queste le tre caratteristiche sulle quali è basato il futuro della nor-mazione tecnica secondo la Relazione IMCO illustrata il 5 novem-
bre scorso all’UNI dall’Europarlamentare Lara Comi.Negli ultimi anni l’attuazione del mercato unico europeo ha avuto ilsuccesso che conosciamo (in termini di qualità e sicurezza dei pro-dotti) grazie all'uso delle direttive di “nuovo approccio” (cioè la stra-tegia che regola il processo di armonizzazione legislativa tra i variStati membri dell’Unione Europea) in sinergia con il sistema europeodi normazione tecnica volontaria. Proprio per questo la Commissioneper il mercato interno e la protezione dei consumatori del ParlamentoEuropeo - IMCO - ha previsto un’opera di rafforzamento della norma-zione tecnica cheverrà avviata con leproposte della Com-missione Europea.L’Onorevole LaraComi, vicepresiden-te della Commissio-ne IMCO del Parla-mento Europeo erelatore Ombra peril Gruppo Politicodel PPE, ha illustra-to il 5 novembrescorso nella sededell’UNI le principa-li innovazioni che ri-
guarderanno il settore, in particolare la necessità di insiste-re sul principio della “rappresentanza adeguata” con valen-za consultiva degli attori del mercato negli organi tecnici, inquanto è di fondamentale importanza, ogni volta che è ingioco l’interesse pubblico, includere le posizioni di tutti isoggetti interessati in maniera appropriata. Inoltre, il futuro
artic
oli
Volontaria, privata,nazionale
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
9U&C n.10 novembre/dicembre 2010
della normazione tecnica si fonda – se-condo la Relazione IMCO – su tre postu-lati: la normazione deve essere volonta-ria, gestita da istituzioni private (ma ri-conosciute) e basata sulla rappresen-tanza nazionale.L’Ononorevole Lara Comi, in occasionedell’adozione della Relazione sul “Futurodella standardizzazione europea” inSessione Plenaria, commenta cosi l’in-contro del 5 novembre: “Sono lieta diaver preso parte a questa giornata di ul-teriore confronto in quanto ho estremamente a cuore la tematica, ra-gion per cui ho introdotto rispetto alla Relazione proposte di modificasoprattutto in merito alla governance del sistema di standardizzazione,vale a dire cambiamenti relativi alla partecipazione di tutti gli attori in-teressati. Le 'societal stakeholders' che rappresentano interessi pub-blici quali la salute e la sicurezza pubblica e i consumatori, devono po-ter partecipare ai lavori degli organismi europei di standardizzazionein maniera più efficace, mentre le PMI devono poter prendere parte alprocesso principalmente a livello nazionale, nei comitati tecnici.Ritengo quanto da me fatto fino ad oggi solo l'inizio, continuerò a la-vorare nei prossimi mesi per rendere la standardizzazione europeaall'altezza dei bisogni economici e sociali dell'Europa e, allo stessotempo per assicurare innovazione, crescita e competitività”.L’aspetto più importante è rappresentato dalla forte attenzione dell’U-nione Europea nei confronti delle PMI, quali strategici utilizzatori del-
le norme. Un settore, quello delle piccole e medie imprese, molto for-te anche in Italia, dove la struttura produttiva è caratterizzata dallapresenza di micro-imprese per il 94,7% del totale delle imprese attive,con il 47,2% degli addetti e il 33,3% del valore aggiunto.Grande attenzione anche per l’istruzione, la ricerca e l’innovazione: ilParlamento Europeo ritiene importante dare inizio ad una operazionedi “education”, promovendo l’inclusione della normazione nei curri-culum accademici, nei programmi scolastici, nei programmi di ap-prendimento permanente e nelle campagne di informazione, al fine disensibilizzare gli operatori economici attuali e futuri e i responsabilipolitici circa l’importanza delle norme. E’ necessario migliorare la co-noscenza e la cooperazione reciproca tra gli autori delle norme, gliinnovatori, la comunità accademica e della ricerca, includendo nellenorme il nuovo sapere, frutto in particolare dei programmi di innova-zione e della ricerca finanziati dal settore pubblico.“Siamo particolarmente soddisfatti del giudizio espresso dalla Com-missione IMCO - ha commentato Piero Torretta, presidente dell’UNIal quale si è associato il presidente del CEI, Ugo Nicola Tramutoli –sull’attività di normazione, alla quale l’UNI contribuisce sia a livellonazionale sia attraverso il CEN a livello europeo. Su alcuni degliobiettivi individuati dalla Relazione siamo già avanti rispetto ad altriStati membri (ad esempio, l’accesso libero e gratuito alla conoscenzadelle norme in oltre 40 centri di informazione nelle principali città, l’e-stremo contenimento dei costi di acquisto delle norme tecniche, latrasparenza di informazione sui lavori di normazione…). Si può e si
deve migliorare; attendiamo le misureche proporrà la Commissione Europeasulla base degli indirizzi del Parlamentoe poi ci attiveremo immediatamente perrendere il nostro lavoro ancora più utileall’economia nazionale in un’ottica eu-ropea”.I rappresentanti delle PMI (CNA, Con-fartigianato e CONFAPI) hanno accoltopositivamente la Relazione IMCO, evi-denziando però che l’accesso alla nor-mazione – nonostante gli sforzi di UNI eCEI – è ancora problematico per le mi-croimprese. Inoltre gli oneri derivantidall’applicazione delle norme per ren-dere i prodotti sicuri e di maggiore qua-lità corrono il rischio di essere vanificatidalla presenza sul mercato di prodottinon conformi, contraffatti e persino pe-ricolosi, che non vengono intercettatida adeguati controlli.
Volontaria,privata,nazionaleartic
oli
VOLUNTARY, PRIVATE, NATIONAL…
These are the three characteristics which it is based on the future ofstandardization in accordance with the IMCO report on November 5last in UNI illustrated by MEP Lara Comi.In recent years the implementation of the Single European Market hashad the success that we know through the use of guidelines for "newapproach" in synergy with the European system of voluntary technicalstandards. That is why the Committee on Internal Market andConsumer Protection of the European Parliament - IMCO - hasprovided a work by strengthening the technical standards that will belaunched with the European Commission's proposals.More details in this article.
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
10 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Svolta “epocale” per la sicurezza e la rintracciabilità del made in Italyalimentare.
Dal 1° maggio scorso gli organismi di certificazione per il rilascio deimarchi BIO (prodotto biologico), DOP (Denominazione di Origine Pro-tetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta), STG (Specialità Tradizio-nale Garantita), DOC (Denominazione di Origine Controllata), DOCG(Denominazione di Origine Controllata e Garantita) e IGT (IndicazioneGeografica Tipica) possono essere autorizzati ad operare dal Ministe-ro delle politiche agricole alimentari e forestali (il cosiddetto MIPAAF)solo dopo aver ottenuto l'accreditamento di ACCREDIA. Si chiude cosìun percorso la cui ultima tappa era stata l'istituzione, ad aprile scorso,di un dipartimento ACCREDIA dedicato proprio alla sicurezza ali-mentare.Quella dei prodotti alimentari italiani certificati costituisceuna componente sempre più significativa della produzioneagroalimentare nazionale.Secondo gli ultimi dati ISTAT e Ismea, le 194 Dop e Igp ita-liane registrate nel 2009 coinvolgono 82mila operatori erealizzano un fatturato al consumo che ha toccato i 9,3miliardi di euro. Le vendite all'estero – una rilevante vocedella produzione agroalimentare nostrana - hanno toc-cato la cifra consistente di 1,3 miliardi di euro, segnandoun +15% rispetto al 2008.Vale 3 miliardi, invece, il mercato “bio” italiano, con unincremento del +9% nel primo semestre 2010, a confer-mare una leadership europea per numero di operatori (ol-tre 45mila) e superficie dedicata (circa 1,1 milioni di ettari).Una indagine svolta da ACCREDIA nel 2007 dimostrava cheerano proprio le certificazioni del settore alimentare le piùconosciute e apprezzate dal cittadino comune. Un risultato cheora dà la misura dell’importanza della svolta in atto.“L’affidamento dal MIPAAF dell’accreditamento degli organismi dicontrollo che operano per l’agricoltura biologica, i vini di qualità ed iprodotti tipici - commenta Federico Grazioli, Presidente di ACCREDIA -rappresenta una sfida che noi intendiamo onorare con il massimo im-pegno verso i consumatori, le istituzioni e le nostre imprese”.In accordo con i dati più recenti (maggio 2010) di ACCREDIA, nel setto-re alimentare le certificazioni di sistema di gestione continuano ad es-sere le più richieste dall’utente-azienda. Il computo totale della qualitàcertificata nell'agroalimentare italiano - tra aziende agricole e ittichee altre realtà del comparto industriale della produzione, trasformazio-ne e distribuzione di prodotti alimentari - tocca le 4.666 unità.La certificazione più richiesta è la ISO 9001 (sistema di gestione per laqualità), adottata da 3794 realtà. A seguire, 821 sono le aziende che sifregiano della ISO 14001 per la gestione ambientale e, infine, 51 a nor-ma BS OHSAS 18001 (salute e sicurezza sul lavoro).Ma quali sono le aziende più certificate? Quelle del nord-est. Al nord-est italiano va la palma del maggior numero di aziende certificate nel
comparto agroalimetare (1.497), seguito dal sud e dalle isole (1.427) edal nord-ovest (848); a chiudere il centro Italia, con 660 imprese certi-ficate.Nel computo regionale, l’Emilia Romagna registra il numero più alto diaziende certificate, ben 819; a seguire, Veneto (542 imprese), Lombar-dia (522) e Sicilia (334).L'agroalimentare italiano ha quantificato 172 accreditamenti. Ma qualie quanti sono gli strumenti di controllo e verifica da parete di ACCRE-DIA su prodotti e aziende dell’agroalimentare italiano? Ad oggi, sono88 gli Organismi accreditati a rilasciare certificazioni di sistema per leaziende del settore agricolo e agroindustriale. Mentre 84 gli accredi-tamenti rilasciati per le certificazioni di prodotto. Nel dettaglio, 30 “co-prono” il settore regolamentato (Bio, Dop, Igp, Stg, Doc, Docg e Igt) e54 quello volontario, tra norme sulla rintracciabilità di filiera (ISO22005) e i più diffusi disciplinari volontari di prodotto (BRC, IFS, GLO-BALGAP, NO OGM, BRC/IOP).ACCREDIA svolge anche per il settore agroalimentare una intensa at-tività di verifica affinché il comportamento di tutti gli operatori del mer-cato, aziende, consulenti, Organismi, ispettori, garantisca l’affidabilitàdelle certificazioni. Dal settembre 2009 all’agosto 2010, le visite ispetti-ve presso gli Organismi di certificazione e le aziende certificate hannoimpegnato gli ispettori ed esperti ACCREDIA per 470 giorni uomo.
artic
oli
Made in Italyalimentare,il ruolo di ACCREDIA
THE AGROFOOD MADE IN ITALY, THE ROLE OF ACCREDIA
An important turning point for security and traceability of Italian food.From 1 May this year the certification bodies for issuing trademarksBIO, PDO, PGI, TSG DOC and DOCG and IGT can be authorized tooperate by theMinistry of Agriculture and Forestry (MIPAAF) only afterobtaining the accreditation by ACCREDIA.Ended, in this way, a course that expected the establishment in Aprillast year an Accredia department dedicated to the food security.More details in this article.
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
13U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Il futuro e la “rinascita” del patrimonio artistico e architettonico del-l'Aquila, danneggiato dal terremoto. Questo il tema della Giornatadi studio e aggiornamento, organizzata il 23 settembre scorso a L'A-quila, da Assorestauro, l'Associazione italiana per il restauro archi-tettonico, e con il patrocinio, tra gli altri, del Vice commissario per lamessa in sicurezza dei Beni Culturali, del Ministero per i Beni e le At-tività culturali Direzione regionale per i beni culturali e paesaggisticiper l’Abruzzo e dell'UNI (Luciano Marchetti).Obiettivo: fare il punto con gli addetti ai lavori, sulla normativa tecni-ca per la conservazione dei beni culturali,"per evitare che i restauri delle opere d'artee architettoniche della città abruzzese pos-sano essere più distruttivi del terremoto". Daqui la necessità di eseguire attività diagno-stiche, di progettazione degli interventi, direcupero e di restauro fatte davvero a rego-la d’arte”.Da qui l'iniziativa di oggi. "L'idea del Ministe-ro dei Beni Culturali, insieme ad Assore-stauro - spiega Luciano Marchetti - è quelladi informare e aggiornare i professionistisulle tecniche e le metodologie frutto disperimentazione e normativa ad hoc, e allo stesso tempo dibattere econfrontarsi sui problemi che pongono il restauro e la conservazionenel territorio aquilano, confrontandosi anche su eventuali critiche aimetodi di gestione della ricostruzione nel post-terremoto. Contesta-zioni che sono sicuramente costruttive perché - sottolinea - forni-scono elementi di dibattito, di conoscenza e di crescita anche per lestrutture amministrative che devono gestire questa situazione"."Il primo passo in un intervento di restauro - spiega Caterina Giovan-nini, presidente di Assorestauro - è il cosiddetto “progetto di cono-scenza” ovvero un rilevamento dello stato del bene, con attività dia-gnostiche di rilievo per verificare le condizioni del manufatto da re-
staurare. Ciò fornirà indicazioni per realizzare ilprogetto conservativo vero e proprio, nell'ambitodel quale sono contenute tutte le operazioni ne-cessarie al progetto esecutivo con gli interventi daeseguire". Come dire: dalla diagnosi della malattiache ha colpito un bene architettonico e artistico fi-no alla cura e al monitoraggio del suo stato di sa-lute. Di questo - aggiunge - le nostre aziende as-sociate sono chiamate a occuparsi a 360 gradi, dalrecupero e conservazione della struttura alle fini-
ture". "Dunque - conclude - è necessario informarsi e aggiornarsi,creare sinergia, in modo da valorizzare le competenze specifiche diciascuna azienda, che deve poi fare riferimento a normative taratesu ogni specifico intervento. E siccome questi protocolli operativi so-no in continua evoluzione, vanno conosciuti e condivisi da tutti, peressere applicati al meglio".“L’esigenza di protocolli operativi da adottarsi nella progettazione diun intervento conservativo e di metodi standard per l’esecuzionedelle analisi richieste dalla Diagnostica”, afferma Giovanna Alessan-drini, presidente della Commissione UNI Beni Culturali – NorMaL, “siè fatta prepotentemente sentire fin dagli anni ’70, ai ricercatori coin-volti nelle problematiche conservative del patrimonio storico-archi-tettonico del Paese. Risale infatti al 1978, su proposta di ricercatoridel Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Ministero competente,dell’Università di Firenze, il primo Decreto del Ministero dei Beni Cul-turali relativo all’istituzione della Commissione NorMaL (NormativaMateriali Lapidei) con la finalità di procedere ad una normativa dimetodi di studio e controllo di manufatti artistici in pietra, finalità ul-teriormente ampliata nel 1984 inserendo nuove classi di materiali og-getto di normativa (malte, intonaci, laterizi e terrecotte, legno). Nel1996 la Commissione NorMal confluisce in ambito UNI con l’attiva-zione della Commissione Tecnica UNI Beni Culturali - NorMaL (persemplicità indicata come Commissione UNI-NorMaL). L’attività adoggi svolta ha portato alla pubblicazione di 44 RaccomandazioniNorMaL e 34 norme UNI classificabili come norme metodologiche(spesso elaborate sulla base di un’ampia sperimentazione tra i diver-
A L'Aquila esperti aconfronto sul restaurodei beni culturali
di Giovanna Alessandrini
artic
oli
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
14 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
si laboratori attivi in ambito normativo) che costituiscono il riferimen-to per il ricercatore al fine di giungere a risultati analitici caratteriz-zati da alta significatività, attendibilità, riproducibilità, confrontabilitàe linee guida per il progettista all’atto della stesura dei progetto di in-tervento conservativo (progetto preliminare, definitivo, esecutivo). Idocumenti elaborati dalla Commissione operante in ambito nazionalevengono trasmessi alla Commissione CEN TC 346 per la loro adozio-ne in ambito europeo.L''Italia in questo settore occupa un ruolo di primo piano, essendostata "la prima, ormai 30 anni fa, a dotarsi di raccomandazioni e poidi normative specifiche", ricorda Vasco Fassina, presidente del Co-mitato tecnico europeo CEN/TC 346 per la conservazione dei beniculturali. "Le norme però hanno tutte un carattere di volontarietà, nelsenso che non vengono imposte ma nascono proprio dal confrontosu una metodologia che deve essere condivisa fra gli addetti ai lavo-ri, architetti, restauratori, storici dell'arte ed esperti scientifici coin-volti nel processo di conservazione di un bene. Per questo il lavorodella commissione che presiedo è proprio quello di mettere a puntole norme, farle conoscere e condividerle, affinché il produttore di unmateriale di restauro, per esempio una malta o una resina, possa se-guire i giusti protocolli nella sperimentazione e offrire così un pro-
dotto sicuro ed efficace. Nel caso dell'Aquila - conclude - una partedi queste norme possono già essere utilizzate e altre sono da co-struire, perché sul rischio terremoto c'è ancora da lavorare. Non acaso oggi siamo qui"."A L'Aquila dopo il terremoto hanno lavorato quasi tutte le universitàitaliane - spiega Claudio Modena, del Dipartimento di Costruzione eTrasporti dell'Università di Padova - attraverso il consorzio Reluis,specializzato in ingegneria sismica, anche applicata ai Beni Cultura-li, e che ha coordinato la presenza degli atenei nell'emergenza postterremoto, con ispezioni, messa in sicurezza e corsi di aggiornamen-to con l'università dell'Aquila e con gli Ordini professionali locali co-involti nella ricostruzione. Dunque, indubbiamente c'è stato un trai-ning a tappe forzate, perché negli ultimi anni si e' avuta una forte in-novazione della normativa, un'espansione nell'uso delle tecnologiepiù avanzate e dei materiali, per cui un aggiornamento era più chenecessario. Oggi, quindi, anche grazie alle ultime decisioni sui finan-ziamenti, la situazione, per quanto oggettivamente difficile, lasciaben sperare che il patrimonio storico e artistico torni a rivivere".
Giovanna AlessandriniPresidente della Commissione Beni Culturali-NorMal UNI
AL’A
quila
espertia
confrontoartic
oli
EXPERTS DEBATE AT L'AQUILA ON THE RESTORATION OFCULTURAL HERITAGE
The future and the rebirth of artistic and architectural heritage ofL’Aquila, damaged by the earthquake, is the theme of the Workshop,organized last September 23 in L'Aquila, by Assorestauro and - amongothers - by the auspices of the Ministry of Cultural Heritage andActivities (Regional Directorate for Cultural Heritage and Landscapefor Abruzzo) and by UNI.The goal is to make the point with those who work on technicalstandards for the conservation of cultural heritage in order to preventthe restoration of works of art and culture of this city that can be moredestructive than the earthquake. Hence the need to performdiagnostics, the design of interventions, recovery and restorationreally made in a workmanlike manner. More details in this article.
LE NORME PIÙ RECENTI DELLA COMMISSIONE BENI CULTURALI – NorMaL
Norma numeroUNI EN 15801:2010
UNI EN 15802:2010
UNI EN 15803:2010
TitoloConservazione dei beniculturali - Metodi diprova - Determinazionedell'assorbimentodell'acqua percapillaritàConservazione dei beniculturali - Metodi diprova - Determinazionedell'angolo di contattostatico
Conservazione dei beniculturali - Metodi diprova - Determinazionedella permeabilità alvapore d'acqua (dp)
Titolo in ingleseConservation of culturalproperty - Test methods- Determination ofwater absorption bycapillarity
Conservation of culturalproperty - Test methods- Determination of staticcontact angle
Conservation of culturalproperty - Test methods- Determination ofwater vapourpermeability (dp)
SommarioLa presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della normaeuropea EN 15801 (edizione dicembre 2009). La norma specifica unmetodo per determinare l'assorbimento dell'acqua per capillarità dimateriali inorganici porosi utilizzati per, e che costituiscono, i beniculturali. Il metodo può essere applicato a materiali inorganici porosisia non trattati che sottoposti a qualsiasi trattamento o invecchiamento.La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della normaeuropea EN 15802 (edizione dicembre 2009). La norma specifica unmetodo per la misurazione dell'angolo di contatto statico di una gocciad'acqua su materiali inorganici porosi utilizzati per, e che costituiscono,i beni culturali. Il metodo può essere applicato a materiali inorganiciporosi sia non trattati che sottoposti a qualsiasi trattamento oinvecchiamento.La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della normaeuropea EN 15803 (edizione dicembre 2009). La norma specifica unmetodo per determinare la permeabilità al vapore d'acqua (WVP) dimateriali inorganici porosi utilizzati per, e che costituiscono, i beniculturali. Il metodo può essere applicato a materiali inorganici porosisia non trattati che sottoposti a qualsiasi trattamento o invecchiamento.
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
17U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Dopo un lungo e intenso lavoro durato più di cinqueanni, la ISO 26000 sulla responsabilità sociale ha
terminato con successo il suo complesso iter di ela-borazione ed è finalmente stata pubblicata, comenorma tecnica internazionale, lo scorso 1° no-vembre. “La ISO 26000 aiuterà quelle organizza-zioni per le quali operare in maniera socialmen-te responsabile è più che una buona idea ma unmodo efficace per svolgere la propria attività.Sarà quindi un potente strumento per muovere leorganizzazioni dall’universo delle ‘buone intenzioni’a quello delle ‘buone azioni’,” come ha dichiarato Ro-bert Steele, Segretario Generale dell’ISO.Per la prima volta nella lunga storia degli Organismi di Normazione, uno
“standard” tecnico non punta a definire caratteristiche di prodotti, pro-cessi o servizi ma va ad impattare direttamente al cuore del mercatoglobale, trattando temi esclusivamente sociali.Il documento è il risultato di un ampio consenso internazionale raggiun-to tra circa 100 Paesi del mondo, tenendo conto delle enormi differenzedi approccio tra Paesi sviluppati, in via di sviluppo o del terzo mondo, epiù di 40 organizzazioni internazionali, ed in rappresentanza di 6 catego-rie di interessi diversi, i cosiddetti stakeholder: governi, imprese, lavo-ratori, consumatori, organizzazioni non governative e mondo della ricer-ca e dei servizi alle imprese. Circa 500 persone hanno preso parte ai la-vori, rendendo il Working Group ISO sulla responsabilità sociale (WG“SR”) il più grande mai attivato nel mondo della normazione tecnica.Al di là dei contenuti specifici, la ISO 26000 rappresenta quindi il miglior
compromesso tra esigenze anche molto diverse e soprattuttorappresenta il primo documento riconosciuto da una pla-
tea così ampia e variegata, che tratta tutti insieme temicome il riconoscimento delle convenzioni internazio-nali sul lavoro, lo sviluppo delle comunità locali, idiritti umani, la tutela ambientale, la concorrenzaleale, la lotta alla corruzione, ecc..La norma raccoglie i frutti dell’accordo generalesu sette principi di responsabilità sociale:• la responsabilità di ogni organizzazione (accoun-
tability) di rendere conto degli impatti ambientali esociali delle proprie decisioni e delle proprie azioni;
• la trasparenza nel fornire informazioni su tali decisioni etali impatti;
• il comportamento etico in termini di onestà, integrità, equità;
Responsabilità sociale:una novità assolutanel panoramadelle norme ISOdi Stefano Sibilio
artic
oli
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
ziative e strumenti già esistenti sul mercato e riconosciuti, e che cometale non fornisce requisiti specifici a fronte dei quali ottenere una certi-ficazione o altra forma di valutazione di conformità.Un'ultima nota sul contributo italiano ai lavori si rende doverosa alla lu-ce del coinvolgimento attivo ai lavori UNI ed ISO da parte di settori stra-tegici del Paese.Al tavolo dell’UNI si sono confrontati infatti le rappresentanze dell’in-dustria, delle PMI, del mondo dei servizi, dei sindacati confederali,dei Ministeri coinvolti, di Regioni e di importanti soggetti della Pub-blica Amministrazione, dei consumatori, delle Università, del mondoassicurativo e bancario, e tanti altri. Grazie alla nutrita delegazionedell'UNI in campo internazionale, in cui per ognuna delle sei catego-rie di stakeholder identificate dall’ISO, l’UNI ha espresso almeno unrappresentante italiano, l'Italia è stata sempre tra i Paesi più presen-ti e più attivi alle riunioni ISO e nelle attività tra una riunione e l’altra.In sede nazionale la Commissione UNI "Responsabilità sociale delleorganizzazioni" è riuscita sempre a definire posizioni nazionali condi-vise da tutti i partecipanti nelle varie fasi di voto, fino all’approvazio-ne finale dell’ultimo draft (FDIS 26000) nella riunione dello scorso 7settembre, in cui la Commissione UNI ha anche deliberato l'adozionenazionale della ISO 26000 come norma nazionale e dato il via ai lavo-ri di traduzione del testo in italiano, ipotizzando iniziative di diffusionee divulgazione.
Stefano SibilioResponsabile Divisione Organizzazione, processi, servizi e societàUNI e membro della delegazione italiana ai lavori ISO SR
• il rispetto degli interessi degli stakeholder dell’organizzazione stessa,cioè di coloro che hanno un interesse diretto o indiretto verso le deci-sioni, le azioni, le attività dell’organizzazione;
• il rispetto del principio di legalità, tenendo presente che la responsabi-lità sociale è un concetto che si propone di andare al di là del mero ri-spetto delle leggi, ma che fonda le proprie basi proprio sulla legalità esull’obbligo di rispettare le leggi;
• il riconoscimento delle norme internazionali di comportamento, anchein luoghi e Paesi in cui tali norme non sono riconosciute dalla legisla-zione locale;
• il rispetto dei diritti umani in ogni loro forma ed il riconoscimento dellaloro universalità.
Per trovare la giusta concretizzazione, tali principi vanno poi a correlar-si con i sette temi fondamentali della responsabilità sociale, ciascunodeclinato in numerosi aspetti specifici:• la governance, cioè il sistema di governo dell’organizzazione attraver-so il quale vengono prese le decisioni e che garantisce la costanteapplicazione della necessaria diligenza;
• i diritti umani in termini di lotta alle discriminazioni, rispetto dei diritticivili, politici, economici, sociali, culturali, diritti fondamentali sul lavo-ro, no a qualsiasi forma di complicità, ecc.;
• i rapporti di lavoro, i nodi dell’occupazione, il dialogo sociale e le rela-zioni sindacali, le tutele e le condizioni di salute e sicurezza dei lavora-tori, ecc.;
• la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell’inquinamento, com-prese la lotta ai cambiamenti climatici, la protezione delle biodiversità,ecc.;
• le corrette prassi gestionali, cioè una concorrenza leale, la lotta allacorruzione, il coinvolgimento della catena del valore, ecc.;
• tutti gli aspetti relativi ai consumatori, a partire da un marketing one-sto, fino alla promozione di consumi sostenibili, di scelte di acquistoinformate, di risoluzione di reclami e dispute, ecc.;
• il coinvolgimento e lo sviluppo della comunità, cioè rapporti positivicon il territorio e le comunità locali, improntati al rispetto ed alla valo-rizzazione, alla cultura, alla creazione di occupazione e ricchezza sulterritorio, all’accesso alla tecnologia.
Un aspetto va ulteriormente sottolineato: la norma ISO 26000 è una gui-da volontaria che chiarisce il significato e l’ampiezza di un tema cosìdelicato, che costituisce un grande contenitore in cui far rientrare ini-
U&C n.10 novembre/dicembre 201018
Responsabilitàsociale:unanovità
assolutaartic
oli
SOCIAL RESPONSIBILITY: AN IMPORTANT NEWS THROUGH THEISO STANDARDS
After a long and intense work lasted more than five years, the ISO26000 on social responsibility has successfully completed the wholeprocess of setting up and has finally been published as internationalstandards, last November 1.For the first time in the long history of standardization bodies, a"standard" does not aim to define the technical characteristics ofproducts, processes or services, but goes directly to the heart toimpact the global market, addressing social issues only.Let’s see more details in this article.
Commentando il voto finale che ha spianato la strada alla definitivapubblicazione della ISO 26000, Jorge E.R. Cajazeira, presidente brasi-liano del WG, ha dichiarato: “Un giorno le organizzazioni guarderannoalla ISO 26000 e diranno: ‘come avremmo potuto sopravvivere suimercati senza la responsabilità sociale?’ Questo perché un giorno ungruppo di sognatori ha cercato di immaginare come poteva essere ilfuturo e ha lavorato duramente per cinque anni per realizzare questoobbiettivo. Sono fiero - ha aggiunto Cajazeira - di essere stato allaguida di un sogno così grande”.Analoga soddisfazione ha espresso il vice-presidente Staffan Söder-berg, svedese, il quale ha voluto sottolineare come la maggiore quali-tà della ISO 26000 risieda nel processo collegiale che l’ha elaborata,fatto di impegno e collaborazione fattiva di tutti gli stakeholder. “Ora”– ha aggiunto – “consegniamo questo importante documento ai veriagenti del cambiamento: coloro che le norme le usano quotidiana-mente”.
I LEADER DEL WORKING GROUP “SR”
Figura tratta dalla norma ISO 26000: I sette argomenti chiave
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
Milioni di giocattoli in tutto il mondo sono stati ritirati dalle autoritàcompetenti a causa degli eccessivi livelli di piombo e cadmio pre-
senti nei materiali utilizzati, del rischio di soffocamento causato dalle pic-cole parti che compongono i giochi, da magneti pericolosi e da altri rischiancora.Due norme ISO appartenenti alla serie ISO 8124 che riguardano la si-curezza dei giocattoli sono state studiate con l’obiettivo di ridurre i ri-schi nei quali può incorrere un bambino divertendosi con dei giochiche nascondono insidie a causa delle sostanze tossiche con cui ven-gono fabbricati.“Non c’è dubbio che la serie di norme ISO 8124 rappresenta la basegrazie alla quale sono state sviluppate le diverse norme inerenti la si-curezza dei giocattoli” ha dichiarato Arnie Rubin Amministratore Dele-gato della Funrise Toys Ltd e Presidente del Consiglio Internazionaledelle Industrie di giocattoli, in una recente intervista pubblicata sullarivista ISO Focus dal titolo “Garantire la sicurezza dei bambini rappre-senta la priorità della nostra industria”.Pubblicata con il titolo generico “Sicurezza dei giocattoli” la serie dinorme ISO 8124 è stata pensata per minimizzare i potenziali rischi diun giocattolo derivanti dal suo utilizzo, in funzione della modalità digioco a cui è destinato, cioè, ad un normale uso che però considerianche delle modalità di gioco non intenzionali (cioè un eventuale abu-so ragionevolmente prevedibile).L’ultima nata della serie è la norma ISO 8124-4:2010 Safety of toys –Part 4: Swings, slides and similar activity toys for indoor and outdoorfamily domestic use (ndr Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Altalene,scivoli e giocattoli per attività similari ad uso familiare per interno edesterno). La nuova norma definisce i requisiti e i metodi di prova peraltalene scivoli e altri giochi similari che vengono utilizzati dai bambiniassicurando loro una protezione efficace durante il divertimento. Lanorma si applica a giocattoli usati nel solo contesto familiare per atti-vità sia in casa che all’aperto ed è rivolta ai minori di 14 anni.I dati inerenti gli incidenti, nonché le analisi dei rischi, sono stati la ba-se di partenza per il miglioramento di una nuova versione di un’altranorma della serie cioè la ISO 8124-3: 2010 Safety of toys – Part 3: Mi-gration of certain elements (ndr Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Mi-grazione di alcuni elementi).Questa norma, che persegue e massimizza le sue finalità, minimizza ilrischio di esposizione dei bambini a eventuali danni causati da ele-menti parzialmente tossici e all’eventualità che alcune parti piccoledei giochi vengano inghiottite. Inoltre, la norma fornisce i livelli massi-mi accettabili delle sostanze pericolose presenti nei giocattoli comead esempio l'arsenico, il cadmio, il piombo, il mercurio e altri compo-nenti chimici riscontrati nei giocattoli. Questa versione della normaISO 8124-3:2010 sostituisce la precedente edizione 1997.“Negli ultimi anni si sono diffusi largamente numerosi timori in meritoalla commercializzazione di giocattoli poco sicuri e non conformi” ha di-chiarato Christian Wetterberg Presidente del comitato tecnico ISO re-
sponsabile dello sviluppo delle norme ISO 8124 “La serie di norme ISO8124 tratta l’aspetto della sicurezza pertanto è molto importante perchéla sua applicazione può realmente ridurre il rischio di danni derivantidall’utilizzo di giocattoli non conformi, e contestualmente può diminuirele probabilità d’incorrere in un pericolo oppure, nel caso più sfortunatoin cui comunque ci sia stato un danno, di ridurre la gravità di una ferita.”"Ci auguriamo che tutte le categorie di produttori di giocattoli in tutto ilmondo si rendono conto dell'importanza della serie ISO 8124. La sicu-rezza dei nostri figli dipende anche da questo!"Con lo scopo di aumentare sempre più la sicurezza dei giocattoli, ilComitato Tecnico ISO/TC 181 Safety of toys (ndr Sicurezza dei giocat-toli) ha anche aggiornato e migliorato le prime due parti della serieISO 8124 cioè la Parte 1 - Safety aspects related to mechanical andphysical properties (ndr aspetti di sicurezza relativi alle proprietàmeccaniche e fisiche) nel 2009 e la Parte 2 - Flammability (ndr infiam-mabilità) nel 2007.Il Presidente dell’ISO/TC 181 ha inoltre confermato che è in previsionel’ampliamento della serie con l’aggiunta di altri nuovi argomenti. Nellospecifico tali tematiche tratteranno:• la concentrazione totale di alcuni elementi nei materiali componentiil giocattolo;
• la determinazione di ftalati plastificanti dei materiali plastici;• le pitture con le mani.Insieme alle norme ISO, a livello nazionale, come nel resto d’Europa, èin vigore la nuova direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli cheabroga la precedente 88/378/CEE. Per i tempi di attuazione la nuova di-rettiva prevede che gli Stati membri dovranno adottarla entro il 20 gen-naio 2011 e applicarla entro il 20 luglio 2011. Inoltre, in adeguamento atale direttiva alcune delle norme EN 71 sono attualmente in revisione.Maggiori dettagli riguardo alle norme inerenti i giocattoli attualmentein vigore sono disponibili sul catalogo UNI al seguente indirizzo:http://webstore.uni.com/unistore/public/searchproducts?action=search&usecache=false&deliveryType=ALL&statusDisabled=0&productNumber=71&productNumberModifier=01
Sicurezza deigiocattoli:le norme internazionaliper giocare e divertirsisenza rischi
ISO TOUGHENS TOY SAFETY FOR HAZARD-FREE AND FUN PLAY
Millions of toys have been recalled around the world because ofhazardous levels of lead or cadmium, choking hazards, dangerousmagnets and other safety hazards. Two new standards in the ISO 8124toy safety series aim to reduce the risk of a child being injured by unsafeequipment or dangerous substances."There is no question that ISO 8124 is a cornerstone of the global toysafety network," said Arnie Rubin, CEO of Funrise and President of theInternational Council of Toy Industries, in a recent interview in ISO'smagazine. "Assuring the safety of children has been our industry'spriority." Published under the generic title, Safety of toys, the ISO 8124series of standards are designed to minimize potential toy hazardsarising from their use in intended play modes (normal use), as well asunintended play modes (reasonably foreseeable abuse).More details in this article.
21U&C n.10 novembre/dicembre 2010
artic
oli
U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
22
• viene fornita una seconda via per determinare la ridondanza in appli-cazioni con componenti “proven use”;
• viene rivisto il calcolo della frazione di guasti sicuri dei componentiSFF (Safe Failure Fraction);
• viene considerato l’impiego di tecnologia ASICS (Appilcation SpecificIntegrated Circuits);
• vengono maggiormente esplicitati i metodi per definire i SIL (SafetyIntegrity Level);
• sono meglio dettagliati i software, i tools e la programmazione a og-getti;
• sono descritte nuove possibili architetture dei sistemi di sicurezza;• sono state aggiunte e rivisitate le definizioni alcune delle quali ver-ranno evidenziate e dettagliate nel prosieguo.
Ciclo di vita in sicurezza (Parte 1)Il nuovo ciclo di vita in sicurezza, illustrato in figura 2, diviso in 16 fasicome nell’edizione precedente, è stato rivisto:• nelle fasi di realizzazione dei SrS (Safety related System), ed in parti-colar modo nelle fasi di specificazione dei requisiti e di realizzazionedei sistemi E/E/PE (Elettrici / Elettronici / Elettronici Programmabili),fasi 9 e 10, precedentemente svolti nella fase 9,
• mentre le fasi 9 e 10 dell’edizione 1, dedicate rispettivamente ai Si-stemi relativi alla Sicurezza (SrS) realizzati con altre tecnologie(valvole di sicurezza, dischi di rottura,ecc.) e con altri mezzi di ridu-zione del rischio (serbatoi di convogliamento, vasche di conteni-mento, ecc.), sono state raggruppate nella nuova fase 11, che è di-ventata il riferimento per la specificazione e realizzazione di tutti glialtri sistemi di riduzione del rischio, diversi dai SIS (Safety Instrumen-ted System), oggetto principale della normativa in esame.
22 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
artic
oli
Èstata pubblicata da IEC (International Electrotechnical Commis-sion), la nuova edizione di uno degli standard più importanti e di
maggiore impatto applicativo in ambito industriale: si tratta della seriedi norme IEC 61508 dedicate alla sicurezza funzionale.La nuova edizione subentra alla prima edizione del 1998 citata all’inter-no di Direttive Europee e testo di riferimento trasversale e generalesulla sicurezza funzionale per molti settori tecnologici che a loro voltasviluppano le norme applicative specifiche per il loro settore: per ilcontrollo di processo (serie 61511), le macchine (serie 62061), gli azio-namenti (61800-5-2), l’EMC (61326-3-X), le comunicazioni (61784-3), ilferroviario (serie 50126/8/9), il nucleare (serie 61513), ecc.Nei prossimi mesi, tutti questi comitati IEC oltre a quelli CEN, CENELECe ISO che fanno riferimento alla sicurezza funzionale, saranno impe-gnati nel valutare il recepimento degli aggiornamenti e l’eventuale revi-sione dei propri documenti normativi, che l’ACOS (IEC - Advisory Com-mittee On Safety) ha stimato in oltre 170 documenti.La nuova versione della norma, ricalca il formato della versione 1 pre-cedente, suddiviso in sette parti:1. requisiti generali2. requisiti per sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabiliper applicazioni di sicurezza
3. requisiti del software4. definizioni ed abbreviazioni5. esempi di metodi per la determinazione dei livelli di integrità di sicu-rezza
6. guida all'applicazione delle IEC 61508-2 e IEC 61508-37. panorama delle tecnologie e delle misure tecniche.A tal proposito, la figura 1 evidenzia, in termini di requisiti tecnici ed al-tri, l’applicazione delle varie parti della IEC 61508, allo scopo di indiriz-zare l’utilizzatore ad una corretta applicazione delle varie parti normati-ve (1, 2, 3, 4) seguendo anche le esemplificazioni e le linee guida ripor-tate nelle rimanenti parti informative (5, 6, 7).La nuova norma Internazionale IEC 61508 sarà presto recepita dal CE-NELEC come norma europea EN 61508 e, successivamente, dal CEI co-me norma nazionale CEI EN 61508, abrogando così la norma attual-mente in vigore.
Novità principaliLe novità principali introdotte dalla seconda edizione della IEC 61508(emessa nel 2010) sono essenzialmente le seguenti:• sono aggiornati i requisiti di sicurezza;• viene modificato il ciclo di vita in sicurezza;• viene introdotto il concetto di integrità di sicurezza anche ai sottosi-stemi;
• viene introdotto anche il requisito di “security” (antintrusione infor-matica e non);
• il manuale di sicurezza diventa obbligatorio e ne vengono definiti i re-quisiti sia per HW che SW;
La sicurezza funzionale:la nuova edizione dellaIEC 61508
di F. Andreolli, A. Brunelli, E. Ciapessoni
Figura 1 - Guida all’applicazione delle parti normative e informative(Figura 1: IEC 61508-1)
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
23U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Per far chiarezza a tal proposito sono stati rivisti i contenuti della tabel-la 1: IEC 61508-1, che evidenzia a fronte delle nuove fasi del ciclo di vitain sicurezza (Safety Life Cycle):• 9: Specificazione dei requisiti dei sistemi E/E/PE
• 10: Realizzazione dei sistemi E/E/PE• 11: Specificazione e realizzazione degli altrisistemi di riduzione dei rischi.Gli scopi e gli obiettivi della fase, corredatidegli input e degli output necessari e richiestiper soddisfare i requisiti di tutti i sistemi rela-tivi alla sicurezza, sia strumentati (SIS), sianon strumentati, sebbene non oggetto direttodella IEC 61508.Inoltre, nella IEC 61508-2 (hardware), i requi-siti delle diverse fasi del ciclo di vita in sicu-rezza relativi alla realizzazione dell’Hardwaredei sistemi E/E/PE, sono ulteriormente appro-fonditi nell’articolo 7, e la fase 10 di realizza-zione e dettagliata nella figura 2, con ulterioridettagli realizzativi riportati nella relativa ta-bella 1.Similarmente, nella IEC 61508-3 (software), irequisiti delle diverse fasi del ciclo di vita insicurezza relativi alla realizzazione del soft-ware dei sistemi E/E/PE, sono ulteriormenteapprofonditi nell’articolo 7, e la fase 10 di rea-lizzazione e dettagliata nella figura 3, con ul-teriori dettagli realizzativi riportati nella relati-va tabella 1.In entrambe le parti 2 e 3 della IEC 61508, l’ar-ticolo 7, esamina e approfondisce i requisitirelativi all’integrazione, validazione, modifica-zione dei sistemi E/E/PE, mentre l’ultimo arti-colo normativo 8 dettaglia sulla valutazionedella sicurezza funzionale che riferendosi airequisiti dell’analogo articolo 8 della IEC61508-1, deve sempre rispondere ai requisitidi pianificazione, esecuzione, completezza,correttezza e precisione, ovvero quello che èstato specificato, sia stato realizzato e siastato anche validato per l’applicazione in si-curezza richiesta.Introduzione di nuovi concetti di sicurezza(Parte 1)La sicurezza funzionale (safety) finora consi-derata solo nei confronti dei pericoli dell’EUC(Equipment Under Control) è stata estesa an-che alla sicurezza antintrusione (security)contro pericoli provocati da azioni non auto-rizzate e male volenti (Punto 7.4.2.3: IEC61508-1), che possono portare e/o provocarerischi di pericolo per il personale, l’ambientee l’impianto industriale.Competenza e indipendenza del personale(Parte 1)Le competenze del personale coinvolto neiprogetti della funzione sicurezza, dapprimarelegate come informative nell’allegato A del-la vecchia IEC 61508-1, ora sono state riporta-te e ridefinite nell’articolo 8 della nuova IEC61508-1.A titolo di esempio si riporta in tabella 2, la ta-
bella 5: IEC 61508-1, che definisce in funzione del richiesto livello di in-tegrità di sicurezza SIL, l’indipendenza del personale coinvolto nellavalutazione della sicurezza funzionale rispetto l’organizzazione cherealizza il sistema strumentato di sicurezza SIS.
Lasicurezzafunzionaleartic
oli
Figura 2 - Nuovo schema di flusso del ciclo di vita in sicurezza (Figura 2: IEC 61508-1)
Tabella 1 - Stralcio dei requisiti del ciclo di vita in sicurezza (Tabella 1: IEC 61508-1)
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
24 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
In particolare, secondo la “nota” riportata in tabella 2, in relazione al ri-chiesto SIL (1, 2, 3, 4), l’indipendenza del personale di valutazione dellasicurezza funzionale è:• X : sufficiente;• X1, X2 : sufficiente in alternativa;
: X2 appropriato per sistemi a maggior grado di complessità,novità o tecnologia;
• Y : insufficiente.Determinazione della tolleranza ai guasti hardware (Parte 2)La tolleranza ai guasti hardware HFT (Hardware Fault Tolerance) oltreche col classico metodo della frazione dei guasti sicuri SFF (Safe Failu-re Fraction) denominata Route 1H, si può ora determinare, anche attra-verso la nuova Route 2H (Punto 7.4.4.3: IEC 61508-2) sia per i componen-ti ad alta complessità tipo B (purché con copertura diagnostica DCmaggiore del 60%), sia per i componenti a bassa complessità tipo A,che sono stati selezionati sulla base di utilizzazioni precedenti - “pro-ven use” (analogamente all’attuale IEC 61511).In queste situazioni di Route 2H, è richiesto un HFT minore:a) 2 per SIL 4b) 1 per SIL 3c) 0 per SIL 2d) 0 per SIL 1Inoltre, i componenti a bassa complessità tipo A, sono considerati”proven in use” se la quantificazione dei guasti hardware casuali sonostati:a) rilevati dall’utilizzo in campo in similari applicazioni di processo eambientali;
b) elaborati statisticamente secondo norme Internazionali IEC 20300-3-2 o ISO 14224;
c) valutati in accordo alle quantità di dati di ritorno dall’utilizzazione, datest e da giudizi.
Requisiti normativi del manuale di sicurezza (Parte 2 e 3)Il manuale di sicurezza deve definire gli attributi di ogni componentedei sottosistemi di sicurezza, i vincoli HW e SW che l’integratore deveconsiderare e le proprietà principali, le caratteristiche funzionali ed icomportamenti in caso di guasto.Il manuale è ora normativo sia per HW e SW (rispettivamente allegatiD della parte 2 e 3), e deve contenere almeno i seguenti elementi:a) la specifica funzionale delle funzioni realizzate;b) l’identificazione dell’HW e SW per consentire l’integrazione;c) le istruzioni ed i vincoli da rispettare per evitare guasti sistematici.Poi per ogni funzione si deve almeno specificare:• i modi di guasto casuali della funzione (rilevati e non rilevati dalla dia-gnostica);
• i tassi di guasto relativi (rilevati e non rilevati dalla diagnostica);• i requisiti e gli intervalli della diagnostica;• gli stati delle uscite in caso di guasto;• la configurazione HW (& SW);• la fault tolerance HW (& SW);• la classificazione in tipo A e tipo B;• la configurazione raccomandata;
• le istruzioni per l’installazione;• ecc..Altri dettagli sulle altre Parti della IEC 61508:2010La parte 4 “Termini e Definizioni” introduce i concetti di element safetyfunction, overall safety function, systematic capability, ecc.Nella parte 5 “Esempi di metodi per la determinazione del SIL” sonostate estesi gli esempi di metodologie di determinazione del SIL.Nella parte 6 “Linee guida di applicazione della IEC 61508-2 &I EC61508-3” sono state riportate maggiori informazioni sul calcolo dellaprobabilità e miglior descrizione sulle tecniche di modellazione proba-bilistica: Reliability block, Fault tree, Markov, ecc.Infine, è stata aggiornata la parte 7 ”Bibliografia”.ConclusioniSi tratta, dunque, di una revisione sostanziale: le novità riguardano daun lato, metodologie alternative per la determinazione della tolleranzaai guasti hardware HFT (Route 2H, già contemplata in qualche manieraanche dalla IEC 61511:2003 rivolta alla sicurezza funzionale nell’indu-stria di processo) e dall’altro lato, le richieste normative essenzialmen-te per la competenza e indipendenza del personale che conduce la va-lutazione della sicurezza funzionale e per la redazione del manuale disicurezza. Pertanto si può ritenere che la nuova edizione 2 della IEC61508:2010 avrà un l’impatto industriale favorevole, sia per la maggiorefacilità di interpretazione e la maggiore generalità e completezza, siaperché in applicazioni che prevedono funzioni strumentate di sicurezzaSIF, realizzate con componenti provati e/o utilizzati precedentemente,si può avere un credito di ridondanza rispetto SIF realizzate con com-ponenti con ratei di guasto non documentati.Sebbene le novità introdotte dalla nuova norma basilare sulla sicurez-za funzionale IEC 61508:2010 non siano sostanziali per l’esperto, per ilneofita che si avvicina alla sicurezza funzionale nell’industria di pro-cesso sono abbastanza rilevanti, perché dovendo seguire la normaspecifica sull’industria di processo IEC 61511:2003 che fa spesso riferi-menti trasversali con la IEC 61508, talvolta con corpo normativo artico-lato in ben 10 parti si potrebbe anche smarrire.Per questo motivo il CEI ha messo a calendario un corso sui sistemistrumenti di sicurezza SIS, che partendo dalla linea guida nazionale diapplicazione della IEC 61511, delinea una corretta implementazionedella IEC 61511 e degli articoli normativi di riferimento trasversali dellaIEC 61508 con esempi applicativi di determinazione dei livelli di integri-tà di sicurezza SIL, attraverso un pratica modellistica consolidata me-diante i grafici e le matrici di rischio, al fine di far rientrare il processoentro i limiti di rischio consentiti dalla regolamentazione legale e socie-taria, nei confronti dei possibili danni all’ambiente, alle persone e allecose.
Fabio AndreolliMembro CEI SC65AAlessandro BrunelliSegretario CEI SC65BEmanuele CiapessoniMembro CEI SC65A
Lasicurezzafunzionaleartic
oli
FUNCTIONAL SAFETY: THE NEW EDITION OF IEC 61508
The International Electrotechnical Commission (IEC) has recentlypublished a new edition of one of the most important applicativestandard affecting the industry: the IEC 61508 series, dedicated toFunctional Safety, that also has multiple links with many otherstandards in several sectors. This brief article aims to illustrate therelevant news regarding the revision of the IEC 61508 Ed. 2 and theconsequences of this update on the Process Industry.
Tabella 2 - Indipendenza del personale coinvolto nella valutazione del-la sicurezza funzionale
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
27U&C n.10 novembre/dicembre 2010
acura
delle
aree
Form
azione
UNIe
CEIrubriche
Formazione
Formazione al servizio dellenuove figure professionaliNumerosi i corsi organizzati dal Centro Forma-zione UNI nel 2010: hanno infatti superato ilcentinaio con più di 1000 presenze, oltre natu-ralmente, ai corsi organizzati presso le aziende.Questi dati confermano che, anche in un pe-riodo di crisi economica, la formazione è unostrumento indispensabile per la competitività.Inoltre, in un periodo di continua evoluzione eglobalizzazione, quale è quello in cui stiamovivendo, il compito della formazione è anchequello di preparare le nuove figure professio-nali da inserire nel mondo del lavoro o di tra-sformare professionalità preesistenti per ade-guarle a nuove esigenze.Il Centro Formazione dell'UNI, che ormai daanni propone corsi, seminari, giornate infor-mative sui temi di maggior attualità, è diventa-to pertanto un punto di riferimento per tutticoloro che desiderano sia migliorare la pro-pria professionalità, sia contribuire, alla com-petitività dell'organizzazione di appartenenza.Nel 2010, oltre ai corsi sui temi tradizionali,quali ambiente, qualità, sicurezza, si è pensa-to di ampliare l’offerta progettando nuovi cor-si anche in quei campi, nei quali si riteneva vifossero delle esigenze formative come, adesempio l’agroalimentare, l’energia.Cosciente dell’importanza del suo ruolo, ilCentro Formazione dell'UNI, proporrà, ancheper l’anno prossimo, un fitto calendario di in-contri. Fra i principali settori che verrannotoccati segnaliamo:AgroalimentareSi arricchirà di nuove proposte formative ilcalendario relativo a questo importante setto-re. Le problematiche relative alla sicurezzaalimentare sono infatti un argomento più chemai attuale e rappresentano un punto fonda-mentale nella tutela della salute pubblica. Laglobalizzazione dei mercati e la notevole com-plessità dei processi produttivi impongono laregolamentazione di tutti gli aspetti sia dell'or-ganizzazione degli interscambi, sia delle me-todologie di produzione: si parlerà dunquenon solo dei cosiddetti imballaggi “attivi” e“intelligenti”, che vanno oltre la semplice fun-zione di contenimento e, interagendo con iprodotti alimentari partecipano alla conserva-
zione del cibo e trasmettono informazioni sul-le condizioni dei prodotti, ma anche del com-portamento da tenere all’interno della filieraalimentare indicando che cosa occorra rea-lizzare a livello di sistema qualità, controlloqualità e conformità dei prodotti.AmbienteAnche per il 2011 saranno attive proposte for-mative finalizzate a fornire una buona cono-scenza di base in materia, a preparare chi sioccupa di gestione ambientale nelle aziende,ad aggiornare coloro che operano nel campodella consulenza e/o della formazione sullostato evolutivo delle normative del settore. Inparticolare il corso per Auditor/Responsabiligruppo di Audit di Sistemi di Gestione Ambien-tale ANGQ Qualificato CEPAS della durata di40 ore, propedeutico per tutti gli operatori im-pegnati in tale attività, permetterà di approfon-dire la conoscenza delle metodologie per laconduzione degli audit migliorando le compe-tenze per una corretta gestione, pianificazio-ne, organizzazione e chiusura degli stessi. Ilcorso propone un primo livello di formazionespecifica sugli audit interni di SGA (della dura-ta di 24 ore) e la possibilità di altre due giorna-te di approfondimento con esame finale e rila-scio dell’attestato di superamento corso.CostruzioniCon la pubblicazione della norma UNI11367:2010, importante tassello messo a dispo-sizione degli operatori per affrontare le sfidedel costruire a regola d’arte nell’interesse del
cittadino-consumatore, visto che si tratta dellaclassificazione acustica delle unità immobilia-ri, sono stati attivati e verranno riproposti an-che il prossimo anno, corsi su tale argomentoche non solo presentano la norma, ma spiega-no anche i requisiti acustici cui essa fa riferi-mento, i loro ambiti di applicazione e di esclu-sione, le metodologie di misurazione.EnergiaLa riduzione dei consumi è un primo passoper minimizzare gli effetti negativi dell'attivitàumana sull'ambiente, rendendo il nostro svi-luppo sostenibile. Tale riduzione può esseremessa in atto attraverso un insieme di com-portamenti, processi e interventi volti al ri-sparmio energetico ogni giorno, in ogni nostraattività. Le attività umane e i bisogni delle po-polazioni aumentano sempre più con il conse-guente incremento della richiesta di energia econ un costo della stessa sempre maggiore.Un importante strumento di politica nazionaleper il miglioramento dell’efficienza energeticaè sicuramente la norma UNI CEI EN 16001 "Si-stemi di gestione dell'energia - Requisiti e li-nee guida per l'uso", recentemente pubblica-ta. Data l'estrema attualità del tema - uso ra-zionale e gestione complessiva dell'energia -che coinvolge in termini più generali l'interapolitica ambientale dell'Unione europea e lacompetitività delle imprese, il Centro Forma-zione UNI continuerà la sua attività formativavolta ad informare tutti i soggetti civili ed in-dustriali sulle potenzialità offerte da tale nor-ma.QualitàIn un mondo in continua evoluzione la qualitàrimane uno degli elementi chiave attraversocui il mercato seleziona l’offerta: per tale moti-vo verranno proposti, anche nel 2011, vari corsisu tale tema, che spazieranno dal “corso ba-se”, momento formativo, propedeutico alla co-noscenza del sistema di gestione per la qualitàsecondo le norme della serie UNI EN ISO 9000,alle novità introdotte dalla norma UNI EN ISO9004, una norma per interagire in modo sempreVers
ione e
lettro
nica
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
più efficiente con il contesto economico-pro-duttivo e per raggiungere e mantenere i risul-tati desiderati fornendo una risposta equilibra-ta a tali aspettative. Saranno trattati anche i te-mi relativi a come redigere una procedura, af-finché sia chiara e semplice da applicare o acome gestire i reclami così da indirizzare l’or-ganizzazione ad una gestione del reclamo fina-lizzata a fornire indicazioni concrete per l’avviodi azioni di fidelizzazione del cliente e di miglio-ramento interno nonché molti altri aspetti cheaiutano a fornire servizi di “qualità”.SanitàLe problematiche relative ai dispositivi medicisono non solo di grande interesse, ma ancheassai complesse. Infatti, tutti i dispositivi me-dici, per poter circolare all’interno del unioneeuropea devono, non solo rispondere allanuova direttiva 2007/47/CE, ma bisogna chesiano caratterizzati in funzione della propriadestinazione d’uso. Anche la gestione dei ri-schi ha un ruolo essenziale nella fabbricazio-ne e nella distribuzione dei dispositivi medicied è questo argomento assai difficile, perchéogni interlocutore attribuisce un valore diver-so alla probabilità che si verifichi un danno eal detrimento che potrebbe derivare dall’e-sposizione ad un pericolo.Gli aspetti da analizzare in questo settore so-no dunque assai vari e continueranno ad es-sere oggetto dei corsi proposti in tale campo.SicurezzaNell’ambito sicurezza protagonisti saranno,anche per il 2011, i corsi sulle principali Diret-tive, ATEX, PED e Macchine, tematiche versole quali è sempre alto l’interesse: anche sesono ormai passati diversi anni dal recepi-mento di queste Direttive UNI ha ritenuto op-portuno proporre sia corsi di base, per dareuna formazione completa ed esaustiva a tutte
le persone che, in azienda, a livello operativo,si trovano ad affrontare, per la prima volta, leproblematiche relative all’applicazione di taliDirettive, sia di approfondimento rivolti a colo-ro che vogliono migliorare le proprie compe-tenze e la propria professionalità. A questi siaggiungeranno i corsi che prenderanno inconsiderazione altri due temi di particolare ri-lievo e interesse: gli impianti termici e quelliantincendio.Con questa breve e sintetica panoramica ab-biamo voluto dare un’indicazione di massimadi quanto verrà offerto nel corso del prossimoanno ma, per chi volesse avere il quadro com-pleto delle attività del Centro di FormazioneUNI, è disponibile sul nostro sito il calendariodelle varie manifestazioni, frequentemente ag-giornato con nuove proposte volte a risponde-re sempre meglio alle esigenze del mercato.
TIS: una nuova sedeper i corsi CEI a BolzanoIl CEI arricchisce la propria offerta formativaallargando la collaborazione con nuovi distri-butori per l’erogazione di corsi di formazione.Recentemente è stato stipulato un accordocon TIS Innovation Park, centro promotoreper l’innovazione, la cooperazione e il trasferi-mento di tecnologie per tutti gli attori del si-stema innovazione altoatesino, che si prefig-ge lo scopo di creare una rete di imprenditori,ricercatori ed esperti. I collaboratori del TISforniscono consulenza e assistenza ai giovaniimprenditori che intendono fondare una pro-pria azienda, aiutano le piccole imprese a in-staurare tra loro una rete di rapporti collabo-rativi e mettono in contatto la scienza e la ri-cerca con il mondo dell’economia.TIS, che ha sede a Bolzano, in Via Siemens19, è posto in un punto nevralgico della città a
pochi chilometri dall’uscita autostradale delBrennero e non lontano dall’aeroporto.Il corso d’apertura della stagione, CEI 64-14“Verifiche degli impianti elettrici”, ha ottenutomolto successo richiamando l’attenzione el’interesse di elettricisti e manutentori elettri-ci, principali destinatari del corso.La giornata di studio informa circa gli obblighidi verifica e le loro modalità di esecuzionepreviste dalla Norma CEI 64-8 sugli impiantielettrici, approfondendo gli obblighi normativie legislativi, la protezione contro i contatti di-retti e indiretti, le caratteristiche essenzialidegli impianti di terra, gli esami a vista dell’im-pianto elettrico, nonché le misure e le prove.Il secondo appuntamento formativo, CEI 11-27“Lavori in prossimità di impianti elettrici e La-vori elettrici sotto tensione in BT e fuori ten-sione in AT e BT in conformità al Testo Unicosulla Sicurezza”, ha avuto luogo a metà no-vembre, presso la sede di TIS.Il corso, conforme al livello 1A e 2A della Nor-ma CEI 11-27, per l’attestazione delle qualifi-che PES o PAV, fornisce gli elementi di com-pletamento alla preparazione del personaleche svolge lavori elettrici, con particolare ri-guardo all’acquisizione delle necessarie co-noscenze teoriche e delle modalità di organiz-zazione e conduzione dei lavori, anche conesempi descrittivi di lavori riconducibili a si-tuazioni impiantistiche reali.Per visionare il calendario completo di tutti icorsi CEI e i programmi per il 2010-2011 e peravere tutte le informazioni è possibile consul-tare il sito CEI all’indirizzo http://www.ceiweb.it alla voce “CEI Formazione” oppure contatta-re direttamente CEI Formazione ai recapitisotto riportati:Tel. 02.21006.280 - 281 - 286 - Fax 02.21006.316e-mail: [email protected]
28 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
acura
delle
aree
Form
azione
UNIe
CEIrubriche
CORSI CEI DICEMBRE 2010/GENNAIO 2011
Data15/12/2010
16/12/2010
10/01/2011
12/01/201113-01-2011
17/01/201118/01/201121/01/201124/01/2011
26/01/2011
31-01-2011
CittàMilano - CEI
Treviso TecnologiaLancenigo di Villorba (TV)Milano - CEI
Milano - CEIMilano - CEI
Milano - CEIMilano - CEIMilano - CEIMilano - CEI
Milano - CEI
Milano - CEI
Corso11-27
31Polveri
11-27
0-15Protezioni
82-25PROIMPLED11-27
44-5
QuadriBT
DescrizioneLavori in prossimità di impianti elettrici e Lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in ATe BT in conformità al Testo Unico sulla SicurezzaLuoghi con pericolo d'esplosione in presenza di polveri; Norme CEI e direttive ATEX
Lavori in prossimità di impianti elettrici e Lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in ATe BT in conformità al Testo Unico sulla SicurezzaManutenzione di cabine elettricheMT/BT del cliente finaleSistemi di protezione e interfacciamento con impianti utente delle reti elettriche di distribuzione inMTImpianti fotovoltaici collegati alle reti elettriche in BT eMT: progettazione e realizzazioneProgettazione degli impianti elettrici a bassa tensioneApparecchi di illuminazione a LEDLavori in prossimità di impianti elettrici e Lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in ATe BT in conformità al Testo Unico sulla SicurezzaProgettazione esecutiva dell'equipaggiamento elettrico delle macchine: Normativa ed esempipraticiI quadri elettrici di bassa tensione
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
Gestione dei rifiutiA cura di Stefano Sibilio – Responsabile Divisione UNI Organizzazione, processi, servizi e società
Non c’è dubbio: il tema della gestione dei ri-fiuti è sempre molto “caldo” e quindi moltodelicato da trattare. Proviamo a farlo conquesto dossier sugli aspetti di normazionedella gestione dei rifiuti in quanto la perce-zione comune sul tema è che in Italia ci siatanto da fare, eppure in ambito normativo l’I-talia riesce spesso a trovare soluzioni chevengono accolte in modo entusiastico in Eu-ropa e talvolta prese a modello.Infatti, sono numerosi i temi di questo dossierche raccontano esperienze di leadership ita-liana in sede CEN, a partire dalla conduzionedei lavori del principale gruppo del Comitatoeuropeo CEN/TC 183 “Waste management”(articolo di Gianmaria Baiano, che apre que-sto dossier), e dalle testimonianze dei delegatiitaliani in tale comitato, che negli anni sono ri-usciti a dare peso e forza alle proposte nor-mative definite in UNI fino a far andare di paripasso l’evoluzione della produzione delle loroaziende con l’evoluzione della normativa,sempre in linea con l’evoluzione dei mercati(articolo di Francesco Mondini). Tale evoluzio-ne ha portato questo Comitato, quasi in modonaturale, ad affrontare finalmente il tema piùinteressante per gli utenti finali: i livelli di pre-stazione dei servizi di raccolta rifiuti e in ge-nere di igiene urbana. Non è stato facile in se-de europea far passare l’importanza e la ne-cessità di approvare l’attivazione di questi
nuovi lavori normativi, in un contesto che siera fin qui dedicato ai soli prodotti (cassonet-ti, camion, sistemi, ecc.), ed il passaggio è tal-mente significativo da comportare anche mo-difiche nelle stesse delegazioni nazionali equindi negli interlocutori coinvolti. Non a casoin UNI sono stati maggiormente coinvolti nu-merosi nuovi soggetti, di provenienza Fede-rambiente (con Hera e AMSA in prima linea),Fise Assoambiente, CONAI tra gli altri.Nell’ambito di questi lavori merita un cennoparticolare una nuova proposta italiana (arti-colo Giovanni Bragadina) che a maggior ra-gione inquadra certamente le necessità delcittadino consumatore: quella di definire de-gli elementi visivi per l’identificazione dellediverse frazioni di rifiuto. Stiamo parlandodella situazione imbarazzante, dal punto di vi-sta normativo, per cui in ogni Regione di Ita-lia, e ancor di più in ogni Provincia fino ascendere al livello comunale, i contenitori perla raccolta dei diversi materiali (carta, vetro,plastica) sono di colori diversi. Quale miglioreoccasione per la normazione di affrontare untema così sentito, apparentemente così sem-plice, ma che nasconde delle insidie e degliinteressi fortissimi?E sempre in tema di leadership italiana in Eu-ropa, il dossier si chiude con un’esperienzacompletamente diversa ma altrettanto di suc-cesso: la normazione delle caratteristiche dei
materiali provenienti da pneumatici fuori uso(articolo di Elio A. Savi). Su questo tema inUNI avevamo a fatica raccolto un’esperienzanon felice condotta in passato con leadershipsvedese, che non aveva portato al consensotra i vari Paesi sui contenuti normativi propo-sti. L’idea di ampliare la base dei partecipanti,di realizzare una norma di carattere speri-mentale (UNI CEN/TS14243) e di mediare traposizioni molto diverse provenienti da produt-tori di pneumatici, operatori della raccolta,distributori, recuperatori e riciclatori dei ma-teriali, utilizzatori degli stessi, ha portato adun successo (all’inizio insperato) con appro-vazione all’unanimità di un testo che certa-mente aprirà la strada per l’ulteriore evolu-zione di un mercato nuovo e particolarmentesignificativo.E tra queste due esperienze di leadership ita-liana in Europa, si dipana il fil rouge del dos-sier, tra i tanti diversi aspetti della gestionedei rifiuti: dalla raccolta dei rifiuti urbani e re-lativo trasporto, al campionamento dei rifiutiper le analisi di laboratorio sugli stessi (artico-lo di Stefania Balzamo sulla norma UNI 10802richiamata in dispositivi legislativi), fino al re-cupero, riutilizzo e/o riciclo dei materiali, doveoltre agli pneumatici, un’esperienza di norma-zione nazionale ha individuato nei veicoli di-smessi (vedere articolo di Claudio Dozio) un’al-tra importante fonte di materiali riutilizzabili.
dossier
U&C n.10 novembre/dicembre 2010 29
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
30 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Gestione
deirifiutidossier
La normativa CEN su contenitorie servizi: un contributo italiano
Nell’ottobre 1989 – poche settimane primadella caduta del muro – fu costituito a Berlinopresso il DIN, che ne assunse la segreteria, ilComitato tecnico europeo CEN/TC 183, ambi-ziosamente finalizzato al “Waste Manage-ment”, e contestualmente nel suo ambito an-che il gruppo di lavoro WG1 per la normalizza-zione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti,la cui segreteria fu affidata ad un delegatoitaliano e quindi all’UNI, dopo aspri contrasti:questa era infatti disputata fra un rappresen-tante dei costruttori francesi ed uno dell’Au-stria, supportato dalla Delegazione tedesca,senza possibilità di coagulare una significati-va maggioranza a favore di uno o dell’altrocandidato.Per superare lo stallo si verificò la disponibili-tà dei responsabili operativi dei servizi comu-nali al momento presenti, il cui profilo di pub-blici funzionari assicurava maggiore indipen-denza di giudizio: fra il Direttore del forno diincenerimento di Copenhagen e quello dell’A-zienda Municipalizzata di Igiene Urbana diGenova fu “provvisoriamente” designato que-st’ultimo, in quanto professionalmente più vi-cino ai problemi della raccolta. Dopo un ven-tennio, malgrado il variare degli incarichi suc-cessivamente assunti nel settore, il medesimodelegato presiede ancora il WG1.Qualche anno dopo fu costituito un secondogruppo di lavoro, relativo ai compattatori usatiper la raccolta, con segreteria francese e, nelnuovo millennio, un terzo gruppo per la nor-mazione dei sistemi di riconoscimento deicontenitori e di rilevazione dei rifiuti contenutimediante dispositivi installati sui mezzi, consegreteria olandese.Al momento dell’avvio dell’attività del TC era-no state approvate norme nazionali relative aisoli cassonetti e solamente in 3 Paesi, Germa-nia, Francia e Italia, vale a dire da parte delDIN, di AFNOR e dell’UNI: in vari altri Paesieuropei – e segnatamente in Olanda, Irlanda,Gran Bretagna e Spagna – c’era poi un gran-de interesse per ottenere l’inclusione nellenuove norme dei propri prodotti per cui ilWG1, oltre a svolgere un complesso lavoro diarmonizzazione degli standard già consolidati(circa gli elementi dimensionali ed i metodi diprova), dovette compiere scelte difficili e tal-volta dolorose al fine di limitare per quantopossibile le variabili tipologiche che avrebbe-ro ostacolato la compatibilità dei diversi con-tenitori rispetto a sistemi unificati di solleva-mento e di svuotamento.Fra le alternative tecnologiche non inclusenelle norme basta ricordare i sistemi di solle-vamento di contenitori “Hook and Hold” (Ir-landa), “Diamond” (Germania), “Bologna” ed
“Europa” (Italia): anche se non sono del tuttousciti di scena nei Paesi di origine, la loro pre-senza si è progressivamente ridotta e, soprat-tutto, non si sono ulteriormente diffusi in am-bito europeo, che oggi utilizza 3 soli sistemi. Inquesto senso l’elaborazione della norma hasenz’altro esercitato una forte azione di orien-tamento del mercato.Inoltre all’epoca non esisteva in Europa alcu-no standard relativo ai cassonetti per raccol-ta differenziata, alle “campane” sollevabilicon gru, ai contenitori “underground” ossiacollocati del tutto o in parte al di sotto delsuolo calpestabile; neppure erano disponibilinorme circa i veicoli di raccolta o l’elettronicada installare su di essi per verificare in temporeale lo svolgimento del servizio.In vent’anni il TC ha svolto un lavoro imponen-te, colmando tutte queste lacune, ed inoltreelaborando, senza potersi riferire ad espe-rienze precedenti, una complessa normativaconcernente i compattatori a caricamentoposteriore, laterale e frontale, nonché i siste-mi di rilevazione dei contenitori svuotati e delloro contenuto, con protocolli unificati di tra-smissione dei dati alla centrale operativa delservizio.In particolare il WG1 ha normato, e in qualchecaso anche già più volte aggiornato, gli stan-dard relativi a:• contenitori mobili (bidoni e cassonetti) perraccolte ordinarie e differenziate, con le EN840-1/-6;
• contenitori stazionari: EN 12574-1/-3;• contenitori sollevati dall’alto e svuotati dalbasso: EN 13071-1/-3;
• ricoveri per cassonetti: EN 15132.Un notevole impegno è seguito all’adozionedella Direttiva Macchine, che ha ovviamentecomportato una rivisitazione di molti contenu-ti delle norme relative ai compattatori, più vol-te osservate e rimandate per chiarimenti alWG2 dal Ministero della Sanità Francese edal Bureau Technique del CEN. Anche il WG1ha speso approfondite discussioni al riguar-
do, al fine di acclarare e far assentire agli or-gani tecnici di controllo il fatto che i conteni-tori NON sono macchine, e pertanto ad essinon si applica la direttiva in questione.Mentre prosegue il continuo adeguamento al-le nuove esigenze di questo corpus, da cui di-pende il regolare svolgimento dei servizi basi-lari di igiene urbana, negli ultimi anni l’attivitàdel WG1 si è sempre più orientata a normaliz-zare la prestazione dei servizi, oltre che le at-trezzature impiegate, estendendosi fortemen-te in altri settori fra cui:• le toilette mobili ed i relativi standard di im-piego (inchiesta pubblica in fase di lancio);
• la definizione degli elementi visuali di rico-noscimento dei contenitori per raccolte dif-ferenziate: il progetto è in fase avanzata disviluppo;
• la definizione delle prestazioni richieste ofornite nonché la verifica e l’accettazionedei servizi di gestione dei rifiuti quali la pu-lizia delle strade, la raccolta dei rifiuti ur-bani, la pulizia e la manutenzione dei con-tenitori, la raccolta dei rifiuti abbandonati,la vuotatura dei pozzi neri, la rimozione deigraffiti dagli spazi pubblici, la raccoltapneumatica, le condizioni generali di ap-palto di questi servizi.
Quest’ultimo gruppo di norme è senz’altro ilprogetto più ambizioso affrontato dal Gruppodi Lavoro per mole (sono previsti testi per ol-tre un milione di battute), complessità e con-tenuto innovativo dei documenti previsti, con-siderando l’assenza di precedenti norme na-zionali in tutte queste materie e che per lamaggior parte degli argomenti affrontati nonesistono neppure disciplinari tecnici predi-sposti da associazioni di categoria nazionali.Tre parti sono già state redatte e sono in cor-so di verifica tecnica in vista dell’inchiestapubblica, mentre altre cinque sono previstenel prossimo triennio. Una certa apatia al ri-guardo da parte delle delegazioni di taluniPaesi lascia supporre che in alcune aree sa-rebbe preferita l’assenza di regolamentazioni
FISE Assoambiente, l’Associazione che rappresenta, a livellonazionale, le imprese private che svolgono servizi ambientali, ha dasempre ribadito l’importanza, per il settore, di disporre di adeguatie aggiornati standard per un omogeneo livello autorizzativo sul ter-ritorio che assicurino soluzioni tecnico-gestionali in grado di ren-dere sempre più efficiente ed efficace l’operatività in questocampo, garantendo al contempo il rispetto per l’ambientale.Coerentemente con questo obiettivo, acquista un ruolo fondamen-tale la partecipazione ed il supporto fornito ai lavori dei tavoli tec-
nici dell’UNI e del CEN. La collaborazione tra l’Associazione e i citati Enti di normazione, nazionaleed europeo, ha permesso e permette tutt’oggi la definizione di soluzioni concrete a vantaggio nonsolo delle imprese ma anche dell’efficienza del sistema nel suo complesso.Pietro Colucci - Presidente FISE Assoambiente
FISE ASSOAMBIENTE
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
31U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Gestione
deirifiutidossier
in questo settore, ma la partecipazione vivaceed in qualche caso conflittuale di altre delega-zioni, fra cui quelle di Germania, Italia, Spa-gna, Portogallo e Finlandia, assicura invece unalto livello di interesse ed una probabile con-
clusione condivisa.Guardando agli oltre vent’anni di conduzioneitaliana dei lavori in questo settore risulta evi-dente il ruolo trainante e determinante delWG1 nell’ambito del TC 183, grazie all’inappun-
tabile servizio di segreteria assicurato dai Fun-zionari dell’UNI che si sono succeduti in que-sto lungo arco di tempo, come pure alla conti-nuità di azione assicurata dal fatto di aver frui-to del contributo di uno stesso Convenor pertutto il periodo ed al sostegno costante deglioperatori che hanno supportato l’iniziativa.Tuttavia, ad una riflessione più complessiva,gli elementi determinanti di questo successoappaiono, al di là degli indubbi contributi disingole persone o imprese, l’inventiva, l’adat-tabilità, l’attenzione tecnica ed il rispetto delleregole che spesso caratterizzano l’impegnodei nostri rappresentanti negli organismi inter-nazionali.
Gianmaria BaianoFISE AssoambienteConvenor del CEN/TC 183/WG1 e Coordinatoredel GL8 Attrezzature e macchine per laraccolta dei rifiuti della Commissione TecnicaAmbiente UNI
Il lavoro di normazione nelCEN/TC183 Waste management:un vantaggio competitivo nellosviluppo dei prodotti
All’interno del CEN/TC 183 “Waste manage-ment” opera, fin dal 1988, il gruppo di lavoro“WG1”, incaricato della redazione delle normerelative ai contenitori per i rifiuti, che spazia, inpratica, dalle pattumiere che abbiamo sul ter-razzo ai bidoni a due ruote, dai contenitoristradali a quattro ruote ai contenitori stazio-nari (cosiddetti “a Casetta”) , fino ai grandicontenitori interrati ed alle campane stradali.Il gruppo di lavoro è stato diretto, sin dall’ini-zio, da un coordinatore italiano, GianmariaBaiano, e da una segreteria italiana pressol’UNI, che, in questi vent’anni e più, ha redattonorme spesso considerate inizialmente ‘im-possibili’, unificando progressivamente stan-dard tra loro estremamente differenziati, origi-nati da storia e tradizioni molto diverse tra lo-ro, che si presentavano a volte come assolu-tamente inconciliabili.Per di più, i prodotti che erano oggetto dellanormativa (i contenitori per rifiuti) si sono nelfrattempo evoluti in modo rapidissimo (pro-prio nel periodo in cui li stavamo normando…!).Quando il nostro lavoro ha preso il via, infatti,alla fine degli anni 80, i rifiuti erano raccolti inItalia per oltre il 90% in modo indifferenziato, ei contenitori stradali (sia a due che a quattroruote e stazionari) erano destinati prevalente-mente alla raccolta del rifiuto indifferenziato, ilcosiddetto “tal quale”, mentre alla raccoltadifferenziata, soprattutto di vetro e carta, rara-mente plastica, erano per lo più destinate le
Contenitori per la raccolta dei rifiuti (CEN/TC 183/WG1)Riferimento TitoloUNI EN 840-1:2004 Contenitori mobili per rifiuti - Parte 1: Contenitori a 2 ruote, con capacità fino a
400 l, per dispositivi di sollevamento a pettine - Dimensioni e progettazioneUNI EN 840-2:2004 Contenitori mobili per rifiuti - Parte 2: Contenitori a 4 ruote e coperchio(i) piat-
to(i), con capacità fino a 1 300 l, per dispositivi di sollevamento a perno(maschio) e/o a pettine - Dimensioni e progettazione
UNI EN 840-3:2004 Contenitori mobili per rifiuti - Parte 3: Contenitori a 4 ruote e coperchio(i)basculante(i), con capacità fino a 1 300 l, per dispositivi di sollevamento aperno (maschio) e/o a pettine - Dimensioni e progettazione
UNI EN 840-4:2004 Contenitori mobili per rifiuti - Parte 4: Contenitori a 4 ruote e coperchio(i) piat-to(i), con capacità fino a 1 700 l, per dispositivi di sollevamento a perno(maschio) largo o BG e/o a pettine largo - Dimensioni e progettazione
UNI EN 840-5:2004 Contenitori mobili per rifiuti - Parte 5: Requisiti prestazionali e metodi diprova
UNI EN 840-6:2009 Contenitori mobili per rifiuti - Parte 6: Requisiti di igiene e sicurezzaUNI EN 12574-1:2006 Contenitori stazionari per rifiuti - Parte 1: Contenitori con capacità fino a
10 000 l con coperchio/i piatto/i o basculante/i, per dispositivo di solleva-mento a perno, a doppio perno o a tasca - Dimensioni e progettazione
UNI EN 12574-2:2006 Contenitori stazionari per rifiuti - Parte 2: Requisiti prestazionali e metodi diprova
UNI EN 12574-3:2006 Contenitori stazionari per rifiuti - Parte 3: Requisiti di igiene e di sicurezzaUNI EN 13071-1:2008 Contenitori stazionari per rifiuti con capacità fino a 5 000 l, sollevati dall'alto e
svuotati dal basso - Parte 1: Requisiti generaliUNI EN 13071-2:2008 Contenitori stazionari per rifiuti con capacità fino a 5 000 l, sollevati dall'alto e
svuotati dal basso - Parte 2: Requisiti addizionali specifici per sistemi interratio semi-interrati
prEN 13071-3 allo studio Contenitori stazionari per rifiuti con capacità fino a 5 000 l, sollevati dall'alto esvuotati dal basso - Parte 3: Connessioni raccomandate per il sollevamento
Altri prodotti (CEN/TC 183/WG1)UNI EN 15132:2006 Ricoveri per contenitori mobili per rifiuti con capacità fino a 1 700 l - Requisiti
prestazionali e metodi di provaprEN 16194 allo studio Mobile non-sewer-connected toilet cabins - Requirements of services and
products relating to the deployment of cabins and sanitary products
Veicoli per la raccolta dei rifiuti (CEN/TC 183/WG2)UNI EN 1501-1:2010 Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali
e di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posterioreUNI EN 1501-2:2010 Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali
e di sicurezza - Parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento lateraleUNI EN 1501-3:2008 Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali
e di sicurezza - Parte 3: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontaleUNI EN 1501-4:2008 Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali
e di sicurezza - Parte 4: Codice di prova dell'emissione acustica per veicoliraccolta rifiuti
prEN 1501-5 allo studio Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generalie di sicurezza - Parte 5: Dispositivi di sollevamento dei veicoli raccolta rifiuti
Sistemi di identificazione (CEN/TC 183/WG3)UNI EN 14803:2006 Identificazione e/o determinazione della quantità di rifiuti
L’elenco completo delle norme UNI è disponibile attraverso il catalogo on-line all’indirizzo: www.uni.com
NORME E PROGETTI DEL COMITATO CEN/TC 183 (aggiornamento ottobre 2010)
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
32 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
sole campane stradali.Come tutti sanno, oggi il rifiuto indifferenziatonon esiste praticamente più e, di solito, i con-tenitori sono disponibili in tutte le versioni de-stinate alla raccolta delle singole frazioni di ri-fiuto, dalla versione per la raccolta della cartaa quella della plastica, dall’organico all’indiffe-renziato, che oggi si chiama “frazione resi-dua”.Personalmente, io mi sono accostato al lavorodella normativa, a metà degli anni ’90, spintomolto dalla curiosità, oltre che dalla necessitàdi comprendere meglio le norme relative aiprodotti di cui dovevo occuparmi in azienda.Muovendomi con cautela, mi chiedevo se misarebbe toccato di passare le notti davanti almio pc per portare avanti anche questo enne-simo lavoro (cioè la redazione delle bozze perlo sviluppo della normativa) che mi sarei do-vuto accollare, gratuitamente, per il noto mec-canismo che opera nei comitati formati da po-che persone, dove i volontari sono identificatiin automatico…..Il lavoro sviluppava mediante riunioni succes-sive, nelle quali i partecipanti esaminavano labozza di norma in fase di elaborazione, propo-nendo varianti, aggiunte, nuove parti.Alla prima riunione a cui ho preso parte, infat-ti, abbiamo passato quasi tutto il tempo adanalizzare i contenitori per rifiuti focalizzandol’attenzione anche su dettagli (il sistema di sol-levamento, gli interassi delle ruote, le mani-glie, etc ..) e discutendo animatamente le variesoluzioni. Ognuno illustrava gli standard esi-stenti nel proprio Paese evidenziandone i van-taggi e gli svantaggi e proponendo spesso ilproprio standard come il candidato miglioreda inserire nella norma.Sembravamo quasi un gruppo di lavoro incari-cato di sviluppare qualche nuovo contenitore.Riguardando gli appunti, al ritorno, mi sembra-va di aver appreso di più, su certi problemi, inquesta prima riunione che in mesi di lavoro nelmio ufficio tecnico. Mah, sarà un’eccezione,mi sono detto.Ma poi, man mano che il lavoro si sviluppava,mi sono accorto che il gruppo di lavoro era inrealtà una eccellente finestra aperta sul setto-re di mia competenza, che mi consentiva unavisione privilegiata del mercato europeo deicontenitori per rifiuti e mi mostrava sia lo statodi fatto dei prodotti più diffusi, sia le tendenzepiù rilevanti e le probabili future evoluzioni.Ciò significa, in pratica, passare in rassegna iprodotti esistenti sul mercato esaminandoli edevidenziando anche il gradimento o la boccia-tura riscontrata dalle varie soluzioni presso laclientela.Significava, in sintesi, avere accesso ad unagrande quantità di informazioni ed esperienzemesse gratuitamente a disposizione dai varipartecipanti, analizzando in anticipo le soluzio-
CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – è il consorzio privatosenza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggicon la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo deimateriali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepi-ti in Italia attraverso il Decreto Ronchi (ora Dlgs. 152/06).In un quadro di responsabilità condivisa in cui si chiedono a tutti isoggetti coinvolti - imprese, Pubblica Amministrazione, cittadini -nuovi comportamenti che permettano di far fronte a nuove respon-
sabilità, i Ministeri dell'Ambiente e delle Attività Produttive hanno definito obiettivi lasciando alleimprese la libertà di decidere come raggiungerli. La politica definisce il cosa, le imprese il come.CONAI è il perno di uno dei sistemi europei più efficaci ed efficienti di recupero e valorizzazionedei materiali di imballaggio basato sul principio della responsabilità condivisa fra i cittadini chesono chiamati a separare i rifiuti in casa, i comuni che organizzano la raccolta differenziata e ilmondo delle imprese che provvede al loro riciclo/recupero.Sulla base di tali presupposti CONAI partecipa alle attività di normazione UNI, EN e ISO sia nell’am-bito della progettazione ecoefficiente degli imballaggi sia nell’ambito delle migliori pratiche digestione a fine vita.Walter Facciotto - Direttore Generale CONAI
CONAI
Titolo principaleWaste management -Levels of performanceand acceptance forstreet cleaning andmunicipal wastemanagement services
Waste management –Waste visual elements
Parte specificaPart 1: General requirements(in approvazione)Part 2: Ways to measure the levels of performance and to settle theacceptance, to draw up and to operate contracts for general or separa-te collection services of municipal waste(allo studio)Part 3: Ways to measure the levels of performance and to settle theacceptance, to draw up and to operate contracts for manual and mecha-nical street and sidewalk cleaning and washing(di prossima stesura)Part 4: Ways to measure the levels of performance and to settle theacceptance, to draw up and to operate contracts for containers cleaningand maintenance(di prossima stesura)Part 5: Ways to measure the levels of performance and to settle theacceptance, to draw up and to operate contracts for abandoned wasteremoval(da mettere allo studio in futuro)Part 6: Ways to measure the levels of performance and to settle theacceptance, to draw up and to operate contracts for street pit cleaning(da mettere allo studio in futuro)Part 7: Ways to measure the levels of performance and to settle theacceptance, to draw up and to operate contracts for graffiti removal ser-vices(da mettere allo studio in futuro)Part 8: Ways to measure the levels of performance and to settle theacceptance, to draw up and to operate contracts for pneumatic wastecollection(da mettere allo studio in futuro)This European Standard specifies a way to identify the various fractionsof municipal waste by a set of visual elements, including colours,symbols, text, etc.This standard is intended to create a unique operative model to easilyidentify the waste from visual elements thereby facilitating collection andrecycling services for both consumers and collectors.(allo studio)
I PROGETTI INNOVATIVI ALLO STUDIO PRESSO IL CEN/TC 183 (aggiornamento ottobre 2010)
Gestione
deirifiutidossier
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
33U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Gestione
deirifiutidossier
ni tecniche ritenute migliori, ed applicabilisenza grandi aggravi di costo, che si voglionoproporre come standard per la normativa manmano che viene completata ed estesa a tuttele famiglie di prodotti.Nel mondo delle industrie italiane, in genera-le, la normativa tecnica è stata spesso consi-derata come un vincolo aggiuntivo, un lacciocostrittivo che si aggiunge a tutti gli altri ed al-le richieste e prescrizioni già imposte da leg-gi e decreti più o meno necessari.E così noi, spesso (per fortuna non sempre) ciinteressiamo alle norme solo dopo che sonostate già approvate, adeguandoci lentamente,quasi contro voglia, come se il nuovo requisi-to normativo aggiuntivo non fosse compensa-to da nulla (nessun vantaggio né tecnico nécommerciale, solo costi…)Con il lavoro nel TC 183 ho invece scoperto ilgrande vantaggio competitivo che ci derivadal vivere la norma durante tutto l‘iter dellasua redazione. Questo ci consente non solo diessere pronti per primi, precedendo la con-correnza, (il che comunque non è cosa da po-co), ma ci permette soprattutto di avere infor-mazioni sulle soluzioni migliori già studiate orealizzate in qualche mercato più all’avan-guardia, inserendole nei nostri prodotti e ri-sparmiando in tal modo una grande quantitàdi tempo e denaro nella fase di sviluppo pro-dotti.Con il tempo, comunque, la norma pian pianosi va affermando anche nei segmenti di mer-cato più ‘lenti’; i clienti si adeguano e spingo-no i fornitori e tutto il settore a fare altrettanto.Ciò tende a diluire il vantaggio competitivoacquisito, ma l’evoluzione continua del mer-cato e dei prodotti pone sempre nuovi obbiet-tivi all’attività della normazione, che non ter-mina mai, perché questi nuovi prodotti, nati dapoco e con poca storia pregressa alle spalle,sono ancora in evoluzione e ciò rende neces-sario un conseguente adeguamento dellanorma.Inoltre, il campo operativo della normativa sista estendendo dal settore di lavoro tradizio-nale dei prodotti, con le loro specifiche co-struttive e prestazionali, ad un settore relati-vamente nuovo: i servizi.La norma inizia in tal modo a standardizzarenon più soltanto il prodotto, ma anche l’appli-cazione e l’utilizzo dello stesso, entrando piùefficacemente a regolare il fine effettivo, il ve-ro scopo a cui è destinato il prodotto : il servi-zio operativo.
FrancescoMondiniSINTERPLAST SpAMembro del GL8 Attrezzature e macchineper la raccolta dei rifiuti della CommissioneTecnica Ambiente UNIe delegato italiano presso il CEN/TC 183
La standardizzazione dei colorie degli elementi visivi per laraccolta differenziata dei rifiuti
Ci sono più tipologie di rifiuto che colori nel-l’arcobaleno.Stabilire i colori per ogni materiale rappre-senta un sogno per ogni “Normatore del ri-fiuto” che si rispetti. Se da un lato apparequanto mai logico ed opportuno standardiz-zare i colori dei rifiuti, dall’altro le abitudinied i localismi impediscono spesso il concre-tizzarsi di una unificazione.Dal 1989 ad oggi il CEN/TC 183 ha normatocontenitori (Waste Container) gruppo WG1,automezzi (Refuse Collection Vehicles RCV)gruppo WG2, dispositivi per l’identificazionee pesatura (Identification Systems and De-termination of the Quantity of Waste) gruppoWG3.Il successo delle norme è assolutamente vi-sibile: la scelta di solo cinque tipi di attacchiper i contenitori contribuisce ogni giorno inEuropa a garantire la sicurezza di persone eoperatori, anche grazie alla compatibilità dicontainer e mezzi di raccolta.Il 7 settembre 2009 durante il meeting WG1meeting in Colonia presso la sede del RAL(ottima occasione per una proposta fulcratasui colori!), la delegazione italiana ha propo-sto di standardizzare a livello CEN gli ele-menti visivi che possano caratterizzare lesingole tipologie di rifiuti urbani oggetto del-la raccolta differenziata. Nasce così il con-cetto di “Waste Visual Elements”.Mi piace ricordare che lo spunto nacque dauna vista al Museo Egizio di Torino nel lugliodello stesso anno.A livello UE ed altresì in tutti i 31 Paesi delCEN, esiste una forte differenza di colori edaspetti estetici per ogni tipologia di rifiuto;esistono norme nazionali, regionali e localimolto diverse fra loro. Molto spesso unapersona che si sposta per lavoro incontra instrada contenitori di colore diverso fra doveabita e dove lavora. Per esempio in Lombar-dia il contenitore della carta è identificatocon il bianco e la plastica con il giallo; inPiemonte è il contrario; ed ancora la carta èblu in Emilia Romagna ed in Catalunya, ma èrossa in Austria.I colori non sono un elemento sufficiente:sembrano tanti, ma i rifiuti sono di più!Non è possibile fare differenze troppo esi-gue, ad esempio con sfumature e toni dellostesso colore: il colore utilizzato per verni-ciare un contenitore in metallo (inox, allumi-nio, ferro zincato a caldo) sarà sempre di-verso dal materiale plastico stampato adiniezione o in rotazionale!Inoltre, nel tempo, i colori virano riducendoprogressivamente la loro intensità in funzio-
ne dei raggi solari.Anche la lingua non è più sufficiente: nellacittà di Brescia che conta circa 200.000 abi-tanti, coesistono 151 razze di uomini conmoltissime lingue diverse.Le immagini possono non essere sufficientiper identificare in modo univoco i materiali,sebbene le tecnologie moderne consentonoelevati livelli di qualità di stampa.Altri fattori quali la pericolosità o la fon-te/origine di provenienza dei rifiuti generanola necessità di dare chiare ed univoche in-formazioni agli utenti/cittadini/studenti.L’uso di pittogrammi consente di usare sup-porti in bianco e nero e permette di stilizzarel’aspetto grafico; il difetto consiste nella dif-ficoltà di cogliere immediatamente il “bucogiusto”.A peggiorare la situazione, entrano in giocole raccolte multi-materiali: Vetro + Alluminio;Plastica + Metalli; Vetro + Plastica + Allumi-nio. O ancora tutti i materiali riciclabili in ununico contenitore.Un altro caso è la raccolta dello stesso ma-teriale ma suddiviso per colore (ad esempioVetro verde, bianco e marrone) ovvero RAEE(diviso in 5 categorie).Si ritiene quindi necessaria una standardiz-zazione che consenta una progressiva for-mazione scolastica e porti, nel tempo, acreare “elementi visivi caratteristici” che di-venteranno ovvi e naturali.Le sagome dei cartelli stradali STOP e DIVIE-TO DI SOSTA sono subito riconoscibili anchesenza colori e scritte. Come si va a “Scuolaguida” così si potrà andare a “Scuola di eco-logia”!
Per poter stampare libri di testo per le scuo-le è necessario unificare gli “elementi visivicaratteristici” per ogni materiale che vieneraccolto in modo differenziato.L’attività seguita alla proposta italiana a Co-lonia del 7 settembre 2009 ha visto una Ana-lisi di Mercato nell’area CEN al fine di cono-scere l’attuale situazione di abbinamento framateriali e colori/simboli/scritte. La ricercaha avuto l’obiettivo di acquisire standard na-zionali e regionali esistenti. L’analisi di mer-cato è stata sintetizzata in una “Tabella Ar-lecchino” comprendente colori e denomina-zioni assai eterogenei e contradditori. Daqui emerse una chiara indicazione: qualsi-voglia standardizzazione avrebbe generatomolti scontenti quantomeno iniziali!
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
34 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Gestione
deirifiutidossier
Il 28 settembre 2010 durante un meeting delWG1 la delegazione italiana ha presentato aMilano la prima Proposta di norma “WASTEVISUAL ELEMENTS” contenente un’innova-tiva e strutturata soluzione con indicazionedegli “elementi visivi caratteristici” di ognifrazione di rifiuto urbano oggetto di raccoltadifferenziata e soprattutto con i criteri di ba-se finalizzati ad una adesione giustificata econsapevole da parte di oltre 500 milioni diabitanti. La proposta è stata approvata all’u-nanimità consentendo il successivo passag-gio al meeting CEN TC/183 di novembre inOlanda per l’avvio formale della standardiz-zazione.La logica introdotta nella proposta di normasi basa su alcuni criteri fondamentali:• colori riservati per la creazione del pannel-lo e per la identificazione immediata diogni forma di pericolo;
• colori definiti con precisione per alcunefrazioni merceologiche che coprono circail 75% in peso dei materiali;
• concetto del Materiale Prevalente in volu-me all’interno di un contenitore;
• pannelli standard conuna parte obbligatoria edun’area libera;• elementi grafici obbliga-tori quali cornici, geome-trie e posizioni da rispetta-re;• varie tipologie di ele-menti visivi che coesisto-no su un pannello indica-tore: colori, testi, logo-grammi, simboli;• utilizzo di QR code perdiffondere facilmente leinformazioni e del corretto
Simbolo di Mobius.Si prevede che la standardizzazione porterà inbreve tempo ad un incremento della raccoltadifferenziata grazie al facile ed immediato rico-noscimento dei materiali. Altresì la progressi-va formazione continua ed omogenea dellepersone - a partire dagli studenti - porterà aduna abitudine ecologica nel medio periodo.Sono ovvie, inoltre, le motivazioni di caratte-re economico/commerciale che derivano dauna riduzione di scorte ed da una produzio-ne più standard. Il beneficio ricadrà in mododiffuso sia sui gestori del servizio di raccoltache sui comuni e quindi sui cittadini.La raccolta differenziata di successo è ba-sata su conoscenze diffuse ed omogenee epuò, anche grazie alle norme tecniche, di-ventare dovunque un’azione normale!
Giovanni BragadinaID&A srlMembro del GL8 Attrezzature e macchineper la raccolta dei rifiuti della CommissioneTecnica Ambiente UNI e delegato italianopresso il CEN/TC 183
La gestione del ciclo integrato dei rifiuti è un insieme complessod’attività che, oggi più che mai, presuppone strutture e organizzazio-ne di tipo industriale, e quindi normative chiare e standardizzazioni etipizzazioni universalmente riconosciute.A maggior ragione oggi, in un quadro di liberalizzazione del settoreche vedrà a breve il confronto concorrenziale per la gestione delciclo dei rifiuti.Gli obiettivi di standardizzazione risulteranno pertanto importanti
per garantire che questo confronto avvenga in un sistema di regole e modelli certi.In un settore che sempre più tende a costruire e irrobustire un moderno sistema industriale, eco-nomicamente forte e tecnologicamente aggiornato allo stato dell’arte, gli aspetti normativi, giàoggi fondamentali, tenderanno ad assumere un ruolo sempre più centrale.Daniele Fortini - Presidente Federambiente
FEDERAMBIENTE LA POSIZIONE ITALIANA SUI LIVELLI DI PRESTAZIONE DE
Qui di seguito pubblichiamo, a beneficio dei lettoridel presente dossier, esclusivamente a titolo esem-plificativo, uno dei contributi presentati dalla dele-gazione italiana nell’ambito dei lavori del CEN/TC183. Si tratta di un contributo realizzato da HERAche ha proposto l’inserimento di un’apposita ap-pendice alla parte 2 della norma sui servizi di igieneurbana allo studio, nello specifico alla parte relativaai livelli di servizio di raccolta rifiuti. Tale appendicepropone, proprio in relazione agli indicatori sui livel-li di prestazione e sugli standard di qualità dei servi-zi ambientali, di mettere in relazione, per ogni fra-zione merceologica del rifiuto considerato e fissatoun obiettivo percentuale di raccolta differenziata, latipologia di area territoriale omogenea in cui vieneeffettuata la raccolta (in modo da distinguere peresempio tra grandi centri urbani e piccoli centri ru-rali) e la tipologia di sistema di raccolta adottato oprescelto (stradale con contenitori statici o carrel-lati di diversa volumetria, di prossimità con piccolicontenitori e sacchi).Tale contributo è attualmente in discussione e per-tanto deve essere letto esclusivamente come unapossibile esemplificazione del lavoro in corso. Si rin-grazia HERA e tutti gli altri membri della delegazioneitaliana al CEN/TC183 per la cortese disponibilità.Proposta di Appendice sui livelli di servizio e diqualitàValori di riferimento per le principali frazioni mer-ceologiche/tipologie di rifiuto e correlazione con la% di Raccolta Differenziata, l’area territoriale omo-genea ed il sistema di raccolta implementatoLa fase di analisi e progettazione dei servizi am-bientali, in particolare di quelli di gestione dei rifiutiurbani, finalizzata alla loro implementazione opera-tiva, è di norma composta, in estrema sintesi, da:1. un’analisi delle informazioni relative al contestoterritoriale (distribuzione popolazione, morfologiadel territorio, vincoli paesaggistici ed urbanistici,ecc.);
2. un’analisi dei dati relativi al flusso dei rifiuti pro-dotti (totale e per filiera) nell’area considerata;
3. un’analisi del numero e tipologia delle utenzepresenti (domestiche e non domestiche, loro dis-tribuzione, eventuali variazioni stagionali, ecc.);
4. un’analisi dei servizi erogati o erogabili (a livellotecnico ed economico – produttività attesa, com-patibilità dei sistemi di raccolta con il territorio,parametri di costo elementari/di sistema/di strut-tura relativi all’area considerata, ecc.);
5. una definizione delle strategie di raccolta in fun-zione:a. del modello territoriale ed organizzativo;b. delle produzioni attese per filiera/territorio/u-
tenza;c. degli obiettivi di raccolta separata che si vo-gliono perseguire;
d. della disponibilità e copertura impiantistica;e. della sostenibilità economica, sociale ed am-
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
35U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Gestione
deirifiutidossier
EI SERVIZI DI IGIENE URBANA. IL CONTRIBUTO DI HERA SPA
bientale dei modelli e sistemi implementati.Il processo è quindi molto complesso e risente diuna molteplicità di variabili esogene ed endogene,spesso rilevanti e addirittura vincolanti, che si in-seriscono ed agiscono al suo interno come al con-torno.Considerato quanto sopra esposto, è chiaro come,anche i parametri e gli indicatori relativi ai livelli diservizio ed agli standard di qualità, risentano di talivariabili, modelli, strategie di sistema.Per dare evidenza di ciò, si vedano i grafici qui ri-portati, che solo a livello qualitativo evidenzianocome, ad esempio, alcuni indicatori relativi ai livellidi servizio ed agli standard di qualità, e di conse-guenza i parametri di costo relativo (in questo ca-so,€/t), siano dipendenti:1. dalla frazione merceologica del rifiuto conside-rato;
2. dagli obiettivi di raccolta separata che si voglio-no perseguire.
I grafici stessi evidenziano anche come alcuni indi-catori del livello di servizio e standard di qualità, infunzione degli obiettivi di raccolta separata che ci siprefigge, vadano correttamente seguiti e progetta-ti/ri-programmati pena lamancata sostenibilità eco-nomica e sociale nell’implementazione di un servi-zio. Una scarsa attenzione nella gestione di tali pro-cessi porterebbe infatti ad un aumento non sosteni-bile degli oneri economici e sociali se i livelli di ser-vizio ed alcuni standard di qualità non venisseroadeguatamente rivisitati verso “il basso” o verso“l’alto” all’aumentare della% di raccolta separata.E’ quindi chiaro che i valori presenti nel testo (delprogetto di norma allo studio, ndr) possano fornire
solo indicazioni e valori di primo riferimento, i qualidebbano poi essere “tradotti” ed eventualmente ri-modulati in relazione al contesto territoriale, alle va-riabili collegate, ai modelli ed alle strategie di siste-
ma implementabili o implementate.Per questo, al fine di:• indicare a livello europeo dei valori normati ecollegati ai livelli di servizio ed agli standard di
FILIERA: Indifferenziato SISTEMADI RACCOLTA
% RD: 0 % Raccolta con contenitori statici Raccolta stradale con contenitori Raccolta di prossimità con piccoli
FREQUENZA [g/g] elevata volumetria (> 2 m3) carrellati media volumetria (< 2 m3) contenitori (< 30 l.) e sacchi
Area metropolitana '6/7-'7/7 '6/7-'7/7 '3/7-6/7
Area urbana '3/7-6/7 '3/7-6/7 '2/7-3/7
Area extra-urbana '2/7-3/7 '2/7-3/7 '1/7-2/7
AREA
OMOG
ENEA
FILIERA: Indifferenziato SISTEMADI RACCOLTA
% RD: 30-35 % Raccolta con contenitori statici Raccolta stradale con contenitori Raccolta di prossimità con piccoli
FREQUENZA [g/g] elevata volumetria (> 2 m3) carrellati media volumetria (< 2 m3) contenitori (< 30 l.) e sacchi
Area metropolitana 3/7-6/7 3/7-6/7 2/7-3/7
Area urbana 2/7-3/7 3/7-6/7 2/7-3/7
Area extra-urbana 1/7-2/7 1/7-2/7 1/7-2/7
AREA
OMOG
ENEA
FILIERA: Indifferenziato SISTEMADI RACCOLTA
% RD: 60-65 % Raccolta con contenitori statici Raccolta stradale con contenitori Raccolta di prossimità con piccoli
FREQUENZA [g/g] elevata volumetria (> 2 m3) carrellati media volumetria (< 2 m3) contenitori (< 30 l.) e sacchi
Area metropolitana 2/7-3/7 2/7-3/7 1/7-2/7
Area urbana 1/7-2/7 1/7-2/7 1/7-2/7
Area extra-urbana 1/7 1/7 1/7
AREA
OMOG
ENEA
FILIERA: Organico SISTEMADI RACCOLTA
% RD: 30-35 % Raccolta stradale con contenitori Raccolta stradale con contenitori Raccolta di prossimità con piccoli
FREQUENZA [g/g] media volumetria (1-2 m3) carrellati media volumetria (< 2 m3) contenitori (< 30 l.) e sacchi
Area metropolitana 2/7-3/7 2/7-3/7 2/7-3/7
Area urbana 1/7-2/7 1/7-2/7 1/7-2/7
Area extra-urbana 1/7-2/7 1/7-2/7 1/7-2/7
AREA
OMOG
ENEA
FILIERA: Organico SISTEMADI RACCOLTA
% RD: 60-65 % Raccolta stradale con contenitori Raccolta stradale con contenitori Raccolta di prossimità con piccoli
FREQUENZA [g/g] media volumetria (1-2 m3) carrellati media volumetria (< 2 m3) contenitori (< 30 l.) e sacchi
Area metropolitana 2/7-3/7 2/7-3/7 2/7-3/7
Area urbana 1/7-2/7 1/7-2/7 1/7-2/7
Area extra-urbana 1/7-2/7 1/7-2/7 1/7-2/7
AREA
OMOG
ENEA
FILIERA: Riciclabili (Carta, Plastica, Vetro) SISTEMADI RACCOLTA
% RD: 30-35 % Raccolta stradale con contenitori Raccolta stradale con contenitori Raccolta di prossimità con piccoli
FREQUENZA [g/g] media volumetria (1-2 m3) carrellati media volumetria (< 2 m3) contenitori (< 30 l.) e sacchi
Area metropolitana 1/7-2/7 1/7-3/7 1/7
Area urbana 1/7-2/7 1/7-2/7 1/14-1/7
Area extra-urbana 1/14-1/7 1/14-1/7 1/14-1/7
AREA
OMOG
ENEA
FILIERA: Riciclabili (Carta, Plastica, Vetro) SISTEMADI RACCOLTA
% RD: 60-65 % Raccolta stradale con contenitori Raccolta stradale con contenitori Raccolta di prossimità con piccoli
FREQUENZA [g/g] media volumetria (1-2 m3) carrellati media volumetria (< 2 m3) contenitori (< 30 l.) e sacchi
Area metropolitana 1/7-3/7 1/7-3/7 1/7-2/7
Area urbana 1/7-2/7 1/7-2/7 1/14-1/7
Area extra-urbana 1/14-1/7 1/14-1/7 1/14-1/7
AREA
OMOG
ENEA
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
qualità, a supporto diuna analisi e proget-tazione di massimadei modelli di raccol-ta territoriale e chepossano essere “tra-dotti”/rimodulati inrelazione al contestoterritoriale ed alle va-riabili collegate allagestione dei rifiuti;• rendere possibile l’i-dentificazione, perogni soggetto interes-sato, del proprio posi-zionamento rispetto atali valori di riferimen-to ed attivare una au-toregolamentazione alivello europeo;• identificare dei li-velli di servizio estandard di qualitàche siano in primabattuta “giustificabi-li” in termini di effi-cacia/efficienza/e-conomicità o megliosposabili ad obiettividi sistema sostenibili(dal punto di vistasociale, ambientale,economico);
• indirizzare gli Stati Membri verso modelli e para-metri collegati ai sistemi di raccolta che sianosostenibili dal punto di vista sociale/ambien-tale/economico;
• garantire comunque servizi che salvaguardino
36 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Gestione
deirifiutidossier
FILIERA: Indifferenziato SISTEMADI RACCOLTA
% RD: 0 % Raccolta con contenitori statici Raccolta stradale con contenitori
Bacino d’utenza [ab./cont] elevata volumetria (> 2 m3) carrellati media volumetria (< 2 m3)
Area metropolitana 50-80 30-50
Area urbana 35-50 25-40
Area extra-urbana 25-40 20-35
AREA
OMOG
ENEA
FILIERA: Indifferenziato PRODUTTIVITA' [kg/ora_addetto]
SISTEMADI RACCOLTARaccolta con contenitori Raccolta stradale Raccolta di prossimità
statici elevata con contenitori carrellati con piccoli contenitorivolumetria (> 2 m3) media volumetria (< 2 m3) (< 30 l.) e sacchi
1700-2000 600-800 250-400
FILIERA: Riciclabili (Carta, Plastica, Vetro) Produttività [kg/ora_addetto]
SISTEMADI RACCOLTARaccolta con contenitori Raccolta stradale Raccolta di prossimità
statici elevata con contenitori carrellati con piccoli contenitorivolumetria (> 2 m3) media volumetria (< 2 m3) (< 30 l.) e sacchi
carta 800-1.200 500-700 250-400
plastica 300-500 200-300 100-150
vetro 1500-2000 800-1300 300-500
FILIERA: Organico PRODUTTIVITA' [kg/ora_addetto]
SISTEMADI RACCOLTARaccolta con contenitori Raccolta stradale con Raccolta di prossimità
carrellati media contenitori carrellati bassa con piccoli contenitorivolumetria (1-2 m3) volumetria (120-1.000 l.) (< 30 l.) e sacchi
900-1.200 300-500 150-300
FILIERA: Indifferenziato SISTEMADI RACCOLTA
% RD: 30-35 % Raccolta con contenitori statici Raccolta stradale con contenitori
Bacino d’utenza [ab./cont] elevata volumetria (> 2 m3) carrellati media volumetria (< 2 m3)
Area metropolitana 65-100 40-65
Area urbana 45-65 30-50
Area extra-urbana 30-50 25-45
AREA
OMOG
ENEA
FILIERA: Indifferenziato SISTEMADI RACCOLTA
% RD: 60-65 % Raccolta con contenitori statici Raccolta stradale con contenitori
Bacino d’utenza [ab./cont] elevata volumetria (> 2 m3) carrellati media volumetria (< 2 m3)
Area metropolitana 80-120 50-80
Area urbana 55-80 40-65
Area extra-urbana 40-65 30-55
AREA
OMOG
ENEA
FILIERA: Organico SISTEMADI RACCOLTA
% RD: 30-35 % Raccolta con contenitori statici Raccolta stradale con contenitori
Bacino d’utenza [ab./cont] elevata volumetria (> 2 m3) carrellati media volumetria (< 2 m3)
Area metropolitana 150-200 100-150
Area urbana 120-150 80-120
Area extra-urbana n.d. n.d.
AREA
OMOG
ENEA
FILIERA: Organico SISTEMADI RACCOLTA
% RD: 60-65 % Raccolta con contenitori statici Raccolta stradale con contenitori
Bacino d’utenza [ab./cont] elevata volumetria (> 2 m3) carrellati media volumetria (< 2 m3)
Area metropolitana 120-150 80-120
Area urbana 100-120 60-100
Area extra-urbana n.d. n.d.
AREA
OMOG
ENEA
FILIERA: Riciclabili (Carta, Plastica, Vetro) SISTEMADI RACCOLTA
% RD: 30-35 % Raccolta con contenitori statici Raccolta stradale con contenitori
Bacino d’utenza [ab./cont] elevata volumetria (> 2 m3) carrellati media volumetria (< 2 m3)
Area metropolitana 200-300 150-250
Area urbana 150-250 100-200
Area extra-urbana 80-150 60-120
AREA
OMOG
ENEA
FILIERA: Riciclabili (Carta, Plastica, Vetro) SISTEMADI RACCOLTA
% RD: 60-65 % Raccolta con contenitori statici Raccolta stradale con contenitori
Bacino d’utenza [ab./cont] elevata volumetria (> 2 m3) carrellati media volumetria (< 2 m3)
Area metropolitana 100-150 80-120
Area urbana 80-120 50-100
Area extra-urbana 40-80 30-60
AREA
OMOG
ENEA
l’igiene, la salubrità e la sicurezza dei cittadini;qui di seguito si allegano una serie di griglie valo-riali costruite per (dati di “input”):1. tipologia di rifiuto/frazione merceologica;2. obiettivo % di raccolta separata;e che contemplino una ripartizione per aree omo-genee di diversa densità abitativa quali:1. Area metropolitana (grandi centri urbani e me-tropoli ad elevata densità abitativa);
2. Area urbana (centri urbani media densità abita-tiva);
3. Area extra-urbana (zone periferiche a densitàabitativa medio/bassa o bassa);
e per tipologia di sistema adottato o prescelto:1. Raccolta con contenitori statici elevata volume-
tria (> 2 m3);2. Raccolta stradale con contenitori carrellati me-dia volumetria (< 2 m3);
3. Raccolta di prossimità con piccoli contenitori(< 30 l.) e sacchi..
Tali griglie sono costruite per alcuni indicatori dellivello di servizio e standard di qualità, ed i livellivaloriali in esse contenute sono da interpretaresecondo le seguenti modalità:• Il range di riferimento indicato in ogni cella iden-tifica, nel valore più basso, un livello di bassa in-tensità/standard e, nel valore più alto, di alta in-tensità/standard;
• Il valore mediano compreso al loro interno puòessere considerato come il valore normalizzatoe di riferimento.
In relazione ai livelli di servizio e nello specificoanche sull’indicatore correlato alla produttività disistema, è chiaramente opportuno evidenziare, incongruenza con quanto sopra descritto, livelli va-loriali costruiti per (dati di “input”):1. tipologia di rifiuto/frazione merceologica;2. tipologia di sistema adottato o prescelto.
LEGENDA:Area metropolitana (grandi centri urbani e metropo-
li ad elevata densità abitativa)Area urbana (centri urbani media densità abi-
tativa) Area extra-urbana (zone periferiche a densità abi-
tativa medio/bassa o bassa)
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
37U&C n.10 novembre/dicembre 2010
recupero agevolato dei rifiuti pericolosi exDlgs 22/1997” DM 3 agosto 2005 “Definizio-ne dei criteri di ammissibilità dei rifiuti indiscarica”. In particolare, la norma UNI EN 14899:2005,definisce come requisito obbligatorio, quel-lo di redigere un piano di campionamentoper soddisfare l'obiettivo del programma diprova. Tale norma specifica i passi proce-durali da intraprendere nella preparazione eapplicazione di un piano di campionamentoche descriva il metodo di raccolta del cam-pione. La norma UNI 10802: 2004, che è sta-ta redatta in Italia, definisce le istruzionitecniche necessarie per condurre a termineun piano di campionamento.La norma UNI EN 14899 può essere utilizza-ta per:• produrre piani di campionamento da utiliz-zare in circostanze regolari o sistematiche(ovvero elaborazione di norme seconda-rie/derivate dedicate a scenari di campio-namento ben definiti);
• incorporare i requisiti di campionamentospecifici nella legislazione nazionale;
• progettare e sviluppare un piano di cam-pionamento da utilizzare caso per caso.
Lo sviluppo di un piano di campionamentonell'ambito di questo quadro di riferimentorichiede di procedere attraverso tre fasi oattività:1. definizione del piano di campionamento;2. prelievo di un campione in campo in con-formità al piano di campionamento;
3. trasporto del campione in laboratorio.Nel processo di definizione del piano dicampionamento l'obiettivo del programmadi prova è tradotto in istruzioni tecnichespecifiche e concrete per il tecnico che de-ve eseguire il campionamento stesso. Utiliz-zando queste istruzioni, il tecnico preleva iltipo e il numero di campioni adeguato asoddisfare l'obiettivo del programma di pro-va, potendo fornire così, al responsabile de-cisionale, tutte le informazioni richieste sul-la caratterizzazione dei rifiuti oggetto di in-dagine. Il processo di definizione del pianodi campionamento costituisce pertanto unafase fondamentale nel campionamento deirifiuti. Il gruppo di lavoro WG 1 del CEN/TC292 sul-la caratterizzazione dei rifiuti, ha prodotto,nel 2006, cinque nuovi Rapporti Tecnici(CEN/TR15310-1/5) che hanno aggiornato e,in alcuni casi, modificato radicalmente l’im-postazione delle precedenti tecniche dicampionamento.I rapporti tecnici sono i seguenti:• TR15310-1 Characterization of waste -Sampling of waste materials - Part 1: Gui-dance on selection and application of crite-ria for sampling under various conditions;
Revisione della norma UNI10802 alla luce dei nuovirapporti tecnici prodottidal CEN
L’UNI con il gruppo di lavoro GL5 “Suolo erifiuti” della Commissione Ambiente ha vo-luto recepire le elaborazioni innovative con-tenute nei rapporti tecnici prodotti nel 2006dal CEN, rinnovando completamente la nor-ma UNI 10802.I rifiuti sono generalmente di natura etero-genea e, per poter prendere decisioni infor-mate sul loro trattamento, recupero o smal-timento è necessario condurre una caratte-rizzazione di base dei rifiuti e fare un pro-gramma di prova in cui stabilire la quantitàdi materiale da prelevare su cui definire lecaratteristiche di interesse. In appoggio alla Direttiva sulle discariche, ilCEN mediante il Comitato Tecnico TC 292,ha suddiviso in tre categorie le prove per lacaratterizzazione dei rifiuti solidi al fine distandardizzarne la metodologia. Le tre cate-gorie individuate sono: 1. Prove di "caratterizzazione di base" dei ri-fiuti che danno informazioni sul compor-tamento alla lisciviazione a lungo terminee sulle proprietà tipiche dei rifiuti stessi.In questo tipo di prove vengono valutatiprincipalmente parametri chimico-fisici .
2. Prove di "conformità" caratterizzate dauna facile e veloce esecuzione tecnica edestinate a determinare se il rifiuto è con-forme allo specifico comportamento pre-visto dalla caratterizzazione di base o avalori di riferimento quali quelli normativi.
3. Prove di "verifica sul campo", ovvero pro-ve veloci per confermare la congruenzadel rifiuto con il campione sottoposto aprove di conformità.
Generalmente per poter eseguire prove dicaratterizzazione dei rifiuti è richiesto pre-cedentemente un campionamento dei rifiutida analizzare. Per poter consentire un cam-pionamento significativo e armonizzarlo a li-vello europeo, il CEN ha definito la normaUNI EN 14899:2005 “Caratterizzazione dei ri-fiuti. Campionamento dei rifiuti. Schemaquadro di riferimento per la preparazione el'applicazione di un piano di campionamen-to”. In Italia, a partire dal 1999 e poi attraver-so successive revisioni fino all’attuale ver-sione del 2004, era stata già prodotta la nor-ma UNI 10802 “Rifiuti. Rifiuti liquidi, granula-ri, pastosi e fanghi. Campionamento manua-le e preparazione ed analisi degli eluati”. Questa norma è citata per il campionamen-to e l’analisi dei rifiuti nei Decreti del Mini-stero dell’Ambiente: DM 5 febbraio 1998“Recupero rifiuti non pericolosi”, DM 12giugno 2002, n. 161 “Norme tecniche per il
Gestione dei rifiutidossier
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
38 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Gestione dei rifiutidossier
Gestione dei rifiutidossier
Le norme citate dal D.M. 3 agosto 2005UNI 10802 Rifiuti - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluatiUNI EN 12506 Caratterizzazione dei rifiuti - Analisi degli eluati - Determinazione di pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, Cr(VI), Cu, Mo, Ni, NO2
- , Pb, S totale, SO4--,
V e ZnUNI EN 13370 Caratterizzazione dei rifiuti - Analisi degli eluati – Determinazione di ammonio, AOX, conducibilità, Hg, indice fenolo, TOC, CN- facilmente
liberabile, F-UNI EN 12457 Caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi.
Parte 1: Prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 2 l/kg, per materiali con elevato contenuto di solidi e con particelle didimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni).Parte 2: Prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con osenza riduzione delle dimensioni).Parte 3: Prova a doppio stadio, con rapporti liquido/solido di 2 l/kg e 8 l/kg, per materiali con elevato contenuto di solidi e con particelle didimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni).Parte 4: Prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 10 mm (con osenza riduzione delle dimensioni).Altre norme citate dalla decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE
UNI EN 13137 Caratterizzazione dei rifiuti - Determinazione del carbonio organico totale (TOC) in rifiuti, fanghi e sedimentiUNI EN 13656 Caratterizzazione dei rifiuti - Digestione assistita a microonde con una miscela di acido fluoridrico (HF), acido nitrico (HNO3) e acido clo-
ridrico (HCl) per la successiva determinazione degli elementi contenuti nei rifiutiUNI EN 13657 Caratterizzazione dei rifiuti - Digestione per la successiva determinazione della porzione solubile in acqua regia degli elementi contenuti
nei rifiutiUNI EN 14039 Caratterizzazione dei rifiuti - Determinazione del contenuto di idrocarburi nell'intervallo compreso tra C10 e C40 mediante gascromato-
grafiaUNI CEN/TS 14405 Caratterizzazione dei rifiuti - Prove di comportamento alla lisciviazione - Prova di percolazione a flusso ascendente (nelle condizioni spe-
cificate)UNI EN 14346 Caratterizzazione dei rifiuti - Calcolo della sostanza secca mediante determinazione del residuo secco o del contenuto di umidità
Ulteriori norme elaborate dal Comitato Tecnico CEN/TC 292UNI EN 12920 Caratterizzazione dei rifiuti - Metodologia per la determinazione del comportamento alla lisciviazione dei rifiuti in condizioni specificateUNI EN 14345 Caratterizzazione dei rifiuti - Determinazione del contenuto di idrocarburi mediante gravimetriaUNI EN 14735 Caratterizzazione dei rifiuti - Preparazione di campioni di rifiuti per prove ecotossicologicheUNI EN 14899 Caratterizzazione dei rifiuti - Campionamento di rifiuti - Indicazioni per la preparazione e applicazione di un piano di campionamentoUNI EN 15002 Caratterizzazione dei rifiuti - Preparazione di porzioni di prova dal campione di laboratorioUNI CEN/TS 14429 Caratterizzazione dei rifiuti - Prove di comportamento alla lisciviazione - Influenza del PH sulla lisciviazione con aggiunta iniziale di
acido/baseUNI CEN/TS 15364 Caratterizzazione dei rifiuti - Prove di comportamento alla lisciviazione – Prova di capacità di neutralizzazione acida e basicaUNI CEN/TS 15862 (in via di recepimento) Characterization of waste - Compliance leaching test – One stage batch leaching test for monoliths at fixed
liquid to surface area ratio (L/A) for test portions with fixed minimum dimensionsCEN/TR 15310-1 Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 1: Guidance on selection and application of criteria for sampling under
various conditionsCEN/TR 15310-2 Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 2: Guidance on sampling techniquesCEN/TR 15310-3 Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 3: Guidance on procedures for sub-sampling in the fieldCEN/TR 15310-4 Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 4: Guidance on procedures for sample packaging, storage, preservation,
transport and deliveryCEN/TR 15310-5 Characterization of waste - Sampling of waste materials - Part 5: Guidance on the process of defining the sampling plan
Altri progetti allo studio presso il Comitato Tecnico CEN/TC 292FprCEN/TR 16110 Characterization of waste - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to wasteprEN 15875 Characterization of waste - Static test for determination of acid potential of sulfidic wasteFprCEN/TS 15862 Characterization of waste - Compliance leaching test - One stage batch leaching test for monoliths at fixed liquid to surface area ratio
(L/A) for test portions with fixed minimum dimensionsFprCEN/TS 15863 Characterisation of waste - Leaching behaviour test for basic characterisation - Dynamic Monolithic Leaching Test with periodic leachant
renewal, under fixed test conditionsFprCEN/TS 15864 Characterisation of waste - Leaching behaviour test for basic characterisation - Dynamic Monolithic Leaching Test with continuous lea-
chant renewal under conditions relevant for specified scenario(s)FprCEN/TR 16176 Characterization of waste - Screening methods for elemental composition by X-ray fluorescence spectrometry for on-site verificationFprCEN/TR 16130 Characterization of waste - On-site verificationprEN 16123 Characterization of waste - Guidance on selection and application of screening methodsFprCEN/TS 16229 Characterization of waste - Sampling and Analysis of weak acid dissociable cyanide discharged into tailings pondsprEN 16023 Characterization of waste - Determination of calorific valueFprCEN/TR 16184 Characterization of waste - State-of-the-art document - Analysis of eluates
LE NORME UNI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
39U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Gestione dei rifiutidossier
• TR15310-2 Characterization of waste -Sampling of waste materials - Part 2: Gui-dance on sampling techniques;
• TR15310-3 Characterization of waste -Sampling of waste materials - Part 3: Gui-dance on procedures for sub-sampling inthe field;
• TR15310-4 Characterization of waste -Sampling of waste materials - Part 4: Gui-dance on procedures for sample packa-ging, storage, preservation, transport anddelivery;
• TR15310-5 Characterization of waste -Sampling of waste materials - Part 5: Gui-dance on the process of defining the sam-pling plan.
Il gruppo di lavoro 5 “Suolo e rifiuti” dellaCommissione Ambiente dell’UNI ha volutorecepire le elaborazioni innovative contenu-te in questi rapporti tecnici, rinnovandocompletamente la norma UNI 10802. E’ ini-ziato quindi un lavoro di revisione della nor-ma tramite il lavoro di un gruppo ristrettoche ha studiato approfonditamente i Rap-porti Tecnici sopracitati e producendo unaproposta di inglobamento di questi all’inter-no della norma.E’ stato deciso di inserire nella norma alcu-ne delle informazioni contenute nei rapportiTR15310 dalla Parte 3 alla 5, lasciando comerapporto tecnico a parte solo il primo, tra-dotto in italiano, dove sono sviluppati tutti ipiù attuali metodi statistici per il calcolo delnumero dei campioni da prelevare e le tipo-logie di campionamento da seguire. Il Rap-porto TR15310-2 è stato inserito solo margi-nalmente in quanto nella norma UNI 10802le tecniche utilizzate per il campionamentoerano già state esaurientemente trattate ecorredate da illustrazioni e da schede parti-colarmente chiarificatrici.La revisione della nuova UNI 10802 è giuntaalla fine della procedura di approvazionenell’ambito del GL5 e dovrebbe essere pubbli-cata al più presto dopo l’inchiesta pubblica.
Stefania Balzamo ISPRA - Istituto Superiore per la Protezionee Ricerca AmbientaleCoordinatrice del GL5 Suolo e rifiuti dellaCommissione Tecnica Ambiente UNI
Una norma nazionaleper la gestione dei veicolifuori uso
Da anni la Comunità Europea è alle presecon la gestione dei rifiuti prodotti nei nostriPaesi. Dopo lunga esperienza e diverse revi-sioni si è arrivati a una definizione chiara delpercorso. Queste sono le priorità, in ordine
decrescente d’importanza: • riduzione dei rifiuti prodotti (in termini qua-litativi e quantitativi),
• riutilizzo replicato dei materiali, compo-nenti, macchinari ed altro,
• riciclo ovvero l’utilizzo di vecchi materialiper fare nuovi prodotti,
• recupero almeno dell’energia contenutanel rifiuti
• e, solo come estrema istanza, la posa,inertizzato e in condizioni di sicurezza, delrifiuto residuo in discarica.
Con giusto zelo, si sono posti degli obiettivida raggiungere ad un tempo determinato. Itraguardi quantitativi attuali sono da rag-giungere entro il 2020.A questo livello sommario, la normativa eu-ropea si può considerare recepita (anche senon sempre attuata) dal nostro Paese1.I rifiuti prodotti debbono essere registrati,inviati mediante vettori autorizzati a impiantiautorizzati al trattamento. Le operazioni re-gistrate sono soggette ad una rendiconta-zione annuale (MUD). Ora, poi, siamo nellafase di trasferimento delle registrazioni a unsistema automatizzato (SISTRI2). Tutto è or-ganizzato perché il rifiuto possa essere ge-stito in modo trasparente, tracciabile e il cit-tadino possa sapere dove finiscono i rifiutipericolosi e come siamo in grado di recupe-rare i materiali di rifiuto. Non solo di materiali si tratta ma anche dicomponenti, apparecchiature, macchine edaltro. I veicoli fuori uso costituiscono una catego-ria di rifiuti da trattare con un capitolo a par-te per varie ragioni. Le macchine e i veicolihanno delle logiche diverse rispetto ai mate-riali di rifiuti; logiche spesso simili a quelleche si ritrovano nelle filiere delle apparec-
chiature elettriche ed elettroniche.Limitandoci ad esempi: le apparecchiaturepossono essere riparate; spesso chi riparadecide, di fatto, il passaggio a rifiuto e puòseparare dei componenti (che non diventa-no rifiuti); molte apparecchiature vannomesse in sicurezza (allontanamento dei ma-teriali pericolosi) prima di essere ulterior-mente trattate. Persino la distinzione tra ri-fiuti pericolosi, e non, ha delle forti peculia-rità.La policy comunitaria affronta la questione a360 gradi. Non solo si prevede una gestioneambientalmente compatibile del rifiuto e unaminore presenza di sostanze pericolose. Sipersegue anche l’obiettivo ambizioso di in-fluenzare le logiche di progettazione deinuovi veicoli in modo che gli stessi siano co-struiti con più materiali riciclati, parti e ma-teriali meno pericolosi e che i veicoli risulti-no più efficienti ed efficaci. Non si dimenti-chi, anche, che molti dei mezzi di trasportohanno particolari obblighi burocratici (sonoiscritti al PRA). Per farla breve, queste scel-te, mettono pressione e incidono in modoparticolare sulle plastiche. I pezzi in plasticasaranno riconoscibili, più semplici nella for-mulazione pur senza limitarne la presenzanel veicolo. Andando al cuore della normativa, si sonofissati obiettivi cogenti di riciclaggio del vei-colo, si sono poste limitazioni nell’uso di so-stanze pericolose nella produzione di nuovicomponenti. Si è incentivato il riutilizzo dimateriali riciclati fissando obiettivi miniminell’omologazione di veicoli nuovi. Non si ètrascurato di ridurre l’impatto delle impresepartecipanti alla filiera del trattamento (au-todemolitori, frantumatori, fonderie di se-conda fusione ed altro).
Nel corso degli ultimi 10 anni la legislazione sui rifiuti ha subito note-voli cambiamenti ognuno dei quali ha comportato necessariamentela disponibilità di norme in grado di valutare il rispetto o meno delleleggi. Sia a livello comunitario attraverso i vari comitati tecnici CENquali i TC 292 , TC 308, TC 183, PC 366 che a livello nazionale attraver-so il GL5, GL8, GL13, GL14 della Commissione UNI “Ambiente”, l’atti-vità di normazione svolta negli ultimi anni è stata notevole permet-tendo a tutti gli operatori del settore di disporre di strumenti utili per
la valutazione dei processi coinvolti nella gestione dei rifiuti. E’ infatti noto a tutti che senza dellenorme precise che ci indicano come eseguire i controlli chimici e biologici atti a classificare irifiuti o delle norme che stabiliscano come raccogliere e trattare i rifiuti per poter essere avviatiallo smaltimento finale, ci troveremmo in una situazione di completa anarchia. Un grosso lavoroè stato fatto ma molto resta da fare. L’aggiornamento dei metodi di controllo dei rifiuti in funzionedell’evoluzione tecnica delle apparecchiature, la necessità di disporre di nuovi test che possanodefinire meglio la pericolosità e quindi il destino dei rifiuti sono solo alcune delle nuove sfide concui dovremo confrontarci nei prossimi anni.
Luigino Maggi - Presidente Commissione Tecnica Ambiente UNI
COMMISSIONE AMBIENTE UNI
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
40 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Gestione dei rifiutidossier
Qui di seguito pubblichiamo, a beneficio dei lettoridel presente dossier, esclusivamente a titolo infor-mativo, lo stato di avanzamento di un nuovo pro-getto di norma nazionale allo studio nel gruppo dilavoro GL8 “Attrezzature e macchine per la rac-colta dei rifiuti” della Commissione UNI Ambiente.Si tratta della prima concretizzazione di una pro-posta pervenuta all’UNI grazie alle istanze delleaziende di igiene ambientale, a cui sta lavorandoalacremente un gruppo di tecnici di tali aziende,con grande interesse e grande partecipazione peri soggetti del settore.Tale contributo è attualmente in discussione pres-so il GL8 e pertanto deve essere letto esclusiva-mente come una informativa sul lavoro in corso. Siringraziano il relatore del progetto e tutti i parteci-panti per la cortese disponibilità.Sintesi del progetto di norma allo studio – provvi-sorio in attesa di definizione Titolo - Indici di manutenzione per il settore dellaraccolta e spazzamento dei rifiuti urbani.Scopo e campo di applicazioneLa norma intende guidare il settore dell'IgieneAmbientale nell'utilizzo di una serie di indicatoriche permettano la valutazione delle attività svoltedal servizio di manutenzione e dei costi sostenuti,elaborando indici utili ad una comparazione fra iservizi aziendali interni e per un confronto fra leaziende dello stesso settore, nonché per la defini-zione di indicatori nei confronti di fornitori di veico-li/attrezzature e fornitori di manutenzione interni(officine di manutenzione) ed esterni (forniture infull e global service).IntroduzioneUn indice è un rapporto di due dati destinato a:• rappresentare un evento determinato in modoobiettivo e preciso;
• controllare il grado di raggiungimento degliobiettivi;
• essere comparato tra unità distinte della stessaimpresa o tra imprese diverse.
L’analisi e la valutazione degli indici possono esse-re applicate a:• un settore di attività;• un’impresa nell’ambito del proprio settore di atti-vità;
• l’evoluzione storica di un’impresa al suo interno;• la funzione manutenzione nell’ambito di un’im-presa;
• la definizione dei rapporti fra le funzioni manu-tenzione ed utilizzo, comunque definite;
• l’evoluzione storica della funzione manutenzioneal suo interno.
Nota: gli indici ricavati costituiscono interessantiindicazioni di "benchmarking" ma non consentonoda soli una valutazione delle imprese che sonodiverse le une dalle altre per storia, cultura, orga-nizzazione, territorio.La scelta di un appropriato numero di indici
dovrebbe essere effettuata considerando che:• la lista indicata nella presente norma non è limita-tiva; a partire dalle basi di valutazione costituitedai dati relativi, ogni impresa può elaborare i pro-pri indicatori adattandoli ai bisogni individuati;
• gli indici possono essere complementari ed inquesto caso non possono essere consideratisingolarmente;
• i valori degli indici, comparati tra diverse unitàoperative, possono assumere significato moltodiverso secondo il livello o la modalità di analisi.Per esempio, in presenza di indici globali identi-ci si possono avere indici analitici diversi;
• un indice è significativo e comparabile se i datiutilizzati nel rapporto corrispondono alla defini-zione precisa dei termini del rapporto ed il lorovalore è ricavato su basi omogenee tra di loro;
• gli indici sono relativi al contesto utilizzato; ilmodo di calcolo ne influenza il significato.Provvedimenti fiscali, tra l’altro, possono altera-re nel tempo i dati di base: questo fatto dovreb-be essere considerato nel confrontare serie sto-riche a valori attuali.
L’uso degli indici può essere sistematico o secon-do necessità per gli obiettivi da perseguire.È compito della direzione aziendale individuare lafunzione responsabile della raccolta e dell’elabo-razione degli indici.La presente norma consente la costruzione dibanche dati di settore.Alcuni indici possono essere espressi in unità dimisura anche diverse da quelle indicate nel testo(per esempio: ore/km, ore/persona, ore/n° cicli)più aderenti alla specifica realtà da gestire.Il principale parametro di riferimento per la valuta-zione degli indicatori di manutenzione è l’oramotore, ove applicabile, salvo tenere in considera-zione l’incidenza su tale parametro delle ore dilavoro dell’attrezzatura (ore PTO) e dei chilometrieventualmente percorsi.Tale incidenza varia a seconda del tipo di serviziosvolto, dalla gravosità dello stesso, e dalle specifi-cità del territorio interessato.Classificazione degli asset per l’igiene ambienta-le ai fini della manutenzioneRaccolta, trattamento, trasporto e conferimentoAutocompattatoriLateraliLeggero (mtt ≤ 7,5 t)Medio (7,5 t < mtt < 18 t)Pesante (18 t ≤mtt ≤ 26 t)Ultrapesante (mtt > 26 t)PosterioriMini (mtt ≤ 3,5 t) limite fra patente B e patente CLeggero (3,5 t < mtt ≤ 7,5 t)Medio (7,5 t < mtt < 18 t)Pesante (18 t ≤mtt ≤ 26 t)Ultrapesante (mtt > 26 t)
FrontaleLeggero (mtt ≤ 7,5 t)Medio (7,5 t < mtt < 18 t)Pesante (18 t ≤mtt ≤ 26 t)Ultrapesante (mtt > 26 t)Veicoli Trasporto/conferimentoVascheLeggero (mtt ≤ 2,2 t)Medio (mtt > 2,2 t)Pianali con sponda idraulicaAutocarri liftcar (multilift)Mini (mtt ≤ 3,5 t) limite fra patente B e patente CLeggero (3,5 t < mtt ≤ 7,5 t)Medio (7,5 t < mtt < 18 t)Pesante (18 t ≤mtt ≤ 26 t)Ultrapesante (mtt > 26 t)Autocarro con gruAutocarro/autoarticolato trasportoAutocarroPesante (mtt ≤ 26 t) Ultrapesante (mtt > 26 t)Rimorchio (compattante e non)Trattore stradaleSemirimorchio (compattante e non)Attrezzature scarrabiliCassoni compattantiCassoni non compattantiCassone con gruContenitori stradali (anche interrati)Igiene del suolo e spazzamento ed attrezzature eveicoli specialiVeicoliVeicoli ausiliari per nettezza urbana (mtt < 3,5 t -cicli, motocicli, quadricicli)Spazzatrici aspirantiPiccola (capacità ≤ 2 m3)Media (2 m3 < capacità ≤ 4 m3)Grande (capacità > 4 m3)Spazzatrici meccanicheLavastradePiccola (capacità ≤ 2 m3)Media (2 m3 < capacità ≤ 5 m3)Grande (capacità > 5 m3)LavacassonettiSpurgoVariAspirafoglieSpazzaneveSpargisaleAttrezzature (scarrabili)AspirafoglieSpazzaneveSpargisaleLavastradeVeicoli specialiMacchine operatrici di vario tipo (carrelli elevato-ri, pale, costipatori, ecc.)Autocarri cava
UNA NUOVA PROPOSTA DI ATTIVITÀ NORMATIVA PER L’IGIENE URBANA - LA MANUTENZIONE DEI MEZZI E I RELATIVI INDICI
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
41U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Gestione dei rifiutidossier
Attualmente, tale filiera è impercettibilmentecoordinata e in modo duttile attraverso unAccordo di programma quadro per la gestio-ne dei veicoli fuori uso (una scelta non cosìrigida come un’Agenzia o un consorzio pub-blico o privato)Il legislatore, per i veicoli fuori uso, ha previ-sto un ampio programma, per quanto corre-dato da norme tecniche, talvolta particola-reggiate, che meritava un momento d’incon-tro, un tavolo tecnico neutro dove mettereinsieme le diverse conoscenze tecniche,competenze e visioni del problema. UNI, inquesta prospettiva, ha garantito la possibili-tà di un pacato confronto tra produttori, im-portatori di veicoli, frantumatori, Enti pubbli-ci con contenuti tecnici, consumatori. Il lavoro in UNI è particolarmente interes-sante ma non cogente per le parti, si trattadi fissare le caratteristiche di un insieme dicomponenti o materiali in modo tale che sia-no compatibili fra loro.Le organizzazioni contribuiscono a titolo vo-lontario all’attività di normazione spinte dallapossibilità di influire sulla definizione deicontenuti delle norme e non subire requisitistabiliti dai concorrenti, essere informati suifuturi sviluppi normativi, con tempi e costi diadattamento ridotti e, quindi, con vantaggicompetitivi sulla concorrenza, essere ag-giornati sullo "stato dell'arte" dei prodot-ti/servizi/processi relativi alla propria attività.Questo è il percorso di normazione tecnicascelto spesso in Europa. UNI, in Italia è laporta (unica) per accedere e avere peso sutali iniziative.
Queste sono state le spinte anche per il no-stro gruppo di lavoro. Il risultato è una nor-ma che potrebbe, per ora, essere conside-rata unica nel quadro continentale.L’esito che si voleva ottenere differisce un po-co da prodotti tipici di UNI. Non si inserisceautomaticamente nei capitoli norma tecnica olinea guida. Non si è trattato, in questo caso,di costruire un’interfaccia condivisa o un pro-tocollo analitico. Tornando alla radice del la-voro di normazione, si può definire, senzadubbio, il nostro, un documento che dice “co-me fare bene le cose”, garantendo sicurezza,rispetto per l’ambiente e prestazioni certe.Il contenuto ambientale non è evidente, aprima vista. Si tratta, infatti, di porre le pre-messe per raggiungere l’obiettivo specificodi reimpiego, riciclo e recupero3. Per rag-giungerlo, gli insediamenti della filiera deb-bono arrivare ai standard operativi e am-bientali di qualità. Questa norma questo haprodotto; sollecitando la capacità di comu-nicare tra tecnici di campi attigui e indican-do un minimo di informazioni da essere con-diviso (es. condizioni per la messa in sicu-rezza e lo smontaggio).Tra le condizioni al contorno vi era la neces-sità che lo strumento fosse duttile lasciandolibera la filiera di smontare i materiali nelpunto più conveniente. Questa norma tecnica, anche, non dovevainterferire con la modalità organizzativa chela filiera autonomamente ha prescelto (si ri-cordi che in Europa esistono dei consorzicome l’olandese ARN4). Per ora, nel nostroPaese, si è scelta la forma del sopra citato
Accordo di Programma.Si è sentita, inoltre, la necessità ambiziosadi ricucire scelte e interpretazioni di vario li-vello gerarchico in un insieme di informazio-ni coerenti per il lettore (pur evitando di pro-durre un manuale) e lo si è fatto usando lospazio destinato agli allegati. Non tutto è stato realizzato. Se vi sarà con-senso, resta aperta la possibilità di migliora-re il prodotto UNI, almeno, sul versante dellematerie prime in uscita dalla frantumazione,della standardizzazione delle plastiche se-condarie ottenute dal mercato automotive edei prodotti post shredding. Un altro capito-lo, poco praticato, riguarda il riuso. Nel cam-po autoveicoli questo significa la rigenera-zione di componenti usati (es. motorini d’av-viamento ma anche centraline elettronicheed altri componenti). Sono pronte nuove frontiere come lo smon-
Note1 Per approfondire: rifiuti in generale - http://ec.europa.
eu/environment/waste/legislation/index.htm
sui veicoli - http://ec.europa.eu/environment/waste/
elv_index.htm
norme nazionali - http://www.reteambiente.it/normativa
/4991/2 il più recente intervento normativo: Dm Ambiente 28
settembre 2010 - http://www.reteambiente.it/normativa
/13957/3 Secondo quanto previsto all’art. 7 “Reimpiego e recu-
pero” del D.lg. 209/2003 e successive modifiche e
integrazioni; gli obiettivi fissati debbono essere garan-
titi da tutti gli operatori economici della filiera4 www.arn.nl
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
taggio dei veicoli ibridi e la lavorazione dicomponenti al litio.Questa norma può essere un punto di par-tenza in questo senso ma è già solida realtà.Nel mondo odierno la concorrenza sul mer-cato si esercita tra stati o grandi agglomera-ti sulle tecnologie. Procedure come questapossono rappresentare un vantaggio tecno-logico.
Claudio Dozio Arpa LombardiaCoordinatore del GL13 Gestione dei veicolifuori uso (secondo la Direttiva 2000/53/CE)della Commissione Tecnica Ambiente UNI
Dal waste managementalle norme tecnicheper il recupero
Nel luglio 2002, Parlamento e Consiglio Euro-peo deliberavano il VI Piano d’Azione, defi-nendo la strategia destinata a caratterizzarele Direttive Europee e la legislazione di ogniPaese della Comunità a protezione dell’Am-biente per i dieci anni a venire. E’ ormai qua-si tempo di formulare bilanci.In particolare riguardo la produzione e ge-stione dei rifiuti, se nel decennio precedenteobiettivo prioritario era garantire la legalitàdelle operazioni di smaltimento in discarica,in questo nuovo ciclo temporale esso è dive-nuto quello di contenerne al massimo la pro-duzione ed il fabbisogno crescente di discari-che, pena un impatto ambientale insostenibi-le. Di qui la strategia orientata a sostituire losmaltimento con il recupero, meglio se attra-verso attività di riciclo.È una strategia complessa, per sviluppare laquale alcuni Stati (tra cui il nostro) non hannocerto brillato. Implica una sostanziale inte-grazione tra politiche di protezione ambienta-le e strategie di sviluppo economico, la ricer-ca finalizzata a tecnologie dedicate e nuovimateriali, la pratica del green public procure-ment, il diffondersi di una cultura orientata alconsumo “sostenibile”. Nonostante i risultatiraggiunti si è diffusa un’idea abbastanza “bu-rocratica” dell’impatto sull’economia realedella normativa ambientale europea, di cuiviene più percepito l’insieme oneroso di “lac-ci o laccioli” che non l’utilità di linee guidainerenti lo sviluppo ordinato dell’attività eco-nomica connessa con effetti positivi sullaqualità della vita quotidiana.Così, seppure le buone ragioni della strate-gia europea appaiano ben chiare osservan-do in TV i guasti di una rivolta popolare con-tro la realizzazione dell’ennesima discarica,è incontestabile che nella realtà quotidianatroppo spesso si dimentica che l’enorme at-
tività economica e di servizi orientati allaraccolta, preparazione e gestione logisticadei rifiuti è fondamentale per favorire la le-galità e rendere possibile la differenziazionedei successivi trattamenti; ma anche chetutto ciò ha senso pratico solo nella pro-spettiva - ogni anno che passa, sempre piùinevitabile - che se ne renda possibile ilmassimo grado di recupero, sia in termini dimateria prima che – eventualmente – qualefonte energetica sostitutiva. Sebbene i successi di tale impostazione sia-no noti (la raccolta differenziata è possibile,si riduce il volume di rifiuti mandati in disca-rica, il mercato ha introitato l’idea che il lorosmaltimento abbia un costo; ecc.) e su que-sta base si siano sviluppati un grande nume-ro di sistemi per la raccolta e la distruzione,in sede di bilanci è bene provare a chiedersise le statistiche non nascondano in realtà
42 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Gestione dei rifiutidossier
dei problemi irrisolti che è necessario af-frontare. Sarebbe interessante promuovere un’indagi-ne tra tutti coloro che hanno qualche respon-sabilità in materia: nel settore o nelle situa-zioni che conosciamo la strategia europea èadeguatamente perseguita? I comportamen-ti del mercato corrispondono a rendere cre-dibile la prospettiva indicata? Le imprese, iprotagonisti cioè dell’attività economica –ciascun gruppo nello specifico settore di rife-rimento – perseguono interessi “di filiera” te-si a supportare una simile prospettiva, utiliz-zando appieno gli strumenti disponibili ?Per rispondere è forse opportuno riflettere sucosa si debba intendere per “ciclo di Recu-pero”. Per la Direttiva Europea e anche laLegge italiana “la disciplina in materia di ge-stione dei rifiuti si applica fino al completa-mento delle operazioni di recupero – che uti-
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
43U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Gestione dei rifiutidossier
lizzano rifiuti per generare materie prime se-condarie, combustibili o prodotti, attraversotrattamenti meccanici, termici, chimici o bio-logici, - che si realizza quando non sono ne-cessari ulteriori trattamenti perché le sostan-ze, i materiali e gli oggetti ottenuti possonoessere usati in un processo industriale ocommercializzati come materia prima secon-daria, combustibile o come prodotto da collo-care, a condizione che il detentore non se nedisfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbli-go, di disfarsene.”Se l’espressione s’interrompesse prima dellasottolineatura i risultati disponibili sarebberosoddisfacenti. Eppure una definizione cosìnetta vista dal lato del mercato non sembralasciare spazio a interpretazioni: non bastache un impianto sia concepito tecnicamentein grado di produrre una materia prima da unrifiuto; perché si possa parlare di recuperocompiuto chi lo gestisce dev’essere anche ingrado di commercializzare e vendere il pro-dotto in tal modo realizzato. Altrimenti dovràgiocoforza liberarsene come un rifiuto. Ed èquesta sottolineatura che giustamente c’in-terroga circa il percorso talvolta ancora dafare.Il ciclo virtuoso concepito con il VI piano d’A-zione si è dimostrato efficace con quei rifiutiriconducibili al materiale originario attraver-so operazioni relativamente semplici: lattined’alluminio, bottiglie di vetro, materiali di ar-redo, manufatti termoplastici monopolimero:perché una volta separati, dilavati e – più omeno finemente – triturati possono esserereimmessi nel mercato attraverso i cicli origi-nali di produzione degli stessi prodotti a finevita.La stessa cosa non può dirsi nel caso di rifiutipiù complessi - di struttura non omogenea onon facilmente stampabili - per diverse ragio-ni, tra cui la difficoltà di far pagare il giustoprezzo per materiali ottenuti attraverso attivi-tà onerose di riciclo in un mercato che deve
accettare con essi nuove materie prime oprodotti necessariamente in competizionecon tutti gli altri per funzionalità, qualità, prez-zo di vendita.Se infatti oggi si può dire che in molteplici si-tuazioni è ormai acquisita l’idea che un pro-dotto finito sia realizzato a partire da un rifiu-to, solo in alcuni casi - frutto del contestoaziendale e della sagacia con cui esso è pro-gettato e proposto (la carta riciclata, il pile, ilpannello ecologico, ecc) - si può parlare diun corretto posizionamento commerciale. Ingenerale, invece, permane l’idea che un rifiu-to possa essere anche accettato come mate-ria prima, ma solo a condizione che costi po-co o niente trattandosi in fondo di un rifiuto.Consolidare il mercato di riferimento dei pro-dotti del Riciclo significa in definitiva svilup-pare un settore della Green Economy conconseguenze fondamentali sia per le strate-gie di politica ambientale che per l’economiadi intere filiere produttive.E poiché molte strade fin qui seguite (mercatiprotetti, prodotti di modesta qualità a bassoprezzo) hanno dimostrato i loro limiti, forse èil caso di non sottovalutare anche un approc-cio di altro tipo: convincere quote crescentidel mercato globale ad accettare prodotti dibuona qualità che utilizzano materiale ricicla-to nonostante il costo, ampiamente giustifica-to dalla motivazione ambientale, non possarisultare inferiore a quello dei prodotti da ma-teria prima vergine.In realtà serve un approccio nuovo da partedel mercato, interessato a completare il ciclodel recupero: l’indirizzo di risorse economi-che e finanziarie oggi finalizzate perlopiù allaraccolta ed allo smaltimento; attività di ricer-ca e sviluppo orientate ad un settore produt-tivo che – diversamente da altri – non saràdelocalizzato; competenze ed organizzazioneaziendale; capacità di marketing ed alleanzecommerciali. Si potrebbe aggiungere, ancheun diverso impegno da parte della P.A. e della
grande impresa; o di intere filiere produttivedestinate a coinvolgere non solo i produttoridel rifiuto od i riciclatori ma anche i settoriproduttivi potenzialmente in grado di utilizza-re la materia prima riciclata ed il sistema delconsumo sostenibile. Ma è noto che il mercato favorisce il determi-narsi di queste condizioni quanto più risulta-no utili a regolare la competizione e gli inte-ressi correlati. Ed è su questo piano cheemerge – esplicito – il ruolo della normazio-ne.Qualsiasi sia l’articolo realizzato, qualunquene sia l’impiego, un utilizzatore di materie pri-me le seleziona ed acquista sulla base di duefattori: prezzo e caratteristiche. E, di solito,può essere interessato a sostituire il fornitoresolo a condizione che il prezzo diminuisca ole caratteristiche del suo materiale siano mi-gliorative. Come determinare tali caratteristiche? Se-condo quali tecniche e metodologie? Conquali livelli di raffinatezza? Sotto quali deno-minazioni riconoscerle? Quali norme impostedalla Legge osservare? La commercializza-zione di un prodotto implica sempre l’accor-do tra due interessi, eventualmente contrap-posti: le norme tecniche del CEN, dell’ISO edegli Enti di normazione nazionale, come no-to, servono ad introdurre punti di riferimentoaccettati da tutti i soggetti normalmente incompetizione in ogni settore produttivo nel-l’area di mercato di riferimento.Ora, se le materie prime riciclate debbonoentrare normalmente in competizione con lerisorse vergini nella produzione di manufatti oin utilizzi comuni, come non pensare chequesto processo non debba riguardare an-ch’esse, pur non sottovalutando il diversopunto di partenza? E non solo perché il sus-sistere di una norma tecnica relativa all’im-piego di un rifiuto quale materia prima vienerichiesto dalla legislazione ambientale. Masoprattutto perché il mercato pretenderà co-munque il verificarsi di un simile presuppo-sto!Non è un processo semplice, né tantomenobreve. Le filiere aziendali interessate ad unciclo di recupero raccolgono imprese spessomolto diverse sotto il profilo della dimensio-ne, delle risorse, delle priorità: produttori, ri-ciclatori, altri produttori, clienti finali. Debbo-no anzitutto riconoscersi, quindi condivideregli interessi comuni, infine rispettarsi al puntoda collaborare sul piano tecnico e normativo.Senza sottovalutare il fatto che il mercato deirifiuti è spesso locale e regolato da legisla-zioni nazionali mentre il mercato dei prodottiè perlopiù internazionale, o comunque quan-tomeno europeo. Se ci si pensa appena è ungrande impegno – anche culturale – richiestoa soggetti che fino a qualche decina d’anni fa
FISE Unire, l’Associazione che rappresenta, a livello nazionale, leaziende di recupero dei rifiuti appartenenti alle diverse filiere mer-ceologiche (carta, vetro, plastica, RAEE, acciaio, gomma, veicolifuori uso, abiti usati, inerti) considera di fondamentale importanzal’attività di standardizzazione UNI e CEN con riferimento alle caratte-ristiche e requisiti dei processi e dei materiali recuperati dai rifiuti alfine della promozione e dello sviluppo degli sbocchi di mercato deglistessi. Ciò risulta essenziale anche per la diffusione nel nostro
Paese degli “acquisti verdi” e più in generale del Green Public Procurement. L’Associazione ritie-ne infatti che solo attraverso l’adeguata qualificazione dei materiali e beni riciclati sarà possibi-le opporsi a pratiche lesive della concorrenza nel mercato di riferimento, come dimostrano leesperienze nel settore del granulo di gomma e degli aggregati riciclati.
Corrado Scapino - Presidente FISE Unire
FISE UNIRE
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
di quest’anno - la prima norma tecnica delsettore a livello europeo riguardo i materialiprodotti da pneumatici fuori uso (caratteriz-za i materiali prodotti dal ciclo di recycling,sulla base di dimensioni ed impurezze, stabi-lisce e normalizza i metodi di campionaturae di prova in tutte le fasi del processo).Con la Specifica Tecnica non sono risolti tuttii problemi relativi alla commercializzazione diquesti materiali; ma è una base indispensabi-le perché – attraverso ulterioriattività tese ad auspicabili inte-grazioni – il Legislatore ed ilMercato possano considerarequesti materiali quali materieprime seconde a tutti gli effetti,anziché rifiuti; sempre che siapossibile svilupparne adeguata-mente il mercato degli impieghi.
ignoravano reciprocamente l’esistenza; onemmeno esistevano.Per testimoniare tale complessità cito unesempio, fra gli altri, che conosco da vicino: ilcomparto dei pneumatici fuori uso (o a finevita). Stando alle associazioni dei Produttori(ETRMA) e dei Riciclatori (ETRA) - a livelloComunitario riguarda il Recupero di 3,5 Milio-ni di T/anno. La peculiarità che complica il re-cupero dei granulati ottenuti dal riciclo deiPFU è nella loro vulcanizzazione. Non posso-no quindi essere riciclati per produrre nuovipneumatici bensì utilizzati o tal quali o nellaproduzione di manufatti di altra natura impie-gando leganti di varia natura (polimeri, bitu-mi, cemento). Il che significa : nuovi materialie nuovi prodotti per mercati da sviluppare. Diriciclo si cominciò a parlare una ventinad’anni or sono.Nel 1999 la Commissione Europea convocòun “Forum del recycling” per discutere i ri-sultati raggiunti ed esplorare gli ostacoli esi-stenti nell’U.E. Il rapporto finale del Forum,tutti d’accordo, raccomandava lo sviluppo distandards per i materiali e le applicazioni delriciclo.Nel 2000 un lavoro preliminare fu iniziato gra-zie ai riciclatori di ETRA. La redazione di unCWA consentì primi elementi d’indirizzo chenel 2002 si conclusero con la pubblicazione diun documento preliminare del CEN:CWA14243.Nel 2003 il CEN creò un gruppo di lavoro(con Segreteria svedese) per trasformarequesto documento in uno standard europeo.Nel 2005 la bozza di documento non rag-giunse la maggioranza qualificata necessa-ria causa il diverso grado d’interesse traPaesi e contrasti emersi anche in Italia traProduttori e Riciclatori. Due anni dopo l’UNI,sostenuto dai riciclatori in ARGO, assumeval’iniziativa riproponendo il processo normati-vo. Nel gennaio 2007 il CEN affidò all’UNI laSegreteria perché la filiera interessata giun-gesse a definire una prima norma tecnicaeuropea. I tempi erano finalmente maturi. Ilgrande spirito di collaborazione indotto dallaSegreteria e l’intelligenza delle parti rappre-sentanti la filiera - con i Produttori riuniti inEcopneus impegnati insieme ai Riciclatoried ai rappresentanti dei settori di principaleimpiego - consentirono alla Delegazione ita-liana di condividere al 100% un progetto diBusiness Plan poi presentato nel novembredello stesso anno alla trentina di esperti del-la Task Force europea. Fu l’inizio di un per-corso ad ostacoli (proposte, redazioni, con-trasti, mediazioni) che attraverso oltre unaventina di risoluzioni approvate all’unanimi-tà, hanno portato il gruppo di lavoro che hoavuto l’onore di coordinare (CEN/PC 366) aredigere - ed il CEN a pubblicare nell’aprile
E questo è il tema di riflessione che, citandoinfine un caso reale, abbiamo voluto qui pro-porre.
Elio A. Savi IMF srlChairman del CEN/PC 366 Tyres recycling e membro del GL14 Materiali da recupero di pneumatici fuori uso della CommissioneTecnica Ambiente UNI
Gestione dei rifiutidossier
U&C n.10 novembre/dicembre 201044
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
Vita quotidiana
46 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
Ci aiutano le norme a manteneresani denti e gengive
Lavarsi i denti dopo ogni pasto, scegliere l’a-deguato spazzolino e sostituirlo spesso, utiliz-zare il filo interdentale, scegliere un buon den-tifricio sono tutte azioni che aiutano a preveni-re le malattie di denti e gengive.Per la scelta di questi prodotti ci vengono inaiuto anche le norme tecniche, che garanti-scono al consumatore sicurezza, qualità, ri-spetto dell’ambiente e prestazioni.“Odontoiatria – Dentifrici - Requisiti, metodi diprova e marcatura” è il titolo della norma UNIEN ISO 11609, che specifica i requisiti delleproprietà fisiche e chimiche dei dentifrici efornisce, oltre a una guida per gli appropriatimetodi di prova, i requisiti per la loro marcatu-ra, etichettatura e imballaggio.La norma, che si applica ai dentifrici destinatiad essere utilizzati quotidianamente dai con-sumatori al fine di promuovere la loro igieneorale, riporta requisiti relativi a: fluoro totalecontenuto, metalli pesanti, pH, microbiologia,abrasività. Tra i metodi di prova troviamo quel-lo per la determinazione del pH, dell’abrasività(dello smalto e dentina), della stabilità.La norma sostituisce la UNI EN ISO 11609 del2001.Passiamo agli spazzolini da denti, classificatinella norma in tre tipologie. La UNI EN ISO16409 “Odontoiatria - Prodotti per l’igiene ora-le - Spazzolini interdentali manuali” (che sosti-tuisce l’edizione 2007) specifica i requisiti e imetodi di prova per i criteri di prestazione de-gli spazzolini interdentali manuali con la testadella spazzola a sezione circolare. La normariporta anche le indicazioni del fabbricante re-
lative alle istruzioni per l’uso e alla marcaturadell’imballaggio.L’uso dello spazzolino dovrebbe essere affian-cato dall’uso del filo interdentale: si applica alporta filo e al filo interdentale integrato peruso manuale la nuova norma UNI EN ISO28158 “Odontoiatria - Porta filo e filo interden-tale integrato”, elaborata allo scopo di presen-tare i requisiti e i metodi di prova per questiprodotti utilizzati per la cura professionale odomestica dell’igiene orale o come parte di untrattamento dentale. I requisiti si riferiscono aimateriali, alla forma e alla resistenza. Queste norme tecniche devono essere utiliz-zate dal fabbricante per poter fornire sul mer-cato prodotti per l’igiene orale adeguati e so-prattutto con caratteristiche di sicurezza in li-nea con lo stato dell’arte, oltre a garantire unlivello di prestazione volto a far durare neltempo i prodotti: per gli spazzolini, per esem-pio, la parola prestazione significa avere le se-tole che durano nel tempo e con una tenutaadeguata (la norma propone dei test specificiper verificare la tenuta delle setole e la lororesistenza al piegamento, che rende lo spaz-zolino inutilizzabile). L'utilizzare prodotti con-formi a tale norma si traduce anche in menocosti (perché se comprano meno) e minoriquantità di rifiuti prodotti.A livello nazionale i lavori normativi in campoodontoiatrico sono seguiti dalla Commissione“Tecnologie biomediche e diagnostiche”.
Simboli per comandi, indicatori e spie: quando il cruscotto è a norma C’è un linguaggio universale dei simboli d’in-formazione che segnalano al conducente diun veicolo un problema almotore, la necessità digonfiaggio degli pneumati-ci o quella di aggiungerecarburante nel serbatoio.Questo linguaggio è conte-nuto nella nuova edizionedella norma internazionaleISO 2575:2010 “Road vehi-cles – Symbols for con-trols, indicators and tell-ta-les”, che raggruppa le in-
formazioni comunicabili al conducente permezzo di simboli studiati appositamente perl’utilizzo nelle autovetture, autocarri e autobus,indipendentemente da marca e modello.Espressione di un consenso internazionaleraggiunto tra i principali produttori automobili-stici, i simboli riportati nella norma limitano ilrischio di confusione che potrebbe risultaredall’esistenza di simboli multipli e contraddit-tori visibili sul cruscotto.La versione aggiornata della ISO 2575 offreper la prima volta agli utilizzatori anche un CD-ROM contenente tutti i simboli grafici in tre dif-ferenti formati - Adobe Illustrator (ai), Encap-sulated Postscript (eps) e Drawing Interchan-ge Format (dxf) – allo scopo di soddisfare leesigenze di qualsiasi progettista grafico delveicolo."Oltre a fornire la grafica vettoriale, gli utentiriceveranno un elenco completo dei significatidi ogni simbolo" riporta Gary Rupp, project lea-der della nuova norma. "I costruttori di veicolied i loro fornitori apprezzeranno di sicuro ilCD-ROM: le informazioni contenute potrannogarantire che ogni simbolo visualizzato all'in-terno del proprio veicolo sia disegnato corret-tamente e che comunichi in modo esatto il suosignificato”.La ISO 2575 raggruppa più di 350 simboli (se-gni convenzionali) per l'utilizzo sui comandi,indicatori e spie. Fornisce inoltre indicazionisui colori appropriati delle spie ottiche, che in-formano il conducente sia della corretta ope-razione sia del malfunzionamento del di -spositivo associato. Per fare un esempio, il co-lore rosso rappresenta il pericolo sia nei con-fronti delle persone che dell’equipaggiamento(comunicando gravi danni immediati o immi-nenti). Alcuni colori sono utilizzati per spiespecifiche, come il colore blu per le luci abba-glianti.Giunta alla sua ottava edizione, la nuova ISO2575:2010 – che annulla e sostituisce la versio-ne del 2004 – è stata aggiornata con nuovisimboli per funzioni aggiuntive, in considera-zione della continua evoluzione tecnologicadel settore. La norma è stata elaborata dal comitato tecni-co ISO/TC 22 “Road vehicles” SC 13 “Ergono-mics applicable to road vehicles”. �
a cura della Com
unicazione UNI rubriche
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
47U&C n.10 novembre/dicembre 2010
a cura della Com
unicazione UNI e
CEI rubriche
Collana Costruzioni: in CD-Rom le raccolte di norme UNI per l’ediliziaNel campo dell’edilizia la conformità dei pro-cessi, dei prodotti e dei servizi alle norme tec-niche è un fattore di fondamentale importan-za. Lo è sempre stato, ma ancor più lo è ades-so che si vanno affacciando nel complessopanorama delle costruzioni nuove sfide cheaprono scenari particolarmente interessantiper chi opera nel settore, come ad esempio:la sostenibilità edilizia (pubblicata a catalogoin queste settimane la UNI EN 15643-1 “So-stenibilità delle costruzioni - Valutazione dellasostenibilità degli edifici – Parte 1: Quadro diriferimento generale”), il rendimento energeti-co (si pensi alla norma UNI CEI EN 16001 suisistemi di gestione dell’energia), la classifica-zione acustica delle unità immobiliari (recentela pubblicazione della norma UNI 11367 “Acu-stica in edilizia - Classificazione acustica del-le unità immobiliari - Procedura di valutazionee verifica in opera”), l’accessibilità (un tema,quest’ultimo, indicato come una delle prioritàdagli organismi di normazione internazionale).La collana Costruzioni, pubblicata in questesettimane in una nuova edizione, raccoglie lenorme UNI del settore, aggiornate al 31 otto-bre 2010.Secondo uno schema già collaudato, la colla-na si compone di sei differenti serie, apposita-mente ideate per venire incontro alle esigen-ze pratiche di chi opera nel settore, a diversilivelli della filiera: committenti, progettisti, im-prese, installatori, produttori e laboratori.Un quadro estremamente esauriente che sisviluppa in 60 CD-Rom, che contengono il cor-
pus normativo di settore, in italiano e – laddo-ve non presente la traduzione – in inglese.Le raccolte contengono anche eventuali erra-ta corrige successivamente pubblicati, cosìda fornire un quadro perfettamente aggiorna-to sullo stato dell’arte della normativa tecnica.Di poco precedente si segnala anche la pub-blicazione del CD-Rom “Eurocodici”, apparte-nente alla medesima collana. Gli Eurocodicisono norme tecniche europee - elaborate dalCEN su specifico mandato della CommissioneEuropea - che forniscono le regole di calcoloper la progettazione delle strutture - edifici eopere di ingegneria civile - e dei relativi ele-menti strutturali, nonché le regole per la veri-fica di conformità dei prodotti strutturali ai Re-quisiti Essenziali numero 1 e numero 2 (resi-stenza meccanica e stabilità; sicurezza in ca-so di incendio) stabiliti dalla direttiva 89/106sui prodotti da costruzione.Il CD-Rom si rivolge in particolare agli inge-gneri civili ed edili i quali possono trovare inesso uno strumento di grande utilità praticaper lo svolgimento del loro lavoro.
Nuova edizione della Guidatecnica CEI 82-25: novità per il settore fotovoltaicoIl CEI annuncia la pubblicazione della nuovaedizione della guida CEI 82-25 “guida alla rea-lizzazione di sistemi di generazione fotovoltai-ca collegati alle reti elettriche di Media eBassa Tensione”. La guida tecnica fornisce ai progettisti, agliinstallatori e, in genere, agli operatori di im-pianti fotovoltaici i criteri per la progettazione,
l’installazione e la verifica dei sistemi di gene-razione, destinati ad operare in parallelo allarete di distribuzione di Media e di Bassa Ten-sione.La guida è stata aggiornata principalmenteper:• apportare le modifiche rese necessarie dal-l’evoluzione normativa e legislativa;
• tenere in considerazione quanto sviluppatodal CT82 in collaborazione con altri comitatiin materia di cavi, contatori, interruttori inBT e con organizzazioni esterne al CEI, tracui il corpo nazionale dei vigili del fuoco;
• aggiornare aspetti legati al dimensionamen-to meccanico e ai sistemi fotovoltaici a con-centrazione;
• revisionare la parte relativa all’interfaccia-mento alla rete elettrica;
• aggiornare e ampliare l’articolo riguardantela misura dell’irraggiamento solare e i relati-vi strumenti di misura.
La nuova edizione della guida tecnica contie-ne 4 allegati. L’allegato A riporta il riepilogodella normativa, i documenti e le leggi di rife-rimento in vigore da rispettare per la proget-tazione e la verifica elettrica di un impiantofotovoltaico, mentre l’allegato B definisce icriteri per la progettazione e la verifica mec-canica di un impianto fotovoltaico. L’allegatoC fornisce cenni sulla risorsa energetica sola-re fotovoltaica, nonché sulla potenzialità degliimpianti fotovoltaici. L’allegato D, che rappre-senta la principale novità della presente edi-zione della guida tecnica, fa riferimento alleprove essenziali da effettuare su moduli e as-siemi fotovoltaici a concentrazione solare perverificare il soddisfacimento dei requisiti mini-mi di sicurezza e qualità, oggetto delle normeCEI EN applicabili, ed ottenere una valutazio-ne preliminare della sicurezza e qualità deicomponenti esaminati.Questo volume recepisce gli aggiornamentilegislativi del nuovo Conto Energia. La guida CEI 82-25 (ed.2010) è disponibilepresso tutti i punti vendita CEI e il CEI Web-Store al prezzo di € 60,00 (prezzo Soci €48,00). �
Recensioni
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
48 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
a cura delle Aree Tecniche UNI e
CEI rubriche
FOCUSnorma
In questo numero di U&C presentiamocome principali novità dell’attività nor-mativa la sostenibilità delle costruzioni,gli impianti di illuminazione di sicurezza
negli edifici, il legno strutturale e le pre-se interbloccate con dispositivo a cor-rente differenziale.
UNI EN 15643-1Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della so-stenibilità degli edifici - Parte1: Quadro di riferimentogenerale14/10/2010Commissione Tecnica Prodotti, processi e sistemi perl'organismo edilizioFornisce i principi generali ed i requisiti, espressi attra-verso una serie di norme, per la valutazione degli edificiin termini di prestazione ambientale, sociale ed econo-mica, tenendo in considerazione le caratteristiche tec-niche e la funzionalità dell'edificio. Progettisti, costruttori.Fa parte di una serie di norme che forniscono un siste-ma per la valutazione di sostenibilità degli edifici utiliz-zando un approccio basato sul ciclo di vita. La serie dinorme permette la valutazione di sostenibilità, simulta-neamente e con gli stessi presupposti, sulla base dellecaratteristiche tecniche e della funzionalità dell’oggettodi valutazione.prEN 15643 parti 2, 3 e 4; ISO 15392; ISO 15686 parti 1,2, 7 e 8.Futuro CPR (Regolamento del Parlamento europeo e delConsiglio che abrogherà la direttiva del Consiglio89/106/CEE) �
UNI CEI 11222Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicu-rezza negli edifici - Procedure per la verifica periodica,la manutenzione, la revisione e il collaudo09/09/2010Luce e illuminazioneSpecifica le procedure per effettuare le verifiche perio-diche, la manutenzione, la revisione ed il collaudo degliimpianti per l'illuminazione di sicurezza negli edifici, co-stituiti da apparecchi per illuminazione di emergenza, alfine di garantirne l'efficienza operativa.Si rivolge alle persone preposte all’espletamento delservizio di manutenzione.Elenca una serie di verifiche periodiche necessarie percontrollare lo stato di funzionamento dell’impianto, nelcorso delle quali si deve rendere disponibile la docu-mentazione tecnica relativa all’impianto, compresa l’e-ventuale documentazione di progetto. Uno specificopunto della norma è dedicato alla manutenzione periodi-ca, che consiste in una serie di operazioni programmate.UNI EN 1838 - CEI EN 50171:2002 - CEI EN 50172:2006 -CEI EN 60598-2-22:1999-
�
NORMA
TITOLO
PUBBLICAZIONE
OT COMPETENTE
SOMMARIO
A CHI SI RIVOLGE
IL VALORE
AGGIUNTO
ALTRE NORME
CORRELATE
IL QUADRO
LEGISLATIVO
NORMA
TITOLO
PUBBLICAZIONE
OT COMPETENTE
SOMMARIO
A CHI SI RIVOLGE
IL VALORE
AGGIUNTO
ALTRE NORME
CORRELATE
IL QUADRO
LEGISLATIVO
UNI 11035-3:2010Legno strutturale- Classificazione a vista dei legnamisecondo la resistenza meccanica - Parte 3: Travi UsoFiume e Uso Trieste27/10/2010Commissione LegnoCompleta il pacchetto relativo alla classificazione a vi-sta dei legnami secondo la resistenza meccanica. Trat-ta il legname, destinato all’uso in strutture portanti, ri-conducibile alle definizioni di Uso Fiume e Uso Trieste.Architetti, ingegneri, strutturisti, professionisti delsettore.Definisce le modalità della classificazione a vista chedeve essere condotta con: scelta della regola in funzio-ne del tipo di legname; esame a vista di tutte le facce edelle testate di ciascun elemento ligneo; applicazione atutte le sezioni dell'elemento ligneo di tutti i criteri diclassificazione previsti da un prospetto che indica lacombinazione specie/provenienza, la sigla di identifica-zione del materiale, la regola di classificazione appro-priata, la categoria a cui ciascun elemento ligneo puòessere assegnato e la classe di resistenza cui ciascunelemento può essere assegnato; assegnazione dell'ele-mento ligneo alla categoria peggiore fra quelle ottenutein c); se l’elemento ligneo non rientra nella categoriaminima, deve essere scartato in quanto non classifica-bile per uso strutturale.UNI 11035-1; UNI 11035-2; UNI 11119; UNI EN 338; UNIEN 384; UNI EN 1310; UNI EN 13183-1; UNI EN 13183-2;UNI EN 14081-1. -
�
CEI 23-96Prese interbloccate con dispositivo a corrente differen-ziale con sganciatori di sovracorrente per installazionefissa per uso domestico e similare (PID)01/09/2010CT 23 - Apparecchiatura a bassa tensionesi applica alle prese interbloccate con dispositivo a cor-rente differenziale (PID) con funzionamento dipendentedalla tensione di rete, per installazione fissa per uso do-mestico e similare, con sganciatori di sovracorrenteprogettisti, installatori, costruttori, verificatoriaggiorna i riferimenti normativi e modifica e aggiungealcune prescrizioni e condizioni di provaCEI 23-42, CEI 23-44
DM 37/08, D.lgs 81/08, D.Lgs 106/09�
NORMA
TITOLO
PUBBLICAZIONE
OT COMPETENTE
SOMMARIO
A CHI SI RIVOLGE
IL VALORE
AGGIUNTO
ALTRE NORME
CORRELATE
IL QUADRO
LEGISLATIVO
NORMA
TITOLO
PUBBLICAZIONE
OT COMPETENTE
SOMMARIO
A CHI SI RIVOLGE
IL VALORE
AGGIUNTO
ALTRE NORME
CORRELATE
IL QUADRO
LEGISLATIVO
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
La presente sezione è focalizzata
sulla pubblicazione
delle norme UNI e CEI.
Relativamente alle norme ISO e IEC
segnaliamo i seguenti link che rimandano
alle più recenti pubblicazioni:
norme ISO: www.iso.org/iso/search.htm
norme IEC: http://webstore.iec.ch
NOVEMBREDICEMBRE
2010leTUTTENORME
NORMECEI, UNI
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
U&C n.10 novembre/dicembre 2010
tutte
le norme
NORME CEI I Soci CEI hanno diritto ad uno sconto sul prezzo di listino dei prodotti e servizi CEINUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DI
PUBBLICAZIONE LISTINO (€)ORGANO TECNICO: CT 8/28 - ASPETTI DI SISTEMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CEI EN 60059/A1 2010-09 Correnti nominali IEC. EN/IT 11,00CEI 8-7;V1 8 pagine (Variante) Fasc. 10684 EORGANO TECNICO: CT 11/7 - LINEE ELETTRICHE AEREE E MATERIALI CONDUTTORI CEI EN 50540 2010-09 Conduttori per linee aeree - Conduttori di alluminio con EI 83,00CEI 11-80 rivestimento in acciaio (ACSS). 62 pagine Fasc. 10670ORGANO TECNICO: CT 15/112 - MATERIALI ISOLANTI - SISTEMI DI ISOLAMENTO CEI 15-195;V1 2010-09 Materiali isolanti elettrici - Proprietà di resistenza alla EI 0,00
sollecitazione termica. Parte 3: Istruzione per il calcolo delle caratteristiche di resistenza alla sollecitazione termica. 8 pagine (Variante) Fasc. 10672
ORGANO TECNICO: CT 17 - GROSSA APPARECCHIATURACEI EN 62271-100 2010-09 Apparecchiatura ad alta tensione. Parte 100: Interruttori a EN/IT 203,00CEI 17-1 corrente alternata. 344 pagine (Settima edizione) Fasc. 10682 ECEI EN 60947-2/A1 2010-10 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori EI 91,00CEI 17-5;V1 automatici. 62 pagine (Variante) Fasc. 10787CEI EN 62271-110 2010-09 Apparecchiatura ad alta tensione. Parte 110: Manovra di EN/IT 67,00CEI 17-95 carichi induttivi. 32 pagine Fasc. 10683 ECEI EN 62271-110 2010-10 Apparecchiatura ad alta tensione. Parte 110: Manovra di EI 67,00CEI 17-95 carichi induttivi. 52 pagine Fasc. 10788ORGANO TECNICO: CT 20 - CAVI PER ENERGIACEI EN 60332-3-22 2010-09 Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di EI 44,00CEI 20-22/3-2 incendio. Parte 3-22: Prova per la propagazione verticale
della fiamma su fili o cavi montati verticalmente a fascio - Categoria A. 30 pagine Fasc. 10659
CEI EN 60332-3-23 2010-09 Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di EI 41,00CEI 20-22/3-3 incendio. Parte 3-23: Prova per la propagazione verticale
della fiamma su fili o cavi montati verticalmente a fascio - Categoria B. 28 pagine Fasc. 10660
CEI EN 60332-3-24 2010-09 Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di EI 40,00CEI 20-22/3-4 incendio. Parte 3-24: Prova per la propagazione verticale
della fiamma su fili o cavi montati verticalmente a fascio - Categoria C. 28 pagine Fasc. 10661
CEI EN 60332-3-25 2010-09 Prove sui cavi elettrici e a fibre ottiche in condizioni di EI 44,00CEI 20-22/3-5 incendio. Parte 3-25: Prova per la propagazione verticale
della fiamma su fili o cavi montati verticalmente a fascio - Categoria D. 28 pagine Fasc. 10662
CEI 20-56 2010-09 Cavi da distribuzione con isolamento estruso per tensioni IT 136,00nominali da 3,6/6 (7,2) kV a 20,8/36 (42) kV inclusi. 120 pagine Fasc. 10658
CEI 20-91;V1 2010-10 Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza IT 11,00alogeni non propaganti la fiamma per applicazioni in impianti fotovoltaici . 6 pagine (Variante) Fasc. 10779
ORGANO TECNICO: CT 22 - ELETTRONICA DI POTENZACEI EN 62040-3/A11 2010-09 Sistemi statici di continuità (UPS). Parte 3: Metodi di specifica EI 13,00CEI 22-24;V1 delle prestazioni e prescrizioni di prova.
14 pagine (Variante) Fasc. 10677ORGANO TECNICO: CT 23 - APPARECCHIATURA A BASSA TENSIONECEI EN 60669-2-1/A12 2010-10 Apparecchi di comando non automatici per installazione EI 8,00CEI 23-60;V2 elettrica fissa per uso domestico e similare. Parte 2-1:
Prescrizioni particolari - Interruttori elettronici. 8 pagine (Variante) Fasc. 10789
CEI 23-95 2010-09 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente IT 137,00destinati ad essere incorporati o associabili a prese fisse (SRCBO). 128 pagine (Seconda edizione) Fasc. 10665
Legenda: EN = inglese - IT = italiano - EI = inglese e italiano - EN/IT = recepita in inglese, sarà tradotta in italiano
tutte
le norme
50
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
CEI 23-96 2010-09 Prese interbloccate con dispositivo a corrente differenziale IT 150,00con sganciatori di sovracorrente per installazione fissa per uso domestico e similare (PID). 140 pagine (Seconda edizione) Fasc. 10666
CEI 23-97 2010-09 Prese interbloccate con interruttori automatici magnetotermici IT 118,00per installazione fissa per uso domestico e similare (PIA). 112 pagine (Seconda edizione) Fasc. 10667
ORGANO TECNICO: CT 27 - ELETTROTERMIACEI EN 60703 2010-10 Metodi di prova per impianti elettrotermici con cannoni CEI 27-12 elettronici. 30 pagine Fasc. 10796 EI 36,00CEI EN 60519-7 2010-10 Sicurezza degli impianti elettrotermici. Parte 7: Norme CEI 27-29 particolari per gli impianti con cannoni elettronici.
30 pagine Fasc. 10795 EI 34,00ORGANO TECNICO: CT 29/87 - ELETTROACUSTICA/ULTRASUONI CEI EN 61094-2 2010-09 Elettroacustica - Microfoni di misura. Parte 2: Metodo primario EN/IT 125,00CEI 29-18 per la taratura in pressione di microfoni campione di
laboratorio con la tecnica di reciprocità. 50 pagine Fasc. 10690 E
CEI EN 60318-6 2010-09 Elettroacustica - Simulatori del cranio e orecchio umano. EN/IT 47,00CEI 29-52 Parte 6: Accoppiatore acustico per la misura delle vibrazioni
dell'osso. 22 pagine Fasc. 10689 EORGANO TECNICO: CT 31 - MATERIALI ANTIDEFLAGRANTICEI EN 60079-20-1 2010-09 Atmosfere esplosive. Parte 20-1: Classificazione dei gas e dei EN 140,00CEI 31-90 vapori - Metodi di prova e dati. 84 pagine Fasc. 10681 EORGANO TECNICO: CT 34 - LAMPADE E RELATIVE APPARECCHIATURECEI EN 60809/A4 2010-10 Lampade per veicoli stradali - Prescrizioni dimensionali, EN 59,00CEI 34-42;V2 elettriche e fotometriche. 48 pagine (Variante) Fasc. 10745 ECEI EN 62493 2010-09 Valutazione delle apparecchiature di illuminazione EI 117,00CEI 34-130 relativamente all'esposizione umana ai campi elettromagnetici.
84 pagine Fasc. 10676CEI UNI 11222 2010-09 Luce e illuminazione. Impianti di illuminazione di sicurezza IT 41,50CEI 34-132 negli edifici. Procedure
per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo. 16 pagine Fasc. 10655
ORGANO TECNICO: CT 46 - CAVI SIMMETRICI E COASSIALI, CORDONI, FILI, GUIDE D'ONDA, CONNETTORI PER RADIOFREQUENZACEI-UNEL 36762 2010-10 Identificazioni e prove da utilizzare per cavi per sistemi di IT 9,00CEI 46 categoria 0 in relazione alla coesistenza in condutture
contenenti cavi per sistemi di I categoria. 6 pagine Fasc. 10784CEI EN 60966-2-1 2010-10 Cordoni di cavo coassiale e per radiofrequenza. Parte 2-1: EN 50,00CEI 46-38 Specifica settoriale per
cordoni di cavo coassiale flessibile. 26 pagine Fasc. 10721 E
CEI EN 60966-2-5 2010-10 Cordoni di cavo coassiale e per radiofrequenza. Parte 2-5: EN 20,00CEI 46-77 Specifica di dettaglio per cordoni per ricevitori radio e TV
- Gamma di frequenza da 0 a 1000 MHz, connettori IEC 61169-2. 14 pagine Fasc. 10724 E
CEI EN 60966-2-6 2010-10 Cordoni di cavo coassiale e per radiofrequenza. Parte 2-6: EN 20,00CEI 46-78 Specifica di dettaglio per cordoni per ricevitori radio e TV
- Gamma di frequenza da 0 a 3000 MHz, connettori IEC 61169-24. 14 pagine Fasc. 10725 E
CEI EN 60966-2-3 2010-10 Cordoni di cavo coassiale e per radiofrequenza. Parte 2-3: EN 17,00CEI 46-81 Specifica di dettaglio per cordoni di cavo coassiale flessibile
- Gamma di frequenza da 0 a 1000 MHz, connettore IEC 61169-8. 14 pagine Fasc. 10722 E
CEI EN 60966-2-4 2010-10 Cordoni di cavo coassiale e per radiofrequenza. Parte 2-4: EN 20,00CEI 46-137 Specifica di dettaglio per cordoni per ricevitori radio e TV
- Gamma di frequenza da 0 a 3000 MHz, connettori IEC 61169-2. 14 pagine Fasc. 10723 E
tutte
le norme
U&C n.10 novembre/dicembre 2010 51
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
52
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
tutte
le norme
U&C n.10 novembre/dicembre 201052
ORGANO TECNICO: CT 48 - COMPONENTI ELETTROMECCANICI PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHECEI EN 61076-3-114 2010-10 Connettori per apparecchiature elettroniche - Prescrizioni di EN 67,00CEI 48-180 prodotto. Parte 3-114: Connettori rettangolari - Specifica di
dettaglio per custodie di protezione da impiegare con connettori ad 8 vie schermati e non schermati per frequenze fino a 600 MHz, per ambienti industriali, che incorporano l'interfaccia della serie IEC 60603-7 - Variante 11 relativa alla IEC 61076-3-106 - Tipo di accoppiamento a baionetta. 30 pagine Fasc. 10726 E
CEI EN 61076-3-117 2010-10 Connettori per apparecchiature elettroniche - Prescrizioni di EN 50,00CEI 48-181 prodotto. Parte 3-117: Connettori rettangolari - Specifica di
dettaglio per custodie di protezione da impiegare con connettori ad 8 vie schermati e non schermati per ambienti industriali, che incorporano l'interfaccia della serie IEC 60603-7- Variante 14 relativa alla IEC 61076-3-106 - Accoppiamento di tipo push-pull. 26 pagine Fasc. 10727 E
CEI EN 61076-3-001 2010-10 Connettori per apparecchiature elettroniche - Prescrizioni di EI 170,00CEI 48-182 prodotto. Parte 3-001: Connettori rettangolari - Specifica di
prodotto in bianco. 156 pagine Fasc. 10786CEI EN 60512-9-1 2010-10 Connettori per apparecchiature elettroniche - Prove e misure. EI 17,00CEI 48-183 Parte 9-1: Prove di durata - Prova 9a: Funzionamento
meccanico. 16 pagine Fasc. 10785ORGANO TECNICO: CT 57 - SCAMBIO INFORMATIVO ASSOCIATO ALLA GESTIONE DEI SISTEMI ELETTRICI DI POTENZACEI EN 61850-7-420 2010-10 Reti e sistemi di comunicazione per l'automazione nell'ambito EN 143,00CEI 57-76 dei sistemi elettrici. Parte 7-420: Strutture di comunicazione
di base - Nodi logici relativi alle risorse energetiche distribuite.106 pagine Fasc. 10728 E
ORGANO TECNICO: CT 59/61 - APPARECCHI UTILIZZATORI ELETTRICI PER USO DOMESTICO E SIMILARE CEI EN 50523-1 2010-10 Collegamento in rete di apparecchi elettrici di uso domestico. EN 120,00CEI 59-36 Parte 1: Specifiche funzionali. 82 pagine Fasc. 10747 ECEI EN 50523-2 2010-10 Collegamento in rete di apparecchi elettrici di uso domestico. EN 38,00CEI 59-37 Parte 2: Struttura dati. 20 pagine Fasc. 10748 ECEI EN 60335-1/EC 2010-09 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare EI 0,00CEI 61-150;V3 – Sicurezza. Parte 1: Norme generali.
8 pagine (Variante) Fasc. 10679CEI 107-53;V1 2010-10 Ventilatori aeratori d’uso domestico e similare - Verifica delle IT 10,00
prestazioni. 6 pagine (Variante) Fasc. 10797ORGANO TECNICO: CT 62 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER USO MEDICOCEI EN 60613 2010-09 Caratteristiche elettriche e di carico dei complessi EI 71,00CEI 62-37 tubo-guaina per diagnostica medica. 46 pagine Fasc. 10673CEI EN 60601-2-29 2010-09 Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Prescrizioni particolari EN/IT 81,00CEI 62-79 relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni
essenziali di simulatori per radioterapia. 34 pagine Fasc. 10691 ECEI EN 61676/A1 2010-09 Apparecchi elettromedicali - Strumenti dosimetrici usati per EN/IT 14,00CEI 62-132;V1 la misura non-invasiva della tensione del tubo radiogeno in
radiologia diagnostica. 10 pagine (Variante) Fasc. 10692 ECEI EN 62353 2010-10 Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da EI 139,00CEI 62-148 effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi
elettromedicali. 110 pagine (Prima edizione) Fasc. 10793CEI UNI EN 1041 2010-09 Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici. EI 57,00CEI 62-151 48 pagine Fasc. 10657CEI EN 62494-1 2010-09 Apparecchi elettromedicali - Caratteristiche dei sistemi digitali EI 50,00CEI 62-156 per la produzione di immagini mediante raggi X. Parte 1:
Definizione e prescrizioni per radiografia generale. 44 pagine Fasc. 10675
CEI EN 62220-1-3 2010-09 Apparecchi elettromedicali - Caratteristiche dei dispositivi EI 84,00CEI 62-157 digitali per la produzione di immagini mediante raggi X. Parte 1:
Determinazione dell'efficienza quantica di rivelazione - Rivelatori usati per immagini dinamiche. 74 pagine Fasc. 10674
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
53U&C n.10 novembre/dicembre 2010
tutte
le norme
CEI EN 62563-1 2010-10 Apparecchi elettromedicali - Sistemi di visualizzazione delle EI 145,00CEI 62-162 immagini mediche . Parte 1: Metodi di valutazione.
120 pagine Fasc. 10794ORGANO TECNICO: CT 65 - MISURA, CONTROLLO E AUTOMAZIONE NEI PROCESSI INDUSTRIALICEI EN 62453-2 2010-10 Specifica dell'interfaccia dello strumento di descrizione dei EN 151,00CEI 65-209 dispositivi di campo. Parte 2: Principi e descrizione dettagliata.
162 pagine Fasc. 10744 EORGANO TECNICO: CT 78 - LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE CEI EN 61111 2010-09 Lavori sotto tensione - Tappeti di materiale isolante per scopi EN/IT 101,00CEI 78-10 elettrici. 40 pagine Fasc. 10685 ECEI EN 61112 2010-09 Lavori sotto tensione - Teli di materiale isolante per scopi EN/IT 125,00CEI 78-11 elettrici. 48 pagine Fasc. 10686 ECEI EN 62192 2010-09 Lavori sotto tensione - Corde isolanti. EN/IT 71,00CEI 78-12 28 pagine Fasc. 10688 ECEI EN 61477 2010-09 Lavori sotto tensione - Prescrizioni minime per l'uso di attrezzi, EN/IT 44,00CEI 78-13 di dispositivi e di equipaggiamenti. 22 pagine Fasc. 10687 EORGANO TECNICO: CT 79 - SISTEMI DI RILEVAMENTO E SEGNALAZIONE PER INCENDIO, INTRUSIONE, FURTO, SABOTAGGIO E AGGRESSIONECEI 79-5/1;V1 2010-10 Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni IT 0,00
di sicurezza (allarmi). Parte 1: Livelli di trasporto. 6 pagine (Variante) Fasc. 10780
CEI 79-5/2;V1 2010-10 Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni IT 0,00di sicurezza (allarmi). Parte 2: Livello applicativo. 4 pagine (Variante) Fasc. 10781
ORGANO TECNICO: CT 82 - SISTEMI DI CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELL'ENERGIA SOLARECEI 82-25 2010-09 Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica
collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione. 164 pagine Fasc. 10668 C IT 60,00
ORGANO TECNICO: CT 86 - FIBRE OTTICHECEI EN 61300-2-34 2010-10 Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre EN 25,00CEI 86-39 ottiche - Procedure di prova e di misura fondamentali.
Parte 2-34: Prove - Resistenza di componenti di interconnessione e muffole a solventi e fluidi contaminanti . 16 pagine Fasc. 10734 E
CEI EN 61314-1 2010-10 Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre EN 50,00CEI 86-70 ottiche - Fan-out per fibre ottiche. Parte 1: Specifica generica.
26 pagine Fasc. 10737 ECEI EN 61202-1 2010-10 Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre EN 76,00CEI 86-128 ottiche - Isolatori per fibra ottica. Parte 1: Specifica generica.
34 pagine Fasc. 10730 ECEI EN 61754-15 2010-10 Dispositivi di interconnessione e componenti passivi in fibra EN 36,00CEI 86-164 ottica - Interfacce di connettori per fibre ottiche. Parte 15:
Famiglia di connettori tipo LSH. 22 pagine Fasc. 10739 ECEI EN 60793-1-47 2010-10 Fibre ottiche. Parte 1-47: Metodi di misura e procedure di EN 39,00CEI 86-225 prova - Perdite per macrocurvatura. 24 pagine Fasc. 10729 ECEI EN 61280-2-3 2010-10 Procedure di prova per sottosistemi di telecomunicazioni in EN 104,00CEI 86-287 fibra ottica. Parte 2-3: Sistemi numerici - Misure di jitter e
wander. 48 pagine Fasc. 10731 ECEI EN 61280-2-9 2010-10 Procedure di prova per sottosistemi di telecomunicazioni in EN 59,00CEI 86-288 fibra ottica. Parte 2-9: Sistemi numerici - Misura del rapporto
segnale-rumore ottico per i sistemi a multiplazione stretta di lunghezza d'onda. 28 pagine Fasc. 10732 E
CEI EN 61290-10-1 2010-10 Amplificatori ottici - Metodi di prova. Parte 10-1: Parametri del EN 67,00CEI 86-289 funzionamento in multicanale - Metodo impulsivo mediante
l'uso di un deviatore ottico ed un analizzatore di spettro ottico. 32 pagine Fasc. 10733 E
CEI EN 61300-2-48 2010-10 Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre EN 28,00CEI 86-290 ottiche - Procedure di prova e di misura fondamentali.
Parte 2-48: Prove - Cicli di temperatura-umidità. 18 pagine Fasc. 10735 E
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
CEI EN 61300-3-43 2010-10 Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre EN 50,00CEI 86-291 ottiche - Procedure di prova e di misura fondamentali. Parte
3-43: Esami e misure - Misura di funzione di trasferimento di modo per sorgenti di fibre ottiche. 26 pagine Fasc. 10736 E
CEI EN 61753-031-3 2010-10 Norma di prestazione di dispositivi di interconnessione e EN 45,00CEI 86-292 componenti passivi per fibre ottiche . Parte 031-3: Dispositivi
di diramazione 1XN e 2XN monomodo, non connettorizzati e non selettivi in lunghezza d'onda, per Categoria U - Ambiente non controllato. 24 pagine Fasc. 10738 E
CEI EN 61754-24-11 2010-10 Dispositivi di interconnessione e componenti passivi in fibra EN 31,00CEI 86-293 ottica - Interfacce di connettori in fibre ottiche. Parte 24 -11:
Connettori tipo SC-RJ con involucro di protezione basato sulla IEC 61076-3-117. 18 pagine Fasc. 10740 E
CEI EN 61754-24-21 2010-10 Dispositivi di interconnessione e componenti passivi per fibre EN 28,00CEI 86-294 ottiche - Interfacce di connettori in fibre ottiche. Parte 24 -21:
Interfaccia standard per connettori tipo SC-RJ con involucro di protezione basato sulla IEC 61076-3-106, Variante 06. 18 pagine Fasc. 10741 E
CEI EN 62149-2 2010-10 Componenti e dispositivi attivi a fibra ottica - Norme EN 50,00CEI 86-295 prestazionali. Parte 2: Dispositivo laser con superficie a
cavità verticale e con emissione a 850 nm. 26 pagine Fasc. 10742 E
CEI EN 62343-5-1 2010-10 Moduli dinamici - Metodi di prova. Parte 5-1: Equalizzatore EN 50,00CEI 86-296 dinamico del gain tilt - Misura del tempo di risposta.
24 pagine Fasc. 10743 EORGANO TECNICO: CT 100 - SISTEMI E APPARECCHIATURE AUDIO, VIDEO E MULTIMEDIALI CEI EN 60728-7-3 2010-09 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori EI 111,00CEI 100-125 e servizi interattivi. Parte 7-3: Monitoraggio dello stato di un
impianto esterno ibrido fibra-coassiale - Specifica del Bus (PSTIB) di interfaccia tra i transponder e l'alimentazione elettrica. 74 pagine Fasc. 10663
CEI EN 60728-1-1 2010-10 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori EI 145,00CEI 100-161 e servizi interattivi. Parte 1-1: Cablaggio a RF per reti
domestiche a due vie. 118 pagine Fasc. 10782CEI EN 60728-13 2010-10 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori EI 162,00CEI 100-162 e servizi interattivi. Parte 13: Impianti in fibra ottica per la
trasmissione di segnali di radiodiffusione televisiva. 140 pagine Fasc. 10783
ORGANO TECNICO: CT 101 - ELETTROSTATICACEI 101-4;V1 2010-09 Elettrostatica. Parte 5-2: Protezione di dispositivi elettronici EI 0,00
dai fenomeni elettrostatici - Guida d'uso. 8 pagine (Variante) Fasc. 10680
ORGANO TECNICO: CT 205 - SISTEMI BUS PER EDIFICI CEI EN 50491-2 2010-09 Requisiti generali per i Sistemi elettronici per la casa e EI 51,00CEI 205-17 l'edificio (HBES) ed i Sistemi di automazione e controllo di
edifici (BACS). Parte 2: Condizioni ambientali. 34 pagine Fasc. 10664
ORGANO TECNICO: CT 210 - COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA CEI EN 55014-1/A1 2010-10 Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni per gli EI 55,00CEI 110-1;V1 elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari.
Parte 1: Emissione. 36 pagine (Variante) Fasc. 10790
CEI EN 61000-4-4/A1 2010-09 Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 4-4: Tecniche EI 12,00CEI 210-35;V2 di prova e di misura - Prova di immunità a transitori/treni
elettrici veloci. 10 pagine (Variante) Fasc. 10669
CEI EN 61000-4-14/A2 2010-10 Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 4-14: Tecniche EI 17,00CEI 210-56;V2 di prova e di misura - Prova d'immunità a fluttuazioni di
tensione. 16 pagine (Variante) Fasc. 10791
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
tutte
le norme
U&C n.10 novembre/dicembre 201054
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
CEI EN 61000-4-34/A1 2010-10 Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 4-34: Tecniche EI 38,00CEI 210-95;V1 di prova e di misura - Prove di immunità ai buchi di tensione
e alle variazioni di tensione per le apparecchiature con corrente di ingresso superiore a 16 A per fase. 22 pagine (Variante) Fasc. 10792
ORGANO TECNICO: CT 309 - COMPONENTISTICA ELETTRONICA CEI EN 60384-1 2010-09 Condensatori fissi per uso in apparecchiature elettroniche. EI 169,00CEI 309-16 Parte 1: Specifica generale. 156 pagine Fasc. 10656ORGANO TECNICO: CT 311 - GENERAZIONE, MICROGENERAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICACEI 11-20;V3 2010-09 Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di IT 0,00
continuità collegati a reti di I e II categoria. 4 pagine (Variante) Fasc. 10671
CEI UNI EN 15900 2010-10 Efficienza energetica dei servizi. Definizioni e requisiti. EN 22,50CEI 311-5 12 pagine Fasc. 10746 EORGANO TECNICO: CT 501 - VALUTAZIONE, ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA CONFORMITÀCEI UNI EN ISO/IEC 17050-1 2010-09 Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità CEI 501-12 rilasciata dal fornitore. Parte 1: Requisiti generali.
20 pagine Fasc. 10678 EI 32,00
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
NORME UNINUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DI
PUBBLICAZIONE LISTINO (€)ORGANO TECNICO: ACUSTICA E VIBRAZIONIUNI EN 15927:2010 7-10-2010 Servizi offerti dagli audioprotesisti EN 46,50UNI EN ISO 10052:2010 19-10-2010 Acustica - Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per IT 64,00
via aerea, del rumore da calpestio e della rumorosità degli impianti - Metodo di controllo
UNI EN ISO 7779:2010 7-10-2010 Acustica - Misurazione del rumore aereo emesso dalle EN 73,50apparecchiature informatiche e di telecomunicazione
UNI/TS 11387:2010 14-10-2010 Acustica - Linee guida alla mappatura acustica e mappatura IT 91,00acustica strategica - Modalità di stesura delle mappe
ORGANO TECNICO: ACUSTICA E VIBRAZIONI; PRODOTTI, PROCESSI E SISTEMI PER L’ORGANISMO EDILIZIOUNI EN ISO 10140-1:2010 21-10-2010 Acustica - Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico EN 54,50
di edifici e di elementi di edificio - Parte 1: Regole di applicazione per prodotti particolari
UNI EN ISO 10140-2:2010 21-10-2010 Acustica - Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico EN 36,00di edifici e di elementi di edificio - Part 2: Misurazione dell’isolamento acustico per via aerea
UNI EN ISO 10140-3:2010 21-10-2010 Acustica - Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico EN 32,00di edifici e di elementi di edificio - Part 3: Misurazione dell’isolamento del rumore da calpestio
UNI EN ISO 10140-4:2010 21-10-2010 Acustica - Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico EN 32,00di edifici e di elementi di edificio - Parte 4: Procedure e requisiti di misurazione
UNI EN ISO 10140-5:2010 21-10-2010 Acustica - Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico EN 57,00di edifici e di elementi di edificio - Parte 5: Requisiti per le apparecchiature e le strutture di prova
UNI EN ISO 10848-4:2010 7-10-2010 Acustica - Misurazione in laboratorio della trasmissione EN 27,00laterale, tra ambienti adiacenti, del rumore emesso per via aerea e del rumore di calpestio - Parte 4: Applicazione a un giunto con almeno un elemento pesante
UNI EN ISO 15186-2:2010 21-10-2010 Acustica - Misurazione mediante intensità sonora EN 51,50dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 2: Misurazioni in opera
I soci effettivi hanno diritto allo sconto del 50% sul prezzo di listino.Norme pubblicate dal 4 settembre al 28 ottobre 2010
tutte
le norme
U&C n.10 novembre/dicembre 2010 55
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
56 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
tutte
le norme
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
UNI EN ISO 15186-3:2010 21-10-2010 Acustica - Misurazione mediante intensità sonora EN 36,00dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Parte 3: Misurazioni in laboratorio alle basse frequenze
UNI EN ISO 3822-3:2010 12-10-2010 Acustica - Misurazione in laboratorio del rumore emesso dai IT 41,50rubinetti e dalle apparecchiature idrauliche utilizzate negli impianti per la distribuzione dell’acqua - Parte 3: Condizioni di montaggio e di funzionamento delle apparecchiature e delle valvole sull’impianto
ORGANO TECNICO: AGROALIMENTAREUNI 11375:2010 23-09-2010 Miele di melata o miele di bosco - Definizione, requisiti e IT 41,50
metodi analisiUNI 11376:2010 23-09-2010 Miele di castagno (Castanea sativa Miller) - Definizione, IT 41,50
requisiti e metodi analisiUNI 11381:2010 23-09-2010 Ambienti delle industrie alimentari - Sistemi di monitoraggio IT 32,00
degli insettiUNI 11382:2010 23-09-2010 Miele di acacia (Robinia pseudacacia L.) - Definizione, IT 36,00
requisiti e metodi analisiUNI 11383:2010 23-09-2010 Miele di eucalipto - Definizione, requisiti e metodi di analisi IT 36,00UNI 11384:2010 23-09-2010 Miele di agrumi (Citrus spp.) - Definizione, requisiti IT 41,50
e metodi analisiUNI EN 12042:2010 21-10-2010 Macchine per l’industria alimentare - Spezzatrici EN 64,00
automatiche - Requisiti di sicurezza e di igieneUNI EN 12043:2010 21-10-2010 Macchine per l’industria alimentare - Celle di lievitazione EN 64,00
intermedia - Requisiti di sicurezza e di igieneUNI EN 12331:2010 9-09-2010 Macchine per l’industria alimentare - Macchine tritacarne EN 60,00
- Requisiti di sicurezza e di igieneUNI EN 13870:2010 9-09-2010 Macchine per l’industria alimentare - Macchine taglia EN 57,00
cotolette - Requisiti di sicurezza e di igieneUNI EN 13871:2010 9-09-2010 Macchine per l’industria alimentare - Macchine cubettatrici EN 66,00
- Requisiti di sicurezza e di igieneUNI EN 13885:2010 9-09-2010 Macchine per l’industria alimentare - Macchine clippatrici EN 60,00
- Requisiti di sicurezza e di igieneUNI EN 453:2010 7-09-2010 Macchine per l’industria alimentare - Impastatrici per IT 66,00
prodotti alimentari - Requisiti di sicurezza e di igieneUNI EN 454:2010 7-09-2010 Macchine per l’industria alimentare - Mescolatrici planetarie IT 66,00
- Requisiti di sicurezza e di igieneUNI EN ISO 13720:2010 7-10-2010 Carne e prodotti a base di carne EN 27,00
- Conta di Pseudomonas spp. presuntoUNI EN ISO 6887-5:2010 7-10-2010 Microbiologia di alimenti e mangimi per animali EN 36,00
- Preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e delle diluizioni decimali per l’analisi microbiologica - Parte 5: Regole specifiche per la preparazione di latte e prodotti derivati
ORGANO TECNICO: AMBIENTEUNI EN 15852:2010 7-10-2010 Qualità dell’aria ambiente - Metodo normalizzato per la EN 60,00
determinazione di mercurio gassoso totaleUNI EN 15853:2010 7-10-2010 Qualità dell’aria ambiente - Metodo normalizzato per la EN 54,50
determinazione di deposizione di mercurioUNI EN 15859:2010 14-10-2010 Qualità dell’aria - Certificazione degli analizzatori automatici EN 57,00
di polveri negli impianti di filtrazione per l’utilizzo su sorgenti fisse - Criteri di prestazione e procedure di prova
UNI EN 1911:2010 7-10-2010 Emissioni da sorgente fissa EN 60,00- Determinazione della concentrazione in massa di cloruri gassosi espressi come HCI - Metodo di riferimento normalizzato
UNI EN ISO 14015:2010 9-09-2010 Gestione ambientale - Valutazione ambientale di siti EN 46,50e organizzazioni (EASO)
UNI EN ISO 14050:2010 16-09-2010 Gestione ambientale - Vocabolario EN 102,50
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
57U&C n.10 novembre/dicembre 2010
tutte
le norme
57
tutte
le norme
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
UNI EN ISO 21258:2010 7-10-2010 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della EN 54,50concentrazione in massa di monossido di diazoto (N2O) - Metodo di riferimento: metodo a infrarosso non dispersivo
UNI EN ISO 25140:2010 7-10-2010 Emissioni da sorgente fissa - Metodo automatico per la EN 54,50determinazione della concentrazione di metano utilizzando un rilevatore a ionizzazione di fiamma (FID)
ORGANO TECNICO: APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E RELATIVI ACCESSORIUNI EN 13135-1:2010 26-10-2010 Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura - Parte 1: IT 57,00
Apparecchiatura elettrotecnicaUNI EN 13135-2:2010 7-10-2010 Apparecchi di sollevamento - Attrezzatura - Parte 1: EN 66,00
Attrezzatura non elettrotecnicaUNI EN 1493:2010 7-10-2010 Sollevatori per veicoli EN 70,00ORGANO TECNICO: CALZATUREUNI CEN ISO/TR 16178:2010 21-10-2010 Calzature - Sostanze critiche potenzialmente presenti nelle EN 60,00
calzature e nei componenti delle calzatureUNI EN ISO 10765:2010 9-09-2010 Calzature - Metodo di prova per la caratterizzazione dei EN 27,00
materiali elastici - Caratteristiche di trazioneUNI EN ISO 10768:2010 9-09-2010 Calzature - Metodo di prova per la determinazione della EN 22,50
resistenza dei materiali elastici per le calzature all’estensione ripetuta - Resistenza alla fatica
ORGANO TECNICO: CCTUNI CEN/TS 843-9:2010 14-10-2010 Ceramiche tecniche avanzate - Proprietà meccaniche delle EN 27,00
ceramiche monolitiche a temperatura ambiente - Parte 9: Metodo di prova per la resistenza alla slabbratura
UNI EN 1007-7:2010 9-09-2010 Ceramiche tecniche avanzate - Compositi ceramici - Metodi EN 46,50di prova per i rinforzi - Parte 7: Determinazione della distribuzione della resistenza alla trazione e della deformazione alla rottura di filamenti in un cavo multifilamento ad alta temperatura
UNI EN 15365:2010 7-10-2010 Ceramiche tecniche avanzate - Proprietà meccaniche delle EN 36,00fibre ceramiche ad alta temperatura in ambiente inerte - Determinazione del comportamento allo scorrimento a caldo (creep) mediante il metodo delle estremità e degli afferraggi freddi
UNI EN 843-7:2010 9-09-2010 Ceramiche tecniche avanzate - Proprietà meccaniche EN 27,00delle ceramiche monolitiche a temperatura ambiente - Parte 7: Prove su anelli a C (C-ring)
UNI EN 843-8:2010 9-09-2010 Ceramiche tecniche avanzate - Proprietà meccaniche delle EN 27,00ceramiche monolitiche a temperatura ambiente - Parte 8: Linee guida per l’esecuzione delle prove di accettazione
UNI EN ISO 11990-2:2010 9-09-2010 Laser e sistemi laser - Determinazione della resistenza al EN 32,00laser di tubi tracheali - Parte 2: Palloncino dei tubi tracheali
ORGANO TECNICO: CEMENTO, MALTE, CALCESTRUZZI E CEMENTO ARMATOUNI EN 12350-10:2010 9-09-2010 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 10: Calcestruzzo EN 27,00
autocompattante - Prova di scorrimento confinato mediante scatola ad L
UNI EN 12350-11:2010 9-09-2010 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 11: Calcestruzzo EN 22,50autocompattante - Prova di segregazione mediante setaccio
UNI EN 12350-12:2010 9-09-2010 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 12: Calcestruzzo EN 27,00autocompattante - Prova di scorrimento confinato mediante anello a J
UNI EN 12350-8:2010 9-09-2010 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 8: Calcestruzzo EN 22,50autocompattante - Prova di spandimento e del tempo di spandimento
UNI EN 12350-9:2010 9-09-2010 Prova sul calcestruzzo fresco - Parte 9: Calcestruzzo EN 22,50autocompattante - Prova del tempo di efflusso
UNI EN 459-1:2010 7-10-2010 Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche EN 64,00e criteri di conformità
UNI EN 459-2:2010 7-10-2010 Calci da costruzione - Parte 2: Metodi di prova EN 73,50
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
U&C n.7 luglio/agosto 201058
tutte
le norme
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
U&C n.10 novembre/dicembre 2010
UNI EN 998-1:2010 7-10-2010 Specifiche per malte per opere murarie EN 46,50- Parte 1: Malte per intonaci interni ed esterni
UNI EN 998-2:2010 7-10-2010 Specifiche per malte per opere murarie EN 51,50- Parte 2: Malte da muratura
ORGANO TECNICO: CIGUNI 10682:2010 21-10-2010 Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione IT 60,00
- Progettazione, costruzione, installazione, collaudo ed esercizio
UNI EN 13203-3:2010 7-10-2010 Apparecchi domestici alimentati a gas per la produzione EN 54,50di acqua calda sanitaria abbinati a un collettore solare - Apparecchi di portata termica nominale non maggiore di 70 kW e capacità di accumulo di acqua di 500 litri - Parte 3: Valutazione del consumo di energia
UNI EN 257:2010 9-09-2010 Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas EN 54,50UNI EN 30-1-1:2010 16-09-2010 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico EN 96,00
- Parte 1-1: Sicurezza - GeneralitàUNI/TS 11291-6:2010 9-09-2010 Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione IT 57,00
del gas su base oraria - Parte 6: Requisiti per gruppi di misura con portata minore di 10 m3/h (contatore MINOREG10)
ORGANO TECNICO: COMPORTAMENTO ALL’INCENDIOUNI EN 13823:2010 16-09-2010 Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione EN 84,50
- Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione
ORGANO TECNICO: COSTRUZIONI STRADALI ED OPERE CIVILI DELLE INFRASTRUTTUREUNI CEN/TS 15901-6:2010 5-10-2010 Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali EI 41,50
ed aeroportuali - Parte 6: Procedura per determinare l’aderenza della pavimentazione mediante misurazione del coefficiente di aderenza trasversale (SFCS): SCRIM©
UNI CEN/TS 15901-7:2010 5-10-2010 Caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali ed EI 41,50aeroportuali - Parte 7: Procedura per determinare l’aderenza della pavimentazione utilizzando un dispositivo con scorrimento longitudinale fisso (LFCG): il GripTester©
UNI EN 12697-44:2010 27-10-2010 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati EN 32,00bituminosi a caldo - Parte 44: Propagazione della fessura mediante prova di flessione su provino semi-circolare
UNI EN 12697-47:2010 9-09-2010 Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati EN 22,50bituminosi a caldo - Parte 47: Determinazione del contenuto di ceneri degli asfalti naturali
UNI EN 13285:2010 14-10-2010 Miscele non legate - Specifiche EN 41,50UNI EN 13286-2:2010 14-10-2010 Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 2: EN 51,50
Metodi di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Costipamento Proctor
ORGANO TECNICO: CTIUNI CEI EN 15900:2010 7-10-2010 Efficienza energetica dei servizi - Definizioni e requisiti EN 22,50UNI CEN/TR 15404:2010 21-10-2010 Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione EN 36,00
del comportamento termico delle ceneri a temperature caratteristiche
UNI CEN/TR 15985:2010 9-09-2010 Isolanti termici - Prodotti di polistirene espanso (EPS) EN 22,50ottenuti in fabbrica - Certificazione volontaria delle materie prime
UNI CEN/TS 15405:2010 21-10-2010 Combustibili solidi secondari - Determinazione EN 32,00della massa volumica di pellet e brichette
UNI CEN/TS 15406:2010 21-10-2010 Combustibili solidi secondari - Determinazione delle EN 32,00proprietà ponte di materiale alla rinfusa
UNI CEN/TS 15639:2010 21-10-2010 Combustibili solidi secondari - Determinazione della EN 22,50durabilità meccanica dei pellet
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
59
tutte
le norme
U&C n.10 novembre/dicembre 2010
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
UNI EN 13141-2:2010 9-09-2010 Ventilazione degli edifici - Verifica della prestazione di EN 46,50componenti/ prodotti per la ventilazione degli alloggi - Parte 2: Bocchette per l’estrazione e l’immissione dell’aria
UNI EN 15599-1:2010 16-09-2010 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni EN 46,50industriali - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP) - Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera
UNI EN 15599-2:2010 16-09-2010 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni EN 22,50industriali - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP) - Parte 2: Specifiche per i prodotti messi in opera
UNI EN 15600-1:2010 16-09-2010 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni EN 46,50industriali - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di vermiculite espansa (EV) - Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera
UNI EN 15600-2:2010 16-09-2010 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni EN 22,50industriali - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di vermiculite espansa (EV) - Parte 2: Specifiche per i prodotti messi in opera
UNI EN 15805:2010 7-10-2010 Filtri per la rimozione di particelle in aria di ventilazione EN 22,50- Dimensioni normalizzate
UNI EN ISO 9229:2008 21-09-2010 Isolamento termico - Terminologia IT 66,00UNI/TS 11325-3:2010 14-10-2010 Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione IT 41,50
delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata
ORGANO TECNICO: CUNAUNI 11324:2010 16-09-2010 Macchine agricole e forestali - Fasciatrici portate, IT 54,50
semiportate e trainate per balle di foraggio - SicurezzaUNI EN 1374:2010 9-09-2010 Macchine agricole - Scaricatori di insilato fissi per sili EN 46,50
cilindrici - SicurezzaUNI EN 14910:2010 9-09-2010 Macchine da giardinaggio - Tagliaerba a motore con EN 64,00
conducente a piedi - SicurezzaUNI EN ISO 4254-10:2010 9-09-2010 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 10: Spandivoltafieno EN 57,00
e ranghiatori rotativiUNI EN ISO 9261:2010 9-09-2010 Macchine agricole per l’irrigazione - Irrigatori e tubi irrigatori EN 41,50
- Specifiche e metodi di provaORGANO TECNICO: CUOIO, PELLI E PELLETTERIAUNI 11380:2010 23-09-2010 Cuoio e pelli - Linee guida per la misurazione della superficie IT 36,00
di cuoi e pelli mediante misuratrici elettronicheORGANO TECNICO: DISEGNI TECNICI/DOC.TECNICA DI PRODOTTOUNI EN ISO 26909:2010 27-10-2010 Molle - Vocabolario EN 80,50ORGANO TECNICO: DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONE AUTOMATICAUNI 11386:2010 14-10-2010 Supporto all’Interoperabilità nella Conservazione e nel IT 66,00
Recupero degli Oggetti digitali (SInCRO)UNI ISO 3297:2010 27-10-2010 Informazione e documentazione - Sistema internazionale IT 46,50
unificato per la numerazione delle pubblicazioni in serie (ISSN)
ORGANO TECNICO: ERGONOMIAUNI 11377-1:2010 23-09-2010 Usabilità dei prodotti industriali IT 36,00
- Parte 1: Principi generali, termini e definizioniUNI 11377-2:2010 23-09-2010 Usabilità dei prodotti industriali IT 51,50
- Parte 2: Metodi e strumenti di interventoUNI EN ISO 9241-400:2007 21-09-2010 Ergonomia dell’interazione uomo-sistema EI 60,00
- Parte 400: Principi e requisiti per i dispositivi fisici di ingresso
ORGANO TECNICO: IMBALLAGGIUNI EN ISO 4180:2010 14-10-2010 Imballaggi - Imballaggi di trasporto completi EN 41,50
e pieni - Regole generali per la definizione dei programmi di prova di prestazione
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
60
tutte
le norme
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
U&C n.10 novembre/dicembre 2010
ORGANO TECNICO: IMPIANTI DI ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI E APPARECCHI SIMILARIUNI EN 115-2:2010 9-09-2010 Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili EN 51,50
- Parte 2: Regole per il miglioramento della sicurezza scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti
UNI EN 12158-1:2010 9-09-2010 Montacarichi da cantiere per materiali - Parte 1: EN 73,50Montacarichi con piattaforma accessibile
UNI EN 12158-2:2010 9-09-2010 Montacarichi da cantiere per materiali - Parte 2: EN 57,00Montacarichi inclinati con dispositivi di trasporto non accessibili
ORGANO TECNICO: IMPIANTI ED ATTREZZI SPORTIVI E RICREATIVIUNI CEN/TR 15913:2009 5-10-2010 Installazioni per gli spettatori - Criteri di disposizione degli EI 51,50
spazi di osservazione per spettatori con esigenze specialiUNI CEN/TR 16041:2010 21-10-2010 Biciclette - Risposte alle richieste di interpretazione EN 27,00
della norma EN 14764UNI CEN/TR 16042:2010 21-10-2010 Biciclette - Risposte alle richieste di interpretazione EN 22,50
della norma EN 14765UNI CEN/TR 16043:2010 21-10-2010 Biciclette - Risposte alle richieste di interpretazione EN 27,00
della norma EN 14766UNI CEN/TR 16044:2010 21-10-2010 Biciclette - Risposte alle richieste di interpretazione EN 27,00
della norma EN 14781UNI EN 1069-1:2010 7-10-2010 Acquascivoli - Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova EN 66,00UNI EN 1069-2:2010 7-10-2010 Acquascivoli - Parte 2: Istruzioni EN 57,00UNI EN 14974:2010 9-09-2010 Installazioni per gli utilizzatori di attrezzature per sport su
rotelle - Requisiti di sicurezza e metodi di prova EN 51,50UNI EN 15288-1:2010 27-10-2010 Piscine - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la progettazione EN 46,50UNI EN 15312:2010 7-10-2010 Attrezzature sportive di libero accesso - Requisiti, inclusa
la sicurezza, e metodi di prova EN 66,00ORGANO TECNICO: INGEGNERIA STRUTTURALEUNI CEN ISO/TS 17892-10:2005 14-09-2010 Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui EI 46,50
terreni - Parte 10: Prove di taglio direttoUNI CEN ISO/TS 17892-11:2005 14-09-2010 Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui EI 51,50
terreni - Parte 11: Determinazione della permeabilità con prove a carico costante o a carico variabile
UNI CEN ISO/TS 17892-12:2005 14-09-2010 Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui EI 41,50terreni - Parte 12: Determinazione dei limiti di Atterberg
UNI CEN ISO/TS 17892-1:2005 7-09-2010 Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui EI 36,00terreni - Parte 1: Determinazione del contenuto in acqua
UNI CEN ISO/TS 17892-2:2005 7-09-2010 Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui EI 41,50terreni - Parte 2: Determinazione della massa volumica dei terreni a grana fine
UNI CEN ISO/TS 17892-3:2005 7-09-2010 Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui EI 36,00terreni - Parte 3: Determinazione della massa volumica dei granuli solidi - Metodo del picnometro
UNI CEN ISO/TS 17892-5:2005 7-09-2010 Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui EI 57,00terreni - Parte 5: Prova edometrica ad incrementi di carico
UNI CEN ISO/TS 17892-6:2005 7-09-2010 Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui EI 36,00terreni - Parte 6: Prova con la punta conica
UNI CEN ISO/TS 17892-7:2005 7-09-2010 Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui EI 36,00terreni - Parte 7: Prova di compressione non confinata su terreni a grana fine
UNI CEN ISO/TS 17892-8:2005 7-09-2010 Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui EI 41,50terreni - Parte 8: Prova triassiale non consolidata non drenata
UNI CEN ISO/TS 17892-9:2005 7-09-2010 Indagini e prove geotecniche - Prove di laboratorio sui EI 54,50terreni - Parte 9: Prove di compressione triassiale, consolidate, su terreni saturi
UNI EN 15258:2009 5-10-2010 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo EI 54,50- Elementi per muri di sostegno
UNI EN 1536:2010 7-10-2010 Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Pali trivellati EN 76,50UNI EN 1538:2010 7-10-2010 Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Diaframmi EN 64,00
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
61U&C n.10 novembre/dicembre 2010
tutte
le norme
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
UNI EN 15878:2010 16-09-2010 Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Termini e definizioni EN 80,50UNI EN 1991-4:2006 23-09-2010 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture EI 108,50
- Parte 4: Azioni su silos e serbatoiUNI/TS 11379:2010 23-09-2010 Scaffalature metalliche - Progettazione sotto carichi sismici IT 73,50
delle scaffalature per lo stoccaggio statico di palletORGANO TECNICO: INGEGNERIA STRUTTURALE;PRODOTTI, PROCESSI E SISTEMI PER L’ORGANISMO EDILIZIOUNI 11385:2010 14-10-2010 Pozzetti e camere d’ispezione di calcestruzzo non armato, IT 32,00
rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali - Requisiti e metodi di prova complementari alla UNI EN 1917
ORGANO TECNICO: LEGNOUNI 11035-3:2010 27-10-2010 Legno strutturale - Classificazione a vista dei legnami IT 46,50
secondo la resistenza meccanica - Parte 3: Travi Uso Fiume e Uso Trieste
UNI CEN/TS 14464:2010 16-09-2010 Segati di legno - Metodo per la misurazione EN 22,50della formazione di crosta
UNI EN 12490:2010 9-09-2010 Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno EN 32,00- Legno massiccio trattato con i preservanti - Determinazione della penetrazione e ritenzione del creosoto nel legno trattato
UNI EN 1533:2010 7-10-2010 Pavimentazioni di legno - Determinazione della resistenza EN 32,00a flessione sotto carico statico - Metodi di prova
UNI EN 312:2010 7-10-2010 Pannelli di particelle di legno - Specifiche EN 36,00UNI EN 408:2010 7-10-2010 Strutture di legno - Legno massiccio e legno lamellare EN 54,50
incollato - Determinazione di alcune proprietà fisiche e meccaniche
ORGANO TECNICO: LUCE E ILLUMINAZIONEUNI CEI 11222:2010 9-09-2010 Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza IT 41,50
negli edifici - Procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo
ORGANO TECNICO: MANUTENZIONEUNI EN 13306:2010 27-10-2010 Manutenzione - Terminologia di manutenzione EN 51,50ORGANO TECNICO: METALLI NON FERROSIUNI 9956:2010 21-10-2010 Titanio - Spugna di titanio - Definizioni, caratteristiche e prove IT 27,00UNI EN 12735-1:2010 16-09-2010 Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura EN 41,50
per condizionamento e refrigerazione - Parte 1: Tubi per sistemi di tubazioni
UNI EN 12735-2:2010 16-09-2010 Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura EN 46,50per condizionamento e refrigerazione - Parte 2: Tubi per apparecchiature
UNI EN 13148:2010 27-10-2010 Rame e leghe di rame - Nastri stagnati a caldo EN 60,00UNI EN 14938-2:2010 16-09-2010 Rame e leghe di rame - Determinazione del contenuto di EN 27,00
bismuto - Parte 2: Metodo spettrometrico per assorbimento atomico in fiamma (FAAS)
UNI EN 15023-3:2010 16-09-2010 Rame e leghe di rame - Determinazione del contenuto EN 32,00di nichel - Parte 3: Metodo spettrometrico per assorbimento atomico in fiamma (FAAS)
UNI EN 15025:2010 16-09-2010 Rame e leghe di rame - Determinazione del contenuto di EN 27,00magnesio - Metodo spettrometrico per assorbimento atomico in fiamma (FAAS)
UNI EN 15605:2010 16-09-2010 Rame e leghe di rame EN 64,00- Spettrometria a emissione ottica accoppiata a plasma induttivo
UNI EN 15915:2010 16-09-2010 Rame e leghe di rame - Determinazione del contenuto di EN 36,00argento - Metodo spettrometrico per assorbimento atomico in fiamma (FAAS)
UNI EN 15916-2:2010 16-09-2010 Rame e leghe di rame - Determinazione del contenuto EN 27,00di tellurio - Parte 2: Contenuto medio di tellurio - Metodo spettrometrico per assorbimento atomico in fiamma (FAAS)
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
62 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
tutte
le norme
UNI EN ISO 10215:2010 7-10-2010 Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe - Determinazione EN 27,00visiva della chiarezza d’immagine degli strati di ossido anodico - Metodo della scala grafica
UNI EN ISO 11876:2010 7-10-2010 Metalli duri - Determinazione del calcio, rame, ferro, EN 22,50potassio, magnesio, manganese, sodio, nichel e zinco nelle polveri metalliche di cobalto - Metodo per spettrometria di assorbimento atomico in fiamma
UNI EN ISO 2085:2010 7-10-2010 Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe - Controllo della EN 17,50continuità degli strati di ossido anodico sottili - Prova al solfato di rame
UNI EN ISO 2128:2010 7-10-2010 Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe - Determinazione EN 17,50dello spessore degli strati di ossido anodico - Metodo non distruttivo mediante microscopio a sezione ottica
UNI EN ISO 2143:2010 9-09-2010 Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe - Valutazione della EN 22,50perdita di potere assorbente dello strato di ossido anodico fissato - Prova alla goccia di colorante con preattacco acido
UNI EN ISO 2376:2010 7-10-2010 Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe - Determinazione EN 17,50della tensione elettrica di perforazione
UNI EN ISO 2931:2010 9-09-2010 Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe - Valutazione della EN 22,50qualità del fissaggio dello strato di ossido anodico mediante misurazione di ammettenza
UNI EN ISO 3210:2010 9-09-2010 Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe - Valutazione della EN 22,50qualità del fissaggio degli strati di ossido anodico mediante misurazione di perdita di massa dopo immersione in soluzioni fosfo-cromiche acide
UNI EN ISO 3211:2010 7-10-2010 Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe - Valutazione della EN 22,50resistenza degli strati di ossido anodico alla criccatura per deformazione
UNI EN ISO 6581:2010 9-09-2010 Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe - Determinazione EN 17,50della solidità comparativa alla luce ultravioletta e al calore degli strati di ossido anodico colorati
UNI EN ISO 7599:2010 9-09-2010 Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe - Specifiche EN 46,50generali per rivestimenti per ossidazione anodica sull’alluminio
UNI EN ISO 7759:2010 7-10-2010 Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe - Misurazione EN 27,00delle caratteristiche di riflettanza delle superfici di alluminio mediante fotogoniometro o fotogoniometro ridotto
UNI EN ISO 8993:2010 7-10-2010 Anodizzazione dell’alluminio e sue leghe - Sistema di EN 32,00valutazione della corrosione puntiforme - Metodo delle immagini tipo
ORGANO TECNICO: METROLOGIA DELLA PORTATA, PRESSIONE, TEMPERATURAUNI EN 13798:2010 7-10-2010 Idrometria - Specifiche di un pozzetto pluviometrico EN 27,00
di riferimentoORGANO TECNICO: MOBILIUNI EN 12227:2010 7-10-2010 Box per uso domestico - Requisiti di sicurezza EN 60,00
e metodi di provaORGANO TECNICO: NANOTECNOLOGIEUNI CEN ISO/TS 27687:2010 7-09-2010 Nanotecnologie - Terminologia e definizioni relative EI 32,00
a nano-oggetti - Nanoparticelle, nanofibre e nanolastreUNI EN ISO 29701:2010 21-10-2010 Nanotecnologie - Prove di rilevazione di endotossine su EN 46,50
campioni di nanomateriali per sistemi in vitro - Prova Limulus amebocyte lysate (LAL)
ORGANO TECNICO: NAVALE; SICUREZZAUNI EN ISO 12402-2:2010 9-09-2010 Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 2: Giubbotti EN 46,50
di salvataggio, livello prestazionale 275 - Requisiti di sicurezza
UNI EN ISO 12402-3:2010 9-09-2010 Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 3: Giubbotti EN 46,50di salvataggio, livello prestazionale 150 - Requisiti di sicurezza
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
63
tutte
le norme
U&C n.10 novembre/dicembre 2010
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
UNI EN ISO 12402-4:2010 9-09-2010 Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 4: Giubbotti di EN 46,50salvataggio, livello prestazionale 100 - Requisiti di sicurezza
UNI EN ISO 12402-5:2010 9-09-2010 Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 5: Aiuti al EN 46,50galleggiamento (livello 50) - Requisiti di sicurezza
UNI EN ISO 12402-6:2010 9-09-2010 Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 6: Giubbotti EN 46,50di salvataggio e aiuti al galleggiamento per scopi speciali - Requisiti di sicurezza e metodi di prova supplementari
ORGANO TECNICO: PRODOTTI, PROCESSI E SISTEMI PER L’ORGANISMO EDILIZIOUNI 11371:2010 23-09-2010 Massetti per parquet e pavimentazioni di legno - Proprietà e IT 41,50
caratteristiche prestazionaliUNI 9182:2010 9-09-2010 Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e IT 76,50
calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestioneUNI EN 12311-2:2010 9-09-2010 Membrane flessibili per impermeabilizzazione EN 27,00
- Determinazione delle proprietà a trazione - Parte 2: Membrane di gomma e di materiale plastico per l’impermeabilizzazione di coperture
UNI EN 12317-2:2010 9-09-2010 Membrane flessibili per impermeabilizzazione EN 22,50- Determinazione della resistenza al taglio delle giunzioni - Parte 2: Membrane di materiale plastico e gomma per l’impermeabilizzazione di coperture
UNI EN 14516:2010 16-09-2010 Vasche da bagno per impieghi domestici EN 46,50UNI EN 14527:2010 16-09-2010 Piatti doccia per impieghi domestici EN 46,50UNI EN 14695:2010 5-10-2010 Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane EI 51,50
bituminose armate per l’impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico - Definizioni e caratteristiche
UNI EN 15643-1:2010 14-10-2010 Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della sostenibilità EN 46,50degli edifici - Parte1: Quadro di riferimento generale
UNI EN 806-4:2010 9-09-2010 Specifiche relative agli impianti all’interno di edifici per il EN 66,00convogliamento di acque destinate al consumo umano - Parte 4: Installazione
UNI EN ISO 8394-1:2010 27-10-2010 Edilizia - Sigillanti - Parte 1: Determinazione EN 22,50dell’estrudibilità dei sigillanti
UNI EN ISO 8394-2:2010 27-10-2010 Edilizia - Sigillanti - Parte 2: Determinazione dell’estrudibilità EN 27,00dei sigillanti impiegando un’apparechiatura normalizzata
ORGANO TECNICO: PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDIUNI EN 15767-3:2010 7-10-2010 Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il EN 41,50
getto di agenti estinguenti - Monitori portatili - Parte 3: Dispositivi per schiuma
UNI ISO/TS 13075:2010 14-10-2010 Sistemi di estinzione a estinguenti gassosi - Sistemi di EN 17,50estinzione ingegnerizzati - Metodo per l’implementazione, la prova e la verifica del calcolo delle portate ai fini dell’approvazione
ORGANO TECNICO: RECIPIENTI PER IL TRASPORTO DI GAS COMPRESSI, DISCIOLTI O LIQUEFATTIUNI EN 13081:2009 19-10-2010 Cisterne per il trasporto di merci pericolose EI 41,50
- Equipaggiamenti di servizio per cisterne - Adattatori ad accoppiatore per il recupero dei vapori
UNI EN 13082:2009 19-10-2010 Cisterne per il trasporto di merci pericolose EI 36,00- Equipaggiamenti di servizio per cisterne - Valvola per il recupero dei vapori
UNI EN 13083:2009 19-10-2010 Cisterne per il trasporto di merci pericolose EI 41,50- Equipaggiamenti di servizio per cisterne - Adattatore per il carico e lo scarico dal fondo
UNI EN 13648-1:2009 26-10-2010 Recipienti criogenici - Dispositivi di sicurezza per la EI 36,00protezione contro la sovrappressione - Parte 1: Valvole di sicurezza per il servizio criogenico
UNI EN ISO 10156:2010 27-10-2010 Gas e miscele di gas - Determinazione del potenziale di EN 51,50infiammabilità e della capacità ossidante per la scelta delle connessioni di uscita delle valvole per bombole
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
64 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
tutte
le norme
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
ORGANO TECNICO: SALDATUREUNI EN ISO 15609-1:2006 12-10-2010 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura EI 32,00
per materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura - Parte 1: Saldatura ad arco
UNI EN ISO 15614-4:2006 19-10-2010 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura IT 46,50per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - Parte 4: Saldatura di finitura di getti di alluminio
UNI EN ISO 15614-5:2005 19-10-2010 Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura EI 51,50per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura - Parte 5: Saldatura ad arco di titanio, zirconio e loro leghe
ORGANO TECNICO: SICUREZZAUNI EN 12013:2008 19-10-2010 Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori IT 60,00
interni - Requisiti di sicurezzaUNI EN 12198-2:2009 7-09-2010 Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei IT 36,00
rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 2: Procedura di misurazione dell’emissione di radiazione
UNI EN 12254:2010 9-09-2010 Schermi per posti di lavoro in presenza di laser EN 41,50- Requisiti di sicurezza e prove
UNI EN 12568:2010 9-09-2010 Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi EN 51,50di prova per puntali e solette antiperforazione
UNI EN 12941:2009 26-10-2010 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie IT 76,50- Elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio - Requisiti, prove, marcatura
UNI EN 12942:2009 26-10-2010 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie IT 73,50- Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove, marcatura
UNI EN 131-2:2010 9-09-2010 Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura EN 57,00UNI EN 13309:2010 16-09-2010 Macchine per costruzioni - Compatibilità elettromagnetica EN 60,00
delle macchine con alimentazione interna elettricaUNI EN 14975:2010 9-09-2010 Scale per sottotetto - Requisiti, marcatura e prove EN 36,00UNI EN 15093:2009 5-10-2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di EI 73,50
laminatoi a caldo di prodotti pianiUNI EN 15094:2009 5-10-2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di EI 73,50
laminatoi a freddo di prodotti pianiUNI EN 1870-5:2010 12-10-2010 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno IT 73,50
- Seghe circolari - Parte 5: Seghe circolari da banco/ troncatrici con taglio dal basso
UNI EN 1870-6:2010 5-10-2010 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno IT 76,50- Seghe circolari - Parte 6: Seghe circolari per legna da ardere e combinate seghe circolari per legna da ardere/seghe circolari da banco, con carico e/o scarico manuale
UNI EN 1870-7:2010 12-10-2010 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno IT 70,00- Seghe circolari - Parte 7: Seghe per tronchi monolama con tavola di avanzamento integrata e carico e/o scarico manuale
UNI EN 1870-9:2010 5-10-2010 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno IT 60,00- Seghe circolari - Parte 9: Troncatrici a doppia lama con avanzamento integrato e con carico e/o scarico manuale
UNI EN 1938:2010 7-10-2010 Protezione personale degli occhi - Occhiali a visiera per EN 54,50utilizzatori di motocicli e ciclomotori
UNI EN 354:2010 7-10-2010 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute EN 36,00- Cordini
UNI EN 420:2010 5-10-2010 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova IT 51,50
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
65
tutte
le norme
U&C n.10 novembre/dicembre 2010
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
UNI EN 421:2010 9-09-2010 Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la EN 46,50contaminazione radioattiva
UNI EN ISO 13287:2008 19-10-2010 Dispositivi di protezione individuale - Calzature - Metodo di EI 41,50prova per la resistenza allo scivolamento
UNI EN ISO 14122-4:2010 9-09-2010 Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al EN 57,00macchinario - Parte 4: Scale fisse
UNI EN ISO 17491-3:2008 21-09-2010 Indumenti di protezione - Metodi di prova per indumenti che EI 32,00forniscono protezione contro prodotti chimici - Parte 3: Determinazione della resistenza alla penetrazione mediante un getto di liquido (prova al getto)
UNI EN ISO 17491-4:2008 21-09-2010 Indumenti di protezione - Metodi di prova per indumenti che EI 32,00forniscono protezione contro prodotti chimici - Parte 4: Determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spruzzo di liquido (prova allo spruzzo)
ORGANO TECNICO: SPECIFICHE E VERIFICHE DIMENSIONALI E GEOMETRICHE DEI PRODOTTIUNI EN ISO 10360-5:2010 7-10-2010 Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Prove di EN 54,50
accettazione e prove di verifica periodica per macchine di misura a coordinate (CMM) - Parte 5: CMM dotate di sistemi tastatori a contatto a stilo singolo e multiplo
UNI EN ISO 25178-601:2010 16-09-2010 Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Tessitura/stato EN 41,50della superficie: metodo areale - Parte 601: Caratteristiche nominali degli strumenti a contatto (stilo)
UNI EN ISO 25178-602:2010 16-09-2010 Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Tessitura/stato EN 54,50della superficie: metodo areale - Parte 602: Caratteristiche nominali degli strumenti senza contatto (tastatori cromatici confocali)
UNI EN ISO 25178-701:2010 16-09-2010 Specifiche geometriche dei prodotti (GPS) - Tessitura/stato EN 51,50della superficie: metodo areale - Parte 701: Campioni di taratura e di misura per strumenti a contatto (stilo)
ORGANO TECNICO: STANIMUCUNI EN 13128:2009 12-10-2010 Sicurezza delle macchine utensili
- Fresatrici (incluse alesatrici)UNI EN 13218:2008 14-09-2010 Macchine utensili - Sicurezza - Rettificatrici fisse IT 91,00ORGANO TECNICO: TECNOLOGIE BIOMEDICHE E DIAGNOSTICHEUNI CEI EN 1041:2009 7-09-2010 Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici EI 57,00UNI EN 1865-1:2010 7-10-2010 Attrezzature per il trasporto dei pazienti utilizzate nelle
autoambulanze - Parte 1: Sistemi generali di barelle e attrezzature per il trasporto dei pazienti EN 51,50
UNI EN 1865-2:2010 7-10-2010 Attrezzature per il trasporto dei pazienti utilizzate nelle autoambulanze - Parte 2: Barelle a propulsione assistita EN 27,00
UNI EN ISO 10873:2010 21-10-2010 Odontoiatria - Adesivi per protesi dentali EN 36,00UNI EN ISO 10993-10:2010 7-10-2010 Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 10:
Prove di irritazione e sensibilizzazione cutanea EN 73,50UNI EN ISO 11609:2010 7-10-2010 Odontoiatria - Dentifrici
- Requisiti, metodi di prova e marcatura EN 46,50UNI EN ISO 11737-2:2010 19-10-2010 Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodi microbiologici EI 54,50
- Parte 2: Prove di sterilità eseguite nel corso della definizione, della convalida e del mantenimento di un processo di sterilizzazione
UNI EN ISO 28158:2010 9-09-2010 Odontoiatria - Porta filo e filo interdentale integrato EN 27,00UNI EN ISO 8362-2:2010 7-10-2010 Contenitori per iniettabili e accessori - Parte 2: Chiusure per EN 22,50
flaconi per iniettabiliORGANO TECNICO: TESSILE E ABBIGLIAMENTOUNI EN 15930:2010 27-10-2010 Fibre - Elasticità delle fibre - Metodi di prova EN 32,00UNI EN ISO 105-D01:2010 9-09-2010 Tessili - Prove di solidità del colore - Parte D01: Solidità del EN 22,50
colore al lavaggio a secco utilizzando solvente percloroetileneUNI EN ISO 105-E05:2010 7-10-2010 Tessili - Prove di solidità del colore EN 17,50
- Parte E05: Solidità del colore agli acidi
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
66 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
tutte
le norme
UNI EN ISO 2061:2010 14-10-2010 Tessili - Determinazione della torsione dei filati - Metodo EN 32,00di conteggio diretto
UNI EN ISO 2307:2010 14-10-2010 Corde di fibra - Determinazione di alcune proprietà fisiche EN 41,50e meccaniche
UNI EN ISO 9554:2010 14-10-2010 Corde di fibra - Specifiche generali EN 46,50ORGANO TECNICO: TRASMISSIONI OLEOIDRAULICHE E PNEUMATICHE; SICUREZZAUNI EN 982:2009 5-10-2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza relativi a IT 51,50
sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Oleoidraulica
UNI EN 983:2009 5-10-2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza relativi IT 51,50a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Pneumatica
ORGANO TECNICO: TRASPORTI INTERNIUNI EN 1526:2008 26-10-2010 Sicurezza dei carrelli industriali - Requisiti aggiuntivi per IT 36,00
funzioni automatiche sui carrelliORGANO TECNICO: TRASPORTO GUIDATO SU FERROUNI 11378:2010 23-09-2010 Metropolitane - Materiale rotabile per metropolitane IT 51,50
- Caratteristiche generali e prestazioniUNI 7360:2010 23-09-2010 Metropolitane - Sagoma cinematica e sagoma limite del IT 46,50
materiale rotabile - Profilo minimo degli ostacoli e distanziamento fra i binari
UNI 7361:2010 23-09-2010 Metropolitane - Scostamenti laterali massimi IT 27,00dei rotabili in moto
UNI EN 12663-1:2010 7-10-2010 Applicazioni ferroviarie - Requisiti strutturali delle casse EN 57,00dei rotabili ferroviari - Parte 1: Locomotive e materiale rotabile per passeggeri (e metodo alternativo per i carri merci)
UNI EN 12663-2:2010 7-10-2010 Applicazioni ferroviarie - Requisiti strutturali delle EN 64,00casse dei rotabili ferroviari - Parte 2: Carri merci
UNI EN 13674-2:2010 23-09-2010 Applicazioni ferroviarie - Binario - Rotaia - Parte 2: Rotaie EN 91,00per scambi e incroci utilizzate in accoppiamento con rotaie Vignole da 46 kg/m e oltre
UNI EN 13674-3:2010 23-09-2010 Applicazioni ferroviarie - Binario - Rotaia EN 46,50- Parte 3: Controrotaie
UNI EN 13803-1:2010 7-10-2010 Applicazioni ferroviarie - Binario - Parametri di EN 73,50progettazione dei tracciati del binario - Scartamento del binario da 1 435 mm e maggiore - Parte 1: Piena linea
UNI EN 14730-1:2010 9-09-2010 Applicazioni ferroviarie - Binario - Saldatura EN 64,00alluminotermica delle rotaie - Parte 1: Approvazione dei processi di saldatura
ORGANO TECNICO: UNI-CEI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀUNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010 9-09-2010 Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità EI 32,00
rilasciata dal fornitore - Parte 1: Requisiti generaliORGANO TECNICO: UNICEMENTOUNI CEN/TS 12390-11:2010 12-10-2010 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 11: Determinazione EI 57,00
della resistenza ai cloruri del calcestruzzo, diffusione unidirezionale
UNI EN 12390-2:2009 12-10-2010 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 2: Confezione e EI 36,00stagionatura dei provini per prove di resistenza
UNI EN 12390-3:2009 26-10-2010 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 3: Resistenza alla EI 54,50compressione dei provini
UNI EN 12390-5:2009 12-10-2010 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 5: Resistenza a EI 41,50flessione dei provini
UNI EN 12390-6:2010 21-09-2010 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 6: Resistenza a EI 41,50trazione indiretta dei provini
UNI EN 12390-7:2009 26-10-2010 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 7: Massa volumica EI 41,50del calcestruzzo indurito
UNI EN 12390-8:2009 26-10-2010 Prove sul calcestruzzo indurito - Parte 8: Profondità di EI 36,00penetrazione dell’acqua sotto pressione
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
67
tutte
le norme
U&C n.10 novembre/dicembre 2010
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
UNI EN 1367-2:2010 5-10-2010 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilitàdegli aggregati - Parte 2: Prova al solfato di magnesio EI 46,50
UNI EN 15743:2010 5-10-2010 Cemento sovrasolfatato - Composizione, specifiche e criteri di conformità EI 57,00
UNI EN 1744-1:2010 5-10-2010 Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Parte 1: Analisi chimica EI 80,50
UNI EN 196-7:2008 26-10-2010 Metodi di prova dei cementi - Parte 7: Metodi di prelievo EI 51,50e di campionatura del cemento
UNI EN 196-8:2010 26-10-2010 Metodi di prova dei cementi - Parte 8: Calore d’idratazione EI 46,50- Metodo per soluzione
UNI EN 480-10:2009 21-09-2010 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione EI 36,00- Metodi di prova - Parte 10: Determinazione del tenore di cloruri solubili in acqua
UNI EN 480-13:2009 5-10-2010 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione EI 36,00- Metodi di prova - Parte 13: Malta da muratura di riferimento per le prove sugli additivi per malta
UNI EN 934-2:2009 26-10-2010 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione EI 57,00- Parte 2: Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura
ORGANO TECNICO: UNICHIMUNI CEN/TS 15968:2010 7-10-2010 Determinazione del perfluoro ottano sulfonato (PFOS) EN 51,50
estraibile in articoli solidi, rivestiti e impregnati, nei liquidi e nelle schiume antincendio - Metodo per il campionamento, l’estrazione e l’analisi per mezzo di LC-qMS o LC-MS
UNI EN 13398:2010 9-09-2010 Bitumi e leganti bituminosi - Determinazione del ritorno EN 22,50elastico di un bitume modificato
UNI EN 13623:2010 7-10-2010 Disinfettanti chimici ed antisettici - Prova in sospensione EN 54,50quantitativa per la valutazione dell’attività battericida rispetto alla Legionella di disinfettanti chimici per sistemi acquosi - Metodo di prova e requisiti (Fase 2, stadio 1)
UNI EN 14733:2010 27-10-2010 Bitumi e leganti bituminosi - Controllo della produzione in fabbrica di bitumi in emulsioni, di bitumi flussati e fluidificati EN 41,50
UNI EN 15928:2010 7-10-2010 Concimi - Determinazione della finezza di macinazione (procedura a secco) EN 17,50
UNI EN 15947-1:2010 27-10-2010 Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, Categorie 1, 2 e 3 EN 41,50- Parte 1: Terminologia
UNI EN 15947-2:2010 27-10-2010 Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, Categorie 1, 2 e 3 EN 32,00- Parte 2: Categorie e tipologie di fuoco artificiale
UNI EN 15947-3:2010 27-10-2010 Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, Categorie 1, 2 e 3 EN 46,50- Parte 3: Requisiti minimi di etichettatura
UNI EN 15947-4:2010 27-10-2010 Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, Categorie 1, 2 e 3 EN 57,00- Parte 4: Metodi di prova
UNI EN 15947-5:2010 27-10-2010 Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, Categorie 1, 2 e 3 EN 51,50- Parte 5: Requisiti per la costruzione e prestazione
UNI EN 15950:2010 27-10-2010 Concimi - Determinazione dell’acido EN 32,00N- (1,2-dicarbossietil)-D,L-aspartico (acido iminodisuccinico, IDHA) mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)
UNI EN ISO 2871-1:2010 9-09-2010 Agenti tensioattivi - Detergenti - Determinazione del EN 22,50contenuto di sostanza attiva cationica - Parte 1: Sostanza attiva cationica ad alta massa molecolare
UNI EN ISO 2871-2:2010 9-09-2010 Agenti tensioattivi - Detergenti - Determinazione del EN 22,50contenuto di sostanza attiva cationica - Parte 2: Sostanza attiva cationica a bassa massa molecolare (tra 200 e 500)
UNI EN ISO 4787:2010 7-10-2010 Vetreria da laboratorio - Strumentazioni volumetriche EN 46,50- Metodi per la verifica della capacità e per l’utilizzo
UNI EN ISO 8510-2:2010 21-10-2010 Adesivi - Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto EN 22,50per incollaggio di un materiale flessibile su rigido - Parte 2: Distacco a 180°
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
68 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
tutte
le norme
ORGANO TECNICO: UNINFOUNI CEN ISO/TS 14907-1:2010 7-10-2010 Riscossione elettronica dei pagamenti - Procedure di prova
per gli apparati utente e gli apparati fissi - Parte 1: Descrizione delle procedure di prova EN 84,50
UNI CEN ISO/TS 17575-1:2010 7-10-2010 Riscossione elettronica dei pagamenti - Definizione EN 46,50dell’interfaccia applicativa per sistemi autonomi - Parte 1: Addebito
UNI CEN ISO/TS 17575-2:2010 7-10-2010 Riscossione elettronica dei pagamenti - Definizione EN 51,50dell’interfaccia applicativa per sistemi autonomi - Parte 2: Comunicazione e connessione ai livelli inferiori
ORGANO TECNICO: UNIPLASTUNI CEN ISO/TS 21003-7:2010 7-10-2010 Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua EN 41,50
calda e fredda all’interno degli edifici - Parte 7: Guida alla valutazione di conformità
UNI CEN/TR 15729:2010 7-10-2010 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Materie plastiche EN 27,00termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) - Rapporto sulla determinazione della abrasione media dopo un numero definito di cicli di prova
UNI EN 13245-1:2010 9-09-2010 Materie plastiche - Profilati di policloruro di vinile non EN 46,50plastificato (PVC-U) per applicazioni edilizie - Parte 1: Designazione dei profilati di PVC-U
UNI EN 13245-3:2010 9-09-2010 Materie plastiche - Profilati di policloruro di vinile non EN 46,50plastificato (PVC-U) per applicazioni edilizie - Parte 3: Designazione dei profilati di PVC-UE
UNI EN 14982:2010 7-10-2010 Sistemi di tubazioni e di canalizzazioni di materia plastica EN 27,00- Elementi di rialzo di materiale termoplastico per camere di ispezione e passi d’uomo - Determinazione della rigidezza anulare
UNI EN 15836-1:2010 9-09-2010 Materie plastiche - Membrane di policloruro di vinile EN 36,00plastificato (PVC- P) per piscine interrate - Parte 1: Membrane omogenee di spessore nominale maggiore o uguale a 0,75 mm
UNI EN 15836-2:2010 9-09-2010 Materie plastiche - Membrane di policloruro di vinile EN 41,50plastificato (PVC- P) per piscine interrate - Parte 2: Membrane rinforzate di spessore nominale maggiore o uguale a 1,5 mm
UNI EN 15860:2010 9-09-2010 Materie plastiche - Prodotti semi- finiti termoplastici EN 60,00per lavorazioni a macchina - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 438-8:2009 12-10-2010 Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Fogli a base EI 41,50di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati) - Parte 8: Classificazione e specifiche per laminati con effetti estetici particolari
UNI EN 438-9:2010 7-10-2010 Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Fogli a base EN 32,00di resine termoindurenti (comunemente chiamati laminati) - Parte 9: Classificazione e specifiche per laminati con strato interno alternativo
UNI EN ISO 179-1:2010 9-09-2010 Materie plastiche - Determinazione delle caratteristiche EN 46,50all’urto Charpy - Parte 1: Prova d’urto non strumentato
UNI EN ISO 3386-1:2010 16-09-2010 Materiali polimerici cellulari flessibili - Determinazione EN 22,50delle caratteristiche sforzo-deformazione in compressione - Parte 1: Materiali a bassa massa volumica
UNI EN ISO 3386-2:2010 16-09-2010 Materiali polimerici cellulari flessibili - Determinazione EN 27,00delle caratteristiche sforzo-deformazione in compressione - Parte 2: Materiali ad alta massa volumica
UNI EN ISO 7231:2010 9-09-2010 Materiali polimerici cellulari flessibili - Determinazione del EN 32,00valore del flusso d’aria ad una caduta di pressione costante
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
69
tutte
le norme
U&C n.10 novembre/dicembre 2010
NUMERO DATA TITOLO LINGUA DI PREZZO DIPUBBLICAZIONE LISTINO (€)
ORGANO TECNICO: UNIPLAST; TESSILE E ABBIGLIAMENTOUNI EN 15619:2010 9-09-2010 Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche EN 46,50
- Sicurezza delle strutture temporanee (tendoni) - Specifiche per supporti tessili rivestiti destinati a tendoni e strutture analoghe
ORGANO TECNICO: UNSIDERUNI 9163:2010 21-10-2010 Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite sferoidale IT 36,00
per condotte in pressione - Giunto elastico automatico - Dimensioni di accoppiamento ed accessori di giunto
UNI EN 1247:2010 21-10-2010 Macchine per fonderia - Requisiti di sicurezza per siviere, EN 57,00materiali di colata, macchine per colata centrifuga, macchine per colata continua o semicontinua
UNI EN 13480-3:2010 23-09-2010 Tubazioni industriali metalliche EN 161,00- Parte 3: Progettazione e calcolo
UNI EN 545:2010 14-10-2010 Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro EN 80,50assemblaggi per condotte d’acqua - Requisiti e metodi di prova
UNI EN ISO 18286:2010 9-09-2010 Lamiere laminate a caldo di acciaio inossidabile EN 27,00- Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma
UNI EN ISO 9444-2:2010 9-09-2010 Acciaio inossidabile laminato a caldo in continuo - Tolleranze EN 27,00sulle dimensioni e sulla forma - Parte 2: Nastri larghi e fogli/lamiere
ORGANO TECNICO: VALVOLE INDUSTRIALIUNI EN ISO 10497:2010 7-10-2010 Prove su valvole - Requisiti per la prova di resistenza al fuoco EN 41,50
NORME RITIRATE CON SOSTITUZIONEDal 4 settembre al 28 ottobre 2010
NORMA RITIRATA IN DATA SOSTITUITA DAUNI 10682:1997 21/10/2010 UNI 10682:2010UNI 10759:1998 09/09/2010 UNI EN ISO 4254-10:2010UNI 11222:2006 09/09/2010 UNI CEI 11222:2010UNI 7247:1973 23/09/2010 UNI 11378:2010UNI 7248:1973 23/09/2010 UNI 11378:2010UNI 7360:1974 + A1:1997 23/09/2010 UNI 7360:2010UNI 7361:1974 23/09/2010 UNI 7361:2010UNI 7491:1975 23/09/2010 UNI 11378:2010UNI 8378:1982 23/09/2010 UNI 11378:2010UNI 8882:1998 23/09/2010 UNI 11378:2010UNI 9163:1987 21/10/2010 UNI 9163:2010UNI 9182:2008 09/09/2010 UNI 9182:2010;
UNI EN 806-4:2010UNI 9956:1992 21/10/2010 UNI 9956:2010UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2005 09/09/2010 UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2005 09/09/2010 UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010UNI CEN ISO/TS 21003-7:2009 07/10/2010 UNI CEN ISO/TS 21003-7:2010UNI CEN/TS 1007-7:2007 09/09/2010 UNI EN 1007-7:2010UNI CEN/TS 14938-2:2007 16/09/2010 UNI EN 14938-2:2010UNI CEN/TS 15023-3:2007 16/09/2010 UNI EN 15023-3:2010UNI CEN/TS 15025:2007 16/09/2010 UNI EN 15025:2010UNI CEN/TS 15365:2006 07/10/2010 UNI EN 15365:2010UNI CEN/TS 15404:2007 21/10/2010 UNI CEN/TR 15404:2010UNI CEN/TS 15405:2007 21/10/2010 UNI CEN/TS 15405:2010UNI CEN/TS 15406:2007 21/10/2010 UNI CEN/TS 15406:2010UNI CEN/TS 15605:2008 16/09/2010 UNI EN 15605:2010UNI CEN/TS 15639:2008 21/10/2010 UNI CEN/TS 15639:2010UNI EN 1069-1:2002 07/10/2010 UNI EN 1069-1:2010
NORMA RITIRATA IN DATA SOSTITUITA DAUNI EN 1069-2:2000 07/10/2010 UNI EN 1069-2:2010UNI EN 12042:2006 21/10/2010 UNI EN 12042:2010UNI EN 12042:2006 21/10/2010 UNI EN 12042:2010UNI EN 12043:2002 21/10/2010 UNI EN 12043:2010UNI EN 12158-1:2005 09/09/2010 UNI EN 12158-1:2010UNI EN 12158-2:2005 09/09/2010 UNI EN 12158-2:2010UNI EN 12227-1:2001 07/10/2010 UNI EN 12227:2010UNI EN 12227-2:2001 07/10/2010 UNI EN 12227:2010UNI EN 12254:2008 09/09/2010 UNI EN 12254:2010UNI EN 12254:2008 09/09/2010 UNI EN 12254:2010UNI EN 12311-2:2002 09/09/2010 UNI EN 12311-2:2010UNI EN 12312-10:2006 16/09/2010 UNI EN 12312-10:2010UNI EN 12312-12:2003 23/09/2010 UNI EN 12312-12:2010UNI EN 12312-13:2003 23/09/2010 UNI EN 12312-13:2010UNI EN 12312-14:2008 23/09/2010 UNI EN 12312-14:2010UNI EN 12312-15:2006 23/09/2010 UNI EN 12312-15:2010UNI EN 12312-16:2006 23/09/2010 UNI EN 12312-16:2010UNI EN 12312-17:2005 23/09/2010 UNI EN 12312-17:2010UNI EN 12312-18:2005 23/09/2010 UNI EN 12312-18:2010UNI EN 12312-19:2006 23/09/2010 UNI EN 12312-19:2010UNI EN 12312-1:2001 16/09/2010 UNI EN 12312-1:2010UNI EN 12312-20:2006 23/09/2010 UNI EN 12312-20:2010UNI EN 12312-2:2003 16/09/2010 UNI EN 12312-2:2010UNI EN 12312-3:2004 16/09/2010 UNI EN 12312-3:2010UNI EN 12312-4:2004 16/09/2010 UNI EN 12312-4:2010UNI EN 12312-5:2005 16/09/2010 UNI EN 12312-5:2010UNI EN 12312-6:2005 16/09/2010 UNI EN 12312-6:2010UNI EN 12312-7:2006 16/09/2010 UNI EN 12312-7:2010
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
70 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
tutte
le norme
NORMA RITIRATA IN DATA SOSTITUITA DAUNI EN 12312-8:2005 16/09/2010 UNI EN 12312-8:2010UNI EN 12312-9:2005 16/09/2010 UNI EN 12312-9:2010UNI EN 12317-2:2002 09/09/2010 UNI EN 12317-2:2010UNI EN 12331:2007 09/09/2010 UNI EN 12331:2010UNI EN 12373-13:2001 07/10/2010 UNI EN ISO 7759:2010UNI EN 12373-14:2001 07/10/2010 UNI EN ISO 10215:2010UNI EN 12373-15:2001 07/10/2010 UNI EN ISO 3211:2010UNI EN 12373-16:2002 07/10/2010 UNI EN ISO 2085:2010UNI EN 12373-17:2002 07/10/2010 UNI EN ISO 2376:2010UNI EN 12373-18:2002 07/10/2010 UNI EN ISO 8993:2010UNI EN 12373-1:2002 09/09/2010 UNI EN ISO 7599:2010UNI EN 12373-3:2000 07/10/2010 UNI EN ISO 2128:2010UNI EN 12373-4:2000 09/09/2010 UNI EN ISO 2143:2010UNI EN 12373-5:2000 09/09/2010 UNI EN ISO 2931:2010UNI EN 12373-6:2000 09/09/2010 UNI EN ISO 3210:2010UNI EN 12373-7:2006 09/09/2010 UNI EN ISO 3210:2010UNI EN 12373-8:2000 09/09/2010 UNI EN ISO 6581:2010UNI EN 1247:2005 21/10/2010 UNI EN 1247:2010UNI EN 12490:2000 09/09/2010 UNI EN 12490:2010UNI EN 12568:2001 09/09/2010 UNI EN 12568:2010UNI EN 12663:2002 07/10/2010 UNI EN 12663-1:2010;
UNI EN 12663-2:2010UNI EN 12735-1:2008 16/09/2010 UNI EN 12735-1:2010UNI EN 12735-2:2008 16/09/2010 UNI EN 12735-2:2010UNI EN 131-2:1994 09/09/2010 UNI EN 131-2:2010UNI EN 13135-2:2005 07/10/2010 UNI EN 13135-2:2010UNI EN 13135-2:2005 07/10/2010 UNI EN 13135-2:2010UNI EN 13141-2:2004 09/09/2010 UNI EN 13141-2:2010UNI EN 13148:2002 27/10/2010 UNI EN 13148:2010UNI EN 13245-1:2006 09/09/2010 UNI EN 13245-1:2010UNI EN 13285:2004 14/10/2010 UNI EN 13285:2010UNI EN 13286-2:2005 14/10/2010 UNI EN 13286-2:2010UNI EN 13306:2003 27/10/2010 UNI EN 13306:2010UNI EN 13309:2002 16/09/2010 UNI EN 13309:2010UNI EN 13398:2004 09/09/2010 UNI EN 13398:2010UNI EN 13480-3:2009 23/09/2010 UNI EN 13480-3:2010UNI EN 13674-2:2006 23/09/2010 UNI EN 13674-2:2010UNI EN 13674-3:2006 23/09/2010 UNI EN 13674-3:2010UNI EN 1374:2002 09/09/2010 UNI EN 1374:2010UNI EN 13798:2003 07/10/2010 UNI EN 13798:2010UNI EN 13823:2005 16/09/2010 UNI EN 13823:2010UNI EN 13870:2005 09/09/2010 UNI EN 13870:2010UNI EN 13870:2005 09/09/2010 UNI EN 13870:2010UNI EN 13871:2005 09/09/2010 UNI EN 13871:2010UNI EN 13871:2005 09/09/2010 UNI EN 13871:2010UNI EN 13885:2006 09/09/2010 UNI EN 13885:2010UNI EN 13885:2006 09/09/2010 UNI EN 13885:2010UNI EN 14035-10:2004 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;
UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-12:2005 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-13:2005 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-15:2005 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
NORMA RITIRATA IN DATA SOSTITUITA DAUNI EN 14035-17:2004 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;
UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-18:2005 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-19:2005 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-1:2005 27/10/2010 UNI EN 15947-1:2010UNI EN 14035-20:2005 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;
UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-21:2006 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-22:2004 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-23:2005 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-24:2004 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-25:2006 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-27:2005 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-28:2004 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-29:2004 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-2:2005 27/10/2010 UNI EN 15947-2:2010UNI EN 14035-31:2006 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;
UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-33:2006 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-34:2005 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-35:2005 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-36:2004 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-38:2006 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-3:2004 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
71
tutte
le norme
U&C n.10 novembre/dicembre 2010
NORMA RITIRATA IN DATA SOSTITUITA DAUNI EN 14035-4:2005 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;
UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-5:2006 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-6:2005 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-7:2004 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-8:2004 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14035-9:2004 27/10/2010 UNI EN 15947-3:2010;UNI EN 15947-4:2010;UNI EN 15947-5:2010
UNI EN 14516:2006 16/09/2010 UNI EN 14516:2010UNI EN 14516:2006 16/09/2010 UNI EN 14516:2010UNI EN 14527:2006 16/09/2010 UNI EN 14527:2010UNI EN 14527:2006 16/09/2010 UNI EN 14527:2010UNI EN 14730-1:2006 09/09/2010 UNI EN 14730-1:2010UNI EN 14733:2005 27/10/2010 UNI EN 14733:2010UNI EN 14910:2007 09/09/2010 UNI EN 14910:2010UNI EN 1493:2009 07/10/2010 UNI EN 1493:2010UNI EN 1493:2009 07/10/2010 UNI EN 1493:2010UNI EN 14974:2006 09/09/2010 UNI EN 14974:2010UNI EN 14974:2006 09/09/2010 UNI EN 14974:2010UNI EN 14975:2007 09/09/2010 UNI EN 14975:2010UNI EN 14982:2007 07/10/2010 UNI EN 14982:2010UNI EN 15288-1:2009 27/10/2010 UNI EN 15288-1:2010UNI EN 15312:2007 07/10/2010 UNI EN 15312:2010UNI EN 15312:2007 07/10/2010 UNI EN 15312:2010UNI EN 1533:2002 07/10/2010 UNI EN 1533:2010UNI EN 1536:2003 07/10/2010 UNI EN 1536:2010UNI EN 1538:2002 07/10/2010 UNI EN 1538:2010UNI EN 15619:2009 09/09/2010 UNI EN 15619:2010UNI EN 1865:2001 07/10/2010 UNI EN 1865-1:2010;
UNI EN 1865-2:2010UNI EN 1911-1:2000 07/10/2010 UNI EN 1911:2010UNI EN 1911-2:2000 07/10/2010 UNI EN 1911:2010UNI EN 1911-3:2000 07/10/2010 UNI EN 1911:2010UNI EN 1938:2000 07/10/2010 UNI EN 1938:2010UNI EN 20140-10:1993 21/10/2010 UNI EN ISO 10140-1:2010;
UNI EN ISO 10140-2:2010;UNI EN ISO 10140-3:2010;UNI EN ISO 10140-4:2010;UNI EN ISO 10140-5:2010
UNI EN 24180-1:1993 14/10/2010 UNI EN ISO 4180:2010UNI EN 24180-2:1994 14/10/2010 UNI EN ISO 4180:2010UNI EN 257:1994 + A1:1998 09/09/2010 UNI EN 257:2010UNI EN 28362-2:1993 07/10/2010 UNI EN ISO 8362-2:2010UNI EN 28394:1992 27/10/2010 UNI EN ISO 8394-1:2010;
UNI EN ISO 8394-2:2010UNI EN 28510-2:1994 21/10/2010 UNI EN ISO 8510-2:2010UNI EN 312:2004 07/10/2010 UNI EN 312:2010UNI EN 3475-802:2003 09/09/2010 UNI EN 3475-802:2010UNI EN 354:2003 07/10/2010 UNI EN 354:2010UNI EN 3730:2001 14/10/2010 UNI EN 3730:2010
NORMA RITIRATA IN DATA SOSTITUITA DAUNI EN 408:2004 07/10/2010 UNI EN 408:2010UNI EN 4113:2001 14/10/2010 UNI EN 4113:2010UNI EN 4114:2001 14/10/2010 UNI EN 4114:2010UNI EN 421:1995 09/09/2010 UNI EN 421:2010UNI EN 459-1:2002 07/10/2010 UNI EN 459-1:2010UNI EN 459-2:2002 07/10/2010 UNI EN 459-2:2010UNI EN 545:2007 14/10/2010 UNI EN 545:2010UNI EN 998-1:2004 07/10/2010 UNI EN 998-1:2010UNI EN 998-2:2004 07/10/2010 UNI EN 998-2:2010UNI EN ISO 10156-2:2005 27/10/2010 UNI EN ISO 10156:2010UNI EN ISO 10156-2:2005 27/10/2010 UNI EN ISO 10156:2010UNI EN ISO 10360-5:2005 07/10/2010 UNI EN ISO 10360-5:2010UNI EN ISO 10497:2004 07/10/2010 UNI EN ISO 10497:2010UNI EN ISO 10497:2004 07/10/2010 UNI EN ISO 10497:2010UNI EN ISO 105-D01:1997 09/09/2010 UNI EN ISO 105-D01:2010UNI EN ISO 105-E05:2006 07/10/2010 UNI EN ISO 105-E05:2010UNI EN ISO 10993-10:2009 07/10/2010 UNI EN ISO 10993-10:2010UNI EN ISO 11609:2001 07/10/2010 UNI EN ISO 11609:2010UNI EN ISO 12402-2:2007 09/09/2010 UNI EN ISO 12402-2:2010UNI EN ISO 12402-3:2007 09/09/2010 UNI EN ISO 12402-3:2010UNI EN ISO 12402-4:2007 09/09/2010 UNI EN ISO 12402-4:2010UNI EN ISO 12402-5:2007 09/09/2010 UNI EN ISO 12402-5:2010UNI EN ISO 12402-6:2007 09/09/2010 UNI EN ISO 12402-6:2010UNI EN ISO 140-11:2005 21/10/2010 UNI EN ISO 10140-1:2010;
UNI EN ISO 10140-2:2010;UNI EN ISO 10140-3:2010;UNI EN ISO 10140-4:2010;UNI EN ISO 10140-5:2010
UNI EN ISO 140-16:2006 21/10/2010 UNI EN ISO 10140-1:2010;UNI EN ISO 10140-2:2010;UNI EN ISO 10140-3:2010;UNI EN ISO 10140-4:2010;UNI EN ISO 10140-5:2010
UNI EN ISO 140-16:2006 21/10/2010 UNI EN ISO 10140-1:2010;UNI EN ISO 10140-2:2010;UNI EN ISO 10140-3:2010;UNI EN ISO 10140-4:2010;UNI EN ISO 10140-5:2010
UNI EN ISO 140-1:2006 21/10/2010 UNI EN ISO 10140-1:2010;UNI EN ISO 10140-2:2010;UNI EN ISO 10140-3:2010;UNI EN ISO 10140-4:2010;UNI EN ISO 10140-5:2010
UNI EN ISO 140-3:2006 21/10/2010 UNI EN ISO 10140-1:2010;UNI EN ISO 10140-2:2010;UNI EN ISO 10140-3:2010;UNI EN ISO 10140-4:2010;UNI EN ISO 10140-5:2010
UNI EN ISO 140-6:2000 21/10/2010 UNI EN ISO 10140-1:2010;UNI EN ISO 10140-2:2010;UNI EN ISO 10140-3:2010;UNI EN ISO 10140-4:2010;UNI EN ISO 10140-5:2010
UNI EN ISO 140-8:1999 21/10/2010 UNI EN ISO 10140-1:2010;UNI EN ISO 10140-2:2010;UNI EN ISO 10140-3:2010;UNI EN ISO 10140-4:2010;UNI EN ISO 10140-5:2010
UNI EN ISO 14122-4:2005 09/09/2010 UNI EN ISO 14122-4:2010UNI EN ISO 14122-4:2005 09/09/2010 UNI EN ISO 14122-4:2010
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
72 U&C n.10 novembre/dicembre 2010
tutte
le norme
NORMA RITIRATA IN DATA SOSTITUITA DAUNI EN ISO 179-1:2007 09/09/2010 UNI EN ISO 179-1:2010UNI EN ISO 2061:1998 14/10/2010 UNI EN ISO 2061:2010UNI EN ISO 2162-3:1998 27/10/2010 UNI EN ISO 26909:2010UNI EN ISO 2307:2005 14/10/2010 UNI EN ISO 2307:2010UNI EN ISO 2871-1:1996 09/09/2010 UNI EN ISO 2871-1:2010UNI EN ISO 2871-2:1996 09/09/2010 UNI EN ISO 2871-2:2010UNI EN ISO 3386-1:2000 16/09/2010 UNI EN ISO 3386-1:2010
NORMA RITIRATA IN DATA SOSTITUITA DAUNI EN ISO 3386-2:2000 16/09/2010 UNI EN ISO 3386-2:2010UNI EN ISO 7231:1999 09/09/2010 UNI EN ISO 7231:2010UNI EN ISO 7779:2003 07/10/2010 UNI EN ISO 7779:2010UNI EN ISO 8261:2001 07/10/2010 UNI EN ISO 6887-5:2010UNI EN ISO 9554:2005 14/10/2010 UNI EN ISO 9554:2010UNI ENV 13803-1:2003 07/10/2010 UNI EN 13803-1:2010UNI ENV 14464:2003 16/09/2010 UNI CEN/TS 14464:2010UNI ISO 14050:2002 16/09/2010 UNI EN ISO 14050:2010
NORME RITIRATE SENZA SOSTITUZIONEDal 4 settembre al 28 ottobre 2010
NORMA RITIRATA IN DATAUNI CEN/TS 14271:2004 09/09/2010UNI EN 608:1996 09/09/2010UNI EN 724:1996 23/09/2010UNI ENV 13734:2001 09/09/2010UNI ENV 13735:2001 09/09/2010
DecollaUNIstore:
non restate a terra!
www.uni.com
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i
U&C_CoverNovDic_progetto 27/12/10 17:29 Pagina AC
Version
e elet
tronic
a
a uso
esclu
sivo d
ei Soc
i