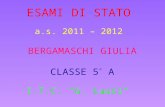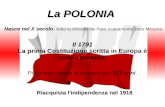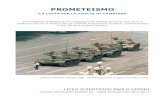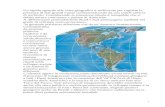Tesina Economia dello Sviluppo_Orlandi.pdf
-
Upload
francesco-orlandi -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of Tesina Economia dello Sviluppo_Orlandi.pdf
-
Il pensiero di Amartya Sen su povert e sviluppo e il suo riflesso nellepolitiche per i popoli indigeni.
Francesco Orlandi
In questo lavoro si inizier riassumendo le principali questioni sorte dallapproccio allapovert come capabilities deprivation e si evidenzier come questo prospettiva hapermesso di considerare da un altro punto di vista il tema della disuguaglianza e lepolitiche di sviluppo messe in atto nei confronti dei popoli indigeni. Il tema dellariduzione della povert per i popoli indigeni offre lopportunit di analizzare leformulazioni di Sen in un caso specifico in cui la discriminazione etnica ha portato acondizioni di estrema indigenza. Questa situazione ha avuto origine nelle condizioni dicolonizzazione e discriminazione strutturale degli Stati nazionali ed in una fase diprofonda trasformazione grazie al protagonismo politico dei movimenti indigeni che hacondotto a una nuova sensibilit nei confronti della diversit culturale.
1. Lanalisi della povert
Lesistenza di aree di povert non appartiene in modo esclusivo alle sole societ piarretrate. Nei paesi sviluppati permangono situazioni di disagio e di deprivazione. Epresente un interesse diffuso nei confronti del problema della povert, tuttavia nonesiste una convergenza di opinioni sul significato da attribuire al termine povert, nsui metodi di analisi e di misurazione pi idonei a fornire indicazioni in meritoallintensit con cui si manifesta la povert, n sullindividuazione delle cause chepossono essere allorigine del fenomeno. Centrale a tutte le teorie il fatto che lapovert una condizione di mancanza, l'obiettivo sar quindi di individuare qual l'oggetto di tale mancanza.
La scuola Utilitarista individua tale oggetto nel benessere economico, inteso comeutilit, ovvero come uno stato di appagamento derivante dall'effettivo uso di beni a cuisi ha accesso. Lutilitarismo tende a trascurare il problema dellineguaglianza delladistribuzione del reddito: non si possono effettuare confronti tra chi vince e che perde,e sono possibili solo valutazioni ordinali di utilit. I giudizi in materia di benessere sonoperci limitati solo allambito ristretto del miglioramento paretiano, cio i casi in cui cchi migliora e nessuno peggiora. I propugnatori dellapproccio dei Bisogni Primari ritengono che la povert debba essereintesa come carenza di un paniere di beni di peculiare importanza per il benessere diogni individuo (es. alimentazione, protezione, abitazione). Le linee di povert ottenutericorrendo al concetto di basic needs vengono definite assolute; il riferimentoprincipale nei confronti di un insieme di bisogni fondamentali che hanno rilevanza diper s, non tenendo presente la relazione esistente tra beni e persone.
La sintesi di queste due diverse interpretazioni fornita dallapproccio di Amartya Sen:loggetto di analisi si trova in una regione di tangenza tra beni primari ed utilit, piprecisamente nella capacit di un individuo di essere e agire. Lo spazio delle capacit contiguo a quello di bisogni primari e utilit, poich le capacit sonoconcettualmente successive allatto di possedere un bene, e antecedenti alraggiungimento di uno stato di appagamento derivante dal suo utilizzo (Sen 1979).
-
Sen introduce lapproccio del titolo valido o entitlement (attribuzione) secondo cui lacapacit di disporre beni e servizi dipende sia dalle condizioni sociali, politiche,economiche e giuridiche della data societ, sia dalla posizione dellindividuo nellastessa. Lapproccio degli entitlements si concentra sulla capacit dei soggetti dicomandare cibo attraverso mezzi legali disponibili nella societ; cio il paniere di benie servizi su cui la persona pu esercitare un controllo, mediante limpiego dei diritti edelle opportunit, indicato dal titolo valido.
Tradizionalmente, lanalisi della povert concerne le sole variabili reddituale emonetaria. La definizione di una soglia di povert, ossia di un valore che ci permetta diidentificare come poveri gli individui che si trovano al di sotto di tale punto diriferimento, finalizzata allidentificazione ultima di un livello di spesa o di consumo(Sen 1979). Sen inaugura un nuovo metodo di costruzione di un indice di povert,mutuandolo dallo studio della disuguaglianza: la povert cui fanno riferimento gli indiciprecedentemente utilizzati , infatti, una povert unidimensionale, che si basasullassunzione implicita di equivalenza tra risorse economiche disponibili e livello dibenessere. Tale approccio misura la povert esclusivamente nellaspetto economico-monetario, e utilizza questa sola dimensione per sintetizzarlo. Tuttavia la povertconnota un disagio che non si esaurisce nella carenza di risorse monetarie, ma checoinvolge una pluralit di dimensioni.
Linadeguatezza di reddito e consumo nel valutare la qualit di vita dovuta alla loroincapacit di tradurre o descrivere quali risultati gli individui possano realmenteconseguire con tali risorse, sia perch queste non valutano le forti differenze edisuguaglianze tra persone, ma anche perch la qualit di vita qualcosa di picomplesso di un semplice insieme di risorse. Variabili come lo stato di salute, lasperanza di vita, il livello di conoscenze e di educazione scolastica, la profondit elestensione delle relazioni sociali, la variet di sentimenti e moti danimo sono tuttielementi costitutivi della vita umana che non possono venire ignorati se siamointeressati a stimare lo standard di vita delle persone (Sen 1976).
La vera rivoluzione all'approccio al problema della povert sta essenzialmente nellanuova prospettiva d'analisi proposta dall'economista indiano: la povert deprivazione di capacit-azioni, per poterla misurare, dunque, non solo necessarioconcentrarci sulla valutazione della moltitudine di aspetti che influenzano la vita di unindividuo, ma, cosa pi interessante, si deve annoverare, tra le variabili da osservare,la libert di godere di diversi ed alternativi stati di benessere. Da qui la necessit diindividuare nuove tecniche che consentano di gestire la multidimensionalit delfenomeno che vogliamo analizzare.
2. Capabilities approach e il ruolo della libert nello sviluppo.
Sen dichiara che, nel giudicare il benessere di una persona, non considerer n utilitn beni primari, ma ci chegli chiama functionings (funzionamenti) di una persona. Unfunzionamento da considerarsi il compimento di un risultato per un individuo: ciche egli in grado di fare o essere. E differente dallatto di possedere un bene: ne infatti posteriore; ma anche differente dal ricavare utilit da quel bene nella forma difelicit o soddisfazione, poich ne antecedente; essa parte dello stato di unapersona. Si pu considerare il seguente esempio: il funzionamento leggere un librotrasmette un quantitativo di informazioni molto pi ampio del semplice fatto di
-
possedere un libro oppure di godere della sua lettura: dato dalla combinazione dellacondizione personale di alfabetismo dellindividuo, dalla disponibilit di un volume daleggere, e ancora da adeguate condizioni di luce che permettano allindividuo didecifrare le parole scritte.
I funzionamenti possono essere da elementari, come lessere adeguatamente nutriti, ogodere di buona salute, a complessi, come avere stima di s o essere integrati nellasociet. Le combinazioni di funzionamenti che un individuo in grado di raggiungerevengono da Sen definite capabilities (capacitazioni): esse esprimono le realiopportunit di azione e di realizzazione degli stati ambiti da una persona. Lecapacitazioni, dunque, riflettono o rappresentano la libert di un individuo a condurreun determinato tipo di vita piuttosto che un altro, i diversi insiemi di funzionamenti cheegli pu raggiungere attraverso la scelta (Sen 1993).
Sen sottolinea limportanza della valutazione della libert effettiva di vivere bene ebenessere; anche nel momento in cui pensassimo che il benessere di un individuodipenda solamente dai funzionamenti raggiunti, la libert al benessere di unapersona rappresenterebbe la libert di godere di alternativi e migliori stati dibenessere.
Secondo la prospettiva proposta da Sen la povert non pu essere consideratasolamente dal punto di vista della scarsit di reddito: questo fattore ovviamentesignificativo nella definizione della condizione di povert, ma solo su un pianostrumentale: ne scaturisce una visione limitata che contribuisce a far s che venganotrascurati altri modi di considerare la diseguaglianza e lequit con riflessi evidentisulle scelte di politica economica che in molti casi hanno portato ad acuire lacondizione di povert dei settori della societ oggetto di tali misure. Da questo se nericava anche che lo sviluppo non pu essere considerato unicamente da un punto divista della crescita economica ma deve avere una pi stretta reazione con lapromozione delle vite che viviamo e delle libert di cui godiamo (Sen 2000:21)
Lanalisi della povert come privazione di capacitazioni consiste in una comprensionepi profonda della natura e delle cause della povert stessa, nonch delladeprivazione ottenuta spostando il centro dattenzione dai mezzi (es. reddito) ai finiche gli esseri umani perseguono e di conseguenza a quelle libert che rendono capacidi vivere una vita dignitosa. Per Sen importante laspetto processuale e abilitantedelle libert, ovvero quelle condizioni che consentono un aumento delle possibilit discelta degli individui utili al conseguimento delle loro aspirazioni. La correlazione fra ladisparit di reddito e quelle esistenti in altri spazi pertinenti pu essere abbastanzadebole o precaria a causa di vari fattori, diversi dal reddito, che operano sulledisuguaglianze dei vantaggi individuali e delle libert sostanziali. Tra questi si pu fareriferimento alla partecipazione politica, laccesso allistruzione e allassistenzasanitaria, lequit di genere ed etnica, laccesso alle infrastrutture. Sono tutti fattoriche qualora declinati in maniera negativa rappresentano una riduzione delle possibilitindividuali di raggiungere una condizione di appagamento e di benessere o di poterscegliere liberamente. La libert quindi per Sen sia mezzo che fine dello sviluppo:solamente garantendo lesercizio delle libert, ovvero la possibilit di determinare lepropria aspirazioni seguendo i propri valori e costumi, sar possibile raggiungere unvero sviluppo, inteso anche come crescita economica (Sen 2000).
-
La necessit di tener conto di differenze nellabilit di trasformare i redditi e i beniprimari in capacit e libert veramente centrale nello studio dei livelli di vita, ingenerale, e in particolare della povert. Tali differenze sono determinate dallet di unapersona (ad esempio a causa delle necessit specifiche dei bambini e degli anziani),dal sesso e dal ruolo sociale, dalle condizioni del luogo in cui si vive, dallambienteepidemiologico e da altri fattori ancora. Come possiamo notare, inoltre, tali differenzenon sono necessariamente dettate da caratteristiche personali immutabili, mapossono essere anche correlate a condizioni sociali che lintervento pubblico in gradodi modificare. Ad esempio, sottolinea Sen, lo stato della sanit pubblica edellambiente epidemiologico pu avere una profonda influenza sulla relazione trareddito personale, da un lato, e libert di godere di buona salute e lunga vita dallaltro(Sen 1997).
Un grosso problema che sorge nel momento in cui misuriamo la povert in termini dideficit di reddito dovuta al fatto che essa anche associata ad una condizione dideprivazione assoluta in termini di capacit: essere relativamente povero in un paesericco pu essere un handicap molto grave, anche qualora il proprio reddito assoluto siaalto in termini di standard mondiali. La necessit di prender parte alla vita di unacomunit pu, infatti, indurre lesigenza di avere beni (televisione, computer,automobile...) o compiere attivit (avere un lavoro, andare al cinema, trascorrerequalche settimana di vacanza) considerate indispensabili per apparire in pubblicosenza vergogna. Ad esempio, nel caso di disoccupazione, la perdita di reddito puvenire compensata da sussidi e aiuti pubblici, tuttavia, la disoccupazione determinaben altri effetti che includono perdita di motivazione, di abilit, autostima,depressione, rottura di relazioni familiari e isolamento dalla vita sociale: anche se lostato sociale pu intervenire garantendo il mantenimento di un livello di redditoelevato rispetto agli standard mondiali, vediamo come il livello di deprivazione siacomunque molto grave (Sen 2000)
Una volta riconosciuto che la natura della relazione tra reddito e capacitazioni varia tracomunit diverse, e tra diversi individui anche allinterno della stessa comunit,dovremmo considerare variabile anche il livello di reddito minimo adeguato perraggiungere il medesimo livello minimo di capacit che dipende, come spiegato, dacaratteristiche personali e sociali. Comunque, Sen ammette che, per datecaratteristiche sociali e personali da cui dipendono le capacit, potrebbe esserepossibile, qualora si vedesse una relazione positiva tra reddito e capacit, identificareun reddito minimo corrispondente al livello minimo di capacit accettato. Una voltastabilita questa corrispondenza, la povert in termini di carenza di capacitazioni puessere vista nella forma tradizionale di povert in termini di carenza di reddito: ci che realmente importante tener conto delle variazioni interpersonali e intersociali nellarelazione tra reddito e capacitazioni (Sen 1993).
Lapproccio delle capacitazioni fornisce quindi una visione diretta di alcune dimensionicruciali della disuguaglianza e della povert che una superficiale comparazione deiredditi non evidenzierebbe, un punto di vista pi ampio che permette sia un analisidescrittivo che di scelta politica.
-
3. Sviluppo umano e popoli indigeni
Per affrontare la questione dello sviluppo e le tensioni che possono sorgere in seno auna collettivit opportuno ricordare come per Sen il libero mercato da solo non sufficiente al raggiungimento di una societ liberista. Questo si evince dalla criticaseniana al criterio di ottimalit paretiana: questo concetto, elaborato dallingegnereitaliano Vilfredo Pareto a inizio del 900, indica una situazione in cui nessuno pumigliorare la propria condizione senza peggiorare quella di un altro; Sen afferma chese lutilit del povero non pu essere aumentata senza diminuire quella del ricco, lasituazione pu essere ritenuta ottima in senso paretiano, ma tuttaltro che ottima insenso reale. Quello che Sen mette in evidenza limportanza dellequa distribuzionedei benefici del mercato e la validit dei valori liberali, in quanto impossibilesoddisfare una minima richiesta di libert quando sia coniugata ad uninsistenzasullottimalit paretiana. Sen si rende conto della tendenza del sistema-mercato adimostrarsi altamente iniquo se, nella sua analisi, vengono considerate (oltre alreddito) le capacitazioni, per esempio quella di poter trasformare tale reddito inbenessere per lindividuo.
Lo sviluppo, il benessere e la giustizia sono relazionati e molta attenzione data aicollegamenti tra le dimensioni economiche, politiche e culturali della vita. Per moltedelle capacitazioni il principale input sar costituito dalle risorse finanziarie e laproduzione economica, ma per altre sar necessario un aggiustamento delle pratichee istituzioni politiche, come leffettiva garanzia e protezione della libert di pensiero,della partecipazione politica, delle pratiche sociali e culturali, delle istituzioni sociali,dei beni comuni, delle norme sociali, delle tradizioni e dei comportamenti culturali(Robeyns 2005)
E importante evidenziare come lapproccio delle capacitazioni non pretende fornireuna teoria generale della povert applicabile in qualsiasi contesto. Al contrario,fornisce una quadro concettuale dentro cui analizzare la questione relazionandola conaltri aspetti della vita economica e culturale di un paese o un determinato gruppodiscriminato (ad esempio per il genere, per letnia o per la religione). In questo modoil pensiero di Sen costituisce un ponte tra il discorso economico e il linguaggio deidiritti umani, mettendo alla base e al vertice del processo di sviluppo la dignit di ogniessere umano. Si possono individuare almeno due punti fondamentali: da un lato almettere in relazione problemi economici classici come la povert e le carestie con unapproccio basato sulle libert sostanziali contribuisce in maniera significativa asottolineare la dimensione etica delleconomia; dallaltro linterdisciplinariet del suoapproccio rende possibile lapertura di nuovi campi di studio, quali quelli relazionatialla concezione culturale della globalizzazione i suoi valori e la sua etica (Vizard,2005). A livello pratico noto come dalle teorie di Sen si sia sviluppato il discorso dellosviluppo umano in vari organismi internazionali a cominciare dallistituzione delloUnited Nations Development Program (UNDP), dellHuman Development Index checalcola lo sviluppo umano degli Stati a partire da variabili quali laspettativa di vita allanascita, leducazione e il reddito, ed alla base dei Rapporti sullo Sviluppo Umanopubblicati dallUNDP.
Sen affronta il tema della diversit culturale e dal suo punto di vista importante che ipopoli le cui tradizioni culturali sono minacciate dai processi di sviluppo e diglobalizzazione abbiano la possibilit di scegliere collettivamente cosa meglio per il
-
loro sviluppo: [Q]ualsiasi conflitto reale tra conservazione della tradizione e vantaggidella modernit richiede una soluzione partecipativa e non un rifiuto unilaterale dellamodernit in favore della tradizione da parte di politici al potere, autorit religiose opersone che ammirano leredit del passato per gusto antropologico(Sen 2000:38). Ilprocesso democratico al centro delle considerazioni di Sen anche quando affermache la partecipazione politica fa parte del processo di sviluppo in quanto libert diacconsentire o rifiutare determinate politiche:i diversi settori della societ (e non soloi privilegiati) devono essere in grado di partecipare attivamente alla scelte delle cosada conservare (o abbandonare) (p.242). Si riconosce quindi dal punto di vista dellalibert, la necessit di lasciare ai diretti interessati la scelta su che tipo di sviluppo sivoglia intraprendere, mettendo in gioco il ruolo fondamentale della democrazia noncome mera concatenazione di strumenti procedurali, ma come effettivacoscientizzazione e partecipazione sulle scelte riguardanti la collettivit.
Nelle argomentazioni di Sen non si definisce una lista di capacitazioni, infatti si lasciaaperta la possibilit ai gruppi locali di definirle sulla base delle proprie priorit e questorende questo approccio particolarmente adatto per affrontare la tematica dellosviluppo umano dei popoli indigeni. Tuttavia, tra i limiti si pu riscontrare comelattenzione posta sulla dimensione individuale della libert e della giustizia fa passarein secondo piano la dimensione collettiva della qualit della vita che alla base dellerivendicazioni indigene (Cimadamore, Eversole, McNeish, 2006).
Con il fine di creare un collegamento tra lapproccio delle capacitazioni e la concezioniindigene dello sviluppo necessario in primo luogo evidenziare come entrambe hannoin comune una visione olistica del benessere, non limitata esclusivamente allaspettodella crescita economica e dei consumi ma anche e soprattutto ai suoi aspetti sociali eculturali. Esiste una stretta relazione tra povert e lappartenere a gruppi che siautodefiniscono indigeni. Vari fattori sono in gioco per determinare tale fenomeno; inprimo luogo, non bisogna dimenticare che nella definizione stessa di popolo indigeno implicito lessere soggetti a privazioni materiali, simboliche e giuridiche e lesseresottoposti alla riproduzione sistematica di relazioni socio-politiche discriminatorie chehanno origine nella violenza del processo di colonizzazione e nella successivastrutturazione degli stati nazionali. Per comprendere e intervenire su questa situazionesvantaggiosa opportuno adottare un punto di vista interdisciplinare che tenga contodella complessa storia di esclusione e diseguaglianza alla base dellodierna situazionedei popoli indigeni (Stavenhagen 1996).
Fin dallemergere della problematica indigena nelle sedi internazionali si prestataattenzione alla mancanza di opportunit per i popoli indigeni che ne causa lasituazione di povert, come laccesso al lavoro, ai servizi pubblici, alla giustizia e lapartecipazione politica. Schematizzando, si pu concludere che la povert tra i popoliindigeni data dalla reazione esistente tra la svalutazione della diversit culturale el'esclusione sociale di cui sono vittime le comunit.
Per ridurre la povert tra i popoli indigeni quindi centrale il riconoscimento dei lorodiritti, primo fra tutti il diritto allautodeterminazione e alluso delle risorse nei loroterritori secondo valori e pratiche che siano condivisi nella loro tradizione culturale.Nel rapporto sullo Sviluppo Umano del 2004 si fa riferimento alla problematicarelazionata con i diritti culturali e si indica la libert culturale come la capacit di unpopolo di vivere nel modo che vuole a ragione di adeguate e libere possibilit di scelta.
-
Sen, autore del primo capitolo del rapporto, indica che la negazione della libertculturale pu generare privazioni significative, impoverendo le vite umane edescludendo le persone dalle relazioni culturali che esse, giustamente ricercano. Laprospettiva dello sviluppo umano pu quindi essere estesa fino ad accoglierel'importanza della libert culturale (UNDP 2004:31).
Psacharopoulos e Patrinos (1994) in uno studio condotto per conto della World Banknei cinque paesi latinoamericani con la maggior percentuale di indigeni sul totale dellapopolazione (Guatemala, Messico, Ecuador, Per e Bolivia) evidenziano come esistauna relazione tra svantaggi sociali e povert (bassi livelli di educazione, malnutrizione,disoccupazione e assenza di assistenza sanitaria) e come la componente indigena inquesti indicatori sia nettamente superiore al resto della societ nazionale. In unostudio del 2006, condotto sempre per conto della World Bank, Hall e Patrinosanalizzano i risultati ottenuti nel decennio 1994-2004 sulla riduzione della povert esulle condizioni dei popoli indigeni. Si mostra come non ci siano stati progressi perquanto riguarda la diminuzione della povert tra i popoli indigeni, mentre nei paesi incui il tasso di povert nazionale diminuisce (Guatemala, Messico e Bolivia), i datiindicano che la povert tra i popoli indigeni decresce a un ritmo pi lento rispetto alresto della popolazione. Da questo gli autori deducono che le condizioni che possonocontribuire a ridurre la povert della popolazione in generale non necessariamentehanno benefici significativi sulla popolazione indigena. Si evince anche come ilprincipale strumento per lo sviluppo dei popoli indigeni la partecipazione politica elopportunit di decidere autonomamente le proprie priorit (Hall e Patrinos 2006).
Un altro studio condotto dalla Banca di Sviluppo Interamericana arrivato allemedesime conclusioni: in base agli indicatori socioeconomici tradizionali, sia basatisul reddito, sia sul concetto di necessit primarie non soddisfatte, i popoli indigeni,come gruppo etnico, sono rappresentati in modo sproporzionato sia tra i poveri, sia traquelli in condizioni di povert estrema (Plant 1998). Nello stesso studio si fariferimento al fatto che le politiche di sviluppo adottate dagli Stati in via di sviluppo,come la produzione di colture per lesportazione, la svendita di territori alle impreseminerarie, sono frequentemente dannose per i popoli indigeni in termini di perdita delterritorio e di subordinazione lavorativa anche se comportano un incremento dellacrescita economica del paese. Questo il caso del Guatemala e di alcune zonemeridionali del Messico, in cui la rapida crescita delleconomia basata sulle piantagionidi caff destinate allesportazione ha avuto come conseguenza lesproprio delle terrecomunitarie indigene. Molti nativi sono diventati lavoratori residenti nelle piantagionidi caff; nelle terre alte guatemalteche, dove si concentra la popolazione indigena, gliappezzamenti di terreno sono divenuti troppo piccoli per fornire un reddito disussistenza e il lavoro stagionale diventato un aspetto importante della vita deinativi: sin dagli anni 40, la servit della gleba e le leggi sul vagabondaggiocostringevano gli indigeni a fornire mano dopera estiva ai proprietari terrieri; dopo,quando la maggior parte delle terre indigene non era pi in grado di provvedere unreddito di sussistenza, sono state le forze del mercato a fornire mano doperastagionale e migrante allagricoltura commerciale(Plant 1998).
La maggior parte del lavoro svolto finora sui fattori determinanti della povert tra ipopoli indigeni si concentrata principalmente sugli esiti del capitale umano. Lamaggior parte degli studi documentano che i popoli indigeni sono svantaggiati in
-
termini di dotazione di capitale fisico e umano. Questi titoli bassi, a loro volta, portanoa differenze significative nei guadagni e, quindi acuiscono lo stato di povert e ildivario con i settori della societ nazionale dominante. Negli ultimi anni, si discussosul ruolo del capitale sociale e le risorse culturali dei popoli indigeni. Il capitale sociale,definito come i valori tradizionali delle comunit locali e le strutture socio-economiche,sono spesso indicati come lunico capitale produttivo di cui le minoranze etnichedispongono in abbondanza. Questi valori e le strutture tradizionali includono ilcontrollo collettivo e la gestione sostenibile delle risorse naturali; sistemi di lavoro esostegno reciproco; forte organizzazione sociale e alti livelli di responsabilitcomunale; un profondo rispetto per la conoscenza dei loro anziani; e una strettoattaccamento spirituale ai loro antenati e la terra. Tali attivit culturali possonosvolgere un ruolo chiave in materia di imprenditorialit economica e nelle strategieper diversificare o intensificare le condizioni di vita. Stretti legami, un forte senso disolidariet, e di relazioni di scambio a base di parentela, svolgono un ruolo importantenel fornire sicurezza economica. Tuttavia, le differenze di gruppo nei risultatisocioeconomici possono essere spiegate cercando nella distribuzione, composizione erestituzione delle attivit generatrici di reddito. Titoli patrimoniali bassi, ad esempio intermini di dimensione dei terreni o anni di scuola, influiscono negativamente sullacapacit di generare reddito, mentre bassi tassi di utilizzo e rendimento soffocano leopportunit. La composizione delle attivit importante anche come il tasso direndimento di un bene spesso influenzato dalla propriet o accesso ad altri benicomplementari. Tuttavia, titoli patrimoniali bassi possono aiutare a spiegare i bassiritorni in termini economici. Inoltre, la discriminazione e altri meccanismi di esclusione,cos come l'internazionalizzazione dei pregiudizi sono fattori che influiscono sui benidelle minoranze escluse (Hall e Patrinos, 2010).
Nella politica operativa della Banca Mondiale sui popoli indigeni (WB 2005/2013) si fariferimento al fatto che un obiettivo dellistituzione finanziaria quello di ridurre lapovert e raggiungere uno sviluppo sostenibile assicurando che il processo di svilupposia rispettoso della dignit, dei diritti umani, delleconomia e delle culture dei popoliindigeni. La WB riconosce che le identit e le culture dei popoli indigeni sonostrettamente collegate con i loro territori in cui essi vivono e con le risorse sulle qualidipendono. Per tale motivo si afferma che la condizione principale posta alfinanziamento di progetti mirati ai popoli indigeni il consenso previo, libero einformato delle comunit e il rispetto dei diritti di propriet culturale, cos comestipulato dai principali strumenti giuridici a tutela dei diritti dei popoli indigeni:Convenzione 169 OIL [1989] e Dichiarazione ONU sui Diritti dei Popoli Indigeni [2007].
4. Conclusione
In questo lavoro si tracciato un profilo dellapproccio di Sen alla povert e allosviluppo e si visto come questo abbia condotto a un interesse di economisti eistituzioni sulle dinamiche complesse che provocano la condizione di povert tra ipopoli indigeni. Nel momento in cui si apre la strada per un analisi della povert chenon sia esclusivamente basato sulla scarsit di reddito si dimostrato come ladiscriminazione istituzionalizzata sofferta dai popoli indigeni sia alla base dellaltapercentuale di povert documentata. A partire da tale considerazione, si sono fattimolti passi avanti sul tema grazie soprattutto alla presa di coscienza sui diritti deipopoli e sul valore della diversit culturale in s e come fondamento dello sviluppo
-
umano e sociale. Le politiche multiculturali adottate dalla maggior parte degli statilatinoamericani muovono nella direzione di una maggiore garanzia del rispetto deidiritti riconosciuti alle popolazioni indigene: educazione bilingue, propriet comunitariadei territori e delle risorse e maggiore autonomia e riconoscimento delle istituzionisociali indigene. Il mutato quadro internazionale in riferimento alle tematiche indigene,specialmente sui diritti sulle risorse naturali e i diritti di propriet culturale,congiuntamente con una riformulazione pi equa delle entrate del mercato ha resopossibile una riduzione dei tassi di povert specialmente in quei paesi che riconosconomaggiori garanzie alla tutela dei diritti dei popoli indigeni; in alcuni casi (Ecuador eBolivia) si riconosce costituzionalmente il diritto dei popoli indigeni a perseguire unosviluppo declinato secondo i termini di quello che si conosce come Sumaq Quasay(buon vivere) basato sui valori di reciprocit e solidariet tra la comunit e lambiente(Cepal 2014).
La questione della riduzione della povert e dello sviluppo economico non pu essereconsiderata separatamente dalle questioni dellidentit e dei modi di vivere indigeni,dalla cultura, dal diritto al territorio e alle risorse naturali e da quellodellautodeterminazione. E certamente un problema conservare lidentit indigena, dauna parte, e migliorare le condizioni economiche, dallaltra. In un mondo dovemigliorare le condizioni economiche significa far crescere le istituzioni del mercato alivello nazionale e globale, molti popoli indigeni si trovano di fronte a un dilemma: separtecipano pienamente al mercato, devono dimenticare la gestione tradizionale deiloro territori, le pratiche tradizionali della ridistribuzione della ricchezza, lacondivisione delle risorse tradizionali e della loro gestione tradizionale (Tauli-Corpuz2012)
Negli ultimi tre decenni sono stati fatti molti passi nello stabilire uno standard minimodi protezione dei diritti dei popoli indigeni grazie allo sforzo realizzato in varie sediinternazionali (Nazioni Unite, Organizzazione Internazionale del Lavoro, BancaMondiale). E importante sottolineare come i popoli indigeni siano stati i protagonisti enon sono beneficiari di queste attenzioni. Tale sforzo ha condotto a un ampio consensointernazionale sulla determinazione dei diritti e delle priorit dello sviluppo per i popoliindigeni la cui manifestazione stata lapprovazione da parte dellAssemblea GeneraleONU della Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP): in questo documento siafferma limportanza del diritto allo sviluppo per i popoli indigeni conseguente dal lorodiritto allautodeterminazione in quanto popoli con eguali diritti a tutti gli altri popolidella terra.
Gli artt. 26 e 32 sono importanti in quanto sanciscono la propriet della terra e dellerisorse naturali dei territori abitati dalle comunit indigene e il diritto a essereconsultati previamente e ad esprimere un consenso libero e informato su progetti cheinteressano i loro territori e le loro risorse naturali e culturali. Conseguentemente aquanto afferma Sen sullimportanza della partecipazione politica come libertstrumentale per il raggiungimento dello sviluppo umano e sociale, il diritto dei popoliindigeni di rifiutare piani di sviluppo che riguardano i loro territori non dovrebbe esserevisto come un ostacolo, ma come una parte intrinseca del processo di sviluppo e unsuo obiettivo, il rifiuto di tale diritto il rifiuto dello sviluppo in s. (Doyle e Gilbert2010).
-
La UNDRIP uno strumento per ampliare le possibilit di sviluppo secondo i principi e ivalori propri ai popoli indigeni verso la realizzazione di quello che stato definitoSviluppo autodeterminato(Tauli-Corpuz 2010). Questo concepito come un obiettivodestinato ad ampliare le possibilit di cui godono i popoli indigeni garantendo il propriodiritto allautodeterminazione. Spesso i piani di sviluppo per superare la povert hannolo spiacevole correlato della perdita dellidentit culturale in nome della modernit odellefficienza economica, la rivendicazione dei popoli indigeni quelladellinscindibilit degli aspetti culturali da quelli economici nelle dinamiche di sviluppo.E una riposta diretta allo sviluppo concepito come assimilazione forzata o comeintegrazione silenziosa: lunica forma di sviluppo che permette la libert sostanzialedei popoli indigeni quella che garantisce la prosecuzione vitale dei propri modi di vitae la libera scelta di quali elementi estranei accettare, quali rifiutare e quali aspettidella propria tradizione abbandonare o condividere con il resto della popolazione.
Bibliografia:
Cepal/Eclac (2014) Los Pueblos Indgenas en Amrica Latina: avances en el ltimodecenio y retos pendientes para la garanta de sus derechos. Economic Comission forLatin America and the Carribean.
Doyle, Cathal and Jrmie Gilbert (2010) Indigenos Peoples and Globalization: fromdevelopment aggression to selfdetermined development. European yearbook ofminority issues, vol 7:219-262
Cimadamore, Alberto D., Eversole, Robyn, McNeish, John-Andrew (2006) Pueblosindigenas y pobreza enfoques multidisciplinarios. Consejo Latinoamericano CienciasSociales
Hall, Gillette and Patrinos, Harry A. (2006) Indigenous Peoples, poverty and humandevelopment in Latin America:1994-2004. World Bank
- (2010) Indigenous Peoples, Poverty and Development. World Bank
Plant, Roger (1998) Issues in Indigenous Poverty and Development. Inter-AmericanBank of Development.
Psacharopoulos, George and Patrinos, Harry A. (1994) Indigenous Peoples and Povertyin Latin America: an empirical analysis. World Bank
Robeyns, Ingrid (2005) The capability approach: a theoretical survey. Journal ofHuman Development, 6:1, 93-117.
Sen, Amartya K. (1976): Poverty: an ordinal approach to measurement,Econometrica, 44,2, 219-231
- (1979) Issue in the measurement of poverty, Scandinavian Journal of economics,285-307
-
- (1993) Capability and Well-Being, in Nussbaum M. and Sen A.K. (eds) The Quality oflife. Oxford India Paperbacks
- (1997) La libert individuale come impegno sociale, Laterza
- (2000) Lo sviluppo libert. Perch non c crescita senza democrazia. Mondadori.
Stavenhagen, Rodolfo (1996) The Challenge of Indigenous Development, in IndigenousPeoples and Development: Poverty, Democracy, Sustainability, D. Iturralde and E.Krotz (eds.) Inter-American Bank of Development,
Tauli-Corpuz, Victoria (2010) The Human Development Framework and IndigenousPeoples Selfdetermined Development or Development with Culture and Identity. UNPermanent Forum on Indigenous Issues, E/C.19/2010/CRP.4
Tauli-Corpuz, Victoria (2012) I popoli indigeni alle soglie del terzo millennio. Qualemodello di sviluppo? Eurolink
UNDP (2004) La libert culturale in un mondo di diversit. Rapporto sullo Sviluppo Umano 2004. United Nations Deveopment Program.
Vizard, Polly (2005) The contribution of professor Amartya Sen in the field of humanrights. Case Papers,91. Centre for the Analysis of Social Exclusions. London School ofEconomics
World Bank (2005/2013) Operational Policy 4.10 on Indigenos Peoples.http://go.worldbank.org/TE769PDWN0
http://go.worldbank.org/TE769PDWN0