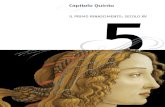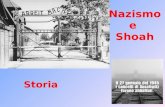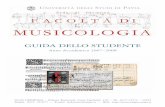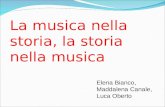Tesi Storia Della Musica
-
Upload
francesco-la-rosa -
Category
Documents
-
view
770 -
download
7
Transcript of Tesi Storia Della Musica

Tesi IV: Il canto Gregoriano Dopo l’editto di Milano (313) si formano canti sacri locali, l’unificazione religiosa li fece riunire nel canto gregoriano (l’unificazione richiese molti secoli): liturgia (intro, lit. della parola, lit. sacrificale): - proprium missae - ordinarium missae (kyrie, gloria, credo, sanctus, agnus dei) uffici delle ore: - mattutino, laudi, prima, terza, sesta, nona, vespro, compieta stili di canto(omo fono): - accentus (1 sola nota con inflessioni melodiche) - concentus (sillabico o semisillabico) - derivata da cantillazione ebraica salmodia: - responsoriale- allelujatica- antifonicainni:- sillabici - melodici - strofici
sequenze: prima mnemonico poi simili agli inni
tropi: sostituzione di testi sillabici ai melismi
modi ecclesiastici (scale eptafoniche ascendenti in 8 modi con nomi greci):- autentico - plagale hanno in comune la finalis e la repercussio
Tesi V: Gli inizi della polifonia La polifonia nasce dall’esigenza di rinnovare il canto sacro senza modificare la melodia (IX sec – contrappunto) Periodi della polifonia: (inizi – ars antiqua – ars nova – età fiamminga – polifonia rinascimentale) Tipi di contrappunto: - organum (melodia gregoriana (principalis) accompagnata una quarta o una quinta sotto da un'altra melodia (organalis), a volte partenza all’unisono - discanto: vox organalis procede x moto contrario - organum melismatico: principalis al basso, organalis acuta e crea melismi Ars Antiqua: scuola di Notre Dame: - Leonin - Perotin Organa diversi: cantus firmus dettoTenor
Clausola: sezione di organum costruita su frammento melismatico del tenor
Conductus: sillabico x processioni
Mottetto:- sostituisce organa e clausole,- sia sacro (latino) che profano (d’oil)- di solito a 3 voci- valori sempre + brevi verso l’acutoHoquetus: interruzione di melodia e trasposizione ad altre voci.

Tesi VI: Scrittura musicale medioevale Riassunto: adiastematica conneumi in campo aperto (vira, punctum, scandicus) , poi2 righe colorate, poi introdotte chiavi, poilettere x note su monocordo (Boezio poi Oddone di Cluny), scrittura da nera a bianca, poitetragram m a e notazione diastematica. Notazione modale (modi ritmici): virga e punctum diventano longa e brevis aggregate in 6 modi ritmici ripetuti in base agli ordines Notazioni mensurali: - franconiana: definita da ars cantus mensurabilis di Francone di Colonia, longa e brevis divise in perfecta e imperfecta, determina il superamento dei modi - dell’ars nova francese: introdotta la minima (scritte così le composizioni di Guillaume de Machaut) - dell’ars nova italiana: sembra provenga dal nulla, definita da Marchetto da Padova, unità di base la brevis, divisio prima, secunda, terza
Tesi VII: Guido D’Arezzo e la solmisazione Boezio (De istitutione musica): musica mundana, humana, instrumentalis Guido D’Arezzo: (995) (Prologus in antiphonarium) nuovo metodo: - esacordo: successione di 6 suoni con semitono al centro e nomi derivati da inno a San Giovanni - solmisazione: esistevano anche altri semitoni (la-sib e si-do) risolse con successione di + esacordi(3 duri, 2 naturali e 2 molli) sol-mi erano le note x passare da un esacordo all’altro (mutazione) (mano guidoniana) - musica ficta: nacquero nuovi semitoni ed esacordi (musica falsa)
Tesi VIII: Teatro nel medioevo – trovatori e menestrelli Accanto al gregoriano si sviluppano monodie sacre in latino e canti profani in latino Monodie sacre e profane: - drammi liturgici: (Visitatio Sepulchri) scarso apparato scenico e rappresentati da religiosi - uffici drammatici: derivati dagli uffici delle ore la lauda tosco-umbra: - in volgare italico - nasce da movimenti spirituali collettivi (Flagellati e disciplinati)- simile a ballata (solista e risposta del coro)- raccolte in laudari (91 di Cortona)- preannuncia ilmadrigalismo - cantico di Frate Sole cantigas spagnole: 400 canti a Santa Maria scritte in gallego canti profani in latino: Carmina Burana dei Goliardi Trovatori, Trovieri e Minnesanger Nasce lo spirito cavalleresco cortese - Trovatori: lingua d’oc, Francia meridionale, Chansò (simile a inno con strofe), stili: trobar plan, ric e clus - Trovieri: lingua d’oil, Francia settentrionale, Chanson, (Chretien de Troyes) -

Minnesanger: forme simili, Lied
Tesi IX: L’Ars Nova – strumenti in uso nel tempo Lasecolarizzazione della società portò alla distinzione tra sacro e profano, calò la produzione sacra e si criticò il contrappunto (intelliggibilità delle parole) Ars Nova Francese: - Philippe de Vitry: pari dignità fra divisione perfecta e imperfecta - + importante il mottetto (3 o 4 voci, isoritmico, molodia gregoriana detta color) - Guillaume de Machaut: Messa di Notre Dame (prima messa polifonica composta da 1 solo compositore, stile del mottetto) Ars Nova Italiana: - polifonia elementare e scarsa produzione - poesia x musica (Franco Sacchetti e Francesco Landino) o
madrigale (2 o 3 voci, endecasillabi a rima baciata AAB) o
caccia (canone a 2 voci all’unisono o
ballata (forma + evoluta, ABBAA) Strumenti del medioevo: organo (portativo e positivo) Salterio, viella, tromba, arpe e percussioni
Tesi X: Scuola Fiamminga e sviluppo del contrappunto vocale Dopo la guerra dei cent’anni (1339-1453) si svilupparono lecappelle musicali (al posto delle scholaeriprese importanza la musicasacra, nacque il ruolo di musicista professionista.Stili e forme:- nascita del contrappunto imitato: basato sull’imitazione che contraddistingue un tema (anche canoni enigmatici) - musica sacra (messa e mottetti) e profana (Chanson) o
messa (si afferma grazie a Dufay, = cantus firmus) o
mottetto (successione di brani in latino ognuno dei quali sviluppava 1 frase del testo sacro) o
chanson (3 voci accompagnate da strumenti)
Scuola inglese: procedimenti x terze e seste,falso bordone (discanto con c.f. alla voce
superiore), JohnDunstable
Scuola borgognona: promossa da Filippo il Buono,Dufay (supera asprezze gotiche, 9
messe),Binchois (stimato x chanson)
Scuola fiamminga: centro di sviluppo del contrapp. Imitato,Ockeghem (13 messe,
mottetti),Desprez (+ comp, 13 messe e parodie)
Tesi XI: Le scuole polifoniche italiane nel secolo XVI Ilrinascim ento si sviluppa nei secoli XV e XVI e sirifà all’arte classica (Firenze, epoca di Petrarca Boccaccio, inneggia virtù umane e fortuna), la musica è presente in tutte le attività e diventa pratica anche dei non professionisti. La stampa musicale: Petrucci stampò una raccota di 96 chanson a 3-4 voci, le musiche vennero stampate a fascicoli (1 x ogni voce) La tradizione fiamminga: compositori fiamminghi composero forme profane nazionali: -

Willaert: messe, 350 mottetti, chansons, maestro di cappella a Venezia (diventa centro della musica sacra cattolica) - Orlando di Lasso: 58 messe, 550 mottetti Musica nelle chiese protestanti (nacquero movimenti di riforma non cristiani): - luterana: Martin Lutero (traduzione scritture in tedesco), messa con corali sillabici (Praetorius e Schutz)- calvinista: Calvino (ugonotti), celebrazioni austere quindi poca musica, solo salmi- anglicana: Enrico VIII Tudor, Anthem (“antifona” simile al mottetto)
La controriforma cattolica:- abolizione sequenze tranne le 5 dell’ordinario- abolizione di testi profani- parole più intelliggibili (la semplificazione del contrappunto da origine al quartetto classico a cappella)La lauda polifonica: S. Filippo Neri fondò l’ordine dell’oratorio deve prima delle preghere si cantavano laude polifoniche a 3-4 voci o travestimenti spirituali (testo profano sostituito da sacro) La scuola romana (a roma i papi si prendono cura delle cappelle) fra i compositori spunta: - Palestrina (1525-1594) opera quasi totamente sacra, opera a Roma, o
102 messe (quasi tutte “parodia”): forte intelligibilità e omoritmiche o
Musica pura con triadi, ritardi preparati e gradi congiunti La scuola veneziana (a differenza di Roma si preferivano musiche policorali sostenute da strumenti) - Andrea Gabrieli: I° organista a S. Marco, semplifica contrappunto x valorizzare il testo, madrigali simili a Willaert (imitazione e qualche cromatismo), mottetti e madrigali - Giovanni Gabrieli: nipote di Andrea, proseguì sulla stessa linea, mottetti e musica strumentale x ogni strumento Forme popolaresche italiane (struttura stofica omofona a 3-4 voci, favorite da Lorenzo il magnifico e Isabella d’Este) - canti carnascialeschi: accompagnavano le mascherate (Heinrich Isaac) - frottole: diffusa da Mantova, strofica e deriva dalla ballata - villanelle: Napoli, strofiche e omofoniche
Ilm adrigale (modello petrarchesco proposto da Bembo):- diverso da quello del ‘300 (strofico a 2-3 voci), nel ‘500 e’ la forma profana più apprezzata (4-5-6 voci e non strofico)- simile alle frottole ma di forma aperta e senza ripetizioni- maggiori madrigalisti: o
Marenzio: poca produzione sacra, 16 libri di madrigali e “Intermezzi Fiorentini” o
Gesualdo di Venosa: non usò madrigalismi o
Monteverdi - madrigali drammatici (rappresentativo): non in stile petrarchesco, “Anphiparnaso” di Vecchi, Adriano Banchieri
Forme popolaresche europee:- Francia:chanson (diversa da quella fiamminga, simile a frottola italiana)- Spagna:villancico (simile a frottola, strofico con ritornelli a 3-4 voci)- Germania: meistersinger (Hans Sachs)lieder a 3-4 voci + complessi

Tesi XII: Forme polifoniche cinquecentesche Sacra:
- stile a cappella tranne Venezia-mottetto: deriva da quello del ‘200 (Perotin), è polifonico solo vocale su testo latino non profano, usa l’imitazione - messa: a 5 voci, musicate solo le parti dell’ordinario con = cantus firmus gregoriano (messa Papa Marcello) - salmi: forma a cori battenti e non più responsoriale - responsori: composizioni di risposta ai salmi Profana: - madrigale: quello del ‘500 è senza ritornelli e di polifonia semplice, con forma abbastanza libera, i madrigali drammatici (rappresentativi) furono i precursori del melodramma.
Tesi XIII: Conquista della tonalità moderna e strumenti Tra XVI e XVII secolo la musica subisceforti trasformazioni:
- ancora polifonia (sacra) ma si afferma la monodia- perde importanza il contrappunto e nasce l’armonia- modi ecclesiastici vengono assorbiti dal maggiore e minore- musica strumentale + importante
Spagna:-Petrell: iniziatore della rinascita musicale spagnolaAlbeniz