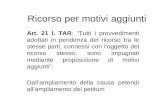Terza pagina Foster ... fileL’intelligenza dei depressi Il nuovo romanzo di Paolo Bianchi ......
Transcript of Terza pagina Foster ... fileL’intelligenza dei depressi Il nuovo romanzo di Paolo Bianchi ......
n. 167 DOMENICA - 19 GIUGNO 2016 Il Sole 24 Ore 25
Terza paginaelzeviro
L’intelligenza dei depressiIl nuovo romanzo di Paolo Bianchiracconta il legametra creatività e psicosisenza vittimismio autocompiacimenti
di Gilberto Corbellini
Che cosa hanno in comune per-sonalità tanto famose quantodiverse come Hans ChristianAndersen, Isaac Asimov, Ing-mar Bergman, Winston Chur-chill, Joseph Conrad, Charles
Darwin, Johnny Depp, Charles Dickens, Bob Dylan, Eminem, William Faulkner, HarrisonFord, Friedrich von Hayek, Stephen King,Hugh Laurie, John Lennon, Abraham Lin-coln, Gustav Mahler, Henri Matisse, Herman Melville, Michelangelo Buonarroti, Wolf-gang Amadeus Mozart, Isaac Newton, Brad Pitt, Edgard Allan Poe, Janet K. Rowling, Ro-bert Schumann, Mark Twain, Walt Whitman,Robin Williams? Sono un’esigua minoranza di individui molto famosi per qualche forma di creatività, che hanno anche sofferto o sof-frono di depressione grave. Dei rapporti tramalattie mentali, e in particolare depressio-ne, e creatività o intelligenza, si discute damillenni. Molti hanno pensato, come PaoloBianchi, che «il male di vivere è solo una ma-ledetta forma di intelligenza». Il romanzo di Bianchi sulla depressione è in-telligente. La storia del protagonista fa capiresenza compiacimenti né vittimismi in cosa consiste l’esperienza di stare, senza sceglierequando, dentro e fuori un baratro di dolorepsicologico senza fine. Un inferno in cui da unmomento all’altro si può essere gettati da inattese, progressive, incontrollabili e intol-lerabili folate di ansia, e da cui si esce altret-tanto inaspettatamente, quasi senza memo-ria di quel dolore. La vita di chi è depresso, co-me Emilio Raviola, è scandita da frequenta-zioni indotte o completamente condizionatedalla malattia. Nella malattia di Emilio si leg-gono in filigrana le radici genetiche e gli ap-porti ambientali della famiglia, ma anche scolastici. Essa lo costringe a selezionare e fil-trare rapidamente le relazioni amorose, ami-cali e familiari sulla base della capacità delle persone di accettare che si possa stare malis-simo e a rischio di morire per autolesionismo,senza alcuna lesione fisica. I conoscenti si di-vidono presto fra chi dice «tirati su, forza, faiqualcosa; reagisci!»: di solito poco intelligen-ti e da tenere alla larga. E chi sa o cerca di capi-re quello che provi, ti ascolta o ti distoglie daipiani autodistruttivi: individui purtroppo ra-rissimi. Emilio deve reinventarsi un punto divista sul mondo, compatibile col fatto che lamalattia depressiva ti apre uno squarcio sullaverità delle cose, sull’illusione della volontà, della libertà, del senso dell’esistenza, del-l’amore, etc. Non tutti ci riescono, e non pochipreferiscono farla finita. Il romanzo di Bian-
chi tratteggia il profilo dei terapeuti profes-sionali, i quali fingono di sapere (è il loro au-toinganno), quali effetti otterranno sommi-nistrando diverse combinazioni di farmaci.In realtà ne hanno un’idea piuttosto vaga. Si tratta di inventarsi dei cocktail tarati suisingoli pazienti, che vogliono giustamentenegoziare i pesanti effetti collaterali diquesti farmaci. La prima prova di intelligenza è capire che la terapia della parola, la psicoterapia, è una ra-pina e un evitabile calvario. Emilio, come molti che soffrono di depressione, ha una for-
midabile padronanza empirica della farma-cologia, a riprova che nel volgere di qualche anno chi è malato sa meglio del medico, cosagli serve. A tratti il libro di Bianchi ricorda la lucida e sarcastica ironia di uno dei testi in as-soluto più belli sulla depressione: The depressed person, dello scrittore suicida David Fo-ster Wallace (Harper Magazine, gennaio 1998). Tra Xanax, ospedalizzazioni, settima-ne trascorse a letto, SSRI, prostitute com-prensive, etc. Emilio trova infine sollievo in-contrando con regolarità un gruppo di autoa-iuto. Il romanzo, pubblicato in collaborazio-ne con Progetto Itaca che promuovere ilsupporto sociale per le persone con disturbo mentale, non propone il ricorso al gruppo disupporto come soluzione. Ogni caso di malattia mentale è una storia a sée l’intelligenza aiuta a scegliere quello chefunziona. I gruppi di autoaiuto sono come i farmaci, vanno bene per chi risponde, e le sta-tistiche raccontano che circa il 17% soltantoentra in un gruppo di supporto tra tutti coloroai quali è stato consigliato, e di questi solo unterzo vi rimane più di quattro mesi. Quanto c’è di vero nell’affermazione che anche PaoloBianchi sembra condividere, cioè che l’intel-ligenza è una malattia mentale? Il tema è anti-co. Per Aristotele «tutti coloro che hanno rag-giunto l’eccellenza nella filosofia, nella poe-sia, nell’arte e nella politica, inclusi Socrate e Platone, avevano un habitus malinconico; di fatto alcuni soffrivano anche di malattia ma-linconica». Non è scontato che la malinconia dei medici antichi coincidesse con la nostradepressione clinica, come non è detto che la depressione unipolare sia un’entità clinicaseparata dal disturbo bipolare. Nell’età tardoantica e soprattutto nel Medioevo la malinco-nia assunse però connotati solo negativi, co-m’era inevitabile per una religione come quella cristiana che esigeva una rinuncia en-tusiastica ai piaceri della vita. L’accidia diven-ta, infatti, un peccato capitale. Nel Medioevo Saturno diventava però il simbolo astrologi-co dell’ambivalenza intellettuale e della vita artistica, associandosi alla malinconia, pre-parando il Rinascimento, dove l’umore de-
presso sarà sinonimo di genialità intellettua-le. Marsilio Ficino, nella seconda metà del XVIsecolo, pensava che una mente tormentata avesse più valore: chi sa non può che essere insoddisfatto, e l’insoddisfazione provoca malinconia. Mentre nel Sud Europa la malin-conia si associava alla genialità ed era un pre-requisito per l’inspirazione intellettuale, nel Nord si associava alla stregoneria. Ma di lì a qualche secolo sarebbe arrivata la psichiatria.Il tema della malinconia nutriva anche il ro-manticismo inglese e tedesco, e la filosofia dell’Ottocento. Kant declamava la nobiltà della malinconia, scrivendo che «la virtù ge-nuina basata sui principi ha qualcosa che ar-monizza molto con la struttura malinconica della mente». Il sublime è sempre accompa-gnato da “terrore e malinconia”. Meno positive le pagine di William James chesoffriva di gravi episodi depressivi, e leggeva questa condizione come una dimensioneemotiva del disincanto sentimentale prodot-to dalla diffusione dalla scienza. «Come puòlo scienziato, allora, pretendere – scriveva– di avere più ragione di altri uomini, affetto co-m’è dal pantano emozionale umano. Così pensa il nostro uomo malinconico, nelle sue ore più buie». Da quasi un secolo, il problemadei rapporti tra malattia mentale e creatività èstudiato empiricamente. I risultati mostranoche tra le persone più creative è più probabiletrovare anche disturbi mentali e che tra le persone con disturbi mentali è più probabile trovare individui creativi. Da qui a dar ragio-ne a chi irresponsabilmente elogia la depres-sione, ce ne passa. Anche perché nessuno sela sceglie, come nessuno può scegliere dinascere intelligente. È semplicemente l’en-nesima prova che il corso evolutivo della vi-ta sulla terra sviluppa le sue strategie senzacurarsi del benessere umano, ingannando-ci con ridicole idee sul senso e il significatodella sofferenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Paolo Bianchi, L’intelligenza è un disturbo mentale, Cairo, Milano, pagg. 180, € 13
filosofia minima
Hitler secondo l’anarchicoFeyerabend
di ArmandoMassarenti
Dopo la recente affermazionedella destra xenofoba inAustria, a un passo dal vincerele elezioni, ho ripensato a ciòche scriveva Paul K. Feyera-
bend nella sua splendida autobiografia, intitolata Ammazzando il tempo e uscita per Laterza nel 1994, anno della sua morte,a 70 anni di età. Esordiva fin dalle prime pagine avvertendo degli strani scherzi che può fare la memoria: quelli in forza dei quali magari oggi ci si stupisce del rina-scere di certe idee che pensavamo del tutto tramontate. Aveva deciso di scrivere quel libro nel 1988, durante il cinquante-nario dell’unificazione tra Austria e Ger-mania. «Ricordavo che gli austriaci aveva-no accolto Hitler con straordinario entu-siasmo, ma ora mi ritrovavo ad ascoltare condanne secche e toccanti appelli uma-nitari. Non che fossero tutti in malafede, eppure suonavano vuoti: lo attribuii alla loro genericità e pensai che un resoconto in prima persona sarebbe stato un modo migliore di fare storia. Ero anche piuttosto curioso. Dopo aver tenuto lezioni per quarant’anni in università inglesi e ameri-cane, mi ero quasi dimenticato dei miei anni nel Terzo Reich, dapprima come studente, poi da soldato in Francia, Iugo-slavia, Russia e Polonia». Persino lui, Paul K. Feyerabend, dunque, già allora quello spirito libero che poi sarebbe divenuto famoso come l’epistemologo dell’anarchi-smo metodologico, aveva subito una forma di attrazione per il regime, e aveva anche meditato di entrare nelle SS. «Per-ché? Perché un uomo delle SS aveva un aspetto migliore, parlava meglio e cammi-nava meglio di un comune mortale: le ragioni erano estetiche, non ideologiche». Finalmente un libertario, un democratico capace di non cadere nelle trappole del-l’ipocrisia! ho pensato ai tempi leggendo Ammazzando il tempo. E che ci fa capire meglio perché il nazismo potesse attrarre le giovani generazioni. Anche rivedere l’immagine stereotipata di Hitler era per Feyerabend un modo per capire meglio la realtà. Abbiamo visto mille volte spezzoni di documentari che ce lo mostrano come una macchietta in preda all’ira. Si tratta di una precisa scelta della propaganda post-bellica. Feyerabend descrive invece così la sua arte oratoria: «Hitler accennava ai problemi locali e a quanto era stato fatto fino ad allora, faceva battute, alcune abbastanza buone. Gradualmente cam-biava il modo di parlare: quando si riferiva a ostacoli e inconvenienti aumentava il volume e la velocità del parlare. Gli accessi violenti che sono le uniche parti dei suoi discorsi conosciute in tutto il mondo erano preparati con cura, ben interpretati e utilizzati con umore più calmo una volta finiti; erano il risultato di controllo, non di rabbia, odio o disperazione».
Ancora oggi, se del nazismo non cer-chiamo di capire le ragioni interne, e magari non ci spaventiamo a rileggere Mein Kampf, non sapremo mai perché esso ha appassionato così tante persone. E sarà anche più difficile difendere i nostri valori più cari: libertà, pluralismo, democrazia. Benché l’intelligenza critica di Feyera-bend fosse già piuttosto acuta, al punto da commentare la lettura di Mein Kampf (ad alta voce alla famiglia riunita) come un «modo ridicolo di esporre un’opinione», «rozzo, ripetitivo, più un abbaiare che un parlare», egli stesso, pochi giorni dopo, avrebbe concluso un tema scolastico su Goethe legandolo proprio a Hitler. Non solo la memoria collettiva può fare brutti scherzi: anche la nostra attenzione critica è qualcosa di quanto mai fragile. Ma lo è ancora di più se ci rifiutiamo di rileggere senza ipocrisia le pagine più buie della nostra storia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
n.@Massarenti24
il lavoro culturale
E Bianciardiinventòil bibliobus
di Goffredo Fofi
I l mito di Luciano Bianciardi non puòche venir rafforzato da questo stu-dio di Elisabetta Francioni, di pro-fessione bibliotecaria dal 1983, così
attento e specifico su una particolare at-tività dello scrittore toscano (“marem-mano”), quella affrontata al ritorno dal-la guerra di bibliotecario che molto cre-deva nell’emancipazione culturale delnostro proletariato. Non fu solo per ne-cessità economiche e in attesa di meglioche egli si dedicò a un’impresa su partedella quale avrebbe poi affettuosamenteironizzato scrivendo quel bellissimopamphlet autobiografico che è Il lavoroculturale, veridico documento dei sogni“pedagogici” della sinistra di quegli an-ni ma anche delle loro ambiguità, spe-cialmente sul rigido fronte comunista.Occorreva aiutare un popolo a crescere,culturalmente e civilmente, dopo ven-t’anni di fascismo, due guerre mondiali,e secoli e secoli di analfabetismo, e anco-ra manca uno studio accurato dei diversimodi di “alfabetizzare” i nostri proletarielaborati dai cattolici e dai comunisticon più prepotenza e in modi più duttili erispettosi dai socialisti e dai laici: nontanto una storia pedagogica quanto unastoria culturale vera e propria, attentaalle teorie e alle pratiche, che si diviseroanzitutto tra quelle “dall’alto” e quelle“dal basso”. (Solo di recente va prenden-do forza negli studi storici, come altroveavviene da anni e anni, una corrente del-la contemporaneistica che non studiasoltanto le grandi forze politiche ed eco-nomiche, ma le esperienze di interventosociale e pedagogico di base, certamenteminoritarie ma prive delle ambiguità edelle prepotenze delle maggiori, gene-ralmente stataliste anche se per schiera-menti diversi.)
Corredato da molte foto significative,questo saggio così “specialistico” si rive-la anche un viaggio nella storia dell’Italiadella ricostruzione rivelatore e appassio-nante, e presenta il duplice interesse didocumento sulla gioventù di Bianciardi,prima della Milano del boom e della “vitaagra”, e di documento sulle esperienze dirisveglio culturale tentate anche dalleistituzioni, e in particolare da una dellepiù necessarie e benemerite di tutte, lebiblioteche pubbliche. Bianciardi cre-dette molto nel suo lavoro, visto non solocome un modo di guadagnarsi il panequasi ideale, per un reduce che era ancheun intellettuale in epoca di forte e gene-rale disoccupazione. Egli fu peraltro tra iprimi a servirsi in modo creativo di unaprospettiva nuova, quella del bibliobus,come lo si chiamò, un povero camionci-no-libreria da far girare nei paesi e nellecampagne e che altrove (per esempio inEmilia) era già un pullman attrezzato. Al-la sua ideazione e al lavoro di convinzio-ne sulle autorità Bianciardi si dedicò confervore, come dimostra la sua corrispon-denza “ufficiale”, e il lavoro di Bianciardialla Chelliana di Grosseto divenne di mo-dello e di sprone per altre consimili av-venture. La parte forse più appassionan-te del saggio di Elisabetta Francioni èquella sui fruitori della biblioteca neglianni della direzione Bianciardi, docu-mentata tra l’altro da un fraterno articolodi Carlo Cassola su un numero di «Comu-nità» del 1954: 700 lettori si fanno presta-re 5.700 libri, con un indice di 7 libri l’an-no pro capite in un Paese di 25mila abi-tanti, 40mila con le frazioni. «In testa allaclassifica degli autori- scrive Cassola -,figura Moravia con 78 passaggi, seguitoda Croce con 76, Hemingway con 69, Ver-ne con 62, Pirandello con 55, Steinbeckcon 52, Caldwell con 47, Conrad con 46,Maupassant con 43, Shakespeare con 41,Dostoevskij e Boccaccio con 39, Pavesecon 38», giù fino a Calvino con 20. Consi-derando le opere, prima dei best-seller diMoravia o Hemingway compare un clas-sico, Madame Bovary. Altrettanto appas-sionante è il resoconto sulle conferenzetenute nella biblioteca (Cassola, Dessì,Capitini, Volpicelli…) e quello delle “let-ture commentate” (le novelle di Boccac-cia, Cecco Angiolieri, il Belli…), eccetera.
Il volume è corredato da brani del Lavoro culturale e della Vita agra e da articolidi Bianciardi del tempo: «Forse 800 fre-quentatori in un centro di 25.000 abitan-ti possono sembrare molti ma non biso-gna dimenticare che tutti i 25.000 paga-no le tasse e tutti hanno diritto a quel ser-vizio pubblico».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Elisabetta Francioni, Luciano Bianciardi bibliotecario a Grosseto (1949-1954), con due interventi di Alberto Petrucciani e Arnaldo Bruni, Associazione Italiana Biblioteche, pagg. 166 in grande formato e con numerose illustrazioni nel testo, € 30
Passate le polemiche legate alla pubblicazione con il Giornale del «Mein Kampf» di Hitler diciamo anche noi sommessamente la nostra. La caratteristica principale del libro come ha ricordato molti anni fa il grande storico del pensiero politico JeanJacques Chevallier è che contiene in anticipo tutto ciò che Hitler avrebbe poi fatto una volta conquistato il potere. È il suo essere un esempio unico di coerenza assoluta, e sempre pericolosa, tra pensiero e azione a renderlo al tempo stesso mostruoso e con buona pace di Luca Sofri che lo trova noioso alquanto interessante.
Viene voglia di rivalutare il diritto deipolitici già rivendicato ironicamente da Jonathan Swift di mentire e di non mantenere le loro spesso irrealistiche promesse elettorali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
il graffio
«Mein Kampf»,troppa coerenza
Continua la seriedei racconti allegati alla Domenicadel Sole 24 Ore. Il 26 giugno sarà la volta di «Gli scapoli delle colline» di William Trevor. Oggi i lettori troveranno «Diario di un uomo superfluo» di Ivan Sergeevič Turgenev. Informazioni sul sito www.ilsole24ore.com
il 26 giugno «gli scapoli delle colline» di william trevor
scrittore americano | David Foster Wallace, nato nel 1962, è morto suicida nel 2008
Foster Wallace come Alberto SavinioNel luglio 2006 Armando Massarenti incontrava a Capri
alle «Conversazioni» organizzate da Antonio Monda David Foster Wallace in viaggio pere la prima volta in Italia.
Massarenti paragona lo scrittore americano ad Alberto Savinioper la prosa leggera, divagante, filosofica e con vocazione civile
www.archiviodomenica.ilsole24ore.com
immigrazione
Solo le storie misurano il doloredi Giorgio Fontana
Da bambino sognavo che esistesseuna macchina del dolore. Un ag-geggio che consentisse, per po-chi istanti, di provare concreta-
mente le sofferenze altrui — specie quelleche mi apparivano più remote: il freddo, lafame, la tortura. Cosa sente un corpo quan-do viene ridotto all’impotenza? Potevo ve-derlo alla televisione. Lo leggevo nelle mieprime avventure attraverso le pagine. Maero sicuro di comprenderlo veramente?
Ritenevo che solo un’effettiva trasmis-sione di quella sofferenza avrebbe potutoscatenare in noi la vera empatia — e dun-que un’azione immediata. Non puoi capi-re, mi dicevo: è vero, a volte realmente nonpossiamo capire. L’immaginazione ha deilimiti irritanti; e lì vedevo l’origine del-l’ignavia morale. E ogni volta che leggo diuna tragedia capitata a chi si è messo inviaggio per fuggire, una parte di me — lapiù radicale, forse anche la più ingenua —ci ripensa con convinzione. Uno strumen-to capace di andare oltre la squallida conta-bilità del male: 366 migranti deceduti nelsolo naufragio del 3 giugno 2013; 3500 imorti in mare nel 2015; centinaia di disper-si il 6 maggio 2011; centinaia di migliaia disfollati dalla guerra in Siria; e così via, e cosìvia. Uno strumento capace di andare oltre itanti discorsi, le tante immagini. Oltre il
dramma della rassomiglianza e dell’as-suefazione. Dopo cento volti straziati dallasofferenza, dopo gruppi e gruppi di bambi-ni affamati che fissano l’obiettivo, dopo uneditoriale indignato, dopo un dialogo con-trito fra amici e compagni — che resta? Co-me propagare un vero incendio delle co-scienze? Volevo un mezzo per proteggercidal pensiero destinale: l’idea che in fondole cose stiano così, che non vi sia altro da fa-re se non compiangere. Lamentarsi insie-me. Un rito consolatorio.
Poi sono diventato grande, e mi sonotrovato a che fare con le parole. Un mezzocertamente molto potente, e nel quale nu-tro grande fiducia. Ma limitato, e a volte ca-rico di menzogna. Pensate solo a ciò che di-venta un essere umano in fuga dall’Eritrea,o dal Sudan, o dall’Afghanistan, quandotocca le coste dell’Europa: un irregolare, un clandestino. Subisce una sorta di tra-sformazione — e basta qualche sillaba. Delresto su questo non ho mai avuto dubbi: ilpotere, anche il potere lessicale, è qualcosadi estremamente pericoloso.
Cosa opporre allora a tutto questo?Qual è la nostra macchina del dolore?Le storie, forse.
Le storie sono ciò che ci impedisce di ri-durre questa immensa tragedia a un muc-chio di concetti e numeri: le storie libera-no le parole dalla loro banalità e dalla loroimprecisione. In un passo di Minima moralia, Adorno scriveva che «la vita passatadell’emigrante è, come è noto, annullata.
Una volta era il mandato di cattura, oggi,invece, è l’esperienza intellettuale cheviene dichiarata non trasferibile e total-mente estranea al carattere nazionale.Ciò che non è reificato, che non si prestaad essere contato e misurato, viene lascia-to cadere». Tutto ciò che all’Europa inte-ressa è appunto il misurabile: un’impron-ta digitale, un nome, un foglio di carta.Quello che c’è dietro — la singolarità ine-ludibile di ogni persona, l’unicità di ogniesperienza — perde di significato.
Ecco, le storie si ribellano a questo pen-siero. Le storie rivendicano l’eccezione el’individualità contro la regola uniforman-te: narrarle, e ascoltarle, fa parte della no-stra possibilità di riscatto morale. Perchénon ci parlano di una massa confusa, ma dipersone. Non dicono di clandestini, ma diesseri umani: liberi, affamati di felicità,terrorizzati dal destino dei propri cari.Esattamente come noi.
Non crediate che sia soltanto un proble-ma transitorio o legato a un dato periodostorico: in gioco c’è molto di più. Perché è inluoghi come i campi che oggi stiamo deci-dendo, concretamente e dolorosamente,che cos’è un essere umano. La libertà dellepersone in fuga misura la nostra: più la ne-ghiamo, più sprofondiamo in un abisso divergogna e crudeltà, e più la libertà che vi-viamo ogni giorno suona come un insulto.La loro possibilità di avere un futuro misu-ra il nostro. La loro stessa esistenza, in bre-ve, misura il valore della nostra.
È terribile pensare a tutti questi indi-vidui come a una semplice massa chegiunge verso di noi in maniera casuale escomposta; ed è sbagliato anche pensarlicome oggetti inerti e semplicemente bi-sognosi di cure.
No, essi testimoniano invece una pro-fonda dignità. Una resistenza all’oppres-sione, alla violenza terrorista o istituzio-nale, ai recinti, alla crudeltà gratuita, alladisperazione. Un fotografo siriano che halavorato nei campi dei rifugiati ha detto:«Le persone che ho incontrato sono nellepeggiori condizioni possibili, ma hanno ildesiderio di continuare a rimanere uma-ni». E dunque soggetti liberi.
È dallo straniero che viene che giungonoi doni migliori, quelli che non avremmomai sospettato di ricevere per paura o diffi-denza. Albert Camus — uno dei primi a ri-cordarci che lo straniero giace dentro di noi— annotava: «Al mondo esiste la bellezzaed esiste l’inferno degli oppressi. Perquanto difficile possa essere, io vorrei es-sere fedele a entrambi». Restare fedeli allabellezza e agli oppressi: non conosco modomigliore per dire quello che siamo chiama-ti a fare, di fronte a chi si mette in viaggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
il 22 giugno a san marino
Questo brano è uno stralcio del testo di Giorgio Fontana «La macchina del dolore»: sarà presentato al Palazzo Pubblico di San Marino, alle 18, al Dig Festival in occasione di «Open Migration: The Journey to Humanity – Unlocked», mostra multimediale sul fenomeno delle migrazioni