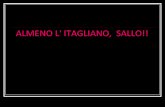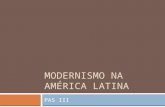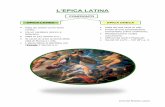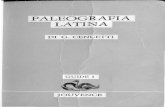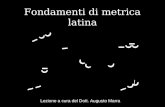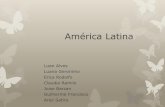TEORIA E TECNICA DELLA...
-
Upload
truonghuong -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of TEORIA E TECNICA DELLA...

EDOARDO SCARPANTI
TEORIA E TECNICA DELLA TRADUZIONE
UN APPROCCIO LINGUISTICO
Appunti per il corso di
Teoria e Tecnica della Traduzione
Scuola Universitaria per Mediatori Linguistici “Oxford”
Mantova
a.a. 2010/2011

2
Fotocopie a uso interno degli studenti del corso
---------------
Si invita a inviare commenti e correzioni
al seguente indirizzo di posta elettronica:
prof. Edoardo Scarpanti
e-mail: [email protected]

3
SOMMARIO
I. La traduzione nella storia
1. La traduzione dall‟antichità al Rinascimento p. 7
2. La traduzione e la sua legittimità nell‟Ottocento p. 14
3. La riflessione sulla traduzione nel Novecento p. 18
II. Teoria della traduzione
1. Che cosa significa tradurre p. 23
2. Il segno linguistico secondo Saussure p. 24
3. Il segno nella semiotica di Peirce p. 27
4. Comunicazione e funzioni testuali secondo Jakobson p. 29
5. Prototesto, metatesto, paratesto, intertesto e ipertesto p. 33
6. Tipologia testuale p. 34
7. Il circolo ermeneutico p. 38
8. Per una definizione di traduzione p. 40
9. Nella mente del traduttore p. 42
III. Tecnica della traduzione
1. Dominante, punctum e residuo p. 45
2. Gli elementi contestuali p. 52
2.1. Contesto p. 52
2.2. Cotesto p. 55

4
2.3. Autore: biografia, bibliografia, citazioni, stile p. 55
2.4. Il problema dei realia p. 56
3. Lessico e significati p. 58
4. Tipologia della traduzione p. 60
5. Lo stile del traduttore p. 62
5.1. Adeguatezza e accettabilità p. 62
5.2. Il rischio del paternalismo p. 63
5.3. Abitudini scolastiche p. 64
5.4. Visibilità del traduttore p. 66
5.5. Uno stile adattabile p. 67
IV. Strumenti del traduttore
1. Strumenti tradizionali p. 72
1.1. Il dizionario monolingue p. 73
1.2. Il dizionario traduttore p. 73
1.3. Dizionari speciali ed enciclopedie p. 74
2. Strumenti offerti dalle nuove tecnologie p. 74
2.1. Dizionari elettronici p. 74
2.2. Corpora p. 75
2.3. Enciclopedie e wiki p. 76
2.4. Forum di discussione p. 77
2.5. Elaboratori di testo e formati dei documenti p. 77
2.6. La traduzione automatica p. 78
3. La presentazione del testo tradotto p. 80
3.1. Forma, norme redazionali e bibliografia p. 80

5
3.2. Standard di trascrizione p. 81
Appendici
1. Selezione di risorse elettroniche p. 82
2. Tabelle di trascrizione (russo e arabo) p. 84
3. Prontuario ortografico e stilistico p. 86
Riferimenti bibliografici p. 89

6

7
I
LA TRADUZIONE NELLA STORIA
1. La traduzione dall’antichità al Rinascimento
Nella civiltà greca con il termine hermenéus si indicava anzi tutto l‟interprete
orale, cioè quella figura professionale che rendeva possibile a un soggetto
grecofono la comunicazione con persone non di lingua greca: per inciso, si noti
che con un certo senso di superiorità i Greci definivano i non grecofoni bárbaroi,
cioè letteralmente “balbuzienti”. Più tardi, con lo stesso hermenéus si passò a
indicare il traduttore di un testo scritto da una lingua all‟altra, ma anche colui che
parafrasava e interpretava un‟opera di natura poetica commentandola e rendendola
fruibile per il pubblico; si trattava, in quest‟ultimo caso, di un‟attività che oggi
faremmo rientrare piuttosto nella filologia o nella critica letteraria1. La stessa
ambiguità semantica si ritrova anche nel corrispettivo latino del greco hermenéus,
cioè intĕrpres, termine dal quale discende direttamente l‟italiano colto interprete,
che però si è maggiormente specializzato nell‟indicare colui che compie una
traduzione orale (o interpretazione), contrapposto in tal senso al traduttore, che
per lo più è colui che traduce un testo scritto2.
1 Dal greco hermenéus, recuperato per via dotta, viene il sostantivo italiano ermeneutica, che
indica nel campo della filosofia la “scienza dell‟interpretazione”. Sulla ricostruzione storica
dell‟attività di traduzione e della riflessione teorica ad essa attinente si può fare riferimento a
Soletti [1994], alle raccolte antologiche di Nergaard [1993; 1995] e alla sintesi di Osimo [2002];
cfr. anche Venuti (ed.) [2002]. Sulla terminologia con la quale si designava nell‟antichità la pratica
della traduzione cfr. Folena [1991].
2 Il latino intĕrpres (gen. interpretis) aveva originariamente il significato di “mediatore”, con
un‟accezione commerciale; non a caso, infatti, si tratta di un composto da inter “fra” e della stessa
radice di pretium “prezzo”. L‟italiano interprete compare nel XIV secolo sia con il senso di

8
Per quanto riguarda invece l‟azione compiuta dal traduttore, il verbo italiano
tradurre e il sostantivo traduzione provengono, anch‟essi per tradizione dotta, dal
latino tradūco “portare oltre” e dal relativo deverbale tradūctio, così come accade
per il verbo francese traduire e il relativo sostantivo traduction. Una forma latina
concorrente, rappresentata dal verbo transfero e da translatio, ha dato invece
origine all‟inglese translate e a translation, entrati nel lessico di quella lingua
come prestiti, sempre per via colta3. Altre lingue, invece, hanno creato calchi
strutturali partendo dalla stessa base latina, come nel caso del tedesco übersetzen.
Il termine greco per “traduzione”, metáphrasis, non ha invece avuto continuatori
diretti, se si esclude il tecnicismo moderno metafrasi per indicare una “traduzione
letterale” contrapposta in tal senso a parafrasi (dal greco paráphrasis)4.
L‟attività di traduzione, dunque, viene indicata con termini che per lo più
rappresentano i continuatori del latino traduco, per l‟italiano e per il francese, e
del suo concorrente transfero, ad esempio per l‟inglese. In entrambi i casi è
evidente come il processo di traduzione sia inteso, attraverso una metafora
spaziale, come un processo di “spostamento” di qualcosa da un luogo a un altro;
precisamente, in questo caso, l‟oggetto che viene idealmente spostato è il testo
oggetto della traduzione, che si immagina come qualcosa che precedentemente si
trovava in una lingua x (è il cosiddetto testo di partenza) e che successivamente si
trova “spostato”, cioè tradotto (ingl. translated), in una lingua y (ottenendo così il
testo di arrivo). L‟evidente metafora spaziale che sottostà a questi termini si
“espositore, commentatore” che con quello di “traduttore”; cfr. Cortelazzo-Zolli [1999: s.v.
interprete].
3 Lo stesso verbo latino aveva prodotto in italiano antico le forme traslatare e tralatare, poi
soppiantate da tradurre, il cui significato prima del XV secolo era soltanto quello di “trasportare,
condurre, trasferire”; la paternità del verbo tradurre spetterebbe, a quanto sembra, all‟umanista
Leonardo Bruni [Migliorini 1960; Cortelazzo-Zolli 1999: s.v. tradurre].
4 Tra i vari termini indicanti il “traduttore” nelle lingue europee, si può notare come il tedesco
Dolmetscher rappresenti uno dei rari prestiti dall‟ungherese in quella lingua, proveniendo da
tolmács; questo, a sua volta, viene dal turco dilmaç. Forme imparentate e con la stessa origine sono
il serbo-croato тумач (tumač), il polacco tłumacz, il ceco tlumočník e il russo толмач.

9
accompagna, per altro, a un‟accezione principalmente agonistica, per cui la
traduzione è implicitamente vista come una gara, che si svolge dal testo di
partenza a quello di arrivo.
Un problema fondamentale che ci si è sempre posti circa il funzionamento del
processo traduttivo sta proprio nella valutazione della più o meno stringente
fedeltà che il testo di arrivo deve mostrare nei confronti del testo di partenza.
Buona parte della letteratura latina era nata, almeno in una prima fase, come una
traduzione e un riadattamento della letteratura greca che la aveva preceduta: così,
ad esempio, il teatro latino reinterpreta e in buona parte traduce quello greco e lo
stesso si può dire di altri generi poetici, dall‟epica sino all‟epigrammatica. Già nel
mondo classico si discuteva se fosse da preferire una traduzione libera, poetica,
oppure una traduzione più fedele all‟originale, letterale, al limite fatta “parola per
parola”, ed è proprio a questo problema che si riferisce il più importante scrittore
di oratoria latina, Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.), quando scrive che i
migliori oratori “non hanno espresso le parole, ma la forza dei poeti greci”; e
quando allo stesso modo aggiunge, in un‟altra sua opera, che “non è necessario
tradurre parola per parola, come sono soliti fare i traduttori poco eloquenti”5.
Cicerone, che ben conosceva il greco, mostra di aver ben compreso come la
traduzione non consista in una semplice sostituzione di “etichette” che
immaginiamo applicate da una certa lingua ai singoli oggetti che compongono la
realtà con altre “etichette” appartenenti a un‟altra lingua, ma come in realtà essa
richieda da parte del traduttore un processo mentale ben diverso, che implica una
vera e propria reinterpretazione del testo di partenza alla luce della diversa cultura
della lingua in cui deve essere formulato il testo di arrivo. In questa ottica, per
Cicerone ciò che si deve esprimere è “la forza” dell‟originale, non le sue “parole”.
Anche alla radice delle tradizioni culturali e letterarie moderne stanno quasi
sempre delle traduzioni o, per meglio dire, dei volgarizzamenti: anzi tutto la
5 Non verba sed vim graecorum expresserunt poetarum (Cic. Academica 1, 10); nec tamen exprimi
verbum e verbo necesse erit, ut interpretes indiserti solent (Cic. De finibus bonorum et malorum 3,
15); la traduzione, questa volta libera, è di chi scrive. Su questi aspetti cfr. Folena [1991: 9].

10
traduzione della Bibbia, che avviene progressivamente nelle diverse lingue volgari
d‟Europa, e quindi la traduzione dei classici, greci e latini, che travasa nelle nuove
culture i fondamenti filosofici e scientifici di quelle antiche civiltà. In altri termini,
si potrebbe dire che la nostra civiltà è nutrita di traduzioni e non è pensabile senza
di esse6. Non meno importanti di quelle dal latino e dal greco furono le traduzioni
dall‟arabo e dal persiano, avvenute in genere attraverso il latino, che permisero
l‟aggiornamento delle conoscenze scientifiche, matematiche e tecnologiche
dell‟Occidente.
Il più importante traduttore dell‟antichità fu senz‟altro san Girolamo, al secolo
Sofronio Eusebio Girolamo di Stridone (347-420), che fra l‟altro portò a termine
la traduzione dal greco in latino dell‟intera Bibbia cristiana. Si noti per altro che,
mentre il Nuovo Testamento era stato composto direttamente in greco, la gran
parte dell‟Antico Testamento era originariamente scritta in ebraico e dunque in
questo caso la traduzione di Girolamo non era stata effettuata sul testo originale,
ma sulla traduzione in greco tradizionalmente detta dei Settanta, dal numero dei
traduttori che, secondo una leggenda, vi avrebbero lavorato ad Alessandria
d‟Egitto: i settanta eruditi (settantadue secondo altre fonti), chiamati dal sovrano
Tolomeo II Filadelfo (285-246 a.C.), si sarebbero ritirati per settantadue giorni in
completo isolamento e miracolosamente avrebbero infine prodotto, l‟uno
indipendentemente dagli altri, settantadue traduzioni identiche del testo biblico7.
Girolamo era esperto anche di traduzioni di testi letterari e mentre sostiene che nel
caso di un testo poetico la traduzione possa essere “libera” e “artistica”, al
contrario sottolinea con decisione come nel caso del testo sacro della Bibbia la
traduzione debba essere il più fedele possibile all‟originale rivelato, dato che nelle
6 [Lepschy 1981; Folena 1991].
7 Porzioni minori dell‟Antico Testamento erano state composte in lingue diverse dall‟ebraico, quali
il greco e l‟aramaico, la lingua parlata dal popolo in Palestina ai tempi di Gesù; anche nel caso del
Nuovo Testamento, del resto, qualcuno ha ipotizzato che del Vangelo secondo Matteo sia esistita
una redazione originale in aramaico, ma sinora non si sono trovate tracce di tale testo.

11
Sacre Scrittura “anche l‟ordine delle parole è un mistero”8. Nei primi secoli del
Cristianesimo, comunque, era fortemente diffusa l‟idea, dovuta soprattutto a
Paolo, che ogni traduzione del testo sacro fosse di per sé un tradimento del testo
stesso, per cui si cercava di evitare il più possibile di ricorrere alla traduzione della
Bibbia nelle lingue parlate, preferendo utilizzare la versione latina di Girolamo,
che prese perciò il nome di Vulgata, cioè di “(versione) per il popolo (lat.
vulgus)”. Più possibilista sul problema della traduzione libera dei testi sacri
sembra essere, invece, sant‟Agostino (354-430), vescovo di Tagaste, fra i più
grandi scrittori dell‟antichità cristiana, che afferma di preferire decisamente
l‟eventuale critica dei grammatici alla concreta possibilità di non essere capito dal
popolo che gli è affidato come pastore di anime.
La necessità di avere a disposizione le traduzioni dei testi antichi nelle lingue
parlate, le cosiddette lingue volgari, divenne sempre più pressante con il passare
del tempo, dato che il latino aveva ormai cessato di essere una lingua parlata e
aveva ceduto il posto ai diversi volgari italiani, al francese antico, all‟inglese
antico (o anglosassone) e via dicendo. Il latino, si badi, rimaneva comunque la
lingua di riferimento della cultura, della Chiesa d‟Occidente e la lingua dei
rapporti internazionali, una sorta di lingua franca della tarda antichità e del primo
medioevo9. I movimenti religiosi del XII e XIII secolo, fra i quali gli stessi
Francescani, richiedevano insistentemente il permesso di tradurre i testi sacri nelle
lingue parlate, ottenendo però una forte opposizione da parte della Chiesa. A tale
necessità si accompagnò poi, in ambito più strettamente culturale, quella di
8 Così si esprime Girolamo nella lettera a Pammachio (Epistola LVII, dell‟anno 395 o 396) [Soletti
1994: 732]. Girolamo, nato in Dalmazia, era cresciuto sin da bambino in un ambiente plurilingue.
9 Non a caso in alcune lingue volgari l‟aggettivo latino si usava anche per indicare ciò che era
“chiaro, ben comprensibile”, come si può dedurre dalla presenza di esempi di questo valore
semantico nella Divina Commedia di Dante (ad es. Paradiso III 93) o anche dalle molte varianti
romanze, non solo antiche ma anche contemporanee, dove ladin e altre forme simili significano
“facile, agevole” e così via. Con l‟espressione lingua franca si indica normalmente una lingua
sovranazionale, utilizzata in particolare per gli scambi commerciali: la lingua franca del mondo
contemporaneo globalizzato è, ovviamente, l‟inglese.

12
ripubblicare e di tradurre i testi classici, greci e latini, soprattutto a partire dal
Rinascimento. Tra i primi, in Francia il letterato Jean de Meun (ovv. de Meung,
XIII sec.) tradusse un trattato latino di arte militare, il De re militari di Vegezio,
con il titolo di Art de chevalerie (1284), con scelte traduttive che cercano di
rendere il testo il più comprensibile possibile al pubblico dei lettori,
attualizzandolo e avvicinandolo così al contesto del mondo medievale. A uno stile
di traduzione altrettanto libero si attenne anche il nostro Giovanni Boccaccio
(1313-1375) che fu un grande volgarizzatore dei classici latini, oltre che l‟autore
del primo capolavoro della prosa italiana, il Decamerone.
Nel corso del Rinascimento si era soliti distinguere in maniera abbastanza netta
fra la traduzione vera e propria, che avveniva in maniera “orizzontale” fra una
lingua contemporanea e l‟altra (ad esempio dal francese all‟inglese), e il
volgarizzamento, termine con il quale si indicava invece la traduzione dal latino a
una delle lingue contemporanee, che come si è già detto venivano chiamate lingue
volgari, cioè lingue “del popolo”. Così, ad esempio, si poteva tradurre il testo
italiano della Divina Commedia in inglese oppure volgarizzare un‟opera di
Cicerone dall‟originale latino al francese. L‟umanista Leonardo Bruni (1370 ca.-
1444), nel suo trattato De interpretatione recta [La corretta traduzione] (1420),
ovviamente composto ancora in latino, discute per la prima volta esplicitamente
del problema della traduzione in termini teorici, proprio con riferimento al
volgarizzamento dei classici latini e greci.
Nel XVI secolo il problema della traduzione entrò a pieno titolo nello scontro
religioso e politico, nel momento in cui buona parte dei Paesi dell‟Europa centro-
settentrionale stava abbandonando la Chiesa di Roma per aderire al
Protestantesimo. Proprio il padre della riforma protestante in Germania, il monaco
agostiniano Martin Lutero (1483-1546), portò a termine un‟importantissima
traduzione della Bibbia in tedesco, ponendo fra l‟altro le basi per la nascita della
lingua tedesca letteraria che conosciamo oggi, basata proprio sulla varietà alto-

13
tedesca da lui utilizzata10
. Accusato da più parti di essersi allontanato troppo nella
sua volgarizzazione dall‟originale latino della Vulgata di Girolamo, Lutero rispose
alle critiche nel 1530 con un‟Epistola sull’arte del tradurre, dove sottolineava
come il primo scopo della sua traduzione fosse stato proprio quello di produrre un
testo che risultasse perfettamente comprensibile al popolo, cercando di ottenere
uno stile scorrevole e adattando le metafore a immagini più attuali, anche al
prezzo di allontanarsi in parte dalla fedeltà completa al testo originale; un
processo, questo, che tecnicamente prende il nome di attualizzazione. In quel
testo, Lutero fra l‟altro scriveva:
Non si deve domandare alle lettere della lingua latina come si ha da parlare in
tedesco, come fanno questi asini, ma bisogna domandarlo alla madre in casa, ai
ragazzi nella strada, al popolano al mercato, e si deve osservare la loro bocca per
sapere come parlano e quindi tradurre in modo conforme. Allora essi
comprendono e si accorgono che parliamo con loro in tedesco11
.
L‟equilibrio tra fedeltà all‟originale e comprensibilità della traduzione è sempre
difficile da ottenere; tale difficoltà è ben espressa da una similitudine giustamente
famosa, inserita da Miguel de Cervantes (1547-1616) nel suo Don Quijote [Don
Chisciotte], uno dei testi più importanti della letteratura castigliana:
Mi pare che il tradurre da una lingua all‟altra, a meno che non sia dalle regine
delle lingue, e cioè la greca e la latina, sia come uno che guarda gli arazzi
fiamminghi dal rovescio; benché si vedano le figure, sono piene di fili che le
ombrano e non si vedono con quella superficie così uguale del diritto; e tradurre
10
Si noti, per inciso, che con l‟espressione Hochdeutsch “alto-tedesco” si indicano le varietà
tedesche meridionali, proprie cioè di quella parte della Germania dove si trovano i rilievi
montuosi, contrapposte alle varietà del nord, cioè delle regioni “basse” e pianeggianti, tra cui
anche i Paesi Bassi dove una varietà basso-tedesca, il neerlandese, è considerata lingua nazionale.
11 Man mus nicht die buchstaben inn der latainischen sprache fragen / wie man sol Deutsch reden
/ wie diese esel thun / sondern man mus die mutter ihm hause / die kinder auff der gassen / den
gemeinen mann auff dem marckt drumb fragen / und den selbigen auff das maul sehen / wie sie
reden / und darnach dolmetzschen / so verstehen sie es den / und mercken / das man Deutsch mit
jn redet [Luther 1530].

14
dalle lingue facili non presuppone né ingegno né ricchezza di linguaggio, come
non lo si presuppone per chi copi un foglio da un altro foglio12
.
Si noti che, appena dopo il passo citato, Cervantes ci tiene a precisare:
E non per questo voglio concludere che questa attività del tradurre non sia degna
di lode; giacché l‟uomo si potrebbe occupare di altre cose ben peggiori13
.
Ormai tramontato il Rinascimento con il suo interesse filologico a preservare i
testi nella loro forma il più possibile vicina all‟originale, il Seicento e il Settecento
furono caratterizzati dalla presenza massiccia di traduzioni e volgarizzamenti
abbelliti e ornati, che in Francia presero il nome di les belles infidèles [le belle
infedeli]: i testi classici venivano rimaneggiati, interpolati, adattati alla cultura
ricevente anche in maniera massiccia, ad esempio censurando scene e temi
scabrosi non consoni al decoro dell‟epoca. Fra i traduttori francesi delle belle
infedeli si segnala soprattutto Nicolas Perrot d‟Ablancourt (1606-1664),
volgarizzatore delle opere di Cicerone, di Tacito e di molti altri classici.
2. La traduzione e la sua legittimità nell’Ottocento
All‟inizio dell‟Ottocento il nuovo clima culturale, il Romanticismo, spostò
l‟attenzione dai singoli testi alle culture che essi rappresentavano e parallelamente
affrontò per la prima volta in maniera scientifica il problema dei rapporti fra le
diverse lingue. L‟idea sottostante era che ogni nazione dovesse avere un suo
12
Me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas,
griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se veen las
figuras, son llenas de hilos que las escurecen y no se veen con la lisura y tez de la haz; y el
traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución, como no le arguye el que traslada ni el
que copia un papel de otro papel (vol. II, cap. 62). Cit. da Osimo [2004, 3-4]. L‟opera fu
pubblicata in due volumi fra il 1605 e il 1615 con il titolo El ingenioso hidalgo don Quixote de la
Mancha per il primo volume e El ingenioso caballero don Quixote de la Mancha per il secondo; la
grafia Quijote è moderna.
13 Y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir; porque en otrascosas
peores se podría ocupar el hombre.

15
popolo, che a sua volta avrebbe dovuto essere identificabile soprattutto sulla base
della propria lingua, la quale avrebbe fatalmente espresso lo spirito di quel popolo
e di quella nazione. Il compito che spettava al traduttore, a questo punto,
consisteva nel ricercare un difficile equilibrio tra la fedeltà alla cultura del testo
originale e l‟adattamento alla cultura di arrivo e tale compito è stato ben espresso
dal filosofo tedesco Friedrich Schleiermacher (1768-1834), che nel 1813 scrisse:
O il traduttore lascia stare il più possibile lo scrittore e sposta il lettore verso lo
scrittore, oppure lascia stare il più possibile il lettore e sposta lo scrittore verso il
lettore14
.
Come si vedrà più avanti, il dilemma così ben individuato e riassunto dalle brevi
parole di Schleiermacher, per altro già presente in altre teorizzazioni precedenti,
sarà una vera e propria costante delle riflessioni sulla traduzione: si tratta, in altri
termini, della difficile scelta fra una traduzione letterale e una versione libera,
della quale si discuterà dettagliatamente nel Cap. III, nei termini di adeguatezza e
accettabilità, cercando di sottolineare come tale scelta debba dipendere in buona
parte dalla tipologia del testo da tradurre e dagli scopi che il traduttore di volta in
volta si prefigge.
Wilhelm von Humboldt (1767-1835), in linea con la sensibilità romantica,
sostiene che i diversi popoli, attraverso le rispettive lingue, esprimono una
concezione del mondo (Weltanschauung) e una percezione della realtà
completamente differenti gli uni dagli altri. Ne consegue necessariamente che una
vera e propria traduzione da una lingua all‟altra, a rigore, non sarebbe possibile, se
non al prezzo di travisare in buona parte lo spirito del testo e della lingua
originari. Tuttavia, il linguaggio fortunatamente è una capacità universale, così
come universale è la comune umanità che lega tutti i popoli, anche distanti fra
loro: in questo senso la traduzione, intesa come passaggio da una cultura a
un‟altra basato sulle comuni caratteristiche universali, è pur sempre possibile. Il
14
Entweder der Übersetzer läßt den Schriftsteller möhlichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm
entgegen; oder er läßt den Leser möglichst in Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen.
Cfr. Schleiermacher [1813: 47]; trad. it. cit. da Osimo [2004, 5].

16
Romanticismo tedesco si esprime, dunque, sulla questione della legittimità della
traduzione con un vero e proprio paradosso: se da un lato ogni traduzione è un
travisamento dello spirito del testo originale, dall‟altro però è pur sempre possibile
comprendere il senso di una traduzione facendo riferimento all‟universalità del
linguaggio umano.
L‟Ottocento è anche il secolo del grande sviluppo delle scienze esatte, attraverso
l‟osservazione dei fenomeni naturali e l‟elaborazione dei primi assiomi scientifici
in molti campi del sapere. La ricerca dei biologi sull‟evoluzione degli esseri
viventi, che si era già sviluppata con l‟interesse per la classificazione delle specie
botaniche e animali a partire da Linneo e che raggiunse il suo culmine con l‟opera
di Charles Darwin, fornì un modello di ispirazione anche per la ricerca in campo
linguistico. Un rinnovato interesse per la comparazione fra le diverse lingue si
sviluppò improvvisamente fra la fine del Settecento e l‟inizio del secolo
successivo, quando iniziarono a giungere in Europa i resoconti degli studiosi
inglesi che, impegnati a osservare la ricchezza della cultura delle nuove colonie
indiane, si erano accorti della straordinaria somiglianza tra le lingue dell‟India, in
particolare la lingua sacra della religione indù conosciuta come sanscrito, e le
lingue d‟Europa sia moderne che storiche, come tedesco, inglese, francese,
italiano, latino, greco e gotico. Queste riflessioni, rielaborate da pensatori come
Wilhelm Schlegel (1767-1845) e da filologi come Franz Bopp (1791-1867),
Rasmus Rask (1787-1832) e Jabob Grimm (1785-1863), portarono gradualmente
alla nascita della linguistica storico-comparativa come scienza moderna e alla
parallela teorizzazione di una lingua originale comune a tutti i popoli indoeuropei,
dall‟India sino all‟Europa, che prese appunto il nome di indoeuropeo e in
Germania quello di Indogermanisch. Anche queste riflessioni, del resto,
rafforzarono l‟idea della presenza di fattori universali comuni a tutte le lingue,
quegli stessi fattori che secondo Humboldt giustificavano la traduzione da una

17
lingua a un‟altra: nel frattempo, anche i testi religiosi e filosofici dell‟India
raggiungono i paesi europei, tradotti ovviamente nelle varie lingue locali15
.
Si diffonde parallelamente, in questo periodo, anche l‟idea che le lingue
nascano, si diffondano e si riproducano, evolvendosi così in altre lingue, proprio
come fanno gli esseri viventi. Come per le specie animali, anche per le lingue è
dunque possibile disegnare un albero genealogico che segua la loro evoluzione nel
tempo, ed è precisamente quanto fa per la prima volta August Schleicher (1821-
1868), elaborando la sua Stammbaumtheorie [teoria dell’albero genealogico].
L‟evoluzione non è solo nella realtà fonetica delle lingue, ma anche nel loro
funzionamento; infatti, a partire da alcuni studi di Humboldt si notò che le lingue
del mondo potevano essere classificate, oltre che sul piano genealogico, anche su
quello tipologico, considerando cioè il loro funzionamento a livello soprattutto
morfologico e sintattico. Dal punto di vista morfologico, ad esempio, furono
individuati alcuni tipi linguistici, fra cui quello isolante, tipico del cinese, quello
agglutinante, come in turco, e quello flessivo, comune alla maggior parte delle
lingue europee. Non solo, ma si teorizzò anche in questo caso una sorta di
evoluzione che avrebbe portato dallo stadio dalle lingue isolanti, considerate più
primitive, a quelle flessive, passando le lingue agglutinanti: anche in questo caso
l‟evidente tensione teleologica non a caso puntava verso le lingue indoeuropee,
considerate le più perfette. La linguistica, tuttavia, non è senza colpe. È proprio in
questo periodo, a metà dell‟Ottocento, che nasce l‟idea di una superiorità delle
lingue indoeuropee, le “nostre lingue”, come tedesco, inglese, francese, spagnolo
e italiano – oltre ovviamente al sanscrito – sulle altre lingue del mondo, meno
perfette e più primitive, come arabo, cinese, sino alle lingue dei nativi americani o
dell‟Africa più remota. Da affermare la superiorità di una lingua ad affermare la
supremazia di una razza su un‟altra il passo è, purtroppo, brevissimo e pochi
decenni più tardi il Nazismo organizzerà spedizioni pseudo-scientifiche
sull‟Himalaya alla ricerca delle tracce dei progenitori comuni degli europei e degli
indiani, i tristemente famosi ariani (si noti che in realtà aria, cioè ariano, è
15
Sulla linguistica dell‟Ottocento si veda la precisa ricostruzione di Morpurgo Davies [1996].

18
semplicemente un titolo onorifico usato nell‟Avesta, il libro sacro della religione
tradizionale persiana).
3. La riflessione sulla traduzione nel Novecento
La scarsa predisposizione ufficialmente mostrata dal Romanticismo nei
confronti della traduzione è, ovviamente, soltanto teorica e di fatto tutto
l‟Ottocento e il Novecento letterari si nutrono di traduzioni: si traduce di continuo
dal tedesco all‟inglese, dall‟inglese al francese, dal francese all‟italiano e
viceversa. In Italia è Benedetto Croce (1866-1952) a ribadire ufficialmente ancora
una volta l‟impossibilità di una vera traduzione, soprattutto per quanto riguarda la
traduzione poetica, e sempre a Croce va attribuita la ripresa in termini precisi della
distinzione, che ha sempre un grandissimo successo, fra traduzioni letterali e
traduzioni infedeli (o libere). A questa prima opposizione, in realtà di natura più
che altro estetica, se ne accompagna però in Croce un‟altra, basata sul modo in cui
il lettore viene messo a contatto con il testo originale: è l‟opposizione che
distingue da una parte le traduzioni naturalizzanti, che avvicinano l‟originale al
lettore, e dall‟altra le traduzioni estranianti, che avvicinano il lettore all‟originale,
come del resto aveva già teorizzato Schleiermacher all‟inizio dell‟Ottocento.
Nel periodo fra le due guerre mondiali il filosofo tedesco di cultura ebraica
Walter Benjamin (1892-1940) riprende il problema dell‟ermeneutica, cioè
dell‟interpretazione, notando come la traduzione sia in verità un‟interpretazione e
insieme l‟espressione del rapporto più intimo delle lingue tra loro: in questo
senso, come già per Humboldt, la traduzione “spezza i limiti di una lingua, è una
crisi salutare, proiezione verso l‟universalità”16
; il ruolo del traduttore è, secondo
Benjamin, ammantato di misticismo, dato che ogni nuova interpretazione di un
testo equivale a una sua ricomposizione, un atto creatore.
Nel corso del Novecento buona parte della riflessione sulla traduzione è legata
ai diversi paradigmi linguistici che sono stati adottati e alle differenti posizioni
16
[Benjamin 1923; Soletti 1994].

19
teoriche. Nella prima metà del secolo il paradigma dominante nella riflessione
linguistica fu senza dubbio quello strutturalista, che si fa risalire al grande
linguista ginevrino Ferdinand de Saussure (1857-1913), il cui pensiero fu raccolto
dagli allievi degli ultimi corsi da lui tenuti a Parigi in un volume, apparso nel 1916
circa tre anni dopo la sua morte, intitolato Cours de linguistique générale
[Saussure 1916], che segnò profondamente tutta la linguistica del Novecento ma
che fu tradotto e pubblicato in Italia soltanto nel 1967.
Nel campo della riflessione sulla traduzione, sia allo strutturalismo che a una
prospettiva semiotica si è ispirato il linguista russo Roman Jakobson (1896-1982),
con un contributo fondamentale alla teoria della traduzione [1959]17
. Jakobson
opportunamente propone di distinguere tre forme diverse di traduzione: la
traduzione intralinguistica18
, che consiste nel riformulare un testo nel medesimo
codice con cui è stato originariamente composto, ad esempio quando diciamo che
la farmacia è “un luogo dove si vendono i farmaci”; la traduzione interlinguistica
(la traduzione vera e propria), che operiamo quando cerchiamo l‟equivalente di un
elemento di un codice linguistico in un altro codice linguistico, ad esempio
traducendo farmacia con Apotheke; infine, la traduzione intersemiotica19
, che
consiste nell‟interpretare un codice linguistico per mezzo di un codice non
linguistico, come quando si utilizza il simbolo della croce per indicare la
“farmacia” [Jakobson 1959; Martinelli 2005, 19].
17
La figura di Jakobson, fondatore del Circolo Linguistico di Praga, è stata di fondamentale
importanza nella diffusione del pensiero strutturalista e fu proprio lui a mediare le idee di Saussure
influenzando personaggi come Claude Lévi Strauss e Roland Barthes, che a loro volta applicarono
l‟approccio strutturalista rispettivamente all‟antropologia e alla critica letteraria, oltre che alla
semiotica. Su Jakobson si veda in particolare la ricostruzione di Bradford [1994].
18 Quella che viene indicata nella ricostruzione di Jakobson come traduzione intralinguistica si
può anche definire traduzione endolinguistica oppure, con un unico termine, riformulazione. Nella
prassi didattica delle scuole italiane un esempio tipico di traduzione intralinguistica è costituito
dalla pratica della cosiddetta parafrasi.
19 La traduzione intersemiotica viene indicata anche con il termine trasmutazione.

20
Un approccio strutturalista, a sua volta, è stato adottato fra gli altri anche da
Mounin (1910-1993), autore di un importante manuale sulla traduzione [1965].
Nella stessa prospettiva strutturalista si muove anche la sistemazione teorica del
problema della traduzione presentata negli anni „70 in Italia da Gianfranco Folena
(1920-1992), la cui posizione rappresenta, per così dire, la vulgata della
concezione che lo strutturalismo ha elaborato della traduzione e ne prende in
analisi tutti i diversi aspetti, recuperando la terminologia e gli elementi
interpretativi proposti dallo stesso Saussure20
. Tra i linguisti, in Italia fra gli altri
Benvenuto Terracini (1886-1968) affronta il problema dalla parte del traduttore e
della sua “grammatica”: il traduttore, in questo senso, deve ricercare le
equivalenze significative fra i due testi, delimitandone le unità espressive, e
attraverso la comparazione deve giungere a ricreare “l‟insieme indimenticabile”
che era presente nell‟originale21
.
Un apporto alla teoria della traduzione è venuto anche dalla riflessione sulla
versione in lingua corrente del testo biblico, in ambito teologico. Con lo sviluppo,
tra Ottocento e Novecento, dell‟esegesi storico-critica, ci si è nuovamente posti
infatti il problema della difficile scelta fra traduzioni letterali – o estranianti nei
termini crociani appena esposti – da una parte, e traduzioni più libere e
naturalizzanti dall‟altra. Eugene Nida ha proposto a questo riguardo di distinguere
tra due diversi princìpi ispiratori: da un lato l‟equivalenza formale, per cui la
traduzione deve riprodurre fedelmente la forma del testo originale, e dall‟altro
l‟equivalenza dinamica, laddove invece il traduttore deve preoccuparsi di ricreare
l‟effetto di quello stesso testo originale, attualizzandolo e rendendolo fruibile e
ben comprensibile al lettore contemporaneo22
. È evidente l‟importanza di queste
riflessioni nel caso della traduzione di un testo come quello biblico, dove le
metafore utilizzate fanno riferimento a un contesto ormai molto lontano nel
tempo.
20
[Folena 1973; 1991].
21 [Terracini 1951]. Sulla linguistica del Novecento cfr. Lepschy [1992] e Robins [1997].
22 [Nida 1959].

21
Nella metà degli anni ‟60 si diffonde un notevole interesse per le nuove
prospettive offerte dall‟informatica e in particolare per la cosiddetta traduzione
automatica. La prospettiva, ancora ovviamente allo stato embrionale, era in quel
momento quella di giungere alla creazione di calcolatori in grado di rendere
completamente automatico il processo traduttivo; una prospettiva che, del resto,
non sarebbe stata del tutto raggiunta nemmeno numerosi decenni più tardi.
Comunque sia, in quegli anni ci fu chi, come Catford, proprio sulla suggestione
delle nuove conquiste dell‟elettronica, vide nella traduzione un atto puramente
meccanico, automatico e automatizzabile23
. Era evidente, però, che le teorie come
quella di Catford erano destinate a infrangersi contro la delusione delle speranze
suscitate dalla traduzione automatica.
Negli anni successivi, Julia Kristeva ha concentrato la propria attenzione sulla
traduzione letteraria, spiegandola con la categoria interpretativa dell‟intertestualità
e con la nozione di mimesi, ripresa dal mondo classico24
. Da questo punto di vista,
la traduzione rappresenterebbe dunque una realtà dialogica di trasformazione
testuale, una sorta di citazione. Più di recente, all‟intertestualità e al concetto di
traduzione come citazione ha fatto riferimento anche l‟estone Peeter Torop, della
scuola semiotica di Tartu25
.
Alla fine del Novecento le teorizzazioni sulla traduzione costituiscono ormai un
campo ben delimitato della riflessione scientifica, raggruppato sotto l‟etichetta di
translation studies. Nuovi paradigmi interpretativi vengono frequentemente
proposti, anche se le posizioni teoriche raggiunte nei decenni precedenti
rimangono ovviamente punti di riferimento fermi, prima fra tutte quella espressa
da Jakobson. Tra i contributi più recenti si segnala, ad esempio, la teoria della
traduzione totale del già citato Torop, che vuole considerare non solo i problemi
23
[Catford 1965].
24 Cfr. Kristeva [1969]. La parola greca mímēsis significa “imitazione” e da essa derivano alcuni
termini dotti entrati anche in italiano, come appunto mimesi, oltre a mimetico, mimetismo,
mimetizzare ecc.
25 [Torop 2000].

22
della traduzione in sé e per sé, ma anche quelli relativi all‟apparato di commento
al testo (note, postfazioni ecc.) e ai luoghi in cui il testo fa implicitamente o
esplicitamente riferimento a un altro testo esterno (rimandi, citazioni, allusioni)26
.
Tornando al contesto italiano, alcuni aspetti della semiotica sono stati presi in
considerazione, con riferimento ai problemi traduttivi, in particolare da Umberto
Eco [1979; 2003]. Negli ultimi anni hanno visto la luce in Italia diversi manuali di
traduzione, per lo più incentrati su singoli approcci alla materia, di per sé spesso
molto validi: fra gli altri, si segnala in particolare il fortunato manuale introduttivo
di Bruno Osimo [2004], con un‟ampia ricostruzione storia della riflessione sulla
traduzione, un‟ottima sintesi degli aspetti più tangibili del lavoro del traduttore e
la presentazione di un approccio teorico particolarmente vicino alla semiotica.
26
Cfr. Torop [2000]; Osimo [2004, 10]; note, postfazioni, prefazioni, commenti e introduzioni
costituiscono il cosiddetto paratesto, concetto su cui si tornerà nel Cap. II; i rimandi a un altro
testo, invece, prendono il nome di intertesto.

23
II
TEORIA DELLA TRADUZIONE
1. Che cosa significa tradurre
Sebbene ciascuno di noi abbia un‟idea abbastanza chiara e intuitiva di che cosa
si intenda comunemente quando si parla di tradurre un determinato testo, tuttavia
non è per nulla facile definire in maniera univoca ed esaustiva che cosa significhi
realmente tradurre, specialmente nel momento in cui si voglia capire a fondo e
descrivere quale sia esattamente il processo mentale e comunicativo che porta alla
creazione di una traduzione. Nel linguaggio corrente, si applica il verbo tradurre a
una serie decisamente vasta di situazioni abbastanza eterogenee fra loro: così, ad
esempio, si traduce un testo scritto dall‟inglese all‟italiano, ma allo stesso modo
una persona può tradurre oralmente ciò che sta dicendo un‟altra persona che parli
in una lingua straniera (anche se per questi casi, cioè per la traduzione orale, i
traduttori professionali parlano piuttosto di interpretazione e non di traduzione) e
ancora si può chiedere a qualcuno di tradurre un appunto, scritto in maniera
oscura e poco chiara, in modo che esso risulti più facilmente comprensibile. Non
solo, ma svolge un compito analogo a quello del traduttore anche, ad esempio, una
madre nei confronti del proprio bambino, quando gli spiega una parola o una frase
difficile, parafrasandola in un linguaggio a lui più comprensibile; analogamente ci
si può trovare a tradurre un‟espressione formulata in una certa varietà di lingua
cercando di riformularla in un‟altra varietà dello stesso codice, più o meno
formale, più o meno chiaramente, oppure in un registro colloquiale, cordiale o al
contrario astioso, e via dicendo27
. Jakobson aveva ben notato questa molteplicità
27
La polisemia del verbo tradurre si ritrova anche nel sostantivo traduzione che indica non
soltanto l‟atto del tradurre, ma anche il risultato di tale atto [Soletti 1994, 731].

24
di funzioni della traduzione e aveva perciò proposto di distinguere le tre forme
diverse di traduzione già trattate più sopra (cfr. Cap. I): la traduzione
intralinguistica (o riformulazione), la traduzione interlinguistica e infine la
traduzione intersemiotica [Jakobson 1959].
Al di là di questa evidente varietà di usi del verbo tradurre, sembra comunque
di poter individuare un aspetto sempre presente nelle diverse accezioni sin qui
elencate: il traduttore compare in tutti i casi come colui che rende accessibile un
testo, orale o scritto che sia e in qualunque lingua esso sia stato redatto, il quale
precedentemente risultava del tutto o in parte inaccessibile. In altri termini, si
potrebbe dire che il traduttore svolga proprio una sorta di ruolo di facilitatore, il
quale permette al destinatario di un messaggio di cogliere pienamente il
significato di quel messaggio. Questa osservazione, apparentemente superficiale,
può essere comunque utile per chiarire sin da ora che il compito del traduttore non
termina con la stesura della traduzione vera e propria, ma in un certo senso esso
deve prevedere anche uno sforzo ulteriore, fornendo al lettore, o all‟ascoltatore nel
caso di una traduzione orale, tutti gli strumenti utili all‟interpretazione e alla
corretta comprensione di quel testo. Resta da definire, in ogni caso, quale sia
l‟esatta natura della traduzione in senso stretto e come si svolga questo processo,
straordinariamente complesso ma allo stesso tempo tanto naturale, nei parlanti di
ogni comunità linguistica. Per fare questo, però, occorre anzi tutto richiamare
alcuni concetti fondamentali dell‟analisi linguistica e semiotica, senza i quali non
è possibile proporre una definizione di traduzione appropriata dal punto di vista
linguistico: essi sono, in particolare, la teoria del segno linguistico elaborata da
Saussure, la teoria dei segni di Peirce e infine la teoria della comunicazione che è
stata proposta da Jakobson.
2. Il segno linguistico secondo Saussure
Una fondamentale caratteristica del linguaggio umano consiste nel fatto che il
codice linguistico è un codice composto da segni del tutto speciali: tali segni

25
infatti sono costituiti sempre da due elementi, sono cioè segni biplanari. Infatti,
secondo Saussure un segno linguistico è composto da un primo elemento fisico
detto significante e da un secondo, psichico, detto significato; il significante è
quello che comunemente chiamiamo parola, ma che meglio potremmo definire
come l‟immagine psichica prodotta nell‟ascoltatore dalla percezione dell‟insieme
dei foni che in sequenza costituiscono la parola stessa (oppure, nello scritto,
dall‟insieme dei grafemi, cioè dei simboli grafici), mentre il significato è il
concetto a cui ci si riferisce con quella parola (significante) in una certa lingua.
Così, in italiano al significante gatto ['gatto], emesso sotto forma di foni
dall‟emittente e ricevuto dal destinatario, corrisponde generalmente il significato,
cioè il concetto mentale, di “mammifero felino domestico” (Fig. 1).
Fig. 1. Il segno linguistico per Saussure
Cambiando la lingua (cioè il codice) di riferimento, ovviamente il legame fra
quel significante e quel significato non esisterà più e sarà necessario scegliere un
nuovo significante per esprimere il significato che si vuole ottenere; ad esempio in
inglese il significante gatto ['gatto] non corrisponde più a nessun significato,
mentre al significato “mammifero felino domestico” corrisponde un significante
completamente diverso da quello utilizzato in italiano, cioè cat ['khæt]. Il
linguaggio umano è dunque arbitrario e insieme convenzionale: infatti, il legame
fra un certo significante e un determinato significato non è tale per natura, ma per
una scelta inizialmente arbitraria che viene in seguito adottata convenzionalmente
significante
significato
['gatto]
segno
linguistico

26
da una specifica comunità linguistica (gli italiani, gli inglesi ecc.). Inoltre è
arbitrario anche il legame fra la forma (la suddivisione interna) e la sostanza (nel
suo complesso) dello stesso significato; cioè, le varie lingue organizzano un certo
significato complesso suddividendolo liberamente fra vari significanti: così, ad
esempio, alle tre parole (significanti) italiane bosco, legno e legna corrispondono
in tedesco le due sole parole Wald (solo per il significato “bosco”) e Holz (per i
due significati “legno” e ”legna”), in francese l‟unica parola bois (per tutti i tre
significati ”bosco”, ”legno” e ”legna”) e così anche in inglese il solo termine
wood (Tab. 1); ancora, al verbo italiano andare e all‟inglese go corrispondono in
tedesco due diversi verbi: gehen “andare (a piedi)” e fahren “andare (con un
mezzo meccanico)”.
bosco legno legna
Wald Holz
bois
wood
Tab. 1
Osservazioni analoghe si possono fare, ad esempio, con i possibili traducenti in
italiano, tedesco e francese dell‟unico significante inglese time (Tab. 2).
tempo volta ora
Zeit mal Uhr Spät
temps fois heure
time
Tab. 2
Tutto ciò ha ovviamente una grande importanza nella pratica della traduzione,
nella quale il traduttore deve tenere in debita considerazione i diversi aspetti
semantici, cioè le rispettive accezioni, dei significanti che egli ha a disposizione
nei due diversi codici linguistici. Ogni lingua, naturalmente, tende a sviluppare
maggiormente quella parte del suo patrimonio lessicale che più risulta utile per la

27
vita della comunità linguistica che utilizza quella lingua: così, ad esempio, gli
eschimesi hanno numerosi termini diversi per indicare ciò che in italiano si
riassume nella sola parola neve, a seconda che si tratti di neve ghiacciata, bagnata,
calpestabile con sicurezza oppure pericolosa e così via. Le uniche parole non del
tutto arbitrarie, nelle quali esiste cioè una parziale motivazione per il rapporto fra
significante e significato, sono le onomatopee (bau-bau, miao, miagolare ecc.),
che conservano qualche legame con il suono naturale che vogliono rappresentare;
un legame che, ovviamente, non può essere perfetto, ma che al contrario è pur
sempre di natura imitativa, cosicché nelle diverse lingue si ritrovano
approssimazioni onomatopeiche anche assai differenti fra di loro, come nel caso
dell‟italiano chicchirichì e dei suoi corrispettivi in inglese, cockadoodledoo, e in
francese, cocorico.
3. Il segno nella semiotica di Peirce
Si noti, tuttavia, che non tutto ciò che comunemente intendiamo come segno
rientra nella definizione saussuriana di segno linguistico. La disciplina che studia i
segni, e che ha stretti rapporti con la linguistica, è la semiotica. Un importante
filosofo e linguista americano dell‟inizio del XX secolo, Charles Sanders Peirce
(1839-1914), considerato il fondatore della semiotica moderna, ha proposto una
classificazione dei vari tipi di segni utilizzati nei processi di comunicazione28
.
Peirce elabora uno schema diverso rispetto a quello di Saussure, che consiste in
una triade (composta da segno, oggetto e interpretante), detta anche triangolo
semiotico, il cui scopo è soprattutto quello di chiarire come vengano composti i
segni nel cervello dell‟emittente e, parallelamente, come essi siano scomposti dal
ricevente (Fig. 2). Un segno, ad esempio una parola, non rimanda direttamente
all‟oggetto designato, ma passa attraverso lo stadio di interpretante nella mente 28
Cfr. Peirce [1931-1948]. Saussure e Peirce elaborarono le rispettive teorie negli stessi anni,
quasi certamente l‟uno all‟insaputa dell‟altro; cfr. anche Osimo [2004, 11-12]. Mentre l‟approccio
scientifico di Peirce prende il nome di semiotica, alle teorie di Saussure sul segno linguistico si è
soliti dare il nome di semiologia.

28
dell‟emittente. Il pensiero interpretante è diverso per ogni individuo, dipendendo
dalle esperienze del singolo soggetto.
Fig. 2. Il triangolo semiotico di Peirce
Come è evidente, nello schema di Peirce il segno non ha il valore bipolare che
ha invece in Saussure, dove esso è composto dalle due facce denominate
significante e significato, ma corrisponde grosso modo al solo significante
saussuriano; allo stesso modo, l‟interpretante può essere sovrapposto al
significato. Alla triade di Peirce può essere anche sostituita la terminologia
proposta in seguito da Ogden e Richards [1949]: simbolo, pensiero (o riferimento)
e infine referente, la cui corrispondenza con i termini introdotti da Peirce e con
quelli di matrice saussuriana è sintetizzata nella tabella che segue (Tab. 3).
Saussure
segno linguistico
significante significato
Peirce segno interpretante oggetto
Ogden
e Richards simbolo
riferimento (o pensiero)
referente
Tab. 3. Saussure, Peirce, Odgen-Richards
Secondo Peirce, inoltre, si possono distinguere almeno cinque diversi tipi di
segni: indici, segnali, icone, simboli e infine segni propriamente detti; tale
distinzione avviene mediante l‟applicazione dei due criteri della volontarietà e
della motivazione. Così, gli indici sono segni assolutamente non volontari e dotati
di una motivazione puramente fisica, come ad esempio il fumo che si alza da un
interpretante
segno oggetto

29
incendio in una foresta, che ha per significato “qui c‟è un incendio in corso”. I
segnali si distinguono invece dai precedenti perché, pur essendo anch‟essi
motivati fisicamente, sono tuttavia del tutto volontari: riprendendo lo stesso
esempio, si possono citare i segnali di fumo prodotti deliberatamente da un
pellerossa Sioux, che hanno lo scopo di inviare specifici messaggi come ad es.
“c‟è un intruso nel territorio” ecc. Le icone sono segni volontari che hanno però
una motivazione analogica; la loro forma esteriore, infatti, richiama per analogia
l‟oggetto che vogliono significare: così ad es. un cartello con il disegno stilizzato
di una foresta da cui si alza un denso fumo sta a significare “pericolo di incendi”. I
simboli sono invece segni volontari con una motivazione esclusivamente
culturale; una certa cultura, cioè, attribuisce convenzionalmente un dato valore a
quel simbolo, senza un motivo apparente: è il caso, ad es., dei cartelli stradali di
divieto di accesso, formati da un cerchio bianco con un bordo rosso. Infine, i segni
propriamente detti sono anch‟essi volontari, ma non hanno nessuna motivazione:
sono, questi, i segni utilizzati dal linguaggio umano, i quali, come si è già visto,
associano arbitrariamente un significante a un significato. Sono questi segni a
rendere possibile l‟intero processo della comunicazione verbale.
4. Comunicazione e funzioni testuali secondo Jakobson
Come si è notato analizzando il pensiero di Saussure, il linguaggio verbale
umano possiede alcune caratteristiche proprie, che lo distinguono sia dal
linguaggio degli altri animali sia da tutti gli altri linguaggi utilizzati dagli uomini,
come possono essere il linguaggio dei segni, dei colori, dei simboli, delle
immagini, dei profumi e via dicendo; tali caratteristiche sono ugualmente valide
per tutte le lingue del mondo, cosicché è impossibile affermare o provare
scientificamente che una lingua è “migliore”, “peggiore” oppure “più (o meno)
complessa” di un‟altra lingua, al di là di giudizi puramente estetici e soggettivi.
Secondo la teoria della comunicazione elaborata dallo stesso Jakobson [1959],
perché esista un atto linguistico è necessaria la presenza di tutti i sei elementi della

30
comunicazione: l‟emittente, il ricevente, il messaggio, il canale, il codice e il
contesto (Fig. 3)29
. L‟emittente è colui che codifica e produce un messaggio,
tipicamente in forma verbale o in forma scritta, mentre il ricevente è colui che lo
riceve e lo decodifica.
Fig. 3. La comunicazione per Jakobson
Il canale rappresenta lo spazio fisico attraverso il quale il messaggio si propaga
(dunque l‟atmosfera che ci circonda per un messaggio verbale, un supporto
cartaceo o elettronico per un messaggio scritto e così via); perché la
comunicazione abbia successo è necessario che il canale sia il più possibile
aperto, cioè che esso subisca il minor disturbo possibile: un foglio macchiato o
una stanza con una forte rumore di fondo rappresenteranno perciò un canale
disturbato e potranno rendere il messaggio in parte o in tutto non comprensibile.
Le porzioni di messaggio eventualmente più o meno disturbate possono in ogni
caso essere reintegrate grazie alla conoscenza, da parte del ricevente, del contesto
della comunicazione, cioè dalla conoscenza condivisa di una serie complessa di
informazioni quali il luogo della comunicazione, il suo scopo, i ruoli dei
partecipanti, le convenzioni sociali, il momento, le persone presenti e via dicendo.
Così, ad esempio, nel corso di una conversazione che si svolge a tavola durante un
pasto sarà molto facile integrare una frase disturbata del tipo per favore passami
la ((…))nestra: è evidente che l‟oggetto desiderato in questo caso è la minestra,
poiché proprio il contesto ci aiuta a escludere altri termini foneticamente simili,
come la finestra o la balestra. Non solo, ma la conoscenza del contesto permette
29
Nella formulazione della sua teoria Jakobson si rifà in parte allo schema della comunicazione
già proposto da Shannon e Weaver [1949].
messaggio emittente ricevente
canale codice contesto

31
anche di reperire i corretti referenti di una frase come, ad esempio, ci vediamo alle
sei al solito posto, nella quale altrimenti né il luogo né l‟orario (sei del mattino
oppure del pomeriggio) sarebbero identificabili da parte del ricevente. Nel caso di
una traduzione di un testo composto molti anni prima, ovviamente, la distanza
temporale creerà non pochi problemi per la ricostruzione del contesto, così come
avverrebbe del resto nel caso della traduzione di un testo contemporaneo ma
composto in un ambiente culturale completamente diverso e in buona parte ignoto
al traduttore. Nel caso di un testo letterario esiste poi un tipo particolare di
contesto, costituito da tutto ciò che in quel testo precede o segue il brano
selezionato per la traduzione: in questo caso si può parlare più specificamente di
cotesto. Di contesto e di cotesto si tornerà a discutere dettagliatamente più avanti
(Cap. III), data la loro importanza nel processo traduttivo. Il presupposto
fondamentale per la riuscita dell‟atto comunicativo è, comunque, che l‟emittente e
il ricevente conoscano e utilizzino il medesimo codice linguistico; ad esempio,
che entrambi stiano utilizzando la lingua italiana o la lingua araba, ma non uno
l‟italiano e l‟altro l‟arabo, o al limite che essi utilizzino due codici diversi a patto
che essi siano conosciuti da entrambi gli interlocutori30
.
Un testo (orale o scritto che esso sia) può di volta in volta privilegiare e mettere
al centro dell‟attenzione uno solo dei sei elementi della comunicazione appena
descritti, pur senza eliminare i restanti cinque; così, Jakobson individua sei diversi
tipi di testo con sei diverse funzioni testuali: si avrà in tal senso una funzione
emotiva, se il testo ha come fulcro di interesse l‟emittente e dunque l‟espressione
del suo stato d‟animo e delle sue sensazioni; una funzione conativa, quando
l‟emittente cerca di influenzare il ricevente, sul quale è incentrato l‟interesse, ad
esempio spingendolo a compiere una determinata azione; una funzione poetica, se
30
Quest‟ultimo è il caso, ad esempio, di una conversazione in un ambiente bilingue o plurilingue
in genere, in cui i due parlanti potranno indifferentemente utilizzare uno o l‟altro codice oppure
inserirli entrambi nei medesimi enunciati, con fenomeni studiati dalla sociolinguistica che vanno
sotto il nome di code-mixing e code-switching. Su questi aspetti cfr. Weinreich [1953]; Auer
[1984]; Romaine [1989]; Berruto [1995].

32
la complessità semantica e strutturale del messaggio obbliga il ricevente a tornare
più volte sul messaggio stesso allo scopo di decodificarlo, come può avvenire in
un brano poetico o anche in un testo pubblicitario; una funzione fàtica, nel caso in
cui ci si preoccupi che il canale di comunicazione sia ben aperto, come quando
nelle conversazioni telefoniche si esordisce dicendo pronto; ancora, una funzione
metalinguistica, se il testo ha come oggetto il codice stesso, cioè la lingua, come
può accadere in un libro di grammatica o in una trattazione di linguistica; infine,
una funzione referenziale, quando il testo ha come scopo la semplice illustrazione
di un aspetto del contesto della comunicazione, come avviene nel caso di un
annuncio all‟altoparlante di una stazione ferroviaria o delle istruzioni per l‟uso di
un elettrodomestico.
Come si può facilmente sperimentare nella comunicazione di ogni giorno, nel
caso che il canale sia in qualche modo disturbato, oltre a sfruttare il più possibile
le informazioni fornite dal contesto, è probabile che all‟emittente sia richiesto,
anche esplicitamente, di produrre un messaggio particolarmente ben articolato
(iperarticolato), rallentando la velocità di fonazione, aumentando il volume della
voce e ponendo attenzione all‟esatta articolazione di ogni fono31
. In ogni atto di
comunicazione il contesto (più o meno ricco) e l‟articolazione del messaggio
(iperarticolato o, al contrario, ipoarticolato) entrano contemporaneamente in
gioco: così, ad esempio, se il messaggio è ipoarticolato e il contesto è povero,
molto probabilmente il ricevente non sarà in grado di decodificare il messaggio
stesso a causa della carenza di informazioni disponibili. Come si è già notato,
ovviamente nel processo traduttivo il ruolo del contesto è fondamentale.
Nello schema dei sei elementi della comunicazione proposto da Jakobson
ovviamente non si fa riferimento alla sola lingua scritta né tanto meno alla sola
lingua parlata, ma nel caso di un testo scritto c‟è un ulteriore fattore di cui bisogna
tener conto, anche nel caso di una traduzione: il destinatario di un testo scritto non
31
Si indica qui con il termine fono un suono prodotto dall‟apparato fonatorio umano per scopi
comunicativi verbali. I foni si trascrivono convenzionalmente fra parentesi quadre, utilizzando
l‟alfabeto fonetico internazionale (IPA).

33
è presente, ma è immaginato dall‟emittente al momento della composizione del
testo stesso. Tale lettore può essere denominato lettore implicito [Iser 1972]
oppure lettore modello [Eco 1979] e può di volta in volta essere incarnato dal
lettore di un romanzo d‟avventura, da uno studente che consulta un manuale
universitario o anche da un familiare dell‟emittente che legge un bigliettino
lasciato sul tavolo della cucina. In ogni caso, è evidente che il traduttore dovrà
tenere in debita considerazione la figura del lettore modello (o implicito) nelle sue
scelte traduttive.
5. Prototesto, metatesto, paratesto, intertesto e ipertesto
La tradizione degli studi di teoria della traduzione definisce spesso l‟atto
linguistico che viene tradotto, cioè il messaggio originario di cui si è trattato sin
qui, come prototesto, ovvero come testo di partenza, mentre indica l‟atto
linguistico prodotto dal traduttore (il nuovo messaggio) con il termine metatesto,
oppure più semplicemente con l‟espressione a esso equivalente testo di arrivo. Il
composto prototesto è stato coniato utilizzando il prefissoide di origine greca
proto-, che fa riferimento a qualunque realtà che ne “preceda”, logicamente o
cronologicamente, un‟altra; da questo punto di vista un prototesto precede sia
logicamente sia cronologicamente il testo di arrivo, dato che non ci potrebbe
essere testo di arrivo senza un testo di partenza. Allo stesso modo, nella parola
metatesto compare il prefissoide di matrice greca meta-, che indica qualcosa che
“segue” e che “viene dopo” una realtà già presente; infatti, il metatesto segue
logicamente e cronologicamente il prototesto, senza il quale esso non
sussisterebbe32
.
Sul modello di prototesto e di metatesto è stato coniato anche il composto
paratesto, con un prefissoide, sempre di origine greca, che ha il significato di
32
Come fa giustamente notare Osimo [2004, XIII], le due espressioni testo di partenza e testo di
arrivo ricorrono “alla metafora topologica della traduzione come percorso geografico o
agonistico”; in tal senso, egli mostra di preferirvi nettamente gli equivalenti prototesto e metatesto.

34
“accanto, a lato”. Con paratesto si indica tutto il complesso testuale che il
traduttore ha introdotto di propria iniziativa e il cui contenuto non compariva nel
prototesto: tale materiale ha in genere una funzione esplicativa e di assistenza nei
confronti di chi fruisce della traduzione e fra i tipi testuali che appartengono a
questa categoria si annoverano le introduzioni, i commenti, le annotazioni di vario
tipo – nel caso di un testo scritto inserite nel corpo del testo stesso sotto forma di
note del traduttore racchiuse fra parentesi (n.d.T.) o anche a pie‟ di pagina – oltre
alle prefazioni, alle postfazioni e a qualunque altra indicazione di carattere
esplicativo e accessorio.
Alla medesima famiglia lessicale appartiene anche il neologismo intertesto,
coniato per indicare tutti i riferimenti che rimandano a un altro testo, diverso da
quello che si sta traducendo, quali allusioni implicite o esplicite, citazioni letterali
o parafrasi, rimandi e via dicendo. Come si vedrà più avanti, la conoscenza da
parte del traduttore dell‟intertesto e più in generale del contesto di riferimento
dell‟opera che egli sta traducendo è di fondamentale importanza per giungere a
un‟interpretazione che sia la più corretta possibile. Si noti, infine, che nel caso di
un testo in formato elettronico l‟intertesto può prendere la forma di ipertesto,
concretizzandosi nei collegamenti ipertestuali, comunemente chiamati con il
prestito inglese link, che hanno lo scopo di collegare direttamente e
immediatamente il testo stesso a un‟altra pagina web, rendendo ben evidente il
ruolo dell‟intertesto – e dell‟ipertesto – nella comprensione e nell‟interpretazione
di un testo da tradurre.
6. Tipologia testuale
Come si è già visto a proposito della teoria della comunicazione formulata da
Jakobson, non tutti i testi rivestono la medesima funzione e dunque, in tal senso,
non tutti i testi sono uguali. Una fondamentale distinzione è anzi tutto quella che
oppone da una parte quei testi che abbiano un valore principalmente denotativo, il
cui messaggio è perciò direttamente e immediatamente percepito dal ricevente

35
senza rischi di ambiguità, e dall‟altra i testi con un carattere maggiormente
connotativo, la cui interpretazione non è immediatamente percepibile come
univoca e chiara e dunque dipende in buona parte dalle scelte interpretative del
ricevente. Come è evidente nell‟esperienza quotidiana di ciascuno di noi, un testo
come le istruzioni per il montaggio di un frigorifero ha un valore soprattutto
denotativo, dato che non si presta, né si deve prestare, a interpretazioni di
qualsiasi tipo, ma al contrario deve dare luogo a una sola e unica interpretazione
che porti all‟ottenimento dello scopo prefissato, cioè il corretto montaggio
dell‟elettrodomestico in questione. Un testo poetico, al contrario, avrà un valore
principalmente connotativo, portando con sé una molteplicità di significati
sottintesi e impliciti, anche a livello simbolico, che il lettore potrà interpretare con
una notevole libertà.
Per quanto riguarda più da vicino la teoria della traduzione, l‟opposizione fra
testi denotativi e connotativi è stata ripresa in particolare da Eco [1979] che ha
parlato in tal senso di testo chiuso, non letterario e non destinato a una
molteplicità di interpretazioni (come appunto si è notato nel caso delle istruzioni
per il frigorifero), e di testo aperto, di fronte al quale il lettore non svolge un ruolo
semplicemente passivo, ma al contrario formula delle ipotesi interpretative che
verifica e corregge nel corso della lettura del testo stesso. Questo processo di
formulazione e verifica di ipotesi da parte del lettore prende il nome di circolo
ermeneutico, come si vedrà più in dettaglio nel prossimo paragrafo33
.
Prima di ciò, è utile tuttavia citare una delle tante classificazione dei tipi testuali
che può avere una certa importanza nei processi traduttivi: si tratta, ovviamente, di
testi di tipo connotativo ovvero, nella terminologia di Eco, di testi aperti. Lo
slovacco František Miko [1978], in particolare, elenca i seguenti stili testuali34
:
stile letterario (esprime esperienze con un alto livello espressivo), colloquiale
(stile comune, di norma orale, fortemente operativo e relazionale), scientifico
(caratterizzato da formalismo e procedimenti deduttivi), burocratico (tipico degli
33
Cfr. Osimo [2004: 21-24].
34 Cit. in Osimo [2004: 27-28].

36
ambienti amministrativi, con una frequente applicazione di formule stereotipate),
giornalistico (stile basato sull‟espressione formalmente accurata di dati, con una
notevole operatività), retorico (con un forte valore soggettivo e relazionale e
l‟applicazione di tecniche retorico-pragmatiche), saggistico (stile che utilizza gli
artifici dello stile letterario per comunicare concetti di carattere scientifico),
divulgativo (tipico della didattica culturale e scientifica, con l‟uso di aneddoti e di
altri artifici estetici e pragmatico-retorici), religioso (stile formale, vicino a quello
letterario, ma con un‟evidente funzione conativa nei termini di Jakobson), storico
(stile caratteristico di un determinato momento storico) e infine stile personale (un
autore riflette sul suo punto di vista sulla realtà). In particolare, tutti gli stili
elencati vengono definiti stili funzionali, in quanto caratteristici dei testi
all‟interno dei singoli ambiti di comunicazione; inoltre i primi quattro stili
vengono detti da Miko primari, mentre gli altri sono secondari.
Tutto ciò che si è detto sin qui al riguardo del processo traduttivo vale,
ovviamente, sia che si sia davanti a una traduzione interlinguistica – dunque a una
traduzione propriamente detta – sia che ci si riferisca a una traduzione
intralinguisica (o riformulazione). In quest‟ultimo caso, in particolare, la
riscrittura di un testo, o in termini scolastici la sua parafrasi, può anche
prescindere dalla presenza fisica di un prototesto, il quale può semplicemente
essere noto al traduttore in termini di conoscenza contestuale anche vaga. È il
caso, ad esempio, delle favole, che le mamme ripetono ogni sera ai propri bimbi
aggiungendo di volta in volta particolari, togliendone altri e dunque operando
un‟incessante parafrasi. Un utile esercizio, in tal senso, può essere quello di
riscrivere una favola nota al proprio contesto culturale di riferimento, ad esempio
quella di Cappuccetto rosso, utilizzando alcuni degli stili testuali individuati da
Miko, di cui si è appena detto. Questo può essere il risultato:
TESTO 1. Cappuccetto rosso in stile burocratico
RAPPORTO GIUDIZIARIO CIRCA IL CASO CAPPUCCETTO ROSSO
In data 2 Aprile del c.a., tale Cappuccetto Rosso, così soprannominata per il mantellino
di cotone rosso veneziano regalo della di lei nonna, dovette recarsi proprio dalla

37
suddetta. La madre di tale Cappuccetto Rosso chiese alla figlia di portare alla nonna: n°
1 pezzo di focaccia; n° 1 bottiglia di vino. Trovandosi la casa della suddetta nonna
all‟interno della zona boschiva, tale Cappuccetto Rosso ebbe ad attraversarla. Testimoni
riferiscono di averla vista interloquire con un lupo dall‟aspetto emaciato. Dopo essersi
fermata a raccogliere fiori di varia specie, giungendo a casa della nonna, la suddetta
C.R. le rivolse una serie di domande, tra le quali chiese la ragione per cui essa avesse
una bocca più grande del solito. In tutta risposta quella che allora tale Cappuccetto
Rosso pensava essere la nonna, la ingoiò in un unico boccone. Il teste, cacciatore di
professione, riferisce di aver sentito un pesante russare proveniente dalla casa della
nonna. Entratovi, dichiara di aver riconosciuto il lupo. Come riferisce, “assalito dal
dubbio che il lupo si fosse mangiato nonna e nipote”, decise di utilizzare un paio di
forbici per aprirne il ventre. Dopo averne estratto le due suddette, tale cacciatore decise
di riempire il ventre di tale lupo con un numero indefinito di pietre. I tre decisero di
allontanarsi e sporgere denuncia. Il cadavere del lupo è stato ritrovato in data 8 Aprile
c.a. da due pescatori sulle rive del fiume Taro. Il maresciallo capo comandante35
.
Lo stesso prototesto contestuale può essere riformulato in stile religioso, ad
esempio in questo modo:
TESTO 2. Cappuccetto rosso in stile religioso
DALLE LETTERE DEI FRATELLI GRIMM
E fu così che, in un giorno benedetto dal Signore, la fanciulla timorata di Dio dovette
recarsi dalla pia nonna malata, la cui dimora stava al di là dell‟oscuro bosco dimenticato
da Dio, perché la sua amorevole compagnia potesse alleviare tutto il male dell‟anziana.
In guardia era stata messa dalla madre, ma in verità vi dico, che a nulla valsero le
copiose avvertenze della devota genitrice, perché non tardò il tentatore ad arrivare. Il
mostruoso lupo dalle diaboliche intenzioni, vista l‟innocente, approfittò della tanto cara
ingenuità dei fanciulli affinché Cappuccetto Rosso rivelasse il luogo in cui dimorava la
povera nonna malata. Fu così che il peccato, incarnatosi nel bavoso lupo, coinvolse
colei che era così pura in una sfida: chi sarebbe arrivato primo dalla nonna? Saltellando,
l‟innocente spensierata, la umile dimora della nonna raggiunse. Ma qualcosa di
oscuramente diabolico era giunto prima di lei. “Oh nonna, così grandi sono gli occhi
tuoi”, pronunciò la graziosa giovane. “Fu il Signore a donarmeli per meglio ammirare la
Sua creazione”, rispose la belva camuffata. “Oh nonna, così grandi son le orecchie tue”,
esclamò la beata fanciulla. “Fu il Signore a donarmele per meglio udire le Sue creature”,
35
Testo originale di Federica Sirelli.

38
replicò la bestia malefica. “Oh nonna, così grande è la bocca tua”, disse la pia ragazza.
“Fu il Signore a donarmela per meglio divorare i figli Suoi”, bestemmiò l‟infernale
abominio chiudendo le fauci attorno all‟innocente. Volle il Signore che di lì passasse un
buon uomo che di mestiere faceva il cacciatore; udite le grida dell‟angelica fanciulla,
irruppe nella umile casa, affrontò l‟indomita belva figlia del peccato e il ventre suo
squarciò. Fu così, che l‟anziana nonna e la giovane Cappuccetto Rosso rividero
finalmente la luce della bontà divina, che ancora una volta sul male aveva trionfato36
.
La lettura di questi testi dimostra, di fatto, come la parafrasi (o traduzione
intratestuale) e la traduzione vera e propria (intertestuale) siano in realtà le due
facce di una medesima realtà: semplicemente, nel caso della parafrasi il nuovo
messaggio viene creato in una diversa varietà linguistica rispetto a quella del
prototesto, mentre nella traduzione interlinguistica avviene il passaggio a un
codice diverso, cioè a un‟altra lingua.
7. Il circolo ermeneutico
Come si è detto nel precedente paragrafo, il ruolo del lettore nel caso di un testo
aperto è particolarmente attivo: in questi tipi di testo è il lettore stesso, infatti, a
formulare continuamente ipotesi interpretative circa il significato globale del
messaggio che si trova ad analizzare, creando quello che si è chiamato circolo
ermeneutico. L‟autore reale del testo, definibile come autore empirico (l‟autore
cioè in carne e ossa) riveste nella coscienza del lettore il ruolo di autore modello,
come si è già visto, nel senso che esso non può essere personalmente conosciuto
dal lettore se non attraverso le sue opere letterarie, sicché il lettore stesso si crea
un‟immagine virtuale dell‟autore. Il testo prodotto dall‟autore modello viene
finalmente sottoposto all‟attenzione del lettore: anche tale lettore, però, agli occhi
dell‟autore diviene un lettore modello, in quanto l‟autore non può conoscere tutti i
suoi lettori e nel momento in cui scrive la sua opera ne considera la destinazione
in termini, appunto, di lettori modello (ovvero di lettori ideali); così, ad esempio,
un autore di romanzi gialli immaginerà come lettore modello un appassionato di
36
Testo originale di Alice Orciani.

39
romanzi gialli e il testo prodotto avrà di conseguenza caratteristiche tali da essere
teoricamente apprezzato da tale tipologia di lettore.
A questo punto il lettore empirico, cioè il singolo lettore reale del testo, formula
una prima ipotesi interpretativa sul senso del testo che sta leggendo: ad esempio,
nel caso di un giallo, egli proverà a immaginare chi possa essere l‟omicida,
basandosi sugli indizi che si sono presentati sino a quel punto. Il lettore ritorna
quindi sul testo, ne legge un‟altra porzione, e a questo punto può confermare la
sua ipotesi interpretativa oppure stravolgerla e formularne un‟altra completamente
nuova. Tale processo si può ripetere più volte, sino alla formulazione di un‟ipotesi
finale da parte del lettore. Lo schema del circolo ermeneutico, volendo
semplificare in parte la questione, si potrebbe riassumere come segue:
Fig. 4. Il circolo ermeneutico
Nel caso di un testo che venga tradotto, tuttavia, c‟è un ulteriore elemento che
complica lo schema del circolo ermeneutico: in questo caso, infatti, il traduttore è
anzi tutto un lettore, ma allo stesso tempo un autore, e ciò dimostra senza dubbio
la grande importanza, e insieme la criticità, del ruolo del traduttore stesso dal
punto di vista del significato e dell‟interpretazione complessiva del testo.
autore empirico
autore modello
lettore modello
lettore empirico
ipotesi interpret.
testo
conferma smentita

40
8. Per una definizione di traduzione
La concezione strutturalista della traduzione è ben riassunta dalla sintesi
proposta da Folena, per il quale “la traduzione è una forma fondata sulla bipolarità
e sull‟arbitrarietà del segno linguistico, sulla tensione fra i due costituenti, nel
senso che solo il significato è trasmissibile in lingue diverse o, in parte, in altri
codici semiotici, mediante nuovi significanti, in base al principio della non
equivalenza delle singole unità costitutive e della equivalenza complessiva dei
messaggi nei codici diversi” [Folena 1973; 1991; Soletti 1994, 733]. Tale
posizione è largamente accettata e si concilia particolarmente bene, del resto, con
le definizioni di traduzione che vengono comunemente date anche al di fuori
dell‟ambito specialistico degli studi traduttologici; così, ad esempio, viene definita
la traduzione in ambito anglofono:
Translation is the communication of the meaning of a source-language text by
means of an equivalent target-language text [Mac Arthur 1992, s.v. Translation].
Le definizioni correnti del processo di traduzione, tuttavia, in genere non
considerano un fatto abbastanza importante: il fatto, cioè, che nel momento in cui
compie una traduzione il soggetto parlante non si limita a riformulare un testo che
ha letto, o udito, in un‟altra lingua, ma al contrario egli produce un messaggio del
tutto nuovo, sebbene tale messaggio abbia come fondamentale caratteristica una
somiglianza sul piano semantico con il testo originario. In questo senso, può
essere utile richiamare un passo del fondamentale saggio di Jakobson sulla
traduzione, che a questo proposito si esprime in termini straordinariamente chiari:
Traducendo da una lingua in un‟altra, per lo più si sostituiscono in una lingua dei
messaggi non ad unità distinte, ma a interi messaggi dell‟altra lingua. Questa
traduzione è una forma di discorso indiretto; il traduttore ricodifica e ritrasmette
un messaggio ricevuto da un‟altra fonte. Così la traduzione implica due messaggi
equivalenti in due codici diversi. L‟equivalenza nella differenza è il problema
centrale del linguaggio e l‟oggetto fondamentale della linguistica37
.
37
Jakobson [1959], trad. it. in Id. [1966: 58].

41
Non solo, ma si deve forse tenere in debita considerazione anche il fatto che tali
testi rappresentano, a tutti gli effetti, degli atti linguistici e che, come tali, hanno
caratteristiche di unicità e di irripetibilità. Se si vuole proporre una definizione di
traduzione che ne prenda in considerazione soprattutto gli aspetti linguistici, si
potrebbe dunque pensare a una formula come la seguente:
La traduzione può essere definita come un complesso processo di natura
linguistica mediante il quale un soggetto parlante interpreta un atto linguistico
prodotto in una certa lingua o in una certa varietà di lingua e produce così un
nuovo atto linguistico, in una lingua o in una varietà diversa dalla prima, il
quale intrattiene un rapporto di somiglianza a livello semantico con l‟atto
linguistico originario.
In questo senso, definire la traduzione come un processo di natura linguistica
significa anzi tutto affermare implicitamente che essa debba partecipare di quelle
caratteristiche che sono tipiche dei processi linguistici e pragmatici in particolare:
fra queste, il fatto che essa venga operata da un singolo soggetto parlante che nel
processo traduttivo rappresenta prima il ricevente di un messaggio, realizzato
attraverso un atto linguistico irripetibile, e poi l‟emittente di un secondo
messaggio. La traduzione, dunque, non è uno spostamento di uno stesso
messaggio da un codice all‟altro, come farebbero pensare le metafore sottintese ai
termini testo di partenza e testo di arrivo, ma piuttosto una formulazione
completamente nuova.
Anche nei termini della teoria della comunicazione di Jakobson, è evidente che
il messaggio originario non può più essere riprodotto in maniera fedele e identica,
dato che nel momento in cui il ricevente diventa a sua volta emittente si deve
necessariamente formulare un messaggio completamente nuovo: ciò non
impedisce, ovviamente, che tale secondo messaggio intrattenga con il messaggio
originario un rapporto di somiglianza, a livello semantico, più o meno stretto. Il
codice con il quale sarà formulato il nuovo messaggio sarà ugualmente nuovo, sia
che esso rappresenti una lingua diversa dalla prima sia che esso costituisca
semplicemente una differente varietà di quella lingua, come si è detto nel caso

42
della parafrasi. Allo stesso modo, nel passaggio dal messaggio originario al nuovo
messaggio, muterà anche il contesto di riferimento e di ciò dovrà tenere
debitamente conto il traduttore. Il canale, infine, potrà mutare oppure rimanere
invariato, ma in ogni caso il soggetto traducente dovrà considerare anche
quest‟ultimo aspetto.
Un ultimo aspetto da tenere in considerazione è la distinzione fra traduzione
scritta e interpretazione orale: anche in questo caso i due fenomeni non sono altro
che le due diverse realizzazioni di un medesimo meccanismo mentale. Come è
ovvio, alcune differenze permangono: nel caso dell‟interpretazione in tempo reale
infatti l‟arco di tempo in cui il prototesto non esiste più e il metatesto non esiste
ancora è brevissimo, anche meno di un secondo, e il lessico mentale è di norma
l‟unica risorsa a cui può attingere l‟interprete; inoltre, sempre nell‟interpretazione
orale non è possibile compiere un altro gesto fondamentale per il traduttore, cioè
ritornare al testo di partenza e rileggerlo per controllare la propria traduzione con
un atto, nei termini di Jakobson, metalinguistico.
9. Nella mente del traduttore
Riprendendo i presupposti teorici forniti da Saussure e da Jakobson, oltre che
dalla psico-linguistica, può essere utile a questo punto cercare di chiarire, da un
punto di vista strettamente linguistico, che cosa avvenga nella mente del traduttore
nel momento in cui egli svolge la propria attività; nel prossimo capitolo ci si
preoccuperà di illustrare, invece, quali saranno i presupposti cognitivi e culturali
di questa stessa attività38
. Anzi tutto, il traduttore deve decodificare in testo di
partenza, che si è qui chiamato prototesto: tale testo si presenta come una
successione di segni linguistici; tale decodifica avviene contestualmente a
un‟eliminazione del rumore di fondo, cioè dei disturbi presenti nel canale, durante
38
Su questi aspetti del processo traduttivo cfr. in particolare Delisle [1988], Vygotskij [1990],
Osimo [2004: 44-54].

43
la quale la mente del traduttore riconduce automaticamente, grazie alla propria
competenza linguistica, gli errori alla forma corretta soggiacente.
A differenza di quanto può avvenire per un comune ricevente, come si è già
notato, nel caso del traduttore è già presente sin dall‟inizio della decodifica del
messaggio una ben precisa attività di tipo metalinguistico, dato che durante la
ricezione stessa il traduttore riflette sul prototesto e anche sul metatesto che andrà
a produrre di lì a poco; in altri termini, egli riflette sulle parole, cioè sui
significanti, prima ancora che sui significati da essi veicolati: “La parola può
essere sostituita dalla sua rappresentazione o dalla sua immagine mnestica, come
qualsiasi altro oggetto” [Vygotskij 1990: 344]. Come si vedrà nel prossimo
capitolo, il traduttore deve in particolare scegliere di volta in volta quale
significato assegnare a un determinato significante presente nel prototesto,
facendo riferimento al contesto generale e al cotesto testuale che ha di fronte.
Questo processo è essenzialmente linguistico e, poiché si svolge senza emissione
di messaggi verbali, consiste in quello che Vygotskij chiama linguaggio interno,
anche noto come endofasia, cioè quello stesso procedimento mentale che sta alla
base del pensiero verbale, cioè dei pensieri e dei ragionamenti che svolgiamo
utilizzando segni linguistici, parole, che ovviamente però non pronunciamo39
.
Dal punto di vista cognitivo, la mente del traduttore, e di qualunque lettore o
ascoltatore, “elabora il testo in modo sintattico, semantico e pragmatico e [ne]
controlla la coerenza interna e quella esterna con la realtà” [Osimo 2004: 50]; tale
controllo avviene sia dal basso, cioè a partire dalle singole parole del testo (analisi
bottom-up) sia dall‟alto, cioè mediante la considerazione del testo nel suo
complesso e del contesto che idealmente lo circonda (analisi top-down) [Bell
39
Cfr. Vygotskij [1990]. Si noti che oltre al pensiero mentale, basato sull‟endofasia, esiste anche
quello che gli psicologi definiscono pensiero operativo, il quale non si basa sulla successione di
segni linguistici, cioè di parole, ma prevede azioni immediate e non verbali, mute, con il vantaggio
della velocità e dell‟immediatezza: ad esempio, se guidando un‟automobile notiamo un pedone che
attraversa improvvisamente la strada davanti a noi, quello che ci permette di frenare in una
frazione di secondo è il pensiero operativo, non certo il pensiero verbale.

44
1998: 187]. In ogni caso la ricezione del testo è sempre molto soggettiva e, come
afferma Segre a proposito dei testi scritti, “non c‟è lettura che possa emarginare la
libertà dell‟immaginazione” [1985: 10-11]. Nel caso della lettura di un testo
scritto, in particolare, si alternano due stati mentali: “un flusso subliminale di
lettura veloce, nel quale il controllo consapevole è quasi soppresso, e una modalità
di lettura analitica consapevole scatenata dal reperimento di forme insolite, testi
marcati, problemi particolari, configurazioni testuali non ancora esperite dalla
mente di chi legge” [Osimo 2004: 52]. Il primo tipo di lettura, ovviamente, è
molto più veloce, mentre il secondo è maggiormente analitico e preciso.
L‟intuizione del traduttore avviene, nella lettura così come nell‟ascolto,
principalmente grazie alla sua competenza linguistica e comunicativa nel codice
in cui il messaggio è trasmesso e, allo stesso tempo, mediante il riferimento alla
sua esperienza e conoscenza del contesto, che naturalmente si può acquisire
soltanto “sul campo”, cioè attraverso la lettura di testi e il contatto con la cultura
dell‟autore modello:
Un buon traduttore è una persona che non ha mai fatto abbastanza esperienza per
svolgere bene il proprio lavoro; un‟altra lingua, un‟altra laurea, un altro anno
all‟estero, altri cinquanta o sessanta libri e sarà pronta a cominciare a fare bene il
proprio lavoro. Ma quel giorno non viene mai; non perché il traduttore sia
incompetente o inesperto, non perché il lavoro del traduttore sia inferiore agli
standard, ma perché un bravo traduttore vuole sempre sapere di più, vuole sempre
avere fatto altre esperienze, non si sente mai del tutto soddisfatto del lavoro
appena finito. Le aspettative stanno eternamente uno o tre passi avanti alla realtà,
e tengono il traduttore eternamente inquieto alla ricerca di altre esperienze40
.
40
[Robinson 1997: 111-112]; trad. it. in Osimo [2004: 53].

45
III
TECNICA DELLA TRADUZIONE
1. Dominante, punctum e residuo
Già i primi traduttori erano ben consapevoli del fatto che la difficoltà di una
traduzione aumenta con la presenza di ambiguità nel testo di partenza, trovandosi
a tradurre, ad esempio, un‟espressione o un singolo termine polisemici nella
lingua di partenza, o incontrando un uso non letterale ma traslato del linguaggio in
parte estraneo alla lingua di arrivo. A partire dall‟antichità queste difficoltà
portarono a infinite discussioni sull‟opportunità di una traduzione libera oppure
letterale, come si è visto a proposito della traduzione della Bibbia di Girolamo,
delle critiche di Paolo ai traduttori e come avvenne pressoché senza sosta sino
all‟Ottocento e alla riflessione di Croce sulla traduzione letterale o fedele,
naturalizzante o estraniante (cfr. Cap. I).
Nel corso dell‟Ottocento, parallelamente alle teorizzazioni sulla classificazione
tipologica delle lingue del mondo iniziate da Humboldt e da altri, si cominciò a
pensare che la traduzione effettivamente fosse tanto più difficile quanto i due
codici linguistici erano distanti fra di loro da un punto di vista tipologico, sia che
tale distanza riguardasse la morfologia, sia che coinvolgesse la sintassi o altri
aspetti della lingua; così, ad esempio, tradurre dallo spagnolo all‟italiano – da una
lingua flessiva a un‟altra lingua flessiva – doveva essere infinitamente più
semplice che rendere una frase italiana in cinese, tipicamente una lingua isolante.
In realtà la difficoltà della traduzione aumenta con la distanza culturale, ancor
più che linguistica41
. Di questo fatto erano ben consci i teorici dell‟Ottocento, che
41
[Soletti 1994, 733].

46
come si è visto sottolineavano l‟impossibilità teorica di una traduzione autentica a
causa dell‟inesprimibile differenza fra lo spirito delle diverse nazioni, pur
recuperandone poi la liceità sulla base del carattere universale dell‟umanità. In
effetti, la competenza che il traduttore deve possedere nelle due lingue che sono
oggetto della traduzione non riguarda soltanto le forme della lingua in senso
stretto, quali fonetica, fonologia, morfologia, sintassi, semantica e lessico: tale
livello, infatti, costituisce soltanto una parte della competenza, che si può
chiamare competenza linguistica. L‟altro livello che deve essere adeguatamente
posseduto dal traduttore è quello della competenza comunicativa, che riguarda più
gli aspetti pragmatici e, appunto, comunicativi del linguaggio che non le sue
strutture; essa concerne, in altri termini, il concreto comportamento di un parlante
in quella lingua, più che le sue conoscenze linguistiche42
. Per fare un esempio
banale e un po‟ assurdo, un traduttore di lingua materna italiana che non avesse
alcuna competenza comunicativa in inglese potrebbe tradurre, sulla base della sua
pur perfetta competenza linguistica inglese, la domanda espressa in italiano quanti
anni hai con un‟improbabile espressione inglese *how many years have you got,
al posto del consueto how old are you.
Come si è visto, per più volte nel corso della storia si è riproposto il dilemma se
preferire una traduzione fedele all‟originale, con il rischio di ottenere un testo
oscuro per il lettore, oppure una traduzione più libera, con il rischio opposto di
travisare in parte o in tutto il senso del testo che si traduceva. Nel Cap. I si è già
trattato, a questo proposito, della posizione di Cicerone, di Girolamo, di Paolo e di
Agostino, e delle discussioni sull‟opportunità di volgarizzare il testo della Bibbia
per renderlo fruibile ai fedeli. Si è visto poi come tali questioni riemergessero
nell‟Ottocento con il Romanticismo tedesco, Croce, e poi nel Novecento con
42
Il rapporto straordinariamente stretto che lega una determinata cultura al codice linguistico da
essa utilizzato, con interferenze che operano continuamente in una sorta di reciproco
rimodellamento, è stato messo in luce fra gli altri dal linguista Sapir [1921], a cui si attribuisce
insieme a Whorf [1956] la cosiddetta “ipotesi Sapir-Whorf” sull‟influsso della lingua sulla cultura
di un popolo; su questo cfr. anche Osimo [2004: 30].

47
l‟esegesi storico-critica e via dicendo. Si noterà come tutte queste discussioni, a
distanza di secoli, non siano riuscite a risolvere definitivamente il problema, anche
perché probabilmente si tratta in realtà di un falso problema, o comunque di un
problema mal posto. Certo è che nel corso della storia si siano succeduti stili
traduttivi diversissimi fra loro nella forma e nel metodo, dei quali forse vale la
pena proporre almeno un esempio.
Un caso celebre di traduzione libera è fornito dalla cosiddetta stele di Rosetta,
che di fatto è una parafrasi ancor più che una traduzione, ma di importanza
epocale; la stele infatti, una lastra di granito alta poco più di un metro, ritrovata
nelle sabbie egiziane, permise nel 1822 a Jean-François Champollion di trovare la
chiave per decifrare la scrittura geroglifica egiziana, sino ad allora completamente
oscura. Il testo dell‟iscrizione è infatti triplice: il testo egiziano in caratteri
geroglifici, lo stesso testo egiziano in caratteri demotici e infine la versione greca
che, pur non riportando una traduzione fedele dell‟originale, ne compie una
parafrasi riassuntiva, sufficiente però per far comprendere a Champollion il
contenuto e la natura del prototesto e quindi per permettergli di interpretarne la
scrittura e la lingua.
Si sono già citate in precedenza le cosiddette belle infedeli, cioè le traduzioni in
voga nella seconda metà del Seicento in Francia, decisamente attualizzanti e poco
fedeli all‟originale. Ma anche in Italia, del resto, tra XVIII e XIX secolo fiorirono
le traduzioni libere, abbellite e rese più appetibili ai lettori contemporanei:
emblematico è il caso di Vincenzo Monti (1754-1828), poeta e drammaturgo, noto
soprattutto per aver volgarizzato l‟Iliade di Omero fra il 1810 e il 1811, in una
versione assai fortunata che divenne un punto di riferimento per i secoli a seguire.
Monti, tuttavia, non conosceva il greco e si limitò a rielaborare traduzioni già
esistenti, suscitando in tal modo lo sdegno di Ugo Foscolo che lo definì senza
mezzi termini “gran traduttor dei traduttori d‟Omero”. Oggi una traduzione come
quella di Monti, affascinante e piacevole da leggere ma pur sempre difficilmente
considerabile “traduzione” nel senso stretto della parola, non sarebbe più
proponibile per gli standard traduttivi ormai comunemente richiesti ai traduttori.

48
Sempre riguardo alle traduzioni omeriche, si può leggere invece come esempio di
volgarizzazione letterale e rispettosa dell‟originale quella ad opera di Rosa
Calzecchi Onesti, pubblicata da Einaudi nel 1950, in cui la distanza dal testo di
Monti è evidentissima:
μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληφάδευ Ἀσιλῆορ
οὐλομένην, ἣ μςπί᾽ Ἀσαιοῖρ ἄλγε᾽ ἔθηκε,
πολλὰρ δ᾽ ἰθθίμοςρ τςσὰρ Ἄφδι πποΐατεν
ἡπώυν, αὐηοὺρ δὲ ἑλώπια ηεῦσε κύνεζζιν
οἰυνοῖζί ηε πᾶζι, Διὸρ δ᾽ ἐηελείεηο βοςλή,
ἐξ οὗ δὴ ηὰ ππῶηα διαζηήηην ἐπίζανηε
Ἀηπεΐδηρ ηε ἄναξ ἀνδπῶν καὶ δῖορ Ἀσιλλεύρ [Ilias I 1-7].
Cantami o Diva, del Pelide Achille / l‟ira funesta che infiniti addusse / lutti agli
Achei, molte anzi tempo all‟Orco / generose travolse alme d‟eroi, / e di cani e
d‟augelli orrido pasto / lor salme abbandonò (così di Giove / l‟alto consiglio
s‟adempìa), da quando / primamente disgiunse aspra contesa / il re de‟ prodi Atride
e il divo Achille [Iliade I 1-7, trad. V. Monti, 1810-1811].
Canta, o dea, l‟ira d‟Achille Pelide / rovinosa, che infiniti dolori inflisse agli Achei,
/ gettò in preda all‟Ade molte vite gagliarde / d‟eroi, ne fece il bottino dei cani, / di
tutti gli uccelli – consiglio di Zeus si compiva – / da quando prima si divisero
contendendo / l‟Atride signore d‟eroi e Achille glorioso [Iliade I 1-7, trad. R.
Calzecchi Onesti, 1950].
Come ulteriore esempio di bella infedele, si può leggere, fra le altre, la
traduzione inglese di Samuel Butler.
Sing, O goddess, the anger of Achilles son of Peleus, that brought countless ills
upon the Achaeans. Many a brave soul did it send hurrying down to Hades, and
many a hero did it yield a prey to dogs and vultures, for so were the counsels of
Jove fulfilled from the day on which the son of Atreus, king of men, and great
Achilles, first fell out with one another [Iliade I 1-7, trad. S. Butler, 1898].

49
Probabilmente non esiste un metodo traduttivo migliore in assoluto, ma un
metodo migliore in una certa situazione e con una determinata finalità. A tal
proposito, Torop [2000: 161] annota: “non esiste una traduzione assoluta o ideale,
ma […] sulla base di un unico originale si può creare tutta una serie di traduzioni
diverse ma, teoricamente, di pari valore”.
L‟impossibilità di ottenere l‟equivalenza assoluta a livello semantico fra i testi
in due codici linguistici differenti è stata ben espressa da Jakobson con le seguenti
parole:
Al livello della traduzione propriamente detta non c‟è, di solito, equivalenza
assoluta fra le unità codificate, per quanto dei messaggi possano servire come
interpretazioni adeguate delle unità e dei messaggi stranieri. La parola italiana
formaggio non può essere identificata esattamente col suo eteronimo russo
corrente, sýr, perché il formaggio bianco è bensì un formaggio, ma non un sýr
[Jakobson1959, trad. in Id. 1966: 58]43
.
Come è ovvio, Jakobson in questo caso sta facendo riferimento all‟equivalenza
semantica nel senso più stretto e non all‟equivalenza comunicativa, che è ben altra
cosa e che, mutatis mutandis, si mantiene pressoché intatta in una buona
traduzione. E proprio in questo consiste il lavoro del traduttore.
Dunque quello del rapporto fra traduzione libera e traduzione letterale è in
buona parte un falso problema, o comunque un problema reale ma posto in
maniera scorretta. Qualunque sia la posizione teorica che si vuole assumere, il
traduttore sa bene che non potrà mai produrre un metatesto che mantenga in sé
un‟immagine perfetta e semanticamente sovrapponibile, quasi trasparente, del
prototesto originario. Ad ogni passaggio traduttivo, infatti, una parte del
messaggio originario si perde, vuoi per il differente contesto, vuoi per il diverso
codice linguistico (a livello lessicale, ma anche morfologico, sintattico e via
43
Likewise, on the level of interlingual translation, there is ordinarily no full equivalence between
code- units, while messages may serve as adequate interpretations of alien code-units or
messages. The English word “cheese” cannot be completely identified with its standard Russian
heteronym “сыр”, because cottage cheese is a cheese but not a сыр.

50
dicendo), vuoi ancora per l‟inevitabile trasformazione della materia fonica
originariamente presente nel testo di partenza, che ad esempio può rendere
apparentemente intraducibile un testo poetico. Il traduttore è ben conscio di questo
fatto e il suo ruolo, la sua responsabilità, sta precisamente nella scelta di quali
elementi del prototesto si possono e si devono sacrificare per poter produrre un
messaggio accettabile nel nuovo codice linguistico. Molto chiare, a questo
proposito, sono alcune annotazioni di Osimo [2004: 37-38]:
Ogni versione, a seconda del modo in cui il traduttore decide di farsi carico di
ciò che non è possibile trasporre direttamente nella lingua o nella cultura
ricevente, del “residuo intraducibile”, mette in risalto alcuni aspetti e ne tace,
ahimè, altri. In altre parole, ogni versione differisce dalle altre soprattutto per il
contenuto (denotativo, ma soprattutto connotativo e stilistico) che il traduttore
ha deciso di sacrificare in nome della comunicabilità, della “trasportabilità” del
testo in questione.
L‟elemento del prototesto che deve essere a tutti i costi mantenuto e preservato è
quello che Jakobson chiamava la dominante, cioè “la componente focalizzante di
un‟opera d‟arte: [essa] governa, determina e trasforma le altre componenti. È la
dominante a garantire l‟integrità della struttura”44
. Come è ovvio, tale scelta non è
facile e dipende in buona parte dalla tipologia testuale a cui ci si trova davanti e
dalla funzione originaria del testo di partenza. Il discrimine fra una buona e una
cattiva traduzione risiederà allora nel difficile equilibrio fra gli elementi che si
sacrificano e quelli che si sceglie invece di mantenere; ovviamente, anche
l‟arbitrio interpretativo deve avere dei limiti, sebbene non sia sempre facile
definire con esattezza quali essi siano.
Il residuo di cui parla Jakobson trova curiosamente un corrispettivo per molti
aspetti assai simile in un elemento postulato da Roland Barthes (1915-1980),
anch‟egli non a caso un devoto strutturalista, e da lui posto alla base della sua
teoria dell‟immagine: nella ricostruzione di Barthes, finalizzata alla critica
artistica della fotografia, l‟elemento insostituibile che rende un‟immagine unica,
44
Jakobson [1935: 41].

51
inimitabile e significativa è il cosiddetto punctum, ciò che attira in modo
ineluttabile la nostra attenzione. Il punctum può essere un elemento di particolare
fascino, oppure più semplicemente qualcosa che non dovrebbe essere dove si
trova, come ad esempio la minigonna della ragazza che legge il giornale al
tavolino di un caffè di Parigi nel celebre scatto di Cartier Bresson; anche in questo
caso, se si elimina il puntcum si toglie ogni valore all‟immagine, così come
eliminando il residuo si ottiene una traduzione che non rispetta il valore del testo
di partenza.
Comunque sia, il processo traduttivo ovviamente non riuscirà mai a riprodurre
in maniera fedele il testo originale, cioè il prototesto, ed è ormai evidente come la
traduzione perfetta non esista né esisterà mai; potranno esistere, per contro, buone
approssimazioni. Non bisogna neppure essere troppo pessimisti, ma
semplicemente tener conto della limitatezza degli strumenti a disposizione del
traduttore, come fa giustamente notare Osimo [2004: 39-40], citando le teorie del
critico letterario Harold Bloom45
:
Seguendo la logica teorica di Harold Bloom, secondo cui in letteratura ogni
interpretazione è un‟interpretazione scorretta (misinterpretation), e ogni lettura è
una lettura scorretta (misreading), si può affermare che ogni traduzione è una
traduzione scorretta (mistranslation). Secondo Bloom, però, rigorosamente
freudiano, tale fenomeno di misreading è dovuto al desiderio inconscio di ogni
autore di eclissare i suoi precursori, i suoi “padri” letterari. Nel caso della
traduzione, invece, il fenomeno della mistranslation non è legato necessariamente a
un desiderio inconscio, quanto a un‟impotenza di cui siamo del tutto consapevoli; è
impossibile capire tutto ciò che un autore vuole trasmettere con il suo testo, ed è
impossibile trasporre tutto ciò che si è capito in altra lingua, lasciando al lettore le
stesse possibilità di comprensione / incomprensione e interpretazione presenti
nell‟originale. Si ha comunque un residuo. L‟importante è tenerne conto.
Il residuo di cui parla Bloom è, in termini traduttivi, quella porzione del
significato del prototesto che viene inevitabilmente persa ad ogni passaggio che
45
Cfr. Bloom [1974; 1975].

52
il messaggio compie per giungere dall‟emittente al ricevente: la codifica,
l‟emissione fisica dei foni, la loro trasmissione nel canale, la ricezione dei foni
e infine la decodifica del messaggio. Ad ogni passaggio successivo si può
avere una perdita di significato e, dunque, un residuo, come è riassunto
graficamente nello schema che segue (Fig. 5).
Fig. 5. Il residuo
Il residuo non è, tuttavia, qualcosa che sia perso per sempre; è infatti
possibile recuperare l‟intero residuo nel paratesto, cercando cioè di utilizzare
gli apparati a disposizione del traduttore, come note, commenti, introduzioni e
quant‟altro, proprio per supplire ai depauperamenti che il significato del
prototesto ha dovuto subire nelle varie fasi dell‟atto traduttivo.
2. Gli elementi contestuali
2.1. Contesto
Ogni testo, anche se di dimensioni ridotte, contiene una quantità sorprendente di
significati connotativi, che possono essere colti con una qualche approssimazione
dal traduttore soltanto se si considerano con attenzione tutti gli elementi a cui fa
riferimento il contesto generale dell‟opera, di cui si è già fatto cenno in
precedenza. Con il termine contesto si indica una tale varietà di oggetti,
conoscenze ed elementi che risulta veramente difficile darne una definizione
precisa: il contesto, infatti, comprende tutti quegli elementi culturali,
antropologici, naturali, fisici, umani che l‟autore ha mentalmente presenti e che
considera e utilizza, consciamente o inconsciamente, come sfondo della propria
R
codifica
R
emissione
R
trasmissione
R
ricezione
R
decodifica
EM. RIC.

53
opera. Possono fare parte del contesto conoscenze apparentemente banali, come il
fatto che a Parigi lungo la riva della Senna si trovino tradizionalmente le
bancherelle per la vendita dei libri usati e delle stampe antiche, oppure fatti assai
meno noti. Alcuni di tali fatti, in realtà, devono rimanere ignoti per il lettore, come
è particolarmente evidente nel caso di un romanzo giallo o di un testo poliziesco.
Come è ovvio, il passaggio dalla lingua del lettore modello originariamente
immaginata dall‟autore a un codice linguistico completamente differente, per di
più immerso in una cultura del tutto diversa, richiede uno sforzo da parte del
traduttore per adattare e rendere comprensibile il contesto originario al nuovo
lettore, cercando di preservarne allo stesso tempo l‟unicità e l‟originalità.
Come è naturale, concorrono a costituire il contesto anzi tutto il luogo e il tempo
in cui l‟opera è stata composta. Una buona parte delle informazioni contestuali di
cui il traduttore deve tenere conto è già implicitamente fornita, infatti, dalla
semplice conoscenza dell‟epoca storica in cui il prototesto è stato scritto e del
luogo in cui l‟autore è vissuto e ha operato. A parte casi del tutto particolari, è
perfettamente normale e prevedibile che autori i quali sono vissuti in uno stesso
contesto socio-culturale e in una stessa epoca, come può essere l‟Inghilterra
vittoriana, facciano riferimento a tale contesto in modi simili o comunque
paragonabili fra di loro. Per indicare il contenuto delle informazioni contestuali
relative all‟autore dell‟opera che ci si appresta a tradurre è stato coniato anche il
termine cronòtopo, che riassume in un solo composto i due elementi informativi
fondamentali: tempo e luogo.
Le informazioni a cui si può fare riferimento nel tentativo di ricostruire il
contesto della formazione di un testo, sia che si tratti di un‟opera moderna sia che
essa sia stata scritta molti secoli or sono, si possono utilmente riassumere nelle
cosiddette “cinque W” della pratica giornalistica contemporanea di ispirazione
anglosassone, che, come è noto, suggeriscono di indagare, per ogni fatto di
cronaca, l‟oggetto del fatto stesso (what), chi ne è stato l‟autore (who), il luogo
(where) e il momento (when) in cui esso è stato portato a termine e infine quale
n‟è stata la causa (why).

54
Costituisce parte integrante del contesto anche il genere letterario a cui il testo in
questione appartiene: è evidente, infatti, che un prototesto di natura letteraria avrà
caratteristiche proprie e conterrà riferimenti impliciti ben diversi da quelli, ad
esempio, di un testo tecnico, giudiziario oppure di argomento medico. In tutti
questi casi cambiano radicalmente non soltanto il contesto, ma anche il lettore
implicito e tutto l‟insieme di impliciti testuali presenti nell‟opera, che possono
condurre a ipotesi interpretative ben differenti fra di loro.
Fra gli altri elementi che costituiscono il contesto, che saranno descritti nei
prossimi paragrafi, rientrano anche il cotesto, cioè le porzioni di testo che
precedono e seguono direttamente il prototesto, e tutti quegli elementi che fanno
riferimento alla figura dell‟autore reale, come la sua biografia e gli altri testi che
egli ha prodotto, cioè la sua bibliografia (la cosiddetta bibliografia dell’autore). A
questi si aggiungono, ovviamente, i testi di approfondimento e di commento scritti
da altri autori, critici o studiosi, al riguardo dell‟autore del prototesto, che vanno a
costituire la bibliografia critica.
Rientra nell‟ambito delle informazioni contestuali, infine, il cosiddetto problema
dei realia, ben noto ai traduttori professionisti: si tratta, cioè, della questione di
come rendere nel metatesto i riferimenti presenti nel testo originale a oggetti, a
concetti, a luoghi e a tutti i referenti concreti che sono ben noti ai lettori modello
della cultura del prototesto ma che, al contrario, si presume che risultino del tutto
ignoti ai lettori della cultura del metatesto; anche di questo aspetto si tratterà nei
paragrafi che seguono.
Il traduttore, una volta che abbia adeguatamente messo a fuoco il contesto
dell‟opera, ivi compresi tutti gli elementi sopra elencati, lo descriverà il più
accuratamente possibile nella prefazione o nel commento al testo tradotto, cioè in
quella parte della traduzione che in precedenza si è definita paratesto.

55
2.2. Cotesto
Come si è già anticipato, per cotesto si intende il testo, orale o scritto che esso
sia, che precede e segue direttamente la porzione testuale isolata per la traduzione,
cioè il prototesto vero e proprio. Nel caso che il prototesto coincida con l‟intera
estensione di un‟opera, è evidente che non si potrà parlare della presenza di un
cotesto in senso stretto. L‟osservazione del cotesto è di grande importanza per
identificare e comprendere tutti i riferimenti contestuali contenuti nell‟opera,
specialmente quando essi riguardano personaggi o fatti descritti in altri punti del
testo stesso. I traduttore, ovviamente, dovrà porre particolare attenzione, nel caso
di un testo letterario, a non anticipare nel metatesto elementi che non sono
presenti direttamente nel prototesto ma di cui egli è venuto a conoscenza
attraverso la lettura del cotesto: così, ad esempio, non potrà certamente rivelare
chi è l‟assassino a metà di un libro giallo, quando mancano ancora centinaia di
pagine alla conclusione.
In secondo luogo, il cotesto può fornire informazioni molto importanti
relativamente alla ricostruzione della psicologia dei personaggi di un‟opera
letteraria, che è importante conoscere per potere stabilire di volta in volta quale sia
la scelta traduttiva più appropriata. In questo senso, Bachtìn giustamente
sottolinea come ogni opera letteraria sia una vera e propria polifonia, un‟opera
cioè a cui tutti i partecipanti contribuiscono con una voce e uno stile diverso e
personale, ivi compreso lo stesso autore e, non da ultimo, il traduttore46
.
2.3. Autore: biografia, bibliografia, citazioni, stile
Per comprendere appieno la straordinaria quantità di riferimenti connotativi
presenti nel prototesto e per riuscire, di conseguenza, a ricostruirne in maniera
plausibile il contesto di riferimento può essere di grande utilità la conoscenza di
alcuni dati riguardanti l‟autore del testo, o per meglio dire il suo autore empirico.
46
Cfr. Bachìn [1979].

56
Di massima importanza, ovviamente, sono i dati biografici relativi all‟autore,
come il luogo e l‟epoca in cui è vissuto, il suo ambiente familiare, la sua
formazione, sino alle sue frequentazioni, vizi e virtù: nulla, o quasi, deve sfuggire
al traduttore, che deve conoscere il suo autore il più possibile. Di pari importanza,
come è ovvio, sono le altre opere scritte dall‟autore stesso, cioè la sua bibliografia,
tenendo ben presente che concorrono a costituire una bibliografia non soltanto le
opere letterarie pubblicate, ma anche le lettere, cioè l‟epistolario, gli appunti
privati, le note, i diari personali e via dicendo, insomma tutto l‟universo letterario
in senso lato che circola intorno a quella determinata figura.
Quando un autore scrive un testo, egli è inevitabilmente esposto all‟influenza di
tutti gli altri testi, letterari e non, con cui è entrato in contatto durante la sua
esistenza, sia che questo processo rimanga inconscio sia che esso si svolga in
maniera del tutto consapevole o addirittura evidente, assumendo l‟aspetto di una
vera e propria citazione. Questo spazio fatto di citazioni, fra un testo e l‟altro, è
definito da Torop [2000: 222] spazio intertestuale, e sarebbe proprio, stando
sempre allo stesso Torop, il luogo dove ogni testo nasce e si sviluppa. Lo spazio
intertestuale, del resto, influenza da parte sua anche il lettore, sebbene ciò avvenga
attraverso conoscenze e ricordi che possono benissimo non essere perfettamente
sovrapponibili con quelli dell‟autore47
.
La conoscenza della bibliografia dell‟autore e delle sue preferenze letterarie
porta inevitabilmente il traduttore a entrare gradualmente in contatto con quello
che si definisce lo stile di quell‟autore: un ulteriore elemento contestuale che,
come è ovvio, riveste un‟importanza fondamentale.
2.4. Il problema dei realia
Il problema dei cosiddetti realia, a cui si è già fatto cenno più sopra,
rappresenta uno di quelli maggiormente dibattuti nella pratica quotidiana della
47
Cfr. Osimo [2004: 41].

57
traduzione48
. Per realia, lo ripetiamo, si intendono quei termini che indicano
oggetti specifici di una certa cultura e che difficilmente trovano un esatto
corrispondente nella lingua di una cultura differente, in genere a causa
dell‟assenza nel codice di arrivo del referente concreto a cui rimandava
direttamente quel significante. Tanto per fare un esempio banale, il problema dei
realia si pone nel caso della traduzione in italiano dell‟inglese bobby, che a
Londra indica il “poliziotto”, ovviamente non un poliziotto qualunque ma il tipico
poliziotto londinese con il tradizionale copricapo, armato – ancora sino a qualche
anno fa – soltanto di sfollagente. Come tradurre bobby? Tutte le possibili rese, da
poliziotto, a bobby, passando per tipico poliziotto londinese, sino a improbabili
attualizzazioni come il dialettale ghisa, cioè il “vigile milanese” che indossa un
copricapo assai simile, sono ovviamente criticabili sotto vari punti di vista. Per
rimanere ancora nel contesto britannico, non è facile neppure decidersi sulla
migliore traduzione di un‟espressione banale come fish and chips: si tratta
veramente solo di “pesce e patatine” o di che cosa?
Le varie soluzioni traduttive maggiormente adottate nel caso dei realia si
possono riassumere schematicamente nell‟elenco che segue:
1) trascrizione o traslitterazione della parola originale, carattere per carattere,
trattandola dunque come un prestito lessicale: pampa, marines, kiwi, banana,
bunga-bunga, Jumbo-jet, Shuttle/shuttle (il primo è la navetta spaziale, il secondo
è il bus-navetta di trasporto per un hotel o un aeroporto), bar, sport ecc.; il prestito
può ovviamente essere in parte adattato foneticamente alla lingua ricevente, come
cachemire in francese preso dall‟hindi Kašmir, o ancora zar, balalaica ecc.;
2) creazione di un calco strutturale, come nei casi di grattacielo da skyscraper,
pellerossa da redskin, guerra lampo da Blitzkrieg e via dicendo;
48
[Osimo 2004: 63-65]. Il termine realia viene per lo più trattato in italiano come indeclinabile; si
tratta infatti di un aggettivo latino, il neutro plurale di realis, -e “vero, reale”, e quindi alla lettera
significa “le cose reali”.

58
3) esplicazione, per lo più attraverso il conio di un‟espressione complessa:
violinista ambulante per l‟ungherese cigány, venditore di libri vecchi per il
francese bouquiniste, poliziotto londinese per bobby ecc.
4) sostituzione con l‟iperonimo, cioè con il termine semanticamente sovraordinato
a quello da tradurre: ad esempio mutare un Beaujolais in un semplice vino rosso;
5) sostituzione per approssimazione, ad esempio traducendo l‟inglese britannico
soccer in italiano con football, o ancora il tedesco Jugendstil in francese con art
nouveau e in italiano con liberty, i nostri maltagliati con l‟internazionale pasta;
La scelta traduttiva, di volta in volta, dipenderà in questi casi da molti fattori
diversi, come l‟esoticità del testo e la sua maggiore o minore caratterizzazione
locale, le preferenze e le abitudini stilistiche dell‟autore, le aspettative dei lettori:
così, ad esempio, un lettore francese è mediamente meno disposto ad accettare
prestiti lessicali da una lingua straniera di quanto invece non sia un lettore
italiano, notoriamente abbastanza esterofilo. Alcune soluzioni sono, ovviamente,
di per sé più rischiose, in particolare le ultime due dell‟elenco appena proposto,
perché finiscono per creare un residuo che molto spesso sarebbe invece evitabile,
impoverendo in tal modo il testo tradotto.
3. Lessico e significati
La scelta di ogni singolo traducente dipende dunque da precise scelte traduttive,
nelle quali il traduttore è lasciato, per così dire, solo con sé stesso. Le competenze
del traduttore devono perciò essere molto vaste e comprendere la storia e la
cultura della lingua di partenza, il repertorio di artifici stilistici e retorici a cui
l‟autore può aver attinto, sino alle caratteristiche proprie di quel singolo autore. In
più, il traduttore deve essere in grado di scrivere bene – non solo da un punto di
vista della grammatica normativa – nella lingua di arrivo, sapendone sfruttare tutte
le potenzialità e le sfumature semantiche, individuando anche come riprodurre i
termini che già nel prototesto appaiono come più marcati, suscitando nel lettore
finale un effetto analogo a quello che doveva sperimentare il lettore del testo di

59
partenza49
. Ciò ovviamente è vero soltanto in termini ideali e nessuno si aspetta
veramente che un traduttore dall‟inglese conosca alla perfezione tutte le opere e
gli autori della sterminata letteratura inglese, da Joyce a Shakespeare, Conrad o
West, ma certamente un buon traduttore non dovrà lasciare nulla di intentato per
raggiungere una competenza che sia la più ampia e completa possibile.
In realtà, il traduttore non è mai solo, ma può contare sulla compagnia, per così
dire, del dizionario monolingue. Infatti, è proprio grazie alle raccolte lessicali e in
particolare agli esempi testuali forniti dal monolingue che il traduttore può
giudicare l‟accettabilità di una determinata espressione nella lingua di arrivo verso
la quale egli sta traducendo. Ogni singola scelta lessicale, infatti, si basa sui
cosiddetti postulati di significato, cioè sull‟individuazione di quale delle accezioni
di un certo significante fosse quella intesa dall‟autore del prototesto, seguita
immediatamente dalla scelta di un traducente che contenga, fra le proprie
accezioni, quella che più si avvicina a quella originale dal punto di vista
semantico, d‟uso e di registro stilistico50
. Nello schema che segue (Fig. 6) si
ripercorre il processo traduttivo, fatto appunto di postulati di significato, che può
portare dall‟inglese bow all‟italiano arco. Come si può notare, ogni singolo
passaggio ha escluso un‟ampia serie di possibili accezioni semantiche, postulando
dunque quale potesse essere l‟accezione scelta dall‟autore del prototesto: in questo
caso, quella di “arma per scagliare le frecce”. In questo caso concreto il ricorso a
un dizionario monolingue può aiutare anche a individuare potenziali accezioni che
il parlante di inglese come seconda lingua potrebbe facilmente non conoscere,
come il valore di bow come “prua” di una nave. Parallelamente, il traduttore deve
anche tenere conto degli effetti psico-linguistici che un certo traducente, come
appunto arco, provoca nel lettore del metatesto: infatti, l‟italiano arco evoca
un‟ampia gamma di accezioni, più o meno ricca a seconda della competenza
lessicale del lettore stesso.
49
Sulle competenze del traduttore cfr. ad es. Eco [1979]; Osimo [2004: 54, 77].
50 [Osimo 2004: 70].

60
Fig. 6. Postulati di significato51
4. Tipologia della traduzione
Da tutto quanto si è detto sin qui, dovrebbe ormai essere chiaro che non esiste
una traduzione uguale a un‟altra. Non solo, ma non esiste un testo da tradurre,
dunque un prototesto, uguale a un altro. Fra i tipi di traduzione che richiedono una
tecnica particolare si annovera anzi tutto la traduzione poetica: un prototesto di
natura poetica, infatti, pone problemi traduttologici non indifferenti. In questo
caso, il rischio potrebbe essere quello di concentrarsi troppo sulla forma
dell‟originale, ottenendo una traduzione ottima sul piano filologico ma non
accettabile dal punto di vista del lettore finale; al contrario, un‟eccessiva libertà
51
Nello schema della Fig. 6 la sigla (V) indica un verbo, (N) un nome.
(N) a weapon for shooting arrows
bow
(N) a long thin piece of wood you use to play
the violin
(N) un’arma per scagliare frecce
(N) a knot for hair-ribbons
(V) to bend your body or head
forward
(N) the act of bending your body or head
(N) the front part of a boat
(=prow)
(N) una struttura architettonica
(V) to accept one’s wishes
arco
(N) una funzione matematica
(N) strumento per suonare il
violino (=archetto)
(N) periodo di tempo
(N) parte della traiettoria di un
proiettile

61
nelle scelte traduttive potrebbe portare a una traduzione d’autore, dove cioè il
peso del traduttore è troppo grande, finendo per fare del traduttore stesso un vero e
proprio autore. Nel caso della traduzione di un testo poetico una possibile tecnica
è quella di operare scelte lessicali di natura estraniante: termini marcati, poetici,
oppure tipici della cultura e dell‟epoca del testo di partenza, per creare nel lettore
l‟impressione di essere davanti a un testo che non è una semplice prosa, ma
appunto una poesia, anzi una poesia di una specifica epoca e appartenente a un
determinato contesto culturale. Un‟altra possibilità è quella di pubblicare la
traduzione con il testo originale a fronte; una soluzione, questa, molto
professionale e onesta, ma poco adottata sia per ragioni di economia editoriale sia,
in alcuni casi, per un certo timore del traduttore di esporsi direttamente a eventuali
critiche per le proprie scelte traduttive.
I vari tipi di traduzione non poetica, quali quella scientifica, tecnica,
giornalistica, divulgativa, teatrale, filmica e via dicendo, possono essere
raggruppati sotto la categoria della traduzione editoriale. In tutti questi casi è
molto importante il ruolo del committente della traduzione, che con le sue
esigenze guida il traduttore verso la creazione di un determinato tipo di metatesto.
Fra questi tipi, in particolare, la traduzione tecnica richiede speciali accorgimenti.
Essa riguarda testi come manuali, orari, articoli scientifici, istruzioni e via
dicendo. In tutti questi casi è evidente che il traduttore dovrà ridurre al minimo la
presenza di riferimenti di natura connotativa, scegliendo dunque elementi lessicali
che denotino con precisione e in maniera univoca il rispettivo referente: così, ad
esempio, nelle istruzioni per il montaggio di un‟automobile non ci si può
permettere di creare ambiguità di nessun tipo, neppure nei più piccoli particolari,
pena il mancato raggiungimento del risultato finale. Esistono anche alcune norme
che cercano di regolamentare la traduzione tecnica: fra queste, l‟obbligo di
segnalare i cambiamenti di unità di misura (ad esempio il passaggio dai chilometri
alle miglia), o ancora la necessità di rispettare il più possibile la struttura sintattica
del testo di partenza, ad esempio evitando di sostituire una parola singola con
un‟espressione formata da due parole, o anche il contrario. È evidente, a questo

62
punto, che i testi tecnici sono una tipologia traduttiva all‟interno della quale il
problema dei realia è particolarmente importante, per non dire decisivo.
Non esistono, comunque, delle soluzioni buone per tutti i casi. Esemplare è
quanto accade nella traduzione dei testi di divulgazione scientifica di area
anglosassone, nei quali l‟autore adotta in genere uno stile fortemente colloquiale,
che invece nella traduzione italiana suonerebbe decisamente fuori posto in un
testo che è comunque di natura scientifica52
.
5. Lo stile del traduttore
5.1. Adeguatezza e accettabilità
Si è visto, dunque, che la tradizionale opposizione fra traduzione letterale e
traduzione libera è da considerarsi ormai superata, in quanto troppo vaga e legata
a criteri di giudizio estremamente soggettivi. In questo senso, Toury ha proposto
una coppia di categorie interpretative che bene esprimono il dilemma del
traduttore: adeguatezza e accettabilità53
. Se lo scopo principale del traduttore è
quello di riprodurre l‟integrità del testo di partenza, si può parlare di adeguatezza,
nel senso che il metatesto si adegua, in un certo modo, al prototesto, alla sua
lingua e alla sua cultura di riferimento contestuale. Al contrario, se lo scopo del
traduttore è principalmente quello di creare un metatesto stilisticamente e
linguisticamente accettabile, di facile accesso, si parlerà di accettabilità. Ognuno
dei due atteggiamenti implica ovviamente alcuni rischi: l‟adeguatezza può creare
difficoltà ai lettori, se non fortemente motivati e ben informati, mentre
l‟accettabilità può arrivare a cancellare del tutto le tracce della cultura del testo di
partenza, finendo per creare un enorme quantità di residuo traduttivo e
impoverendo in tal modo il testo stesso.
52
[Osimo 2004: 55].
53 Cfr. Toury [1995]; Osimo [2004: 59].

63
Un esempio, abbastanza spassoso, di testi decisamente non accettabili nella
lingua di arrivo è fornito dai seguenti cartelli sparsi per il mondo, che un sito web
di appassionati viaggiatori ha raccolto e pubblicato on-line:
LADIES ARE REQUESTED NOT TO HAVE CHILDREN IN THE BAR
(in un bar di un hotel, Norvegia).
SPECIALIST IN WOMEN AND OTHER DISEASES (ambulatorio medico, Roma).
PERSONS ARE PROHIBITED FROM PICKING FLOWERS FROM ANY BUT
THEIR OWN GRAVES (cimitero, Italia).
YOU ARE WELCOME TO VISIT THE CEMETERY WHERE FAMOUS RUSSIAN
AND SOVIET COMPOSERS, ARTISTS, AND WRITERS ARE BURIED DAILY
EXCEPT THURSDAY (hotel nei pressi di un cimitero ortodosso, Mosca).
IF THIS IS YOUR FIRST VISIT TO THE USSR, YOU ARE WELCOME TO IT
(hotel, Mosca).
ARE YOU AN ADULT THAT CANNOT READ? IF SO, WE CAN HELP
(insegna pubblicitaria per un corso di alfabetizzazione, Sidney).
YOU ARE INVITED TO TAKE ADVANTAGE OF THE CHAMBERMAID.
(hotel, Giappone).
CUSTOMERS WHO FIND OUR WAITRESSES RUDE OUGHT TO SEE THE
MANAGER (ristorante, Nairobi)54
.
5.2. Il rischio del paternalismo
A volte il traduttore è portato a sottovalutare le capacità del lettore e adotta, di
conseguenza, un atteggiamento che si potrebbe definire paternalistico: aumenta il
numero degli interventi paratestuali, con note, spiegazioni, un‟introduzione
persino eccessiva, e inoltre interviene sullo stesso testo dell‟opera cercando di
renderlo maggiormente comprensibile55
. Un caso tipico è quella della cosiddetta
specificazione, mediante la quale il traduttore aggiunge particolari non presenti nel
prototesto, generalmente allo scopo di chiarire un‟espressione: così, ad esempio,
era stanco di percorrere quella strada può diventare era stanco di dover 54
Fonte: www.alphadictionary.com/fun/mistranslation.html.
55 [Osimo 2004: 62].

64
percorrere ogni giorno tutta quella strada. In questo modo, per altro, il traduttore
interviene in maniera piuttosto pesante sulle ipotesi interpretative che il lettore
compie riguardo al senso globale del testo. Un altro caso è fornito dalla tendenza
all‟esplicitazione, attraverso la quale si tende a rendere espliciti particolari che,
invece, l‟autore aveva deciso di lasciare sottintesi, ad esempio traducendo
parcheggiò ed entrò in tabaccheria con parcheggiò, scese dall’automobile ed
entrò in tabaccheria. Ognuna di queste scelte, come è evidente, rappresenta una
presa di posizione molto forte del traduttore nei confronti del testo, con notevoli
rischi in termini di aderenza al prototesto e alla volontà dell‟autore.
5.3. Abitudini scolastiche
Le cattive abitudini sono dure a morire, come è noto, e una delle cattive
abitudini del traduttore è quella di attenersi ancora, magari molto tempo dopo la
fine dei propri studi scolastici, a quelle norme di stile che gli sono state insegnate
durante gli anni dell‟infanzia. Il problema è che parecchie di quelle scelte
stilistiche evidentemente sono, dal punto di vista della qualità del testo,
abbastanza discutibili, dato che erano state intese esclusivamente a scopo didattico
e non certo per fini letterari56
. Una delle abitudini più comuni è quella di sostituire
una parola, considerata troppo generica, con un termine più specifico: anche in
questo caso è evidente che lo scopo didattico di queste sostituzioni era quello di
ampliare il vocabolario degli scolari; il risultato, però, è quello magistralmente
descritto da Italo Calvino in un passo in cui lo scrittore definisce antilingua questo
particolare registro linguistico:
Caratteristica principale dell‟antilingua è quello che definirei il “terrore semantico”,
cioè la fuga di fronte a ogni vocabolo che abbia di per sé stesso un significato, come se
fiasco, stufa, carbone fossero parole oscene, come se andare, trovare, sapere
indicassero azioni turpi. Nell‟antilingua i significati sono costantemente allontanati,
56
[Osimo 2004: 143-150].

65
relegati in fondo a una prospettiva di vocaboli che di per sé stessi non vogliono dire
niente o vogliono dire qualcosa di vago e sfuggente57
.
Così, fatalmente, in una traduzione influenzata dalle abitudine scolastiche il
protagonista di un romanzo, magari proprio in un testo in cui il registro linguistico
sarebbe volutamente colloquiale, assurdamente non va da nessuna parte ma vi si
reca o vi si porta, di notte non dorme ma si riposa, non compera qualcosa ma lo
acquista, non si ricorda di una certa persona, ma la rammenta, come si sentiva
dire nei doppiaggi dei film americani degli anni ‟50. Il traduttore, invece,
dovrebbe essere in grado di riconoscere e, per quanto gli è possibile, riprodurre
nel metatesto tutti i registri linguistici che sono presenti nel testo di partenza:
questo, ovviamente, richiede però un‟elevata competenza comunicativa nella
lingua del prototesto, oltre che in quella del testo di arrivo.
Esistono, in ogni caso, delle precise spie linguistiche che rivelano sino a che
punto il traduttore sia ancora legato alle abitudini scolastiche: ad esempio l‟uso
del pronome personale egli, ormai comunemente relegato ai registri più elevati e
letterari così come il suo corrispettivo femminile ella; ancora, l‟uso anomalo dei
tempi verbali, senza considerare la profonda diversità delle varietà regionali
dell‟italiano, facendo magari parlare un personaggio di Milano con un
sorprendente, per lui, passato remoto. Un‟altra tendenza molto diffusa è
l‟eliminazione delle ripetizioni che l‟autore aveva inserito nel prototesto, anche in
questo caso sulla scia delle abitudini scolastiche e degli esercizi di ricerca dei
sinonimi; tuttavia, bisogna forse decidere caso per caso quando conviene
rispettare la volontà dell‟autore, il quale certamente non ha inserito tali ripetizioni
semplicemente per errore. In breve, si potrebbe dire che il traduttore non deve
correggere il testo che ha di fronte, ma lo deve tradurre. La qual cosa parrebbe
abbastanza ovvia.
57
[Calvino 1980: 122-123].

66
5.4. Visibilità del traduttore
Tutte le scelte del traduttore concorrono a creare nel lettore empirico
un‟impressione diversa, che può portare a non considerare neppure la presenza e
l‟azione di un traduttore su quel testo oppure, al contrario, a notare di continuo gli
interventi dell‟autore sul testo stesso. In questo senso, si può parlare di traduttore
invisibile, nel primo caso, ovvero di traduttore visibile nel secondo58
. Il paratesto,
ovviamente, è uno dei luoghi dove si gioca maggiormente la visibilità del
traduttore. Così, ad esempio, la scelta di corredare il testo di un apparato di note
particolarmente ricco, magari con un‟ampia introduzione, può rendere il traduttore
eccessivamente visibile, arrivando a interferire con la stessa natura del testo di
partenza e con le scelte stilistiche dell‟autore. Al contrario, un traduttore troppo
anonimo e invisibile può lasciare il lettore troppo solo, rischiando che
quest‟ultimo non sia in grado di decodificare buona parte dei significati del testo
stesso.
A favore della presenza di un ricco apparato critico, con note e commenti assai
generosi, è sempre stato Vladimir Nabokov (1899-1977), che si è letteralmente
scagliato contro il mito della scorrevolezza, con il quale troppo spesso i traduttori
hanno giustificato una notevole libertà nei confronti dell‟autore59
:
In primo luogo, dobbiamo accantonare una volta per tutte il concetto convenzionale
secondo cui una traduzione “deve essere scorrevole” e “non deve avere l‟aria di una
traduzione”. […] In realtà, qualsiasi traduzione che non abbia l‟aria di una traduzione, a
un attento esame, è destinata a risultare inesatta; mentre, d‟altra parte, l‟unica virtù di
una buona traduzione è la fedeltà e la completezza. Se sia di scorrevole lettura o no
dipende dal modello, non dall‟imitatore60
.
Tuttavia, il traduttore non deve vivere questi dilemmi con angoscia e non si può
non essere d‟accordo con Umberto Eco quando afferma che nell‟attività di
traduzione c‟è sempre una buona parte di divertimento, che consiste nella
58
[Osimo 2004: 56, 60-61]
59 [Osimo 2004: 70; 87-88].
60 [Nabokov 1984: XII-XIII].

67
sensazione di scommessa, di gioco d‟azzardo, che è insita in ogni singola scelta
traduttiva. Inoltre, un traduttore a volte può inconsapevolmente passare alla storia
proprio grazie a una traduzione tecnicamente erronea, che però ha avuto di gran
lunga più fortuna e un maggiore influsso culturale della corrispondente traduzione
corretta. Esiste una lunga serie di traduzioni celebri, ma sbagliate; fra queste si
possono citare, ad esempio: che cos’è il bacio? Un apostrofo rosa tra le parole
“ti” e “amo”, traduzione celeberrima ma assai libera dell‟originale francese del
Cyrano di Edmond Rostand, la cui resa fedele sarebbe stata un puntino rosa sulla
“i” del verbo “aimer”, con ben altro effetto; ancora, il titolo del film Arancia
meccanica, tratto dal romanzo di Anthony Burgess A Clockwork Orange,
letteralmente suonerebbe Un’arancia a orologeria. Infine il caso più
emblematico: se non ci fosse stato un errore traduttivo dell‟espressione Big
brother contenuta nel romanzo di George Orwell 1984, oggi parleremmo tutti del
Fratello maggiore, certamente una formula di gran lunga meno efficace del
celeberrimo Grande fratello, che però tutto può essere considerato tranne che la
corretta traduzione dell‟originale Big brother, letteralmente “fratello maggiore” o
“fratellone”.
5.5. Uno stile adattabile
Se è lecito trarre qualche conclusione dalle osservazioni sin qui proposte, forse
si può rimarcare come la scelta vincente per il traduttore generalmente sia quella
di adottare uno stile di traduzione adattabile e flessibile, che muta con il cambiare
delle esigenze del testo, dell‟autore e dei lettori, a seconda delle diverse tipologie
testuali e dei differenti contesti di riferimento. In questo senso si possono rileggere
tutte le antinomie sin qui proposte: testo chiuso e testo aperto, le sei funzioni
testuali individuate da Jakobson; e ancora significato denotativo e connotativo,
adeguatezza e accettabilità, sino alle scelte più concrete, come quella di affidarsi
maggiormente al dizionario monolingue oppure alla conoscenza personale del
contesto. I diversi poli appena elencati ovviamente vanno intesi come gli estremi
di segmenti che rappresentano un continuum, dove le scelte possono situarsi lungo

68
una scala che prevede infinite gradazioni intermedie, come si può riassumere nello
schema che segue (Fig. 7).
Fig. 7. Le scelte traduttive
Un esempio può forse chiarire meglio che cosa si voglia intendere qui per stile
adattabile del traduttore. Un caso interessante può essere fornito dal discorso del
Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, del primo maggio 2011, nel quale è
stata annunciata al mondo l‟uccisione del leader di Al-Qaida, Osama bin Laden.
Quello che segue è l‟incipit del discorso.
Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the
United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al
Qaeda, and a terrorist who‟s responsible for the murder of thousands of innocent men,
women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was
darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11
are seared into our national memory – hijacked planes cutting through a cloudless
September sky; the Twin Towers collapsing to the ground; black smoke billowing up
from the Pentagon; the wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania, where the
actions of heroic citizens saved even more heartbreak and destruction.

69
Come è già evidente da queste poche righe, si tratta senz‟altro di un testo
particolare, fortemente caratterizzato dal punto di vista retorico e strutturato per
avere un forte impatto emotivo sugli spettatori televisivi che lo avrebbero
ascoltato in diretta dalla viva voce del Presidente. Quella che segue è un proposta
di traduzione, che cerca, per quanto è possibile, di adattare le singole scelte
traduttive allo stile, allo scopo e alla natura del prototesto.
Buona sera. Questa notte posso annunciare al popolo americano e al mondo che gli Stati
Uniti hanno condotto un‟operazione che ha portato all‟uccisione di Osama Bin Laden,
leader di al-Qaida e terrorista responsabile dell‟omicidio di migliaia di uomini, donne e
bambini innocenti. Sono passati quasi dieci anni da quando una limpida giornata di
settembre fu oscurata dal peggior attacco contro il popolo americano della nostra storia.
Le immagini dell‟11 settembre sono scolpite nella nostra memoria nazionale: aerei
dirottati attraversano un cielo di settembre senza nubi; le Torri Gemelle crollano su sé
stesse; fumo nero si alza dal Pentagono; la tragedia del volo 93 a Shanksville, in
Pennsylvania, in cui cittadini eroici hanno evitato un dolore e una distruzione più
grandi61
.
Senza soffermarsi a commentare ogni singolo passo della traduzione, si noti che
già nella prima riga di testo il verbo report, propriamente “segnalare, riferire,
riportare”, è stato reso con annunciare, sottolineando in questo modo in maniera
maggiore la solennità del momento e l‟ufficialità dell‟annuncio stesso,
prendendosi però il rischio di allontanarsi in piccola parte dal testo di partenza.
Coerentemente con lo stile degli annunci ufficiali del governo statunitense,
fortemente patriottici, si è scelto di rendere American people con popolo
americano. Ma il commento potrebbe ancora essere lungo; in ogni caso è evidente
come l‟equilibrio traduttivo non sia cosa facile da ottenere, se non entrando in
sintonia con gli scopi e le convinzioni dell‟autore del prototesto e considerando
allo stesso tempo tutti gli aspetti del contesto.
L‟estrema importanza di un‟attenta considerazione del contesto può essere
esemplificata con un altro testo, questa volta di natura letteraria, al quale si
premettono alcune righe di informazione sul suo autore, Chain Adamson.
61
Traduzione di Gloria Bernini.

70
Chain Adamson nasce nella Columbia Britannica il 6 giugno del 1906. La famiglia
Adamson è funestata da tragici fatti tuttora inspiegati, come la scomparsa nel nulla del
fratello di Chain, Abel, all‟età di 17 anni, durante una partita di caccia con Chain e i
genitori. Adamson studia come traduttore e interprete; inizia quindi la sua carriera
traducendo le opere del marchese De Sade dal francese in inglese. Nel 1939 pubblica il
suo unico romanzo, I want to kill him, che ha sùbito un breve ma intenso successo
editoriale. Dopo una vita di eccessi, sempre dedito all‟alcool e alle droghe, Adamson
viene trovato senza vita nell‟estate del 1940, nella sua automobile parcheggiata in un
bosco paludoso presso Clearwaters, in Florida.
That day, that fucking day, I was wandering on my car just around, till I stopped near
that swamp. It was such a stinking swamp. I stopped, I said. Then I went there. Along
the water‟s edge, below the humid trees, there I went. And at once I saw something
there. Yes, there, a fucking I-don‟t-know-what, a sunk little boat, whose bow was the
only piece you could see. Then I had the idea. That was the place, and the right one.
There I could hide the body. Fuck! Am I my brother‟s keeper? [C. Adamson, I want to
kill him, New York, The Black Friars, 1939, p. 47]
Ho sottoposto questo testo agli studenti del mio corso di teoria e tecnica della
traduzione, che hanno formulato interessanti proposte traduttive tra cui le due che
riporto qui di seguito. A detta degli stessi studenti, la conoscenza del contesto e in
particolare della biografia dell‟autore si è rivelata fondamentale nell‟elaborazione
del metatesto.
Quel giorno, quel fottutissimo giorno, stavo guidando senza meta prima di fermarmi
vicino a quella palude. Era davvero puzzolente. Mi fermai, dicevo. E andai là, lungo la
riva, sotto gli alberi umidicci, è lì che andai. E improvvisamente vidi qualcosa. Sì,
proprio lì, c‟era un fottutissimo non-so-cosa, una piccola barca sommersa, di cui si
vedeva solo la prua. E allora mi venne l‟idea. Quello era il posto, quello giusto. Lì avrei
nascosto il corpo. Cazzo! Devo parare il culo a mio fratello?62
Quel giorno, quel fottuto giorno, stavo andando in giro in macchina, finché non mi sono
fermato vicino a quella palude. E quanto puzzava quella palude. Mi sono fermato, come
ho detto. Allora sono andato là. Lungo la riva, sotto gli alberi umidi, è là che sono
andato. E all‟improvviso ho visto qualcosa. Sì, là, un che-cazzo-ne-so, una barchetta
andata a fondo, solo la prua usciva dall‟acqua. Poi ho avuto l‟idea. Era quello il posto, il
62
Traduzione di Veronica Azzini e Federica Sirelli.

71
posto giusto. Era lì che potevo nascondere il corpo. Cazzo! Sono forse il custode di mio
fratello?63
Sono traduzioni senz‟altro diverse fra loro, ma entrambe decisamente valide.
Una delle principali differenze, tuttavia, sta proprio nella diversa possibilità di
accedere al contesto che era stata accordata agli studenti: la seconda coppia di
traduttori, infatti, aveva accesso a Internet e, in questo modo, ha potuto
identificare una delle citazioni letterarie presente nel prototesto,
quell‟interrogativa am I my brother’s keeper? che è ripresa alla lettera dal
racconto biblico di Caino e Abele. Poco importa che in realtà il prototesto fosse
inventato di sana pianta e che Chain Adamson, se mai esistito, non abbia mai
scritto alcun romanzo; ciò che importa, invece, è osservare ancora una volta come
la conoscenza del contesto si riveli fondamentale nell‟operare tutte le scelte
traduttive.
63
Traduzione di Alice Orciani e Andrea Siligardi.

72
IV
STRUMENTI DEL TRADUTTORE
1. Strumenti tradizionali
Il primo strumento del traduttore è, per così dire, il traduttore stesso. La
competenza del traduttore, infatti, si crea nel tempo attraverso un processo di
formazione che comincia da lontano. Già negli anni dell‟infanzia il futuro
traduttore acquisisce una competenza linguistica e comunicativa nella propria
lingua materna, che sarà poi fondamentale successivamente. In questa fase risulta
ovviamente un vantaggio la presenza in famiglia di un parlante che possieda una
diversa lingua materna: un ambiente plurilingue, infatti, può influire
positivamente sulla creazione di una competenza linguistica multipla e anche sullo
sviluppo di un interesse, pur ancora embrionale, per gli aspetti metalinguistici
della comunicazione. La formazione continua con la scuola secondaria e in questo
caso la scelta di un liceo linguistico o comunque di un istituto dove alle lingue
straniere sia riservato un numero di ore di lezione adeguato costituisce un
vantaggio nella preparazione del traduttore, alla quale concorrono anche le
esperienze all‟estero, con viaggi di studio finalizzati, oltre che a migliorare la
competenza linguistica nella lingua straniera, anche a consolidare la competenza
comunicativa.
La recente riforma universitaria ha introdotto la nuova laurea in sceinze della
mediazione linguistica, conferita al termine di un corso di studi triennale che
sostituisce il vecchio diploma universitario per traduttori e interpreti. Lo studente
che desidera poi essere riconosciuto ufficialmente come traduttore o interprete
professionale può accedere alla laurea magistrale, che prevede ulteriori due anni

73
di studio, organizzati nei due curricula di traduzione scritta e di interpretariato
orale.
1.1. Il dizionario monolingue
Il dizionario monolingue può essere considerato lo strumento principe del
traduttore, in quanto esso permette di conoscere in maniera non superficiale le
diverse accezioni di significato dei singoli termini e allo stesso tempo di verificare
l‟accettabilità della ipotesi traduttiva attraverso le attestazioni e le
esemplificazioni riportate nella seconda parte delle entrate. Oggi l‟accesso ai
dizionari di questo tipo avviene in molti casi nel formato elettronico, attraverso
siti Internet dedicati a questo scopo, ma talvolta la consultazione dell‟opera
cartacea risulta ancora indispensabile: basti pensare al più importante e autorevole
dizionario monolingue della lingua italiana, il cosiddetto Battaglia, i cui volumi
sono ancora disponibili soltanto nel formato tradizionale.
1.2. Il dizionario traduttore
In alcuni casi può essere utile la consultazione di un dizionario bilingue, cioè di
un dizionario traduttore, che permette un accesso più snello e immediato alle
informazioni fondamentali circa il traducente che si sta ricercando. In questo caso
è importante ricorrere a un dizionario di grandi dimensioni, sufficientemente
esteso da registrare un numero di accezioni abbastanza elevato; solo in questo
modo ci si potrà mettere al riparo da spiacevoli inconvenienti traduttivi dovuti
all‟eccessiva fretta con cui si sceglie un determinato traducente. Anche nel caso
dei dizionari traduttori oggi lo strumento di Internet è di fondamentale
importanza.

74
1.3. Dizionari speciali ed enciclopedie
In molti casi si rende necessaria la consultazione di altri tipi di repertori
lessicali, che rispondono a esigenze specifiche. Nella prassi scolastica il traduttore
è già entrato in contatto con il dizionario dei sinonimi e dei contrari, che può
essere di qualche utilità a livello stilistico, ad esempio, per evitare inutili
ripetizioni nel metatesto. Il dizionario enciclopedico, invece, si dimostra
particolarmente prezioso per individuare tutte le informazioni contestuali e
connotative legate a un certo termine, così come avviene anche per il dizionario
etimologico, che mostra la storia e l‟origine delle parole di una determinata
lingua.
Un altro repertorio particolarmente utile è il dizionario delle citazioni, che
permette di risalire all‟autore e all‟opera da cui è stato tratto un certo brano o una
determinata citazione. Ancora alle informazioni di natura contestuale è legato il
dizionario biografico, che riporta le notizie fondamentali relative alla vita e alle
opere degli autori letterari. Completa il gruppo dei dizionari speciali il lessico di
frequenza, che indica con quale frequenza i lemmi di una certa lingua ricorrano
nei testi di quella comunità linguistica: un simile strumento può rivelarsi
particolarmente utile, ad esempio, per pianificare lo studio e l‟acquisizione del
lessico in una lingua straniera o ancora per stabilire quanto una forma che si
desidera scegliere come traducente sia effettivamente diffusa e conosciuta.
2. Strumenti offerti dalle nuove tecnologie64
2.1. Dizionari elettronici
Già da diversi anni sono disponibili in formato elettronico numerosi ottimi
dizionari, sia monolingui che traduttori: inizialmente stampati su CD-ROM, oggi
tali opere sono accessibili soprattutto via Internet. Come è naturale, gli strumenti
migliori sono a pagamento, ma in rete è sempre possibile trovare ottimi dizionari
64
Sugli questi strumenti si veda in particolare la monografia di Osimo [2001]. Una breve rassegna
di alcuni degli indirizzi Internet più utili per il traduttore è presentata più avanti, nell‟Appendice 1.

75
anche gratuiti (per una selezione, si veda l‟Appendice 1, come anche per gli altri
strumenti descritti qui di seguito). Gli aspetti positivi del ricorso a un dizionario in
formato elettronico sono ovviamente molteplici: anzi tutto le ricerche si possono
effettuare per lemmi o per singole lettere, oppure sfogliando virtualmente il testo
come avveniva con l‟edizione a stampa; poi, i dizionari on line possono essere
frequentemente aggiornati con una spesa molto ridotta, a differenza di quelli
cartacei; infine, i lessici in rete possono contenere riferimenti ipertestuali, cioè dei
link, che rimandano direttamente a raccolte di testi o ad altri materiali lessicali.
Un‟impressionante raccolta di link a dizionari in rete è presentata dal sito The
Translator’s Home Companion, a cui corrisponde in Italia la pagina della rassegna
bibliografica di Biblit: gli indirizzi di questi e di altri siti sono riportati più avanti,
nell‟apposita appendice. Molto consultato dai traduttori è anche il sito Word
Reference, con l‟accesso diretto a vari dizionari bilingui inglese-italiano, fra cui il
Concise Oxford Paravia. Presentare una rassegna delle risorse di questo tipo,
tuttavia, non è di grande utilità, perché il loro numero è in costante aumento e
qualsiasi elenco finirebbe per essere già troppo datato nel momento in cui viene
reso pubblico; per costruirsi un proprio elenco personale aggiornato basterà,
dunque, fare ricorso a un qualunque motore di ricerca, come Google.
2.2. Corpora
Un vantaggio delle risorse elettroniche rispetto a quelle tradizionali è senz‟altro
costituito dalla possibilità di accedere, in modo rapido e completo, a una serie
molto estesa di raccolte di testi, letterari e non, prodotti in qualunque lingua del
mondo: si tratta dei corpora on line, che in genere sono di accesso gratuito.
L‟utilità dell‟uso di un corpus testuale, per il traduttore, risiede soprattutto nel
fatto che in questo modo egli può facilmente verificare l‟accettabilità di una
determinata espressione nella lingua di arrivo, essendo certo in tal modo
dell‟effetto finale della sua traduzione nei confronti di un parlante madrelingua.
Un simile strumento, del resto, sarebbe quasi del tutto inutilizzabile senza le

76
possibilità offerte dalle nuove tecnologie, dato che non basterebbe una vita, ad
esempio, per leggere tutte le opere letterarie comprese in un corpus on line,
mentre oggi è sufficiente aprire una pagina Internet e compilare un modulo di
ricerca testuale, cioè un form, per ottenere in tempo reale tutti i risultati. In
Inghilterra il punto di riferimento è senz‟altro il British National Corpus, mentre
in Italia è disponibile un ottimo portale, con la raccolta di corpora in varie lingue,
a cura dell‟Università di Bologna, sede di Forlì.
Anche nel caso dei corpora c‟è la possibilità di costruirsi al momento un proprio
corpus testuale, relativo ai milioni di pagine pubblicate in Internet: basterà
ricercare una stringa di testo su Google o su un altro motore di ricerca,
ovviamente inserendola fra le virgolette ad apice che indicano che si vuole
ricercare il testo esattamente così come è scritto, per conoscere in tempo reale il
numero totale delle attestazioni di quella frase nel web e tutti i relativi link.
2.3. Enciclopedie e wiki
Le informazioni contestuali di cui ha bisogno il traduttore possono essere
reperite negli strumenti di consultazione di natura enciclopedica. In Internet si
possono trovare essenzialmente due tipi di enciclopedie: da una parte le edizioni
on line di volumi a stampa, che hanno il pregio della completezza e
dell‟affidabilità delle informazioni in esse contenute ma che spesso sono
accessibili solo a pagamento, e dall‟altra le cosiddette wiki, cioè le enciclopedie
libere costruite a partire dai contributi degli utenti – prima fra tutte la celebre
Wikipedia – che però hanno il difetto di non garantire in maniera assoluta
l‟affidabilità di tutti i contenuti in esse pubblicati. Il già citato Google, come è
ovvio, può essere utilmente utilizzato come una vera e propria enciclopedia,
sempre tenendo debitamente conto del problema dell‟affidabilità del contenuto
delle pagine a cui si viene di volta in volta rimandati.

77
2.4. Forum di discussione
Uno strumento particolarmente utile per il traduttore è costituito dai forum di
discussione, nei quali i colleghi discutono di qualunque aspetto della traduzione,
dai dubbi sulla resa di singoli passaggi testuali sino agli aspetti legali ed
economici della loro professione. Iscrivendosi a uno si questi forum, in genere
gestiti dalle associazioni di traduttore, è anche possibile ricevere regolarmente le
e-mail con gli ultimi aggiornamenti pubblicati. In Italia, fra gli altri, si può
segnalare il forum di Biblit, particolarmente attivo e completo.
2.5. Elaboratori di testo e formati dei documenti
Oggi il traduttore lavora e scrive, nella grande maggioranza dei casi,
direttamente al computer. Fra gli elaboratori di testo senz‟altro il più diffuso è
Word, un elaboratore commerciale sviluppato da Microsoft, costantemente
aggiornato e venduto in più versioni compatibili sia con le piattaforme Windows
che con quelle Macintosh. Di facile apprendimento, Word contiene un numero di
strumenti in genere sufficiente per venire incontro alle esigenze del traduttore,
permettendogli di concentrarsi sul testo più che sull‟aspetto finale della pagina
(compito che spetta invece al curatore editoriale e che esula in parte dalle
caratteristiche tipiche di Word). Tra gli strumenti più utili ci sono l‟inserimento
delle note a pie‟ di pagina e la correzione automatica, con la possibilità di
scaricare da Internet i dizionari praticamente di qualsiasi lingua del mondo. Come
è ovvio, lo strumento della correzione automatica va usato con cautela, anche
perché si limita a individuare gli errori di ortografia più evidenti, senza riuscire a
isolare gli scambi tra omofoni, gli errori di concordanza morfologica o sintattica e
via dicendo. Il controllo e la correzione della bozza finale della traduzione, invece,
andranno sempre fatti a mano sulla stampa cartacea, dato che il testo a video tende
a nascondere gli errori e a renderli meno evidenti per i nostri sensi.
Il traduttore che debba scambiare un testo vie e-mail oppure consegnarlo per la
stampa a un editore deve tenere conto anche del formato elettronico di quel testo e

78
della sua compatibilità, cioè della facilità o meno con cui esso potrà essere aperto
dall‟elaboratore installato sui computer di altri utenti. Le ultime versioni di Word,
se non si opta per un altro formato nel menù delle impostazioni, salvano i file con
estensione docx, che però non è assolutamente compatibile con le versioni
precedenti: in questo caso, dunque, converrà optare per la vecchia estensione doc.
Se poi si desidera che il proprio file sia universalmente compatibile e sia
visualizzato nello stesso modo in tutti i sistemi operativi, si può decidere di
salvarlo come pdf, che costituisce il formato di interscambio professionale più
sicuro. Se nel testo si sono utilizzati caratteri diversi dall‟alfabeto occidentale
basato sul latino, sarà bene allegare anche una copia del font utilizzato, oppure
specificarne il nome, e comunque orientarsi sui nuovi font compatibili con lo
standard Unicode, che assicurano una perfetta compatibilità con tutti gli
elaboratori.
2.6. La traduzione automatica
Negli ultimi decenni del Novecento le difficoltà pratiche incontrate per secoli
dai traduttori si sono nuovamente evidenziate nel momento in cui si è cercato di
mettere mano alla cosiddetta traduzione automatica, ottenuta mediante
l‟elaborazione di appositi programmi informatici che avevano come scopo quello
di produrre automaticamente, e in linea teorica senza l‟intervento umano, una
traduzione a partire da un testo originale. Gli effetti assai deludenti, soprattutto nei
primi anni, della traduzione automatica si spiegano proprio con il problema già
esposto della differenza fondamentale fra competenza linguistica e competenza
comunicativa, oltre che con l‟impossibilità da parte dell‟intelligenza artificiale
dell‟elaboratore di prendere in considerazione il contesto della comunicazione
stessa. Così, negli ultimi anni si è sottolineata la differenza fra la machine
translation “traduzione automatica” e la computer assisted translation (CAD)
“traduzione con l‟uso del computer”, orientandosi decisamente verso
quest‟ultima.

79
Un banale esempio permette facilmente di farsi un‟idea dei limiti della
traduzione automatica: si tratta di un breve testo, sottoposto ad alcuni dei più
popolari strumenti di traduzione gratuiti presenti in rete. Il commento, in questo
caso, sembra superfluo e ci si limita a osservare che lo strumento che ha fornito il
risultato migliore sembra essere stato il traduttore incluso nel motore di ricerca di
Google, che per altro permettere di scegliere fra un numero impressionante di
lingue diverse.
PROTOTESTO
Today I went to my aunt‟s farm, but when I was halfway it started to rain. So I decided
to stop for a while and I found a small tent over there.
Oggi sono andato alla fattoria di mia zia, ma quando ero a metà strada ha cominciato a
piovere. Così ho deciso di smettere per un po‟ e ho trovato una piccola tenda laggiù.
BING
Oggi sono andato a farm di mia zia, ma quando ero a metà strada ha cominciato a
piovere. Così ho deciso di interrompere per un po‟ e ho trovato una piccola tenda
laggiù.
SDL
Oggi sono andato alla fattoria di mia zia, ma quando ero la mezza maniera che ha
cominciata piovere. Così ho deciso di fermare per un mentre e ho trovato una piccola
tenda laggiù.
SYSTRAN
Oggi sono andato all‟azienda agricola di mia zia, ma quando ero mezzo modo ho
cominciato piovere. Così ho deciso di fermarmi per un po‟ ed ho trovato una piccola
tenda là.
REVERSO
Oggi io andai alla fattoria di mia zia, ma quando io ero a metà strada che ha cominciato
a piovere. Quindi io decisi di fermare per un tempo ed io trovai là una piccola tenda.

80
3. La presentazione del testo tradotto
3.1. Forma, norme redazionali e bibliografia
La forma, nel caso dei lavori da presentare per l‟editoria, talvolta è altrettanto
importante quanto il contenuto. Al traduttore fortunatamente non è richiesto di
produrre un testo nella forma definitiva per la stampa, ma comunque presentare
una traduzione impaginata male e piena di errori di battitura non è certamente un
indice di professionalità. Inoltre esiste almeno un caso in cui il traduttore deve
curare anche l‟aspetto esteriore del suo testo: quello della sua tesi di laurea, di cui
deve curare con attenzione frontespizio, sommario, prefazione, elenco delle
illustrazioni e delle abbreviazioni, corpo del testo (spesso con il testo originale a
fronte), commento, conclusioni, glossari e indici.
Ogni editore stabilisce un elenco di norme redazionali, che riguardano l‟uso
della punteggiatura, delle virgolette per le citazioni, delle maiuscole e delle
minuscole, delle sigle e delle abbreviazioni, sino alle norme bibliografiche da
seguire con attenzione per riportare i titoli dei testi utilizzati e consultati nel
proprio lavoro. Anche in questo caso un traduttore che non rispetti le norme
redazionali non solo presenterà un testo curato male, ma soprattutto obbligherà
l‟editore a spendere tempo e denaro per correggere quel testo uniformandolo alle
proprie norme, con la conseguente decisione di affidarsi a un diverso traduttore
per il prossimo lavoro.
Al di là delle norme redazionali, il testo dovrà ovviamente apparire
perfettamente pulito dal punto di vista dell‟ortografia prevista dalle regole della
lingua di arrivo, se non si vuole svalutare un lavoro che magari è costato giorni e
giorni di fatica. Anche questo aspetto, ovviamente, non deve essere sottovalutato e
non si deve credere che il correttore automatico di Word ci possa sostituire in
questo ingrato compito. Sarà utile, dunque, tenere sotto mano un prontuario come
quello presentato in Appendice 3.

81
3.2. Standard di trascrizione
La cura del traduttore deve essere indirizzata anche verso la corretta trascrizione
delle parole e dei nomi propri di origine straniera. In questo caso esistono delle
tabelle di conversione stabilite dalle norme ISO per l‟uniformazione, che spesso
però non vengono seguite alla lettera e che vengono variamente adattate dai
singoli editori. Sarà bene, quindi, informarsi presso il proprio editore, per
presentare un testo che non abbia bisogno di ulteriori interventi anche sotto questo
aspetto. In Appendice 2 sono presentate alcune fra le tabelle di trascrizione più
importanti.

82
APPENDICE 1
SELEZIONE DI RISORSE ELETTRONICHE
Rassegne di dizionari
Rassegna di Biblit (vedi sotto). Dizionari mono- e bilingui, dizionari settoriali. Più
di 600 link.
http://www.biblit.it/dizionari_glossari.htm (elenco dei link ai dizionari on-line)
http://www.biblit.it/ricerca_diretta.htm (pagina con i form di ricerca diretta sui dizionari on-
line più importanti)
The Translator‟s Home Companion. Impressionante raccolta di dizionari e
strumenti per il traduttore.
http://www.lai.com/companion.html
The Free Dictionary. The American Heritage Dictionary of the English Language,
Collins English Dictionary, ecc.
http://www.thefreedictionary.com/
Foreign Word. Accesso a dizionari bilingui, fra cui il Collins inglese-italiano.
http://www.foreignword.com/
Accesso simultaneo a decine di dizionari di inglese on-line.
http://www.alphadictionary.com/index.shtml
Dizionari bilingui inglese-italiano, fra cui Concise Oxford Paravia Italian
Dictionary e Word Reference Dictionary
http://www.wordreference.com/
Dizionari speciali
Dizionario etimologico della lingua inglese.

83
http://www.etymonline.com/
The Acronym Finder. Dizionario di sigle, abbreviazioni e acronimi, con centinaia
di migliaia di entrate.
http://www.acronymfinder.com/
Corpora
Raccolta di corpora in varie lingue, a cura dell‟Università di Bologna, sede di
Forlì
http://sslmit.unibo.it/corpora/alf_index.php
British National Corpus.
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
Forum di discussione e altro
Biblit. Forum di riferimento per i traduttori, con approfondimenti, tariffe di
traduzione, sondaggi, link a strumenti ecc.
http://www.biblit.it/
AITI. Associazione Italiana Traduttori e Interpreti
http://www.aiti.org/
Tariffometro. Uno strumento un po‟ naif per calcolare le tariffe, con informazioni
su dimensioni delle cartelle e altro.
http://www.tariffometro.it/
Cataloghi bibliografici
ICCU. Istituto Centrale per il Cataologo Unico, da cui si accede all‟OPAC SBN,
ricerca su tutti i testi editi in Italia.
http://www.sbn.it/

84
APPENDICE 2
TABELLE DI TRASCRIZIONE
(RUSSO E ARABO)
Cirillico (lingua russa)
ISO e IPA

85
Arabo
ISO, IPA e altre codifiche

86
APPENDICE 3
PRONTUARIO ORTOGRAFICO E STILISTICO
Abbreviazioni
Per le abbreviazioni esistono apposite norme ISO, reperibili in rete. Comunque
sia, è sempre bene chiarire in un elenco dettagliato da premettere al testo tutte le
abbreviazioni che si sono utilizzate e il loro significato. In genere le abbreviazioni
sono riconoscibili grazie alla presenza di un punto (cit. per citato, a c. di per a
cura di, cfr. per confronta e via dicendo), ma nel caso delle unità di misura non si
deve utilizzare il punto (mg per milligrammi, km per chilometri).
Accento
L‟accento deve essere segnato graficamente soltanto quando una parola sia tronca,
cioè accentata sull‟ultima sillaba (perché, però, tè, caffè, affinché ecc.), oppure
quando esista il pericolo di fraintendimenti fra due parole omofone, specie se
monosillabiche (ad esempio te rispetto a tè), mentre per le parole di più sillabe la
scelta è lasciata a chi scrive (ad esempio àmbito e ambìto, oppure ambito). In tutti
questi casi bisogna anche distinguere graficamente fra accento acuto e accento
grave, il primo per indicare una vocale o oppure e semi-chiusa, il secondo per le
vocali o ed e semi-aperte e per le altre vocali. Particolare attenzione va posta nel
rischio che l‟elaboratore di testi inserisca un apostrofo al posto dell‟accento,
ovviamente. Alcuni dei casi di omofonia più frequenti da segnalare sono: da
preposizione semplice e dà voce del verbo dare, la articolo o pronome e là
avverbio di luogo, ne particella e né congiunzione avversativa (con il valore di e
non), se congiunzione ipotetica e sé pronome riflessivo, si pronome o particella e
sì affermazione, te pronome e tè sostantivo (la bevanda).
Apostrofo
L‟apostrofo serve per indicare un‟elisione, come avviene frequentemente nel caso
degli articoli: l’automobile, un’amica. Altri casi ricorrenti sono: bell’uomo,

87
sant’Agnese, senz’altro, d’accordo, pie’ di pagina e gli imperativi sta’, fa’, da’,
di’, va’ ecc. Sull‟obbligatorietà di alcune elisioni non tutte le grammatiche
concordano: mi importa oppure m’importa, si arriva o s’arriva e via dicendo.
Sono da ricordare, invece, i casi in cui l‟elisione assolutamente non va messa, in
quanto è avvenuto un troncamento: un amico, qual è ecc. Gli elaboratori di testo
talvolta inseriscono una lineetta verticale al posto dell‟apostrofo, che invece deve
essere a forma di mezzaluna; in questi casi sarà necessario regolare le preferenze
del programma.
Bibliografia
I sistemi di citazione bibliografica concorrenti sono essenzialmente due: quello
tradizionale, che riporta ogni volta il titolo completo di un‟opera nelle note, ad
esempio G. Rossi, Libro interessantissimo, Einaudi, Torino, 1987, p. 6, e quello
anglosassone, che riporta solo un riferimento in forma abbreviata, ad esempio
[Rossi 1987: 6], per poi riportare il titolo completo solo alla fine del volume nella
sezione dei riferimenti bibliografici, come segue: Rossi, G. [1987]: Libro
interessantissimo, Einaudi, Torino. Le norme di citazione variano notevolmente a
seconda degli editori e delle collane, ma l‟importante è mantenere uno stesso
criterio dall‟inizio alla fine del testo.
Corsivo
Sebbene esistano notevoli differenze a seconda dei criteri editoriali, in genere
vanno in corsivo titoli di libri, di film e di opere teatrali, titoli di quadri, nomi di
navi e simili. Il corsivo può anche essere utilizzato per identificare una parola
straniera, come bobby, oppure per dare maggiore enfasi a una parola o a un
concetto particolarmente importanti nel testo.
“D”
La d eufonica si usa di preferenza quando la particella a cui è aggiunta termina
con la stessa vocale della parola che la segue, mentre negli altri casi si può evitare:
ed ecco ma e altri.

88
Date
Le date si sciolgono nella maniera più naturale, come 6 agosto 1987. Si cerca di
evitare le abbreviazioni, come ‟73.
Maiuscole
Le maiuscole sono obbligatorie per nomi di persona come Luigi e cognomi come
Rossi, nomi di animali domestici come Fido, luoghi come Firenze, periodi storici
come il Settecento, movimenti culturali come l‟Illuminismo, cariche istituzionali
come il Presidente quando non siano aggettivi (il presidente Napolitano), nomi di
popoli come gli Inglesi ma non gli aggettivi (i bambini inglesi), nomi di libri,
giornali e opere d‟arte ma solo per la prima parola come il Corriere della sera,
istituzioni come lo Stato, feste come il Natale, formule di cortesia come Egregio
Signore, espressioni geografiche come Mezzogiorno e Sud. Inoltre, la maiuscola è
obbligatoria dopo il punto fermo, il punto esclamativo, il punto interrogativo,
all‟inizio di un periodo e all‟inizio di un discorso diretto.
Numeri
I numeri vanno scritti per esteso, come centoventidue, a meno che non siano
troppo alti.
Punteggiatura
Ferma restando una certa libertà stilistica nell‟uso della punteggiatura, è bene
verificare che dopo ogni segno di punteggiatura sia presente uno – e uno solo –
spazio bianco. Le virgolette servono a indicare un discorso diretto e come si
aprono così si devono ovviamente chiudere, sia che si tratti di “virgolette ad
apice” che di «virgolette a caporale». Il punto fermo va dopo la chiusura delle
virgolette, mentre il punto interrogativo va messo prima.

89
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
AUER, P. [1984]: Bilingual conversation, Amsterdam, Benjamins.
BACHTÌN, M. [1979]: La parola nel romanzo, in C. Strada Janovič (a cura di),
Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, pp. 67-230.
BELL, R. [1998]: Psycholinguistic / cognitive approaches, in Routledge
Encyclopedia of Translation Studies, ed. M. Baker et alii, London, Routledge,
pp. 185-190.
BENJAMIN, W. [1923]: Die Aufgabe des Übersetzers, Heidelberg, Weissbach
[trad. it. Il compito del traduttore, in Angelus novus, Torino, Einaudi, 19822,
pp. 39-52; rist. in S. Nergaard, La teoria della traduzione nella storia, Milano,
Bompiani, 1993, pp. 221-236].
BERRUTO, G. [1995]: Fondamenti di sociolinguistica, Bari, Laterza.
BLOOM, H. [1974]: The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, New York,
Oxford University Press [trad. it. L’angoscia dell’influenza. Una teoria della
poesia, a c. di M. Iacono, Milano, Feltrinelli, 1983].
– [1975]: A Map of Misreading, New York, Oxford University Press.
BRADFORD, R. [1994]: Roman Jakobson: Life, Language, Art, London, Routledge.
CALVINO, I. [1980]: L’antilingua, in Id., Una pietra sopra. Discorsi di letteratura
e società, Torino, Einaudi, pp. 122-126.
CATFORD, J.C. [1965]: A Linguistic Theory of Translation, Oxford, Oxford
University Press.
CORTELAZZO, M.–ZOLLI, P. [1999]: Dizionario etimologico della lingua italiana,
Bologna, Zanichelli.
DELISLE, J. [1988]: Translation. An Interpretative Approach, Ottawa, Ottawa
University Press.
ECO, U. [1979]: Lector in fabula, Milano, Bompiani.

90
– [2003]: Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani.
FOLENA, G. [1973]: Volgarizzare e tradurre: idea e terminologia della traduzione
dal Medio Evo italiano e romanzo all’Umanesimo europeo, in AA.VV., La
traduzione. Saggi e studi, Trieste, Lint, pp. 57-120.
– [1991]: Volgarizzare e tradurre, Torino, Einaudi.
ISER, W. [1972]: Der implizite Leser, München, Fink.
JAKOBSON, R. [1935]: The Dominant, in Id., Language in Literature, ed. K.
Pomorska-S. Rudy, Cambridge (Mass.), Belknap Press, 1987, pp. 41-46.
– [1959]: On Linguistic Aspects of Translation, in R.A. Brower (ed.), On
Traslation, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1959, pp. 232-239
[trad. it. Aspetti linguistici della traduzione, in Saggi di linguistica generale,
Milano, Feltrinelli, 1966, pp. 56-64].
KRISTEVA, J. [1969]: Sēmeiōtikḗ: recherches pour une sémanalyse, Paris, Edition
du Seuil [trad. it. Semiotiche. Ricerche per una semanalisi, Milano, Feltrinelli,
1978].
LEPSCHY, G.C. [1981]: Traduzione, in AA.VV., Enciclopedia Einaudi, vol. 14,
Torino, Einaudi, pp. 446-459.
– [1992]: La linguistica del Novecento, Bologna, il Mulino.
LUTHER, M. [1530]: Sendbrief von Dolmetschen [trad. it. in Nergaard 1995, pp.
99-119; rist. in M. Lutero, Lettera del tradurre, Venezia, Marsilio, 1998].
MAC ARTHUR, T. [1992]: The Oxford Companion to the English Language,
Oxford, Oxford University Press.
MARTINELLI, L. [2005]: Imparare a tradurre. Corso di base per tradurre dal
tedesco all’italiano, Trento, UNI Service.
MIGLIORINI, B. [1960]: Storia della lingua italiana, voll. 1-2, Firenze, Sansoni.
MIKO, F [1978]: The Programme of the Text, Nitra, Nitra University.
MORPURGO DAVIES, A. [1996]: La linguistica dell’Ottocento, Bologna, il Mulino.
MOUNIN, G. [1965]: Teoria e storia della traduzione, Torino, Einaudi.

91
NABOKOV, V. [1984]: Foreword, in M. Lermontov, A Hero of Our Time, Oxford,
Oxford University Press, pp. I-XIII.
NERGAARD, S. [1993]: La teoria della traduzione nella storia, Milano, Bompiani.
– [1995]: Teorie contemporanee della traduzione, Milano, Bompiani.
NIDA, E.A. [1959]: Principles of Translation as Exemplified by Bible Translating,
in R.A. Brower (ed.), On Translation, Cambridge (Mass.), Harvard University
Press, pp. 11-31.
OGDEN, C.K. e RICHARDS, I. [1949]: The Meaning of Meaning. A Study of the
Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism, London,
Routledge.
OSIMO, B. [2001]: Traduzione e nuove tecnologie. Informatica e internet per
traduttori. Guida pratica con glossario, Milano, Hoepli.
– [2002]: Storia della traduzione. Riflessioni sul linguaggio traduttivo
dall’antichità ai contemporanei, Milano, Hoepli.
– [2004]: Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario. Seconda
edizione, Milano, Hoepli.
PEIRCE, C.S. [1931-1948]: Collected Papers, Cambridge, Harvard University
Press.
ROBINS, R.H. [1997]: Storia della linguistica, Bologna, il Mulino.
ROBINSON, D. [1997]: Becoming a Translator. An Accelerated Course, New
York-London, Routledge.
ROMAINE, S. [1989]: Bilingualism, Oxford, Blackwell.
SAPIR, E. [1921]: Language. An Introduction to the Study of Speech, New York,
Brace & Co.
SAUSSURE, F. DE [1916]: Cours de linguistique générale, a cura di C. Bally e A.
Sechehaye, Lausanne-Paris, Payot [trad. it. Corso di linguistica generale, a
cura di E. De Mauro, Bari, Laterza, 1967].
SCHLEIERMACHER, F. [1813]: Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens,
in Zur Philosophie, vol. 2, Berlin, Reimer, 1835-1846 [trad. ingl. On the

92
Different Methods of Translating, in L. Venuti (ed.), The Translation Studies
Reader, London, Routledge, 2002, pp. 43-63; trad. it. Sui diversi modi del
tradurre, in Nergaard 1993, pp. 143-181].
SEGRE, C. [1985]: Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi.
SHANNON, C.E.–WEAVER, W. [1949]: The Mathematical Theory of
Communication, Urbana, University of Illinois Press.
SOLETTI, E. [1994]: Traduzione, in G.L. Beccaria (a cura di), Dizionario di
linguistica e di filologia, metrica, retorica, Torino, Einaudi, pp. 731-733.
TERRACINI, B.A. [1951]: Il problema della traduzione, in Conflictos de lenguas y
de culturas, Buenos Aires, Imam, 1951 [rist. in Conflitti di lingua e di cultura,
Venezia, Neri Pozza, 1957, pp. 49-121; rist. a cura di B. Mortara Garavelli,
Milano, Serra e Riva, 1983].
TOROP, P. [2000]: La traduzione totale, a cura di B. Osimo, Modena, Logos [ed.
orig. Total’nyj perevod, Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus – Tartu University
Press, 1995].
TOURY, G. [1995]: Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam,
Benjamins.
VENUTI, L. (ed.) [2002], The Translation Studies Reader, London, Routledge.
VYGOTSKIJ, L.S. [1990]: Pensiero e linguaggio, Ricerche psicologiche, a c. di L.
Mecacci, Bari, Laterza.
WEINREICH, U. [1953]: Languages in Contact, New York-The Hague, Mouton
[trad. it. Lingue in contatto, Torino, Boringhieri, 1974].
WHORF B.L. [1956]: Language, Thought, and Reality. Selected Writings, ed. J.B.
Carroll, Cambridge Mass., MIT [trad. it. Linguaggio, pensiero e realtà, Torino,
Boringhieri, 1970].