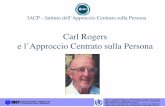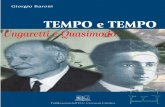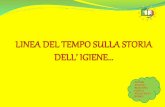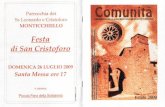Sulla Persona e Sul Tempo
-
Upload
maury59m919926609 -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Sulla Persona e Sul Tempo
7/30/2019 Sulla Persona e Sul Tempo
http://slidepdf.com/reader/full/sulla-persona-e-sul-tempo 1/10
Sulla persona e sul tempo: il VERBO
Par t e I
Esiste un momento, nella storia di un libro, in cui il narratore si trova a prendere una
decisione importante, che non potr à più var iare e che deve necessariamente segnare il procedere dell’opera. Dall’inizio sino alla sospirata parola “fine”.Per essere precisi è l’apertura stessa del libro che condiziona una variabile essenziale,
e ogni scelta qui fatta deve essere razionale, certa, e precisa.In verità la scelta del verbo è spesso implicita nell’idea stessa del romanzo. La chiave
di lettura passa attraverso questa decisione e spesso l’autore ne è consapevole sin dal prim o istante. I n genere è la frase di apertura che condiziona il racconto, m a anche qui esistono le debite eccezioni che come tale non possono essere ignorate.
Sul la per sona
Sulla persona, dunque. È la prima scelta, la più sofferta, perché ogni decisione sul tipodi narrazione passa attraverso questo problema, e condizionerà in manierainequivocabile tutto lo svolgersi del romanzo. Così come la struttura narrativa, che inalcuni casi diviene assolutamente forzata.Esistono sostanzialmente tre modi di scrivere un libro, a questo riguardo. Ognuno èvalido ma si deve sapere a quali pericoli si corre incontro nell’usare l’uno piuttosto chel’altro e quali sono i limiti di ciascuna tecnica, prima di cominciare.In genere la scelta è sentita, precede la narrazione ed è l’unica che appareappropriata per quello che stiamo scrivendo. Spesso è legata al personaggio a cui sida vita. A volte è un artifizio e come tale deve essere considerato.
Tre possibilità, quindi, la prima, la seconda e la terza persona. Ognuna con un suospecifico carattere. Esaminiamo nel dettaglio ciascuna di queste opzioni.
La prim a persona – è stata una della prime ad essere introdotte nella formula delromanzo (Robinson Crusoe*01, Gulliver’s Travels, etc.) e per anni ha avuto un forteimpatto sul lettore. Gestisce il racconto attraverso un unico personaggio,generalmente il protagonista*02 e spesso il narratore assiste in prima persona allevicende di cui si narra.Il libro si svolge in un’unica chiave di lettura. L’unico punto di vista che ci è concesso èquello del personaggio e di questo bisogna tenerne conto in ogni circostanza. Ilnarratore conosce solo quello che accade quando lui è presente. Tutto il resto viene
riferito di seconda mano. E in maniera fondamentale le emozioni e le interiorità sonosolo quelle del narratore. Non può entrare dentro l’animo degli altri, non può esserecerto di cosa stanno provando o di cosa stiano pensando.Può al massimo ipotizzare, ma ogni valutazione, essendo soggettiva può anche esseresbagliata*03.L’intero romanzo quindi si svolge in soggettiva, si suppone che chi narra sia semprepresente al momento dell’azione, e non possono esistere situazioni che si svolgonosenza che egli ne venga a conoscenza. Diversamente non le potrebbe neancheriportare.Quando si usa quindi la prima persona? Come al solito la scelta è dell’autore, ma cisono delle linee guida che vanno sottolineate.
Innanzitutto la prima persona esprime il desiderio del protagonista di comunicare. Lofa per un esigenza personale. Ha vissuto la storia e la vuole donare agli altri. E inmaniera particolare è a conoscenza degli stati emotivi che lo hanno guidato per tutto il
7/30/2019 Sulla Persona e Sul Tempo
http://slidepdf.com/reader/full/sulla-persona-e-sul-tempo 2/10
percorso.I romanzi che focalizzano maggiormente la loro attenzione sull’interiorità delpersonaggio (del protagonista, in realtà) hanno un grande vantaggio nell’uso dellaprima persona. Così come i testi che cercando di creare un profondo interesse emotivonel lettore (identificazione) fanno vedere il mondo attraverso gli occhi di chi parla. Un
mondo distorto, sia ben chiaro, perché ogni informazione è filtrata dall’emozioni nonneutrali del narratore.Esempi di questo tipo di narrazione sono il diario e il romanzo epistolare.Ancora, come in Conan Doyle, nel tentativo di gestire una situazione esterna, in terzapersona, ma situando il lettore al centro della scena. Noi vediamo con gli occhi diWatson. Egli ci conduce nel mondo della Londra vittoriana e ci indica, da una distanzaestremamente ravvicinata le gesta del suo compagno. Il vantaggio è quello di esserespettatori: se fosse Holmes a narrare probabilmente dovrebbe rivelarciimmediatamente la sua linea di condotta e perderemmo interesse perché i percorsilogici che lo portano alla soluzione del caso apparirebbero meno eclatanti.Watson ci conduce in prima persona nella scena del crimine, ce ne rende partecipi e ci
riempie di dubbi su quello che accadrà. Insieme a lui valutiamo i limiti e gli indizi delcaso e ne rimaniamo sconvolti, perché ci rendiamo conto che non andiamo da nessunaparte*04. Quando Holmes però troverà l’indizio chiave, la soluzione del caso, tuttoapparirà logico, e l’effetto sarà esaltato. Ma solo perché il nostro racconto non èpassato attraverso la sua narrazione*05.Allo stesso tempo la narrazione in prima persona, sostituendosi al narratoreonnisciente, ci mostra solo alcuni aspetti della storia tenendone fuori altri. Ciò che èassente esiste solo nella mente dell’autore*06, ma il lettore non lo scopre se nonattraverso artifizi o nel successivo procedere della storia.Ragione per cui l’andamento generale (ma non è ben inteso una regola obbligata) diun racconto in prima persona è molto lineare: accade un fatto quindi ne segue unaltro. Ogni avvenimento è in qualche modo causa del successivo ed effetto delprecedente. Chiaramente una struttura così rigida può essere spezzata con l’uso diflash-back o flash-forward che possono dare dinamicità all’azione.Questo perché la prima persona è in genere usata per l’introspezione, e questa spessosi serve del ricordo.La prima persona in questo ambito diviene d’atmosfera e di effetto. Ha un grossoimpatto e ci guida dove vuole il narratore. Non ci sono dubbi a riguardo. Il lettore è ilprotagonista. Il mondo è visto in una soggettiva ed è spesso frutto di esperienzepassate.La letteratura gotica e romantica dell’800 ne è un esempio esaltante. Edgar Allan Poeusa la prima persona per introdurre il personaggio, creare un suo background efiltrare il mondo attraverso le manie e le ossessioni dello stesso. Nel racconto “laSfinge”, ad esempio, l’immagine di una farfalla notturna appare alnarratore/protagonista come un mostro mitologico che scala il pendio di unamontagna. E questo perché è attraverso i suoi occhi che gestiamo la narrazione. Se lastessa scena fosse descritta dal di fuori si vedrebbe con chiarezza che in realtà ilprotagonista sta guardando una farfalla a pochi centimetri di distanza. La scenaapparirebbe senza significato e non si capirebbe che è stata una distorsione, un giocoottico, a creare l’illusione del mostro sulla montagna.Esemplare è il caso di Frakenstain di Mary Shelley. La narrazione è tutta in primapersona, ma si sposta su più piani, giocando con i diversi personaggi. In primo luogoesiste un narratore principale. Egli soccorre un uomo che si scopre essere il dottorFrankenstain. All’interno della prima narrazione se ne apre un’altra. Un lunghissimo
flask-back che durerà per tutta la lunghezza del libro ci narra le vicende del dottore.La cosa sorprendente è che ad un certo punto nella narrazione di Frakenstaininterviene lo stesso mostro da egli creato che apre una nuova parentesi narrativa,
7/30/2019 Sulla Persona e Sul Tempo
http://slidepdf.com/reader/full/sulla-persona-e-sul-tempo 4/10
arma a doppio taglio. Il rischio concreto è quello di perdere di vista la finalità dellastoria, la gestione dei personaggi e le caratteristiche e le individualità degli stessi. Unodegli errori più banali che spesso lo scrittore inesperto compie è quello di prendere ipersonaggi inserirli in una storia e usarli indifferentemente, perdendo di vistal’importanza delle interazioni tra gli stessi e il punto di vista di ciascuno. I personaggi
vengono fatti parlare e agiscono a casaccio.Esistono in ogni caso delle enormi differenze anche all’interno di storie in terzapersona e che meriterebbero da sole una trattazione a parte. Per rimanere sinteticidiciamo che una fiaba dei fratelli Grimm è profondamente diversa da un opera diStepehn King, per esempio, così come Tolkien non ha niente a che vedere con AgataChristie. Chiaramente le sfumature tra i tipi di narrazione sono notevoli per tutta unaserie di tecniche narrative e di stili che non possono essere semplificati con unasemplice teoria della terza persona. Tuttavia gli esempi citati hanno dellecaratteristiche a riguardo dell’uso della persona che possono essere sottolineate.In genere le forme di narrazione che si competono alla terza persona sono tre. Quelladel narratore onnisciente che può entrare liberamente nella mente dei personaggi,
quella del narratore che conosce un unico punto di vista, generalmente quello delprotagonista, quella dell’osservatore.Nel primo caso il narratore si muove come meglio crede, gestisce i personaggidall’esterno e dall’interno (conosce i loro pensieri, il loro passato, segreti che nonrivelerebbero a nessuno, etc.) ed è a conoscenza di ogni cosa che accade nel suomondo (l’albero che cade nella foresta)*09.In Stephen King troviamo spesso questo tipo di narrazione, per esempio. Nei suoiromanzi si arriva a conoscere addirittura le paranoie e gli eccessi schizofrenici deiprotagonisti: noi conosciamo i pensieri e le voci che essi sentono. Tipico in questocaso è “IT”.Ancora più esemplare è J.R.R. Tolkien con “il Signore degli Anelli”. Qui il mondo ègestito a più livelli. Si assiste (specie ne “le due torri”) ad un montaggio in parallelo, incui più vicende prendono vita. Non solo, per quanto all’interno della narrazione, eperfettamente amalgamata ad essa, assistiamo a descrizioni si popoli e culture, adigressioni storiche, a racconti mitologici. Se si conosce l’opera di Tolkien il motivo èevidente: Tolkien crea un vero e proprio mondo in cui egli è una sorta di Dio. Benlungi da manie di onnipotenza, tuttavia, egli si dilunga nel “Silmarillon”*10 neipassaggi della creazione del mondo e della nascita delle forze e dei popoli che logovernano.Tolkien arriva addirittura a concepire una lingua con una sua grammatica, una suasintassi e un suo lessico. È ovvio che di mondo del genere egli conosce ogni singolodettaglio e questo traspare ampiamente nella sua opera.Nella narrazione gestita secondo un unico punto di vista il narratore si sostituisce alprotagonista della vicenda e segue la vicenda come se il libro procedesse in primapersona. Niente di quello che accade al di fuori del protagonista viene a nostraconoscenza. Sebbene l’intero romanzo sia in terza persona tutto è filtrato attraversogli occhi del protagonista.L’esempio più celebre potrebbe essere il “de bello gallico” di Cesare in cui egli parla dise stesso in terza persona. Ma rimanendo agli autori citati in Stephen King si puòcitare “il Gioco di Gerald”, vissuto esclusivamente attraverso gli occhi dellaprotagonista (che di fatto è l’unico personaggio presente sulla scena) o per certi versisimile “Misery” dove il mondo viene visto attraverso gli occhi di Paul Sheldon. Quelloche passa nella mente di Annie, sebbene evidente vista la sua forte personalità, ècomunque filtrato attraverso le emozioni del protagonista. Ancora con Tolkien lo
Hobbit si svolge secondo il punto di vista di Bilbo e in pratica non siamo a conoscenzadi quello che accade al di fuori della sua presenza.Le implicazioni di questa tecnica sono notevoli, ma come detto, richiederebbero una
7/30/2019 Sulla Persona e Sul Tempo
http://slidepdf.com/reader/full/sulla-persona-e-sul-tempo 5/10
trattazione a parte. Basti dire che la maggior parte di romanzi moderni usa questasoluzione, riservandosi di variare di momento in momento il punto di vista delpersonaggio secondo le esigenze narrative. Esemplare è per citarne uno “Triplo” diKen Follett. Ma all’interno di uno stesso capitolo o paragrafo il narratore spesso variada punto di vista a punto di vista, giocando quasi come il narratore onnisciente*11,
ma limitando le sue potenzialità di momento in momento.A cavallo tra questo e l’ultimo tipo narrativo possono essere introdotti i gialli. AghataCrhistie gioca con Poirot in terza persona e tramite il suo punto di vista ci mostra lavicenda. Tuttavia i fatti vengono allo stesso tempo descritti dall’esterno. Poco ciimporta delle emozioni di Poirot e dei personaggi coinvolti, della loro interiorità o delleemozioni del momento. Il protagonista in questo caso è l’intreccio e la soluzione delcaso a partire dagli elementi oggettivi della vicenda è ciò a cui il romanzo tende.In dieci piccoli indiani questo è ancora più evidente, e questo esempio ci portaall’ultimo stile narrativo, quello dell’osservatore esterno.L’esempio più notevole sono le fiabe. La vicenda viene narrata così come accade.Siamo di fronte a una drammaturgia delle storia, in cui si comunicano sostanzialmente
immagini e dialoghi, o descrizioni di ambienti. È ovvio che siamo a conoscenza deisentimenti che può provare Biancaneve persa nel bosco e di quelli di Pollicino quandosi ritrova a tu per tu con l’orco, ma il narratore non si sofferma sull’interiorità dei due,né sul loro passato né sulle loro aspirazioni segrete. Quando lo fa è perché èessenziale allo svolgersi della vicenda. In Cenerentola per esempio sappiamo bene chelei ha dei sogni e delle aspirazioni, e in qualche modo la vicenda si svolge secondo ilsuo punto di vista e non certo quello della matrigna. Tuttavia la maggior parte diqueste informazioni vengono ricavate dal lettore (o ascoltatore, come accade ingenere) e il narratore non si sofferma sui percorsi emotivi di Cenerentola o delPrincipe frustrato che non riesce a trovarla. Le scene ci vengono descritte comeaccadono, poi è il lettore che trae le conseguenze.Questo tipo di narrazione, per il modo diretto con cui comunica informazioni èsicuramente il più indicato nella letteratura per ragazzi specie nelle fasce di età piùbasse. Tuttavia, e specie usato in porzioni di romanzo, ha i suoi risvolti pratici e puòservire per mandare avanti delle scene. Specie in quelle nelle quali si vuolesottolineare l’azione e tramite essa risalire eventualmente alle emozioni deipersonaggi*12.Questo tipo di narrazione può essere usata anche nella prima persona. Infatti sebbeneil narratore non può sapere con esattezza cosa passa nella mente delle persone che glistanno intorno, lo può dedurre dalle loro azioni, dalle loro espressioni, dal tono cheusano per parlare (come avviene al cinema o a teatro). Tramite queste informazioni èpossibile, infatti, comunicare anche il vissuto interno.
L’uso di più form e – quanto detto è vero in generale. Tuttavia spesso all’interno di unromanzo, specie di una certa lunghezza, è probabile che l’autore scelga di introdurrevari momenti narrativi che spezzano l’unità della narrazione stessa e consentono difocalizzare momenti diversi con tecniche differenti.Uno degli esempi più eclatanti è forse “Il drago volante” di Peter Straub. Qui lanarrazione avviene in terza persona sino a quanto, alcuni capitoli dopo l’introduzione,il narratore si rivela essere uno dei protagonisti che sin dal primo momento è statovisto sempre dall’esterno. In questo punto, e nei pochi in cui il narratore ricomparirà,la voce narrante è in prima persona, per poi passare alla terza per tutto il resto dellibro. Non di meno il narratore si concede le libertà del narratore onnisciente,introducendo situazioni alle quali non ha mai preso parte e altre ricostruite dal
racconto degli altri personaggi con i quali è a contatto.In qualche modo Graham*13 fa la stessa cosa che ha fatto Stoker con Dracula,raccogliendo testimonianze e riordinandole come narratore esterno. Lo stesso Graham
7/30/2019 Sulla Persona e Sul Tempo
http://slidepdf.com/reader/full/sulla-persona-e-sul-tempo 6/10
infatti la prima volta che appare come narratore tiene a sottolineare il fatto che moltevicende verranno ricostruite in base a come le ha comprese lui e che quello che diràdei protagonisti è una sua supposizione, non dandoci quindi la certezza che le cosesiano andate esattamente come le descrive.In IT di Stephen King la quasi totalità della narrazione è in terza persona. Esistono dei
momenti, tuttavia, nel quale l’autore introduce quelli che lui chiama “interludi” neiquali a parlare è Mike, uno dei sette ragazzi protagonisti, che inserisce delle parti delracconto in prima persona. Nello stesso romanzo esiste una lunga introduzione in cuila storia passa attraverso un interrogatorio. Qui la tecnica utilizzata è decisamentediversa da quella del resto del libro.Sempre in IT, verso la fine del libro, Bill sogna e il contenuto del sogno ci vienetrasmesso in seconda persona. All’interno di tutta l’opera, comunque, il punto di vistasi sposta più volte da un punto all’altro e da un protagonista all’altro*14, fornendoprospettiva diverse della stessa storia.Si è citato lo stesso Frankenstain, in cui una narrazione in prima persona si spostaverso la terza, in un certo modo, in quanto il narratore principale in realtà sta
parlando attraverso la voce di un personaggio che gli è estraneo, il quale a sua voltane introduce un altro. E questo sempre usando la prima persona.In conclusione, sebbene la scelta del punto di vista dal quale raccontare una storia èessenziale per scrivere anche solo la prima pagina dell’opera, è essenziale sapere chela narrazione non è un qualcosa di statico, ma può piegarsi alle diverse necessitàdell’autore che in definitiva deve comunicare informazioni ed emozioni. Il modo concui sceglie di farlo deve essere il più possibile vicino a quello che garantisce l’effettomigliore.
Note : *01 - Robinson nasce in un ambito del tutto particolare: siamo all'inizio del settecentoe si stanno gettando le basi dell'illuminismo, la nuova corrente di pensiero che ponel'ingegno umano come luce del mondo. Il romanzo vuole essere un diario -inizialmente spacciato per reale - in cui si mette in evidenza il modo in cui un uomo èin grado di gestire la propria vita modificando l'ambiente circostante (ostile e privo diogni mezzo della vita a cui Robinson era abiutato). La narrazione in prima persona inquesto caso è obbligatoria: deve sembrare il racconto di chi ha vissuto realmente inun isola deserta dopo un naufragio.*02 - Ma non necessariamente, come in Arthur Conan Doyle dove nelle avventure diSherlok Holmes è Watson a narrare la storia.*03 - In genere si sottolineano le emozioni dei personaggi in chiave drammatica: leloro emozioni si intuiscono da come agiscono e da quello che fanno (cfr. nota 9).*04 - Una narrazione in terza persona presenterebbe la scena in maniera più neutrale.Qui l'intento è invece confondere il lettore e gettarlo nel buio più totale.*05 - In un racconto di Stephen King è Watson che ci racconta il caso e che alla finearriva alla soluzione. L'idea è quella di mostrare il percorso che generalmente segueHolmes e di illustrare il momento chiave in cui tutti i tasselli del mosaico raggiungonoil loro posto e la soluzione del caso appare evidente. L'effetto suscitato è decisamentenotevole.*06 - In "Ulisse" di Joyce, per esempio, la chiusura del libro è data da un flussocontinuo di pensieri che escono fuori dalla testa della protagonista. Lo stream of consciousness, questo genere di tecnica tipica di vari autori di inzio novecento (comeper esempio la Woolf), tuttavia non è esclusivo della prima persona.
*07 - "Bright lights, big city", nell'originale.*08 - Volume II, capitolo 5.*09 - Questo in generale è vero per qualunque narrazione, in quanto si suppone che
7/30/2019 Sulla Persona e Sul Tempo
http://slidepdf.com/reader/full/sulla-persona-e-sul-tempo 7/10
l'autore comunque conosca ogni aspetto e dettaglio della storia che crea. Tuttaviacosa egli racconti al suo pubblico è altra cosa. È probabile che Verne avesse dellerisposte certe alla fine di "Ventimila leghe sotto i mari" e che egli sapesse esattamenteciò che invece nel romanzo rimane in sospeso. Tuttavia il lettore sa solo quello che c'èscritto e questo è l'elemento chiave che distingue i vari tipi di narrazione.
*10 - Libro che introduce le vicende del Signore degli Anelli, sebbene sia il terzo diun'ipotetica trilogia insieme a "Lo Hobbit"*11 - Il limite tra queste due forme, in molti caso, è assolutamente sfumato eartificioso.*12 - Un uomo che scaglia un bicchiere contro il muro, urlando, per esempio èestremamente indicativo di una persona adirata. Lo si capisce anche senza bisogno discrivere "tizio era adirato". Anzi spesso il lettore preferisce capire quello che accadesenza che gli venga detto esplicitamente. Buona parte del lavoro di uno scrittore sibasa su questo concetto. Il lettore non è stupido, non c'è bisogno di spiegare tuttoquello che avviene.*13 - La voce narrante.
*14 - L'introduzione dei personaggi all'inizio del libro è paradigmatica. Ci vengonosvelati non solo le caratteristiche della vita presente dei personaggi, delineandone conchiarezza caratteristiche e personalità, per quanto anche le vicende passate vengonovissute da differenti punti di vista pur narrando porzioni di storia che in qualche modosi sovrappongono.
7/30/2019 Sulla Persona e Sul Tempo
http://slidepdf.com/reader/full/sulla-persona-e-sul-tempo 8/10
Pa r t e I I
Esiste un momento, nella storia di un libro, in cui il narratore si trova a prendere una decisione importante, che non potr à più var iare e che deve necessariamente segnare il procedere dell’opera. Dall’inizio sino alla sospirata parola “fine”.
Per essere precisi è l’apertura stessa del libro che condiziona una variabile essenziale,e ogni scelta qui fatta deve essere razionale, certa, e precisa.
In verità la scelta del verbo è spesso implicita nell’idea stessa del romanzo. La chiave di lettura passa attraverso questa decisione e spesso l’autore ne è consapevole sin dal prim o istante. I n genere è la frase di apertura che condiziona il racconto, m a anche
qui esistono le debite eccezioni che come tale non possono essere ignorate.
Su l tem po
Esiste un secondo parametro che bisogna considerare scrivendo un libro e che anchein questo caso è plastico e può essere introdotto in momenti diversi del romanzo in
base alle esigenze narrative e alla struttura che si sta costruendo.Anche in questo caso ogni singola voce meriterebbe una trattazione autonoma, ma èopportuno conoscere l’effetto che ciascun tempo verbale provoca nel lettore e qual èla scelta più ragionata da usare nella costruzione della linea temporale della storia.Il verbo può essere usato secondo le varie coniugazioni del tempo indicativo, in lineadi principio, e ciascuna di essa può essere predominante in tutto il corso del romanzo,dando un’impronta particolare che genera ritmi, tempi, sensazioni e atmosfere.In linea di principio vale la prima regola che viene insegna quando si impara a scriverequalcosa: per tutta la durata dell’azione, il tempo deve essere sempre lo stesso. Nonsi può iniziare al presente e concludere al passato. È un errore e non ammettegiustificazioni.Presente – il tempo presente da l’idea di qualcosa che sta accadendo nel momento incui si svolge la narrazione. È in genere il più usato dagli americani nel raccontoverbale (in Italia generalmente quando raccontiamo qualcosa che ci riguarda usiamosempre il passato) e introduce l’ascoltatore direttamente sul luogo dell’azione. Spessoè schematico, quindi, da informazioni dirette e da un coinvolgimento del tuttoparticolare: la vicenda si sta svolgendo in quel preciso momento, non esiste unaconclusione certa e tutto può accadere.È un tempo verbale di forte impatto e di grande atmosfera. Ottimo per creare tensionee per aumentare il senso di identificazione del lettore. Può essere usato sia in primache in seconda e in terza persona, sebbene l’effetto drammatico è enfatizzato dallaprima persona. In terza può creare un’atmosfera nostalgica, malinconica. È in linea diprincipio l’unico tempo ammesso nella seconda persona*1.Può tuttavia essere stancante e non garantisce la plasticità e la sicurezza che offreinvece la narrazione al passato.Esempi notevoli: “Il senso di Smilla per la neve” di Peter Høeg, in cui la vicenda riescead andare avanti per oltre quattrocento pagine senza perdere interesse. Lesceneggiature cinematografiche (che in realtà sono un modello letterario a parte) incui la drammaticità*2 è espressa al massimo livello in quanto il contenuto dellasceneggiatura è anche quello che si vedrà nel film. Niente di più e niente di meno.Il reportage, sia in forma scritta che in formato audiovideo.Passato Prossimo – è il tempo in cui generalmente in Italia si gestisce la narrazionevocale nella vita di tutti i giorni (a parte alcune regioni in cui è più utilizzato il passatoremoto). Nella sua forma scritta è usato spesso in romanzi di giovani autori specie
italiani, riguardo a vicende personali, spesso di adolescenti. La sua cadenza, infatti,consente una forte forma riflessiva e di atmosfera. Ci introduce in qualche modo nellasfera affettiva dei protagonisti e ci da un senso di incompletezza.
7/30/2019 Sulla Persona e Sul Tempo
http://slidepdf.com/reader/full/sulla-persona-e-sul-tempo 9/10
La storia cioè può evolvere, non necessariamente è stata scritta. È una storia recente,e probabilmente i personaggi ne sono ancora fortemente influenzati. Usata inquest’ottica ha generalmente bisogno della terza persona. “Rosa ha passato una giornata d’inferno. Sua madre ha detto a Gianni che non potràandare al concerto quella sera. Seduta sul suo letto guarda*3 le foglie che cadono.
Ieri Antonio le ha detto che se vanno al cinema è okay. È stata una cosa buona, ma[…]” Nella narrazione in prima persona ci fornisce un impatto emotivo interessante, specienella caratterizzazione di un personaggio romantico e in storie di mistero. Questo èvero soprattutto in abbinamento con il trapassato prossimo. Descrive in partel’ambiente e le abitudini del personaggio. Esempio di questa forma narrativa sono imonologhi che introducono alcune delle storie di E. A. Poe, alcune storie di Lovecraft evia dicendo.Imperfetto – L’imperfetto è il tempo dell’introspezione psicologica del personaggio.Specie in terza persona da un aria di malinconia e di studio. Indica qualcosa cheavviene abitudinariamente. Crea atmosfera e da un senso dilatato del tempo. Ciò che
è detto si trascina oltre l’unità temporale.È un tempo di stato. Le cose sono così e non muteranno, almeno sino a quando nonavviene qualcosa di particolare.Un esempio notevole è Eveline di James Joyce*4, in cui la malinconia della figura dellaragazza e la staticità iniziale del suo personaggio si contrappone al forte iter emotivoche la muove dentro. L’imperfetto è anche il tempo del ricordo, infatti. Le coseandavano così, e probabilmente vanno tutt’ora in questa direzione.È utile anche per sottolineare grandi passaggi temporali. Il romanzo, o il racconto, nonnecessariamente deve descrivere ogni momento, anzi la dilatazione, la contrazione, eil salto del tempo e della linea temporale sono una delle caratteristiche principali dellaparola scritta e del racconto. Un ampio intervallo di tempo può essere racchiuso indescrizioni all’imperfetto di un qualcosa che si ripeteva costantemente in quella fasedella storia. Un esempio può essere “La mia Africa” di Karen Blixen dove la maggiorparte della narrazione si basa su avvenimenti che avvenivano di routine e soloraramente si sofferma su episodi isolati e su storie con introduzione, sviluppo econclusione. E tuttavia il romanzo della Blixen racchiude un tempo di oltre dieci anni.In prima persona, specie con l’uso del trapassato prossimo, è utile nella costruzione distorie romantiche e gotiche.Trapassato prossimo – Di particolare effetto nelle storie gotiche e romantiche. “Erosolito recarmi in tale posto, con il calare delle tenebre. A quel tempo il maniero erastato affittato da una nobile famiglia inglese che passava parte del tempo, etc, etc. Ioero terrorizzato dall’idea di poter rimanere solo anche per un minuto, etc. etc. ancheperché era possibile che, etc. etc. ”. Generalmente però il verbo portante è sempre ilpassato remoto, raramente il passato prossimo.Si utilizza in particolare per sottolineare azioni e stati d’animo, specie alla primapersona. In terza persona sposta la linea temporale più indietro di quella in corso nellastoria per il tempo imperfetto. Se uso in pratica l’imperfetto per sottolineare l’anno2000, se nella stessa linea narrativa mi riferisco al 1980 devo usare il trapassato.Può essere inoltre introduttivo: “Era stata una giornata afosa, e i bambini avevanogiocato tutta la mattina […] tizio scese le scale […].” Passato remoto – è il verbo principe con i quali i racconti sono concepiti. È il piùplastico e malleabile, si riferisce ad eventi passati (la storia in genere la si raccontaperché è accaduta nel passato e ora è conclusa, sia che abbia strascichi nel presente omeno), e indica un’azione specifica. “Chiuse la porta”, “Guardai dalla finestra”, “Dissi
queste parole”, etc.L’azione finisce con il verbo e indica progressione nella narrazione. Generalmente èindicativo di azione.
7/30/2019 Sulla Persona e Sul Tempo
http://slidepdf.com/reader/full/sulla-persona-e-sul-tempo 10/10
Trapassato rem oto – sposta l’azione narrativa su una linea temporale precedente aquella principale. Crea una sensazione di premessa e di causa alla quale devesuccedere un effetto. È generalmente implicito nell’uso di questo verbo che le coseche vengono narrate hanno un risvolto o un impatto nella storia presente (intesocome presente la linea narrativa che si sta portando avanti).
Può essere usato nel flash-back, ma non è obbligatorio*5.Futu ro sem plice – L’uso è sostanzialmente limitato e si usa solo quando la lineatemporale portante è al presente*6. Può essere usato da solo con la seconda personaper aumentare l’effetto drammatico (il già citato Nortghager Abbey della Austin) onell’anticipazione, dove tuttavia si preferisce il condizionale passato : “quella sarebbestata l’ultima volta che lo avrebbe visto”, “Jenny sarebbe andata a lavoro anche quellamattina”, “ci sarebbero stati giorni migliori”.Può esprimere ineluttabilità, arresa nei confronti del destino, attesa: “Johnny sa cheandrà sempre così”, “Che cosa accadrà adesso?”, “Ci dovrà essere per forza una viad’uscita”.L’uso come tempo portante si può avere in una profezia.
Futuro Anteriore – Sposta indietro la linea narrativa futura. Come tale è improbabiletrovarlo come tempo verbale portante di una storia.
Chiaramente, a conclusione di questo discorso, c’è da sottolineare che le lineetemporali in cui ci si muove sono essenzialmente due: presente o passato. Sono lorol’elemento portante della narrazione e in base ad essi ci si muove.L’uso dei diversi tempi verbali aiuta a definire sfumature e sottolineare passaggi. Èinfatti improbabile che un racconto possa essere scritto interamente all’imperfetto*7 oal futuro.L’importanza tuttavia dell’effetto che l’uso del verbo sarà in grado di suscitare èfondamentale per la costruzione di una storia. È il verbo infatti l’elemento portanteattorno a cui ruota la frase, ed è lui che definisce gli eventi e ciò che accade. La storia,appunto.
Note : *1 - Con le dovute, ovvie, eccezioni.*2 - Intesa nel senso di “azione”.*3 - Nell’esempio la linea temporale principale è al presente. È ovvio tuttavia che lostare seduta a letto è una situazione statica che non avrà alcuno sviluppo. Lanarrazione riguarda le vicende sino a quel momento e ha come tempo portante ilpassato prossimo.*4 - Curioso notare che in inglese l’imperfetto non esiste e che la storia è narrata al “Past Tens”, il passato semplice.*5 - Il flash-back può essere gestito anche con la dominanza di un altro dei tempiverbali. Compreso il presente, che spesso, anzi, crea una frattura netta tra la lineanarrativa principale al passato e il rimando al passato, aumentando l’effettodrammatico.*6 - Per regola grammaticale. Se la storia è al passato si deve usare il condizionaleper esprimere futuro.*7 - In realtà alcuni tipi di narrazione lo usano come tempo portante. Per esempio unrapporto ufficiale in genere è all’imperfetto “il paziente si mostrava disidratato e nonera in grado di rispondere alle domande del medico”, “Il signor Rossi urtava con l’autola moto del Signor Bianchi e provocava danni…”. Nel già citato Eveline è l’imperfetto iltempo principale.
I bambini quando giocano usano generalmente l’imperfetto per descrivere l’azione chestanno portando avanti: “Adesso tu eri un poliziotto che mi dava la caccia e poi io tiraggiungevo e ti sparavo e tu morivi.”