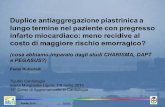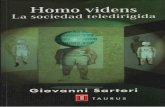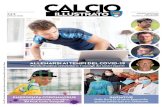SPECIALE CATECHESI 223 prima parte Atti · p. 22 CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI ... i segni dà una...
Transcript of SPECIALE CATECHESI 223 prima parte Atti · p. 22 CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI ... i segni dà una...
Speciale Catechesi 1
COLLEGAMENTO PASTORALE
Poste Italiane s.p.a. – Spedizione in a.p. – D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n° 46) art.1, comma 2, DCB Vicenza
Vicenza, 12 dicembre 2011 Anno XLIII n. 17
SOMMARIO
p. 2 PRESENTAZIONE
p. 4 RELAZIONE BIBLICA (Prof.ssa A. ANGHIGNONI)
p. 12 INTERVENTO TEOLOGICO (Mons. L. BORDIGNON)
p. 20 INCONTRO PER CAP, GRUPPI BIBLICI…
p. 21 INCONTRO DI CATECHESI FAMILIARE
p. 22 CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI
Periodico mensile degli uffici pastorali diocesani – Autorizzazione trib. di Vicenza n. 237 del 12/03/1969 – Senza pubblicità – Direttore respons. Bernardo Pornaro – Ciclostilato in proprio – Via Vescovado, 1 – Vicenza – Tiratura inferiore alle 20.000 copie.
Speciale Catechesi 2
Presentazione… di don A. Bollin
Vi consegno, care/i catechiste/i e operatori pastorali, gli Atti del nostro 35° Convegno diocesano.
Ringrazio fraternamente la parrocchia di Sandrigo che nei giorni 9-10-11 settembre u.s. ci ha accolto, come pure tutte/i le/i catechiste/i del Vicariato e i relatori e gli animatori dei laboratori del sabato pomeriggio.
Esprimo una viva riconoscenza alla Caritas diocesana, a don Giovanni Sandonà e a don Giovanni Cecchetto con cui abbiamo fatto un buon cammino assieme e organizzato il Convegno. Sono grato a quante hanno dedicato tempo e passione per rivedere gli interventi e i materiali. Faccio mie le parole dell’apostolo di Tarso ai cristiani di Filippi: “Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo … Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù”(Fil 1,3-6).
Il TEMA DEL CONVEGNO IN CONTINUITA’ CON QUELLO DEL 2010 Il tema del nostro Convegno si colloca nel solco e nell’orizzonte della scelta dell’educare, espressa dagli Orientamenti pastorali CEI 2010-2020 e si pone in continuità con la tematica sviluppata nel 2010: “Educazione ed evangelizzazione: un binomio chiave per la proposta del Vangelo oggi” [Cf. Educazione e catechesi, in “Catechesi” 80(2010-2011)4, 10-65]. Il Convegno dei catechisti dello scorso anno ci ha offerto una linea interpretativa per comprenderli e avviarne una applicazione catechistica: tutto si gioca sul binomio evangelizzazione ed educazione, per cui si è concluso - con una felice sintesi del DGC n° 147 - che si evangelizza educando e si educa evangelizzando. Solo mettendo insieme le forze di chi o tra chi ha la passione e compiti educativi si può vincere la sfida educativa e trasformarla in “avventura”; e la catechesi si conferma il cuore della missione educativa della Chiesa. Nel decennio dedicato al rilancio dell’educazione, dopo una visione d’insieme, l’attenzione si è volutamente posata sulle persone con disabilità e le loro famiglie: sono gli ultimi del Vangelo, i primi agli occhi del Signore, chi incontra e serve loro serve e ama il Signore (cf. Mt 25,31-46); una Chiesa che li accoglie e li ama è veramente evangelica. Gli Orientamenti pastorali “Educare alla vita buona del Vangelo” portano l’attenzione su di loro in almeno tre passaggi (cf. nn° 36-38-54), invitando le comunità cristiane a prendersi cura di loro, ad essere vicine alle famiglie segnate da disabilità, ad accompagnarli nei cammini di iniziazione alla vita cristiana: esse/i sono nel cuore e al centro della Chiesa. Non è stato difficile - allora - individuare il tema e trovare lo slogan per il 35° Convegno catechistico: “Nonposso dire Gesù, ma lo amo!” Le persone con disabilità e l’annuncio del Vangelo. Si è valorizzata una espressione forte e incisiva di Jean Vanier ( canadese, classe 1928, fondatore della comunità dell’Arca). Il convegno di quest’anno ha avuto poi una forte valenza unitiva. Attualmente nelle nostre parrocchie si segue una pluralità di modelli di catechesi, di sussidi vari e di metodi spesso così differenti che si fatica anche tra catechiste della stessa zona pastorale trovare momenti comuni, di incontro e di condivisione. Occorre individuare un tema unificatore dell’esperienza catechistica. Ebbene, il convegno e la tematica di quest’anno hanno svolto e svolgono questa funzione unitiva: in esso tutti possono convergere e si può manifestare la comunione tra coloro che condividono la passione per l’annuncio del Vangelo.
LE GIORNATE DEL CONVEGNO NEGLI ATTI Venerdì ci si è mossi dal fondamento biblico (con la prof.ssa A. Anghignoni): cosa dice e insegna la Bibbia a proposito delle persone con disabilità, della sofferenza umana … come si è comportato Gesù, come li ha avvicinati, cosa ha fatto per loro? Gesù – secondo l’evangelo di Giovanni – con i miracoli, i segni dà una duplice guarigione: fisica e interiore, nell’umanità e nella luce del credere. Poi Gesù vive la domanda sul perché della sofferenza, carica su di sé tutte le sofferenze, perché nessuno sulla terra possa sentirsi solo quando soffre: Egli è il Dio con noi.
Mentre nella serata il film di Pupi Avati “una sconfinata giovinezza” (del 2010) ci ha fatto pensare – sotto la guida esperta del prof. O. Brugnoli – soprattutto con la figura del cane che si chiamava “perché”. La mattinata di sabato è stata aperta con la riflessione teologica di don L. Bordignon: Quale comunità ecclesiale? Cosa significa comunità “grembo”? Come la Chiesa vede – accoglie – accompagna questi fratelli e sorelle? Cosa dovrebbe fare per dirsi comunità evangelica? E’ seguita la forte e commovente testimonianza della dott.ssa R. Sartori sul tema “Nella comunità il limite diventa ricchezza”. Infine, tramite i laboratori di sabato pomeriggio (diretti da Francesca Gasparotto e Silva Stefanutti), in cui è stato dato spazio alla dimensione metodologica, ci è stato indicato – seguendo le diverse disabilità – come approcciarsi e
Speciale Catechesi 3
proporre il Vangelo e fare sentire parte viva della Chiesa chi è disabile. E a conclusione del Convegno la commissione per la catechesi ha pensato e preparato un decalogo per incoraggiare i catechisti a proseguire il cammino; la cartolina è stata donata a tutti al termine della S. Messa di domenica presieduta dal Vescovo Beniamino: “Il decalogo del catechista … per una diaconia del cuore”.Tutto questo viene raccolto negli Atti (di cui si pubblica la 1a parte).
LE/I CATECHISTE/I, UNA “PRESENZA ACCANTO” Le/i catechiste/i - ne sono certo e il convegno 2011 ci ha offerto sollecitazioni, proposte, orientamenti condivisi – vogliono e si impegnano ad essere sempre di più una “presenza accanto” alle persone , ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie: una presenza discreta e amica, una presenza credente e convinta, una presenza d’amore e fraterna, una presenza condivisa con la Caritas, per manifestare il vero volto della Chiesa oggi. Si racconta che Rabbi Abraham Yeshaya Karelitz si alzava sempre solennemente in piedi in presenza di una persona affetta da sindrome di Down: “Se l’Eterno aveva privato costui della capacità di studiare a fondo la Torah – diceva – il motivo è che egli è già abbastanza perfetto ai suoi occhi” [F. Hadjadj, Mistica della carne, 2009].
Buona lettura.
Antonio Bollin Direttore
A tutte/i le/i catechiste/i e a quanti in vario modo sono impegnati nell’annuncio del Vangelo, presento – a nome mio, di Igino e di Paola, dei Collaboratori dell’Ufficio e del gruppo redazionale – l’augurio di un Santo Natale e di Buon Anno Nuovo con un pensiero di Papa Paolo VI:
“Cercate e trovate nel vangelo, nella buona novella annunciata per il Natale, ciò che è indispensabile alla prosperità e alla pace dell’umanità”
(dal Messaggio natalizio del 1965). Estendete questo fraterno augurio alle vostre famiglie e ai ragazzi che accompagnate nel cammino di fede. Vi ricordo nella preghiera e invoco su tutte/i voi la benedizione del Bambino Gesù.
Don Antonio Bollin
In copertina: Domenico Ghirlandaio, Natività, 1485
Speciale Catechesi 4
Salmi storici Il Sal 78 è la voce di un maestro: esso è in larga parte in stile narrativo, il racconto della storia di come il Signore si è comportato con Israele. Da questo punto di vista somiglia ai Salmi 105, 106 e 136, un gruppo che è spesso classificato con l’etichetta “Salmi storici”. Questi salmi recitano tutti una versione della storia che narra le origini più remote d’Israele, quella che si legge nella Bibbia dal Libro della Genesi ai Libri di Samuele, cioè da Abramo a Davide. Tuttavia ciascuna versione si dimostra selettiva e distintiva. La peculiarità di ciascuna versione deriva dallo scopo del suo racconto specifico. Ogni racconto è composto per trarre una lezione dalla tradizione. Questi salmi sono didascalici nel senso più ampio del termine. Lo stile scelto da ciascuno per presentare la propria storia può variare dalla Torah all’inno alla preghiera, fermo restando lo scopo centrale: informare, correggere, alimentare la fede della comunità in seno alla quale ciascuno veniva eseguito. Questi salmi sono interessati al passato e alla sua attinenza con il presente e il futuro. Il passato è quello ricordato, non quello ricercato, cioè come il Gesù dei vangeli che è il Gesù ricordato, non quello ricercato. Eventi vissuti concretamente e raccontati come interazioni del Dio d’Israele con la volontà e il comportamento d’Israele. Per questi salmisti l’azione e la volontà di Dio sono elementi essenziali della realtà. Qualsiasi racconto dell’esperienza passata che escludesse Dio quale protagonista sarebbe stato riduttivo e irrilevante.
RELAZIONE BIBLICA
RELAZIONE 1a parte: CUSTODITI DAL SIGNORE COME SUA PUPILLA (Dt 32,10)
Porgi l’orecchio al mio insegnamento
Il catechista è colui che deve insegnare le cose di Dio. Vediamo, allora, prima di tutto come Dio insegna al suo popolo.“Porgi l’orecchio al mio insegnamento” (Sal 78,1). Vogliamo guardare insieme come Dio educa il suo popolo: la nostra è una tensione verso di lui. Cominciamo con il salmo 78, dove c’è la storia d’Israele che ogni catechista dovrebbe conoscere. Infatti Gesù ha scelto quel popolo, si è incarnato in quel popolo, con quella lingua e in quella terra. Quindi non possiamo spiegare Gesù se non conosciamo il suo popolo, se non conosciamo la sua mamma, che era ebrea. Il salmo è la preghiera d’Israele di ieri ed è la preghiera della Chiesa di oggi, ma è stata anche la preghiera di Gesù. Il salmo è la preghiera per eccellenza, la preghiera universale. Sono parole antiche, parole difficili: è Dio che ti insegna come parlare con lui, come chiedergli le cose. È vero che ci sono anche salmi addirittura imprecatori, che non sono inseriti nel salterio perché sono violenti. Ora si è capito lo scopo di questo tipo di salmi: colui che li pronuncia si sfoga così con Dio e non si ammala, perché consiglia a Dio come vendicarlo. E Dio si vendica, ma a modo suo. Dio ci chiede un orecchio attento (Shema Israel, Ascolta Israele!).Questo salmo incomincia proprio così: “Porgil’orecchio, popolo mio, porgi l’orecchio al mio insegnamento, ascolta le parole della mia bocca”. Noi abbiamo bisogno di ascoltare con l’orecchio e sentire la Parola di Dio. Per gli ebrei l’ascolto è un sentire e buttare nella pancia, è un comprendere. Oggi il termine più vicino è empatia. Dio non ti chiede solo di sentire, ti chiede di ascoltare, che è molto più impegnativo. Se ascoltiamo veramente una persona, ci stanchiamo molto, perché veniamo coinvolti emotivamente. Colui che ti parla, infatti, ti consegna la sua vita e la sua sofferenza. E questo tipo di ascolto stanca molto.“Aprirò la mia bocca in parabole, rievocherò gli arcani dei tempi antichi. Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai loro figli; diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che egli ha compiuto”. (Sal 78,2-4) Basterebbe questo versetto per dire chi dovrebbe essere il catechista e in realtà ogni cristiano.
IL RACCONTARE… Il racconto è fondamentale nella Bibbia: il verbo raccontare attraversa l’Antico e il Nuovo Testamento. Come Gesù anche i rabbini insegnavano con le parabole, che sono racconti. Le
Speciale Catechesi 5
parabole di Gesù, come le parabole dell’Antico Testamento, sono vere ieri, oggi e domani, perché superano il dato storico per assumere una valenza superiore: la valenza esemplificativa. Per esempio nella parabola del seminatore non si parla di questo e quel seminatore, ma dell’atteggiamento che tutti i seminatori di ogni epoca hanno nell’azione del seminatore. Le parabole valgono per tutti gli uomini e per tutti i tempi. Le parabole sono un tipo di racconto e Gesù raccontava le parabole, raccontava e spiegava la Sacra Scrittura. Ad Emmaus, per esempio, ha spiegato ai discepoli tutti i passi delle Scritture che lo riguardavano, mostrando così che la Parola di Dio si era realizzata. Questo è un messaggio di speranza. Anche la Nuova Evangelizzazione va fatta con lo stesso stile, cioè narrando alle persone le meraviglie di Dio, in questo modo esse superano lo scoraggiamento, oggi così pregnante e si aprono alla Speranza. Lodare il Signore per le sue meraviglie diventa così balsamo, potenza d’amore, forza fisica per la nostra anima.
RACCONTARE PER NON DIMENTICARE LE MERAVIGLIE DI DIO “Ha stabilito una testimonianza in Giacobbe, ha posto una legge in Israele: ha comandato ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, perché le sappia la generazione futura, i figli che nasceranno. Anch’essi sorgeranno a raccontarlo ai loro figli perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma osservino i suoi comandi. Non siano come i loro padri, generazione ribelle e ostinata, generazione dal cuore incostante e dallo spirito infedele a Dio.”(78,5-8) Leggendo queste pagine noi diciamo che nel mondo ebreo c’era tanta violenza e che gli ebrei erano incostanti e infedeli. Però, dobbiamo stare attenti a giudicare, perché anche noi siamo uomini con i nostri difetti. “Non siano come i loro padri generazione ribelle e ostinata, generazione dal cuore incostante e dallo spirito infedele a Dio. I figli di Efraim, valenti tiratori d’arco, voltarono le spalle nel giorno della lotta, non osservarono l’alleanza di Dio, rifiutando di seguire la sua legge. Dimenticarono le sue opere, le meraviglie che aveva loro mostrato. Aveva fatto prodigi davanti ai loro padri, nel paese d’Egitto, nei campi di Tanis. Divise il mare e li fece passare e fermò le acque come un argine. Li guidò con una nube di giorno e tutta la notte con un bagliore di fuoco. Spaccò le rocce nel deserto e diede loro da bere come dal grande abisso. Fece sgorgare ruscelli dalla rupe e scorrere l’acqua a torrenti”. (Sal 78, 5-16) Dio ha continuato a fare meraviglie e queste sono raccontate in questo salmo, perché il popolo non le dimentichi. Quando il popolo è infedele Dio si arrabbia. Se Dio si arrabbia come può Israele stare davanti a Dio? Non può! Che cosa fa Dio allora? Dio perdona.
Speciale Catechesi 6
CHE COS’E IL PERDONO? Il perdono è lo spazio di vita che Dio permette di nuovo e che dà al suo popolo. Se non c’è più relazione, non c’è più spazio in cui giocare la vita. Il perdono è lo spazio che Dio ridà al suo popolo per potergli stare davanti, per poter avere una relazione con lui. Allora ecco il racconto di tutte le cadute d’Israele e di tutti i lamenti del popolo, che ha ricevuto tantissimo da Dio, ma ha continuato a peccare contro di lui. “Eppure continuarono a peccare contro di lui a ribellarsi all’Altissimo nel deserto. Nel loro cuore tentarono Dio, chiedendo cibo per le loro brame; mormorarono contro Dio dicendo: «Potrà forse Dio preparare una mensa nel deserto?» Ecco, egli percosse la rupe e ne scaturì acqua, e strariparono torrenti. «Potrà forse dare anche pane e preparare carne al suo popolo?» All’udirli il Signore ne fu adirato; un fuoco divampò contro Giacobbe e l’ira esplose contro Israele, perché non ebbero fede in Dio nè speranza nella sua salvezza” (78,17-22) Questo salmo è antichissimo, eppure quanto lo possiamo sentire davvero nostro!
FECE PIOVERE SU DI ESSI LA MANNA COME CIBO“Comandò alle nubi dall’alto e aprì le porte del cielo; fece piovere su di essi la manna per cibo”(Sal78,23-24)Che cosa fa Dio? Dà al popolo una dieta differenziata: manna alla mattina e quaglie alla sera, così non si ammalano. C’è una storia ebraica che dice che col cibo di Dio non avevano bisogno di andare in bagno, non c’era niente da espellere, non c’era niente in più, perchè tutto veniva reso vita. Di tutto ciò che ti dà Dio non si butta via niente, perché tutto viene trasformato in vita, vita buona, vita bella, vita con Dio.“L’uomo mangiò il pane degli angeli, diede loro cibo in abbondanza. Su di essi fece piovere la carne come polvere e gli uccelli come sabbia del mare; Mangiarono e furono ben sazi, li soddisfece nel loro desiderio. La loro avidità non era ancora saziata, avevano ancora il cibo in bocca, quando l’ira di Dio si alzò contro di essi, Quando li faceva perire, lo cercavano, ritornavano e ancora si volgevano a Dio; ricordavano che Dio è loro rupe, e Dio, l’Altissimo, il loro salvatore; non erano fedeli alla sua alleanza. Lo lusingavano con la bocca e gli mentivano con la lingua; il loro cuore non era sincero con lui e non erano fedeli alla sua alleanza”. (Sal 78,25-37)
DIO PERDONA FIDANDOSI DEL PECCATORE “Ed egli pietoso perdonava la colpa, li perdonava invece di distruggerli”. Qui si può riassumere tutta la storia d’Israele, storia d’infedeltà e di continue riprese. Quando perdona, Dio rilancia, fa una nuova proposta, crea all’infedele uno spazio in cui gli dà una cosa ancora più grande. Nel salmo 78 è raccontata tutta la storia d’Israele: è il momento di massima educazione di Dio. Questa
Speciale Catechesi 7
educazione avviene nel deserto, il luogo senza parole. Nel luogo dove non ci sono le parole degli altri, possiamo sentire la parola di Dio.
L’AZIONE EDUCATIVA DI DIO NEL DEUTERONOMIO
Legge predicata, Legge profeticaIl Deuteronomio si presenta come un libro dell’alleanza, ossia come un documento del patto fra Dio e Israele. La condizione posta a Israele per entrare in possesso della terra è l’obbedienza alla legge ricevuta sul Sinai. L’epilogo (Dt 31,1 – 34,12) riguarda la scelta di un successore di Mosè nella persona di Giosuè. Segue il racconto della morte di Mosè sul monte Nebo, senza che egli possa entrare nella terra promessa. Il cantico di Mosè è una rivisitazione della storia d’Israele in bilico fra la giustizia di Dio, la sua misericordia e le benedizioni di Mosè alle tribù d’Israele, che fanno apparire quest’uomo di Dio come l’ultimo e il più grande dei padri d’Israele, e presentano il Deuteronomio, nella redazione finale, come il suo testamento spirituale. Oltre che legge predicata, potremmo dire che il Deuteronomio è una Legge profetica, per il carattere umanitario delle sue prescrizioni e per la sua preoccupazione di proteggere le categorie sociali più indifese, come l’orfano, la vedova, lo straniero, il levita, la donna. Questo passo esprime una costante della Scrittura: è Dio il grande educatore del suo popolo. Il castigo più terribile che potrebbe colpire gli uomini della Bibbia non è quello di punizioni particolari, ma di sentirsi abbandonati da questa guida amorevole, sapiente e instancabile. L’azione educativa comporta dei momenti di rottura col passato (l’uscita dalla terra deserta); si compie attraverso una crescita progressiva, propiziata da gesti di attenzione e di amore (lo educò, ne ebbe cura, lo custodì); comporta una partnership e una elevazione profonda dello spirito (lo sollevò sulle sue ali); esige una fiducia assoluta e incondizionata (il Signore lo guidò da solo, non c’era con lui alcun Dio straniero).
DEUTERONOMIO CAPITOLO 32: IL RIB Vediamo ora il capitolo 32 del Deuteronomio, che è una sorta di salmo di genere letterario chiamato in ebraico Rib. Che cos’è il Rib?Il Rib è una modalità ebraica per risolvere le liti senza andare in tribunale. La parte lesa si rivolge al colpevole e avendolo già perdonato, cerca di convincerlo del suo errore. Infatti sa che chi fa il male in realtà fa male a se stesso e si autocondanna. Il colpevole, a questo punto, deve smettere di fare del male a sé e agli altri. Non si cerca risposta al proprio problema, ma si tenta di ricondurre l’ingiusto sulla via della giustizia. La confessione della colpa diventa accettazione del perdono già offerto. Il Rib è il modo in cui l’uomo può rispondere al male nella storia usando le categorie di giustizia di Dio. Nel Vangelo di Matteo Gesù dice: “Se hai una disputa con tuo fratello vai e parlagli in segreto”. Gesù suggerisce di richiamare il fratello senza portarlo in tribunale, ma ricorrendo al Rib. Gesù per tutta la vita ha fatto il Rib a noi uomini, ci ha chiamato e richiamato esortandoci a non fare il male.
Prendiamo il libro del Deuteronomio. In questo canto 32 del Deuteronomio, composto secondo le diverse opinioni degli studiosi tra il 3° e il 6° secolo, i copisti hanno introdotto delle tracce che sembrano tardive, forse soltanto delle aggiunte, soprattutto l’arcaicità è attestata da espressioni di una corporeità eccessiva. Questo brano è molto corporeo, come molte parti della Bibbia sono molto sensibili, parlano della corporeità, perché tutte le relazioni con Dio passano attraverso il nostro corpo.
Leggiamo Deuteronomio cap. 32,1-4 “Ascoltate, o cieli: io voglio parlare: stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire; come scroscio sull’erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano. Voglio proclamare il nome del Signore: date gloria al nostro Dio!
Speciale Catechesi 8
Egli è la Roccia; perfetta è l’opera sua; tutte le sue vie sono giustizia; è un Dio verace e senza malizia; Egli è giusto e retto” Qui siamo nel discorso di Mosè morente. Le ultime parole di una persona che sta per morire sono le più importanti, perché in questo c’è la sintesi di quello che egli ha capito della vita.
MOSE’ RICORDA I GESTI D’AMORE DI DIO PER IL POPOLO INFEDELE
“Peccarono contro di lui i figli degeneri, generazione tortuosa e perversa. Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente? Non è lui il padre che ti ha creato che ti ha fatto e ti ha costituito?Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani. Interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l’Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell’uomo,… perché porzione del Signore è il suo popolo Giacobbe è sua eredità”. (Dt 32,5-9)
Per il Signore Giacobbe è la porzione della sua eredità. Siamo figli prediletti di Dio come una porzione di torta che lui si è riservata.“Lo circondava in terra informe,lo istruiva, lo custodiva come pupilla del suo occhio. Come aquila… che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo non c’era con lui alcun dio straniero. …e lo nutrì con i prodotti della campagna; gli fece succhiare miele dalla rupe e olio dai ciottoli della roccia; crema di mucca e latte di pecora insieme con grasso di agnelli, fior di farina di frumento e sangue d’uva, che bevevi spumeggiante”. (Dt 32,10-14)
L’abbondanza. Dio non dà solo il necessario, Dio dà il di più. E quest’abbondanza la vediamo dal primo capitolo di Genesi e per tutta la Bibbia.
Nel salmo ci sono tre verbi che sono i verbi dell’educazione (circondare, allevare, custodire), con significati affini. Essi nell’insieme sottolineano la valenza educativa nella sua totalità. Gli aspetti più importanti dell’educazione sono: *in primo luogo l’iniziativa è sempre di Dio;
*quest’iniziativa ci circonda, ci avvolge anche se non sempre l’accogliamo, perché cerchiamo di scrollarcela di dosso;
*inoltre c’è un aspetto più specificamente istruttivo.
Alle catechiste spetta il compito di dare l’intelligenza delle cose di Dio, di custodire, di comprendere e di prendersi cura dei “piccoli” a loro affidati.
Speciale Catechesi 9
RELAZIONE 2a parte: GESÙ CI VIENE INCONTRO CON UNA BUONA NOTIZIA
Si trovava là un uomo…malato
Vi fu una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme (Gv5,1)
Si sale a Gerusalemme, perchè è a 800 metri sopra il livello del mare. È sempre una salita Gerusalemme, ci sono anche i salmi delle salite e delle ascese. Nella Bibbia quando si parla di salire non si sale solo con i piedi, ma si sale anche col cuore: sono sempre due le salite. Gesù va a Gerusalemme e c’era una festa, una festa del pellegrinaggio. Erano tre le feste del pellegrinaggioPesach, Sucot e Shavuot. Di fatto noi sappiamo che Gesù andava a Gerusalemme per la festa come tutti i pellegrini.
V’è a Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, una piscina, chiamata in ebraico Betzaetà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Un angelo infatti in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l’acqua; il primo ad entrarvi dopo l’agitazione dell’acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. (Gv 5,2-4)
Questa religiosità noi la possiamo collocare a Lourdes, dove c’è la piscina del malato e chi scende nella piscina a volte guarisce. L’acqua in tutta la Bibbia ha una valenza doppia, perché la poca acqua ti fa vivere. Nel deserto senza acqua muori. In Israele ci sono i fiumi con i ciottoli sotto e, quando piove tantissimo, il terreno non assorbe l’acqua, quindi l’acqua straripa e, quando straripa, ha una potenza enorme e uccide. Quindi l’acqua è una potenza salvifica quando è poca ed ha una potenza mortifera quando è troppa. Israele ha paura delle grandi acque, perché Israele non è un popolo di navigatori, è un popolo del deserto. Sappiamo inoltre che alle nozze di Cana, che è il primo segno di Gesù, quell’acqua di purificazione diventa vino. Ma era l’acqua di purificazione nelle giare, in cui gli ebrei si lavavano fino al gomito prima di mangiare. Questo gesto non era solo una norma igienica, ma assume una valenza religiosa.
Si trovava là un uomo che da trentotto anni era malato. Gesù vedendolo disteso e, sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» (Gv5-5-6) (“sapendo”…Gesù lo sa perché è Dio).
“Vuoi guarire?”. Voi provate dire a un malato se vuol guarire. Ma certo che vuol guarire! Ma è importante per Gesù questa domanda, perché sta facendo prendere coscienza all’uomo di chi sia, ma soprattutto che cosa vuole veramente. Quello che fa fare Gesù col suo sguardo e con la sua parola è sempre un cammino interiore: andare nel più profondo di te e dire la tua identità e dire il tuo desiderio più profondo. Gesù prende l’iniziativa inizia il dialogo e gli chiede il suo desiderio più profondo. Gli chiede: «Vuoiguarire?».
Gli rispose il malato: «Signore, io non ho nessuno che m’immerga nella piscina quando l’acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me». (Gv1,7)
Quest’uomo è malato da tanto tempo, e non dice subito a Gesù: “Sì, voglio guarire”, egli dice in realtà il suo dolore più profondo, la solitudine. La solitudine che può diventare la più grande malattia dell’anima.
Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E sull’istante quell’uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. (Gv1,8-9)
Proprio quel giorno doveva guarire Gesù? Non poteva farlo il giorno prima o aspettare il giorno dopo? Altrimenti sarebbero venute fuori tutte le discussioni coi Giudei, per cui il sabato non si possono fare 39 melakà, 39 azioni. Neanche aprire l’ombrello si può, neanche chiamare l’ascensore. Tu non puoi fare nessuna azione che trasformi il reale: è lo shabbat! E Gesù guarisce il malato. Come lo guarisce? Lo
Speciale Catechesi 10
guarisce con una parola: «Alzati!» Ma l’ha visto, gli ha parlato, si è preso cura, ha sentito nel profondo la solitudine di quest’uomo.
Dissero dunque i Giudei all’uomo guarito: «È sabato e non ti è lecito prender su il tuo lettuccio». (È sabato e non si può portare il lettuccio, non si può nemmeno portare un libro da una stanza all’altra). Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Gli chiesero allora: «Chi è stato a dirti: prendi il tuo lettuccio e cammina?». Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allontanato, essendoci folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco che sei guarito; non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio». (Gv1,11-14)
Il sabato è il tempo di Dio: attenzione, perché ha una valenza fondamentale questo segno, non miracolo,(nei sinottici i miracoli sono 29 nel vangelo di Giovanni i segni sono 7 e Giovanni li chiama segni non miracoli). Il vangelo di Giovanni può essere interpretato a tantissimi livelli: è il vangelo dell’aquila, il vangelo che vola più in alto ed è anche il più difficile da comprendere. «Vai e non peccare più!», perché se pecchi ti succede qualcosa di più grave. Noi sentendo quest’affermazione diciamo: «Allora se uno è malato è perché ha peccato e se non ha peccato lui hanno peccato i suoi genitori». Era una credenza di allora che la malattia fosse legata intimamente al peccato, come fosse un pegno da pagare. In realtà Gesù sta portando quest’uomo su un altro piano: la malattia non nasce dal peccato. La malattia è segno di disagio ed oggi alcuni medici dicono che addirittura il tumore è psicosomatico. Di fatto qui Gesù fa fare un cammino profondissimo all’uomo, lo mette in discussione. Ma vi siete chiesti perché Gesù ne guarisce solo uno? Ce n’erano tanti di malati, c’era una folla di gente ammalata, perché guarisce solo questo? Perché era solo. Gesù vede la sua solitudine prima della sua malattia e allora Gesù si fa compagno, amico, vicino. Gesù gli dice: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina!». Guardate che Gesù gli sta dicendo di andare contro la legge, perché quell’uomo di sabato non può portare il suo lettuccio. Gesù in realtà gli sta dicendo di fare una cosa che non si può fare nella religiosità ebraica, nei 613 precetti. Gesù va oltre la legalità, vede l’umanità e gli sta facendo fare un cammino.
Che cos’è il peccato? Il peccato nella Bibbia, letteralmente, è sbagliare bersaglio ed è una ferita che tu fai all’altro, al mondo, a Dio e tocca tutte le relazioni ed è una ferita che fai anche a te stesso. Questo è il peccato, non portare il lettuccio, anche se secondo la mentalità di allora era un peccato. Vedete quanto è sconvolgente Gesù! Forse in questo brano, quello che Gesù gli dice, è più sconvolgente della guarigione. Da trentotto anni quest’uomo era malato. Quest’uomo ha fatto un cammino di maturazione e adesso è pronto per dare un nome al suo desiderio più profondo e al suo bisogno di guarigione, che non è solo la gamba che non funziona, cioè l’essere paralitico, ma è la solitudine. Gesù è venuto a guarire prima di tutto questa realtà: Lui è il Dio con noi. Il nostro Dio è un Dio che sta nella sofferenza, è un Dio che sta con te sempre e il messaggio dirompente di questo Vangelo è che adesso quest’uomo non sarà più solo.
Vedendo e sapendo
Ci sono dei vocaboli che si richiamano nella mistica ebraica: machol, danza, ha un suono simile alla parola machalà, malattia, a mechilà, perdono, a chemlà, compassione. La malattia è provocata dall’incapacità di perdonare noi stessi o gli altri o di danzare, atti, questi ultimi, che danno libero sfogo a forze psicologiche e spirituali sprofondate nell’intimo del nostro animo: reprimere la loro libera effusione provoca afflizione dell’anima e conseguente malattia fisica. La danza così nella spiritualità ebraica diventa un vero e proprio strumento di guarigione interiore. Chi danza si libera dentro, si purifica, esce da se stesso e va incontro ai fratelli e alle sorelle che ha accanto. Chi accetta di entrare nella danza, anche solo in senso spirituale, riceve fra le mani lo strumento adatto per la guarigione, così da poter pian piano sconfiggere la malattia; riceve la chiave per aprirsi al perdono e alla compassione verso di sé e verso gli altri. Loro dicono così: chi ha compassione perdona, danza e non si ammala. Che cosa vuol
Speciale Catechesi 11
dire? Ci sono delle malattie che sono causate anche da non aver perdonato, da portarsi dentro dei macigni, dei pesi enormi, che poi a un certo punto diventano malattia. Questa è una delle possibili letture: questa è mistica ebraica. La compassione e il perdono sono una via di guarigione. Io l’ho chiamato, permettetemi, il “carisma della leggerezza”. A volte in certe situazioni o le sorvoli o muori, perché ti tirano giù, ti prendono talmente tanto di dolore che poi il dolore diventa corporeo, fisico e crepi. O impariamo davvero a sorvolare su certe situazioni o restiamo inghiottiti. La guarigione ci conduce in una condizione spirituale nuova, nella quale noi possiamo incominciare un cammino di conversione. Bisogna dirlo, perché nella Bibbia è anche così, chi guarisce cambia la vita.
Passiamo al capitolo 9: Vide un uomo cieco
Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio» (Gv 9,1-3)
Si cerca sempre un motivo. Voi provate a leggere la Bibbia dalla prima all’ultima pagina non c’è la spiegazione della sofferenza. Ci sono tanti tentativi di capire il perché della malattia, ma non c’è una risposta chiara, univoca, unica. E non la dà neanche Gesù. Ma se lui non ha peccato e nemmeno i suoi genitori perchè questo è malato? E Gesù: «È così perché si manifestassero in lui le opere di Dio».
«Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finchè è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finchè sono nel mondo sono la luce del mondo» (Gv9, 4-5)
La luce è la prima parola che Dio dice in Genesi 1: «Sia luce!». E se ricordate nella trasfigurazione Gesù ha un vestito bianco tutto luminoso. Tutto questo discorso e questa guarigione è perché Gesù manifesti chi è: lui è la luce. E dire luce è una parola esplosiva nella Bibbia.
Detto questo sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco. (Gv9,6)
Sul fatto che Gesù abbia sputato per terra e col fango abbia fatto un impasto, apriamo un varco che va da Qumram fino a Genesi e da Genesi a Qumram. Noi siamo adam, da adamà , polvere del suolo. Ma si narra che Gesù era stato a Qumram, dove c’erano gli Esseni e lì c’erano dei profeti che erano anche guaritori o medici e conoscevano delle tecniche di guarigione. Nel mondo ebraico si dice che Gesù avesse imparato lì delle tecniche di guarigione, usando il fango. Col fango e la saliva che cosa ha fatto Dio quando ha creato? Ha fatto l’uomo e poi ha baciato il suo “fantoccino”, gli ha insufflato la neshama,la scintilla divina. Gli ebrei dicono l’ha baciato. C’è della saliva nel bacio: questa è una nuova creazione, perché l’uomo guarito è un uomo nuovo, completamente.
…gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Siloe (che significa inviato)». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano:« Non è egli quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Allora gli chiesero: «Come dunque ti furono aperti gli occhi?». Egli rispose: «Quell’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: Và a Siloe e lavati! Io sono andato e, dopo essermi lavato, ho acquistato la vista». Gli dissero:« Dov’è questo tale?». Rispose: «Non lo so». Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco: era infatti sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri dicevano: «Come può un peccatore compiere tali prodigi?». E c’era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!»… (Gv 9,7-17)
Speciale Catechesi 12
«È un profeta»: dice il cieco guarito, riferendosi a Gesù. E noi ci domandiamo come mai Gesù compie anche questo segno di sabato. Gesù ci sta rivelando chi è: Gesù è Signore del sabato.
Per noi uomini cessare ogni attività un giorno alla settimana è riconoscere che Dio è il Signore della nostra vita. È entrare nel tempo di Dio: questo è lo shabbat degli ebrei. Anche per noi la domenica dovrebbe essere entrare nel tempo di Dio e cessare le nostre attività abituali. Così riconosceremo anche noi che egli è il Signore della nostra storia e del nostro tempo. È facile dirlo, ma è difficile farlo. Chissà se un giorno alla settimana riusciamo a spegnere il cellulare, non è facile, perché togliamo tutti i contatti con il mondo esterno.
Per finire riprendiamo il perché nella Bibbia non c’è una risposta razionale alla sofferenza e alla malattia. Neanche Gesù ce la dà. Lui che cosa fa? Alla fine ormai l’odio era divampato. Il suo messaggio d’amore è quello di un amore in più, è tantissimo amore che crea degli squilibri da altre parti e genera l’odio. Gesù ha amato ed è finito in croce per amore: ha vissuto il tradimento di quelli che amava e questo è più pesante delle ferite dei chiodi. Gesù sulla croce vive la domanda, neanche lì risponde del perché della sofferenza. A volte il dolore d’amore, ti prende il cuore, te lo stringe in una morsa e ti fa dolore fisico. Gesù ha vissuto la domanda, perché mai nessuno su questa terra, in qualsiasi dolore, possa sentirsi solo.
Perchè basta invocare il suo nome e lui è l’Emmanuele, il Dio con noi.
PROF.SSA ANTONELLA ANGHIGNONI (Biblista, docente presso ISSR S.M. di Monte Berico)
Testo trascritto da SILVA STEFANUTTI e non rivisto dalla relatrice
INTERVENTO TEOLOGICO
LA COMUNITA’ “GREMBO” ACCOGLIENTE DELLE PERSONE CON DISABILITA’
La Christifideles Laici al n. 26, afferma che la parrocchia è “l’ultima localizzazione della Chiesa e, in un certo senso, la chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie”. Proprio perché vive in mezzo alle case della gente è il luogo ordinario dell’esperienza cristiana che cerca di cogliere, alla luce del Vangelo, tutti gli aspetti della vita delle persone, nelle sue diverse fasi. E’ come “la fontana del villaggio” alla quale tutti possono accedere per la loro sete. Essa è aperta a tutti, sani o disabili e si pone al servizio di ognuno, specialmente dei più deboli.
Di fatto, però, si ha l’impressione che la presenza della persona “diversamente abile” (disabile), nel contesto della comunità, costituisca un problema, una “preoccupazione”. E’ solo a seguito di una
riflessione più seria, meno emotiva, che si comprende come la disabilità, prima di essere “pre-occupante” è “pro-vocante”, non solo perché richiama attenzione e rispetto, ma perché spinge l’intera comunità a mettersi in discussione: * a riconoscere la radice della comune umanità e realizzare con la persona disabile un incontro tra persone, prima ancora che con la disabilità, senza il velo del pietismo, percepito dallo stesso disabile e dal suo ambiente familiare con un senso di disagio; * e costringe i suoi membri a meglio comprendere la propria umanità. Il disabile infatti, mette in discussione le nostre presunte sicurezze, evidenzia le nostre paure, contesta il mito dell’efficienza e ci obbliga a riconoscere il bisogno che tutti
Speciale Catechesi 13
abbiamo dell’altro, di essere accettati e amati così come siamo; * infine obbliga a rivisitare la qualità della nostra fede, perché è vero che la presenza del disabile suscita tutta una serie di interrogativi, proprio in riferimento alla fede.
Quale immagine di comunità?
A partire dal Concilio Vaticano II, la teologia, la predicazione e la catechesi hanno fatto ricorso a tutta una serie di immagini per presentare la Chiesa nella maniera più accettabile e comprensibile possibile. Anzi, fu lo stesso Concilio che, nella Costituzione sulla Chiesa (Lumen Gentium), ha evocato tutta una serie di immagini bibliche nella intenzione di darci una comprensione meno incompleta del mistero della Chiesa. Sono immagini desunte dalla vita pastorale e agricolacome ovile, gregge, campo, olivo, vite; altre dal linguaggio edilizio, come edificio o tempio; altre ancora dalla vita domestica,come famiglia, sposa di Cristo (S. Paolo, Ef 5, 21-33). La teologia per suo conto ha approfondito, in particolare, tre altre grandi immagini bibliche ampiamente presenti nel documento conciliare LG e nello stesso NT, un po’ meno nella catechesi: la Chiesa come Corpo di Cristo, come Tempio dello Spirito Santo, come Popolo di Dio. Accanto a questi nomi ne ha elaborato altri come Società, comunità, sacramento.Ultimamente, a partire forse dalla constatazione che queste ultime grandi metafore sono poco spendibili dal punto di vista pedagogico, anche perché presuppongono una conoscenza approfondita della Bibbia, pur restando fondamentali, si è ricorsi a tutta una serie di altre immagini caratterizzate da una accentuazione della dimensione più affettiva, più comunionale e comunitaria: la Chiesa come comunità, come scuola, come famiglia, come casa, e siamo giunti all’immagine che sta a titolo di questo nostro incontro, la Chiesa come “grembo”.Che cosa di più intimo, di più affettivo del “grembo” materno.
L’immagine della Chiesa come grembo
Proviamo ad evocare i possibili rimandi di questa immagine, cioé di una chiesa concepita come grembo, la cui realizzazione dovrebbe costituire l’impegno di tutti. Si tratta di realizzare comunità disposte a rendersi effettivamente accoglienti nei confronti di tutti, in particolare di chi vive alcune disabilità. Dal punto di vista antropologico, l’immagine del grembo rinvia a quel processo che sta alla base di ogni vita umana, le cui tappe sono: il concepimento, la gestazione, la generazione di ogni creatura che viene a questo mondo. Nel nostro caso l’immagine del grembo rinvia alla cura amorevole che la comunità deve avere nei confronti di tutti i suoi figli, in particolare di coloro che sono più bisognosi di cura. Che la Comunità cristiana sia grembo lo avevano già detto i Padri della Chiesa in riferimento soprattutto al Battesimo e più precisamente al fonte battesimale: quel grembo da cui scaturisce la vita soprannaturale, che fa di ogni battezzato un figlio di Dio. L’accostamento del battesimo, e dunque della ri-nascita dall’acqua e dallo Spirito, alla nascita naturale evidenzia, fin dall’inizio della vita, il destino trascendente della nuova creatura rispetto alla vicenda ‘naturale’ della generazione, ma evidenzia anche la cura che la chiesa, la comunità cristiana dove avere nei confronti dei propri figli, definiti i “neofiti”, cioè i “nuovi nati”. In tale prospettiva trova positivo apprezzamento l’aspetto della tenerezza, dell’intimità “carnale” tra madre e figlio, della cura e della protezione della madre nei confronti del figlio. C’è però un rischio insito nella configurazione della comunità cristiana come ”grembo”, il rischio di offrirsi come luogo di rifugio, dove il figlio non diventa mai adulto. Offrirsi come grembo ai propri figli disabili, espone la comunità ad un rapporto iper-protettivo, quando c’è, che impedisce al disabile di crescere. Fra l’altro è diffusa l’idea che il disabile non possa più di tanto crescere, sviluppare sue potenzialità, dare un suo contributo in famiglia, nella comunità cristiana, nella società. La “compassione”, questo nobile
Speciale Catechesi 14
sentimento evangelico, non è semplicemente una specie di intima sofferenza nei confronti del disabile, ma è un “patire insieme” la fatica del crescere, cioè di aiutare il disabile a cavare da sé il meglio delle sue possibilità, a sentirsi soggetto responsabile e non solo oggetto di cure, per quel tanto che gli è consentito. E’ proprio questo rapporto che lo apre alla comprensione dello stesso messaggio evangelico. Se l’educatore, il catechista non è sorretto da questa intima convinzione, difficilmente riuscirà a far giungere il messaggio evangelico. Nella misura in cui si sente considerato, non tanto a partire dai suoi limiti, ma a partire dalle sue possibilità egli entra in sintonia con i suoi educatori e vive una comprensione affettiva del messaggio evangelico. Non dobbiamo dimenticare che il messaggio di Gesù è destinato a tutti e se Gesù ha avuto una preferenza nell’annuncio del Regno l’ha avuta nei confronti di tutte quelle categorie di persone che la società di allora aveva messo ai margini: ciechi, zoppi, lebbrosi, malati d’ogni genere, pubblicani e peccatori. A sollecitare ulteriormente la responsabilità della comunità c’è una considerazione fondamentale da tener presente: cioé che la salvezza, anche per questi nostri fratelli, passa attraverso l’ascolto della Parola e quindi attraverso la fede intesa come risposta a questa Parola. Sta alla comunità allora elaborare metodi, indovinare linguaggi, individuare persone capaci di far giungere la buona notizia di Gesù.
L’importanza della comunicazione
La comunicazione, intesa come modo di comunicare diventa, allora determinante. Ovviamente essa varia a seconda dei vari tipi di disabilità e le diverse capacità dei soggetti. Passa comunque attraverso tutto un insieme di atteggiamenti, di attenzioni, di contatto visivo, a volte tattile, di mimica facciale, di sguardi, che richiedono “pazienza”, calma e tranquillità. Una comunità che vive la frenesia del fare, difficilmente riuscirà ad essere grembo nei confronti di questi suoi figli. Se l’approccio catechistico poi, è di tipo esclusivamente intellettuale, dottrinale, verbale, difficilmente
il Vangelo sarà avvertito come buona notizia. Oggi la tecnica ha messo a disposizione strumenti che facilitano la comunicazione anche per quanti non dispongono della comunicazione verbale, ma anche in questo caso l’educatore, il catechista, l’operatore pastorale sono chiamati ad essere attenti a cogliere il di più delle risposte prefabbricate offerte dai nuovi strumenti, a manifestare interesse alla fatica e alla soddisfazione del disabile per essersi potuto esprimere ed essere stato capito. A volte si è tentati di anticipare la comprensione della risposta, privando così la persona del disabile della soddisfazione di dimostrare che è in grado di comunicare, di farsi capire. Ebbene, concepire la comunità cristiana come “grembo”, evoca tutte queste attenzioni, le stesse attenzioni che la madre dedica al suo bambino per coglierne i messaggi, i bisogni, non attraverso discorsi ma attraverso il linguaggio di tipo percettivo-affettivo.
La comunità cristiana come grembo
E’ vero però che il termine “grembo” porta con sé anche dei rischi. Primo fra tutti quello di voler proteggere il disabile al punto da creargli, una vita quasi speciale, parallela, fatta di cose su misura, percorsi diversi, di opportunità ridotte anziché introdurlo e accompagnarlo nelle stesse opportunità e nei medesimi percorsi dei suoi coetanei, rendendolo non semplicemente oggetto delle cure, ma soggetto e protagonista per quel tanto che la sua disabilità gli consente. Se il termine “grembo”, usato per definire la comunità cristiana, evoca tutto questo insieme di atteggiamenti, di attenzioni, mi chiedo se le nostre comunità effettivamente sono in grado di esprimersi così nei confronti di tutti i suoi membri e in particolare nei confronti dei disabili. Offrirsi come grembo non vuol dire solo e principalmente integrare il disabile nella comunità, sottraendolo alla tentazione dell’isolamento e del considerarlo come il “diverso”. A questo proposito si deve riconoscere che oggi l’integrazione del
Speciale Catechesi 15
disabile, dal punto di vista legislativo e culturale è piuttosto avanzata. L’integrazione nel territorio si concretizza attraverso alcuni interventi che vanno dall’abbattimento delle barriere architettoniche e ancor più di quelle ideologiche. Integrazione del disabile significa soprattutto permettergli di vivere con gli altri, frequentare gli stessi luoghi con uguali opportunità, poter usufruire di interventi d’aiuto personalizzato così da metterlo nella condizione di accedere alla realtà “normale” con i “normali”. E’ a questo punto che entra a pieno titolo la comunità parrocchiale come luogo privilegiato, “grembo” appunto, di accoglienza e di ascolto di quei bisogni appena sussurrati o a volte troppo impegnativi per essere presi in considerazione dal quartiere o da altri ambiti sociali.In particolare, in quanto grembo, la comunità è chiamata non solo a generare alla fede tramite il sacramento del Battesimo, ma ad inserire il disabile in quei percorsi o itinerari che portano alla maturità della fede i propri figli. La comunità allora, è chiamata non solo a generare, ma anche ad educare: deve passare dalla generazione all’educazione.
La comunità cristiana come famiglia
Al fine però di una più ampia configurazione e comprensione della comunità come grembo e dei suoi compiti nei confronti dei disabili che la abitano, mi sembra importante esplorare due altre metafore che evocano altre dimensioni della comunità e sollecitano altre attenzioni e responsabilità nei confronti dei disabili: si tratta dell’immagine della comunità cristiana come famiglia e come casa. Oltretutto sono due metafore che si richiamano vicendevolmente.
L’ikona anzitutto della comunità cristiana come “famiglia”
In questi ultimi anni il tema della Chiesacome famiglia è diventato, per molte chiese, parte importante di molti progetti pastorali. Penso alla Chiesa africana che, a
partire dal Sinodo dei Vescovi sulla Chiesain Africa del 1995, si è compresa proprio come “Familia Dei”, immagine a partire dalla quale stanno maturando scelte pastorali importanti. Tale prospettiva è presente anche in Italia, per esempio con il progetto dal titolo quanto mai significativo: “Parrocchia, famiglia di famiglie”. Il senso di questi progetti va nella direzione di comunità che privilegiano l’insieme e la varietà dei rapporti familiari. Oltretutto, nell’immaginario collettivo, l’ikona del grembo rinvia immediatamente alla realtà della “famiglia”, ben sapendo che oggi questo legame famiglia e grembo non è scontato. Si può generare indipendentemente dal rapporto con la comunità coniugale e familiare, nel contesto di un rapporto esclusivo tra madre e figlio. L’ideale tradizionale del grembo materno nel contesto della famiglia, intesa come intreccio di relazioni di tipo sponsale tra marito e moglie, di tipo genitoriale tra genitori e figli, di tipo filiale tra figli e genitori, fraterno tra fratelli e sorelle, questo ideale è messo in questione. Senza addentrarci nella problematica complessa della famiglia oggi, ma ispirandoci al concetto più comunemente accettato, la famiglia costituisce lo sbocco naturale del frutto del grembo. Essa integra il nuovo nato nel contesto più ampio delle relazioni familiari. La famiglia infatti è costituita dall’intreccio di molteplici relazioni. La relazione madre-figlio si integra in un insieme di altre relazioni che dilatano la libertà e la coscienza di ogni figlio, disabile o meno, e pone le premesse indispensabili per comprendere e quindi per vivere nel modo giusto, lo stesso impegno educativo nei confronti dei figli. C’è infatti un nesso strettissimo tra generazione ed educazione. Potremmo sinteticamente descriverlo così: l’educazione è l’insieme delle azioni mediante le quali i genitori fanno sperimentare al figlio la realizzazione progressiva di quella promessa di vita buona che gli hanno fatto mettendolo al mondo.Che ci sia un nesso strettissimo tra generazione ed educazione, la cosa sembra pacifica. Sennonché, oggi non è più così. Oggi si pensa all’educazione non tanto come un aiuto offerto ai figli perché
Speciale Catechesi 16
comprendano e vivano una vita buona – ciò è considerato una mancanza di rispetto della loro libertà e dignità – ma come un disimpegno progressivo così da liberarli da quell’originario rapporto di dipendenza nei confronti dei genitori che sta agli inizi della loro vita. Dietro a questa idea di educazione ci sta un luogo comune secondo il quale occorre sempre rispettare le idee altrui, l’opinione altrui, giuste o sbagliate che siano e quindi liberare i figli a se stessi. Ripensare le nostre comunità alla luce della categoria “famiglia” – non certo in sintonia con tali estremismi - vuol dire impegnarsi a delineare il volto concreto delle nostre comunità sulla base di alcuni fondamentali che strutturano la famiglia e che condizionano l’impegno educativo.
Alcuni “fondamentali” della famiglia che strutturano la comunità cristiana
1. La comunità cristiana pensata come “famiglia” ci induce a pensare alla parrocchia come comunità radicata in un territorio. Sì, perché di fatto la famiglia ci colloca tutti, individui e famiglie, in un determinato luogo, in uno spazio, una casa, una tenda. La parrocchia allora, pensata come famiglia fissa la presenza della chiesa in un determinato territorio. Attraverso la parrocchia, la chiesa, cioè la comunità dei credenti, riesce ad abitare spazi sociali e territori diversissimi ed entrare in contatto con soggetti ben precisi, e con le tensioni e i problemi che li abitano (povertà, immigrati, disabili, ecc.). Nel suo impegno nei confronti dei suoi figli disabili non potrà non tener conto del contesto umano, sociale, culturale in cui essi sono aiutati a vivere la loro fede.
2. Inoltre, pensata come famiglia, la comunità cristiana deve porsi come soggetto educante. Dicevamo che la famiglia non é solo il luogo della generazione, ma in forza dello stretto legame che esiste tra generazione ed educazione, essa si sa chiamata ad educare tutti i suoi figli. Ebbene, la comunità cristiana pensata come famiglia si sente ulteriormente stimolata a rafforzare il suo impegno educativo. Al di là delle
diverse concezioni circa l’educazione, rimane che fondamentalmente educare significa anzitutto amare le persone concrete e desiderare il loro bene. Il disabile in particolare nella misura in cui si sente amato, nella misura in cui percepisce che la premura di chi lo circonda è sorretta dalla fiducia nelle sue possibilità si apre anche alla comprensione affettiva del messaggio evangelico. Ovviamente la famiglia non è soltanto un modulo a cui ispirare l’azione educativa, ma è un soggetto con il quale si deve interagire. Al catechista pertanto che si rende partecipe di questo impegno della comunità, si chiede innanzitutto di essere capace di costruire rapporti e di promuovere capacità relazionali, integrative di quelle che la famiglia offre. Questo chiede attenzione verso un ascolto attivo, un atteggiamento empatico, una comunicazione che della parola non fa l’unico strumento comunicativo. Se un tempo al catechista si chiedeva di essere un buon trasmettitore dei contenuti di fede, oggi gli si chiede di essere capace di intuire le domande che si nascondono dietro lo sguardo, il gesto, il silenzio del disabile. Gli si chiede certo una buona preparazione teologica, indispensabile per poter avere la libertà di tradurre i contenuti nel linguaggio che non è quello dei catechismi scritti, gli richiede anche una preparazione specifica che tenga conto della modalità di comprensione e di espressione del disabile. E’ una richiesta eccessiva? Direi di no, si tratta di stabilire delle priorità nell’ordine del giorno delle nostre comunità cristiane, perché l’enfasi che accompagna la riflessione sul mondo dell’handicap, anche nella chiesa, non suoni puramente pubblicitaria.
La comunità cristiana come “casa”
E’ anche vero che il fatto di nascere in una famiglia rinvia alla realtà della casa che la ospita. E abitare una casa, possiede risorse insospettate per rinnovare quelle attitudini evangeliche da viversi soprattutto nei confronti di chi, in famiglia è più in difficoltà. Proviamo allora una rilettura “domestica” di quella realtà che è la parrocchia, non a caso definita, casa dei credenti.
Speciale Catechesi 17
Che la parrocchia rinvii all’immagine della casa, lo sta a dire lo stesso termine “Parrocchia”. Infatti, è una parola greca portatrice di un duplice significato: può significare il “vicino di casa”, “confinante”, ma anche lo straniero, il pellegrino, il forestiero che non è nella casa. Mi piace pensare la parrocchia in riferimento al primo significato, cioè come un “vicinato”,un insieme di case vicine con il compito di trasformare in casa lo spazio nel quale essa è collocata e di rendere domestiche persone e cose, affinché l’ambiente risulti portatore delle promesse che la casa porta con sé.
Quali sono queste promesse che la casa evoca?
La casa, soprattutto la casa natale, è il luogo che dischiude lo spazio all’intimità, agli affetti e a tutte quelle relazioni che la abitano. E’ il luogo della protezione, della sicurezza, il luogo dove si viene generati alla coscienza, alla vita come dono gratuito, dove si colloca l’avventura dell’esistenza. L’esperienza della casa inoltre, risulta decisiva per la formazione della propria identità. Quando uno si pensa e cerca di rispondere all’interrogativo: ma chi sono io?nel tentare di darsi una risposta si pensa sempre in riferimento alla casa, alle cose di casa, alle persone di casa. Questa immagine della parrocchia come “casa/famiglia” ci permette allora di delineare un volto di comunità che coltiva alcuni tratti importanti a servizio dei suoi abitanti, in particolare di chi ha più bisogno, senza dimenticare mai che nessun luogo, dalla casa alla parrocchia, sia pur addomesticata, è privo di ambiguità. Andare alla parrocchia vuol dire andare alla stabilità e all’attendibilità delle relazioni, all’abitudine, o meglio al proprio habitat. Il disabile deve percepire che la parrocchia è il proprio habitat attraente.
Per un’azione catechistico-pastorale adeguata
Questi tratti che abbiamo evocato ci possono aiutare a tracciare, verificare, migliorare i percorsi pastorali e spirituali per
le persone con disabilità all’interno delle nostre comunità e in modo particolare per consolidare l’impegno a sensibilizzare la comunità dei credenti verso le persone con disabilità e le loro famiglie quali soggetti attivi di evangelizzazione. E’ chiaro che non possiamo dedurre da queste immagini un percorso organico di evangelizzazione dei disabili. E’ possibile però inquadrare le suggestioni che le metafore portano con sé, nel contesto di una visione organica di quanto le comunità cristiane sono chiamate a fare. E’ importante ricordare che la presenza nelle nostre comunità di persone “diversamente abili” comporta, più che la messa in opera di attività specifiche, un fecondo ripensamento di quello che la parrocchia (“Chiesa che vive fra le case degli uomini”, “famiglia dei figli di Dio”, “grembo accogliente”) è, a partire dalle sue radici evangeliche. Mi permetto, a questo punto di individuare alcuni nuclei tematici che devono diventare mete concrete del nostro lavoro:
Alcuni obiettivi prioritari
1. Lavorare per una corretta cultura della disabilità. Il valore della persona con disabilità quale membro attivo della chiesa e non solo destinataria di cura pastorale, dev’essere la prima condizione da realizzare affinché nessuno sia escluso dalla partecipazione alla vita ecclesiale. Concretamente si tratta di condividere un linguaggio comune che sia rispettoso della disabilità in particolare e delle diversità in generale (es. Certe definizioni non si usano più: insufficienza mentale, handicappato, ecc.). Il rispetto della specificità della disabilità deve però tradursi in accoglienza. Ogni persona e non solo il disabile per sviluppare le proprie potenzialità e maturare ha bisogno di sentirsi accolta, di sperimentare un contesto di comunione, di condivisione, di amore. E una comunità è accogliente se riconosce nel proprio ambito tutte le presenze che la costituiscono (bambini, giovani, famiglie, malati, anziani, stranieri, diversamente abili, ecc. ) e sa valorizzare la ricchezza di ciascuna di esse. I diversamente abili appartengono come gli
Speciale Catechesi 18
altri cristiani a una diocesi, ad una parrocchia e la comunità cristiana deve prendere coscienza della necessità di accogliere al suo interno tutte queste persone. Escluderne qualcuna o non interessarsene, la comunità, risulterebbe essere un Corpo privo di alcune sue membra.
2. Oltretutto, la cura dei membri più deboli, nella prassi di Gesù, è segno caratteristico della venuta del Regno di Dio, della sua presenza nella storia ed è parte integrante della missione della Chiesa. Detta così la cosa risulta piuttosto generica. Si tratta allora di precisare le modalità con cui tutto ciò dev’essere realizzato. La riflessione in proposito potrebbe essere riassunta attorno a tre parole: 1) Integrazione cioè operare perché il disabile abbia piena cittadinanza nella comunità, evitando ogni forma di isolamento. Si tratta di rendere la persona “diversamente abile” soggetto a pieno titolo, secondo le sue possibilità nell’ambito della vita parrocchiale. 2) Normalizzazione.Significa operare perché il disabile si avvicini il più possibile al comportamento della vita comune. Aiutarlo perché, nel limite del possibile, faccia le cose che fanno gli altri e che sono considerate normali, nell’arco della giornata e della settimana. 3) Personalizzazione. Nelle attenzioni e nelle cure di vario genere, come pure nei diversi rapporti educativi e religiosi si avrà cura di partire dal considerare il disabile non a partire dalla sua disabilità, ma dal fatto che egli è persona che ha il diritto di svilupparsi in tutte le sue dimensioni: fisiche, morali e spirituali. Si tratta quindi di mettere in atto azioni pastorali, anche se inizialmente poche, semplici e concrete, tutte orientate al raggiungimento dell’integrazione, della normalizzazione e della personalizzazione del disabile. Nel caso del disabile essa si concretizza in un rapporto che ti coinvolge nei minimi gesti quotidiani. Azioni ordinarie come alzarsi per bere, girare la pagina di un libro, premere il tasto del diplay per far scattare una risposta, ecc. sono azioni che chiedono qualcuno che “agisca per..”,che abbia mani, bocca, orecchi per… E’ un atteggiamento di premura esistenziale
verso l’altro affinché questi possa esprimere se stesso, sentirsi degno di essere amato per il fatto di esserci.
3. Considerare la presenza della disabilità nella Chiesa come presenza da comprendere e valorizzare. Essa é abitata dallo Spirito, e pertanto è portatrice di senso. Proprio perché essa è una realtà dell’esperienza umana, come tale, essa interpella la nostra ragione per colmare un bisogno di senso, anche sul piano religioso. Si tratta allora di attivare un processo di inclusione pastoraleaffinché la persona diversamente abile possa modificare alcuni atteggiamenti, presenti anche nelle nostre comunità, che non solo non garantiscono la piena partecipazione nella chiesa, ma che di fatto creano esclusione. Penso, al criterio della efficienza a cui si ispira molta nostra pastorale, della ricerca della efficacia immediata che sottende tante nostre attività pastorali, al criterio della visibilità. Sono tutti atteggiamenti che di fatto creano esclusione, emarginazione nei confronti di chi non è in grado di rispondere a questo standard di vita.
4. Inoltre, una pastorale per persone “diversamente abili” non può non preoccuparsi di offrire condizioni e strumenti affinché ciascuno possa vivere il più consapevolmente possibile la scoperta della propria interiorità, partendo dalla convinzione di fede dell’azione misteriosa dello Spirito nel cuore di ciascuno. Se è vero che il Dio di Gesù Cristo è un Dio che per primo ama l’uomo indipendentemente dalle capacità intellettuali e fisiche, ma solo in quanto persona voluta a sua immagine e somiglianza, la comunità cristiana deve preoccuparsi di promuovere la persona disabile anche nella sua specificità spirituale. La persona disabile dev’essere messa nella condizione di essere abilitata a scoprire cosa c’è “dentro” di lei, non solo renderla competente nelle autonomie quotidiane. Concretamente si tratta di preparare persone (catechisti/e) che facilitino la trasmissione dell’esperienza di fede (es. utilizzando diversi linguaggi per chi è in deficit di capacità sensoriali o cognitive). Il fatto poi, di credere che il
Speciale Catechesi 19
disabile (intellettivo) possa coltivare la dimensione della spiritualità, non autorizza certo a pensare che la disabilità costituisca un privilegio. Tutto questo non ha niente da vedere con la spiritualità. Infatti, anche per chi crede, la disabilità – come la malattia – pone molti interrogativi sul perché di questa realtà e ne suscita molti altri. Chi vive o lavora con i disabili sa che spesso si procede per tentativi, anche quando si possiedono metodologie pensate e programmate. Si è sempre alla ricerca di linguaggi diversi per comunicare e per fare in modo che il disabile resti sempre soggetto di scelte, anche minime.
5. La gratuità. Succede spesso di valutare la vita propria e degli altri in base ai successi professionali, affettivi, sociali. A volte identifichiamo la positività di un’esistenza con la possibilità di misurare i risultati che si vedono e che tutti possono apprezzare. Esistono però anche gesti di dedizione assoluta verso un’altra persona che nessuno mai conoscerà; gesti i cui effetti restano nascosti da una comunicazione difficile e incomprensibile, ma non per questo meno reale. I criteri per valutare l’efficacia della nostra azione catechistica, in questo caso sono del tutto inadeguati. In quest’ambito si opera in assoluta gratuità.
Conclusione
Di fronte alla disabilità, la comunità cristiana e, in essa i catechisti, si rendono conto di non essere del tutto preparati a svolgere un servizio che sia nello stesso tempo gratuito e competente. Le risorse umane a disposizione sono spesso limitate. D’altra parte una risposta dev’essere data, se non altro per fedeltà al Vangelo. Occorre anche ribadire che la disabilità non è solo di qualcuno. Essa è estremamente democratica e parla a tutti, a prescindere dall’età, dal sesso, dalla situazione economica. Infatti, disabili non lo si è solo dalla nascita, lo si può diventare per età, per incidente, traumi, malattie, disagi di diverso tipo, in un momento della vita in cui magari si è già usciti dai circuiti scolastici o lavorativi ed allora la solitudine e il senso del disagio e di inadeguatezza diventano
ancor più forti e fonte di maggiore sofferenza. Proprio per questo la disabilità spesso resta chiusa nei ristretti confini della famiglia e della casa, spesso troppo angusti. La comunità cristiana può fare molto: può diventare il luogo di un’accoglienza senza riserve, senza aspettative di particolari prestazioni, senza l’ombra del pregiudizio. Può essere veramente il luogo in cui siamo tutti uguali e nella diversità troviamo il completamento delle reciproche difficoltà, creando nuovi spazi di integrazione e non solo per i disabili. Realizzare tutto questo non è semplice né immediato, occorre un lavoro serio di preparazione e di programmazione di interventi anche piccoli ma mirati, insieme ad una spontaneità e freschezza di rapporti che consenta di fare delle nostre comunità dei veri “grembi”, delle vere “famiglie”, delle vere “case”.
BibliografiaCONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, Dignità e diritti delle persone con handicap mentale, Roma. CEI, UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE, La Parola di Dio nella catechesi ai disabili, Roma 2008 MARTINI C.M., Comunità cristiana e handicap, in Rivista diocesana milanese, LXXV (1983) 487- 492. COLLINI M., Oltre il limite. La Chiesa e l’handicap,ed. Franco Angeli MORANTE G., D, come diversità. Cinque sentieri per l’inclusione dei disabili in parrocchia. Ed. ElleDiCi, Torino PAGAZZI G.C., Sentirsi a casa: Abitare il mondo da figli ed. EDB, Bologna 2010 G. Angelini, Il Figlio, una benedizione, un compito,ed. Vita e Pensiero, Milano 1991 AA.VV. L’arte di educare nella fede. Le sfide culturali del presente, Edizioni Messaggero, Padova 2008.
MONS. LUCIANO BORDIGNON (Teologo, docente del Seminario diocesano)
FINE PRIMA PARTE
Speciale Catechesi 20
PROPOSTE CATECHISTICHE… DIOCESI DI VICENZA UFFICIO PER L’EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI
DIVENTARE CREDENTI ALLA LUCE DELLA PAROLA BREVE PERCORSO BIBLICO
INCONTRO FORMATIVO PER ANIMATORI DEI CENTRI DI ASCOLTO, DEI GRUPPI BIBLICI E PER QUANTI OPERANO NELLA PASTORALE DATA: Domenica 29 Gennaio 2012 ORARIO: ore 15,00-18,00 SEDE: Chiesa Parrocchiale di San Marco – Vicenza PROGRAMMA DELL’INCONTRO ore 15,00 - 15,15 Accoglienza e preghiera iniziale ore 15,15 - 16,30 Diventare credenti alla luce della Parola
(prof. Milani don Marcello - Biblista) ore 16,30 - 17,00 Pausa ore 17,00 - 17,45 «Discepoli come Bartimeo»: lectio… in musica su Mc 10,46-52 DESTINATARI: - quanti animano i Centri di Ascolto della Parola di Dio (CAP) in parrocchia o i gruppi biblici - coordinatore/i dei CAP in Parrocchia - quanti seguono la catechesi dei Giovani/Adulti - responsabili e membri dei gruppi liturgici - giovani e adulti interessati a pregare con la Parola di Dio - catechisti parrocchiali - adulti impegnati nella Pastorale familiare e nella vita di coppia COORDINATORI DELL’INIZIATIVA: Davide Viadarin, Annalinda Zigiotto, Suor Maria Zaffonato PER PARTECIPARE: Si invita, per questioni organizzative, a segnalare la propria presenza alla Segreteria dell’Ufficio entro Mercoledì 25 Gennaio 2012, telefonando (0444/226571) o inviando una e-mail ([email protected]). NOTE TECNICHE: Per il parcheggio, è possibile usufruire di quello interno al Cinema Parrocchiale San Marco oppure degli appositi spazi che costeggiano le mura di Parco Querini. PRESENTAZIONE E SENSO DELLA PROPOSTA Da alcuni anni l’ultima domenica di gennaio viene riservata per un incontro formativo fra quanti si impegnano per l’annuncio del Vangelo agli adulti, primi destinatari del messaggio cristiano e responsabili di trasmettere la fede alle nuove generazioni. Con l’appuntamento di gennaio 2012 si vuole proporre un progetto triennale di riflessione sul credere in modo maturo di fronte alle domande profonde e, a volte, controverse che il contesto contemporaneo pone al singolo e alla comunità ecclesiale.
Speciale Catechesi 21
INCONTRO DI CATECHESI FAMILIARE
DIOCESI DI VICENZA UFFICIO PER L’EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI
4° INCONTRO DIOCESANO SULLA CATECHESI FAMILIARE
Domenica 11 marzo 2012 ore 15.00 – 17.30
SEDE: Opere parrocchiali di Laghetto in Vicenza PROGRAMMA:
Ore 15.00: Preghiera iniziale e saluto Ore 15.15: Breve relazione:
Catechesi familiare: quali contenuti? Ore 15.30: Lavoro a piccoli gruppi per uno scambio di esperienze Ore 16.30: Discussione in assemblea e comunicazioni dei rappresentati
vicariali Ore 17.00: Conclusioni
INVITATI:
- I catechisti/e rappresentanti delle parrocchie, che hanno già avviato il modello della catechesi familiare
- I delegati delle parrocchie intenzionati ad iniziare tale modello - I rappresentanti dei vicariati - Quanti sono interessati al tema.
PER PARTECIPARE: E’ indispensabile, per motivi organizzativi, dare la propria adesione telefonando all’Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi (0444/226571) o inviare una mail: [email protected] entro il 3 marzo 2012.
PRESENTAZIONE Da qualche anno alcune comunità parrocchiali o zone pastorali hanno avviato, per accompagnare i fanciulli e i ragazzi nell’itinerario di fede e sacramentale, l’esperienza della catechesi familiare, modello di catechesi che vanta una tradizione pluridecennale. Arrivati a questo punto della sperimentazione, avvertiamo la necessità di riflettere sui contenuti da proporre, sugli itinerari di fede da attivare e soprattutto sul rapporto tra Parola di Dio e catechismi CEI all’intero di tale esperienza. Riteniamo importante, inoltre, la presenza dei rappresentanti vicariali per poter fare il punto delle sperimentazioni nelle varie zone. Questo è l’obiettivo del prossimo appuntamento diocesano.
PER INCORAGGIARE LA SCELTA DELL’IRC A SCUOLA L’IRC (insegnamento della religione cattolica) a scuola è un’esperienza importante che rimane nella vita. E’ diversa ma complementare all’esperienza della catechesi in parrocchia finalizzata ad introdurre alla fede e all’incontro con Gesù Cristo. Anche le/i catechiste/i sono invitate/i a incoraggiare e sostenere i ragazzi e le loro famiglie a continuare nella scelta dell’IRC, disciplina scolastica (soprattutto nei mesi precedenti l’iscrizione!). In parrocchia sono a disposizione materiale informativo per spiegare le ragioni positive di tale scelta (adesivi e dèpliants multilingue). C’è pure una bella lettura del nostro Vescovo Beniamino che va fatta conoscere. Si potrebbe inoltre organizzare un incontro con un docente di religione della zona. Tutto il materiale preparato dall’Ufficio diocesano per l’IRC si può scaricare dal sito web: www.vicenza.chiesacattolica.it
Speciale Catechesi 22
L’Ufficio Diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi, in collaborazione con l’Opera Diocesana Esercizi Spirituali Villa S. Carlo
organizza un
CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI
presso Villa S. Carlo di Costabissara
da venerdì 24 febbraio 2012 (ore 18.30) a domenica 26 febbraio 2012
(pranzo compreso)
Le riflessioni saranno tenute da
Sr. Michela Vaccari delle Suore Orsoline
Teologa
Tema del corso:
“Vi trasmetto innanzitutto quello che anch’io ho ricevuto: la Parola che rende buona la vita” (1 Cor 15,3)
Iscrizioni e indicazioni organizzative
Le iscrizioni si ricevono presso Villa S. Carlo, chiamando il 0444/971031. All’atto dell’iscrizione va precisato se si desidera una camera singola o si accetta eventualmente anche una doppia, per favorire così una maggiore partecipazione. Il termine ultimo, per permettere all’Ufficio per l’Evangelizzazione e la catechesi di preparare il materiale occorrente e alla Casa di organizzare l’accoglienza, è martedì 21 febbraio 2012. Un consiglio: chi si iscrive partecipi all’intero corso. Ci rendiamo conto che, “prendersi” un tempo personale in un fine settimana non è una scelta semplice, soprattutto se si ha famiglia e si lavora, ma è anche vero che questa esperienza acquista significatività se vissuta nella sua interezza. Il “mini-percorso” proposto risulta poco utile se vissuto frammentariamente. Partecipare a questo tipo di ritiro quaresimale non è come ascoltare una relazione, quanto piuttosto creare uno spazio privilegiato nel corso dell’anno, per fermarsi un po’, meditare, stare con il Signore in un clima di silenzio e ascolto orante. Ognuno poi farà come può e come il Signore non mancherà di suggerire… Vi aspettiamo !!