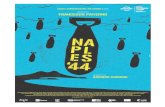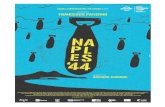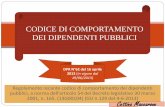sezione II civile; sentenza 27 gennaio 1997, n. 826; Pres. Patierno, Est. Paolini, P.M. Maccarone...
-
Upload
vincenzo-colonna -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of sezione II civile; sentenza 27 gennaio 1997, n. 826; Pres. Patierno, Est. Paolini, P.M. Maccarone...

sezione II civile; sentenza 27 gennaio 1997, n. 826; Pres. Patierno, Est. Paolini, P.M. Maccarone(concl. conf.); Ferraioli (Avv. Agresta) c. Condominio lungomare Matteotti 97/99, Pescara, ealtri (Avv. De Dominicis, Nuzzo, Di Baldassarre). Conferma Trib. Pescara 28 dicembre 1993Author(s): Vincenzo ColonnaSource: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 4 (APRILE 1997), pp. 1147/1148-1157/1158Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191402 .
Accessed: 24/06/2014 23:33
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.34.79.228 on Tue, 24 Jun 2014 23:33:28 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1147 PARTE PRIMA
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 27 gen naio 1997, n. 826; Pres. Paterno, Est. Paolini, P.M. Mac
carone (conci, conf.); Ferraioli (Aw. Agresta) c. Condomi
nio lungomare Matteotti 97/99, Pescara, e altri (Aw. De Do
minici, Nuzzo, Di Baldassarre). Conferma Trib. Pescara
28 dicembre 1993.
Comunione e condominio — Condominio negli edifici — Con
troversie — Intervento in appello del singolo condomino —
Ammissibilità (Cod. civ., art. 1130, 1131; cod. proc. civ., art.
344).
Il singolo condomino, che non abbia partecipato personalmente al giudizio di primo grado promosso dal condominio a tutela
di diritti su parti comuni dell'edificio, è legittimato ad inter
venire nel processo di appello. (1)
(1) Con il principio di cui in massima la corte risponde al rilievo, mosso dai ricorrenti, secondo cui non può ritenersi ammissibile l'inter
vento di alcuni condomini nel giudizio di secondo grado (in cui sia
regolarmente costituito il condominio in persona dell'amministratore), trattandosi di un intervento meramente adesivo (di «mero sostegno del la difesa del condominio»), quando — al contrario — il combinato
disposto di cui agli art. 344 e 404 c.p.c. consente unicamente l'inseri
mento, nel procedimento di appello, di posizioni giuridiche autonome
rispetto a quelle già dedotte in giudizio e suscettibili di essere pregiudi cate dalla decisione in procinto di essere resa. Il principio è stato soven te richiamato dalla Cassazione per risolvere contestazioni relative alla
legittimazione processuale (attiva o passiva; dell'amministratore o dei
singoli condomini) e decisive ai fini della definizione dei rispettivi pro cedimenti. Sotto questo profilo, la peculiarità del caso sta nella non decisività dell'obiezione sollevata dai ricorrenti, poiché il contestato 'in tervento' dei singoli condomini non ha (e, specularmente, la loro esclu sione non avrebbe) avuto — se non in termini di maggiori (o minori) spese processuali a carico dei soccombenti — alcuna incidenza risoluti va in ordine alla definizione del giudizio, per il fatto di costituire «mero
sostegno» ad una difesa già assunta dall'amministratore per conto del condominio. Ma tant'è, il tutto rientra nella pratica quotidiana dei gio chi e delle rappresaglie processuali.
Il principio non è, dunque, nuovo: configurando il condominio quale «ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei
singoli condomini», la conclusione a cui la Suprema corte perviene è che i singoli condomini possono (rientrando nella loro «facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominia
le») «sia intervenire nei giudizi in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore, sia proporre i mezzi d'impugnazione am missibili per evitare gli effetti, a loro sfavorevoli, di sentenze pronun ciate nei confronti del condominio rappresentato dall'amministratore»
(così Cass. 22 novembre 1986, n. 6881, Foro it., Rep. 1986, voce Co munione e condominio, n. 117; nei medesimi termini da ultimo Cass., 20 aprile 1995, n. 4468, id., Rep. 1995, voce cit., n. 65; 28 ottobre
1995, n. 11278, id., 1996, I, 1778, alla cui nota si rinvia per ulteriori
richiami). È bene precisare, peraltro, che si tratta di un litisconsorzio facoltativo: «quando il contraddittorio sia stato legittimamente instau rato tra un singolo condomino o un terzo, da una parte, e l'ammini stratore del condominio, dall'altra, non si pone un problema di integra zione necessaria del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, salva la loro facoltà di intervento nel giudizio» (in questi termini, De
Tilla, Sulle azioni proponibili dai singoli condomini, in Giusi, civ., 1994, I, 3159, spec. 3165). Diversamente, si è in presenza di un litiscon sorzio necessario — secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalen te — quando il terzo «opponga la proprietà esclusiva del bene conte stando il diritto di tutti i condomini, sicché la controversia riguardi l'esistenza stessa della condominialità e pertanto un rapporto soggettivo unico ed inscindibile, nel qual caso è necessaria la presenza nel processo anche degli altri condomini, dovendo la pronuncia avere effetto nei confronti di tutti» (Cass. 19 ottobre 1994, n. 8531, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 99; nello stesso senso, Cass. 22 dicembre 1995, n. 13064, id., Rep. 1995, voce cit., n. 102, e Riv. giur. edilizia, 1996, I, 476).
Nulla di nuovo, dunque: si deve riconoscere, però, che il motivo de dotto in ricorso — pur nella sua strumentalità — sollecita una riflessio ne più attenta sulla natura del rapporto che lega l'amministratore ai condomini. Infatti, configurandolo — semplicisticamente — come un
rapporto di 'rappresentanza ex mandato' (in questi termini si è espres sa, recentemente, anche Cass. 27 settembre 1996, n. 8530, Foro it., 1997, I, 872; su questo punto, v. più approfonditamente la nota che
segue) ed ammettendo — in linea con la giurisprudenza prevalente —
una piena fungibilità tra la posizione giuridico-processuale (ed il potere di agire a difesa dei diritti inerenti al condominio) dell'amministratore e quella dei singoli condomini, determinati a «far valere direttamente le ragioni in precedenza azionate per il tramite di un rappresentante» (in virtù di «una forma di rappresentanza reciproca, atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostitutiva scaturente dal fatto che ogni
Il Foro Italiano — 1997.
Svolgimento del processo. — Il condominio nell'edificio con
traddistinto con i nn. 97/99 del lungomare Matteotti di Pesca
ra, nonché Irma Cacciatore, costei anche nella qualità di com
ponente del condominio anzidetto in quanto proprietaria esclu
siva di unità immobiliare costituente porzione dell'edificio
cennato, con ricorso al Pretore di Pescara del 12 luglio 1989,
fecero presente che Nicola Ferraioli e la Alessandra s.r.l., ri
spettivamente, proprietario e conduttrice di locali siti al piano terreno del fabbricato condominiale, adibiti a sede di ristoran
te, avevano intrapreso nella chiostrina dello stabile dedotto in
controversia lavori di costruzione di una canna fumaria, che,
dopo aver attraversato «in senso orizzontale la chiostrina ad
un'altezza da terra di circa mi 2», era destinata a proseguire, in appoggio al muro condominiale, oltre il tetto dello stabile;
denunciarono che il manufatto in questione, realizzato in viola
singolo non può tutelare il diritto proprio senza necessariamente, e con
temporaneamente, difendere l'analoga posizione subiettiva di tutti gli altri»: negli stessi termini, Càss. 21 giugno 1993, n. 6856, id., Rep. 1993, voce Intervento in causa e litisconsorzio, n. 10, e Arch, locazioni, 1993, 717), non è possibile sottrarsi alla logica obiezione secondo cui la presenza contemporanea, nello stesso giudizio, del mandante (il con
domino/i) e del mandatario (l'amministratore) si rivela del tutto super flua (cfr. De Tilla, Azione del condomino per vizi dei beni comuni e responsabilità del costruttore-venditore, in Giust. civ., 1994, I, 2563,
spec. 2565). Rinviando, per quanto riguarda il problema (centrale) dell'esatta in
dividuazione del legittimato passivo nelle controversie che coinvolgono il condominio, ai rilievi svolti nella nota a Cass. 27 settembre 1996, n. 8530, cit., si deve sottolineare che un (più esile) filone giurispruden ziale si è orientato diversamente, rimarcando — significativamente ed
originalmente — la distinzione tra i poteri di azione ed intervento del l'amministratore e quelli dei singoli condomini: «la legittimazione pas siva ad processum spetta all'amministratore, o ai singoli partecipanti, a seconda che la lite abbia ad oggetto l'opposizione a un interesse co mune dei condomini — cioè si riferisca a cose o servizi comuni, o, comunque, all'edificio nel suo insieme — ovvero l'opposizione a inte ressi particolari dei singoli. E poiché, quando le delibere dell'assemblea condominiale non hanno per contenuto l'interesse esclusivo, bene indi
viduato, di uno o più partecipanti, esse riguardano direttamente o indi rettamente l'interesse dei condomini come tali, e tendono a soddisfare le esigenze della gestione collettiva, in tali ipotesi la legittimazione pas siva spetta all'amministratore del condominio (cfr. Cass. 3 settembre
1957, n. 3420, Foro it., Rep. 1957, voce cit., n. 167)» (così Cass. 12 marzo 1994, n. 2393, id., Rep. 1994, voce cit., n. 237; 12 marzo 1994, n. 2392, ibid., n. 208, e Giust. civ., 1994, I, 3159, con nota di De Tilla: la lettura contestuale delle due pronunce consente di cogliere, agevolmente, le divergenze nella ricostruzione del fenomeno; v. anche Cass. 29 novembre 1995, n. 12342, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n.
217, e Riv. giur. edilizia, 1996, I, 479; 26 marzo 1996, n. 2678, Foro
it., Mass., 262, secondo cui, nell'ipotesi di una polizza assicurativa sti
pulata dal condominio in persona dell'amministratore, i singoli condo mini non sono «individualmente legittimati ad agire in proprio nei con fronti della compagnia assicuratrice»; la circostanza che «il condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, non compor ta che... ciascun condomino possa sostituirsi all'amministratore stesso ed agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell'assicuratore ed il singo lo condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappre sentare l'ente di gestione, contraente della polizza nell'interesse di tutti i partecipanti al condominio»).
In definitiva, se si ritiene — è una constatazione pacifica — che la
rappresentanza processuale dell'amministratore (che — precisa Trib. Bo
logna 21 gennaio 1993, id., Rep. 1994, voce cit., n. 214, e Arch, loca
zioni, 1994, 367 — gli è «conferita direttamente dalla legge, senza ne cessità di una preventiva autorizzazione dell'assemblea»; analogamente, De Tilla, Sulle azioni proponibili dai singoli condomini, cit., 3164) non incontri dal lato passivo, ai sensi dell'art. 1131, 2° comma, c.c. «limite alcuno nelle controversie riguardanti cose o parti comuni» (v. Cass. 8 luglio 1995, n. 7544, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 171; 23 gennaio 1995, n. 735, ibid., n. 175; 29 ottobre 1994, n. 8946, id., Rep. 1994, voce cit., n. 203), è coerente concludere che la rappresentan za in giudizio spetti «inderogabilmente all'amministratore... restando in facoltà del singolo condomino di intervenire nella lite solo ad adiu vandum come portatore di un interesse proprio, e non come rappresen tante del condominio ancorché delegato dall'assemblea condominiale»
(Cass. 8 agosto 1989, n. 3646, id., Rep. 1989, voce cit., n. 151; cfr. anche Cass. 22 ottobre 1993, n. 10474, id., Rep. 1994, voce cit., n.
210); ma, allora, un intervento di questo tipo (meramente adesivo) nel
giudizio di appello, da parte del singolo condomino (terzo rispetto al l'interesse comune tutelato ed azionato dall'amministratore: il punto è sviluppato nella nota che segue), non dovrebbe, ai sensi dell'art. 344
c.p.c., ritenersi ammissibile. [V. Colonna]
This content downloaded from 195.34.79.228 on Tue, 24 Jun 2014 23:33:28 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
zione delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei condomini
il 4 luglio 1985, «occupava per circa 30 cm. e per tutta la sua
altezza i finestroni della scalinata, e, inoltre, distava appena 25 cm. dalle finestre degli appartamenti di proprietà di alcuni
condomini, fra i quali la Cacciatore Irma» illgittimamente dan
neggiando la proprietà condominiale e dei singoli condomini;
quindi, agendo ai sensi dell'art. 1171 c.c., chiesero, sulla scorta
delle esposte allegazioni, dichiararsi l'opera contestata lesiva del
loro possesso, e, a tutela di questo, disporsi la relativa rimozione.
Il pretore, dopo aver disatteso l'istanza di adozione di prov vedimenti interdittali, nel riscontrato intervenuto completamen to dell'opera denunciata, con sentenza del 25 gennaio 1991, re
* * *
Uniti e divisi: il (particolare) rapporto tra amministratore e condomini.
Sommario:
1. Premessa: il rapporto amministratore/condominio in due recenti pro nunce della Cassazione
2. La configurazione tradizionale dell'amministratore condominiale: un
mandatario dei singoli condomini. 3. La tesi che individua nella figura un titolare di un ufficio di diritto
privato. 4. Gli interessi coinvolti nell'attività amministrativa. 5. La rilevanza dell'organizzazione nel rapporto che lega i condomini
all'amministratore. 6. Il rischio di confondere (identificandoli) il rapporto di amministra
zione con il potere di rappresentanza. 7. II rifiuto di modelli ideologici rappresenta la premessa per l'identifi
cazione della reale dimensione degli interessi coinvolti.
1. - La sentenza offre lo spunto per brevi annotazioni sulla figura dell'amministratore condominiale, che dalla corte è qualificato come
'rappresentante ex mandato' dei componenti il condominio. Sembra ri
farsi alla più articolata elaborazione della figura svolta recentemente da Cass. 27 settembre 1996, n. 8530, Foro it., 1997, I, 872; in tale
pronuncia la corte ha riconosciuto la legittimità dell'azione di un ex
amministratore, indirizzata nei confronti dei singoli condomini, per il rimborso di somme anticipate durante (e nell'interesse del)la gestione condominiale sulla base della considerazione che l'«amministratore del
condominio configura un ufficio di diritto privato, oggettivamente orien
tato alla tutela degli interessi individuali dei condomini» e che «il rap
porto, analogo a quello del mandato con rappresentanza, si stabilisce
tra la persona nominata alla carica di amministratore ed i singoli con
domini»; la conclusione è che, risultando applicabile l'art. 1720, 1° com
ma, c.c., la domanda può essere proposta, cumulativamente, nei con
fronti «sia dell'amministratore in carica, sia dei singoli condomini» mo
rosi. La formula adoperata nella configurazione del rapporto amministratore/condominio è stata, a sua volta, ripresa (quasi alla let
tera) da Cass. 24 marzo 1981, n. 1720 (id., Rep. 1981, voce Comunione
e condominio, nn. 67-69, e, Giust. civ., 1981, I, 2018, con nota di
Basile), che aveva risolto un caso analogo. Nel precedente del 1981, la legittimità della pretesa dell'amministra
tore cessato dalla carica, nei confronti dei singoli condomini, è stata
fondata sulla considerazione che, mancando nel condominio i «tratti
minimi essenziali» di un «ente fornito di autonomia patrimoniale, di stinto dai condomini», il «rapporto, definibile — a grandi linee — di
cooperazione, di amministrazione del condominio si stabilisce tra la per sona nominata amministratore e i singoli condomini». Si tratta — pre cisava la Suprema corte — di un rapporto «tra l'incaricato e ognuno dei condomini, singolarmente... analogo a quello del mandato con rap
presentanza, pur differenziandosene nei tratti caratteristici peculiari della
costituzione... e del contenuto»; ne deriva che la cessazione dell'ammi nistratore dall'incarico non elimina la legittimazione, processuale e so
stanziale, passiva dei singoli condomini in occasione dell'azione di rim
borso (ex art. 1720, 1° comma, c.c.) delle anticipazioni fatte nell'esecu
zione dell'incarico, in quanto «il debito resta nei singoli condomini perché
per loro conto l'anticipazione avvenne». Fondatamente Basile, cit., 2023, ha intravisto in una simile ricostruzione del fenomeno condominiale
una decisa connotazione ideologica (per un'analisi complessiva delle scelte
e dei «valori che sottendono i principi codificati», v., sempre di Basile,
Regime condominiale ed esigenze abitative, Milano, 1979, 38 ss.): poi ché a quella negazione è pur necessario riconoscere un ruolo nel ragio namento della corte (non essendo idonea — secondo l'autore — a «le
gittimare la pur esatta soluzione della lite»), il sospetto è che la nega zione della dimensione collettiva, persino nel rapporto di amministrazione, serva a «riaffermare la preminenza che, nell'istituto condominiale, ha
l'individuo, e in specie... la proprietà individuale». La critica di Basile è, dunque, indirizzata alla motivazione con cui
«il Supremo collegio vorrebbe giustificare il carattere individuale del
l'obbligo di rimborso», inesatta «soprattutto perché presuppone erro
II Foro Italiano — 1997.
sa nel contraddittorio e nella resistenza, fra l'altro, di Nicola
Ferraioli e della Alessandra s.r.l., statuendo sul merito delle
azioni possessorie ravvisate esperite dagli istanti sunnominati, sul ritenuto presupposto che l'eseguita, illegittima, realizzazione
della ripetuta canna fumaria avesse comportato «spoglio del muro
perimetrale condominiale e, comunque, molestia del possesso condominiale», condannò i resistenti a rimuovere il manufatto
in argomento.
Sull'appello di Nicola Ferraioli e della Alessandra s.r.l., il
Tribunale di Pescara, con sentenza del 28 dicembre 1993, data
nel contraddittorio del condominio nell'edificio ai nn. 97/99 del
lungomare Matteotti del suddetto capoluogo abruzzese, nella
neamente che, per stabilire i connotati di tale obbligo, occorra accertare la natura individualista o collettivista del fenomeno condominiale, e del rapporto che vi inerisce». Cass. 8530/96 e Cass. 826/97 (in contesti
differenti) ripropongono ora, a distanza di quindici anni, il medesimo schema argomentativo, confermando la tenace resistenza di cui sono
capaci certi «muri» ideologici; soprattutto la lettura di Cass. 8530/96
rivela, anzi, che quanto appariva il sintomo di un contraddittorio cedi mento ideologico, è divenuto consapevole e coerente sistema, opzione dunque. Infatti, oltre a ribadire che il rapporto, analogo a quello del mandato con rappresentanza, si instaura tra l'amministratore ed i sin
goli condomini, la corte si è spinta a configurare l'amministratore con dominiale come «un ufficio di diritto privato, oggettivamente orientato alla tutela degli interessi individuali dei condomini e realizzante una
cooperazione, in regime di autonomia, con condomini singolarmente considerati» (anche Cass. 12 marzo 1994, n. 2392, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 208, e Giusi, civ., 1994, I, 3159, con nota di De Tilla, Sulle azioni proponibili dai singoli condomini, richiama la medesima formula — l'estensore è il medesimo di Cass. 8530/96: il cons. Corona — ed argomenta quasi negli stessi termini, parlando infatti di un «com
plesso» di interessi individuali alla cui tutela è orientato l'ufficio). Af fermazione davvero singolare nella configurazione del condominio, tale da far apparire la collettività dei condomini un puro dato casuale e la stessa regolamentazione codicistica dei rapporti condominiali — per usare un'espressione di Cass. 24 marzo 1981, n. 1720, cit. — un «dato accidentale».
Rappresenta, si diceva, una radicalizzazione in senso individualistico del ragionamento sviluppato dai giudici nel 1981 (e, in misura minore, anche di quello svolto nel 1994), i quali almeno, seppure in modo con traddittorio rispetto alla soluzione adottata, ammettevano che la «com
pressione dell'autonomia individuale» — vale a dire la circostanza che il rapporto amministratore/condomini sorga per effetto di una delibe
razione di gruppo, retta dal principio maggioritario, o di un provvedi mento dell'autorità giudiziaria su ricorso anche di uno solo di essi —
fosse un «fenomeno non porpriamente eccezionale laddove l'ordina mento dà rilevanza primaria alla collettività degli interessi di cui parte
cipi quello unisoggettivo»; riconoscevano che il contenuto di detto rap
porto fosse «qualificato dall'accezione "sociale" dell'interesse gestito, attinta dalla collettività degli interessi condominiali anziché dalla sfera individuale del singolo condomino, nonché dalla spiccata autonomia
dei poteri gestori rispetto alle autodeterminazioni di ciascun dominus»; e, soprattutto, individuavano in quello dell'amministratore «una sorta di ufficio di diritto privato oggettivamente orientato alla salvaguardia della collettività di interessi, alla cui gestione concorre con attribuzioni
primarie... e autonomo potere d'azione anche contro i singoli condomini». Non è dato cogliere le ragioni che hanno indotto ora la Cassazione
a rimuovere anche quell'ultimo (seppur contraddittorio) richiamo alla dimensione collettiva degli interessi amministrati. Probabilmente, costi tuisce la reazione (estrema, quanto ingiustificata) di chi guarda con preoc cupazione sia alle ricostruzioni svalutative del concetto di persona giuri dica (sull'argomento si rinvia a Inizitari, La vulnerabile persona giuri dica, in Contratto e impresa, 1985, 679; è ovvio — ha rivelato Pugliatti, La proprietà e le proprietà, in La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1964, par. 19, spec. 185 — che, dilatando i confini del concetto, «la formula che dovrebbe legittimare l'attribuzione della personalità giuri dica, si allarga sempre di più e proporzionalmente si attenua il morden te di essa, fino a che si giunge al massimo di genericità e di ambigui
tà»); sia alla tendenza, in atto su più versanti, a riconoscere una sogget tività giuridica, quindi un'attitudine ad essere titolari di rapporti giuridici, a soggetti, enti o collettività organizzate, non dotati di personalità giu ridica (Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati in
Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, 122; per una sin
tesi informativa, v. Basile, Associazioni, fondazioni, comitati, in Riv.
dir. civ., 1990, II, 201); sia al mero sospetto che il problema della per sonalità giuridica si vada riducendo ad un «problema di linguaggio»
(Rescigno, Associazione non ricoosciuta e capacità di testimoniare, pub blicato ora in Persona e comunità, Padova, 1987, 274) e sia alla soffer
ta constatazione che la prospettiva attuale (di un «diritto che tende ad
esprimersi come mera registrazione dell'accaduto, non come limite, im
pegnativamente vincolante, all'accadere») abbia reso «la "personalità giuridica" una mera convenzione linguistica o comunque un effetto di
This content downloaded from 195.34.79.228 on Tue, 24 Jun 2014 23:33:28 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1151 PARTE PRIMA 1152
contumacia di Irma Cacciatore e nell'intervento nel processo di Ferdinando Franci e di Elsa Tursini, successori a titolo parti colare della Cacciatore nella situazione da costei, a suo tempo, dedotta in controversia, nonché di Franca Tucceri, di Anna Maria
Perrone e di Umberto Trotta, componenti del condominio ap
pellato, rigettato il gravame, confermò l'impugnata decisione
pretorile. Il tribunale, dopo aver rilevato doversi ravvisare legittimo ed
ammissibile l'intervento nel processo della Tucceri, della Perro
ne e del Tortora, come detto, componenti della collettività con
dominiale attrice originaria, alla stregua dell'orientamento giu
risprudenziale secondo il quale, avuto riguardo al dato che il
tipo residuale» ed imponga di discutere di «effetti il cui ambito di rife ribilità in chiave soggettiva potrà determinarsi solo a posteriori (appun to sul già accaduto) senza necessariamente diventare centro unitario d'im
putazione di situazioni giuridiche soggettive, al di là degli esiti connessi al rapporto già instaurato» (Lipari, Spunti problematici in tema di sog gettività giuridica, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1988, spec. 647-648). Il discorso rischia di scivolare lungo l'accidentato (e suggestivo) sentie ro della configurazione soggettiva del condominio: ma, da un lato, la natura ed i limiti di queste note non consentirebbero di andare oltre la relatività di un'evocazione scientifica; dall'altro, il rischio sarebbe d'incorrere in un errore metodologico nel momento in cui si antepones se un'esposizione concettuale all'esame del tema specifico che, inevita
bilmente, da quella scelta di principio sarebbe orientato.
2. - L'unica premessa possibile è che nelle vicende condominiali sono coinvolti diversi centri di interesse: coesistono gli interessi del singolo condomino, quelli comuni alla collettività dei condomini e quelli del l'amministratore. Soprattutto, si rivela indispensabile cogliere la rela zione che lega la posizione di quest'ultimo alle prime due. Sotto questo profilo, le due recenti sentenze non introducono elementi di novità: individuano nell'amministratore un mandatario dei singoli condomini, facendo propria un'impostazione tradizionale (Salis Condominio negli edifici, voce del Novissimo digesto, Torino, 1957, III, 1140 ss., parla di «mandatario di persone singole») sottoposta recentemente ad una serrata ed.efficace critica (v. Amagliani, L'amministratore e la rappre sentanza degli interessi condominiali, Milano, 1992 spec. 119, 125, 170).
Non essendo opportuno, oltreché agevole, ritornare sulle diverse teo rie relative alla natura del condominio basterà ricordare che, se per una dottrina minoritaria (quanto autorevole: Branca, Comunione, Con dominio negli edifici, in Commentario Scialoja-Branca, cit., 1982, spec. 554 e 589) «l'amministratore non è né un mandatario, né un commesso, ma un organo», con la conseguenza che «a) le norme sul mandato...
valgono solo se non contraddicono ai principi propri dell'organo; b) l'amministratore, benché nominato dalla maggioranza dei condomini, li rappresenta tutti (come dice la legge), anche i dissenzienti, cioè rap presenta la collettività o ente condominiale», la conclusione comune alla dottrina e giurisprudenza prevalenti è il riconoscimento — nell'am ministratore — della figura di un mandatario con rappresentanza (v. la nota di richiami a Cass. 9 giugno 1994, n. 5608, Foro it., 1994, I, 3436; per ulteriori riferimenti dottrinari: Benacchio, Il condominio edilizio, Padova, 1969, 149; Corona, Contributo alla teoria del condo minio negli edifici, Milano, 1973, par. 36, spec, nota 61; più recente mente, si sono espressi per l'applicabilità della normativa generale in tema di mandato Girino-Baroli, Condominio negli edifici, voce del
Digesto civ., Torino, 1988, III, 418; Vinci-Gagliardi, Codice commen tato della comunione e del condominio, Padova, 1989, 1104).
La parziale compatibilità tra la disciplina dell'amministrazione con dominiale e quella del mandato ha indotto, però, alcuni autori ad esclu dere la natura volontaria o convenzionale del potere di rappresentanza. Soprattutto non è apparso «agevole — ha rilevato Benacchio, op. cit., 149 — conciliare un atto di autonomia privata con la obbligatorietà legale di cui all'art. 1129 c.c. E ancor più difficile è conciliare la figura del mandatario con la facoltà di agire contro il mandante (art. 1131, 1° comma) e con la determinazione legale dei poteri conferiti (art. 1130 e 1131 c.c.)». Inoltre, si è accertato come difetti, nella fattispecie, quel la «eguale legittimazione» all'espletamento dell'attività tendente alla rea lizzazione degli interessi programmati che — secondo Pugllatti, La rappresentanza in diritto privato, in Studi sulla rappresentanza, Mila no, 1965, 516 — caratterizza le ipotesi di rappresentanza volontaria, in quanto «nessuna fungibilità o equivalenza di effetti può sussistere tra l'attività dell'amministratore del condominio e quella eventualmente posta in essere dai condomini (pretesi mandanti)» (Amagliani, op. cit., 120: l'assunto è dimostrato nei par. 2-4 del cap. II; cfr., supra, le osser vazioni svolte nella nota di richiami); e che «l'attività dell'amministra tore (sia esecutiva che negoziale) si rivolge... alla soddisfazione di inte ressi di soggetti (che possono) non necessariamente (essere) condomini» (in questi termini, ancora Amagliani, op. cit., 124: il riferimento è alla figura dei conduttori). Da tali rilievi c'è chi ha inteso la rappresentanza di cui all'art. 1131 in termini di rappresentanza legale (Palmieri, L'am ministratore di condominio edilizio ed i suoi poteri rappresentativi in
Il Foro Italiano — 1997.
condominio è ente di gestione sfornito di personalità distinta
da quella dei suoi partecipanti, deve ritenersi il potere dei singo li condomini, oltre che di agire singolarmente a difesa dei diritti
comuni inerenti all'edificio condominiale, di intervenire, anche
in appello, nei giudizi a tal fine instaurati dall'amministratore
del condominio, motivò la pronuncia considerando, per quanto in questa sede ancora interessa, doversi escludere avere gli ap
pellanti acquisito il diritto di installare la canna fumaria in di
scussione nell'ambito delle parti comuni dell'edificio di cui trat
tasi sulla scorta delle statuizioni di una sua precedente sentenza
in data 27 aprile 1989, resa fra le stesse parti ed ormai divenuta
definitiva, posto che in tale sentenza, per come documentato
giudizio, in Dir. e giur., 1955, 112; Blandini, Sull'amministrazione di condominio di case, id., 1963, 372, che equipara la figura dell'ammini stratore a quella del tutore; sull'argomento v. Rezzonico, Condominio e responsabilità civile, Torino, 1992, 243); per Benacchio, pur trattan dosi di «una figura del tutto speciale» ed «in ultima analisi legale», «non si può trascurare di prendere in considerazione il fatto che... il
potere di scelta resta sempre in ultima analisi all'assemblea dei condo mini» e che la legge stessa non esclude «che sia in sede di nomina, sia in base al regolamento vengano attribuiti all'amministratore altri
poteri oltre quelli legali» (Bernacchio, op. cit., 150). Secondo Amagliani, «per quante deviazioni si possano ipotizzare ri
spetto alla figura del mandato, i due caratteri... evidenziati (e cioè l'in
dispensabile perseguimento dell'interesse del mandante ed il carattere sostitutivo dell'attività) non possono venire meno senza che venga del tutto compromessa la utilità del riferimento allo schema legale in di scorso» (op. cit., 124) e, invece, la legittimazione dell'amministratore «allo svolgimento di una porzione di attività (certamente di rilevanza non secondaria) non riconducibile al (contratto di) mandato» conferi rebbe «innegabilmente un carattere assai ibrido al fenomeno così rico struito» (op. cit., 177), così da far ipotizzare «l'esistenza di una fatti
specie contrattuale che sia in grado di essere utilizzata al fine di (tentare di) definire la struttura e rinvenire la disciplina dell'istituto in esame. Si tratterebbe, in sostanza, di un contratto non assimilabile al mandato, e quindi di un nuovo tipo di contratto, ma nel contempo di un contrat to tipico, in quanto disciplinato dalla legge: il contratto di amministra zione di condominio» (Amagliani, op. cit., 134; all'argomento è dedi cato il terzo capitolo della monografia).
3. - L'«inserimento dell'amministratore in un'organizzazione stabile, la configurabilità della sua posizione giuridica come potere-dovere, e la circostanza che i suoi compiti consistono in attività materiali, oltre che giuridiche» hanno indotto, invece, Basile, Condominio negli edifi ci. I. Diritto civile, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, Vili, 8, a considerarlo «più che un mandatario, come titolare di un ufficio di diritto privato». La ricostruzione è utile, ma — come ha osservato Amagliani, op. cit., 133, in nota 54 — non «appagante ed esaustivo» (il giudizio si fonda sull'autorevole opinione di Trimar chi, Esecutore testamentario (dir. priv.), voce dell' Enciclopedia deI di ritto, Milano, 1966, XV, 407, secondo cui l'ufficio (di diritto) privato è l'espressione... di aspetti o profili della realtà giuridica propria di vari istituti. Come non è mera descrizione, così non è modo esclusivo di qualificazione»). In effetti la figura (positivamente disegnata) del l'amministratore presenta, in forma più o meno marcata, quei tratti caratterizzanti un ufficio di diritto privato: il titolare dell'ufficio —
secondo la ricostrruzione operata da Trimarchi, voce cit., 407 — svol ge un'attività «per uno scopo che va oltre quello specifico di dati inte ressati o serve direttamente al conseguimento del fine istituzionale»; inoltre, «punti fermi» di un ufficio sono la presenza di un «interesse alieno, il dovere, il potere e l'agire in proprio nome...» ed il carattere necessario e doveroso «dell'agire e di intervento (sotto varia forma) della pubblica autorità» (l'argomento dell'ufficio di diritto privato è stato ripreso in più occasioni dagli autori impegnati nell'esame della figura dell'esecutore testamentario: il primo è stato Messineo, Contri buto alla dottrina della esecuzione testamentaria, Roma, la prima edi zione risale al 1923; v. anche Natoli, L'amministrazione dei beni eredi tari, Milano, 1947; Contorsi Lisi, L'esecutore testamentario, Padova, 1950; Candian, Del c.d. «ufficio privato», e, in particolare, dell'esecu tore testamentario, in Scritti giuridici in onore della Cedam ne! cin quantenario della sua fondazione, Padova, 1953, I, 211).
Mutuando le efficaci argomentazioni di Trimarchi (voce cit., 407-408) si può sostenere che, nella nostra ipotesi, è ben possibile configurare un ufficio di diritto privato, non rilevando in senso contrario né la circostanza che normalmente la nomina dell'amministratore sia frutto della libera inziativa e volontà dei condomini (solo in caso di inerzia dell'assemblea ad essa provvede l'«autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini»; art. 1129); ne che i condomini abbiano «il pote re di ampliare o di diminuire la sfera delle attribuzioni» dell'ammini stratore. Anche la fattispecie condominiale presenta — per usare anco ra le parole dell'autore richiamato — una «situazione giuridica sogget
This content downloaded from 195.34.79.228 on Tue, 24 Jun 2014 23:33:28 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
dalla relativa motivazione, non risultava contenuta nessuna de
claratoria suscettibile di imporre agli appellati «la subiezione
del loro diritto di compossesso ad altro esclusivo del Ferraioli
e della Alessandra s.r.l.» e di comportare «costituzione di una
servitù coattiva ...né il regime della medesima, né la sua impo sizione fra il bene condominiale e quello di esclusiva proprietà del condomino Ferraioli», detenuto dall'altra appellante in ve
ste di conduttrice, e, perciò, in una qualità non idonea a legitti mare la insorgenza di suoi diritti reali nei riguardi delle con
troparti. Nicola Ferraioli e la Alessandra s.r.l. ricorrono, con quattro
motivi, per la cassazione della suindicata sentenza di secondo
grado, notificata il 3 febbraio 1994.
tiva complessa rappresentata da doveri di gestione da attuarsi a mezzo di congrui poteri»; una gestione «imparziale, rappresentata da attività
giuridiche... funzionalmente collegate con gli interessi da tutelare». Il richiamo all'idea di ufficio di diritto privato è utile, però, nella
misura in cui evidenzia l'alterità del profilo della rappresentanza dei
soggetti (art. 1131) da quello della tutela degli interessi condominiali che si realizza attraverso quelle attività e quei poteri che la legge attri buisce all'amministratore (art. 1130). Non è necessario ricorrere all'isti tuto della rappresentanza per spiegare perché gli atti posti in essere dal l'amministratore (anche quello nominato dall'autorità giudiziaria) nel
l'espletamento delle sue funzioni siano vincolanti per i partecipanti al condominio (in deteminate circostanze, infatti, sono vincolati anche sog getti estranei al rapporto come i conduttori); come, specularmente, non la sola circostanza di essere condomini vincola agli atti compiuti dal l'amministratore (si pensi all'ipotesi di cui all'art. 1123, 3° comma). Ciò dipende dal fatto che l'amministratore è «fornito di una specifica legittimazione» (la conclusione, riferita all'esecutore testamentario, è di Natoli, op. cit., II, 342); incongruente è, per contro, il ricorso esclu sivo all'istituto della rappresentanza (ex lege o ex mandato) dei condo
mini, che non riesce a spiegare un'attività diretta alla cura di interessi
(dei singoli condomini) potenzialmente (spesso realmente) in conflitto tra loro e, addirittura, a volte diretta proprio contro l'interesse egoisti co del condomino.
Gli interessi coinvolti nell'agire dell'amministratore sono diversi, il
più delle volte antagonistici; variamente si compongono e trovano tute la nell'attività posta in essere dall'amministratore (è Cass. 21 maggio 1973, n. 1464, Foro it., 1973, I, 1513, ad evidenziare che i poteri ed i limiti «della rappresentanza attiva e passiva dell'amministratore... so no condizionati dal vario interferire fra situazioni individuali e situazio ni collettive in ordine agli interessi che nell'ambito del singolo condomi nio esigono protezione e tutela»). Non è possibile considerarli in bloc
co, perché il loro antagonismo non consente una contestuale difesa da
parte di un solo soggetto, il che potrebbe realizzarsi solo indirettamente
quale effetto della difesa di un interesse soprastante; d'altro canto, l'am ministratore non potrebbe neanche tutelare uno solo di essi (ora l'uno, ora l'altro), in quanto, così facendo, verrebbe meno alle ragioni ed alla funzione stessa del suo incarico (il suo ufficio), cioè la tutela del
l'interesse comune (l'espressione non a caso ricorre nell'art. 1130, n.
2) a tutti i partecipanti (tali rilievi rappresentano lo svolgimento di alcu ne considerazioni di Candian, cit., 229).
In questa sede preme sottolineare l'inadeguatezza dell'art. 1131 (il riferimento, cioè, alla rappresentanza dei partecipanti) a spiegare (e qua lificare le funzioni che l'amministratore è doverosamente chiamato a
svolgere secondo) l'art. 1130: è il primo, infatti, a presupporre il secon
do, assicurando a quelle attribuzioni uno strumento tecnico-giuridico come il potere di rappresentanza. L'art. 1131 ed il richiamo della giuris prudenza e dottrina prevalenti al contratto di mandato rispondono al
l'esigenza (sottolineata anche da Amagliani, op. cit., 132, ivi ulteriori richiami alla nota 53) di «individuare, con riferimento alle specifiche
ipotesi, gli strumenti tecnico giuridici nei quali si sostanziano» i poteri dell'amministratore; peraltro, il rimando alla fattispecie contrattuale del
mandato è utile a spiegare il carattere doveroso delle funzioni, non po tendo che derivare da un'assunzione volontaria del corrispondente ob
bligo (si tratta, naturalmente, dell'ipotesi normale; diverso è il caso del
l'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria).
4. - Sotto questo profilo, la richiamata Cass. 8530/96 si apprezza
per aver confermato, come nel precedente del 1981 (e del 1994), la com
patibilità della figura del mandatario con quella del titolare di un uffi
cio di diritto privato. I motivi della soddisfazione si fermano, purtrop
po, qui; nel tentativo, infatti, di identificare il/i soggetto/i dell'interes
se correlato ai doveri dell'ufficio, la corte parla di un rapporto di
cooperazione che si instaura tra l'amministratore ed i singoli condomi
ni, e di un ufficio orientato alla tutela degli interessi individuali, incor
rendo, in tal modo, in una serie di incongruenze e contraddizioni: ridu
ce la funzione stessa dell'(ufficio di) amministratore ed il rapporto (di
mandato) che lega l'amministratore ai partecipanti ad una dialettica tra
singoli; trascura del tutto sia la centralità dell'art. 1130, che il testuale
richiamo all'interesse comune operato dal legislatore nello stesso artico
li. Foro Italiano — 1997.
Il condominio nell'edificio ai nn. 97/99 del lungomare Mat teotti di Pescara, da un lato, Ferdinando Franci, Elsa Tursini, Franca Tucceri, Umberto Tortora ed Anna Maria Perrone, dal
l'altro, resistono al ricorso, notificato il 5 aprile 1994 (tempesti vamente, essendo stati festivi il 3 e il 4 aprile 1994), con distinti
controricorsi, rispettivamente, dell'11 maggio 1994, e del 16 mag
gio 1994 (tempestivamente, essendo stato festivo il 15 maggio 1994).
Irma Cacciatore, cui il ricorso è stato notificato il 7 maggio 1994, si è astenuta da ogni attività difensiva nella presente sede.
Così i ricorrenti, come i controricorrenti Ferdinando Franci, El
sa Tursini, Franca Tucceri, Umberto Tortora ed Anna Maria
Perrone hanno depositato memoria.
lo (questa semplificazione è operata anche nella sentenza in epigrafe quando rileva che, con l'intervento in giudizio, il condomino fa valere direttamente le ragioni in precedenza azionate per il tramite di un rap presentante», identificando così l'interesse del singolo con quello difeso
dall'amministratore); confonde, inoltre, i piani di operatività degli art. 1130 e 1131, elevando uno strumento (la rappresentanza dei partecipan ti) a sostanza del rapporto, un mezzo a fine. Se, al contrario, si vuol dare un senso al richiamo — apprezzabile, a parere di chi scrive, per i motivi che si sono evidenziati — alla figura dell'ufficio, è indispensa bile guardare all'art. 1130; è lì che il legislatore ha definito il contenuto del rapporto che lega l'amministratore ai partecipanti al condominio e la funzione della figura dell'amministratore nel contesto condominia
le; il richiamo all'art. 1131 potrà essere utile solo per definire la forma della sua azione.
Queste considerazioni inducono a ritenere, con cautela, «applicabili in linea di massima, per analogia, al rapporto fra l'amministratore e i condomini le norme che regolano il mandato, che non siano in contra sto con le norme o i principi relativi alla fattispecie specifica dell'ammi nistratore di condominio» (in questi termini, Benacchio, op. cit., 151). Devono indurre, soprattutto, a distinguere l'interesse alla gestione che si manifesta con il conferimento dell'incarico, dall'interesse della (atti vità di) gestione che si realizza con il concreto esercizio delle attribuzio ni di cui all'art. 1130: in ogni caso, l'interesse particolare del singolo condomino non è oggetto di tutela immediata e diretta.
Dal primo punto di vista, è la stessa struttura dell'atto (la delibera zione assembleare di nomina) a rivelare l'esistenza di un unico centro di interessi e di una parte contrattuale unitaria, pur in presenza di una
pluralità di soggetti; se, dunque, il rapporto contrattuale «lega l'ammi nistratore al gruppo dei condomini unitariamente considerato», la con
seguenza è che «l'attività del primo deve curare il raggiungimento del l'interesse imputabile al secondo» (sul punto, ampiamente, Amagliani,
op. cit., 166 ss.). Il problema è che, così presentata, la conclusione non sembra chiarire quale sia l'interesse che coagula la pluralità dei condomini: evitando opportunamente di ricorrere alle tanto vituperate formule quali «interesse collettivo» o «interesse di gruppo», è possibile isolare un interesse (comune a tutti partecipanti al condominio) che si identifica nel ruolo stesso dell'amministratore, nella necessaria presenza di un punto di riferimento (stabile ed unitario) delle aspettative di tutti i condomini; un interesse, appunto, alla gestione, all'azione ammini strativa delineata nell'art. 1130, a cui risponde l'assunzione di un obbli
go al compimento di quelle attività, non certo di un obbligo alla tutela dell'interesse del singolo condomino (si è già detto della possibilità di un'azione rivolta contro il condominio; si può parlare — richiamando
Pugliatti, La proprietà e le proprietà, cit., 188 — di una «rappresen tanza di interessi, anziché di volontà», di un soggetto che non «è legitti mato, dunque, dal negozio di mandato dei componenti, né rappresenta la loro volontà: è legittimato dalla legge... La legge ha creato la rappre sentanza della collettività, in vista della realizzazione dell'interesse di
essa, e non già una rappresentanza dei singoli, in base alla loro volontà»). Per quanto riguarda il secondo profilo, gli interessi individuali acqui
stano sicuramente rilevanza, in quanto sono variamente coinvolti nel concreto espletamento dell'attività gestoria: è compito dell'interprete, nella relatività delle situazioni, identificare il/i soggetto/i portatori de
gli interessi concretamente tutelati con lo specifico atto di amministra
zione; nel già evidenziato vario interferire delle situazioni giuridiche sog
gettive, gli interessi variano a seconda dell'attività e delle attribuzioni
esercitate, a seconda delle circostanze che motivano il loro esercizio.
Proprio quell'episodico (spesso contraddittorio) variare delle situazioni
incrina la linearità della relazione che caratterizza il mandato con rap
presentanza, dell'agire in nome e per conto di determinati soggetti, ed
induce ad escludere che l'attività dell'amministratore sia diretta (com'è enfaticamente sostenuto nelle sentenze) alla tutela dell'interesse dei «con
domini singolarmente considerati». L'attuazione di tali interessi si può
configurare solo come effetto, riflesso ed indiretto, della realizzazione
del (logicamente) primario interesse alla gestione; un interesse, quest'ul
timo, non soprastante (superindividuale, collettivo o di gruppo), sem
plicemente diverso — qualitativamente — (da quello individuale), in
quanto comune a tutti i condomini e, quindi, realizzabile solo nella
dialettica tra l'amministratore e tutti i condomini (tant'è che solo l'as
This content downloaded from 195.34.79.228 on Tue, 24 Jun 2014 23:33:28 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1155 PARTE PRIMA 1156
Motivi della decisione. — 1. - Il condominio nell'edificio ai nn. 97/99 del lungomare Matteotti di Pescara, ed Irma Caccia
tore, componente della collettività condominiale considerata, han
no introdotto nel presente giudizio un'azione intesa ad ottenere
la tutela del possesso vantato su una chiostrina, su un muro
perimetrale e sui finestroni della scalinata integranti parti co
muni dell'edificio cennato che hanno sostenuto essere stato leso
dalla realizzazione della canna fumaria di cui in narrativa, in
trapressa e completata da Nicola Ferraioli, egli pure partecipe del condominio, in quanto proprietario di unità immobiliari in tegranti porzione del piano terreno del fabbricato condominia
le, e dalla Alessandra s.r.l., detentrice a titolo locatizio delle
semblea può nominare e revocare l'amministratore, gli può attribuire
maggiori poteri ed impartire direttive).
5. - Di tale realtà il codice mostra le tracce; a rivelarle vi sono alcune
(rare) pronunce. Marita di essere segnalata Cass. 17 aprile 1974, n. 1046, Foro it., 1974, I, 2360, secondo cui si è in presenza di un «mandato ad amministrare conferito da più soggetti organizzati in gruppo». Si
evidenzia, usualmente (v., Basile, voce cit., 8; De Tilla, Sulle azioni
proponibili dai singoli condomini, cit., 3163) come la giurisprudenza tenda prevalentemente a concepire il rapporto che vincola l'amministra tore all'insieme dei condomini in termini di mandato collettivo (così, tra le altre, Cass. 5 aprile 1982, n. 2085, Foro it., Rep. 1983, voce
cit., n. 72, e Giur. it., 1983, I, 1, 989; Trib. Milano, ord. 29 settembre
1993, Foro it., 1994, I, 1967; v. anche Cass. 24 dicembre 1994, n. 11155, id., 1995, I, 1867, con osservazioni di Piombo, e Corriere giur., 1995, 476, con commento di Izzo, che, pronunciandosi a favore della possibi lità che l'amministrazione del condominio sia affidata ad una società di persone, individua nel condominio il mandante e rileva un «notevole
parallelismo» tra la disciplina delle società semplici ove il potere di am ministrazione deriva «da un rapporto di mandato fra la collettività dei soci ed il socio amministratore» e quanto dispone l'art. 1131).
Differenze sostanziali (si pensi all'inconciliabilità del dettato dell'art. 1129 con quello dell'art. 1726) fanno, invece, preferire la formula più elastica adottata da Cass. 17 aprile 1974, n. 1046, cit.: un mandato conferito da una pluralità di individui inseriti in un'organizzazione e vincolati alla sua disciplina (legislativa e regolamentare); il condominio è caratterizzato «da una peculiare «organizzazione di gruppo» normati vamente strutturata ed inderogabilmente imposta, la quale per l'un ver so circoscrive e disciplina i rapporti interni fra i condomini in un ambi to preciso, caratterizzato a sua volta dall'operare del criterio della quo ta e del principio maggioritario; e per altro verso, anche nell'interesse dei terzi, fa sì che il gruppo si presenti all'esterno come tale, per il tramite di una unitaria rappresentanza». Si tratta — spiegava la corte» di riconoscere «la esistenza di una serie di situazioni giuridiche tipica mente collettive, che come tali si esplicano nei confronti e dei partecipi e dei terzi», e di constatare come, senza che sia necessario «ricorrere alla nozione di soggettività giuridica... la reductio ad unitatem di cui il governo della maggioranza costituisce strumento e sintomo, faccia sì che la volontà prevalsa in sede di delibarazione assembleare si ponga come volontà comune, vincolante anche nei riguardi dei dissenzienti...; faccia sì che nei limiti delle attribuzioni demandategli dalla legge o dal
regolamento, ovvero dei poteri efficacemente conferitigli dall'assemblea, l'amministratore del condominio, col declinare tale sua qualità, spenda implicitamente il nome di tutti i partecipi, tutti impegnandoli nei con fronti dei terzi; faccia sì, infine, che all'amministratore competano..., entro siffatti limiti, il potere di agire in giudizio e contro i terzi e (addi rittura) contro i condomini».
Emerge, dunque, una figura che non può e non deve obbedire ad alcuno dei condomini 'singolarmente considerati': «questo alcuno —
evidenziava Candian, op. cit., 216, in riferimento alla generale figura del titolare di ufficio — non esiste, perché, i destinatari dell'attività dell'ufficiale essendo necessariamente e immediatamente una pluralità, non si potrebbe obbedire ad alcuno senza violare, o rischiare di violare, gli interessi di un altro o di più altri»; l'ufficiale-amministratore «obbe disce alla legge della funzione affidatagli» ed alle indicazioni provenien ti dall'assemblea; non spende il nome di 'alcuno singolarmente conside
rato', dichiara solo la propria qualità o funzione. Si può accogliere, dunque, l'efficace conclusione di Cass. 17 aprile 1974, n. 1046, cit., secondo cui «la prefigurazione legale di tanti e così notevoli aspetti del contenuto del rapporto, anche se reca in sé qualche suggestione, per una qualificazione di quest'ultimo come rapporto organico, non contrasta in nulla con la preferenza costantemente accordata da questa corte all'inquadramento entro lo schema del mandato... con l'ulteriore risultato di sottolineare in maniera ancora più chiara la duplice facies della figura dell'amministratore: contraente in ordine al contratto di mandato nei confronti dell'intero gruppo, e quindi ad esso estraneo ed in certo senso contrapposto; abilitato ad operare all'interno del gruppo, e nei confronti dei singoli partecipi, nel momento esecutivo del contrat
to, in quanto e per quanto ciò comportano le sue attribuzioni, da ri
guardarsi come contenuto necessario e tipico della sua prestazione».
Il Foro Italiano — 1997.
unità immobiliari appartenenti all'altro suddetto attuale ri
corrente.
Il Pretore di Pescara, investito della cognizione dell'azione
in argomento, ne ha sanzionato l'accoglimento con l'altrove ri
cordata sentenza del 25 gennaio 1991, conclusiva del primo sta
dio del processo. Nicola Ferraioli e la Alessandra s.r.l. hanno proposto appello
avverso la citata sentenza pretorile, chiedendone l'integrale ri
forma ed instando per la pronuncia di decisione recante la loro
assoluzione dall'avversa pretesa. Nel giudizio di secondo grado conseguentemente instaurato
dinanzi al Tribunale di Pescara, nell'avvenuta costituzione del
Ne deriva «una corrispondente duplicità di posizioni giuridiche, ricon
ducibili, appunto, le une ai rapporti esterni, e le altre ai rapporti interni
della sfera condominiale».
6. - L'idea, poi, secondo cui i condomini «non costituiscono un ente, sono e rimangono persone distinte, che acquistano od assumono, cia
scuno per le cose di sua proprietà e, proporzionalmente al valore di
queste (art. 1118 c.c.), per le cose comuni, rispettivamente, diritti ed
obblighi» (Saiis, voce cit., 1140; Id., Il condominio negli edifici, in
Trattato Vassalli, Torino, 1959, 271), ripresa e sviluppata da Corona — peraltro, estensore delle citate sentenze 8530/96 e 2392/94 — per il quale l'amministratore anche «quando agisce o è convenuto in rap
presentanza di tutti i condomini, non rappresenta un ente, un soggetto distinto dai partecipanti, ma i singoli condomini», dunque «nel condo minio i partecipanti sono gli unici diretti responsabili per le obbligazio ni assunte per la cosa comune» (Corona, op. cit., 149, ed ivi le note 29 e 30; in questo senso anche A. Lener, Potere (dir. priv.), voce del
Enciclopedia del diritto, Milano, 1985, XXXIV, 631) e confermata dalla sentenza in rassegna è frutto di quell'evidenziata sovrapposizione di piani, che induce ad identificare ed esaurire il rapporto di ammini strazione nel potere di rappresentanza, anziché cogliere in questo un mero strumento tecnico-giuridico attraverso cui il gruppo si presenta all'esterno nel momento esecutivo del contratto (può valere, in questo contesto, la considerazione di Pugliatti, La proprietà e le proprietà, cit., 188, secondo cui parlare di «rappresentanza d'interessi» significa unicamente «mettere in rilievo il fatto che la legge prende direttamente in considerazione gli interessi (di quei soggetti) e predispone la rappre sentanza come strumento tecnico per la tutela di essi»).
Peraltro, i due profili si presentano, in specifiche ipotesi, ben distinti; e come tali, in (a dire il vero, rare) circostanze, sono stati colti dalla
Suprema corte È Cass. 22 ottobre 1993, n. 10474, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 210, e Riv. giur. edilizia, 1994, I, 465, a cogliere la sostan za della questione, quando si preoccupa di distinguere il ruolo ed i po teri di un soggetto (condomino o terzo) a cui l'assemblea degli utenti del servizio di riscaldamento (proprietari e conduttori delle singole uni tà immobiliari) abbia affidato la gestione del servizio, da quelli dell'am ministratore nominato (dai soli proprietari) ai sensi dell'art. 1129: poi ché l'assemblea degli utenti è «organo del condominio» e ne esprime «la volontà», il primo (incaricato da questa assemblea) è un «mandata rio dei condomini e, stipulando il contratto di fornitura... in nome e
per conto dei mandanti» impegna «direttamente i condomini»; ciò non
esclude, però, che legittimato passivo, anche in ordine a quegli atti, continui ad essere l'amministratore, poiché «la rappresentanza in giudi zio del condominio spetta inderogabilmente, a norma dell'art. 1131 c.c., all'amministratore nominato dall'assemblea dei condomini prevista dal l'art. 1129». È Cass. 24 dicembre 1994, n. 11155, cit., — chiamata, s'è detto, a pronunciarsi sull'ammissibilità di un'amministrazione affi data ad una società di persone — a domandarsi, mancando fra le nor me sul condominio «una disposizione che individui, tra più amministra
tori, quello tenuto a rappresentare il condominio nei rapporti con i
terzi», quale sia la relazione tra il potere di rappresentanza e quello di amministrazione: alla luce del segnalato parallelismo tra la disciplina dell'amministrazione della società semplice (in cui è, tra l'altro, previ sto nell'art. 2266, 2° comma, che "in mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministrato
re") e quanto dispone l'art. 1131, secondo cui «la rappresentanza ap partiene a chi ammininistra, la mancanza della norma di cui sopra —
conclude la corte — lungi dall'escludere la possibilità di configurare come legittima una pluralità di amministratori, comporta, in linea di
principio, l'attribuzione a tutti i soggetti che amministrano, della quali tà di rappresentanti del condominio, anche rispetto ai terzi. Sarà com
pito dei condomini, per una migliore organizzazione al fine di evitare conflitti nell'azione dei vari amministratori, predisporre regole che ri
partiscano le competenze di ciascuno con esclusiva validità nei rapporti interni».
7. - Risulta parzialmente confermata l'affermazione secondo cui non è possibile configurare la figura dell'amministratore condominiale qua le rappresentante dei singoli condomini, in quanto «la gestione — e,
This content downloaded from 195.34.79.228 on Tue, 24 Jun 2014 23:33:28 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
condominio appellato e nella contumacia della Cacciatore, han
no spiegato interventi nella causa, fra l'altro, Franca Tucceri, Anna Maria Perrone ed Umberto Trotta, componenti della col
lettività condominiale attrice originaria, per sostenere le ragioni da questa fatte valere e per sollecitare la conferma della decisio
ne impugnata. Il tribunale, disattendendo le contestazioni sollevate al riguardo
da Nicola Ferraioli e dalla Alessandra s.r.l., ha dichiarato am
missibile l'intervento nel processo dei tre summenzionati con
tendenti, richiamando, a sostegno della pronuncia resa sul te
ma, la giurisprudenza di questa Corte suprema per la quale «il
condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quelle dei suoi partecipanti, sicché l'esistenza del
l'organo rappresentativo unitario — amministratore — non pri va i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti sia esclusivi che comuni, inerenti all'immobile condominiale, né, in conseguenza, di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia
stata assunta dall'amministratore, nonché di avvalersi dei mezzi
di impugnazione e anche di intervenire in appello per evitare
gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti
dell'amministratore».
Nicola Ferraioli e la Alessandra s.r.l., con il primo motivo
di ricorso, censurano la pronuncia resa sul punto dal giudice del merito, denunciandola viziata da «violazione o falsa appli cazione dell'art. 344 c.p.c.»: più specificamente, sulla premessa che la considerata disposizione giurisprocessualistica, preveden do che «nel giudizio di appello è ammesso solo l'intervento dei
terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404»
c.p.c., e, cioè, di soggetti titolari di un diritto autonomo rispet to a quelli dedotti in discussione dai contendenti, e però suscet
tibile di essere pregiudicato dalla decisione in procinto di essere
resa su questi, consentirebbe in secondo grado solo l'intervento
quindi, la posizione del soggetto al quale viene affidata — si colloca
autonomamente tra le situazioni di interesse di soggetti tra di loro in
palese conflitto» e «con funzione strumentale, nel quadro di un fine
più vasto e sostanzialmente di ordine pubblico» (Natoli, La rappresen tanza, Milano, 1977, 34 e 36; dissente Amagliani, op. cit., 121 in nota
20). In realtà, senza richiamare concetti di complessa portata (come l'or
dine pubblico) e, soprattutto, senza scomodare (come, purtroppo, si
è finora fatto) categorie storiche o modelli ideologici (individualista o
collettivista?), si può, con una certa ragionevolezza, ritenere che l'orga nizzazione (la cui più articolata espressione è la figura dell'amministra
tore) della pluralità di soggetti rappresenta l'obiettivazione completa del
l'interesse del singolo, che non avrebbe modo di realizzarsi se non in
una dimensione pluralistica, perciò necessitata; il fatto che il godimento delle unità raffiguri il fine ultimo — ha argomentato, nel 1973, Coro
na, op. cit., 140 e 141 — non esclude che «l'organizzazione strumentale
sia caratterizzata dalla subordinazione degli interessi individuali dei par
tecipanti (il fatto organizzativo, di per sé, esige una certa subordinazio
ne degli organizzati)», come pure non si può escludere a priori che
«positivamente il godimento delle proprietà solitarie e l'uso delle parti comuni siano subordinati alle necessità della convivenza». Non ha sen
so, dunque, continuare a puntualizzare che l'interesse rappresentato è
individuale, in quanto è chiaro che lo è nella misura in cui è di tutti
o, meglio, comune a tutti, ma con nessuno identificabile. Ecco perché è prferibile parlare di interesse comune; il ricorso a tale formula ellittica
(desunta dal codice: art. 1130) ha il pregio di evitare l'equivoco che
può ingenerare il riferimento ai singoli, alla dimensione individuale, quasi che il codice si proponesse di disciplinare un rapporto di vicinato, una
forma sì più intensa, ma pur sempre riconducibile al dato accidentale
della mera vicinanza di interessi, e non della loro (necessaria e necessi
tata) comunanza.
Significativa, d'altra parte, è la terminologia impiegata dal legislato re: nell'art. 1131, 1° comma, precisa che «l'amministratore ha la rap
presentanza dei partecipanti»; non dunque dei singoli condomini o pro
prietari (i termini normalmente adoperati in questa parte del codice), con ciò sottolineando la dimensione partecipata (quindi meta-individuale) dell'interesse. Ad essere rappresentato non è il singolo condomino, ma
questo in quanto partecipe di una sfera unica (o, se si preferisce, comu
ne) di interessi, un'identità del tutto spersonalizzata ed oggettivata in
un'astratta posizione giuridica: quella del partecipante, titolare di un
interesse identico a quello di tutti i partecipanti. Quell'interesse si esau
risce nel rispetto delle norme (legislative e regolamentari) sull'organiz zazione del condominio; parallelamente, l'amministratore realizza e sod
disfa l'interesse dei partecipanti, semplicemente esercitando le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge e, eventualmente, dal regolamento: «va considerato — ha osservato Trib. Milano, ord. 29 settembre 1993,
cit. — che pur trattandosi di un mandato collettivo, ciascun condomino
ha il diritto soggettivo di fruire di una corretta gestione dei beni e dei
Il Foro Italiano — 1997.
principale, assumono non essere riscontrabile nella fattispecie una situazione del genere di quella prevista dalla disposizione cennata, per essere la Tucceri, la Perrone ed il Trotta intervenu
ti nel processo esclusivamente ai fini di un «mero sostegno della
difesa del condominio».
Il mezzo non è fondato. In proposito, è da dire che, giusta
quanto ortodossamente ritenuto dal tribunale, in ragione della
peculiare natura del condominio, concepito dal sistema come
ente di gestione sfornito di personalità distinta da quelle dei
suoi componenti, nonché del dato che costoro devono intender
si rappresentati ex mandato dall'amministratore della collettivi
tà condominiale, l'iniziativa giudiziaria da quest'ultimo intra presa a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca, atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostitutiva sca
turente dal fatto che ogni singolo non può tutelare il diritto
proprio senza necessariamente, e contemporaneamente, difen
dere l'analoga posizione subiettiva di tutti gli altri (cfr., in tale
senso, ex aliis, la recente Cass. n. 11278 del 28 ottobre 1995, Foro it., 1996, I, 1778, e, prima, sent. n. 12304 del 14 dicembre
1993, id., Rep. 1994, voce Comunione e condominio, n. 209).
Consequenzialmente, è da ritenere che il condomino che «in
terviene» personalmente nel processo istituito dall'amministra
zione del condominio per far valere diritti della corporazione condominiale non è un terzo che si intromette in una vertenza
in corso fra estranei, ma è una delle parti originarie determina
tasi a far valere direttamente le ragioni in precedenza azionate
per il tramite di un rappresentante: non può essere considerato,
quindi, un interventore in senso proprio, e deve escludersi nei
suoi riguardi l'applicazione dei principi in materia di intervento
dei terzi nel processo di appello, di cui all'art. 344 c.p.c. (Omissis)
servizi comuni e delle somme che versa e di vedere rispettate le norme di legge e regolamentari».
Si è in presenza di una organizzazione che, lungi dal ridursi a mero servizio accessorio e strumentale al godimento della proprietà indivi
duale, diviene essa stessa utilità che contribuisce a definire l'oggetto del diritto di proprietà. L'appartenenza, in tale contesto, non si limita a cogliere la relazione che intercorre tra il bene individuale e la situazio
ne giuridica soggettiva, ma fissa l'inserimento di quella situazione in
un contesto pluriindividuale la cui ampiezza — inevitabilmente — de
termina (non semplicemente l'uso, ma) la stessa individuazione del be
ne, oggetto del diritto di proprietà (per l'efficace considerazione secon
do cui ad individuare il bene in senso giuridico, quale «cosa che può formare oggetto di diritti», sia la situazione giuridica — riconosciuta e tutelata dall'ordinamento — che su di esso insiste, e non la cosa nella
sua materiale consistenza, si rinvia a M. Costantino, Beni in generale, in Trattato diretto da Rescigno, Torino, 1982, voi. VII): diritto di ac
cesso alle utilità (beni e servizi) comuni e diritto all'esclusività del godi mento del bene individuale (right of access e right of esclusion, concetti — tradizionalmente tenuti distinti e separati a rimarcare la differenza
tra beni inclusivi e beni esclusivi — su cui si rinvia alle pagine introdut
tive di Jannarelli al cap. Ill «Beni, interessi, valori» del volume Dirit
to privato europeo, a cura di Lipari, Padova, 1996) costituiscono pro fili differenti, ma — nella dimensione condominiale — inscindibili, che
valgono a definire la posizione giuridica del condomino-partecipante. La disciplina codicistica interviene a regolare il regime di appartenenza dei beni condominiali, costituendo un sistema di norme (un'organizza zione, dunque, di cui è massima espressione l'amministratore) diretto
a regolare — nel modo più efficiente e meno conflittuale possibile —
le forme ed i limiti del rapportarsi di una pluralità di soggetti a beni
(cose e servizi destinati ad essere) di utilità comune.
Vincenzo Colonna
This content downloaded from 195.34.79.228 on Tue, 24 Jun 2014 23:33:28 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions