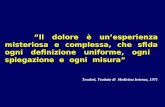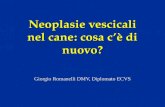Sezione II civile; sentenza 2 settembre 1963, n. 2418; Pres. Flore, Est. G. Rossi, P. M. Tavolaro...
Transcript of Sezione II civile; sentenza 2 settembre 1963, n. 2418; Pres. Flore, Est. G. Rossi, P. M. Tavolaro...

Sezione II civile; sentenza 2 settembre 1963, n. 2418; Pres. Flore, Est. G. Rossi, P. M. Tavolaro(concl. conf.); Conioli (Avv. Romanelli) c. SpinelliAuthor(s): A. L.Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 2 (1964), pp. 323/324-325/326Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156038 .
Accessed: 25/06/2014 00:55
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 00:55:17 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA 324
degli art. 1(593 cod. civ. e 5, 7 della « cartella d'oneri »
(approvata con decreto pres. 9 aprile 1953 n. 562), per avere
la Corte di Lecce ritenuto il suo obbligo di risarcire la per dita delle 500.000 lire, per ciò solo che sul plico v'era la
indicazione « dispaccio speciale » ; sarebbe occorsa, secondo
la ricorrente, la specifica dichiarazione di detto valore
numerario.
L'argomentazione svolta a sostegno di questo motivo
risulta condotta essenzialmente su una linea che, per sè, attiene all 'an della responsabilità ; d'altro canto, la società
si duole ripetutamente che sia stata ammessa una responsa bilità senza limiti in ordine al quantum, ; e si può ben dire
che, fin dall'inizio della lite, essa ha obiettato essenzial
mente di non poter essere tenuta a rimborsare tutta la
somma di 500.000 lire. Il motivo in esame, dunque, pre senta due profili : attiene l'uno all'a/i, l'altro al quantum.
In punto di an si osserva che, nel passaggio dall'abro
gato cod. comm. (art. 406) al vigente cod. civ., è scomparsa la previsione della mancanza assoluta di responsabilità del vettore in ordine al danaro non denunciato ; o, come
si dice, non sussiste oggi più la presunzione iuris et de
iure che la perdita dei valori non denunciati sia dovuta
al fatto dello stesso mittente (nell'ordine d'idee per cui, non dichiarando i valori, quest'ultimo non mette sull'av
viso il vettore onde adotti le congrue misure di sicura
custodia). Attualmente, combinando l'onere di esatta indi
cazione della natura delle cose da trasportare a carico del
mittente (art. 1683, 1° comma), con la sanzione per cui
sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omis
sione o dall'inesattezza delle indicazioni (art. 1683, 3°
comma), e con il principio secondo il quale il vettore non
risponde della perdita o avaria che deriva dal fatto del mit
tente (art. 1693, 1° comma), la materia risulta regolata nel
senso che occorre, volta per volta, accertare se l'omissione
delle indicazioni sia stata la causa della perdita dei valori, avvenuta per difetto di quelle speciali e congrue misure di
custodia che, da un lato, il vettore avrebbe potuto adottare
al fine di evitare la perdita della cosa trasportata e, dall'al
tro, egli non abbia attuato proprio per non essere stato
messo sull'avviso. In simile ipotesi si può parlare, in rela
zione all'art. 1693, 1° comma, di perdita per fatto del mit
tente, e, ad un tempo, si verifica la fattispecie dell'art. 1683, 3° comma.
Ciò precisato, non è dubbio che, già in base alla disci
plina del codice civile, l'avvertenza « dispaccio speciale »
sarebbe da considerare sufficiente per mettere sull'avviso il
vettore ai fini di una custodia particolarmente oculata ; cioè per escludere quella, fra le ipotesi di non responsabilità del vettore, che l'art. 1693, 1° comma, fa consistere nel
« fatto del mittente ».
Con la conseguenza della possibilità, per il vettore, di liberarsi dall'obbligo di risarcimento solo provando il caso
fortuito (le altre ipotesi dell'art. 1693, 1° comma, non en
trano qui in considerazione). Altrettanto palese è, inoltre ed ancor prima, che nella
specie ogni problema di an della responsabilità risulta
superato per la ragione di specie che l'art. 5 della « cartella
d'oneri » prevede positivamente il modo della « speciale »
custodia cui la società era tenuta per ciò che un plico re
casse l'indicazione di « dispaccio speciale » : questo doveva
essere custodito in una cassetta munita di serratura. Così,
l'indagine intorno all'adeguatezza della custodia, che in
genere deve effettuarsi volta a volta, con una valutazione
in concreto, restava semplificata e ridotta alla semplice constatazione se il « dispaccio speciale » fosse stato chiuso
a chiave nella cassetta.
E poiché la corte di merito ha accertato in fatto che il
« dispaccio » de quo venne invece collocato su un sedile
posteriore dell'autocorriera, nè v'è prova alcuna del for
tuito o della forza maggiore (prevista dalla norma della
« cartella d'oneri »). non possono esistere dubbi sull'ara della
responsabilità. Circa il quantum, si osserva che è bensì vero, in via
generale e con riferimento alla disciplina del codice, che il
principio della limitazione di responsabilità del vettore
entro l'àmbito del valore denunciato dal mittente, già
espressamente formulato nella seconda parte dell'art. 406
cod. comm., può considerarsi tuttora vigente, in quanto tale norma costituiva applicazione delle regole dell'art.
1228 cod. civ. del 1865 (responsabilità contrattuale limitata
ai danni prevedibili), che trovansi riprodotte nell'art. 1225
cod. civ. vigente, e, d'altronde, in tema di trasporto di
cose di particolare valore, non sembra che, in applicazione di tale regola, ci si possa sottrarre alla alternativa per cui
o il vettore può esser chiamato a rispondere solo del valore
del plico o pacco, considerato nella sua consistenza mate
riale esteriore, data la impossibilità pratica di individuare
un limite di danno prevedibile, diverso ed intermedio.
Tutto ciò può ritenersi corretto, ma, appunto, in via gene rale e con riguardo alla disciplina del codice.
Senonchè, nella specie, il 2° comma dell'art. 7 della
« cartella d'oneri », recante la disciplina speciale del rap
porto, stabilisce : « In caso di perdita totale o parziale di
pieghi contenenti sovvenzioni o versamenti, l'impresa è
responsabile del danno derivato all'amministrazione, salvo
che l'evento dannoso sia attribuibile esclusivamente a
causa di forza maggiore ». La corte di merito ha ritenuto
che, sempre eccettuata l'ipotesi della forza maggiore, che
qui non ricorre, in base a tale norma il concessionario
risponda senz'altro per l'intera somma contenuta nel plico,
indipendentemente da ciò che essa risulti indicata o meno
sull'involucro. E non si vede come questa interpretazione
possa censurarsi. Da un lato, invero, la norma non condi
ziona l'obbligo di risarcimento alla indicazione esterna del
valore ; dall'altro, essa impone di risarcire il danno deri
vato all'amministrazione. Ora, quando va perduto un plico contenente sovvenzione in denaro il danno che l'ammini
strazione risente è costituito da tale denaro, non dal costo
della carta che lo avvolge. Anche il terzo motivo, dunque, va disatteso.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 2 settembre 1963, n. 2418 ; Pres. Flore, Est. G. Rossi, P. M. Tavolaro (conci,
conf.) ; Conioli (Avv. Romanelli) c. Spinelli.
(Gassa App. Brescia 10 febbraio 1961)
Agricoltura — Imponibile di mano «l'opera — Con
tratti collettivi «li lavoro postcorporativi — Di
chiarazione d'ille«|it limit à costituzionale del «1. 1.
16 settembre 1947 n. 929 — Incidenza (D. 1. 16 set
tembre 1947 n. 929 norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli, art. 1).
La dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle norme sul
cosiddetto imponibile di mano d'opera in agricoltura
{art. 1 del d. I. 16 settembre 1947 n. 929) non giustifica la
reiezione della domanda proposta contro il datore di lavoro
dal lavoratore non assunto con riferimento alle clausole
dei contratti collettivi postcorporativi che stabiliscono per i
datori di lavoro associati l'obbligo di assumere un deter
minato contingente di lavoratori, se non nel caso che tali
contratti collettivi trovino la loro ragion d'essere proprio nelle esigenze sancite dalle norme dichiarate illegittime e si coordinino intimamente con esse, in quanto destinati
a disciplinarne consensualmente le concrete modalità di
esecuzione. (1) L'accertamento di questo rapporto di dipendenza, che si
risolve in una indagine ermeneutica circa le finalità e la
portata di pattuizioni di natura privatistica, è compito del giudice di merito. (2)
(1-2) In precedenza la stessa Sezione, cassando un'altra sentenza della Corte d'appello di Brescia (12 maggio 1961, Foro it., 1961, I, 1540, con ampia nota di richiami), aveva affermato la legittimità delle clausole dei contratti collettivi di lavoro post
This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 00:55:17 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

325 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 326
La Corte, ecc. — Con l'unico motivo si deduce che la sentenza impugnata è inficiata da falsa applicazione dell'art. 136 Cost, e da difetto di motivazione, per aver dichiarato inammissibile l'azione esercitata dal Cornioli, attribuendo decisiva rilevanza, ai sensi del citato art. 136 Cost., alla
pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 78 del 30
dicembre 1958, Foro it., 1959, I, 9) che ha dichiarato l'il
legittimità costituzionale del decreto legisl. n. 929 del
1947, sul massimo impiego della mano d'opera in agricol tura, laddove avrebbe dovuto invece tener conto che l'azione non era fondata sulle disposizioni di tale decreto, bensì
sulle clausole del contratto collettivo 10 novembre 1953
e dell'accordo integrativo ad esso allegato. La censura è pienamente fondata.
Come si è già rilevato nella esposizione delle vicende del
processo, la sentenza di primo grado, nell'accogliere in gran
parte la domanda del Cornioli, non aveva affatto richia
mato ed applicato le norme del cit. decreto del 1947, ma
aveva invece ritenuto che la pretesa dedotta in giudizio trovasse il suo fondamento nelle clausole del menzionato
contratto collettivo relative alla occupazione della mano
d'opera, che determinavano per l'annata agraria 1953-54
l'imponibile tecnico cui erano soggette le aziende agrarie in funzione della natura, dell'ubicazione e dell'estensione
dei terreni coltivati, nonché nelle clausole dell'accordo
integrativo concernente il cosiddetto « superimponibile ».
Ora è evidente che, trattandosi di un contratto collettivo
postcorporativo, le dette clausole hanno natura convenzio
nale e privatistica : per modo che gli obblighi che da esse
derivano a carico dei soggetti iscritti alle associazioni sin
dacali stipulanti e da esse rappresentate, o di coloro che
abbiano prestato adesione al contratto collettivo, espri mendo espressamente o implicitamente la volontà di uni
formarvisi, trovano la loro fonte diretta ed immediata
ed il loro titolo giuridico in una libera manifestazione di
autonomia privata, e non già nelle norme legislative dichia
rate incostituzionali o in un provvedimento coercitivo
emanato dalla pubblica amministrazione in conformità delle
norme stesse. E sotto questo profilo, che non è stato affatto
considerato dalla sentenza di appello, l'accertata invalidità
di esse e la conseguente loro inapplicabilità (art. 136 Cost., art. 30, 3° comma, legge 11 marzo 1953 n. 87) costituisce
una ragione non idonea, o per lo meno non sufficiente, a
giustificare la reiezione della domanda.
D'altra parte, in questa sede non è consentito vagliare se le pattuizioni collettive di cui si discute trovino la loro
ragion d'essere proprio nelle esigenze sancite dalle norme
imperative di quel decreto e si coordinino intimamente a
corporativi facenti obbligo ai datori di lavoro associati di assu
mere un determinato contingente di lavoratori, purché le asso
ciazioni sindacali avessero agito nei limiti del mandato loro con
ferito dai soci (sent. 7 giugno 1963, n. 1517, id., 1963, I, 2176, con nota di richiami). Con ciò la menzionata sentenza non aveva
risolto il problema, pur in essa rettamente impostato e discusso, dei limiti istituzionali del contratto collettivo, ma aveva consi
derato come una quaestio facti, da risolversi ili base alla valuta
zione del contegno degli interessati (i quali, nella specie, avevano
dato pacificamente e per lungo periodo esecuzione all'obbligo sindacalmente concordato), lo stabilire se il c. d. mandato asso
ciativo conferito all'associazione sindacale comportasse il potere di vincolare gli iscritti alla stipulazione di contratti di lavoro. La
sentenza in epigrafe si differenzia dalla precedente, perchè, mentre
ha completamente omesso di considerare il problema ora accen
nato, ha però avvertito, almeno implicitamente, che la presenza di un collegamento oggettivo e funzionale tra la disciplina legis lativa, poi dichiarata costituzionalmente illegittima ma intanto
vigente, e la disciplina collettiva in questione, non avrebbe con
sentito di risolvere la disputa sulla base del rilievo del contegno osservante dei datori di lavoro iscritti al sindacato (contegno
osservante, che poteva essere stato determinato, per l'appunto, da quel collegamento con la disciplina legislativa allora vigente).
Per ulteriori riferimenti, consulta Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 1960, n. 51 (id,., 1961, III, 190), e la sentenza n. 78
del 30 dicembre 1958 della Corte costituzionale (id., 1959, I,
9), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto
legisl. 16 settembre 1947 n. 929. A. L,
queste, in quanto destinate a disciplinarne consensualmente le concrete modalità di esecuzione, e se in conseguenza debbano considerarsi anch'esse travolte per effetto della
menzionata pronuncia della Corte costituzionale. In realtà,
per risolvere tale questione è pur sempre necessaria una
indagine ermeneutica circa le finalità e la portata delle
predette pattuizioni collettive ; e questa indagine, che è
stata pure del tutto omessa dalla Corte di Brescia, non può esser compiuta da questo Supremo collegio, giacché, ap
punto in considerazione della natura negoziale e privati stica delle pattuizioni stesse, involge la necessità di apprez zamenti di mero fatto, devoluti in via esclusiva ai giudici del merito.
Pertanto, la sentenza impugnata deve esser senz'altro
cassata ; e la causa va, quindi, rinviata ad altra corte,
affinchè, in riferimento all'appello a suo tempo proposto dallo Spinelli, riesamini la controversia, adeguandosi ai
criteri giuridici testé enunciati.
Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 29 agosto 1963, n. 2392 ; Pres.
Celentano P., Est. Stella Eichtee, P. M. Cutru
pia (conci, parz. diff.) ; Lomani (Avv. Supino) c.
Min. esteri.
(Conferma App. Roma 2 agosto 1960)
Console — Depositi volontari — llesponsabilità dello Stato italiano (R. d. 7 giugno 1866 n. 2996,
regolamento della legge consolare, art. 114). Console — Depositi ili moneta estera — Oggetto
dell'obbligo di restituzione (R. d. 7 giugno 1866
n. 2996, art. 114).
Lo Stato italiano è responsabile dei depositi eseguiti presso i
consoli ai sensi dell'art. 114 del regolamento consolare. (1) Non essendo ammesso il deposito irregolare presso il console,
questi è tenuto a restituire la somma in moneta estera
ricevuta in deposito, e non Vequivalente in lire ita
liane. (2)
La Corte, ecc. — Deve preliminarmente disporsi la
riunione del ricorso principale e di quello incidentale, clie sono iscritti sotto distinti numeri di ruolo.
Deve esaminarsi poi il ricorso incidentale, che, con il
suo unico motivo, censura la sentenza per avere ritenuto
la legittimazione passiva del ministero degli affari esteri.
L'amministrazione, denunciando la violazione e la falsa
applicazione degli art. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
del regolamento per l'esecuzione della legge consolare
approvato con r. decreto 7 giugno 1866 n. 2996, in rela
zione all'art. 28 della Costituzione e al r. decreto legge 5
dicembre 1938 n. 1928, il tutto in relazione agli art. 100
e 360, nn. 1, 3 e 5, cod. proc. civ., sostiene che il deposito in questione erroneamente è stato considerato riferibile
ad essa. In vero i consoli, quando accettano « sotto la loro
responsabilità », ai sensi dell'art. 114 del detto regola
mento, depositi da parte di connazionali, adempiono una
funzione che non rientra tra quelle proprie dell'ammini
strazione degli esteri, ma che li riguarda personalmente. Il contratto di deposito, per essere riferibile all'ammini
strazione, deve essere stipulato con le rigorose e inderoga bili formalità stabilite dalla legge e dal regolamento sulla
contabilità generale dello Stato, mentre il deposito presso
(1-2) Sulla prima massima v., in senso conforme, Cass. 15
maggio 1959, n. 1445 (Foro it., Rep. 1959, voce Console, n. 1, citata nella motivazione della presente), che ha riformato App. Trento 13 settembre 1957 (id., Rep. 1958, voce cit., n. 13 ; rip. in extenso in Foro pad., 1958,1, 04, con nota critica di Biscottini).
Sulla seconda massima, non risultano precedenti editi.
This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 00:55:17 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions