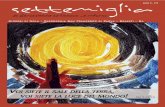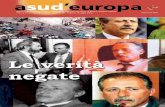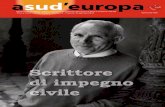Settemiglia - anno I, n°6
-
Upload
giuseppe-de-luca -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
description
Transcript of Settemiglia - anno I, n°6

settemiglia
settemigliada Gerusalemme ad Emmaus ...e ritorno
Supplemento a IN DIALOGOMensile della Chiesa di NolaAut.ne Trib. di Napolin. 3393 del 7/03/1985Direttore Responsabile:MARCO IASEVOLI
Coordinatore Redazione:DON GIUSEPPE DE LUCARedazione:VINCENZO FIORENZAENZO VITIELLOALFONSO QUARTUCCIELENA FIORENZAVINCENZO DONNARUMMA
E-Mail ed Info:[email protected]
Per leggere e scaricarele pubblicazioni precedenti:www.settemiglia.it
SPIRAGLI...Deli o e Cas go
“[...]Eppure all’inizio c’era una visio-ne chiara, un alto ed urgente pro-posito nella mia anima.”
Eccoci qua, ci ritroviamo di nuovo per rifl e ere, leggere, sognare. Ci sono libri che terrorizzano un le o-re solo a sen rne il tolo. Bene, oggi vi parlerò proprio di uno di ques ro-manzi, sperando di sfatare l’angoscioso mito che l’accompagna. Il protagonista di questo mese è un “innocente” librici-no in tolato Deli o e cas go di Dosto-evskij, autore russo del secondo ‘800 indiscu bilmente conosciuto per la sua terrifi cante fama di scri ore prolisso e noioso. Allora, giustamente, vi chiede-rete: “Ma perché mai dovremmo leg-gerlo? Non ci basta unicamente essere a conoscenza della sua esistenza?” La risposta potrebbe essere che è un clas-sico ed in quanto tale va conosciuto. Ma, precisamente, cos’è un classico? Per rispondere a questa domanda pa-rafraserò le parole di uno stravagante autore italiano: Italo Calvino. Per lui un classico è un’opera che ha ancora qual-cosa da dire. Forse è proprio racchiuso qui il fascino di questo libro spavento-so, è un romanzo che, nonostante sia cristallizzato nel tempo, ha ancora un sapore vero e reale. “Com’è possibile? Di cosa parlerà mai per essere così at-tuale?”. Per chi sa guardare in profon-dità, l’unico argomento senza tempo è l’uomo. Ricco di sfacce ature e in-congruenze, dall’animo pieno di fi ordi, l’uomo rimane il mistero più intricato da risolvere e il nostro Fëdor (permet-terete l’informalità) sa bene come sca-
vare in profondità e riportare alla luce tesori nascos . Tornando al romanzo, potremmo inserirlo nella categoria dei gialli; apparentemente ha tu e le carte in regola: l’omicida e la vi ma, l’inve-s gatore fi ccanaso e tu a una serie di personaggi strani che non hanno nulla da invidiare alle fi gurine create dal-la Chris e. Eppure c’è qualcosa di di-verso. Forse è perché già conosciamo chi sarà l’assassino (e stavolta non è il maggiordomo), lo vediamo all’azione, ne conosciamo i proge , e le mo va-zioni, sen amo i ba accelera del suo cuore, ne proviamo l’angoscia o la soddisfazione? Non credo. Per cono-scere men depravate ci sono ben altri romanzi che potrebbero sconvolgere di più. E allora? Dov’è la novità? L’innova-zione è nel percorso, nella strada tor-tuosa di un ragazzo che “Voleva diven-tare un Napoleone e perciò ha ucciso”, nell’introspezione sua e del mondo che gli è vicino, tu si trovano risucchia- dal vor ce della perdizione, si cade,
ognuno nel suo sarcofago, verso la stes-sa direzione, una caduta dolorosa che lacera e dilania, una caduta senza fi ne perché l’abisso nel quale si precipita è “se stessi”, fi gure accartocciate, immor-talate in questo girone dantesco che li vuole soff eren e impossibilita dal risca o, almeno fi no a che non si ab-bandonano alla loro fi nitudine di uomi-ni ed acce ano la sfi da più grande che
è quella d’amare. Sembra di rivederci tu o il terrore e lo sconforto del Gesù dello Getsemani e, allo stesso tempo, la dolcezza infi nita dell’abbandonarsi al meraviglioso a o d’amore che è il per-dono di Dio. In questo romanzo, dun-que, oltre all’apoteosi dell’uomo razio-nale che per esistere deve abbracciare la fi losofi a dell’annientamento, tro-viamo anche la dolcezza di un volto di donna, la comprensione di due occhi di padre, che sanno accogliere lo sgomen-to, ascoltare la superbia e con paziente maieu ca rar fuori le confessioni più dolorose ma paradossalmente più libe-ratorie. Per riuscire in questa missione d’ascolto, in questo lavorìo psicologi-co, ovviamente bisogna appartenere a quel mondo; ancora una volta troviamo il Dio che si è fa o uomo, che è disceso per comprendere, soff rire, arrabbiarsi, amare. Ancora una volta, dunque, Do-stoevskij tesse una so le trama che ci riunisce al cielo. Tra la hybris (l’arrogan-za) dell’uomo e l’azzurro abbagliante c’è solo un passo da compiere, scen-dere giù in profondità, toccare l’umano troppo umano (per scomodare anche Nietzsche), per poi risalire a “riveder le stelle”.
Elena Fiorenza
Deli o e Cas goDi Fedor M. DostoevskijEditore Einaudi Collana Tascabili classiciData uscita 19/09/2005Pagine 655
“È il rendiconto psicologico di un deli o. Un giovane, che è stato espulso dall’Università e vive in condizioni di estrema indigenza, sugges onato, per leggerezza e instabilità di concezioni, da alcune strane idee non con-crete che sono nell’aria, si è improvvisamen-te risolto a uscire dalla bru a situazione. Ha deciso di uccidere una vecchia che presta denaro a usura...”
Rubriche 8
“Sarei curioso di sapere che cosa gli uomini temono più di tutto”
settemigliada Gerusalemme ad Emmaus …e ritorno
Diocesi di Nola – Parrocchia San Francesco di Paola – Scafati – Sa
Questa raffi gurazione del Risorto fa parte di un poli co dipin-to da Isenheim di Grünewald
(1475 – 1528), per un ospedale che accoglieva i mala di “fuoco di sant’An-tonio” (Herpes Zoster), mala a che al-lora era ancora più devastante. In quell’ospedale, Grünewald, pensa di costruire una vera e propria “macchina sacra” a cui affi da una straordinaria ca-pacità di conforto: l’ammalato si imme-desimava in Cristo in croce delle prime ante, piagato dalle sue stesse piaghe, in un secondo momento, quando le ante si aprivano, contemplava il dolce miste-ro del Natale e si faceva piccolo in brac-cio alla Madre della Luce che lo guidava a specchiarsi nel volto trasfi gurato del Risorto, che abbagliandolo di luce, lo guariva dalla disperazione.Tanto è raccapricciante e umiliante l’uomo crocifi sso, quanto sfolgorante ed esaltante l’uomo luminoso risorto.Questo è il Cristo che ci a ende il gior-no di Pasqua, il Cristo che ci lascia vede-re tu o: la luce del suo volto e le ferite che ancora sanguinano; la bellezza del suio corpo glorioso e la ferita inu le del costato, arrivata quando non c’era più sangue. Era già sparso tu o.Il Tempo di Pasqua - dopo quaranta giorni di preparazione, dopo le cele-brazioni gravide di signifi cato della se mana Santa - è anch’esso un pe-riodo che ci perme e di accostarci ad un mistero grande e davvero diffi cile da comprendere: un mistero che sta nel-lo spazio del paradosso tra il Crocifi sso e il Risorto. E tu o questo ha una re-lazione molto dire a con noi tu , un eff e o posi vo di salvezza sulla nostra vita concreta. Cosa ha compreso Grünewald quando ha rifl e uto sulla morte e passione di Cristo? Cosa ha immaginato per giun-gere ad una immagine così radiosa del-la “luce dentro Gesù”?Gesù ha assunto le nostre tenebre, le ha caricate su di sé, nel suo corpo e nel suo spirito, ma misteriosamente e divinamente le ha trasformate in luce, annientandole nel suo amore così forte
per noi. Lo sfondo plumbeo e ossessivo della crocifi ssione si è trasformato in un infi nito cielo stellato, rischiarato da un globo di luce sfolgorante che viene da Gesù stesso. Quando mai una luce così intensa si è sprigionata da una persona e non dal sole!? Quella stessa luce che vediamo è diven-tata per noi l’Eucaris a, il pane lumino-so della vita che ci rende a nostra volta luminosi. E’ la stessa luce che ammiria-mo no e e giorno ininterro amente nella cappella dell’Adorazione Perpe-tua; è la stessa luce che ci investe tu e le volte che ci riconciliamo con Dio.Gesù è la Luce - trasformato e riempi-to dalla luce, trasfi gurato, nella visione straordinaria di Grünewald - ed è venu-to, vissuto, morto e risorto per comu-nicarci che in lui anche noi possiamo
diventare luminosi fi gli di Dio. Gli eroi di questo mondo vengono illumina dai rifl e ori esterni; ma in Cristo risorto ci è dato di essere illumina da dentro e trasforma dalla sua luce e grazia. Se quaranta sono sta i giorni di prepa-razione alla Pasqua, cinquanta ce ne sono off er per percepire, anche mini-mamente, la divinizzazione off ertaci da Gesù Risorto. Essa è ben più di qualsiasi gloria terrena, perché non è cosa ester-na a noi, fa a di beni e ogge , ma è una vera e propria, in ma e sostanziale trasformazione interna a noi, del nostro io più profondo, nella redenzione per tu quelli che credono in lui, e nella san tà per chi lo segue.La sua Pasqua sia la nostra Pasqua, la sua luce il rifl esso con nuo sui nostri vol !
don Peppino, parroco
Periodico MensileAnno I - N°6Aprile 2011Mail ed Info:[email protected]

settemigliasettemiglia
“Salve, cara Deo tellus sanc ssima, salve…”. Così inizia l’inno alla sua
terra, anzi, alla nostra terra, Francesco Petrarca. “Salve, terra san ssima cara a Dio, salve, porto sicuro per le gen one-ste, terra tremenda contro i superbi, terra più nobile di ogni altra e più fer le e più bella, avvolta da due mari, famo-sa per le Alpi gloriose, veneranda per la gloria delle armi e per le sacre leggi, dimora delle Muse, ricca di tesori e di eroi, che degna d’ogni più alto favore reser concordi l’arte e la natura e fecero maestra del mondo. A te voglioso dopo tanto tempo io ritorno per non lasciar- mai più: tu alla mia vita darai grato
riposo e alfi ne mi concederai nel tuo seno tanta terra quanta ne ricoprano le mie fredde membra. Pieno di gioia io contemplo, o Italia, dall’alto del fron-
doso Monginevro; rimangono alle mie spalle le nubi e un vento soave mi colpi-sce la fronte, mentre l’aria salendo con moto leggero mi accoglie. Riconosco la mia Patria e gioioso la saluto: salve, mia bella madre, salve o gloria del mondo!”. Nel leggere queste parole mi sono con-vinto ancora di più che l’Italia è stata sempre una, perché formata non solo e non tanto dai suoi confi ni, quanto dalla sua meravigliosa gente. Se potessi di-rei a Massimo D’Azeglio di capovolgere la sua frase: gli italiani ci sono, ci sono sempre sta . Ciò che occorre ancora fare è l’Italia, quella del Parlamento, delle Is tuzioni, dei Palazzi. Se una di-sunità esiste è proprio tra chi governa e chi è governato, tra chi ha in mano il po-tere della cosa pubblica e chi quel pote-re lo avverte ogni giorno sulla sua pelle. Sono trascorsi 150 anni da quando Vit-torio Emanuele II fu proclamato Primo Re d’Italia. Non voglio entrare nel meri-to di come lo sia diventato. Vi rimando alla le ura dei numerosissimi libri pub-blica sulle conseguenze (devastan per il Sud) della Spedizione dei Mille. Di fa o, dopo 150 anni, l’Italia non si sen-te ancora unita, e perché? È colpa dei terroni? È colpa dei polentoni? È colpa della mafi a? È colpa dei leghis ? Secon-do me è colpa di una classe dirigente che non è in grado di tes moniare una poli ca sociale veramente e profonda-mente radicata nella nostra Cos tuzio-ne. Non si può scaricare sempre su “al-
tro” la responsabilità di uno stato che, dopo 150 anni, è ancora tanto lontano dall’essere pienamente realizzato nei sui valori fondan . Ecco perché davan a tu o ciò io grido: “Ecce Italia!”. Da-van alle misere beghe da cor le che ci stanno abbrutendo, davan alle oli-garchie di potere che stanno divorando le nostre risorse, davan al tenta vo strisciante e imperterrito di ipno zzar-ci facendoci credere che il virtuale è il
vero, io grido: “Ecce Italia!”. È un grido di dolore, non di commiserazione, di sdegno, non di pie smo, di ribellione, non di fatalismo. Si può rinascere? Da una crisi così profonda, e non solo eco-nomica, potremo uscire solo se avre-mo il coraggio di inves re sui giovani, off rendo loro le migliori opportunità di esprimere pienamente i loro talen e di col vare i loro sogni. Il resto è ipocrisia.
Vincenzo Fiorenza
“ECCE ITALIA”Agonia, morte e possibile resurrezione del nostro Paese
“Si muore un pò per poter vivere”, ci suggerisce una celebre canzone. Nella nostra vita noi nasciamo, moriamo, ma non necessariamente in questo ordine.Ogni qualvolta ci capita una situazione spiacevole e non riusciamo a reagire, ci chiediamo “Perchè proprio a me?”. Ma troppe volte ci sfugge un importan-te par colare: la nostra vita, le nostre sconfi e, le condividiamo con colui che ci ha creato, perchè ci ha resi uguali a Lui. Quando qualcuno ci disprezza e non comprende il nostro valore, quan-do le persone che amiamo decidono di non prendersi più cura di noi, quando il lavoro va a rotoli, quando prendia-mo un ca vo voto a scuola, quando il nostro corpo si prende gioco di noi e ci fa soff rire anche nello spirito, quando il buio invade anche le nostre piccole certezze e non riusciamo nemmeno più a credere in qualcosa a cui aggrapparci per risalire, quando chiudiamo gli occhi tanto forte perchè l’unica cosa che vor-remmo sarebbe svegliarci quando tu o il dolore è passato... in tu ques casi noi ci s amo avvicinando a Dio, a Gesù che sulla croce ha soff erto ma che poi
è risorto.La Pasqua, dunque, è nella nostra vita, assorbe tu e le sconfi e, ci fa riaprire gli occhi e aff rontare ogni os lità, per-chè il nostro Padre ci ha insegnato che è possibile rinascere a nuova vita. Un esempio lo possiamo incontrare in ognuno di noi, in ogni vita che durante il suo percorso si è spenta, ma poi si è riaccesa, dando tes monianza di quan-to sia grande l’amore di Dio. E’ questo il caso di Paola, una ragazza quasi dicio enne che due anni fa, in una fase tanto delicata della sua vita come l’adolescenza, ha perso improvvi-samente la sua mamma, suo più grande punto di riferimento. “La vita mi sembrava inu le”, raccon-ta, “ma adesso ho capito che devo an-dare avan , che non è fi nita qui. Tra poco compirò dicio o anni e ho un padre e un fratello che mi amano e, per loro e per la mia mamma, mi rim-boccherò le maniche e mi darò da fare.In fondo lei voleva questo, ed io le darò questo.”Tu possiamo rinascere.
Rosa Matarazzo
Riflessioni 2
Rosaria Sco o
settemiglia“NON ABBIATE PAURA! APRITE, ANZI, SPALANCATE LE PORTE A CRISTO”
(Giovanni Paolo II)
Il 12 Marzo 2011 sarà ricordato dalla nostra comunità cris ana come un giorno di grande grazia. Infa dopo
il restauro, la chiesa piccola San Fran-cesco di Paola di Scafa , riapre al culto come Cappella dell’Adorazione Eucari-s ca, giorno e no e, su indicazione del nostro Vescovo Beniamino Depalma, e con l’impegno dell’intera comunità par-rocchiale scafatese.A conclusione della Santa Messa, cele-brata in serata nella chiesa nuova San Francesco di Paola da Sua Ecc. Mons. Beniamino Depalma, Vescovo di Nola, è par ta al suono delle campane la processione eucaris ca, preceduta da una folta schiera di fedeli con in mano le candele ed alla fi ne del corteo il bal-dacchino con l’ostensorio. Quando la processione è giunta dinanzi la vicina Cappella dell’Adorazione, il vescovo è entrato insieme agli altri sacerdo , ed ha pronunciato una breve preghiera prima che il San ssimo Sacramento fosse posto sull’altare, dando così avvio a quell’esperienza unica per il cris ano a diventare adoratore in spirito e verità in virtù della sua consacrazione ba e-simale. Mons. Beniamino Depalma nell’omelia
ha so olineato che se la nostra fede è veramente sincera e crediamo in quello che il vangelo ci annuncia, dobbiamo rispondere a questa sfi da con l’impe-gno dovuto, perché “in tempi in cui le nostre chiese rimangono spesso chiu-se, una cappella sempre aperta, per chiunque voglia avvicinarsi a qualsiasi ora del giorno o della no e, è come le braccia sempre aperte di Gesù pronte ad accogliere ogni uomo” (Padre Justo Antonio Lo Feudo mss)L’adorazione eucaris ca perpetua è una realtà presente in tu o il mondo e coinvolge milioni di persone. In Italia è presente in circa 50 Parrocchie con ol-tre 15.000 adoratori che hanno scelto di vivere la propria vita off rendo un’ora alla se mana alla presenza di Gesù Eu-cares a. L’adorazione Eucaris ca è un tempo trascorso in preghiera davan al Sacra-mento dell’Eucaris a esposto solenne-mente. Adorare è lasciarsi amare da Dio per imparare ad amare gli altri. Adorare è entrare nell’esperienza del Paradiso, vuol dire prepararsi ad entra-re nella pienezza della condizione fi liale di quando si contemplerà il volto di Dio. Si può pregare in vari modi, ma il modo
migliore è una preghiera di silenziosa meditazione, sul mistero dell’Amore con cui Gesù ci ha amato, tanto da dare la sua vita ed il suo Sangue per noi. Adorare, oggi, vuol dire anche me ersi all’ascolto del Signore in silenzio. Nel si-lenzio del cuore Dio ci ispira e in questo modo ci parla. “Dio è amico del silenzio: dobbiamo ascoltare Dio perché ciò che conta non è quello che diciamo noi, ma quello che Egli dice a noi e a raverso di noi” (Madre Teresa)Il silenzio è pienezza. Stare in silenzio, nella preghiera, equivale a stare in ascolto. Non ci può essere adorazione senza silenzio. Il silenzio è rivelazione. Il silenzio non rappresenta tanto l’altra faccia della parola, ma è parola esso stesso. Dopo aver parlato, Dio tace, ed esige da noi il silenzio, non perché la co-municazione sia terminata, ma perché restano altre cose da dire, altre confi -denze, che possono essere espresse unicamente dal silenzio. San Cirillo di Alessandria diceva che noi siamo come l’acqua: se si me e sul fuoco diventa bollente! Così è chi sa adorare in silenzio l’ospite divino, fuo-co d’amore che può rendere ardente la nostra povera acqua se s amo volen- eri sul fuoco del suo amore.
Il silenzio è fede.Quando taci perché è Lui che agisce, quando rinunci ai suoni, alle voci del mondo, per stare alla Sua Presenza, quando non cerchi comprensione, per-ché basta essere conosciuto da Lui, il silenzio è fede.Il silenzio è adorazione.Quando abbracci la Croce senza chiede-re: «Perché?». Il silenzio è adorazione.
Pasquale Velleca
Eventi 7
Rosaria Sco o

settemiglial’altare e, giunto ai suoi piedi, si prostra a terra mentre tu si inginocchiano. Dopo qualche a mo di adorazione si alza e, dalla sede, recita l’orazione. Inizia la Liturgia della Parola: il profeta Isaia presenta la fi gura del servo del Si-gnore, che “ha spogliato se stesso fi no alla morte” mentre “portava il peccato di mol ”; San Paolo aff erma che Cristo, pur essendo Figlio, “imparò l’obbedien-za” e così “divenne causa di salvezza eterna per tu coloro che gli obbedi-scono”; infi ne è le a la narrazione della Passione del Signore secondo Giovanni. Dopo la preghiera universale inizia l’A-dorazione della Croce. “Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo”: con tali paro-le, per tre volte, l’assemblea è invitata all’adorazione della croce che viene in-nalzata. Poi, in processione dopo il ce-lebrante, i fedeli possono avvicinarsi e accostarsi, venerandolo, allo strumento che Dio ha scelto per la salvezza dell’uo-mo. Terminata l’Adorazione, l’Eucaris a conservata all’altare della reposizione è portata all’altare. Recitato il “Padre Nostro”, ai fedeli è distribuita la comu-nione; da questo momento l’Eucaris a non sarà più presente nell’aula liturgi-ca: l’assenza del Signore si sen rà fi no alla no e di Pasqua. Dopo le ul me orazioni, la celebrazione termina come era iniziata: in silenzio.Questo silenzio perdurerà per tu a la giornata del Sabato Santo. “Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silen-zio e solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme”: con queste parole un’an- ca omelia presenta il Sabato Santo
come il giorno del grande silenzio. È il silenzio del mondo che tace davan alla morte del suo Signore; è il silenzio della chiesa che sosta presso il suo sepolcro; è il silenzio della liturgia che, immobile, a ende di celebrarne la resurrezione nella veglia pasquale.Veglia Pasquale nella No e Santa“Per an chissima tradizione questa è la no e di veglia in onore del Signore”: in ques termini il messale parla della no e tra il Sabato e la Domenica, la no e in cui si celebra la veglia pasqua-le. Sant’Agos no defi nisce questa cele-brazione nel cuore della no e “la Ma-dre di tu e le veglie”: l’intera fede non avrebbe senso senza l’evento che qui si celebra, l’intera liturgia è fondata sul mistero che in essa si compie, la chiesa
stessa ha le sue radici piantate in que-sta no e. Il Crocifi sso Risorto irradia nella no e la sua luce, dà compimento alla storia d’amore di Dio per l’uomo, fa scaturire l’acqua della vita eterna e si dona nella sua presenza sempre viva nell’Eucaris a; è dall’acqua del ba e-simo e dal sacramento dell’altare che nasce il popolo di Dio, la chiesa. La luce, la parola, l’acqua, il pane e il vino scan-discono il ritmo delle veglia, che viene così a svolgersi in qua ro momen : Lucernario, Liturgia della Parola, Litur-gia Ba esimale e Liturgia Eucaris ca. Il colore liturgico è il bianco. La celebra-zione inizia al buio; all’esterno dell’aula liturgica è fa o divampare un fuoco. Il celebrante benedice il fuoco e il cero pasquale e accende quest’ul mo a n-gendo alla fi amma del primo. “La luce di Cristo”: queste le parole che indicano il cero mentre, per tre volte proceden-do verso il presbiterio, è innalzato. La chiesa viene illuminata; il cero pa-squale è posto accanto all’ambone, da cui è proclamato il preconio pasquale, ossia l’annuncio della resurrezione con l’an co testo dell’“Exultet”. La Liturgia della Parola mira a ripercorrere l’inte-ra storia della salvezza, dalla creazione alla redenzione operata da Cristo; di par colare importanza è la terza le u-ra, dal libro dell’Esodo, in cui si racconta la liberazione degli Ebrei dalla schiavitù dell’Egi o e il loro passaggio a raverso il Mar Rosso: è prefi gurazione della li-berazione dell’uomo dal peccato, è pre-fi gurazione del passaggio dalla morte alla vita. Dopo le le ure tra e dall’An- co Testamento si innalzano, dopo due
giorni di silenzio, il canto del Gloria e il
suono delle campane. Segue l’orazione e, poi, la le ura dell’Epistola, cos tuita da un passo della le era di San Paolo ai Romani. Al termine dell’Epistola, in pie-di, il celebrante intona l’Alleluia. Si trat-ta di un Alleluia “nuovo”, di una lode che trova nella resurrezione la sua ra-gion d’essere; il suo canto era stato so-speso con l’inizio della Quaresima, ora per tre volte il celebrante lo intona e per tre volte l’assemblea risponde. Lo si canta ancora come verse o del salmo. Infi ne la proclamazione del vangelo: la pietra rotolata via e il sepolcro vuoto. Le parole dell’angelo: “Non è qui. È ri-sorto”. In questo sepolcro, alla luce di tali parole, tu a la storia della salvezza riceve compimento. Dalla morte e dalla resurrezione di Cristo scaturisce l’acqua che lava le colpe e rigenera l’uomo; lì è la sorgente del ba esimo, da cui nasce il popolo di Dio. “Per mezzo del ba esi-mo dunque siamo sta sepol insieme a lui nella morte affi nché […] anche noi possiamo camminare in una vita nuo-va”: l’Epistola spiega chiaramente il legame tra il ba esimo e la Pasqua, la ragione per cui la Liturgia Ba esimale è parte fondamentale della veglia. Il cele-brante, dopo l’omelia, si reca dunque al ba stero e, immergendo il cero nell’ac-qua, la benedice. Chiede poi all’assem-blea di rinnovare le promesse ba esi-mali: la rinunzia a Satana e la fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Se vi sono ba ezzandi, è loro amministrato il ba esimo; il celebrante asperge poi l’assemblea con l’acqua ba esimale e ritorna alla sede, dalla quale guida la preghiera dei fedeli. Per due giorni non si era celebrato il sacrifi cio eucaris co: ora il pane e il vino vengono nuova-mente porta all’altare e consacra nel corpo e nel sangue del Risorto; i fedeli ricevono la comunione; l’Eucaris a tor-na a riempire il tabernacolo. La bene-dizione segna, infi ne, il compimento di tu a la liturgia pasquale.Si dice che un tempo i pagani temesse-ro i cris ani che uscivano dalla veglia pasquale, perché avevano in volto un sorriso che risultava loro inspiegabile. In eff e , se si entra nel ritmo del Triduo Pasquale, dopo aver celebrato in tale li-turgia la passione, la morte e la resur-rezione di Cristo, non si può non uscire dalla veglia con il sorriso e la gioia sul volto.
Alfonso Quartucci
Approfondimento 6
PIETER PAUL RUBENS(Siegen 1577 - Anversa 1640)Resurrezione di Cristo, 1616olio su tela di cm 183 x 155
settemigliaIL TRIDUO PASQUALELiturgia e mistero
“Centro di tu o l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifi sso, sepolto
e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 24 aprile”: con tali parole, nella solennità dell’Epifania, la chiesa ha proclamato l’annuncio del giorno di Pasqua. L’ha defi nita culmine di un triduo, ossia momento terminale cui tende inevitabilmente, come a una condizione di senso, un periodo di tre giorni. E ha aff ermato che ques tre giorni sono il centro dell’anno liturgico, l’evento da cui tu a la vita liturgica na-sce e riceve signifi cato. Il riferimento è al Triduo Pasquale.L’anno liturgico è l’arco di tempo com-preso tra la prima domenica di Avvento di un anno e quella dell’anno successi-vo; è scandito in tempi, all’interno dei quali bisogna fare una prima dis nzio-ne tra tempo ordinario e tempi for . I colori liturgici so olineano tale diff e-renza: il tempo ordinario è cara erizza-to dal colore verde. I tempi for sono qua ro: il tempo di Avvento, di Nata-le, di Quaresima e di Pasqua. Il colore dell’Avvento e della Quaresima è il vio-la, segno di a esa e penitenza; quello dei tempi di Natale e di Pasqua è il bian-co: i primi sono tempi di preparazione e conversione in vista dei secondi.Il tempo di Quaresima ha inizio con la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri e termina il giovedì della grande se -mana precedente la Pasqua, la Se ma-na Santa. Due sono le celebrazioni del Giovedì Santo; la prima di esse appar- ene ancora al tempo di Quaresima ed
è presieduta dal vescovo nel ma no, nella propria ca edrale, con la conce-lebrazione dei presbiteri della diocesi. Si tra a della Messa Crismale, nella quale i presbiteri rinnovano le proprie promesse ricordando il giorno in cui il Signore is tuì il sacramento dell’Ordi-ne e il vescovo benedice gli oli dei ca-tecumeni e degli infermi e consacra il crisma.La messa vesper na segna la fi ne del-la Quaresima e l’inizio del Triduo Pa-squale. Il Triduo è il cuore e la fonte della liturgia della chiesa in quanto è la celebrazione del mistero centrale della fede: la celebrazione del mistero della redenzione operata da Cristo nel suo sacrifi cio, morte e resurrezione. Il
nome indica certamente un arco di tre giorni ma, sopra u o, indica un’unica, grande liturgia a uantesi in tre mo-men che, pur dis n , risultano intrin-secamente inscindibili.Giovedì Santo “in Coena Domini”Il primo di ques momen , quello che apre il Triduo, è dunque la celebrazione della sera del Giovedì Santo: la “Messa nella Cena del Signore”. Nella seconda le ura Paolo ricorda l’ul ma cena di Gesù con i suoi apostoli: ricorda come, prima di esser tradito, egli avesse preso il pane e il vino e, dandoli agli apostoli, avesse de o che quel pane e quel vino erano il suo corpo e il suo sangue off er- in sacrifi cio. Ricorda come egli avesse
ordinato agli apostoli di ripetere quel sacrifi cio in sua memoria. Nella le e-ra di Paolo è, in defi ni va, espresso il mistero che viene celebrato nella sera del Giovedì: l’is tuzione del sacramen-to dell’Eucaris a e, come sua conse-guenza, del sacramento dell’Ordine. In quell’ul ma cena, e dunque nel Gio-vedì Santo, ha il suo fondamento ogni celebrazione eucaris ca: nella messa il sacerdote consacra il pane e il vino ed a raverso di lui si ripete la transustan-ziazione, la reale conversione delle so-stanze del pane e del vino in quelle del corpo e del sangue di Cristo. Tale miste-ro e tale liturgia si rinnovano nella cele-brazione del Giovedì Santo. Segno della liturgia “nuova” è il tabernacolo vuoto: di nuovo, per la prima volta, il pane e il vino saranno il corpo e il sangue di Gesù che si immola sull’altare. Il colore liturgico è il bianco; nella processione d’ingresso vengono porta gli oli bene-de dal vescovo nel ma no. Il segno della croce dà inizio alla liturgia che si concluderà soltanto con la benedizione impar ta al termine della veglia pa-squale. Durante il canto del Gloria suo-nano le campane: tale canto e tale suo-no taceranno fi no alla no e di Pasqua. La liturgia della parola presenta, con un brano dell’Esodo, l’origine della Pasqua ebraica e dell’agnello immolato; con un passo di San Paolo, l’is tuzione del sa-crifi cio del vero agnello nell’Eucaris a. Il vangelo secondo Giovanni ricorda, in-vece, il celebre episodio della lavanda dei piedi. Il senso del passo di Giovanni rientra perfe amente nell’economia
della celebrazione: non si tra a di una deviazione dal mistero dell’Eucaris a, quanto della manifestazione dell’amore che in essa si compie. Gesù, “dopo aver amato i suoi che era-no nel mondo, li amò sino alla fi ne”: è l’amore che porta il Maestro al servizio dei discepoli, è l’amore che si consuma nel sacrifi cio eucaris co; il volto di Cri-sto si manifesta, in duplice modo, nel pane spezzato e nell’acqua sporca del ca no. Il gesto della lavanda dei piedi è ripetuto dal sacerdote dopo l’omelia; lì, in quel ca no e in quell’asciugatoio, è espresso il dovere di ogni cris ano: l’a-more nel servizio ai fratelli. La proces-sione off ertoriale apre la liturgia euca-ris ca. Il pane e il vino porta all’altare divengono, durante la preghiera eucari-s ca, il corpo e il sangue di Cristo; dopo questa celebrazione il sacrifi cio si rin-noverà soltanto con la veglia pasquale: fi no ad allora la chiesa si as ene dal ce-lebrare la messa. Dopo la distribuzione della comunione ai fedeli l’Eucaris a è lasciata sull’altare e, recitata l’ul ma orazione, il celebrante, inginocchiato, la incensa. Si forma quindi la processio-ne che, accompagnando il Sacramento, giunge all’“altare della reposizione”, il luogo preparato per custodire il pane consacrato fi no all’azione liturgica del Venerdì. L’Eucaris a è nuovamente in-censata durante il canto del “Tantum ergo” e, dopo qualche a mo di adora-zione, l’assemblea si scioglie in silenzio. L’altare viene spogliato e le croci pre-sen nell’aula liturgica sono portate via o velate. “Vegliate e pregate”: le parole che Gesù aveva rivolto a Pietro, Giaco-mo e Giovanni nel Getsèmani sono ora rivolte a ogni fedele. A ognuno è richie-sta l’adorazione e la preghiera dinanzi all’Eucaris a, dinanzi al Signore nella no e del suo tradimento.Venerdì Santo “in Passione Domini”Come già de o, la chiesa non celebra l’Eucaris a nel giorno della morte del Signore. L’azione liturgica del Vener-dì pomeriggio cos tuisce il secondo momento del Triduo: la “Celebrazione della Passione del Signore”. La celebra-zione si svolge in tre par : Liturgia della Parola, Adorazione della Croce, Santa Comunione; il colore liturgico è il rosso. Il celebrante si dirige in silenzio verso
Approfondimento 3

settemiglia Vangelo 4
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo GiovanniVangelo Gv 18,1-19,42 Dal Vangelo secondo Giovanni
- Ca urarono Gesù e lo legaronoIn quel tempo, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cèdron, dove c’era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi disce-poli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di solda e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdo e dai farisei, con lanterne, fi accole e armi. Gesù allora, sapendo tu o quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?». Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?». Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho de o: sono io. Se dunque cercate me, lasciate che ques se ne vadano», perché si compisse la parola che egli aveva de o: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allo-ra Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l’orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rime la spada nel fodero: il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo?». 90- Lo condussero prima da AnnaAllora i solda , con il comandante e le guardie dei Giudei, ca urarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna: egli infa era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo». Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdo-te ed entrò con Gesù nel cor le del sommo sacerdo-te. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell’altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla por naia e fece entrare Pietro. E la giovane por naia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest’uomo?». Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si scaldava.Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tu i Giudei si riuniscono, e non ho mai de o nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho de o loro; ec-co, essi sanno che cosa ho de o». Appena de o questo, una delle guardie presen diede uno schiaff o a Gesù, dicen-do: «Così rispondi al sommo sacerdote?». Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male. Ma se ho parla-to bene, perché mi percuo ?». Allora Anna lo mandò, con le mani legate, a Caifa, il sommo sacerdote.- Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Non lo sono! Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?». Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l’orecchio, disse: «Non ho forse visto con lui nel giardino?». Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò.- Il mio regno non è di questo mondo Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi non vollero entrare nel pretorio, per non con-ta-minarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest’uo-mo?». Gli risposero: «Se costui non fosse un malfa ore, non te l’avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Pren-detelo voi e giudicatelo secondo la vostra Legge!». Gli risposero i Giudei: «A noi non è consen to me ere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva de o, indicando di quale morte doveva morire.Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdo hanno consegnato a me. Che cosa hai fa o?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero comba uto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare tes monianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos’è la verità?». E, de o questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa al-cuna. Vi è tra voi l’usanza che, in occasione della Pasqua, io rime a uno in libertà per voi: volete dunque che io rime a in libertà per voi il re dei Giudei?». Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!». Barabba era un brigante.- Salve, re dei Giudei! Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece fl agellare. E i solda , intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». E gli davano schiaffi . Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l’uomo!». Come lo videro, i capi dei sacerdo e le guardie gridarono: «Crocifi ggilo! Crocifi ggilo!». Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifi ggetelo; io in lui non trovo colpa». Gli risposero i Giudei: «Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, perché si è fa o Figlio di Dio».
settemiglia Vangelo 5
All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di me er in libertà e il po-tere di me er in croce?». Gli rispose Gesù: «Tu non avres alcun potere su di me, se ciò non fosse stato dato dall’alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande».- Via! Via! Crocifi ggilo! Da quel momento Pilato cercava di me erlo in libertà. Ma i Giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesa-re! Chiunque si fa re si me e contro Cesare». Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sede e in tribu-na-le, nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la Parascève della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato dis-se ai Giudei: «Ecco il vostro re!». Ma quelli gridarono: «Via! Via! Crocifi ggilo!». Disse loro Pilato: «Me erò in croce il vostro re?». Risposero i capi dei sacerdo : «Non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifi sso.- Lo crocifi ssero e con lui altri dueEssi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo de o del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo croci-fi ssero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l’iscrizione e la fe-ce porre sulla croce; vi era scri o: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Mol Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifi sso era vicino alla ci à; era scri a in ebraico, in la no e in greco. I capi dei sacerdo dei Giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: “Costui ha de o: Io sono il re dei Giudei”». Rispose Pilato: «Quel che ho scri o, ho scri o».- Si sono divisi tra loro le mie ves I solda poi, quando ebbero crocifi sso Gesù, presero le sue ves , ne fecero qua ro par – una per ciascun soldato –, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tu a d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma riamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la Scri ura, che dice: «Si sono divisi tra loro le mie ves e sulla mia tunica hanno ge ato la sorte». E i solda fecero così.- Ecco tuo fi glio! Ecco tua madre! Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo fi glio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tu o era compiuto, affi nché si compisse la Scri ura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.(Qui si genufl e e e di fa una breve pausa) - E subito ne uscì sangue e acquaEra il giorno della Parascève e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato – era infa un gior-no solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero porta via. Vennero dunque i solda e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano sta crocifi ssi insieme con lui. Venu però da Ge-sù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei solda con una lancia gli colpì il fi anco, e su-bito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà tes monianza e la sua tes monianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infa avvenne perché si compisse la Scri ura: «Non gli sarà spezzato alcun osso». E un altro passo della Scri ura dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafi o».- Presero il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromiDopo ques fa Giuseppe di Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per more dei Giudei, chiese a Pi-lato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo - quello che in precedenza era andato da lui di no e - e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di áloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la se-poltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifi sso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parascève dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.- Egli doveva risuscitare dai mor Il primo giorno della se mana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di ma no, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tu e due, ma l’altro discepo-lo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posa là, ma non entrò.Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posa là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e crede e. Infa non avevano ancora compreso la Scri ura, che cioè egli doveva risorgere dai mor .

settemiglia Vangelo 4
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo GiovanniVangelo Gv 18,1-19,42 Dal Vangelo secondo Giovanni
- Ca urarono Gesù e lo legaronoIn quel tempo, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cèdron, dove c’era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi disce-poli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di solda e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdo e dai farisei, con lanterne, fi accole e armi. Gesù allora, sapendo tu o quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?». Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?». Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho de o: sono io. Se dunque cercate me, lasciate che ques se ne vadano», perché si compisse la parola che egli aveva de o: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allo-ra Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l’orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rime la spada nel fodero: il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo?». 90- Lo condussero prima da AnnaAllora i solda , con il comandante e le guardie dei Giudei, ca urarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna: egli infa era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo». Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdo-te ed entrò con Gesù nel cor le del sommo sacerdo-te. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell’altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla por naia e fece entrare Pietro. E la giovane por naia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest’uomo?». Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si scaldava.Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tu i Giudei si riuniscono, e non ho mai de o nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho de o loro; ec-co, essi sanno che cosa ho de o». Appena de o questo, una delle guardie presen diede uno schiaff o a Gesù, dicen-do: «Così rispondi al sommo sacerdote?». Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male. Ma se ho parla-to bene, perché mi percuo ?». Allora Anna lo mandò, con le mani legate, a Caifa, il sommo sacerdote.- Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Non lo sono! Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?». Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l’orecchio, disse: «Non ho forse visto con lui nel giardino?». Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò.- Il mio regno non è di questo mondo Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi non vollero entrare nel pretorio, per non con-ta-minarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest’uo-mo?». Gli risposero: «Se costui non fosse un malfa ore, non te l’avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Pren-detelo voi e giudicatelo secondo la vostra Legge!». Gli risposero i Giudei: «A noi non è consen to me ere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva de o, indicando di quale morte doveva morire.Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdo hanno consegnato a me. Che cosa hai fa o?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero comba uto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare tes monianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos’è la verità?». E, de o questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa al-cuna. Vi è tra voi l’usanza che, in occasione della Pasqua, io rime a uno in libertà per voi: volete dunque che io rime a in libertà per voi il re dei Giudei?». Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!». Barabba era un brigante.- Salve, re dei Giudei! Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece fl agellare. E i solda , intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». E gli davano schiaffi . Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l’uomo!». Come lo videro, i capi dei sacerdo e le guardie gridarono: «Crocifi ggilo! Crocifi ggilo!». Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifi ggetelo; io in lui non trovo colpa». Gli risposero i Giudei: «Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, perché si è fa o Figlio di Dio».
settemiglia Vangelo 5
All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di me er in libertà e il po-tere di me er in croce?». Gli rispose Gesù: «Tu non avres alcun potere su di me, se ciò non fosse stato dato dall’alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande».- Via! Via! Crocifi ggilo! Da quel momento Pilato cercava di me erlo in libertà. Ma i Giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesa-re! Chiunque si fa re si me e contro Cesare». Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sede e in tribu-na-le, nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la Parascève della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato dis-se ai Giudei: «Ecco il vostro re!». Ma quelli gridarono: «Via! Via! Crocifi ggilo!». Disse loro Pilato: «Me erò in croce il vostro re?». Risposero i capi dei sacerdo : «Non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifi sso.- Lo crocifi ssero e con lui altri dueEssi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo de o del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo croci-fi ssero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l’iscrizione e la fe-ce porre sulla croce; vi era scri o: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Mol Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifi sso era vicino alla ci à; era scri a in ebraico, in la no e in greco. I capi dei sacerdo dei Giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: “Costui ha de o: Io sono il re dei Giudei”». Rispose Pilato: «Quel che ho scri o, ho scri o».- Si sono divisi tra loro le mie ves I solda poi, quando ebbero crocifi sso Gesù, presero le sue ves , ne fecero qua ro par – una per ciascun soldato –, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tu a d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma riamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la Scri ura, che dice: «Si sono divisi tra loro le mie ves e sulla mia tunica hanno ge ato la sorte». E i solda fecero così.- Ecco tuo fi glio! Ecco tua madre! Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo fi glio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tu o era compiuto, affi nché si compisse la Scri ura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.(Qui si genufl e e e di fa una breve pausa) - E subito ne uscì sangue e acquaEra il giorno della Parascève e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato – era infa un gior-no solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero porta via. Vennero dunque i solda e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano sta crocifi ssi insieme con lui. Venu però da Ge-sù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei solda con una lancia gli colpì il fi anco, e su-bito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà tes monianza e la sua tes monianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infa avvenne perché si compisse la Scri ura: «Non gli sarà spezzato alcun osso». E un altro passo della Scri ura dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafi o».- Presero il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromiDopo ques fa Giuseppe di Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per more dei Giudei, chiese a Pi-lato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo - quello che in precedenza era andato da lui di no e - e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di áloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la se-poltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifi sso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parascève dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.- Egli doveva risuscitare dai mor Il primo giorno della se mana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di ma no, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tu e due, ma l’altro discepo-lo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posa là, ma non entrò.Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posa là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e crede e. Infa non avevano ancora compreso la Scri ura, che cioè egli doveva risorgere dai mor .

settemiglial’altare e, giunto ai suoi piedi, si prostra a terra mentre tu si inginocchiano. Dopo qualche a mo di adorazione si alza e, dalla sede, recita l’orazione. Inizia la Liturgia della Parola: il profeta Isaia presenta la fi gura del servo del Si-gnore, che “ha spogliato se stesso fi no alla morte” mentre “portava il peccato di mol ”; San Paolo aff erma che Cristo, pur essendo Figlio, “imparò l’obbedien-za” e così “divenne causa di salvezza eterna per tu coloro che gli obbedi-scono”; infi ne è le a la narrazione della Passione del Signore secondo Giovanni. Dopo la preghiera universale inizia l’A-dorazione della Croce. “Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo”: con tali paro-le, per tre volte, l’assemblea è invitata all’adorazione della croce che viene in-nalzata. Poi, in processione dopo il ce-lebrante, i fedeli possono avvicinarsi e accostarsi, venerandolo, allo strumento che Dio ha scelto per la salvezza dell’uo-mo. Terminata l’Adorazione, l’Eucaris a conservata all’altare della reposizione è portata all’altare. Recitato il “Padre Nostro”, ai fedeli è distribuita la comu-nione; da questo momento l’Eucaris a non sarà più presente nell’aula liturgi-ca: l’assenza del Signore si sen rà fi no alla no e di Pasqua. Dopo le ul me orazioni, la celebrazione termina come era iniziata: in silenzio.Questo silenzio perdurerà per tu a la giornata del Sabato Santo. “Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silen-zio e solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme”: con queste parole un’an- ca omelia presenta il Sabato Santo
come il giorno del grande silenzio. È il silenzio del mondo che tace davan alla morte del suo Signore; è il silenzio della chiesa che sosta presso il suo sepolcro; è il silenzio della liturgia che, immobile, a ende di celebrarne la resurrezione nella veglia pasquale.Veglia Pasquale nella No e Santa“Per an chissima tradizione questa è la no e di veglia in onore del Signore”: in ques termini il messale parla della no e tra il Sabato e la Domenica, la no e in cui si celebra la veglia pasqua-le. Sant’Agos no defi nisce questa cele-brazione nel cuore della no e “la Ma-dre di tu e le veglie”: l’intera fede non avrebbe senso senza l’evento che qui si celebra, l’intera liturgia è fondata sul mistero che in essa si compie, la chiesa
stessa ha le sue radici piantate in que-sta no e. Il Crocifi sso Risorto irradia nella no e la sua luce, dà compimento alla storia d’amore di Dio per l’uomo, fa scaturire l’acqua della vita eterna e si dona nella sua presenza sempre viva nell’Eucaris a; è dall’acqua del ba e-simo e dal sacramento dell’altare che nasce il popolo di Dio, la chiesa. La luce, la parola, l’acqua, il pane e il vino scan-discono il ritmo delle veglia, che viene così a svolgersi in qua ro momen : Lucernario, Liturgia della Parola, Litur-gia Ba esimale e Liturgia Eucaris ca. Il colore liturgico è il bianco. La celebra-zione inizia al buio; all’esterno dell’aula liturgica è fa o divampare un fuoco. Il celebrante benedice il fuoco e il cero pasquale e accende quest’ul mo a n-gendo alla fi amma del primo. “La luce di Cristo”: queste le parole che indicano il cero mentre, per tre volte proceden-do verso il presbiterio, è innalzato. La chiesa viene illuminata; il cero pa-squale è posto accanto all’ambone, da cui è proclamato il preconio pasquale, ossia l’annuncio della resurrezione con l’an co testo dell’“Exultet”. La Liturgia della Parola mira a ripercorrere l’inte-ra storia della salvezza, dalla creazione alla redenzione operata da Cristo; di par colare importanza è la terza le u-ra, dal libro dell’Esodo, in cui si racconta la liberazione degli Ebrei dalla schiavitù dell’Egi o e il loro passaggio a raverso il Mar Rosso: è prefi gurazione della li-berazione dell’uomo dal peccato, è pre-fi gurazione del passaggio dalla morte alla vita. Dopo le le ure tra e dall’An- co Testamento si innalzano, dopo due
giorni di silenzio, il canto del Gloria e il
suono delle campane. Segue l’orazione e, poi, la le ura dell’Epistola, cos tuita da un passo della le era di San Paolo ai Romani. Al termine dell’Epistola, in pie-di, il celebrante intona l’Alleluia. Si trat-ta di un Alleluia “nuovo”, di una lode che trova nella resurrezione la sua ra-gion d’essere; il suo canto era stato so-speso con l’inizio della Quaresima, ora per tre volte il celebrante lo intona e per tre volte l’assemblea risponde. Lo si canta ancora come verse o del salmo. Infi ne la proclamazione del vangelo: la pietra rotolata via e il sepolcro vuoto. Le parole dell’angelo: “Non è qui. È ri-sorto”. In questo sepolcro, alla luce di tali parole, tu a la storia della salvezza riceve compimento. Dalla morte e dalla resurrezione di Cristo scaturisce l’acqua che lava le colpe e rigenera l’uomo; lì è la sorgente del ba esimo, da cui nasce il popolo di Dio. “Per mezzo del ba esi-mo dunque siamo sta sepol insieme a lui nella morte affi nché […] anche noi possiamo camminare in una vita nuo-va”: l’Epistola spiega chiaramente il legame tra il ba esimo e la Pasqua, la ragione per cui la Liturgia Ba esimale è parte fondamentale della veglia. Il cele-brante, dopo l’omelia, si reca dunque al ba stero e, immergendo il cero nell’ac-qua, la benedice. Chiede poi all’assem-blea di rinnovare le promesse ba esi-mali: la rinunzia a Satana e la fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Se vi sono ba ezzandi, è loro amministrato il ba esimo; il celebrante asperge poi l’assemblea con l’acqua ba esimale e ritorna alla sede, dalla quale guida la preghiera dei fedeli. Per due giorni non si era celebrato il sacrifi cio eucaris co: ora il pane e il vino vengono nuova-mente porta all’altare e consacra nel corpo e nel sangue del Risorto; i fedeli ricevono la comunione; l’Eucaris a tor-na a riempire il tabernacolo. La bene-dizione segna, infi ne, il compimento di tu a la liturgia pasquale.Si dice che un tempo i pagani temesse-ro i cris ani che uscivano dalla veglia pasquale, perché avevano in volto un sorriso che risultava loro inspiegabile. In eff e , se si entra nel ritmo del Triduo Pasquale, dopo aver celebrato in tale li-turgia la passione, la morte e la resur-rezione di Cristo, non si può non uscire dalla veglia con il sorriso e la gioia sul volto.
Alfonso Quartucci
Approfondimento 6
PIETER PAUL RUBENS(Siegen 1577 - Anversa 1640)Resurrezione di Cristo, 1616olio su tela di cm 183 x 155
settemigliaIL TRIDUO PASQUALELiturgia e mistero
“Centro di tu o l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifi sso, sepolto
e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 24 aprile”: con tali parole, nella solennità dell’Epifania, la chiesa ha proclamato l’annuncio del giorno di Pasqua. L’ha defi nita culmine di un triduo, ossia momento terminale cui tende inevitabilmente, come a una condizione di senso, un periodo di tre giorni. E ha aff ermato che ques tre giorni sono il centro dell’anno liturgico, l’evento da cui tu a la vita liturgica na-sce e riceve signifi cato. Il riferimento è al Triduo Pasquale.L’anno liturgico è l’arco di tempo com-preso tra la prima domenica di Avvento di un anno e quella dell’anno successi-vo; è scandito in tempi, all’interno dei quali bisogna fare una prima dis nzio-ne tra tempo ordinario e tempi for . I colori liturgici so olineano tale diff e-renza: il tempo ordinario è cara erizza-to dal colore verde. I tempi for sono qua ro: il tempo di Avvento, di Nata-le, di Quaresima e di Pasqua. Il colore dell’Avvento e della Quaresima è il vio-la, segno di a esa e penitenza; quello dei tempi di Natale e di Pasqua è il bian-co: i primi sono tempi di preparazione e conversione in vista dei secondi.Il tempo di Quaresima ha inizio con la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri e termina il giovedì della grande se -mana precedente la Pasqua, la Se ma-na Santa. Due sono le celebrazioni del Giovedì Santo; la prima di esse appar- ene ancora al tempo di Quaresima ed
è presieduta dal vescovo nel ma no, nella propria ca edrale, con la conce-lebrazione dei presbiteri della diocesi. Si tra a della Messa Crismale, nella quale i presbiteri rinnovano le proprie promesse ricordando il giorno in cui il Signore is tuì il sacramento dell’Ordi-ne e il vescovo benedice gli oli dei ca-tecumeni e degli infermi e consacra il crisma.La messa vesper na segna la fi ne del-la Quaresima e l’inizio del Triduo Pa-squale. Il Triduo è il cuore e la fonte della liturgia della chiesa in quanto è la celebrazione del mistero centrale della fede: la celebrazione del mistero della redenzione operata da Cristo nel suo sacrifi cio, morte e resurrezione. Il
nome indica certamente un arco di tre giorni ma, sopra u o, indica un’unica, grande liturgia a uantesi in tre mo-men che, pur dis n , risultano intrin-secamente inscindibili.Giovedì Santo “in Coena Domini”Il primo di ques momen , quello che apre il Triduo, è dunque la celebrazione della sera del Giovedì Santo: la “Messa nella Cena del Signore”. Nella seconda le ura Paolo ricorda l’ul ma cena di Gesù con i suoi apostoli: ricorda come, prima di esser tradito, egli avesse preso il pane e il vino e, dandoli agli apostoli, avesse de o che quel pane e quel vino erano il suo corpo e il suo sangue off er- in sacrifi cio. Ricorda come egli avesse
ordinato agli apostoli di ripetere quel sacrifi cio in sua memoria. Nella le e-ra di Paolo è, in defi ni va, espresso il mistero che viene celebrato nella sera del Giovedì: l’is tuzione del sacramen-to dell’Eucaris a e, come sua conse-guenza, del sacramento dell’Ordine. In quell’ul ma cena, e dunque nel Gio-vedì Santo, ha il suo fondamento ogni celebrazione eucaris ca: nella messa il sacerdote consacra il pane e il vino ed a raverso di lui si ripete la transustan-ziazione, la reale conversione delle so-stanze del pane e del vino in quelle del corpo e del sangue di Cristo. Tale miste-ro e tale liturgia si rinnovano nella cele-brazione del Giovedì Santo. Segno della liturgia “nuova” è il tabernacolo vuoto: di nuovo, per la prima volta, il pane e il vino saranno il corpo e il sangue di Gesù che si immola sull’altare. Il colore liturgico è il bianco; nella processione d’ingresso vengono porta gli oli bene-de dal vescovo nel ma no. Il segno della croce dà inizio alla liturgia che si concluderà soltanto con la benedizione impar ta al termine della veglia pa-squale. Durante il canto del Gloria suo-nano le campane: tale canto e tale suo-no taceranno fi no alla no e di Pasqua. La liturgia della parola presenta, con un brano dell’Esodo, l’origine della Pasqua ebraica e dell’agnello immolato; con un passo di San Paolo, l’is tuzione del sa-crifi cio del vero agnello nell’Eucaris a. Il vangelo secondo Giovanni ricorda, in-vece, il celebre episodio della lavanda dei piedi. Il senso del passo di Giovanni rientra perfe amente nell’economia
della celebrazione: non si tra a di una deviazione dal mistero dell’Eucaris a, quanto della manifestazione dell’amore che in essa si compie. Gesù, “dopo aver amato i suoi che era-no nel mondo, li amò sino alla fi ne”: è l’amore che porta il Maestro al servizio dei discepoli, è l’amore che si consuma nel sacrifi cio eucaris co; il volto di Cri-sto si manifesta, in duplice modo, nel pane spezzato e nell’acqua sporca del ca no. Il gesto della lavanda dei piedi è ripetuto dal sacerdote dopo l’omelia; lì, in quel ca no e in quell’asciugatoio, è espresso il dovere di ogni cris ano: l’a-more nel servizio ai fratelli. La proces-sione off ertoriale apre la liturgia euca-ris ca. Il pane e il vino porta all’altare divengono, durante la preghiera eucari-s ca, il corpo e il sangue di Cristo; dopo questa celebrazione il sacrifi cio si rin-noverà soltanto con la veglia pasquale: fi no ad allora la chiesa si as ene dal ce-lebrare la messa. Dopo la distribuzione della comunione ai fedeli l’Eucaris a è lasciata sull’altare e, recitata l’ul ma orazione, il celebrante, inginocchiato, la incensa. Si forma quindi la processio-ne che, accompagnando il Sacramento, giunge all’“altare della reposizione”, il luogo preparato per custodire il pane consacrato fi no all’azione liturgica del Venerdì. L’Eucaris a è nuovamente in-censata durante il canto del “Tantum ergo” e, dopo qualche a mo di adora-zione, l’assemblea si scioglie in silenzio. L’altare viene spogliato e le croci pre-sen nell’aula liturgica sono portate via o velate. “Vegliate e pregate”: le parole che Gesù aveva rivolto a Pietro, Giaco-mo e Giovanni nel Getsèmani sono ora rivolte a ogni fedele. A ognuno è richie-sta l’adorazione e la preghiera dinanzi all’Eucaris a, dinanzi al Signore nella no e del suo tradimento.Venerdì Santo “in Passione Domini”Come già de o, la chiesa non celebra l’Eucaris a nel giorno della morte del Signore. L’azione liturgica del Vener-dì pomeriggio cos tuisce il secondo momento del Triduo: la “Celebrazione della Passione del Signore”. La celebra-zione si svolge in tre par : Liturgia della Parola, Adorazione della Croce, Santa Comunione; il colore liturgico è il rosso. Il celebrante si dirige in silenzio verso
Approfondimento 3

settemigliasettemiglia
“Salve, cara Deo tellus sanc ssima, salve…”. Così inizia l’inno alla sua
terra, anzi, alla nostra terra, Francesco Petrarca. “Salve, terra san ssima cara a Dio, salve, porto sicuro per le gen one-ste, terra tremenda contro i superbi, terra più nobile di ogni altra e più fer le e più bella, avvolta da due mari, famo-sa per le Alpi gloriose, veneranda per la gloria delle armi e per le sacre leggi, dimora delle Muse, ricca di tesori e di eroi, che degna d’ogni più alto favore reser concordi l’arte e la natura e fecero maestra del mondo. A te voglioso dopo tanto tempo io ritorno per non lasciar- mai più: tu alla mia vita darai grato
riposo e alfi ne mi concederai nel tuo seno tanta terra quanta ne ricoprano le mie fredde membra. Pieno di gioia io contemplo, o Italia, dall’alto del fron-
doso Monginevro; rimangono alle mie spalle le nubi e un vento soave mi colpi-sce la fronte, mentre l’aria salendo con moto leggero mi accoglie. Riconosco la mia Patria e gioioso la saluto: salve, mia bella madre, salve o gloria del mondo!”. Nel leggere queste parole mi sono con-vinto ancora di più che l’Italia è stata sempre una, perché formata non solo e non tanto dai suoi confi ni, quanto dalla sua meravigliosa gente. Se potessi di-rei a Massimo D’Azeglio di capovolgere la sua frase: gli italiani ci sono, ci sono sempre sta . Ciò che occorre ancora fare è l’Italia, quella del Parlamento, delle Is tuzioni, dei Palazzi. Se una di-sunità esiste è proprio tra chi governa e chi è governato, tra chi ha in mano il po-tere della cosa pubblica e chi quel pote-re lo avverte ogni giorno sulla sua pelle. Sono trascorsi 150 anni da quando Vit-torio Emanuele II fu proclamato Primo Re d’Italia. Non voglio entrare nel meri-to di come lo sia diventato. Vi rimando alla le ura dei numerosissimi libri pub-blica sulle conseguenze (devastan per il Sud) della Spedizione dei Mille. Di fa o, dopo 150 anni, l’Italia non si sen-te ancora unita, e perché? È colpa dei terroni? È colpa dei polentoni? È colpa della mafi a? È colpa dei leghis ? Secon-do me è colpa di una classe dirigente che non è in grado di tes moniare una poli ca sociale veramente e profonda-mente radicata nella nostra Cos tuzio-ne. Non si può scaricare sempre su “al-
tro” la responsabilità di uno stato che, dopo 150 anni, è ancora tanto lontano dall’essere pienamente realizzato nei sui valori fondan . Ecco perché davan a tu o ciò io grido: “Ecce Italia!”. Da-van alle misere beghe da cor le che ci stanno abbrutendo, davan alle oli-garchie di potere che stanno divorando le nostre risorse, davan al tenta vo strisciante e imperterrito di ipno zzar-ci facendoci credere che il virtuale è il
vero, io grido: “Ecce Italia!”. È un grido di dolore, non di commiserazione, di sdegno, non di pie smo, di ribellione, non di fatalismo. Si può rinascere? Da una crisi così profonda, e non solo eco-nomica, potremo uscire solo se avre-mo il coraggio di inves re sui giovani, off rendo loro le migliori opportunità di esprimere pienamente i loro talen e di col vare i loro sogni. Il resto è ipocrisia.
Vincenzo Fiorenza
“ECCE ITALIA”Agonia, morte e possibile resurrezione del nostro Paese
“Si muore un pò per poter vivere”, ci suggerisce una celebre canzone. Nella nostra vita noi nasciamo, moriamo, ma non necessariamente in questo ordine.Ogni qualvolta ci capita una situazione spiacevole e non riusciamo a reagire, ci chiediamo “Perchè proprio a me?”. Ma troppe volte ci sfugge un importan-te par colare: la nostra vita, le nostre sconfi e, le condividiamo con colui che ci ha creato, perchè ci ha resi uguali a Lui. Quando qualcuno ci disprezza e non comprende il nostro valore, quan-do le persone che amiamo decidono di non prendersi più cura di noi, quando il lavoro va a rotoli, quando prendia-mo un ca vo voto a scuola, quando il nostro corpo si prende gioco di noi e ci fa soff rire anche nello spirito, quando il buio invade anche le nostre piccole certezze e non riusciamo nemmeno più a credere in qualcosa a cui aggrapparci per risalire, quando chiudiamo gli occhi tanto forte perchè l’unica cosa che vor-remmo sarebbe svegliarci quando tu o il dolore è passato... in tu ques casi noi ci s amo avvicinando a Dio, a Gesù che sulla croce ha soff erto ma che poi
è risorto.La Pasqua, dunque, è nella nostra vita, assorbe tu e le sconfi e, ci fa riaprire gli occhi e aff rontare ogni os lità, per-chè il nostro Padre ci ha insegnato che è possibile rinascere a nuova vita. Un esempio lo possiamo incontrare in ognuno di noi, in ogni vita che durante il suo percorso si è spenta, ma poi si è riaccesa, dando tes monianza di quan-to sia grande l’amore di Dio. E’ questo il caso di Paola, una ragazza quasi dicio enne che due anni fa, in una fase tanto delicata della sua vita come l’adolescenza, ha perso improvvi-samente la sua mamma, suo più grande punto di riferimento. “La vita mi sembrava inu le”, raccon-ta, “ma adesso ho capito che devo an-dare avan , che non è fi nita qui. Tra poco compirò dicio o anni e ho un padre e un fratello che mi amano e, per loro e per la mia mamma, mi rim-boccherò le maniche e mi darò da fare.In fondo lei voleva questo, ed io le darò questo.”Tu possiamo rinascere.
Rosa Matarazzo
Riflessioni 2
Rosaria Sco o
settemiglia“NON ABBIATE PAURA! APRITE, ANZI, SPALANCATE LE PORTE A CRISTO”
(Giovanni Paolo II)
Il 12 Marzo 2011 sarà ricordato dalla nostra comunità cris ana come un giorno di grande grazia. Infa dopo
il restauro, la chiesa piccola San Fran-cesco di Paola di Scafa , riapre al culto come Cappella dell’Adorazione Eucari-s ca, giorno e no e, su indicazione del nostro Vescovo Beniamino Depalma, e con l’impegno dell’intera comunità par-rocchiale scafatese.A conclusione della Santa Messa, cele-brata in serata nella chiesa nuova San Francesco di Paola da Sua Ecc. Mons. Beniamino Depalma, Vescovo di Nola, è par ta al suono delle campane la processione eucaris ca, preceduta da una folta schiera di fedeli con in mano le candele ed alla fi ne del corteo il bal-dacchino con l’ostensorio. Quando la processione è giunta dinanzi la vicina Cappella dell’Adorazione, il vescovo è entrato insieme agli altri sacerdo , ed ha pronunciato una breve preghiera prima che il San ssimo Sacramento fosse posto sull’altare, dando così avvio a quell’esperienza unica per il cris ano a diventare adoratore in spirito e verità in virtù della sua consacrazione ba e-simale. Mons. Beniamino Depalma nell’omelia
ha so olineato che se la nostra fede è veramente sincera e crediamo in quello che il vangelo ci annuncia, dobbiamo rispondere a questa sfi da con l’impe-gno dovuto, perché “in tempi in cui le nostre chiese rimangono spesso chiu-se, una cappella sempre aperta, per chiunque voglia avvicinarsi a qualsiasi ora del giorno o della no e, è come le braccia sempre aperte di Gesù pronte ad accogliere ogni uomo” (Padre Justo Antonio Lo Feudo mss)L’adorazione eucaris ca perpetua è una realtà presente in tu o il mondo e coinvolge milioni di persone. In Italia è presente in circa 50 Parrocchie con ol-tre 15.000 adoratori che hanno scelto di vivere la propria vita off rendo un’ora alla se mana alla presenza di Gesù Eu-cares a. L’adorazione Eucaris ca è un tempo trascorso in preghiera davan al Sacra-mento dell’Eucaris a esposto solenne-mente. Adorare è lasciarsi amare da Dio per imparare ad amare gli altri. Adorare è entrare nell’esperienza del Paradiso, vuol dire prepararsi ad entra-re nella pienezza della condizione fi liale di quando si contemplerà il volto di Dio. Si può pregare in vari modi, ma il modo
migliore è una preghiera di silenziosa meditazione, sul mistero dell’Amore con cui Gesù ci ha amato, tanto da dare la sua vita ed il suo Sangue per noi. Adorare, oggi, vuol dire anche me ersi all’ascolto del Signore in silenzio. Nel si-lenzio del cuore Dio ci ispira e in questo modo ci parla. “Dio è amico del silenzio: dobbiamo ascoltare Dio perché ciò che conta non è quello che diciamo noi, ma quello che Egli dice a noi e a raverso di noi” (Madre Teresa)Il silenzio è pienezza. Stare in silenzio, nella preghiera, equivale a stare in ascolto. Non ci può essere adorazione senza silenzio. Il silenzio è rivelazione. Il silenzio non rappresenta tanto l’altra faccia della parola, ma è parola esso stesso. Dopo aver parlato, Dio tace, ed esige da noi il silenzio, non perché la co-municazione sia terminata, ma perché restano altre cose da dire, altre confi -denze, che possono essere espresse unicamente dal silenzio. San Cirillo di Alessandria diceva che noi siamo come l’acqua: se si me e sul fuoco diventa bollente! Così è chi sa adorare in silenzio l’ospite divino, fuo-co d’amore che può rendere ardente la nostra povera acqua se s amo volen- eri sul fuoco del suo amore.
Il silenzio è fede.Quando taci perché è Lui che agisce, quando rinunci ai suoni, alle voci del mondo, per stare alla Sua Presenza, quando non cerchi comprensione, per-ché basta essere conosciuto da Lui, il silenzio è fede.Il silenzio è adorazione.Quando abbracci la Croce senza chiede-re: «Perché?». Il silenzio è adorazione.
Pasquale Velleca
Eventi 7
Rosaria Sco o

settemiglia
settemigliada Gerusalemme ad Emmaus ...e ritorno
Supplemento a IN DIALOGOMensile della Chiesa di NolaAut.ne Trib. di Napolin. 3393 del 7/03/1985Direttore Responsabile:MARCO IASEVOLI
Coordinatore Redazione:DON GIUSEPPE DE LUCARedazione:VINCENZO FIORENZAENZO VITIELLOALFONSO QUARTUCCIELENA FIORENZAVINCENZO DONNARUMMA
E-Mail ed Info:[email protected]
Per leggere e scaricarele pubblicazioni precedenti:www.settemiglia.it
SPIRAGLI...Deli o e Cas go
“[...]Eppure all’inizio c’era una visio-ne chiara, un alto ed urgente pro-posito nella mia anima.”
Eccoci qua, ci ritroviamo di nuovo per rifl e ere, leggere, sognare. Ci sono libri che terrorizzano un le o-re solo a sen rne il tolo. Bene, oggi vi parlerò proprio di uno di ques ro-manzi, sperando di sfatare l’angoscioso mito che l’accompagna. Il protagonista di questo mese è un “innocente” librici-no in tolato Deli o e cas go di Dosto-evskij, autore russo del secondo ‘800 indiscu bilmente conosciuto per la sua terrifi cante fama di scri ore prolisso e noioso. Allora, giustamente, vi chiede-rete: “Ma perché mai dovremmo leg-gerlo? Non ci basta unicamente essere a conoscenza della sua esistenza?” La risposta potrebbe essere che è un clas-sico ed in quanto tale va conosciuto. Ma, precisamente, cos’è un classico? Per rispondere a questa domanda pa-rafraserò le parole di uno stravagante autore italiano: Italo Calvino. Per lui un classico è un’opera che ha ancora qual-cosa da dire. Forse è proprio racchiuso qui il fascino di questo libro spavento-so, è un romanzo che, nonostante sia cristallizzato nel tempo, ha ancora un sapore vero e reale. “Com’è possibile? Di cosa parlerà mai per essere così at-tuale?”. Per chi sa guardare in profon-dità, l’unico argomento senza tempo è l’uomo. Ricco di sfacce ature e in-congruenze, dall’animo pieno di fi ordi, l’uomo rimane il mistero più intricato da risolvere e il nostro Fëdor (permet-terete l’informalità) sa bene come sca-
vare in profondità e riportare alla luce tesori nascos . Tornando al romanzo, potremmo inserirlo nella categoria dei gialli; apparentemente ha tu e le carte in regola: l’omicida e la vi ma, l’inve-s gatore fi ccanaso e tu a una serie di personaggi strani che non hanno nulla da invidiare alle fi gurine create dal-la Chris e. Eppure c’è qualcosa di di-verso. Forse è perché già conosciamo chi sarà l’assassino (e stavolta non è il maggiordomo), lo vediamo all’azione, ne conosciamo i proge , e le mo va-zioni, sen amo i ba accelera del suo cuore, ne proviamo l’angoscia o la soddisfazione? Non credo. Per cono-scere men depravate ci sono ben altri romanzi che potrebbero sconvolgere di più. E allora? Dov’è la novità? L’innova-zione è nel percorso, nella strada tor-tuosa di un ragazzo che “Voleva diven-tare un Napoleone e perciò ha ucciso”, nell’introspezione sua e del mondo che gli è vicino, tu si trovano risucchia- dal vor ce della perdizione, si cade,
ognuno nel suo sarcofago, verso la stes-sa direzione, una caduta dolorosa che lacera e dilania, una caduta senza fi ne perché l’abisso nel quale si precipita è “se stessi”, fi gure accartocciate, immor-talate in questo girone dantesco che li vuole soff eren e impossibilita dal risca o, almeno fi no a che non si ab-bandonano alla loro fi nitudine di uomi-ni ed acce ano la sfi da più grande che
è quella d’amare. Sembra di rivederci tu o il terrore e lo sconforto del Gesù dello Getsemani e, allo stesso tempo, la dolcezza infi nita dell’abbandonarsi al meraviglioso a o d’amore che è il per-dono di Dio. In questo romanzo, dun-que, oltre all’apoteosi dell’uomo razio-nale che per esistere deve abbracciare la fi losofi a dell’annientamento, tro-viamo anche la dolcezza di un volto di donna, la comprensione di due occhi di padre, che sanno accogliere lo sgomen-to, ascoltare la superbia e con paziente maieu ca rar fuori le confessioni più dolorose ma paradossalmente più libe-ratorie. Per riuscire in questa missione d’ascolto, in questo lavorìo psicologi-co, ovviamente bisogna appartenere a quel mondo; ancora una volta troviamo il Dio che si è fa o uomo, che è disceso per comprendere, soff rire, arrabbiarsi, amare. Ancora una volta, dunque, Do-stoevskij tesse una so le trama che ci riunisce al cielo. Tra la hybris (l’arrogan-za) dell’uomo e l’azzurro abbagliante c’è solo un passo da compiere, scen-dere giù in profondità, toccare l’umano troppo umano (per scomodare anche Nietzsche), per poi risalire a “riveder le stelle”.
Elena Fiorenza
Deli o e Cas goDi Fedor M. DostoevskijEditore Einaudi Collana Tascabili classiciData uscita 19/09/2005Pagine 655
“È il rendiconto psicologico di un deli o. Un giovane, che è stato espulso dall’Università e vive in condizioni di estrema indigenza, sugges onato, per leggerezza e instabilità di concezioni, da alcune strane idee non con-crete che sono nell’aria, si è improvvisamen-te risolto a uscire dalla bru a situazione. Ha deciso di uccidere una vecchia che presta denaro a usura...”
Rubriche 8
“Sarei curioso di sapere che cosa gli uomini temono più di tutto”
settemigliada Gerusalemme ad Emmaus …e ritorno
Diocesi di Nola – Parrocchia San Francesco di Paola – Scafati – Sa
Questa raffi gurazione del Risorto fa parte di un poli co dipin-to da Isenheim di Grünewald
(1475 – 1528), per un ospedale che accoglieva i mala di “fuoco di sant’An-tonio” (Herpes Zoster), mala a che al-lora era ancora più devastante. In quell’ospedale, Grünewald, pensa di costruire una vera e propria “macchina sacra” a cui affi da una straordinaria ca-pacità di conforto: l’ammalato si imme-desimava in Cristo in croce delle prime ante, piagato dalle sue stesse piaghe, in un secondo momento, quando le ante si aprivano, contemplava il dolce miste-ro del Natale e si faceva piccolo in brac-cio alla Madre della Luce che lo guidava a specchiarsi nel volto trasfi gurato del Risorto, che abbagliandolo di luce, lo guariva dalla disperazione.Tanto è raccapricciante e umiliante l’uomo crocifi sso, quanto sfolgorante ed esaltante l’uomo luminoso risorto.Questo è il Cristo che ci a ende il gior-no di Pasqua, il Cristo che ci lascia vede-re tu o: la luce del suo volto e le ferite che ancora sanguinano; la bellezza del suio corpo glorioso e la ferita inu le del costato, arrivata quando non c’era più sangue. Era già sparso tu o.Il Tempo di Pasqua - dopo quaranta giorni di preparazione, dopo le cele-brazioni gravide di signifi cato della se mana Santa - è anch’esso un pe-riodo che ci perme e di accostarci ad un mistero grande e davvero diffi cile da comprendere: un mistero che sta nel-lo spazio del paradosso tra il Crocifi sso e il Risorto. E tu o questo ha una re-lazione molto dire a con noi tu , un eff e o posi vo di salvezza sulla nostra vita concreta. Cosa ha compreso Grünewald quando ha rifl e uto sulla morte e passione di Cristo? Cosa ha immaginato per giun-gere ad una immagine così radiosa del-la “luce dentro Gesù”?Gesù ha assunto le nostre tenebre, le ha caricate su di sé, nel suo corpo e nel suo spirito, ma misteriosamente e divinamente le ha trasformate in luce, annientandole nel suo amore così forte
per noi. Lo sfondo plumbeo e ossessivo della crocifi ssione si è trasformato in un infi nito cielo stellato, rischiarato da un globo di luce sfolgorante che viene da Gesù stesso. Quando mai una luce così intensa si è sprigionata da una persona e non dal sole!? Quella stessa luce che vediamo è diven-tata per noi l’Eucaris a, il pane lumino-so della vita che ci rende a nostra volta luminosi. E’ la stessa luce che ammiria-mo no e e giorno ininterro amente nella cappella dell’Adorazione Perpe-tua; è la stessa luce che ci investe tu e le volte che ci riconciliamo con Dio.Gesù è la Luce - trasformato e riempi-to dalla luce, trasfi gurato, nella visione straordinaria di Grünewald - ed è venu-to, vissuto, morto e risorto per comu-nicarci che in lui anche noi possiamo
diventare luminosi fi gli di Dio. Gli eroi di questo mondo vengono illumina dai rifl e ori esterni; ma in Cristo risorto ci è dato di essere illumina da dentro e trasforma dalla sua luce e grazia. Se quaranta sono sta i giorni di prepa-razione alla Pasqua, cinquanta ce ne sono off er per percepire, anche mini-mamente, la divinizzazione off ertaci da Gesù Risorto. Essa è ben più di qualsiasi gloria terrena, perché non è cosa ester-na a noi, fa a di beni e ogge , ma è una vera e propria, in ma e sostanziale trasformazione interna a noi, del nostro io più profondo, nella redenzione per tu quelli che credono in lui, e nella san tà per chi lo segue.La sua Pasqua sia la nostra Pasqua, la sua luce il rifl esso con nuo sui nostri vol !
don Peppino, parroco
Periodico MensileAnno I - N°6Aprile 2011Mail ed Info:[email protected]