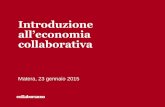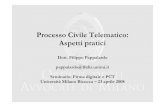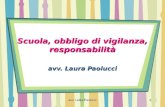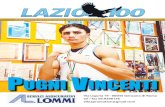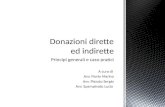Introduzione all'economia collaborativa - Marta Mainieri - Sharing School
Sentenza 11 luglio 1961; Pres. Benvenuto P., Est. Mainieri; Giagni (Avv. Morelli) c. Soc. C.i.n.e.s....
Transcript of Sentenza 11 luglio 1961; Pres. Benvenuto P., Est. Mainieri; Giagni (Avv. Morelli) c. Soc. C.i.n.e.s....
Sentenza 11 luglio 1961; Pres. Benvenuto P., Est. Mainieri; Giagni (Avv. Morelli) c. Soc. C.i.n.e.s.(Avv. Genzano, Helbig)Author(s): D. T.Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 815/816-817/818Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150460 .
Accessed: 24/06/2014 21:35
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.34.79.208 on Tue, 24 Jun 2014 21:35:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
815 PARTE PRIMA 816
f
chiede ohe il Tribunale dichiari la nullita della nomina
prefettizia, nullita ehe si risolve nella revoca dell'atto
amministrativo, ehe verrebbe posto nel nulla con la sen
tenza, mentre i tribunali possono conoscere soltanto degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in
giudizio (art. 4 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E). A ciõ deve aggiungersi ehe il Dini, non essendo perso
nalmente interossato, non e attivamente legittimato a far
valere la nullita dei decreti prefettizi. Per le considerazioni sõpra svolte, va dichiarato il
difetto di giurisdizione deH'autorita giudiziaria ordinaria a
conoscere della domanda proposta. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
TRIBÜNALE DI ROMA.
Sentenza 11 luglio 1961 ; Pres. Benvenuto P., Est. Mai
nieei ; Giagni (Ayv. Morelli) c. Soc. C.i.n.e.s. (Aw
Genzano, Helbig).
Cinematojjral'o c cinematogratia — Contratlo tli sec
iiegjjialura — Natura — Reeesso <lel committente — Ammissibilitä — Coiisef|iienze (L. 22 aprile 1941
n. 633, protezione del diritto d'autore, art. 44, 45, 46, 50 ; cod. civ., art. 2094, 2222, 2227).
Formmdo la sceneggiatura di un film oggetto di contratto di
lavoro fiduciario, il prodwttore committente pud recedere
dal contratto, la cui esecuzione sia giä iniziata, tenendo
indenne lo sceneggiatore delle spese, del lavoro esegwito e
del mancato guadagno. (1)
Il Tribunale, ecc. — L'attore deduce ehe il reeesso della
Societä convenuta dal contratto, quando egli aveva giä fornito parte deH'opsra relativa alia sceneggiatura del film,
obbliga la C.i.n.e.s. a tenerlo indenne delle spese, del la
voro eseguito e del mancato guadagno, die si concretano
in lire 850.000, residuo di quelle pattuite. Tale deduaione conduce il Collegio all'esame sulla na
tura del contratto, le cui clausole prevedevano : «l'impegno del Giagni a prestare la sua opera per la stesura del sog
getto, del trattamento e della sceneggiatura di un film, avente ad oggetto il sacerdozio, mediante il complessivo
eompenso di un milione ».
Ai fini di una completa indagine, diretta alia esatta
qualificazione del contratto concluso dalle parti, conviene
innanzitutto stabilire quale sia la natura dell'opera cine
matografica. Al riguardo due concezioni, diverse e contra
stanti, vengono sostenute : quella, secondo cui l'opera cine
matografica e un'opera composta, ossi a un'opera priva di
autonomia, clie si risolve nel concorso delle due parti, e
quella, secondo cui essa & un'opera complessa, in cui e
(1) 13 da file vare che la sentenza, pur avendo qualificato lo sceneggiatore come prestatore d'opsra subordinate, ha rifce nufco applicabile 1'art. 2227 cod. civile.
Non risultano precedenti giurisprudenziali in termini. Si consulti, nella motivazione, Trib. Napoli 19 gennaio 1956, Giur. lav., 1956, II, 155 ; nonchž Cass. 5 giugno 1950, n. 1411, Foro it., 1950, I, 1265.
In dottrina, si vedano : Montanari e Ricciotti, La disci
plina giuridica della cinematografia, Firenze, 1953, I, pag. 68, se condo cui il rapporto tra produttore ed autore, al quale il primo abbia commesso la creazione o la elaborazione di un soggetto o di una sceneggiatura, o di entrambe, non e di semplice locazione d'opera, implicando un vero e proprio trasferimento della pro priety intellettuale sull'opera commissionata ; nella eitata ipotesi si ha, secondo tali A., un atto di disposizione su opera futura. Se condo il Lega, Sulla natura giur. del rapp. tra il regista, ecc., in Giur. Cass, civ., 1950, 2° quadr., 324, gli autori del soggetto e della sceneggiatura conferiscono un risultato definitivo (opus) ed il loro rapporto e certamente di locatio operis. Per un accenno, si veda anche A. Giannini, Opera cinematografica e c vnlralti eine matografi^i, in Riv. dir. civ., 1958, I, 436.
D. T.
prominente la riunione ad opera di un solo soggetto delle
varie collaborazioni ; onde l'opera ha una sua propria auto
nomia e puõ eonsiderarsi capaoe di un di st into diritto di
autore. La prima concezione dä rilievo ai momento della
oreazione intellettiva, cioe ai momento della personality; la seoonda, inveee, dä rilievo ai momento di estrinsecazione
della creazione, intesa taie espressione nel suo risultato
finale.
La duplice concezione sembra põssa assumersi a giusti ficazione della costruzione del nostro ordinamento positivo, di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi ai suo esercizio,
ehe, negli art. 44 e 45, enuncia rispettivamente clie la qua lifica di « coautori» dell'opera cinematografica e attribuita
all'autore del soggetto, a quello della sceneggiat-ura, a
quello della musica ed ai direttore artistico (regista) e clie,
inveee, 1'esercizio dei diritti di utilizzazione economica della
opera cinematografica spetta a clii lia organizzato la produ zione dell'opera stessa (produttore), entro il limite indicato
nel successivo art. 46, 1° comma.
La costruzione legislativa risente del travaglio dottri
nale, circa la delimitazione della natura e della portata dell'attivitä di tutti coloro ehe intervengono alla creazione
dell'opera cinematografica, travaglio ehe si manifesto anclie
nella revisione di Berlino del 1908 della Convenzione di
Berna del 1886 e ehe e chiaramente espresso nel rapporto della Commissione, in cui si riaccosta il film alle opere let
terarie ed artistiehe e, soltanto di sfuggita, si accenna alla
possibility dell'esistenza di un'opera nuova.
Ciõ precisato, oceorre rilevare ehe la limitazione del
riconoscimento del contributo creativo alle sole quattro
categorie ora ricordate o certamente in funzione del con
cetto stesso di opera dell'ingegno, ehe e creazione nel campo
letterario, scientifico o artistico, obiettivata in forma con
oreta ed organica attraverso mezzi e con linguaggi espres sivi determinati, di idee, di fatti immaginari, di sentimenti.
La legge pone sullo stesso piano, come coautori, i quat tro astratti soggetti innanzi eitati, ma e innegabile ehe il
ruolo di costoro ha qualitativamente e quantitativamente un valore diver so.
L'autore del soggetto si limita a fornire la trama del
film, consistente in una novella, un romanzo, una eommedia
ed in genere in una produzione letteraria, dalla quale e
dato cogliere gli elementi fondamentali della vicenda cine
matografica. Siffatto contributo b essenziale, ma non determinante.
II soggetto della vicenda espone la concezione dell'autore,
quale si e sviluppata attraverso le sue personali intuizioni,
rappresentazioni e reazioni emotive, costituenti il conte
nuto psichico originale, che si obiettivizza nella forma
esterna. Ma, ai fini del raggiungimento del risultato, come
opera d'arte, la trama deve essere trattata, ossia ridotta ai fini cinematografici. Dopo la riduzione, il soggetto va elabo
rato, attraverso trasposizioni, mutazioni ed aggiunte agli
episodi e, a volte, anche ai personaggi dell'azione origi naria, ai fini della formazione delle « sequenze », ehe dänno lo svolgimento dell'azione cinematografica.
Ora il contratto intercedente tra produttore e sceneg giatore, esaminato sotto il profilo giuridico, ad eccezione delle poche norme sul diritto di autore di cui si e fatto cenno che qualificano la figura dello sceneggiatore nel
quadro dell'opera cinematografica, ricade sotto 1'applica zione delle norme del codice civile (art. 2094 segg.). Esso
concerne una delle forme di lavoro intellettuale, come tale
preso in considerazione dalla Societä delle Nazioni e poi dairO.N.U., in conseguenza del voto emesso nella confe
renza di Roma (1928) per la tutela degli artisti esecutori, fuori della Convenzione di Berna sulla proprietä letteraria.
Ammettendo la qualifica di rapporto di lavoro, che nel
decreto del Capo del Governo 27 novembre 1939 n. 1803, assunse la denominazione ufficiale di « contratto individuale di scrittura », benche il nome successivamente non sia en trato nella prassi, viene posto un altro problema preliminare, e ciofe se il contratto di lavoro del coautore dell'opera cine
matografica debba qualificarsi di lavoro subordinato o au tonomo. Se si tiene presente la distinzione tra i due lavori
This content downloaded from 195.34.79.208 on Tue, 24 Jun 2014 21:35:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
817 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 818
fatta dal vigente codice civile agli art. 2044 e 2222, appare evidente che quello che discrimina la locatio operarum dalla locatio operis e la subordinazione del prestatore di
lavoro alia direzione dell'imprenditore. Xel contratto cinematografico, difatti, si ritrovano i due
elementi: subordinazione e rischio, che rappresentano i
lati caratteristici del contratto di lavoro. Quanto al primo elemento, esso deriva dal fatto ebe il coautore del film
rimane pur sempre un prestatore d'opera subordinato, non
essendo egli svincolato dal piano organizzativo e dal cri
terio direttivo del produttore del film o di chi per lui, e
non essendo le prestazioni di lavoro dell'artista del cinema,
per quanto elevate e pregiate, la sola esclusiva determina
zione del risultato dell'opera. Ed e proprio in questo il
carattere distintivo della locatio operarum dalla locatio operis.
Riguardo all'altro estremo, esso si ricava dal fatto che
l'autore dell'opera cinematografica, nella specie, lo sceneg
giatore non partecipa ai rischi dell'impresa, cbe, invece, e organizzata dal produttore, il quale fornisce i capitali
necessari; e la sopportazione del riscbio giustifica la subor
dinazione ed i poteri dell'imprenditore. N6 si obietti che la particolare figura del produttore
snaturi il contratto di lavoro. Basta in proposito conside
rare che se, de iure condendo, il complesso problema concer
nente l'inquadramento giuridico della figura del produttore merita il piu attento esame, anche in relazione al preva lente indirizzo della dottrina intesa ad ottenere, sotto la
spinta delle organizzazioni internazionali dei produttori ci
nematografici, il riconoscimento al produttore della qua lifica di autore, e vano il negare che, con il sistema attuale
vigente in Italia, nel produttore si accentua l'esercizio dei
diritti di utilizzazione economica. Egli, difatti, pur rice
vendo dagli autori i contributi fondamentali per la produ zione dell'opera cinematografica, ha facolta di scelta e di
coordinamento, ed assume il rischio del processo produt tivo del film, ft questa caratteristica che da struttura essen
ziale ai contratti stipulati dal produttore con i coautori
del film, a nulla rilevando la questione se il produttore,
per lo sfruttamento economico dell'opera da lui condotta a
termine con i suoi mezzi, agisca per mandato ex lege o sia
titolare di un diritto di godimento iure proprio. Le clausole contenute nella scrittura privata intercorsa
tra le parti dimostrano agevolmente la natura del con
tratto in controversia.
Con esso difatti l'attore s'impegnava a prestare la sua
opera a favore della C.i.n.e.s. per la stesura del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura definitiva di un film,
il cui argomento concerneva l'attivita spirituale di uno o
piu sacerdoti e sui problemi inerenti all'esercizio di tale
missione.
L'obbligo, quindi, assunto dall'attore era caratteristico
dell'opera svolta dallo scenografo, per essersi il Giagni
impegnato a creare il soggetto, ad elaborarlo in forma cinema
tografica e a costituire il piano particolareggiato delle di
verse serie di scene. II fatto, poi, secondo il quale l'attore
avrebbe compiuto la sua opera, « seguendo gl'indirizzi e le
iudicazioni del produttore e del regista », vieppiü dimostra
come lo sceneggiatore sia un prestatore d'opera subordi
nato ed il ruolo assolutamente preponderante che il regista assume su quello degli altri autori nella fase di esecuzione
dell'opera ed in quella particolarmente delicata della sua
immediata preparazione. D'altra parte, per quanto concerne il produttore, la sua
posizione si spiega con il fatto, che, assumendo egli il ri
schio dell'impresa e spettandogli, a termini dell'art. 46,
1° comma, legge cit., lo sfruttamento cinematografico del
l'opera prodotta, egli deve assicurarsi le migliori condizioni
per il piii intenso sfruttamento del prodotto della sua im
presa ; da ciõ deriva il suo diritto a richiedere la coopera
zione degli artisti e degli operatori, in modo da creare un
complesso organizzato di mezzi e di prestazioni adeguate
alle finalitä previste. Xe tale criterio direttivo, che compete
al produttore, vulnera il titolo originario del diritto d'autore,
costituito, aisensi dell'art. 6 legge cit , dalla creazione del
l'opera, quale particolare espressione del lavoro intellet
tuale, in quanto, se il coautore dell'opera, nella specie,
lo scenografo, e vincolato ai piano organizzativo del pro duttore, Pattivitä di questi in ordine alle modificazioni
inoontra sempre i limiti di cui all'art. 46 stessa legge, ehe
consentono modifiche puramente tecniche, giustificate da
esigenze eeonomiche.
Riguardo all'altro aspetto della clausola, la posizione di prevalenza del regista nei confronti dello sceneggiatore 6 determinata dal fatto ehe il regista, procedendo ad un
incisivo lavoro di rielaborazione, di coordinamento e di
direzione, imprime all'opera in corso di produzione il tim
bro talora prepotente e, comunque sempre inconfondibile, della sua personalita e del suo particolare ingegno creativo.
Ciõ stabilito quanto alla natura del contratto, giova osservare come la facoltä di recesso del committente, pre vista dall'art. 2227 cod. civ., trovi la sua giustificazione nel carattere fiduciario del rapporto.
La risoluzione, quindi, puõ avere luogo senza una giusta causa e senza ehe il committente sia obbligato a darne
comunicazione. L'esercizio della facoltä di recesso obbliga,
perõ, il committente a retribuire il lavoratore per la parte del lavoro eseguito e a tenerlo indenne del lucro cessante
o mancato guadagno, eon il criterio dell'arbitritim boni
viri, indipendentemente dalla utilitä ricavatane. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
TRIBUNALE DI PALERMO.
Decreto 20 marzo 1961 ; Pres. Terra nova P., Est. Burgio ; ric. Soe. Siciliana azionaria elementi prefabbricati
(S.a.e.p.).
Soeietä — Soeietä per azioni — Mancata determina
zione statutaria «lella ripartizione de<|li 111 iii —
Integrazione mediante esercizio della deleya ad
apportare modiliehe — Ammissibilitä — Liiniti
(Cod. civ., art. 2328, n. 7, 2428).
Ghi, nell'atto costitwtivo di soeietä, e stato delegato ad apportarvi le modificazioni eventualmente suggerite dal tribunale in
sede d'omologazione, pud giovarsi di detta delega per
integrate la mancanza, nello statuto, di clausole relative
alla ripartizione degli utili, assegnandone il 5% ai fondo di riserva, e il rimanente alle azioni, salvo le detrazioni
deliberate dalVasscmblea. (1)
Il Tribunale, ecc. — L'atto eostitutivo e lo statuto
della Siciliana azionaria elementi prefabbricati non con
tengono, contro il disposto dell'art. 2328, 1° comma, n. 7,
le norme relative alla ripartizione degli utili. Di seguito ai rilievo in sede di omologazione, 1'ist ante Giuseppe Fer
raro, avvalendosi dei poteri a lui conferiti dall'art. 10
(1) Siill';inmiissibi 1 it a della delega, di solito conferita ad
alcuni degli amministratori, ad apportare all^atto eostitutivo
le modificazioni richieste dal giudice in sede d'omologazione, su cui s'indugia il decreto riportato, cons. Trib. Lucera 15 aprile 1948 (Foto it., Rep. 1948, voce Soeietä, n. 87), pronunciato su
ricorso del notaro A. Giuliani, il quale, in nota ai presente decreto (Riv. notariato, 1961, 914), ritiene ingiustificato il rilievo
inteso dal Tribunale di Palermo a provocare il successivo atto
di rettifica dal momento ehe i soci, non avendo disciplinato la ripartizione degli utili, si erano rimessi ai regime di legge,
poi espletato dal delegato in sede di rettifica.
Graziani, Diritto delle soeietä, 1960, pag. 209, richiamando
il decreto del Tribunale di Lucera, considera indubbiamente
valida la clausola ; Romano Pavoni, in Riv. dir. comm., 1951,
II, 275, la ritiene autonoma rispetto ai negozio eostitutivo della
soeietä ; Frž, Soeietä per azioni2, pag. 74 in nota (Commentario del
eodiee civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, sub art. 2330),
precisa ehe con la delega « non si attribuisce una vera e propria facolta di modificare lo statuto, ma soltanto quella di apportare a questo atto le modificazioni strettamente necessarie per otte
nere 1'approvazione dell'autoritä giudiziaria »(ivi citazioni di dot
trina, tra cui A. Scialoja, Saggi di vario diritto, II, pag. 147, e
di giurisprudenza correnti sotto il codice di commercio abrogato).
This content downloaded from 195.34.79.208 on Tue, 24 Jun 2014 21:35:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions