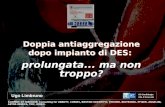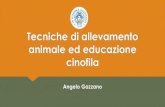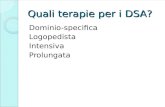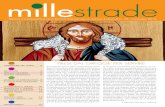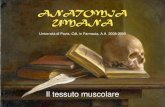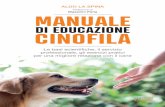Seminario tenuto degli allievi educatori della Scuola Cinofila il Mio ... · alcuni schemi motori...
Transcript of Seminario tenuto degli allievi educatori della Scuola Cinofila il Mio ... · alcuni schemi motori...
1
Conoscer
e
IL CANE
Seminario tenuto degli allievi educatori della Scuola Cinofila il Mio Cane (MI)in data 16 marzo 2013
1
2 3
Si dice sempre che il cane è il migliore amico dell’uomo, ma per capire come mai proprio il cane e non un altro animale lo si possa considerare davvero tale bisogna tornare indietro migliaia di anni ed individuare il momento del primo incontro tra uomo e cane - anzi tra uomo e lupo - e capire lo straordinario iter evolutivo che ne è seguito.C’è un vecchio proverbio che dice “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”…e dunque, visto che il cane è parte integrante della nostra vita, rientra a pieno titolo tra i membri del nucleo famigliare e occupa un posto rilevante (spesso anche il divano..) all’interno delle nostre mura domestiche, è corretto e doveroso conoscere la storia di “chi ci siamo portati in casa”!!Uomo e lupo si sono incontrati circa 400.000 anni fa e la loro storia avrebbe potuto, da subito, prendere una piega molto diversa.Sostanzialmente si incontrarono poiché iniziarono condividere ambienti e territori di caccia: erano due specie in aperta competizione per le risorse cibo e ambiente.Ma questa coabitazione anziché sfociare in una lotta aperta (che avrebbe portato all’allontanamento o addirittura all’estinzione di una delle due) si trasformò invece in una lenta e progressiva intensifi cazione dei contatti e delle relazioni che nel corso dei millenni si trasformò in una vera e propria coevoluzione: un processo di sviluppo delle due specie così indissolubilmente intrecciato e congiunto al punto da costituire ciascuna un forte fattore selettivo per l’altra.Possiamo dunque dire che (in qualche modo e con il peso dovuto ovviamente) se la specie uomo è giunta al livello di industrializzazione, tecnologia , struttura socio-politica che conosciamo oggi, in parte lo si deve anche al cane. Quindi..se non siete soddisfatti di come è la società moderna..ora sapete con chi prendervela!!
UOMO E
CANE
storia
di un
antica
allea
nza
,
di Andrea Aiolfi
4 5
Nel caso dell’evoluzione delle razze canine differenziatisi da più di 10 progenitori è possibile identifi care i meccanismi fondamentali, che sono: la selezione naturale che premia gli individui che si adattano nel modo migliore all’ambiente circostante , la selezione artifi ciale che invece premia coloro che rispondono maggiormente, sia dal punto di vista fi sico che del carattere, a ciò che è ricercato maggiormente nell’uo-mo; la deriva genetica, che è l’effetto del caso sulle frequenze genetiche e infi ne le migrazioni che i cani compiono al seguito degli uomini.Nella selezione artifi ciale le mutazioni discontinue che appaiono per caso,vengono mantenute incrociando la prole del soggetto portatore, mentre quelle continue sono dovute al lento modifi carsi di caratteristiche cercate con mirati accoppiamenti.I cambiamenti innaturali invece sono fortuiti e diffi cilmente adattivi ma possono rivelarsi utili in alcune circostanze come ad esempio il cambiamento del clima o del territorio.Il lupo per poter trasmettere i suoi geni deve avere svariate caratteristiche, tra cui una forte dominanza, mentre tra i primi lupi addomesticati è stato premiato il carattere sottomesso, che in parte è stato trasmesso ai nuovi cuccioli, così come la propen-sione alla collaborazione che è fortemente ereditaria. Inoltre alcuni tratti caratteriali sono legati a caratteristiche morfologiche; nel nostro caso è inutile sottolineare che un temperamento più giocoso e infantile si associa a caratteristiche morfologiche ben precise del lupo, muso piu corto e stop + accentuato, occhio più rotondo ecc, cioè a caratteristiche morfologiche che sono presenti nel cucciolo di lupo; queste sono ca-ratteristiche che infatti ritroviamo in molte razze canine.La genetica tende poi a rendere la popolazione omogenea in situazione di gruppi ridotti come quelle dei primi lupi addomesticati, che sono molto simili tra di loro,
Tornando alla storia, un grande punto di svolta nelle relazioni uomo-cane si ebbe all’incirca 25.000/30.000 anni fa, quando l’umo iniziò a creare i primi villaggi semipermanenti. Con i nuovi insediamenti, l’uomo diede vita ad una nuova nicchia biologica, il villaggio appunto, che produceva inevitabilmente rifi uti organici, carcasse, ossa, scarti, avanzi di macellazione delle prede che venivano accumulati all’esterno del villaggio, creando vere e proprie discariche.Alcuni lupi capirono il vantaggio di avvicinarsi all’uomo per sfruttare questa nuova nicchia alimentare ed accedere facilmente ad una nuova (e praticamente illimitata) fonte di cibo.Inizialmente quindi non c’era nessun tipo di collaborazione: nessun quadretto romantico o scena da cartone animato disneyano. Il lupo aveva semplicemente imparato a vivere nei presi dei villaggi per trarne vantaggi.Molto probabilmente, in un lasso di tempo medio-lungo, anche l’uomo imparò a convivere con la presenza dei lupi e a sfruttarne utilitaristicamente le qualità, come compagno di caccia e come guardiano e sentinella del villaggio.Iniziò così ad inserirlo progressivamente nella vita sociale della comunità, iniziando ad occuparsene e nutrirlo, riproducendo i soggetti che si dimostravano più miti, collaborativi e adatti a svolgere determinati compiti.Era iniziato il processo di domesticazione che, lentamente, dal lupo porterà alla nascita del Canis Familiaris prima e alla creazione delle attuali razze canine poi. I primi ritrovamenti di canis familiaris provengono dal sito archeologico di Oberkassel in Germania e risalgono a 14.000 anni a.C.: uno dei primi ritrovamenti in cui si testimonia il legame sociale ed emotivo tra uomo e cane.A partire da circa 10.000 anni fa, si hanno ritrovamenti di cani un po’ in tutto il mondo e la sua diffusione è via via sempre più rapida.Da quel momento in poi, nella storia dell’uomo il cane sarà sempre presente, assumendo di volta in volta ruoli, status e funzioni diverse fi no ad arrivare ai nostri giorni, dove l’amore per i cani, e la cultura cinofi la in generale, sembrano aver guadagnato fi nalmente il giusto peso e la meritata considerazione.
le raz
ze
di Alessandro Gatti
6 7
essere gratifi cati!Per le razze, che ancora oggi vengono impiegate nella conduzione dei greggi, bisogna tener conto che sono molto ‘’ motivate’’ a mettere in atto
alcuni schemi motori del comportamento di guida del gregge. La prolungata presen-za in situazioni in cui è impossibile il soddisfacimento di tali motivazioni porta il cane ad attuarle spesso e mal volentieri fuori contesto e in maniera compulsiva.I guardiani del gregge invece svolgono un ‘’lavoro’’ radicalmente diverso, sono stati plagiati in maniera completamente diversa dai conduttori.Questi cani venivano spesso lasciati, per moltissimo tempo, soli con il gregge con il quale il cane crea un forte legame sin dai primi mesi di vita) , accompagnandolo e difendendolo.Per svolgere tale compito è stato necessario selezionare cani con una forte indipen-denza, capaci di prendere decisioni in totale autonomia, con un forte senso di terri-torialità e di gruppo, scarso interesse e predatorio che poteva provocare l’allonta-namente del cane dal greggeo oppure perchè poteva essere indirizzato sul gregge stesso.
Gruppo 2 Pinscher Shnouzer Molossi e Bovari svizzeri
Anche il gruppo 2 come il precedente, comprende tipologie di cani molto differenti sia morfologicamente che per attitudini e utilizzo.I cani di tipi Pinscher e Shnouzer, sono principalmente cani da difesa e da guardia, si tratta di cani in cui i comportamnti istintivi sono poco presenti a vantaggio della versatilità addestrativa.Il cane da difesa inoltre deve essere molto legato al padrone, meno al territoroi in quanto deve accompagnarlo nei vari spostamenti, data la loro fi sionomia sono cani molto reattivi e resistenti.I molossi invece di struttura fi sica più massicia erano inizialmente usati come cani da guardia delle proprietà e per il combattimento, con il trascorrere degli anni il loro impiego si è evoluto principalmente nella difesa delle proprietà e delle persone. Si è dovuto quindi plasmare un carattere molto forte, territoriale e con un senso del possesso marcato.Si può fare unaulteriore suddivisione tra molossi usati per la guardia di greggi, e queli da guardia e difesa personale.I primi sono praticamente come i pastori da guardia dei greggi, mente gli altri sono più portati ad instaurare un rapporto stretto con il proprio branco di appartenenza.L’aspetto fi sico di questi cani è caratterizzato da molti tratti infantili ( muso schiac-ciato, orecchie pendenti ecc) e anche nel comportamente da adulti mantengono tratti infantili. Sono cani che tendono inoltre ad avere un buona propensione alla competi-tività, ma lo scarso livello di attivazione generale fa si che la reattività sia abbastanza bassa.
anche se chiaramente non ci fu selezione voluta su caratteri secondari come per esempio forma della testa, colore del mantello, portamento delle orecchie ecc, sta di fatto che quando l’uomo è diventato stanziale fossero già presenti ceppi diversi che hanno dato vita a tipi mor-fologicamente diversi. Le modifi che morfologiche sono arrivate più tardi nel processo evolutivo e sono state spesso involontarie, frutto della deriva, dell’isolamento della popolazione e degli incroci tra consan-guineiLe associazioni tra tipi morfologici e attitudini funzionali, è stata scoperta in tempi molto più recenti, anch’essa parte da scoperte casuali che si innestano su basi già precostituite, ma che vengono poi affi nate dalla selezione attuata dall’uomo che valorizza alcuni tratti (è emblema-tico l’esempio dei levrieri e della loro struttura che diviene sempre più adatta alla corsa che parte dall’osservazione di cani reali che possedevano caratteristiche migliori per la velocità rispetto ad altri cani di diversa tipologia).La razza come la intendiamo oggi è all’interno di una specie è una popolazione molto omoge-nea che trae la sua origine da motivi naturali quali l’isolamento o dal volere della selezione umana.
Da sempre i cani vengono suddivisi in gruppi, ma queste suddivisioni non possono essere considerate razze in senso moderno. La più antica classifi cazione che si conosca comprende solo 3 categorie : cani da caccia, cani da guardia e cani commestibili, ed è contenuta nel libro dei riti cinese che risale all 800 a.C.400 anni più tardi Senofonte suddivise i cani secondo la loro distribuzione territoriale, ma an-che in questo caso non sono chiare le correlazioni tra queste razze e particolari caratteristiche fi siche. Dobbiamo arrivare nel 945 dc, quando il re del Galles Hywel Dda raccoglie nelle sue leggi la prima classifi cazione dettagliata dei cani nel mondo, mettendo in correlazione la caratteristiche fi siche e comportamentali per arrivare a una defi nizione di razza in senso più moderno. Il sistema delle razze canine nasce in Inghilterra nel 1795 con i registri di canile che costi-tuiscono le prime testimonianze di ciò che si trasformò nello standard per il pedigree canino.
GRUPPO 1 cani da pastore e bovari, esclusi bovari svizzeri
Parlando di cani da pastore bisogna distinguere bene se si tratta di pastori da conduttori del gregge o di pastori da guardia del bestiame, in quanto le 2 funzioni sono radicalmente diverse.Nei pastori conduttori la pressione selettiva sull’impulso collaborativo è stata massima, man-tenendo schemi motori già presenti nel lupo ma adibiti alla caccia, quali l’accerchiamento, uniti ad un ovvio bloccaggio della sequenza predatoria al semplice fi ssare o pizzicare.La grande intelligenza adattiva e obbedienza rendono queste razze molto effi caci a svolgere compiti complessi impartiti dal padrone. Vien da pensare che grazie a questa grande moti-vazione collaborativa li si possa impiegare oggi in molteplici attività non necessariamente legate alla pastorizia, quali per esempio discipline sportive ; ne hanno proprio bisogno per
8 9
Gruppo 5 Cani nordici Spitz e primitivi
Questo gruppo contiene i cani nordici, da slitta e da caccia, gli spitz tedeschi e giap-ponesi e alcuni cani detti primitivi.I cani nordici selezionati per sopravvivere in un ambiente ostilissimo, sono diventati molto comuni negli ultimi anni anche nelle nostre città, ma non trovano nei climi caldi o temperati il loro principale problema di adattamento.Nonostante la stretta convivenza tra cane e uomo, il legame era praticamente solo utilitaristico, nel momento in cui la stagione non consentiva l’utilizzo delle slitte i cani spesso venivano abbandonati a se stessi e si procuravano da vivere cacciando. Chiaramente sopravviveva solo il più forte, e a cuasa di tale passato sono considerati degli “ spazzini e ladri “Quasi tutti i nordici non sono aggressivi nei confronti degli umani e ciò è dovuto allo spirito degli eschimesi, che erano molto ospitali nei confronti delle rare persone che incontravano, ciò li rende inadeguati alla gurdia, chiaramente il cane non doveva essere attaccato al territorio e tanto meno al padrone che poteva scambiarlo più volte.La diffi coltà di trovare risorse per il sostenatamento ha portato lo sviluppo della com-petitività, ma la sopravvivenza del gruppo contava molto, diafatti hanno sviluppato, o mantenuto una grande capacità di ritualizzare gli scontri e organizzare gerarchie ben precise, sviluppando una capacità di comunicazione eccezionale.Altri cani nordici completamente diversi per indole e uso sono i giapponesi, cani usati per la guardia, la caccia e il combattimento, sono comunque cani abbastanza distaccati e decisamente poco tolleranti verso le manipolazioniGli spitz tedeschi sono molto simili strutturalmente e caratterialmente, la funzione principale era quella di avvisare il gruppo quando qualcuno entrava nel territorioi cani primitivi sono quasi tutti invece cani da caccia.
Gruppo 6 Segugi
Fin da cuccioli rispetto agli individui di altre razze privilegianol’uso dell’olfatto ri-spettoagli altri sensi, e la loro abilità nel seguire le tracce è già signifi cativamente maggiore rispetto a quella di altri caniI segugi devono localizzare una traccia, seguirla con costanza, anche in condizioni di diffi coltà,seguendo debolissime emanazioni. Caratteristica indispensabileè una soli-da tenacia, ai limiti della cocciutaggine.Il cane dispone di una certa libertà di decisione e indipendenza nel lavoro che con-
Gruppo 3 Terrier
Il gruppo raccoglie svariati cani, suddivisi per funzioni e fi sionomia. Al giorno d’oggi pratica-mente tutti sono usati e considerati cani da compagnia, nonostante la loro origine come cani da lavoro.La maggior parte di essi nasce come cani da caccia di piccoli mammiferi, tassi e volpi, al contrario però dei levrieri e altri cani da caccia i terrier non appartenevano alle classi agiate ,ma alla gente comune.Sono cani particolarmente rustici, molto legati alla famiglia e per questo sono divenuti ottimi compagni.La predazione si serve prevalentemente di pulsioni istintive, il loro compito era quello di scovare le prede spesso superiori per taglia, segnalarle al padrone tramite l’abbaio( che è una caratteristica dei terrier) e se necessario ucciderla.Alcune razze proprio grazie a queste caratteristiche si specializzarono nei combattimenti, la tempra e la velocità dei cani da caccia fu incrociata con la forza e la stazza dei molossi, in modo da ottenere cani perfetti per tale compito.L’istinto predatorio è chiaramente molto radicato e sviluppato da anni di selezione.Come i molossi i terrier sono cani sempre pronti al gioco anche in età adulta. a discapito della taglia necessitano grande quantità e qualità di movimento.Quasi tutti sono spesso competitivi con i cospecifi ci, per far sì che fossero cani “competitivi” nei combattimenti, è stato sovvertito il comportamento originario del lupo che ritualizza le lotte rendendole incruente e sono stati selezionati quegli esemplari che perdono facilmente la capacità di capire i segnali di inibizione della sequenza aggressiva.
Gruppo 4 Bassotti
Nel gruppo 4 troviamo un unica razza siddivisa in nove varietà a seconda del tipo di pelo e di taglia.L’utilizzo era più o meno quello dei terrier da caccia in tana, per cui l’apparente deformità e risultata particolarmente utile.La dentatura dei cani è formidabile e spesso sproporzionata alla stazza, ma necessaria insieme alla grande tempra e coraggio, per uccidere prede quando il cacciatore era impossibilitato nel raggiungerlo.La forte competizione è stata esasperata negli anni, tanto che, spesso causa problemi nei rap-porti con i i cani di taglia più grande; tenacia, impulso alla lotta, abbaiare e la facile evocabi-lità di comportamenti di aggressione , sono spesso fastidiosi difetti di un cane da compagnia ma sono tutti considerati molto ereditabili.
10 11
Gruppo 9 Compagnia
Questo gruppo raccoglie razze molto diverse tra loro sia morfologicamente che per origine, quasi tutti sono di taglia piccola o addiritura nana ma sempre con ca-ratteristiche morfologiche infantili, anche il carattere conserva una conformazione neotenica(richiesta di attenzioni, propensione al gioco scarso istinto predatorio ecc)Alcuni sono molto reattivi altri più calmi e pacati, ciò è dovuto spesso alla conforma-zione fi sica che rende per esempio un buldog francese per forza di cose un cane calmo, perchè anche con poco movimento può avere problemi respiratoriIl loro unico scopo è quello i fare compagnia, e spesso sono inseriti in un contesto come quello delle città moderne, e per fare ciò si è dovuto selezionare esemplari che potessero trarre un livello accettabile di benessere anche da qualche breve passeggiata e dalla sola presenza del padrone, senza dover svolgere attività particolari.Spesso questi cani sono sottoposti al fenomeno dell’antropomorfi zzazione.
Gruppo 10 Levrieri
Il gruppo è decisamente omogeneo: cambiano da una razza all’altra quasi solo la ta-glia e il mantello. La forma è costante perché determinata dalla funzione, che è quella di sviluppare la velocità massima nella caccia ad inseguimento a vista.Sono frose gli unici cani che hanno manteuto pressochè inalterata la loro forma nel corso dei secoli.Fisicamente perfetti per la loro funzione i levrieri, hanno un istinto predatorio molto marcato, non sono cani partciolarmente portati a competere dato che spesso lavora-vano in mute. La tendenza ad abbaiare è scarsa, come l’addestrabilità dato che svol-gevano un tipo di caccia molto istintiva.Da tutto ciò ne deriva un cane poco reattivo veso gli stimoli sonori e olfattivi, ma reattivissimo agli stimoli visivi.Data la loro indole calma e pigra sono cani che si adattano anche a vivere in città se hanno la possibilità di fare il dovuto movimento all’ aperto.
serva anche nella vita quotidiana.Spesso lavorano in squadra e questa puculiarità li rende cani docili e socievoli con i propri simli vista la necessità di lavorare in gruppo.Sono inolte cani nei quali appunto l’olfatto ha un forte peso, una volta naso a terra seguono una pista anche per chilometri, quindi da liberi tendono ad allontanarsi molto dal padrone,, spesso non sentendo nemmeno il richiamo.
Gruppo 7 Cani da ferma
La funzione principale di questi cani è di scovare il selvatico, interrompendo la sequenza di caccia per aspettare il cacciatore.Altri Inseguono la preda e la spingono a portata del cacciatore indicando dove si trova con la classica posa da ferma che consiste nell’esasperare lo sguardo verso la preda, per ottenere ciò è stato necessario interrompere la sequenza predatoria del cane al semplice atto dello sguardo fi sso, o in alcuni casi al semplice morso per afferrare la preda e riportarla al cacciatore.L’istinto predatorio è forte, ma l’impulso a seguire la selvaggina non è tale da far perdere al cane il collegamento con il proprietario.Normalmente sono cani socievoli sia con i cospecifi ci che con l’uomo, e ciò li ha resi ottimi cani anche da compagnia.
Gruppo 8 Cani da riporto
Questo gruppo è formato sostanzialmente da cani da caccia per il ritrovamento della selvag-gina, e il suo recupero, spesso in acquitrini o arbusti.Questi cani sono diventati di gran moda, soprattutto labrador , Golden e cocker per la loro versatilità.Della sequenza predatoria i retriver hanno conservato tramite il processo di selezione sola-mente la fase di localizzazione e morso per afferrare la preda, ormai uccisa dal cacciatore e riportargliela, per fare ciò si sono dovuti selezionare cani che usassero la bocca in maniera “morbida” senza affondare i denti nella preda in modo da rovinarla. la così detto “bocca dura” è considerato un grave difetto, che avendo una base genetica è molto diffi cile da correggere.Sono cani tendenzialmente molto docili sia con uomo che con cospecifi ci, le forme di aggres-sività e competitività avrebbero potuto minare l’attività venatoria.Le abilità istintive non sono molto sviluppatea vantaggio della versatilità nell’apprendimento di compiti nuovi attraverso l’addestramento.i cocker, analoghi per comportamento differiscono nell’impiego della caccia, anzichè pren-dere e portare la selvaggina morta, venivano usati per stanarla, formando dei cerchi intorno a una zona, non abbaiano ne “puntano” ma usano molto la coda per segnalare la distanza della preda.
12 13
In questi ultimi anni sono aumentati gli animali considerati domestici: conigli, fu-retti, maialini domestici, caprette tibetane, numerosi roditori, iguane, ecc.…. e si sono affi ancati ai più tradizionali cani, gatti, uccelli e pesci; ma nonostante tutto il cane, nell’immaginario collettivo, rimane il miglior amico dell’uomo. Spesso però quando si decide di arricchire la propria vita con la compagnia di un animale viene subito in mente un cane, ma è sempre la scelta giusta?Probabilmente le persone che decidono di prendere un cane lo fa solo per il piacere di avere accanto un compagno straordinario, per avere qualcuno sempre vicino, per avere una scusa per fare due passi, per avere occasione di scambiare due chiacchere al parco con chi condivide la stessa esperienza, in una parola per compagnia.Se si ha tanto tempo a disposizione e lo si vuole dedicare al proprio pet, se si ama passeggiare, stare in compagnia, all’aria aperta il cane dà sicuramente più spunti per assecondare queste inclinazioni. Se si ha poco tempo invece, se si è spesso fuori casa e non si ha la possibilità di portarsi con se il proprio cane, o semplicemente non al-letta l’idea di uscire fuori in pieno inverno, ma preferite oziare davanti ad un camino acceso, forse l’animale che fa per voi è il gatto. Da quando è iniziata la convivenza tra uomo e cane, entrambi ne hanno tratto un re-ciproco vantaggio ed abbiamo così iniziato a selezionare cani che meglio potevano aiutarci nelle nostre attività: caccia, pesca, guardia della proprietà e difesa personale, trasporto, conduzione e difesa dei greggi.La maggior parte dei cani sono stati selezionati per svolgere uno specifi co compito, quindi non dovremo mai scordarci che questi cani sono comunque cani da lavoro che sono cani che hanno bisogno di lavorare, soprattutto mentalmente; ovviamente tra le diverse razze da lavoro ci sono notevoli differenze e le esigenze dei cani cambiano
la sce
lta
di un c
ane
di Pierangelo Alpoggio
14 15
Maschio: ha maggior imponenza, ed alcuni cani, specialmente di razza, hanno un carattere ed una tempra più forte della femmina e per questo più portato ad una scalata gerarchica, se non ben controllata da un proprieta-
rio fermo, coerente e con una certa esperienza.I maschi, inoltre, non vanno quasi mai d’accordo con i coospecifi ci e va’ anche ricordato che è in attività sessuale perenne.
Femmina: sono tendenzialmente più docili, ubbidienti, addestrabili e più facil-mente gestibili con i coospecifi ci anche dello stesso sesso, per contro c’è il proble-ma del ciclo riproduttivo (calore), inoltre esiste la possibilità che nei periodi che circoscrive il calore, può cambiare radicalmente personalità e diventare irritabile e aggressiva.
Taglia: la scelta della taglia è personale, ma dovrebbe essere valutata in parte dalle condizioni ambientali dove dovrà vivere il cane ed in parte da chi dovrà adot-tarlo; se la persona che lo adotta è un’esile signora di mezza età, diffi cilmente potrà gestire un cane di grossa taglia.Qualunque cane, di qualsiasi taglia, se lasciato socializzare correttamente nel pe-riodo giovanile è in grado d’imparare a gestire le interazioni con i coospecifi ci, la tendenza di relazionarsi in maniera competitiva con gli altri cani, è sicuramente diversa nelle varie razze, ma non in correlazione con la taglia. I cani sotto i 3 kg sono piuttosto delicati e richiedono particolari attenzioni e cure.
Mantello: costituito da due tipo di pelo: il pelo di copertura, il più superfi ciale, e il sottopelo.Esso può essere mono o pluricolori, inoltre dalla lunghezza identifi chiamo i cani a pelle nuda, a pelo raso, a pelo corto, a pelo semilungo o pelo lungo. Come è facile immaginare, il cane con il pelo lungo richiede più cure e quindi dobbiamo mettere in conto accurate spazzolature quotidiane, inoltre se il cane vive fuori, il suo pelo raccoglierà foglie, terra, fango e sarà perennemente sporco. Quindi per la scelta del tipo di mantello, pelo lungo o pelle nuda, bisognerà tener conto dove il cane andrà a vivere e al clima della zona dove abiterà.
Muso: ricordiamoci che se scegliamo un cane con il muso schiacciato(Brachicefalo), dovremo fare i conti con possibili problemi di salute, inoltre la canna nasale cor-ta non permette un buon raffreddamento/riscaldamento dell’aria inspirata per cui l’apparalo respiratorio di questi cani e particolarmente delicato e la respirazione molto meno effi ciente.Questo disagio si fa sentire quando il cane è sotto sforzo o quando le temperature sono alte.
moltissimo, quindi dovremo valutarle attentamente prima di scegliere o potremmo avere dei problemi di convivenza. Se si vuole lavorare con il proprio cane, è ovviamente a questi soggetti a cui dobbiamo rivol-gere la nostra attenzione; per lavoro intendo principalmente l’attività sportiva, agonistica e non, perché di lavoro vero è proprio è ormai piuttosto raro, infatti rimangono solo alcuni cani da caccia usati per la loro originaria funzione, pochissimi cani pastore e altre eccezioni.La scelta in ogni caso, deve tener presente le esigenze dell’animale scelto, e i fattori da con-siderare sono molteplici. Vediamo quindi di affrontarli per cercare di evitare che si presentino problemi di convivenza reciproca dovuti a differenza di carattere e abitudini di vita; ricordate-vi che state scegliendo quello che sarà il vostro compagno per i prossimi 10 – 15 anni di vita.Economico: da non sottovalutare microchip, alimentazione, visite veterinarie e vaccinazioni obbligatorie, test della fi laria e, per la leishmaniosi e profi lassi tutti gli anni, poi quelle extra: esami delle feci, sverminazione, sterilizzazione, antibiotici e se necessario interventi vari.Inoltre è consigliabile stipulare un’assicurazione per coprire i vari danni che il vostro cane può fare, se il cane è di razza, c’è la spesa iniziale da affrontare.Tempo: è sicuramente determinante per stabilire se il cane è davvero l’animale giusto per noi; ricordiamoci che il cane è un animale sociale e come tale ha bisogno di compagnia, lasciarlo molte ore solo a casa, signifi ca renderlo infelice e frustato creando in lui problemi di ansia che possono degenerare in comportamenti patologici.Importante è capire che il tempo trascorso con il vostro cane va’ valutato anche qualitati-vamente e non solo quantitativamente, è necessario che dedichiate qualche ora della vostra giornata per passeggiare, giocare e lavorare con lui, cioè dovete impegnarlo sia fi sicamente che mentalmente perché abbia le giuste valvole di sfogo.Coerenza ed educazione: importante è che tutti i membri della famiglia siano d’accordo nel volere vivere con un cane, un cane deve essere educato e questo richiede tempo, impegno e coerenza da parte di tutti i componenti della famiglia.Quando accogliete un cane all’interno della vostra famiglia, iniziate una relazione con un essere vivente di un’altra specie, non è sempre una situazione facile, poiché i cani hanno una percezione del mondo diversa dalla nostra, ma per altri aspetti ci assomigliano molto.
Cucciolo: tutti siamo attratti dai cuccioli, ma non sempre, per chi non ha esperienza con i cani, il cucciolo è una scelta giusta; sono i proprietari a plasmare il carattere del cucciolo, a decidere come sarà da adulto; nei primi mesi, tuttavia, la sua educazione richiederà notevole tempo ed energia, infatti distrugge, fa i bisogni in casa, mordicchia, ecc.…Bisogna ricordarsi che non si può allontanare il cucciolo dalla madre prima della nona setti-mana di vita, altrimenti avremo cani con alterazioni comportamentali (diffi coltà di relazioni sociali, problemi di iperattività, scarso controllo emozionale).
Adulto: se invece si opta per un esemplare adulto, è possibile che sia già adeguatamente educato, ed inoltre potete conoscere il suo carattere defi nitivo; ma può capitare che il suo comportamento sia segnato da episodi negativi o dalla mancanza di esperienze
16 17
suna garanzia sulle condizioni di salute ed inoltre questi cuccioli vengo-no allontanati dalla madre appena sono in grado di nutrirsi da soli; non hanno ricevuti gli insegnamenti materni e non sono stati sottoposti agli
stimoli necessari per essere individui equilibrati.
Canile: si possono trovare e adottare cani adulti, cuccioli di razza o meticci, op-pure cercarlo nelle associazioni per i cani di assistenza che non hanno superato i test attitudinali.
Potremmo continuare ancora, ma credo che questi spunti siano suffi cienti per far rifl ettere i futuri proprietari di cani sull’importanza di una scelta attenta prima dell’adozione di un cane.Informarsi presso i veterinari, allevatori, educatori e istruttori cinofi li è un ottimo modo per essere indirizzati verso la scelta migliore, preludio di una felice convi-venza ed anche un ottimo modo per abbattere il triste fenomeno dell’abbandono.Concludo ponendo l’attenzione sull’importanza di rivolgersi ad un educatore per impostare con il proprio cane un percorso educativo in relazione all’età del cane che può essere la puppy class per i cuccioli fi no a 5 mesi con l’obbiettivo di favori-re la socializzazione dei cani, l’affi atamento con il proprietario e la prevenzione di alcune patologie comportamentali, ed un corso di educazione di base per i cani ol-tre i 5 mesi con l’obbiettivo di insegnare la gestione del cane nella società umana.
Orecchie: se le orecchie sono molto lunghe e cascanti sono mediamente soggetti con mag-giore frequenza alle otiti, rispetto a cani con orecchie corte ed erette e quindi necessitano di cure e pulizie più frequenti.
Zampe: le zampe cortissime dei bassotti e dei bassethound non costituiscono di per se un problema, ma sollecitano più del normale la schiena che a lungo andare può risentirne, per questi cani è proibito ingrassare e le scale sono da evitare il più possibile per non provocare ulteriori sovraccarichi alla loro già provata colonna vertebrale.
Razza, oggi la F.C.I. organo mondiale che coordina tutti gli enti cinofi li, riconosce più di 400 razze, a cui bisogna aggiungere milioni di meticci. Abbiamo di fronte a noi una scelta enor-me di tipi di cane, eppure le razze realmente diffuse sono poche. La scelta di un cane, che ricordiamo è una scelta impegnativa, non può e non deve fermarsi a ciò che vediamo e non conosciamo, e quindi è bene non dimenticare le fi nalità per cui era originariamente utilizzato, in caso contrario si corre il rischio di venire meno ai desideri del proprietario e alle esigenze del cane.
Una volta stabilito che cane vogliamo dobbiamo decidere dove andare a prenderlo e le possi-bilità che abbiamo sono molte e varie.
Allevamento: soprattutto se vogliamo un cane di razza dovremo fare molta attenzione a chi ci rivolgiamo, essendo animali costosi, perché selezionati si potrebbe rischiare di spendere parecchi soldi per un cane che quei soldi non li vale affatto perché alle sue spalle non ha un costoso lavoro di selezione che solo gli allevatori seri fanno. L’allevatore è un cinofi lo che seleziona una razza, cioè effettua degli accoppiamenti tali che gli permettono di ottenere dei cani sani, caratterialmente e morfologicamente sempre più vicini allo standard di razza. Un allevatore conosce perfettamente la razza che alleva, deve conoscere le linee di sangue, deve portare i propri cani alle esposizioni per avere una valutazione morfologica, deve eseguire delle prove di lavoro per aver una valutazione comportamentale del soggetto, deve fare i controlli sanitari del caso per escludere patologie ereditarie. Fare l’allevatore richiede note-vole impegno sia in termini di tempo che economico, quindi sarebbe meglio evitare quegli allevatori che offrono troppe razze diverse, proprio perché allevare seriamente richiede molto tempo. Diffi date di chi alleva più di 2 o 3 razze.
Privati: questi possono rappresentare un’alternativa economica agli allevamenti, il pro-blema è che molte volte questi proprietari non sanno nulla di genetica, di selezione, linee di sangue, patologie ereditarie e quindi non si curano di fare gli opportuni accertamenti, inoltre non hanno le competenze di un allevatore professionista, e quindi si potrebbero avere dei problemi comportamentali.
Negozio: si possono anche acquistare nei negozi di animali, ma noi lo sconsigliamo perché attraverso importazioni dall’estero, costituiscono veri e propri magazzini, non forniscono nes-
19
La Puppy Class è un programma di sviluppo esperienziale del cucciolo che ha come obiettivi principali :1. Avere una cane ben socializzato con gli altri cani, con altri animali, con ambien-ti, con rumori e odori diversi. Ottima palestra per prevenire problemi di comporta-mento!2. Cosa e come stimolare le capacità cognitive del cane 3. Formare e informare i proprietari sui bisogni del cucciolo e sul modo corretto di comunicare con lui4. Prevenire futuri problemi comportamentali.
La Puppy class è la base dell’educazione, non educazione di base!
Sono ammessi ad una Puppy Class i cuccioli che vanno dai 2 ai 5 mesi di età (de-vono aver effettuato almeno la prima vaccinazione) di razze e taglie anche diverse tra loro. Il campo dove si svolgerà la lezione sarà arricchito con strumenti ed ac-corgimenti ad hoc ed inoltre molto importante sarà la presenza di un cane adulto ed equilibrato.
PUNTI CHIAVE:
• Instaurare una comunicazione corretta agevola la relazione• Il rispetto dell’ altro come individuo permette di creare fi ducia• La fi ducia è la base per una relazione sana• Una corretta socializzazione permette di prevenire un gran numero di problemi di comportamento agevolando una crescita e relazione sana
la pup
py cla
ss
di Sabrina Aguiari
20 21
In un percorso di Puppy Class si potrà quindi iniziare con il piede giu-sto perché il proprietario verrà indirizzato dall’educatore cinofi lo circa il modo più corretto di comunicare con il suo compagno a quattro zampe!
Ricordare che non tutti i cani amano il contatto fi sico, ricordare che i cani comu-nicano attraverso le posture del corpo per cui molta importanza dovrà essere data alle posture che il proprietario emette nella comunicazione con il pet.
BUONA SOCIALIZZAZIONE E CORRETTA MANIPOLAZIONEMolta attenzione verrà data nell’abituare il cucciolo ad essere manipolato quoti-dianamente dal proprietario partendo dalla testa e arrivando alla coda, abituarlo ad essere spazzolato e pettinato, abituarlo alla museruola (come gioco) e abituarlo ad essere contenuto.
IL GIOCOGiocare è un’attività fonda-mentale per i mammiferi. At-traverso il gioco il cucciolo può interagire con i diversi oggetti del mondo oppure pro-porre ad un compagno uno scambio relazionale. Il gioco è fortemente connesso all’ap-prendimento : si gioco per im-parare e si impara giocando. Nel cucciolo il gioco sociale inizia tra i 20 e i 25 giorni di vita.
Attraverso il gioco si possono apprendere:• Abilità motorie• Abilità socio relazionali• Abilità cognitiveLo stato emotivo che merge durante il gioco crea fi ducia e agevola la relazione so-ciale e crea intimità: durante il gioco si apprendono comportamenti sociali corretti. Quali tipi di giochi esistono? Il gioco con oggetti, individuale, sociale e cinestesi-co. Non esistono giochi pericolosi in sé ma:• Modi di condurli errati e diseducativi• Attività in grado di enfatizzare certe disposizioni di razza• Eccessi e maniacalità nell’ ossessiva ripetitività di un singolo gioco.
PROGRAMMA DELLA PUPPY:• Educare alla calma• Corretta comunicazione cane-proprietario• Buona socializzazione e corretta manipolazione da parte del proprietario• Imparare a giocare con il cucciolo• Percorsi di propriocezione• Gestione delle iniziative e delle risorse• Pettorina e guinzaglio• Gestione in libertà e… richiamo!• “Problemi” del cucciolo: eliminazioni inappropriate, saltare addosso, saper stare da solo, masticazione,…
LA CALMAIl cucciolo deve imparare ad essere un cane calmo e non troppo agitato! Possiamo sce-gliere una copertina su cui il nostro cuccio-lo si potrà coricare quando resterà al nostro fi anco calmo e tranquillo. Rinforzando il cucciolo tutte le volte in cui in uno stato di calma si accomoda sulla sua copertina lo aiutiamo a capire che quello è un compor-tamento corretto e che lo stato emozionale corretto sarà essere calmo e tranquillo al no-stro fi anco.
CORRETTA COMUNICAZIONE CANE-PROPRIETARIOMolto spesso il proprietario si pone in maniera errata nei confronti del cane che equivoca le richieste che gli vengono fatte. Una buona comunicazione è la base su cui instaurare una buona relazione!! La relazione è la base della vita con il nostro cane.
22 23
REGOLE GENERALI DA NON DIMENTICARE MAI:
Un buon compagno per il cucciolo è colui che agisce in maniera:- COERENTE- COSTANTE- FAVORISCE LE ESPERIENZE DEL CUCCIOLO, SOSTENENDOLO SENZA ESPORLO A RISCHI!
GESTIONE DELLE INIZIATIVE E DELLE RISORSEPer il cane risorse quali l’alimentazione, il territorio, il gioco sono estremamente importanti e noi dobbiamo esser in grado di valorizzarle e gestirle al meglio. Il rito alimentarie con la cor-retta gestualità della ciotola pone il nostro cucciolo davanti al primo problema da risolvere per ottenere il cibo. Molta importanza ha anche il giusto posizionamento del luogo di riposo del pet, che serve anche per dargli il giusto equilibrio sono-veglia. L’uscita dalla porta ordinata prima del proprietario e poi del cane ma senza dare segnali, aspettando che ragioni e capisca che deve guardarci per avere il permesso.
PROBLEMI” COMUNI DEL CUCCIOLO:
ELIMINAZIONI INAPPROPRIATE: il cucciolo non è in grado di mantenere il controllo del-la vescica, per cui: sporcare nei luoghi inappropriati non è una colpa per lui! Per questo mo-tivo è di essenziale importanza NON PUNIRE il cucciolo se sporca in un luogo indesiderato. Il proprietario deve semplicemente portare fuori il cucciolo per sporcare dopo che il pet ha:• Mangiato• Dormito• Giocato• Girato un paio di volte su se stesso.
SALTARE ADDOSSO: Per il cane saltare addosso è auto gratifi cante perché ottiene le nostre attenzioni! Per far cessare questo comportamento ignorare il cane ed eliminare la comunica-zione verbale e voltarsi di spalle tenendo le braccia lungo i fi anchi. Si riprenderà la comu-nicazione con il cucciolo solo se calmo: in questo modo gli insegniamo un comportamento alternativo che verrà rinforzato con lodi, cibo o gioco.
STARE DA SOLO: Nei primi giorni di adozione del cucciolo (che avrà 60 giorni) sarà molto importante completare il passaggio dall’ attaccamento al distacco. Attraverso questo graduale processo si costruiranno le basi per l’equilibrio del cucciolo. Nei primi giorni dopo l’adozione è importante non lasciare mai da solo il cucciolo, essere per lui un punto di riferimento, favo-rire e incentivare le sue esplorazioni, evitare di suscitare paure o ansie. Un buon processo di attaccamento favorisce il naturale distacco: per questo possiamo successivamente iniziare a lasciare da solo il cane a casa per brevi periodi andando poi ad allungare sempre di più i tempi.
MORDERE E DISTRUGGERE: il cucciolo attraversa la fase esplorativa in cui conoscerà il mondo attraverso la bocca. La distruttività e il mordicchiare sono pertanto normali. Importan-te però orientare il cucciolo su giocattoli per cani e ossetti.
24 25
La comunicazione è la trasmissione di informazioni da un emittente ad un desti-natario per mezzo di messaggi. La parola “comunicazione” deriva dal verbo latino “commūnĭco”, che signifi ca “mettere in comune, accomunare, far partecipe, condividere (qualcosa)”: per quan-to riguarda il linguaggio, ciò che si condivide è un messaggio e, i soggetti attivi in tale condivisione sono l’emittente e il ricevente. Al fi ne di condividere effi cace-mente un messaggio è d’altra parte indispensabile che gli interlocutori utilizzino gli stessi moduli comunicativi, o per semplifi care la medesima lingua. All’interno della stessa specie, in condizioni normali, la comprensione dei mes-saggi comunicativi non rappresenta un problema in quanto emittente e destinatario possiedono la medesima architettura fi siologica e cognitiva. Il tutto si complica nel momento in cui la comunicazione/comprensione diventa intraspecifi ca.L’essenza del rapporto tra l’uomo e il cane è insita nella comunicazione, ma, seb-bene queste due specie si siano coevolute nell’arco di migliaia di anni, oggi la maggior parte dei proprietari non possiede più una propensione all’osservazione e all’interpretazione dei segnali e dei comportamenti del suo compagno a quattro zampe.
La comunicazione avviene attraverso quattro canali• Uditivo, che si distingue in linguistico (le parole e il loro signifi cato) e paralin-guistico (il tono, il ritmo e la frequenza, ovvero l’insieme dei suoni emessi indipen-dentemente dal signifi cato delle parole).• Visivo, che si può differenziare in sistema cinestesico (tutti gli atti comunicativi espressi dal movimento del corpo), prossemica (tutti gli atti comunicativi che ri-
la com
unicaz
ione
del ca
ne
di Riccardo Garavaglia
26 27
cercano il contatto tra di loro e con la madre.Tutti questi contatti sono indispensabili per il corretto sviluppo psicofi si-co dei cuccioli.
La comunicazione tattile tra i conspecifi ci ha anche un’importanza sociale e si possono distinguere:• contatti rassicuranti, come per esempio appoggiarsi, strusciarsi, colpetti muso contro muso oppure muso contro avambracci;ù• contatti di dominanza, come porre il muso o la zampa sulle scapole del conspeci-fi co, la T position, la monta;• contatti di sottomissione, come leccare la bocca, strusciarsi contro il fi anco del conspecifi co con orecchie basse e posteriore basso;• contatti di gioco, come i colpi d’anca oppure mordersi;• contatti a scopo sessuale con naso e lingua nell’area genitale.
La comunicazione tattile è molto utilizzata anche dall’uomo verso il cane, ed ogni manipolazione ha un suo specifi co e preciso signifi cato, e va sempre attuata con la massima cautela: carezze lente effettuate a mano aperta nel verso del pelo trasmet-tono calma e rilassamento, viceversa pacche energiche che scompigliano il pelo provocano eccitamento e maggiore attivazione.E’ molto importante sapersi relazionare con cani sconosciuti, a tale proposito si ri-corda di non accarezzarli mai avvicinando la mano sopra la testa, ma è importante prima farsi annusare la mano e, solo se il cane si mostra disponibile, accarezzarlo sotto il muso. Un atteggiamento errato potrebbe provocare reazioni negative di paura e/o di aggressività.Per quanto riguarda l’abbraccio molti cani hanno imparato che questa nostra mo-dalità di relazione è in realtà un segnale di affetto, benché per loro abbia un signi-fi cato di sfi da e dominanza: in generale sarebbe sempre meglio evitarlo con cani sconosciuti e soprattutto insegnare ai bambini a non farlo mai.
olfatto e paraolfattoL’olfatto è il senso più sviluppato ed è quello che permette di percepire le sostanze chimiche volatili e trasformarle, dopo l’elaborazione cerebrale, in odori.La mucosa olfattiva, che riveste le cavità interne del naso, è una superfi cie ricca di recettori olfattivi (circa 220 milioni; nell’uomo solo 5 milioni) specifi ci per la percezione delle sostanze volatili. La mucosa è ripiegata su sé stessa, come se fosse un tappeto ripiegato in tante pliche, in modo da ottenere un’ottimizzazione dello spazio, tanto è vero che se potessimo distenderla, occuperebbe una superfi cie compresa tra i 18 e i 150 cmq a seconda della razza. La grande capacità discriminativa è dovuta quindi ad un maggiore sviluppo della mucosa olfattiva, ma anche, e soprattutto dall’ampiezza e dalla maggiore comples-sità dell’area deputata all’analisi delle informazioni olfattive. Tuttavia un cane per
guardano il modo in cui ci si sposta nello spazio), aptica (tutti gli atti comunicativi espressi mediante il contatto tra i corpi).• Olfattivo, ovvero la percezione delle sostanze chimiche volatili.• Tattile, ovvero il contatto dei corpi.
Ogni specie è caratterizzata da un diverso sviluppo dei sensi ed è sensibile esclusivamente ad alcuni stimoli in relazione alla particolare nicchia ecologica occupata e, ciò ha evidentemente determinato anche una specializzazione dei segnali comunicativi. Le capacità sensoriali del cane fanno si che questi si trovi immerso nell’ambiente in modo completamente differente da quanto accade all’uomo, e tale aspetto rappresenta probabilmente il punto di partenza delle incomprensioni tra le due specie.Prima di analizzare la fi nestra sensoriale del cane è utile analizzare brevemente la comunica-zione.La comunicazione viaggia su tre livelli: il contenuto esplicito, il verbale (le parole), e il sup-porto su cui la comunicazione appoggia, il paraverbale (il tono, il volume e il timbro della voce) ed il non verbale, ovvero il linguaggio del corpo e le posture.Il cane non capisce il signifi cato delle parole, ma ascolta attentamente i toni, i volumi, i tim-bri della voce cercando di intuire le intenzioni dei compagni umani. Se proviamo a fare un complimento al nostro cane con tono minaccioso, lui reagirà sottraendosi, piegando la testa di lato ed abbassando la testa e la coda, al contrario il peggior insulto detto in modo gioioso ed amichevole lo farà reagire con manifestazioni di gioia e felicità. Il cane, pertanto, è un acuto ed eccellente decodifi catore del linguaggio non verbale, la sua capacità di leggere anche i minimi segni, unita ad un senso dell’olfatto molto sviluppato, lo porta a rilevare tutti i segnali chimici connessi con gli stati d’animo umani.La mancanza di comprensione crea un circolo vizioso, in cui da un lato il proprietario va incontro a cadute motivazionali che minano la relazione, e dall’altro il cane va incontro a fenomeni di stress e di frustrazione.Passiamo ora in rassegna i cinque sensi del cane per capire quali sono i più importanti.
Il tattoNel cane il tatto è “dislocato in tutto il corpo” e permette di percepire gli stimoli meccanici derivanti dal contatto con il mondo esterno e di trasformali, dopo l’elaborazione cerebrale, in sensazioni pressorie, dolorifi che o termiche.I recettori deputati alla percezione tattile sono distribuiti lungo tutto il corpo alla base di al-cuni peli, particolarmente concentrati a livello dei ciuffi sopracciliari, dei ciuffi guanciali, dei ciuffi labiali e delle vibrisse.Il contatto fi sico è di fondamentale importanza ed inizia già nei primi giorni di vita. I cuccioli ricevono innumerevoli stimolazioni tattili durante la fase neonatale: infatti immediatamente dopo il parto la madre li lecca per liberarli e pulirli dai residui del sacco amniotico, per stimo-lare il loro primo respiro concentrandosi nella zona ombelico-genitale, e, nelle settimane suc-cessive per stimolare l’eliminazione delle feci e delle urine data la loro immaturità sensoriale. Inoltre i cuccioli, dato che non sono in grado di mantenere costante la temperatura corporea,
28 29
gustoIl gusto non è un senso particolarmente sviluppato nel cane, il nostro lo
è assai di più: basti pensare che il cane possiede all’incirca 1.700 papille gustative contro le 9.000 dell’essere umano. L’appetibilità di un cibo o di altro è determinato dall’odore dello stesso, e non dal suo sapore, ovvero il cane mangia un alimento soltanto se questo risulta per così dire “gustoso” al suo olfatto.In molti avremo notato che nella bocca del cane, il cibo rimane per un brevissimo tempo, talvolta sembra che passi solo un attimo prima di essere ingurgitato. Il mo-tivo è appunto che la presenza di un numero inferiore di papille gustative limita la “raffi natezza” del palato e, quindi, la sua capacità di gustare gli alimenti.Il cane distingue i cinque gusti fondamentali, cioè dolce, salato, amaro, aspro e umani (parola giapponese che signifi ca “saporito”, dovuto al glutammato di sodio presente in alcuni cibi). In genere il cane non ama i sapori acidi o aspri, ma prefe-risce quelli dolci e quelli salati.
uditoIl cane riesce a percepire suoni e rumori con frequenze che si avvicinano agli ultra-suoni fi no a 40.000 Hz (l’uomo fi no a 20.000 Hz) e che provengono da maggiori distanze. I padiglioni auricolari completamente mobili permettono l’individuazio-ne veloce ed accurata della provenienza del suono, discriminandone l’origine gra-zie alla massa della testa tra le due orecchie e quindi alla differente percezione tra un orecchio e l’altro.Sebbene la comunicazione acustica abbia il vantaggio di poter essere modulata nel momento preciso dell’emissione, cosa che non accade con la comunicazione olfattiva, risulta comunque svantaggiosa in quanto può essere facilmente percepita dalle prede, ed infatti i lupi, con eccezione dell’ululato, sono poco vocalizzatori. Invece l’emissione di suoni, come l’abbaio, l’ululato, il guaito, l’uggiolio e il rin-ghio è particolarmente utilizzata nel cane domestico, ciò è probabilmente dovuto al fatto che siamo proprio noi, i loro conviventi umani, che contribuiamo a far sviluppare questo canale comunicativo rispetto ad altri perché a noi maggiormente congeniale.Il cane può emettere una varietà assortita di vocalizzi, ognuno con sfaccettature e signifi cati diversi, che si distinguono in base alla tonalità, alla durata e alla frequen-za. Generalmente vocalizzi emessi a bassa intonazione indicano minaccia, rabbia o sicurezza, viceversa più la tonalità si alza e più tale parametro indica insicurezza; vocalizza brevi sono invece associati a paura, dolore o necessità intensa. E’ impor-tante ricordare che più il suono è lungo e più è probabile che il cane stia prenden-do una decisione consapevole sulla natura del segnale e sul comportamento che ne seguirà. Suoni che si ripetono spesso a ritmo incalzante indicano un grado di eccitamento o di bisogno pressante, al contrario suoni distanziati e non ripetitivi denotano un basso livello di eccitazione o una disposizione d’animo transitoria.
avere un ottimo fi uto deve vivere numerose esperienze olfattive per aumentare il numero dei neuroni e delle sinapsi che lavorano sull’elaborazione olfattiva e per sviluppare comunque maggiore attenzione alla ricerca di questi stimoli.Per comprendere questa capacità discriminativa basti pensare che durante il 19° Congresso Nazionale dell’Associazione Urologia Italiana, svoltosi a Genova nel settembre 2012 (www.auro.it) , è stato annunciato l’inizio di uno studio che verrà condotto da Gianluigi Taverna dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano in collaborazione con Lorenzo Tidu, tenente co-lonnello del Centro militare veterinario dell’Esercito, i cui protagonisti saranno dei pastori te-deschi, che, dopo un’educazione basata sul rinforzo positivo, saranno in grado di individuare soggetti con tumore prostatico semplicemente annusando dei campioni urinari. I dati raccolti fi no ad oggi evidenziano una sensibilità diagnostica otto volte superiore a quella delle proce-dure cliniche attualmente utilizzate!Il cane vive essenzialmente in un mondo di odori, ma non solo, un odore che nell’uomo può occasionalmente riportare alla mente un ricordo, nel cane diventa un segno indelebile e recu-perabile in qualsiasi momento dalla sua memoria a lungo termine.Quando due cani si incontrano si annusano nella zona genitale, anale e del padiglione aurico-lare, raccogliendo informazioni importanti l’uno sull’altro: è sostanzialmente un sistema di riconoscimento e di individualizzazione per capire che soggetto ci si trova di fronte.La comunicazione olfattiva si realizza anche attraverso l’urina, le feci e la raspatura del terre-no grazie alle ghiandole interdigitali, mediante le quali il cane lascia informazioni riguardanti il sesso, l’età e l’eventuale presenza del calore nella femmina.
Il paraolfatto permette di percepire i feromoni, particolari sostanze non percepibili dall’uomo che hanno la caratteristica di innescare una reazione immediata.L’organo deputato alla percezione feromonale è l’organo vomero nasale o organo di Jacob-son, posizionato sopra il palato tra il naso e la bocca. Si tratta di una via di mezzo tra gusto ed olfatto, e rappresenta un tipo di percezione molto intrinseca e primitiva, nel senso che non viene elaborata dalla corteccia cerebrale, ma queste sostanze, una volta percepite, innescano una reazione immediata.Il meccanismo di azione dei feromoni non risulta ancora chiaro, ma inducono modifi cazioni comportamentali quali appagamento, rilassamento, allarme o comportamenti sessuali.Le ghiandole secernenti i feromoni sono: le anali, perianali e circumanali, il cui secreto può essere modifi cato da un processo infi ammatorio ed innescare un’aggressione da parte dei conspecifi ci; le sebacee del solco intermammario; le periorali; le ceruminose del padiglione auricolare; le podali e le interdigitali.I feromoni possono essere di diversi tipi:• di identifi cazione, implicati durante gli scambi sociali;• di allarme;• di appagamento, come quelli secreti a livello del solco intermammario in grado di favorire l’attaccamento primario del cucciolo;• di adozione, in grado di indurre la madre del neonato a mettere in atto le cure parentali;• di delimitazione territoriale.
30 31
rezza, minaccia o sfi da, al contrario un avvicinamento che descriva una traiettoria semicircolare che porti il soggetto a fi anco dell’altro, comuni-ca intenzioni pacifi che.
Le postureLe orecchie, la coda, i peli, lo sguardo e la posizione del corpo ci possono dire mol-to su quello che un cane comunica. Questo insieme di caratteri concorre a defi nire la postura del cane.Vediamo ora le posture più importanti:
Postura neutra o rilassata: bocca rilassata e semiaperta con lingua semiesposta, orecchie sollevate, pupille piccole, coda bassa e rilas-sata.
Postura di attenzione: bocca chiusa, denti e lingua non visibili, testa ed orecchie in avan-ti, pupille dilatate, coda orizzontale non rigi-da parallela al terreno.
Postura dominante, ovvero quella assunta da un cane che vuole comunicare la sua sicurez-za verso un altro soggetto. Orecchie dritte in avanti, coda tenuta in vista, ben in alto ad an-golo retto rispetto al corpo, corpo rigido.
Postura sottomessa: orecchie rivolte all’in-dietro, coda tra le gambe, sguardo sfuggente, posteriore basso.
La vistaIl cane, non avendo il dono della parola, utilizza soprattutto il proprio corpo, ovvero le postu-re, le mimiche facciali, il movimento di coda e orecchie e lo sguardo, per comunicare con i suoi simili e con gli esseri umani.La vista del cane risulta più effi ciente al buio, di giorno è meno precisa rispetto a quella uma-na, ma il cane è in grado di vedere molto bene piccoli soggetti in movimento da una grande distanza, capacità che deriva dal loro istinto predatorio. Ha un campo visivo molto più ampio di quello umano, ma la sua vista è caratterizzata da una pessima visione binoculare che non gli permette di vedere molto bene gli oggetti vicini e fermi.Secondo alcuni studi, la percezione dei colori è diacromatica: sensibili al blu e al giallo, gli altri colori probabilmente risultano delle sfumature di questi e quindi sono poco sensibili al rosso e al verde. Spesso i giochi per cani in vendita hanno colori accattivanti più per gli esseri umani che per i cani, cerchiamo di ricordare questa differenza e quando scegliamo un gioco per il nostro amico a quattro zampe prediligiamolo di colore blu o giallo piuttosto che rosso.
Il linguaggio del corpoIl linguaggio del corpo avviene mediante• la prossemica, ovvero la disposizione del proprio corpo rispetto all’interlocutore (vicino, lontano, di fi anco, di dietro);• la cinetica, ovvero il movimento complessivo del corpo rispetto all’interlocutore (velocità, traiettoria, coreografi a);• l’orripilazione di alcune parti del mantello (piloerezione);• le posture, ovvero l’esposizione complessiva rispetto all’interlocutore (impettito, raccolto, sdraiato, seduto, pancia all’aria) ed il movimento delle parti articolate del corpo (coda, orec-chia, fronte, occhi).
La prossemicaIl cane comunica posizionandosi in modo diverso rispetto all’altro e la diversa prossemica assume differenti signifi cati: utilizza la posizione frontale per rivolgersi a noi in modo diretto, per avanzare richieste e fronteggiarci; si pone posteriormente a noi quando si sente minaccia-to e chiede protezione; la posizione laterale indica alleanza e collaborazione.La prossemica individua anche lo spazio interposto tra gli individui e si possono pertanto evidenziare: una zona intima a cui hanno accesso solo i componenti della famiglia, una zona personale a cui possono accedere i famigliari meno stretti e gli amici, ed una zona sociale per gli individui poco conosciuti o sconosciuti. Non dobbiamo mai dimenticare che il cane è mol-to sensibile allo spazio di interposizione, un approccio diretto o una vicinanza troppo stretta può renderlo irritabile ed aumentare le sue paure e la sua aggressività.
La cineticaIl cane porta molta attenzione alla cinetica, alla velocità, alla traiettoria e alla coreografi a uti-lizzata dall’altro. Un avvicinamento diretto seguendo una linea diritta può comunicare sicu-
32 33
sono chiaramente minacciosi, ma, poiché scodinzolano, i proprietari in-terpretano questo comportamento come amichevole. Non è così, un cane che scodinzola dimostra la sua intenzione di interazione e la sua agitazio-
ne, che può essere positiva o negativa.E’ importante saper leggere le posture e le mimiche globalmente, ma anche saperle contestualizzarle alla situazione in atto.
Bibliografi a• Articoli de “Corso formativo per i proprietari di cani: il patentino” – Ministero della Salute, 2009• Capire il linguaggio dei cani – Stanley Coren• Dispense “Corso di Formazione per Educatori Cinofi li” – Scuola Cinofi la Il mio cane• Il linguaggio del cane – Roger Abrantes, Editoriale Olimpia 2008• Inchiesta “Che senso ha?” di Federica Forte, pubblicato sulla rivista Quattrozampe n.62, no-vembre 2012• La comunicazione del cane – Alexa Capra, Daniele Robotti, Edagricole 2007
Sitografi ahttp://www.ilmiocane.net/articoli-cinofi li.htmhttp://www.canedifamiglia.it/http://www.educazionedelcane.net/linguaggio.asphttp://digilander.libero.it/Comtech/pdf/La%20comunicazione.pdf
Invito al gioco: postura tipica in cui il cane si pone con il posteriore in alto e le zampe anteriori in basso; spesso saltella da una parte all’altra e può anche abbaiare.
Postura della paura: coda portata sotto il corpo, orecchie tirate indietro e schiacciate sulla testa, corpo basso ed arretrato, espressione facciale tipo lifting, midriasi, tal-volta eliminazione di urina e spremitura dei sacchi anali.
Aggressività da sicurezza: labbra arricciate per esibire denti e gengive superiori con visibili pieghe nella zona sopra il naso, bocca aperta a forma di C; occhi spalanca-ti e sguardo intenso rivolto all’interlocutore; coda alta, dritta e rigida, leggermente incurvata sul dorso; corpo proteso in avanti; zampe unite; pelo alzato sul dorso e sulle spalle (piloerezione).
Aggressività da paura: labbra arricciate, muso allunga-to, qualche piega nella zona sopra il naso; bocca aperta con denti scoperti; orecchie indietro e appiattite contro la testa; occhi allungati leggermente chiusi; pupille di-latate; coda in mezzo alle gambe; corpo abbassato, testa bassa e di lato; piloerezione.
Oltre alle posture molto importanti sono anche le mimiche facciali e la posizione della coda: a tal proposito si ricorda come lo scodinzolare venga generalmente interpretato come un se-gnale di amicizia e di felicità, ma non è sempre così.A volte può capitare di vedere due cani che si avvicinano cautamente, minacciosi che hanno le punte delle loro code che si muovono velocemente, il loro atteggiamento e la loro postura
34 35
CENNI DI COMUNICAZIONE
La relazione tra uomo e cane, come qualsiasi altro rapporto identifi cabile come relazione, è attuabile solo attraverso la comunicazione, che è il primo passaggio per iniziare ad instaurare un riferimento l’uno verso l’altro. Per comunicazione si intende uno scambio di contenuti decifrabili da parte di tutti e due gli interlocutori, perciò le informazioni che questi si scambiano devono essere chiare sia per l’uomo sia per il cane.Le persone, per comunicare tra di loro utilizzano quasi sempre la parola, ma quan-do si entra in relazione col cane si deve tenere in considerazione che non è il suo canale comunicativo adeguato. Incontriamo la comunicazione col cane sul piano visivo e quindi gestuale: il lin-guaggio del corpo è il modello corretto che ci permette di entrare attivamente in relazione. E’ ormai da tempo assodato che tutti gli animali possiedono la capacità di comuni-care tra di loro. Ogni specie ha il proprio linguaggio, più o meno articolato e com-plesso, secondo il grado di socialità raggiunto dagli individui che la compongono.Gli animali hanno sviluppato spesso delle forme di comunicazione corporee che permettono di evitare attacchi e lotte inutili e dannose per l’individuo stesso. Que-sto linguaggio, innato e universale, viene utilizzato principalmente dal cane quan-do, percependo il comportamento altrui come minaccioso od ostile, vuole evitare il confl itto, comunicando all’altro individuo la propria volontà di tregua.Il cane, come il lupo, appartiene ad una specie altamente sociale strutturata per vivere in branchi composti da vari individui.
CALMANT
II SEGNA
LI
di Laura ferrario
36 37
Indubbiamente, in una comunità numerosa, per assicurare la costante funzionalità del branco e l’intesa fra i membri, occorrono maggiori competenze comunicative di quelle richieste da una vita individuale o da una semplice convivenza a due.Specialmente, tra individui dotati di una notevole carica aggressiva, si rivela indispensabile, per la sopravvivenza del branco stesso, l’uso di un linguaggio tanto sofi sticato e sottile da rivelarsi capace di garantire all’intera comunità l’equilibrio dei ruoli gerarchici e sociali e la mutua cooperazione, attraverso segnali precisi e inequivocabili, fi nalizzati all’interruzione o alla prevenzione di possibili confl itti o aggressioni. I cani hanno le stesse capacità sociali dei lupi nell’evitare i confl itti, ma è più diffi cile perce-pirle. Il cane, che è addomesticato, usa manifestazioni più sottili, lettere molto più piccole. Infatti i cani, normalmente, non sono nella situazione di pericolo dei lupi e perciò non hanno bisogno di usare lettere grandi o di alzare la voce per comunicare tra loro, ma attraverso gli stessi segnali possono prevenire o interrompere qualcosa. Li usano per prevenire l’accadere di eventi, evitare minacce da parte di uomini e cani, placare il nervosismo, la paura, lo schia-mazzo e situazioni spiacevoli. Inoltre, i cani usano questi segnali sia per calmare sé stessi quando si sentono stressati o a disagio (es: ”Ok non preoccuparti va tutto bene” o anche “ Sono preoccupato ma ce la posso fare”), sia per indurre l’altro a sentirsi più sicuro e a capire la buona volontà che questi segnali esprimono (es: ”Vengo in pace, da me non hai nulla da temere, ti prego sii pacifi co anche tu!”).
Questi segnali, già da anni evidenziati dalle ricerche sui lupi, furono studiati per la prima volta nei cani da Turid Rugaas fondatrice e direttrice del Centro di Educazione Cinofi la “Hagan Hundeskole” nei pressi di Oslo, che da oltre trenta anni studia il comportamento del cane.Turid Rugaas li denominò “Calming Signals” (segnali calmanti) proprio perché utilizzati dal cane sia per calmare se stesso quando è stressato o a disagio sia per calmare gli altri individui, comunicando loro in modo inequivocabile le proprie intenzioni pacifi che.I cani, come i lupi hanno maggior interesse ad evitare inutili quanto pericolosi confl itti e, se possono farne a meno, (se non soffrono di evidenti squilibri comportamentali) evitano di usa-re l’aggressività come biglietto da visita.
Tutti i cani del mondo usano gli identici segnali e se, in età precoce, hanno potuto vivere un’adeguata socializzazione sono in grado di emetterli e comprenderli, anche quando questi segnali sono usati per imitazione dall’uomo.
Sui segnali comunicativi in generale ci sarebbe da dire che in alcune razze, gli interventi allevatoriali hanno modifi cato morfologicamente alcuni strumenti molto importanti per la trasmissione dei segnali corporei, (i cani con la coda mozzata non riescono a manifestare i loro stati emotivi attraverso lo scodinzolio della coda. I cani che hanno pelo molto folto sugli occhi, non possono segnalare attraverso lo sguardo, ecc.) e questo va a discapito della com-prensione reciproca.
I SEGNALI CALMANTICome abbiamo visto, i segnali calmanti sono usati per mantenere una
sana gerarchia sociale e per risolvere confl itti all’interno del branco o tra i cani che oggi vivono con noi, ma sono tecniche che possono essere di grande aiuto anche nel rapporto quando sono riportate alla nostra interazione con i cani. Quante volte ci siamo posti queste domande:Come possiamo fare per farci chiaramente capire dal nostro cane?Quale tipo di comunicazione dobbiamo tenere per relazionarci correttamente con il nostro cane?Perché capita spesso che chiediamo di fare qualcosa a fi do e questo sembra non capire?
Noi dovremmo imparare ad osservare i segnali:• Cosa sono• Come sono usati• Com’è possibile imparare a capire meglio i nostri cani
I segnali inviati dal cane sono stati per comodità classifi cati e distinti per aiutarci a capire lo svolgimento dell’intera sequenza relazionale. Turid Rugaas ne ha eviden-ziati una trentina. Con la pratica e molta osservazione si riesce a coglierli tutti e ad essere sempre in grado di capire lo stato d’animo del cane, sia nei confronti di altri cani, sia nei nostri confronti. Vediamone alcuni:
GIRARE LA TESTAE’ un movimento veloce della testa da un lato all’altro, oppure la testa può ri-manere di lato per un po’. Può andare da un gesto minuscolo, fi no alla rotazione completa della testa. Utilizzato per dire all’altro di calmarsi, che sia questo cane o uomo. Anche tu puoi girare la testa se nell’avvicinarti noti che il cane comincia ad agitarsi o spaventarsi
GUARDARE ALTROVESpesso avviene quando due cani si incontrano, guardano altrove per un attimo per poi salutarsi con gioia. e’ un segnale simile a girare la testa ed è quindi utilizzato per evitare di dichiarare lo scontro e per spostare la comunicazione su un piano amichevole.
SOCCHIUDERE GLI OCCHISocchiudere gli occhi per rendere lo sguardo più dolce, abbassare le palpebre e non fi ssare in modo ostile. Sono tutti segnali che il cane usa quando deve guardare qualcuno direttamente e non vuole risultare minaccioso.
38 39
VOLTARSI DI LATO E DI SPALLEE’ un segnale molto forte. Spesso utilizzato da uno o più cani durante la fase di gioco che sta diventando troppo vivace. Improvvisamente, uno o più soggetti si voltano di lato o danno le spalle con l’obiettivo di calmare un po’ la situazione. Utilizzato anche da un cane adulto che si sente infastidito da uno più giovane, oppure nell’in-contro tra due cani, se un soggetto ringhia o si comporta in modo intimidatorio (ad esempio se corre incontro troppo velocemente). Il cane potrebbe voltare le spalle anche a noi se per esempio stiamo usando un tono troppo irritato o quando viene strattonato al guinzaglio potrebbe girarsi nel senso opposto e tirare di più.
LECCARSI IL NASOE’ un rapido movimento della lingua diffi cile da cogliere da un occhio non allenato. E’ fre-quente nell’approccio tra due cani sconosciuti. Durante l’interazione con l’uomo si può osser-vare più frequentemente in queste occasioni:- Quando viene abbracciato- Quando viene sgridato- Quando una persona si china su di lui- Quando viene accarezzato sulla testa- Quando mostra timore di qualcosa o qualcuno- Quando gli parli con tono irritato
IMMOBILIZZARSIIl cane che si immobilizza indica che non vuole provocare reazione di difesa o di offesa. È uti-lizzato spesso dal cane che diventa oggetto di attenzioni da parte di un altro cane sconosciuto che si avvicina troppo a lui per annusarlo dappertutto. Non importa la posizione: in piedi, seduto o sdraiato, senza muovere un muscolo. Il cane può emettere questo segnale verso l’uomo che lo sgrida, che lo intimorisce o che lo stressa.
CAMMINARE LENTAMENTE, USARE MOVIMENTI LENTITutti i movimenti lenti nel cane hanno un forte potere calmante. Il cane rallenta alla vista dell’altro cane e lo stesso capita se accadono troppe cose intorno al cane, in questo caso sta cercando di calmare la situazione. Se vuoi calmare un cane impaurito, timoroso o preoccupato, muoviti lentamente. Quando av-vicini un cane per mettergli il guinzaglio, più ti muovi lentamente più alta sarà la probabilità che lui rimanga fermo.Spesso, nell’interazione uomo-cane quest’ultimo emette questo segnale verso il proprietario che lo sta richiamando con tono irritato. Classica scena del cane che sta giocando con altri cani e il proprietario lo richiama: inizia con un tono tranquillo ma quando vede che il cane non torna cambia il tono di voce. Il cane percepisce un tono irritato e per cercare di calmarlo
torna lentamente verso di lui. Il proprietario interpreta male il signifi cato di quelle movenze e, pensando ad una forma di disobbedienza o pigrizia del cane, si arrabbia ancora di più con il cane che molto probabilmente
emetterà nuovi segnali calmanti con scarsi risultati.
POSIZIONE DI GIOCOIl cane si abbassa sulle zampe anteriori, il posteriore è sollevato. Una sorta di in-chino.Se questo segnale è eseguito da un cane saltellante e giocoso l’interpretazione che viene data è quella di un chiaro invito al gioco. Se invece il cane sta fermo nell’in-chino allora probabilmente siamo in presenza di un segnale di calma. Solitamente lo usa il cane che vuole fare amicizia con un suo simile poco propenso al gioco o intimidito o nervoso. Lo può anche utilizzare quando incontra un altro animale (cavalli o mucche) che lo rende un po’ insicuro.
SEDERSIIl cane potrebbe sedersi se un altro cane lo mette a disagio o quando il proprieta-rio lo chiama strillando. Anche l’uomo lo può usare: si può sedere quando il cane è stressato e non riesce a rilassarsi o facendo sedere gli ospiti se il cane è un po’ diffi dente verso gli estranei.
METTERSI A TERRAIl cane lo usa da cucciolo quando il gioco diventa troppo vivace, lo usa da adulto se un cane giovane mostra di aver paura di lui o quando si stanca di giocare e vuole che gli altri si calmino.
SBADIGLIARELo sbadiglio fuori contesto è un chiaro segnale calmante. Andare dal veterinario, un litigio in famiglia, tenerlo troppo stretto, un bambino che lo abbraccia e tante altre situazioni in cui il cane si sente a disagio. Anche il proprietario può sbadiglia-re per calmare un cane ansioso o preoccupato.
ANNUSAREE’ molto diffi cile distinguere questo segnale dato che i cani annusano normalmente il terreno per informarsi di ciò che succede o di chi è passato di lì prima di loro. Generalmente il cane che è interessato realmente ad un odore rivolge lo sguardo a terra, invece, un cane che comunica un segnale di pacifi cazione, mentre annusa tiene la coda dell’occhio verso la situazione che lo preoccupa. Durante una si-tuazione di possibile confl itto, un’ottima strategia vivente è quella di far fi nta di essere fortemente interessati a qualcos’altro per spostare l’attenzione del possibile aggressore verso qualcosa che lo possa distrarre; la ricerca di un odore può far dimenticare la tensione.
40 41
Il cane può annusare quando un altro cane gli si avvicina, quando qualcuno gli va incontro, o quando capita una situazione improvvisa (ad esempio quando due cani si trovano inaspetta-tamente troppo vicini). CURVAREIl modo più cortese che ha un cane per avvicinare un altro è quello di descrivere una traietto-ria curva mentre si dirige verso di lui. Camminando col cane al guinzaglio, capita spesso di incrociare un altro cane che procede nel senso di marcia opposto al nostro. In questi casi non è infrequente osservare che i cani, avvicinandosi, deviano curvando. Così facendo si mandando un segnale di pacifi cazione evitando confl itti. Se notiamo che il nostro cane non si avvicina all’altro facendo una curva, e l’altro è un po’ timoroso, possiamo dirigere noi il nostro cane affi nché si avvicini curvando.
METTERSI IN MEZZOPosizionarsi tra due o più cani o persone ha lo scopo di creare una barriera tra ciò che viene ritenuto fonte plausibile di confl itto. È frequente osservare un cane che si interpone tra due persone a stretto contatto fi sico (che ballano, litigano, si abbracciano) o tra due cani che gio-cano troppo violentemente, che sono irruenti o che sono causa di tensioni nel gruppo.
aGITARE LA CODAAgitare la coda non è sempre sinonimo di gioia. Bisogna osservare non solo la coda, ma tutto il cane. se striscia verso di te, piangendo e facendo pipì, l’agitare la cosa è un chiaro segnale di resa che tenta di farti calmare. Il cane lo userà quando il proprietario va in collera nel tentativo di calmarlo.
GRATTARSIIl cane che si gratta fuori contesto (quando non ha realmente prurito) ci dice che sta vivendo un disagio e grattandosi scarica lo stress accumulato.
SCROLLARSILo scrollarsi segue spesso una tensione “corporea”, ( carezze da uno sconosciuto o troppo pressanti, giochi troppo irruenti ecc.).
MA C’E’ DI PIU’….I segnali indicati precedentemente sono i più comuni ma i cani si calmano tra loro anche giocando a fare i cuccioli, ad esempio: si fanno piccoli e cercano di leccarsi le facce, posso-no sbattere le palpebre, schioccare le labbra, alzare una zampa anteriore, fi ngere di ignorare che l’altro esista e anche fare pipì in alcune situazioni può essere interpretato come segnale calmante.
CONCLUSIONI
La scoperta di questi segnali ci apre un mondo nuovo, affascinante e complesso, che ci offre lapossibilità di capire meglio il nostro amico a quattro zampe per relazionarci con lui in maniera piùcorretta e appagante. La comunicazione del cane richiede da parte nostra un’atten-ta osservazione ed analisi dei movimenti che intendono esprimere le intenzioni, ma anche della disposizione che il corpo assume in ogni momento nei confronti dell’interlocutore (posture).
Impariamo ad utilizzare i segnali calmanti con il nostro cane e con cani che non conosciamo, soprattutto durante l’approccio ricordiamoci di tenere in considera-zione:• La nostra postura del corpo che sarà neutra (verticale); no inclinata in avanti o indietro• La traiettoria di avvicinamento: non diretta ma formando una sorta di curva• Lo sguardo: non fi ssare il cane negli occhi ma guardarlo e distogliere lo sguardo in modo ripetuto Un interessante esercizio da fare è quello di osservare il vostro cane mentre si re-laziona con gli altri.Scoprirete sottili segnali dei quali non vi eravate mai accorti.
Lettura Consigliata:Turid RugaasL’intesa con il cane: I Segnali CalmantiEd. Haquihana
DVD consigliato:Clarissa v. Reinhardt presentato da Turid RugaasCalming Signals Ed. Haquihana
Bibliografi a:• Turid Rugaas – L’intesa con il cane: i segnali calmanti • Dott.ssa Eleonora Mentaschi – dispensa Corso di Formazione Educatore Cinofi lo (Rho – Mi-lano)• Deborah Bianchi – dispensa Corso di Educatore Cinofi lo San Zaccaria (Ravenna)
42 43
Numerose e recenti ricerche scientifi che hanno dimostrato che la maggior par-te dei problemi comportamentali diffusi tra i cani che vivono in citta’ possono essere risolti semplicemente rivedendo la loro gestione da parte dei proprietari” (J.Dehasse”).L’inoperosita’ e’ la maggior causa di problemi comportamentali del cane.I cani che svolgono suffi ciente attivita’ sono in uno stato di benessere e cio’, oltre ad essere il desiderio di ogni proprietario e’ alla base di un qualunque percorso di educazione.Un cane felice e soddisfatto della sua vita e’ piu’ predisposto ad imparare e colla-borare con noiQuindi vedremo come e’ possibile pensare alla gestione del cane attraverso attivi-ta’ che soddisfi no i suoi bisogni etologici e fi siologici.
Conoscere i bisogni del caneLa piramide di Maslow che modellizza i bisogni dell’uomo viene applicata al cane ottenendo una gerarchia di quattro livelli:
• Primo Livello - bisogni fi siologici e di sicurezza: fame, sete, sonno, movimento, protezione dai pericoli, paura, dolore• Secondo Livello - bisogni di appartenenza: il cane e’ un animale sociale e quin-di forte e’ il bisogno di appartenere ad un gruppo, bisogno di affetto e relazione• Terzo Livello - bisogni di accreditamento: necessita’ di sentirsi parte di un grup-po, avere considerazione, essere apprezzati, avere un ruolo• Quarto Livello – bisogni di auto-realizzazione: bisogni cognitivi e di varieta’.
DEL CA
NEI BISOG
NI
di Anna Zanon
44 45
Le conseguenze di questo modello sono che:• ci si trova in uno stato di benessere quando si possono soddisfare regolarmente i bisogni• perche’ nasca il desiderio di soddisfare quelli di livello superiore e’ necessario che quelli di livello inferiore siano soddisfatti• ogni comportamento anche quando sembra illogico, e’ sempre motivato dal tentativo di soddisfare uno o piu’ bisogni. Se vogliamo comprendere il comportamento del cane, dobbia-mo comprendere il bisogno nascosto dietro a questo comportamento.
Attivita, in formula
Che cosa si intende per attivita’? Attivita’ e’ tutto cio’ che e’ occupazione, lavoro, esercizio, in opposizione ad inattiva’, riposo, mancanza di azione. L’attivita’ non presuppone movimento : per es. un cane da caccia che fa la punta alla preda non e’ inattivo, e’ immobile ma sta rifl et-tendo su come risolvere il problema su quando agire...J.Dehasse propone un modello ipotetico secondo cui l’attivita’ generale di un cane e’ la som-ma delle attivita’ fondamentali: alimentare, locomotoria, masticatoria, vocale, ludica, intellet-tuale (l’attivita’ intellettuale e’ 10 volte piu’ dispendiosa dell’attivita’ fi sica).Mediamente un cane ha bisogno di 4-7 ore di attivita’ in un giorno con differenze che dipen-dono dalla razza, dall’essere cani da lavoro, da caccia e poliziotti, guida ...e questo bisogno e’ pressoche’ stabile nel tempo, cioe’ non varia da giorno a giorno. Questo si traduce nel fatto che l’aumento di una attivita’ comporta la riduzione di un’altra. Si puo’ ridurre quindi una at-tivita’ ma mai eliminarla e questo perche’ ogni attivita’ e’ espressione di un bisogno specifi co e come abbiamo visto, tutti i bisogni hanno necessita’ di essere soddisfatti. Nel seguito vengono descritti i bisogni di ogni livello e le attivita’ per soddisfarli in modo adeguato. Si cerchera’ di fornire suggerimenti per fare in modo che la formula delle Attivita’ possa essere completata in modo effi ciente avendo come obiettivo il benessere del cane.
Bisogni Fisiologici e di Sicurezza
Quando il cane non ha soddisfatti questi bisogni, si trova in uno stato di ”urgenza”. Le attivita’ capaci di soddisfare questi bisogni sono:Bisogni PrioritariAttivita’Fame, seteAlimentareMovimentoLocomotoria, LudicaPaura, sicurezzaIntellettuale, Ludica
Di seguito qualche indicazione per ciascuna attivita’:Attivita’ Alimentare: ci sono molte alternative al fornire il cibo nella ciotola, che in piu’ sono gratifi canti per il cane e che nessitano di tempi
maggiori per essere svolti e che quindi ci sono di aiuto per completare la Formula delle Attivita’, alcuni esempi:• cibo come premio e rinforzo per i comportamenti corretti. Utile uscire sempre in passeggiata con una parte della razione di cibo e/o con qualche premio piu’ goloso ed essere sempre attenti a premiare i comportamenti che ci piacciono del nostro cane (es, la calma, l’autocontrollo, ...)• cibo come motivazione per agire, giocare e lavorare• cibo come oggetto di una ricerca olfattiva (es, distribuire le crocchette per casa e farle cercare al cane, arrivare a nasconderle in altre stanze, spargerle in giardino...)• cibo come premio di un “problem solving”. Esistono in commercio vari giochi di attivazione mentale che richiedono che il cane si concentri e trovi una soluzione per scovare un bocconcino, ma si possono pure facilmente costruire con la nostra fantasia o prendendo spunto da alcuni libri di giochi...• cibo all’interno di un gioco : dispenser come il pipolino, kong, all’interno di scatole, ...anche questi giochi che possono essere pensati da noi.Ma se decidiamo di offrire il cibo in ciotola, possiamo approfi ttare di questo mo-mento per insegnare una competenza molto importante: la calma e l’autocon-trollo. Ci sono degli esercizi molto semplici che un educatore puo’ insegnare per insegnare al cane a gestire con calma e autocontrollo un momento cosi’ eccitante come e’ quello della pappa. Il concetto alla base e’ quello di aspettare che il cane si metta tranquillo spontaneamente e ci guardi, prima di posare la ciotola a terra. La competenza che il cane acquisisce e’ che “agitarsi non serve”, anzi che il mezzo per arrivare a cio’ che desidera e’ la calma e la relazione con noi.
Attivita’ Locomotoria: un cane dovrebbe poter uscire almeno 3 volte al giorno e cio’ vale anche per i cani che vivono in giardino. Le uscite dovrebbero essere ab-bastanza lunghe per garantire:• bisogni fi siologici (cacca, pipi, movimento..)• liberta’• socialita’• relazione con noi (attraverso qualche gioco, esercizio di condotta,..)
Alcuni suggerimenti per la passeggiata:• portare sempre con se’ dei premi golosi (o parte della razione di cibo) per essere pronti a premiare i suo comportamenti corretti e i suoi successi• essere attenti alle situazioni che creano disagio al cane (per es, un cane che ha
46 47
paura o problemi di socializzazione con altri cani, imparare ad avvicinarsi di lato, facendo una curva, ..farsi aiutare da un educatore per improntare un percorso di ri-socializzazione per arrivare ad avere un cane che scodinzola felice alla vista degli altri cani)• saper leggere cosa attrae il nostro cane al fi ne di evitare che si metta nei guai,..per es attra-versando una strada
Attivita’ Intellettuale: Sono attivita’ intellettuali tutte quelle situazioni che richiedono al cane una rifl essione, una scelta: in passeggiata, nell’incontro con le persone, durante il gioco.Il cane basandosi sulle sue esperienze, sulle emozioni che ha provato e che sono state raffor-zate, in base alle sue motivazioni, alle sue capacita’ logiche e cognitive, alla stima che ha di se’, prendera’ delle decisioni e fara’ delle scelte. Ecco perche’ e’ importante che il nostro cane sia in uno stato di benessere e di equilibrio, di relazione positiva nei confronti delle persone e di altri cani e che abbia le competenze per integrarsi nel mondo in cui vive.
Esercitare la mente e’ una delle migliori soluzioni all’inoperosita’ del cane perche’ le attivita’ intellettuali sono 10 volte piu’ faticose dell’attivita’ fi sica: per es, 5’ di attivita’ per discrimi-nare tra due oggetti equivalogono a 100’ di corsa nei campi..Inoltre esercitare la mente signifi ca allenare la mente del cane a porsi in uno stato emozio-nale positivo, ad aumentare la stima di se’, a farsi un bagaglio esperienziale, ad acquisire competenze che potra’ riutilizzare in altre situazioni e che gli permetterranno una piu’ facile integrazione e benessere.Esistono in commercio diversi giochi di attivazione mentale e a livelli di diffi colta’ progressi-va, ma possono anche essere frutto della nostra fantasia.In cosa consiste un gioco di Attivazione Mentale? Si mette il cane di fronte alla necessita’ di mettere in moto il suo cervello, di rilassarsi , di concentrarsi per analizzare ed “arrivare da solo” alla soluzione del problema.
Di seguito alcuni suggerimenti per svolgere correttamente un gioco di attivazione mentale:• il proprietario deve sempre essere presente durante la sessione di gioco• il proprietario non deve intervenire per sollecitare, incitare o sgridare il cane• in caso di disinteresse, si puo’ aumentare “la posta in premio” o spostare di poco il gioco rispetto al cane• se il cane mostra segnali di stress e agitazione si puo’ intervenire per proprorre un gioco piu’ semplice • non aiutare il cane a risolvere il problema, semmai fare un passo indietro• terminare la sessione sempre con un successo da parte del cane• la durata max di una sessione e’ di 10-15’
Il Bisogno di Sicurezza si esprime e si soddisfa attraverso una corretta gestione e una profon-da relazione; esso comprende:• la liberta’ dal disagio e dalla paura,• dare prevedibilita’ negli orari (pappa, uscite) e nel comportamento (comunicazione chiara
e comprensibile, regole, coerenza..)• rappresentare per il cane una Base SicuraUna corretta Gestione e’ fatta di calma e autocontrollo, regole e coerenza
nei comportamenti, una gestione quotidiana basata sui bisogni, l’applicazione del-la formula delle Attivita’, un’educazione che abbia come obiettivo l’integrazione del cane nell’ambiente spesso cittadino in cui vive.
Una sana e profonda relazione si basa sopratutto sul fatto che diamo importanza alla relazione con rispetto e conoscenza per le diversita’ . E’ importante saper leg-gere i segnali di disagio (segnali calmanti, posture del corpo..) e chiedere consiglio e supporto ad un educatore per avere strumenti che aiutino il cane ad integrarsi:• “anche solo se”..il disagio e’ del cane e non crea a noi problemi• “anche solo se” ..il problema e’ evitabile.Non sempre evitare un problema e’ la miglior solu-zione, si prenda ad esempio un cane che ha paura degli altri cani, potremmo sem-plicemente evitare gli incontri ma se rispettiamo il fatto che il cane e’ un animale sociale, dovremmo lavorare ed impegnarci per aiutarlo nella ri-socializzazione.
Bisogni sociali, di appartenenza e di accreditamento
Come possiamo soddisfare i bisogni sociali, di appartenenza e di accreditamento:• Condividere il maggior numero di esperienze con il cane (tempo e qualita’)• Dedicare tempo e attenzione alle cure parentali e fi siche• Capire i segnali, imparare e rispettare la comunicazione dei corpi, molto impor-tante nel mondo del cane. Ricordiamoci l’importanza di avvicinarci di lato, mai diretti,..• Dare competenze al cane per gestire la nostra assenza: abituarlo gradualmente, fornire oggetti da masticare,..• Essere collaborativi: attraverso giochi, piccole attivita’ svolte insieme,...• Bisogni di auto-realizzazione e cognitivi
I bisogni di auto-realizzazione sono relativi alla possibilita’ da parte del cane di svolgere attivita’ che:• Piacciono al cane e lo fanno stare bene le Motivazioni• Possono discostarsi dalla routine e forniscono stimoli e varieta’ cognitive (pas-seggiate in luoghi diversi, insegnare tricks, sport cinofi li,..)I cani hanno tutti le stesse motivazioni ma nelle differenziazione delle razze c’e’ stata una esaltazione o repressione di alcune motivazioni: un cucciolo di Border Collie sara’ portato a fare giochi predatori (correre dietro a una pallina,..), uno di rottweiller giochi competitivi tipo tira-molla, uno di labrador giochi epimeletici e collaborativi (il riporto).Conscere le motivazioni e’ indispensabile nella scelta del cane (e’ sempre consi-gliato un colloquio pre-adozione con un educatore) e nella gestione quotidiana per
48 49
garantire l’espressione delle motivazioni principali di razza e nell’esercitare altre motivazioni al fi ne di allargare la possibilita’ di piacere ed evitare fi ssazioni e situazioni di frustrazione.
BIBLIOGRAFIA Joel Dehasse, Il mio cane e’ felice?, Le Point Veterinarie Italie, 2010 Simone dalla Valle, Un cane per amico, TEA editore, 2012 Eleonora Mentaschi, I bisogni del cane, sito Scuola cinofi la “Ilmiocane”, 2012 Martina Nagel & Clarissa v.Reinhard, Lo Stress nel cane, Haqihana editore,2004 Turid Rugaas, L’intesa con il cane: I segnali Calmanti, Haqihana editore, 2005
Lo stress è uno Stato con cui organismo reagisce ad una minaccia interna o esterna e raccoglie le sue forze per superare una situazione di pericolo.
Lo stress può essere utile o dannoso; infatti possiamo evidenziare lo stress positi-vo: reattività e rendimento fi sico ottimale per far fronte alla situazione di pericolo e lo stress negativo: patologie da stress prolungato nel tempo.
La manifestazione dello stress avviene attraverso alterazioni a livello fi siologico e alterazioni del comportamento.
Per analizzare quali sono le principali cause dello stress ho distribuito un questio-nario a diversi proprietari di cani. Il questionario è composto da una parte che evi-denzia le informazioni generali e lo stile di vita del cane e una parte con una lista di sintomi e comportamenti potenziali indicatori di stress. L’indicazione del livello di stress di ciascun soggetto è stata ottenuta assegnando un punteggio alle domande relative ai sintomi indicatori di stress.La media dei punti stress dei soggetti ( 16, 46) è stata presa come valore di riferi-mento e indica il livello medio di stress del campione.
Per quanto riguarda il sesso, dallo studio si evidenzia che i maschi hanno una me-dia punti stress più alta delle femmine. Ma si evidenzia anche che i soggetti sterilizzati ( sia maschi che femmine) mo-strano una media stress più alta. Questo potrebbe derivare dal fatto che il mutato atteggiamento sociale degli altri cani nei confronti del soggetto sterilizzato possa risultare stressante.
nEL CA
NElo str
ess
di Veronica Piazzolla
50 51
È molto importante quindi valutare attentamente eventuali sterilizzazioni. La sterilizzazione viene vista spesso come cura ai problemi di comportamento che però non sempre vengono risolti dalla castrazioni ma spesso vengono peggiorati. E’ un aspetto da valutare con una per-sona competente.
Analizzando la provenienza dei cani si evidenziano diversi aspetti; i cani che arrivano da un negozio o dal canile hanno, per diverse motivazioni, una media stress superiore al valore di riferimento. I cani che arrivano da un allevamento hanno una media stress al di sotto del valo-re di riferimento. La motivazione è semplice, le prime fasi di vita del cane sono fondamentali; nei primi due mesi si stabilisce, attraverso le varie stimolazioni alle quali viene sottoposto il cucciolo, il carattere del cane adulto. Un allevatore competente presta molta attenzione a questa fase critica della vita dei cani e ciò fa sì che i cani da adulti siano più equilibrati; si prevengono i problemi di comportamento.Prendere un cane da un privato ovviamente è più un rischio nel senso che la persona potrebbe non avere le conoscenze specifi che di quali sono le esigenze di un cucciolo.Per quanto riguarda i cuccioli in vetrina molto spesso vengono staccati troppo presto dalla madre e stare chiusi in pochi metri quadri di certo non permette al cucciolo di affrontare le esperienze necessarie al suo equilibrio.I Cani del canile ovviamente presentano un livello di stress piuttosto alto visto la permanenza in gabbia.
Di fondamentale importanza è l’età di adozione di un cane; I cani adottati prima dei 60 giorni di vita presentano una media stress di molto superiore al valore di riferimento. Questo perché staccare il cucciolo della mamma prima dei 60 giorni è un gravissimo errore che sfocerà quasi sempre in problemi di comportamento dell’adulto. L’aspetto più importante è: non adottare MAI un cucciolo prima dei due mesi di vita.Ho voluto anche analizzare lo stress in riferimento al luogo di residenza del cane. Dallo studio notiamo che i cani che vivono in campagna hanno una media stress più bassa rispetto al valore di riferimento mentre i cani che vivono in città hanno una media più alta. Questo ci mostra come la vita frenetica della città molto spesso rappresenta una fonte di stress per il cane. La città è piena di rumori, odori e limitazioni per il cane.
Analizzando la quotidianità abbiamo notato che la media stress rimane piuttosto alta per i cani che riposano meno di 19 ore al giorno. Quindi 18 / 19 è da considerare il periodo di riposo medio giornaliero di cui il cane ha bisogno. Sì nota però che anche l’eccesso di ore di sonno produce un alto livello di stress.
È stato valutato il livello di stress in relazione alle ore che il cane abitualmente trascorre da solo casa;
Lo studio evidenzia che se il periodo di solitudine non supera le cinque ore la media stress è inferiore al livello di riferimento. La media stress dei cani che rimangono soli più di sei ore è superiore al valore di riferimento.
Per loro rimanere soli per più di sei ore è troppo.
Le passeggiate sono un altro aspetto fondamentale nella vita del cane e non solo per i bisogni. Servono al cane per fare movimento, per interagire con il mondo.Ovviamente notiamo che i cani che vivono sempre in giardino hanno una media stress molto elevata. I cani che passeggiano fi no a tre ore hanno una media stress al di sotto del valore di riferimento, mentre i cani che superano le tre ore hanno un valore superiore. Valutiamo quindi attentamente se il soggetto risente delle lunghe e frequenti uscite.
La vita in città limita molto la possibilità di camminare liberi ai nostri cani e di socializzare in modo corretto con i propri simili. Dallo studio notiamo che i cani che hanno la possibilità di passeggiare liberi ed incontrare liberi altri cani hanno una media stress inferiore al valore di riferimento.Invece i cani che sono costretti a camminare sempre al guinzaglio o che non incon-trano altri cani in libertà hanno una media stress piuttosto alta.
Il gioco è una valvola di sfogo o una fonte di stress? Come dimostra l’inchiesta i cani che non giocano regolarmente hanno una media stress al di sotto del valore di riferimento e forse sorprenderà il fatto che i cani che giocano regolarmente hanno una media stress al di sopra della soglia. Queste è do-vuto dal fatto che il gioco non sempre è una valvola di sfogo adeguata anzi aumen-ta l’attivazione emozionale dei cani e l’eccitazione. È di fondamentale importanza valutare attentamente i giochi che si fanno con i cani e le modalità. Quindi può essere utile rivolgersi ad un educatore anche per capire come impostare i diversi giochi.
Per quanto riguarda il gioco tra cani e bambini notiamo un maggior valore di stress. Molto spesso ai bambini è concesso tutto e il cane costretto sopportare le mara-chelle dei bambini. È fondamentale sorvegliare sempre cani e bambini quando sono insieme e insegnare i bambini rapportarsi con il cane in modo corretto.I dati dimostrano anche che i cani che non praticano sport hanno una media stress più alta; i cani che praticano uno o due sport hanno una media stress più bassa e questo può essere spiegato dal fatto che praticato nel modo corretto lo sport può essere una valvola di sfogo per il cane. È fondamentale però valutare la disciplina sportiva più adatta al cane e quanto spesso praticare lo sport.
Nell’ambito della salute, i cani che soffrono di malattie mai o raramente hanno una
52 53
media stress più bassa mentre i cani che soffrono spesso molto spesso di malattie hanno una media stress più alta.Ovviamente ogni malattia è causa di stress per l’organismo.Il gruppo con problemi intestinali ha una media particolarmente alta di stress. Infatti i pro-blemi intestinali sono strettamente correlati allo stress di cui possono essere sia sintomo che causa.
Analizzando invece la manipolazione da parte di estranei notiamo che essa molto spesso è risentita come un aspetto negativo da parte del cane, soprattutto se questa non avviene in modo corretto. La maggior parte delle persone che incontriamo per strada si precipita sul no-stro cane in modo diretto e appoggiando la mano sopra la testa del cane, cosa davvero poco gradita. Cerchiamo quindi di prestare attenzione alle reazioni del nostro cane e di evitargli i troppi incontri stressanti.
Nel momento in cui il cane si sente minacciato ( per situazione di reale pericolo o semplice-mente per una percezione del cane) il corpo attiva i meccanismi interni di allarme. Come detto in precedenza se le minacce esterne permangono nel tempo si sviluppa lo stress negativo. Il livello di stress sarà tanto più alto quanto più frequenti sono queste situazioni.
Concludendo riassumiamo quali sono i risultati dell’inchiesta; gli aspetti da tenere maggior-mente in considerazione per prevenire lo stress sono: il sonno, il correre liberi e il contatto sociale con i propri simili. Prestare molta attenzione anche all’età e al luogo di adozione del cucciolo, alle ore in cui il nostro cane rimane solo a casa e ai giochi e alle attività che svol-giamo con lui.
“Papà, mamma prendiamo un cane?” Molto spesso tutto inizia così, con la ri-chiesta di prendere un cucciolo da accudire, per diventare amici e compagni di vita e il binomio cane-bambino può diventare poi molto più istruttivo di tanti giochiIl cane può essere un compagno di avventure incredibili, può essere un ottimo insegnante di vita, può aiutare il bambino a rispettare le diversità e a non averne paura; gli fa capire che gli animali non sono dei peluches, ma esseri viventi da ri-spettare; può perfi no insegnargli i rudimenti del dolore, il signifi cato del distacco defi nitivo una volta che se ne sarà andato sul Ponte dell’Arcobaleno.La presenza di un cane è molto utile per lo sviluppo dei bambini per diversi motivi: il bambino impara ad essere responsabile di un altro essere vivente, ad occuparsi di lui e a comprendere l’esistenza di regole; ha un compagno di giochi e di confi -denze; il cane è una valvola di sfogo per gli eccessi sentimentali del bimbo, del suo bisogno di affetto; i due imparano a conoscere i propri limiti e a non oltrepassarli, il bambino impara così le regole sociali.
Il cane, però, può anche rappresentare un pericolo per il bambino, soprattutto se l’animale non viene gestito correttamente all’inizio di questa convivenza”. Va premesso, che non tutti i cani sono in grado di convivere con i bambini. Infatti, solo se nei primi tre mesi di vita del cucciolo esso ha contatto con i bambini, allora sarà in grado di riconoscerli come tali e di interagire con loro.Ci sono cani, però, che non avendo mai visto un bambino dimostrano un compor-tamento di aggressività quando ne incontrano uno.Proprio per questo motivo i bambini, almeno fi no ai sei anni di età, non devono essere mai lasciati da soli con il cane, anche e soprattutto se è quello di famiglia.
e bam
binican
i
di Alessandro Cicerale
54 55
Nella maggior parte dei casi è stato rilevato, infatti, che gli episodi di morsi ai bambini si verifi cano nell’ambiente domestico ad opera del cane di famiglia.Non dobbiamo adesso pensare che i cani siano tutti aggressivi e pericolosi, dobbiamo salva-guardare la salute sia dei bambini che dei cani rispettando le esigenze di entrambi, cercando di fare capire ai bambini di rispettare il proprio amico a quattro zampe e nello stesso tempo aiutandoli a non averne paura, perché i bambini fobici sono quelli più a rischio in assoluto, perché sono quelli che scappano, facendo scattare nel cane la molla predatoria.Il comportamento predatorio fa parte dei comportamenti normali del cane ma, se diretto verso i bambini, può creare grossi problemiI cani possono assalire per diversi motivi:per gioco, per difesa della propria incolumità, per difesa di qualcosa che considerano di loro proprietà, perché considerano i bambini come delle prede
Si deve cercare di gestire nel modo migliore il binomio cane-bambino quando arriva un bam-bino in una famiglia dove c’è già un cane e quando arriva un cane dove c’è già un bambino.
Nel primo caso l’arrivo di un bambino porta un totale cam-biamento nella vita dell’intera famiglia, compreso il cane. Questi si vede entrare all’improvviso la padrona con un neonato per lui estraneo che diventerà il beniamino della famiglia.Per non rivoluzionare all’improvviso la vita del cane , dovremmo rifl ettere prima sui possibili cambiamenti che vorremmo effettuare, introducendoli a piccoli passi. Pri-ma di tutto dovremmo abituare il cane a ricevere meno attenzioni. Questo farà in modo che il cane non colleghi l’arrivo del bebe’ con la diminuzione dell’attenzione nei suoi riguardiPrima dell’arrivo del bebe’ potrebbe risultare utile portare a casa gli indumenti del bambino e della madre per dare modo al cane di annu-sarli e abituarlo ai nuovi odori. Si può anche cercare di abituare il cane alle operazione future con il bebe’ come il cambio pannolini, fare il bagnetto o dare da mangiare, utilizzando una bambola. Se il cane rimane calmo lo premiamo.All’arrivo a casa dall’ospedale lasceremo annusare il bebè al cane per conoscerlo. Il cane deve capire e i proprietari devono cercare di agevolare la curiosità del cane non mandandolo via quando si avvicina a meno che non ci siano reali pericoli. La cosa più importante è che il bambino rappresenti per il cane qualcosa di positivo.Mano a mano che il bambino crescerà dovremo spiegare che bisogna lasciare riposare il cane mentre dorme, cercando, in caso, di trovare un posto sicuro alla cuccia in modo da non essere
Nel primo caso l’arrivo di un bambino porta un totale cam-biamento nella vita dell’intera famiglia, compreso il cane.
Prima dell’arrivo del bebe’ potrebbe risultare utile portare a
raggiunta, mentre mangia non dovremo mai toglierli la ciotola.I bambini devono essere costantemente tenuti sotto controllo dei genitori per proteggere il cane stesso, che può diventare, involontariamente, vitti-
ma di dispetti e maltrattamenti.E’ utile abituare il bambino a fare eseguire dei comandi al cane, come “seduto”, in modo che il cane impari ad obbedirgli e a rispettarlo.Si deve insegnare ai bambini come evitare i morsi dei cani: immobilizzarsi, accuc-ciarsi, non guardare il cane fi sso negli occhi e non gridare. Alcune volte il correre davanti ad un cane libero, i movimenti bruschi, le urla possono provocare involontariamente un cane.
Nel secondo caso, quando cioè arriva un cane in una casa dove c’è già un bimbo, prima di scegliere un cane è importante farsi un’idea di quello che si sta realmente cercando. In questa scelta fondamentale giocano un ruolo importante le abitudini della famiglia, lo stile di vita, chi si occupa del cane, dove la fami- glia vive, città, campagna etc.Una volta arrivato il cane a casa dobbiamo trovargli un posto dove possa andare a riposarsi senza essere disturbato; tenerlo in un ambiente con continui stimoli, bambini che giocano, strillano, giochi rumorosi , pianti, stereo, elettrodomestici, televisione etc. può portare il cane ad un eccesso di stimolazione e stress dovu-ti alla mancanza di riposo. Nei primi 4-5 mesi di vita del cucciolo la mancanza di sonno può comportare problemi fi sici gravi per il normale sviluppo endocrino (stress) e fi siologico.Dobbiamo insegnare ai bambini a lasciare degli spazi al cane dove possa rilassarsi e riposarsi senza essere continuamente disturbatoI bambini molto piccoli, più o meno fi no ai tre anni, non sono capaci di capire gli altri essere viventi: per esempio non sanno che i cani possono provare dolore. Può quindi accadere che diano botte o pizzicotti al cane (o anche ad altre persone) ma non per fare del male, solo per fare delle prove, per vedere cosa succedeMolto importante è capire i segnali che un cane può inviare attraverso la sua postu-ra. Questo risulta più facile per un genitore che per un bambino, ma coinvolgerlo come se fosse un gioco all’interpretazione delle posture può risultare anche diver-tente e molto soprattutto educativo. Bisogna insegnare ad osservare: posizione del corpo, orecchie, bocca, mimiche ed espressioni del muso e coda.Si farà capire così, ad esempio, che un cane dominante o molto sicuro di sé ha il corpo ben piantato e rigido orecchie dritte, sguardo fi sso, la coda bene in vista tendenzialmente verso l’alto, che un cane pauroso tendenzialmente avrà il corpo
56 57
che tende ad arretrare verso il basso, orecchie indietro, la coda in mezzo alle gambe e il muso tirato con dilatazione delle pupille, ecc.I cani, inoltre, hanno un sistema di comunicazione che li aiuta a capire le intenzioni dell’altro cane e molto spesso vengono riproposti anche all’uomo. La norvegese Turid Rugaas autrice del libro “L’intesa con il cane: I segnali calmanti” da oltre trent’anni lavora con i cani e alla fi ne degli anni Ottanta studiò il comportamento dei cani scoprendo 27 differenti posture e movimenti che i cani utilizzano per comunicare.Alcuni segnali di pacifi cazione (girare la testa, guardare altrove, leccarsi il naso, distogliere lo sguardo) possono essere riconosciuti anche quando il cane si trova insieme al bambino; dobbiamo riuscire a cogliere questi gesti per aiutare il cane ad uscire da uno stato di disagio e insegnare al bambino il comportamento corretto da avere con il proprio cane.
Infi ne, il cane può avere un ruolo importante nel rapporto con i bambini sia in ambito educa-tivo che terapeutico.Oltre che un compagno di giochi all’interno della famiglia, infatti, il cane può essere impiega-to in ambiti educativi o ludico-ricreativi con l’obiettivo di integrare la sfera didattica dell’ap-prendimento con quella emotivo-relazionale.E’ possibile in tal senso impostare programmi di intervento con obiettivi didattici e compor-tamentali. Ad esempio i soggetti iperattivi attraverso l’apprendimento di regole e lo svolgi-mento di compiti specifi ci imparano, con il rispetto dei tempi e delle reazioni dell’animale, ad autocontrollarsi e a focalizzare l’attenzione su azioni specifi che.
I programmi di terapia assistita con i cani sono fi naliz-zati al raggiungimento di obiettivi terapeutici attraverso l’interazione fra pazienti e cani appositamente selezio-nati e addestrati. In tal senso i cani posso diventare “te-rapeuti” dei bambini in diversi contesti quali ospedali pediatrici soprattutto per pazienti lungo degenti,nei re-parti di neuropsichiatria, chirurgia o affi ancare progetti per il trattamento non farmacologico del dolore, istituti riabilitativi ed educativi, integrazione al supporto psico-logico o alla psicoterapia.
...CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO!
Il rapporto uomo-cane risale alla notte dei tempi. Si tratta di un legame intenso, ca-rico di emozioni forti da entrambe le parti. Questa convivenza, però, non è sempre facile e a volte rischia di trasformarsi in una relazione scorretta.La mancanza di conoscenza (o di esperienza) e i fatti di cronaca rischiano di creare un’immagine sbagliata dell’animale.Con questa ricerca, Antonella Martinoni ha voluto approfondire questo aspetto andando a campionare le risposte degli alunni di alcune scuole primarie della pro-vincia di Milano. Lo spunto è nato da un episodio accaduto tra i suoi cani e un bambino di nove anni che, salendo in auto, si è trovato di fronte due cagnoni neri. La reazione istintiva è stata quella di strillare mentre Antonella interveniva immediatamente richiamando i cani e tranquillizzando il bambino spaventato.La fase successiva, un contatto tra il bimbo e i due riesenschnauzer, ha trasformato però la paura in un sorriso.I bambini delle scuole coinvolte sono stati scelti anche perché fanno parte di una fascia evolutiva in grado di valutare in modo oggettivo senza grandi pregiudizi. Il sondaggio prevedeva diverse fotografi e di cani ritratti in vari stati emotivi (at-tenzione, disagio, noia, giocosità, timore, felicità e timore) e le risposte hanno evidenziato una serie di risposte che vale la pena di analizzare.Per esempio, nelle immagini in cui il cane è palesemente aggressivo i bambini non hanno avuto diffi coltà a interpretare questo atteggiamento. Al contrario, nelle foto-grafi e in cui il cane mostra disagio, gli stessi non riconoscono lo stato di malessere
un CAN
E...VEDERE
di Antonella Martinoni
58 59
e questo neanche per i soggetti che vivono con un animale in casa. Questo risultato è particolarmente preoccupante perché potrebbe portare a un atteggiamento sbagliato da parte dei proprietari e di conseguenza a reazioni esagerate dell’animale e quindi a un atteggiamento aggressivo. Da queste a da altre considerazioni derivanti dalla ricerca si evince che la conoscenza del comportamento canino è scarsa e purtroppo spesso ricalca uno stereotipo deformato e radi-cato da generazioni. Infatti, ancora oggi nella vita di tutti i giorni si possono notare approcci sbagliati da parte di molte persone nei confronti dell’animale.Va considerato anche che i bambini di oggi saranno i proprietari di domani e quindi su di loro è necessario investire per tentare di migliorare il rapporto cane-padrone in modo da condurre una vita più equilibrata e soddisfacente per entrambi.L’obiettivo è di considerare il cane come “compagno di vita” tenendo conto della sua perso-nalità e delle sue attitudini.
Cane e gatto, due specie diverse e per tradizione condannate a non andare d’accor-do. Cancelliamo queste idee. Pur essendo animali diversi possono diventare amici, anzi, anche ottimi amici! L’importante è partire conoscendo le caratteristiche e le abitudini di entrambi, senza troppo improvvisare.
EVOLUZIONE
Cane, discende dal lupo, un animale sociale che vive in branco, abituato a condurre un’esistenza scandita da ruoli all’interno del gruppo famiglia. 400.000 mila anni fa l’uomo e il lupo si incontrano. I motivi principali si pensa siano fondamentalmente due: - Scopi utilitaristici (tesi più probabile, il lupo aveva la funzione di “spazzino”, guardiano e in seguito diventerà un collaboratore per varie attività);- Maternaggio.Gatto, è un felino. Al pari della tigre e del puma è un essere solitario e individua-lista, poco incline a giocare la parte del “gregario”. Molto più recente di quella del cane, si ritiene risalga alla civiltà egiziana 6/7 mila anni fa. (il gatto si avvicina perché sfrutta gli avanzi). Si pensa che i motivi principali possano essere:- Utilitarismo (eliminazione dei roditori e “spazzino”);- Il desiderio di avvicinarsi ad una specie selvatica e di gran fascino.In entrambi il processo di domesticazione ha comportato cambiamenti rispetto agli antenati: - Neotenia, - Modifi cazione dell’assetto ormonale - Prolifi cità
E GATT
O...CAne
di Diana Panzetti
60 61
Le razze in entrambe le specie sono il frutto di processi di selezione artifi ciale da parte dell’uo-mo.
SVILUPPO COMPORTAMENTALE
Gatto: le prime settimane di vita del gattino sono molto importanti per la costruzione degli schemi emotivi e comportamentali che gli serviranno per la vita futura. E’ molto importante che inizi nella maniera migliore, sia fi sicamente che psicologicamente. -> Non è opportuno togliere la il gattino dalla madre e dai fratellini prima delle 12 settimane. Stando insieme impara lezioni di comportamento e gestione delle emozioni (gestire la frustrazione). Il suo carattere da adulto dipenderà oltre che dalla genetica anche dall’ambiente in cui vive. Il periodo sensibile è tra le 2 e le 7 settimane d’età, durante il quale particolari eventi hanno la maggior probabilità di avere effetti di lunga durata.In questo periodo si formano i rapporti sociali, per questo è importante che i gattini entrino in contatto con esseri umani e altre specie. L’esposizione positiva a stimoli ambientali etc migliorerà le dotazioni interiori dei singoli individui.Sembra invece che in gatti allevati a mano, e quindi svezzati in modo inadeguato vi sia un incidenza di comportamenti aggressivi.Cane: lo stesso vale anche per il cane.I primi 3/4 mesi sono determinanti per il resto della vita. Il cucciolo deve rimanere con la mamma fi no a 60 giorni almeno. Lo sviluppo è suddiviso in fasi, PRENATALE (durante la gestazione), NEONATALE (I-II settimana), Di TRANSIZIONE (III settimana) e di SOCIA-LIZZAZIONE (III/IV settimana alla XII/XIV). La madre insegna la calma e l’autocontrollo, l’inibizione al morso, la gerarchizzazione alimentare. Molto importante è che il cucciolo af-fronti più esperienze positive possibili.
LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE
Nonostante le credenze popolari facciano pensare che la convivenza sia una cosa impossibile tra il cane e il gatto, non è sempre così! Capita, e anche spesso che i due riescano ad andare d’accordo. Se il cane ha un’indole tranquilla sarà il gatto a compiere i primi approcci, mostrandosi dispo-nibile. È raro che il gatto assalga per primo il cane. Conoscere quali sono le rispettive caratteristiche di specie e dei singoli è la base per sapere se una convivenza potrebbe essere possibile o meno.A parte lo scodinzolare, con un signifi cato così diverso tra i due essi sono più simili di quanto si pensa. Per esempio vediamo alcune posizioni tipiche:RILASSATA nel cane e nel gatto ha praticamente le stesse caratteristiche: coda bassa, orec-chie alte, posizione sciolta;GIOCOSA/AMICHEVOLE: coda alta, orecchie alzate;PAURA: piloerezione, orecchie indietro, coda bassa;AGGRESSIVO: orecchie in avanti, attenzione, corpo proteso verso ciò che infastidisce.
Se le osserviamo con attenzione possiamo notare quante similitudini. Ogni postura va valutata nel suo complesso, impariamo che gli animali non si esprimono a parole come noi ma attraverso posture, vocalizzazioni
e movimenti. Le fusa invece sembra che non generino nessun tipo di reazione nel cane.
PRINCIPALI PROBLEMATICHE DI CONVIVENZA
Una delle principali problematiche che possono rendere diffi cile la convivenza dei due animali può essere LA FORTE PULSIONE PREDATORIA del cane, dovuta da: - Impulsi innati; - Un’assenza di “stimoli giusti” che potrebbe sfociare in sti-moli sostitutivi (come il gatto); - La sequenza di inseguimento provoca nel cane auto soddisfacimento e auto rinforzo; - Può manifestarsi anche se la preda è ferma (i cani mordono, giocano, sbattono i peluche). INTRODURRE ALLA CONVIVENZA
CONDIVISIONE delle PRINCIPALI e più IMPORTANTI RISORSE, quali: - TERRITORIO/SPAZIOIl gatto è un animale fortemente territoriale, il fatto che utilizzi anche spazi verti-cali permette che i due trovino il giusto equilibrio. È bene dar modo al gatto e al cane di poter avere degli spazi propri, dove poter stare tranquilli, saranno poi loro stessi a scegliere se interagire o meno.- CIBOI due animali hanno una diversa concezione del cibo, il cane mangia per fame, ap-pagamento (masticare rilassa) e noia; mentre il gatto mangia perché è un compor-tamento puramente funzionale, rifornimento di energie per le sue attività,preferisce ed è meglio che possa fare tanti piccoli pasti. Non è così risaputo ma è meglio che l’acqua sia posizionata lontano dal cibo. (fare attenzione che il cibo del gatto ha un odore molto forte, che piace parecchio ai cani, far in modo che non sia accessibile al cane, e lo stesso vale per la lettiera).Non dimentichiamoci che PREVENIRE è MEGLIO CHE CURARE!!!Vediamo come comportarsi:• Un presupposto che non dovrebbe assolutamente mancare è quello di socializ-zare i due animali fi n da piccoli, con più specie differenti possibile, ambienti e persone..• Essere consapevoli che alcuni soggetti potrebbero anche non farcela mai ad ac-cettare questa convivenza;• Dare al gatto vie di fuga/percorsi alti (dove il gatto possa avere un suo spazio dove rifugiarsi);• L’inserimento deve essere sempre molto graduale, non si deve assolutamente avere fretta di farli convivere a tutti i costi;
62 63
• Non forzarli MAI ad interagire;• Se si hanno dei dubbi meglio chiedere l’aiuto di un esperto prima di arrecare qualche danno ad uno dei due animali;• Prima di un incontro vero e proprio si può far in modo che i due inizino a familiarizzare con l’odore dell’altro, tenendo magari prima il nuovo arrivato in una stanza e l’altro in giro e in seguito scambiarli. • Una volta che questo viene fatto far incontrare i due in sicurezza, attraverso un cancelletto per bambini, o mantenendo il cane al guinzaglio.• Far in modo che il gatto non percepisca il cane come invasore o/e viceversa.
CONSIGLI SULL,’EDUCAZIONE
METODO GENTILE con entrambi, basato sul RINFORZARE i COMPORTAMENTI DE-SIDERATI :- il gatto è molto più indipendente del cane e può essere, solo in parte, addestrato, mentre si più lavorare sulla sua educazione,- Evitare di fare differenze tra i due,- Essere sempre coerenti e agire tutti allo stesso modo.
CONCLUSIONI
Quest’amicizia è davvero POSSIBILE!!! Non da tutti i soggetti potremo aspettarci un rap-porto fantastico tra le due specie, ma con molti, più di quanto si pensa, questo può accadere!Valutare per bene i fattori genetici ed il vissuto. Impariamo ad osservare i nostri amici a 4 zampe, nonostante siano diversi riescono a trovare il loro equilibrio, cerchiamo di imparare da loro!!
...E METODI Di EDUCAZIONE CINOFILA
Con il termine “ETOLOGIA” si intende lo studio del comportamento degli ani-mali.Prima di Darwin l’uomo aveva sempre pensato di essere separato dagli animali e che il comportamento di questi fosse semplicemente dettato dall’istinto, distin-guendo così, in modo radicale, l’uomo come unico essere vivente superiore e ra-zionale.Charles Robert Darwin (1809 – 1882) cambiò il mondo: le sue scoperte furono sconvolgenti. Darwin spiegò l’evoluzione come un susseguirsi di cambiamenti in cui solo gli individui migliori si riproducono, trasmettendo alla prole le caratte-ristiche vincenti. Questa è quella che noi tutti oggi conosciamo come “selezione naturale”.Darwin dedicò un capitolo importante al tema degli istinti naturali, applicando la sua teoria della selezione naturale: anche il comportamento, sostenne, è soggetto alla selezione naturale.Poiché l’evoluzione ci dice che l’uomo è solo una delle tante specie e da esse deri-va, il comportamento animale acquisisce un ruolo sempre più importante nella compren-sione dell’uomo stesso.Dopo Darwin nacquero in Europea e negli Stati Uniti tanti studi etologici. Ciò che è importante rilevare è che si svilupparono
evoluz
ione...STO
RIA,
di Maddalena Hartmann
64 65
differenti metodi per studiare e comprendere il comportamento: alcuni credevano nell’im-portanza dello studio in ambito naturale, come Konrad Lorenz reale fondatore dell’etologia, mentre altri si concentrarono sullo studio degli animali in laboratorio, sottoponendoli a diver-si test per verifi care le risposte e comprendere ogni singolo meccanismo di apprendimento. Ecco che, nel 1900, nasce in Europa la corrente del tropismo e negli Stati Uniti del behavio-rismo detto anche comportamentismo. Secondo questa scuola il comportamento animale si può spiegare come semplici risposte a determinati stimoli: Stimolo e Risposta. Ogni stimolo provoca una risposta, un comportamento.Non è previsto alcun livello cognitivo o di elaborazione mentale, tra lo stimolo e la risposta non si ha pensiero. Gli animali sono come automi che agiscono in modo meccanico; quello che importa veramente per i comportamentisti è giungere ad un’approfondita comprensione empirica e sperimentale delle relazioni tra certi tipi di stimoli e certi tipi di risposte compor-tamentali.
Uno degli assunti principali è il meccanismo del condizionamento, in base al quale l’asso-ciazione ripetuta di uno stimolo, detto stimolo neutro, con una risposta che non è ad esso direttamente correlata, farà sì che, dopo un periodo di tempo, a tale stimolo segua la risposta condizionata.Troviamo, ad esempio, Skinner ed i suoi esperimenti con i ratti da laboratorio e le sue speciali gabbie, dette Skinner Box. Grazie a questo esperimento si scoprì che esiste un meccanismo di apprendimento defi nito “Condizionamento Operante”. I comportamenti cui segue un premio od una ricompensa tendono ad essere ripetuti ed assimilati, quelli cui segue una punizione, al contrario, tendono a diminuire ed a scomparire. Questa è ancora oggi considerata la base del metodo “gentile” per capire alcuni comportamenti dei nostri cani.
Un altro esperimento importante fu quello di Pavlov, scienziato russo (1849-1936), che sco-pri` un meccanismo di apprendimento chiama-to “Condizionamento classico”. Se facciamo un esempio con i nostri cani possiamo vedere come, solamente prendendo le chiavi di casa in mano, essi si alzino perché hanno ormai associato ru-more chiavi = uscita. In principio il solo rumore delle chiavi non ave-va alcun particolare signifi cato per l’animale, ma dopo che, per diverse volte, il rumore veniva se-guito dall’uscita con il proprietario, ecco che il cane associa le due cose per il “Condizionamento classico” scoperto da Pavlov.
In Europa, verso la fi ne degli anni ‘30, si impose sempre piu’ prepotentemente la scuola di pensiero dei cognitivisti; questi grandi scienziati rifi utarono l’approccio di tipo meccanico e meccanicista della scuola americana del Comportamentismo e si concentrarono non solo
sulla comprensione e lo studio dei comportamenti istintivi, ma anche sul-la fi logenesi e sull’ontogenesi del comportamento. La teoria cognitiva pone al centro del suo interesse il soggetto attivo che opera nel mondo,
non grazie a stimoli e apprendimenti, ma sviluppando le proprie capacità mentali. Il cognitivismo considera la men-te umana come un elaboratore di informazioni provenienti dall’am-biente.Il principale oggetto di studi del cognitivismo è, quindi, la mente come sistema complesso di regole, indipendente dai fattori biologici, sociali, culturali, emozionali etc.il Cognitivismo è fortemente inte-ressato ai processi mentali, tanto da affermare che un cambiamento a livello comportamentale è sem-pre connesso e spiegabile in base a un cambiamento a livello cognitivo; l’appren-dimento non consisterebbe, quindi, nel semplice trasferimento dell’informazione esterna all’interno, ma sarebbe piuttosto il risultato di una sua complessa trasfor-mazione a livello cognitivo.Ad affi ancamento ed a completamento del cognitivismo alla fi ne degli anni Ot-tanta, in Europa e negli Stati Uniti, prende avvio una nuova disciplina: la zooan-tropologia che ha come obiettivo di ricerca l’interazione fra l’uomo e l’animale. il presupposto di tale disciplina è che gran parte delle espressioni culturali dell’uo-mo abbiano origine da un processo di ibridazione con l’animale, ovviamente non biologica, derivante dall’interazione della coppia e non più esclusivamente frutto dell’uomo.
Solamente sul fi nire del secolo scorso si cominciò ad intuire che elementi teorici tratti dalla psicologia potevano dimostrarsi utili per sviluppare le varie tecniche di addestramento. Attraverso lo studio sul comportamento non istintivo si rivelava più facile l’apprendimento nel cane. Fino a quel momento non si era mai parlato di psicologia canina, in quanto la chiesa non lo riteneva possibile, solo per il fatto che il cane non possiede un’anima.
Oggi, la psicologia canina è entrata a far parte del bagaglio culturale della cinofi lia moderna.Dipende soprattutto dall’uomo comprendere il cane ed il suo comporta-mento, scegliendo di conseguenza le tecniche più adatte alla riuscita dell’educa-zione. Sarà necessario imparare a conoscere il cane eliminando la tentazione di renderlo simile all’uomo nel suo comportamento, evitare di antropomorfi zzarlo quindi, e sarà soprattutto necessario imparare a ragionare da cane, provando a im-
66 67
medesimarci in una specie diversa. Molte persone credono che per educare un cane sia necessario punirlo, sottometterlo o ren-derlo meno “spontaneo”, ma questo era appannaggio di vecchi modelli di training, venuti alla luce con l’addestramento del cane per la guer-ra. Questi metodi oggi purtroppo sono ancora utilizzati da vecchi educatori che ritrovano nel metodo coercitivo, defi nito “classico”, il meto-do piu’ effi cace e valido per educare un cane.In realtà gli studi effettuati hanno dimostrato che la collaborazione è lo strumento migliore per poter convivere serenamente con il nostro amico a quattro zampe. Da questa convinzione di partenza e attraverso gli studi behaviouristi-ci nasce infatti l’educazione “gentile”.
Il metodo gentile si basa sulla motivazione in-nata in qualsiasi essere vivente di conservare, far propri e mantenere nel tempo solo i comportamenti che garantiscono un vantaggio, una soddisfazione. In altre parole un premio, un benefi cio. Nell’educazione del cane il metodo gentile, a differenza del metodo classico coercitivo che si fonda sul principio della paura e della punizione, utilizza come strumento principale il premio sotto forma di cibo, attenzione o gioco (rinforzo positivo) ad emissione del comportamento gradito, tendendo ad ignorare le risposte scorrette.Con il metodo gentile il cane è lasciato libero di interagire con l’ambiente e con l’uomo; il conduttore premia, quindi rinforza, i comportamenti graditi e ignora quelli neutri o sgraditi: il cane impara così a discriminare gli uni dagli altri e si motiva nel tempo ad esibire solo quelli vantaggiosi.Queste tecniche non hanno però mai soppiantato i metodi coercitivi. Strumenti come il collare elettrico e il collare a punte fortunatamente vengono sempre meno utilizzati, ma si fa ancora largo uso di metodi tradizionali, come lo strattone e il collare a strangolo; si continua a punire il cane perché non esegue l’esercizio richiesto, o non lo esegue nel modo richiesto. Il cane DEVE obbedire!Fortunatamente c’è chi rifi uta ogni forma di coercizione. Le tecniche “gentili” fanno leva sulla motivazione, sulla collaborazione e soprattutto sulla comprensione del comportamento e dei meccanismi di apprendimento.
Si parla di educazione “gentile” perché non si costringe il cane a obbedire, e non lo si sgrida se disobbedisce. L’addestramento non avviene secondo una fi losofi a di “io comando/tu ob-bedisci”, ma attraverso la comunicazione con il cane, la comprensione, la collaborazione.Nei metodi tradizionali il cane deve obbedire a un comando, nel metodo gentile il cane è sempre libero di scegliere cosa fare! L’unico strumento usato nell’educazione gentile è la capacita’ del cane di associare.
Il cane impara ad associare il proprio comportamento a un rinforzo po-sitivo (qualcosa che al cane piace, che il cane vuole ottenere), e quindi a uno stimolo condizionato. Ad esempio il cane impara che sedersi gli
permette di ottenere la pallina o di uscire di casa o un boccone.Inoltre il metodo gentile permette di lavorare su tutti gli esercizi; anzi, con il meto-di gentile potete lavorare anche ad esercizi che non potreste proprio costruire con i metodi tradizionali, come toccare un oggetto con il naso, o mostrare la lingua a comando!
Vi permette anche di lavorare in situazioni particolari: a distanza, con il cane libe-ro, con un cane aggressivo o pauroso, che reagisce al contatto fi sico e alla pressio-ne psicologica. Con il metodo gentile infatti non c’è manipolazione, non c’è pres-sione. Il cane è sempre libero di scegliere: sta a te fare in modo che scelga proprio il comportamento che vuoi ottenere.
Con i metodi gentili si possono correggere anche i comportamenti sbagliati. Quello che si deve fare è insegnargli che quel comportamento non funziona: non gli permette di ottenere quello che vuole. Se tira al guinzaglio, non riesce ad arri-vare dove vuole. Se salta addosso, non ottiene la pallina o la tua attenzione. Inoltre si può anche insegnare al cane che c’è un altro comportamento (o più di uno) che funziona meglio, possiamo insegnargli delle attività alternative.
Il metodo gentile fa leva sui meccanismi di condizionamento classico e condizio-namento operante utilizzando il concetto di rinforzo positivo e punizione negativa.Negli ultimi anni le nuove teorie del cognitivismo sono approdate anche nella cultura cinofi la e attraverso una visione zooantropologica della relazione uomo-animale hanno sviluppato nuovi metodi di educazione.
L’approccio cognitivo-zooantropologico (CZ) si discosta non soltanto dall’adde-stramento tradizionale, basato su coercizioni e punizioni, ma anche dal metodo gentile, basato sul rinforzo positivo. Anche il metodo CZ è “gentile” perché non utilizza coercizioni e rispetta le caratteristiche etologiche del cane, ma va oltre perché si rivolge alla mente del cane, alle sue capacità di apprendimento ed allo sviluppo del suo potenziale cognitivo; il fi ne dell’educazione è sviluppare la mente del cane per realizzare in pieno tutte le sue potenzialità. In questo contesto la rela-zione cane-proprietario è alla base del processo pedagogico, in quanto il proprieta-rio si pone come mediatore di conoscenze.
La cinofi lia tradizionale “non coercitiva” punta a creare un bagaglio di segnali (o comandi) resi noti al cane attraverso un training progressivo e a disposizione del proprietario in tutte quelle situazioni in cui il proprietario abbia bisogno di dire al cane cosa fare, ovvero abbia bisogno di tenerlo “sotto controllo”. Nell’approccio
68 69
cognitivo-zooantropologico c’è la cura della relazione con il proprietario, c’è un enorme la-voro di accreditamento, di acquisizione della fi ducia del cane da parte del proprietario e della sviluppo della sua voglia di lavorare insieme, di fare delle attività insieme.
Il proprietario non ha bisogno di condizionare il cane per avere una risposta affi dabile perché l’affi dabilità sarà data dalla volontà spontanea del cane di seguire le indicazioni della sua guida, il suo proprietario.L’obiettivo principale nel rapporto con il proprio cane è quindi diventare una “base sicura” per lui, far si’ che possa aver fi ducia in noi. Ricordiamoci sempre che cani capiscono molto più facilmente i concetti di “sicuro” o “peri-coloso” piuttosto che di giusto o sbagliato!
Forse perchè è considerato ormai da millenni il miglior amico dell’uomo, oggi il cane è dato sempre più per scontato.Ma poniamoci una domanda: questo animale, che si è dimostrato cosi versatile, imparando a svolgere per noi innumerevoli compiti e ad essere un buon compagno di vita, riuscirà ora a reinventarsi per tenere il passo con una società moderna in continua trasformazione come la nostra? Sicuramente ci riuscirà, ma avrà bisogno del nostro aiuto. Cane e uomo sono da sempre andati d’amore e d’accordo, nonostante una limitata comprensione reciproca, ma adesso sta a noi ad assumerci la responsabilità, per poter garantire a questo legame un futuro soddisfacente e impegnandoci a migliorare la relazione e la comprensione fra noi ed il cane. Solo cosi facendo, l’uomo e il cane continueranno a conviere armoniosamente insieme.“Il lupo nel tuo salotto”: è un immagine potente per ricordare all’uomo che il proprio cane è sotto sotto un animale e non una persona.Ma il cane è un lupo? Stando al loro DNA si, infatti il 99,96 per cento dei geni è in comune tra le due specie. Seguendo questa logica si potrebbe asserire che anche i lupi sono cani, ma nessuno lo fa. I lupi sono sempre stati rappresentati come selvaggi, ancestrali, primitivi, mentre invece il ruolo dei cani, è quello di sottoprodotti artifi ciali del lupo.Molti articoli e programmi televisivi sul comportamento del cane, sostengono che comprendere il lupo è la chiave per capire il cane domestico, ma in realtà non è esattamente cosi. Biologicamente è cosi, ma dal punto di vista comportamentale e morfologico se ne differenzia notevolmente. La chiave per capire il cane domestico è prima di tutto capire il cane domestico, ed è un punto di vista che ormai molti scienziati in tutto il mondo sostiene.
Gerarc
hia
e domina
nza
di Alessandra Ceretto
70 71
Non si può negare che il cane condivide molte caratteristiche di base con gli altri membri della famiglia dei canidi, alla quale appartiene anche il lupo.I cani si sono evoluti dai loro antenati canidi e da loro hanno preso la struttura anatomica, l’olfatto, la capacità di riporto e di formare legami duraturi, ma non è corretto prendere come unico punto di riferimento il lupo.La natura del branco è fondamentale per capire il comportamento sociale del lupo e quindi l’eredità che hanno lasciato al cane domestico, ma si pensava, fi no a poco tempo fa, che fosse un’organizzazione fondata sulla competizione. Ma ora sappiamo che non è cosi, sappiamo che per la maggior parte si tratta di gruppi familiari.I branchi che nascono in natura, allo stato brado, sono entità armoniose, dove l’aggressività è un eccezione. All’inizio i biologi si basavano sullo studio dei branchi in cattività, sicuramente più facili da osservare, ma il comportamento osservato non era armonioso.
Oggi, il concetto di “dominanza” per spiegare il comportamento del cane domestico, è ormai sorpassato.L’idea più dannosa che modella le tecniche di addestramento moderne è che i cani sono spinti a stabilire una gerarchia di dominanza, ovunque si trovino. Questa idea, purtroppo, ha stravolto la prospettiva sulle loro relazioni sociali, sia fra cani di una stessa casa che con i proprietari.Tra la fi ne degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90 si era convinti che ogni sintomo di problema comportamentale del cane, stesse ad indicare che stava diventando dominante. Nei libri di allora sul training e purtroppo anche su alcuni di oggi, si afferma che i proprietari, per evitare
che il cane diventi dominante, devono essere il soggetto Alfa del branco.E’ corretto discutere su come si comportano i lupi e fare il paragone con il comportamento del cane, ma noi umani in quale posizione ci
collochiamo? Secondo la “legge del branco” noi ci inseriamo a fi anco del cane. Le regole del branco si basano sul comportamento e sul modo di comunicare fra cani, quindi noi in questo ruolo abbiamo ben poco a che fare.Sfortunatamente molte volte ci si basa sull’idea che i cani vedano tutto in termini di status soprattutto per interpretare i rapporti con il padrone. Secondo l’opinione diffusa, il cane lo percepisce come un altro membro del branco, e quindi come un ostacolo alla costruzione dello status.L’idea che i cani sotto sotto siano dei lupi, purtroppo pervade ancora l’addestramento, nonostante sia stata ormai abbandonata dalla comunità scientifi ca e veterinaria e da un numero sempre più crescente di addestratori.La domesticazione ha portato, comunque, il cane a differenziarsi dal lupo e non solo a livello morfologico, ma anche dal punto di vista comportamentale e sociale. Quindi, per comprendere il cane domestico, dovremmo studiare il cane domestico e non il lupo.Il mito del branco ha avuto risvolti applicativi nell’educazione e nell’addestramento del cane contribuendo cosi alla diffusione di dogmi privi di fondamento scientifi co. Ecco che la dominanza viene chiamata in causa per spiegare qualsiasi tipo di problema, dalla disobbedienza ai problemi comportamentali di qualsiasi genere.Il rapporto tra uomo e cane però, ha ben poco se non nulla a che fare con la dominanza.Il cane, pur discendendo dal lupo, è una specie differente e dobbiamo trattarlo come un cane e non come un lupo travestito da cane. Il cane non vuole diventare dominante ed elevare il proprio status nel “branco” umano perchè non ne fa parte. Ma nemmeno noi dobbiamo cercare di dominare il cane usando le regole del branco, in quanto il cane non capirà cosa cerchiamo di dirgli.Dobbiamo essere proprietari responsabili nel gestire il cane e modellare il suo comportamento attraverso la socializzazione e il training, in modo che possa vivere in armonia con noi.Saper costruire una corretta relazione con il nostro cane è fondamentale, e questo è attuabile solo se condividiamo con lui la nostra vita, le sfi de di ogni giorno; la relazione è dialogo, collaborazione, momenti di incontro e confronto e va costruita giorno dopo giorno, sulla base del rispetto e non sulla coercizione e l’ imposizione.
Bibliografi a“La naturale superiorità del cane sull’uomo” di John Bradshaw Rizzoli 2010
72 73
Alcuni brevi cenni agli studi sull’Arousal in psicologia umana, ci permettono di comprendere concetti e defi nizioni basilari per arrivare subito al fulcro del nostro interesse, il cane.Infatti ciò che i manuali di psicologia umana defi niscono come Arousal , trova esatto corrispettivo per i nostri cani.Nell’uomo è uno Stato fi siologico e psicologico di vigilanza e reattività agli sti-moli. Implica una serie di modifi cazioni corporee: attivazione del sistema nervoso ed endocrino, e di quello reticolare nel cervello, con conseguente• aumento del battito cardiaco e pressione arteriosa • messa in circolo nell’organismo di numerose sostanze, come DOPAMINA e SE-ROTONINATutto ciò dispone ad una condizione di: ALLERTA, PRONTEZZA SENSORIA-LE e ATTIVAZIONE.Il livello di attivazione psico-fi siologica è considerato fattore di grande importanza nell’effi cienza del soggetto in compiti o prestazioni
La relazione tra livello di attivazione “AROUSAL” ed EFFICIENZA del soggetto, ci dice che: • Con livelli BASSI di attivazione
- l’individuo si distrae facilmente- perdita dell’attenzione
AROUSA
l e
APPREN
DIMENT
O
di Valentina Dell’Orto
74 75
Con livelli TROPPO ELEVATI di attivazione - eccessiva ansietà, aumento dell’esplorazione- conseguente disorganizzazione del comportamento.Come infatti vedremo nel cane, l’apprendimento e l’effi cienza del soggetto vanno di pari pas-so con un livello INTERMEDIO di attivazione. Nel cane l’ AROUSAL è il livello di attivazione emozionale, parametro fondamentale stret-tamente correlato alle altre componenti cosiddette “posizionali” del cane: le MOTIVAZIONI e le EMOZIONI.
In pratica, questa interrelazione, ci dice come il nostro cane si cala nella realtà: • CHE COSA è più portato a fare • COME REAGISCE a situazioni ed eventi esterni • COME SI RELAZIONA con noi e con gli altri partner sociali.
Ogni individuo, sia in quanto tale e unico, sulla scorta della sua storia personale, sia in quanto geneticamente determinato dall’appartenenza ad una razza e dall’eredità parentale, avrà una peculiare articolazione e prevalenza di Motivazioni, Emozioni ed Arousal. Ipotizzando un percorso pedagogico, sarà quindi compito del trainer, dell’educatore, discipli-nare ed equilibrare le modalità e i livelli di espressione di queste strutture, in modo da favorire il benessere del cane e di conseguenza porre le condizioni ideali per l’apprendimento. Infatti, perché il cane possa apprendere nel migliore dei modi, il livello di Arousal dev’essere intermedio, corrispondere cioè allo “stato di calma”. Ad un arousal troppo alto o troppo basso, si collegano invece stati alterati del cane che osta-colano l’apprendimento.Vi sono specifi ci modi e attività che l’educatore e tutti noi proprietari, possiamo mettere in atto per innalzare o viceversa, abbassare, l’arousal nei nostri cani.In sede di training quindi risulta di fondamentale aiuto lavorare sulla CALMA e l’AUTO-CONTROLLO, tenendo presente che un soggetto facilmente eccitabile non può essere co-stretto in una situazione di calma, ma che vi va “traghettato” gradualmente. Un rapido excursus di alcuni gruppi di razze, ci permetterà di capire la tendenziale prevalenza di determinate motivazioni e livelli di arousal in ciascuno di essi.
Grazie al giusto mix di attenzione verso l’esterno e concentrazione, è possibile raggiungere quello “stato di calma” che appunto corrisponde ad un livello di attivazione medio e che risul-ta ottimale per l’apprendimento.Vi sono numerosi esercizi, attività e discipline non competitive adatte a tutti i cani, che predi-spongono proprio a questo “stato di calma”. Possiamo ad esempio parlare di semplici giochi “rebus” come il “Doggy Zen”, o di Mobility Dog, dove il superamento di alcuni attrezzi/ostacoli rappresenta una palestra di vita per il no-stro cane, aiutandolo ad acquisire sicurezza e a superare le sue paure……..e....... soprattutto
di Attivazione Mentale, la quale riveste un ruolo fondamentale all’inter-no di quella che il comportamentalista francese J. Dehasse ideò come “ FORMULA ATTIVITA’ ”.
Partendo da un adattamento della “ PIRAMIDE dei BISOGNI “ di Maslow dall’uo-mo al cane, Dehasse comprese come, all’interno di tutti i bisogni, le motivazioni e le attività che il cane è spinto a soddisfare e perseguire, l’attività intellettuale avesse un peso di 10 volte le altre.In questo modo ci ha fornito idee e strumenti effi caci per soddisfare appieno le ne-cessità del nostro compagno, aiutandolo nel raggiungimento del benessere psico-fi sico.
BIBLIOGRAFIAPer la parte di Psicologia umana:“Dizionario di Psicologia Cognitiva”- a cura di M.W.Eysenck- Wikipedia“Arousal and Performance”- articolo inglese di psicopedagogia
Per la parte cinofi la:“Pedagogia cinofi la”- di R. Marchesini- 2007 Esercizi pratici di L. SpennacchioCenni dal Manuale di “MobilityDog” - di L. Spennacchio -Stralci dalla Tesi di laurea della Dott.ssa Elena Botti: “Relazione uomo-cane: prospettive di ricerca per una migliore qualità della vita”. “Il mio cane è felice?”- di J. Dehasse-
76 77
Da circa 400 mila anni, cani e uomini hanno unito il loro percorso evolutivo permettendo la nascita e lo sviluppo della società umana così come la conosciamo oggi e la comparsa delle innumerevoli razze canine che possiamo osservare.Infatti, quasi tutte le razze che oggi abbiamo altro non sono che una selezione, consapevole o inconsapevole, di soggetti particolarmente portati ad esegurire un determinato lavoro, sia esso di caccia, di guardia, di conduzione bestiame o sem-plice compagnia.
GLI SPO
RT
CINOFIL
I
di Cristian Salvaterra
78 79
Quando portiamo nelle nostre case un cane di razza, troppo spesso dimentichiamo che esso è stato selezionato per uno scopo specifi co, che vorrebbe esprimere comportamenti che gli sono negati dal contesto o dal proprietario, per cui la comparsa di problemi legati a questa impossibilità è molto frequente.Per poter ancora far fare ai cani moderni quelle attività che in passato erano il loro lavoro, l’uomo ha inventato gli sport cinofi li, che ricreano in modo più o meno realistico i compiti originali.Il mondo degli sport cinofi li è molto ampio e variegato e, purtroppo, non molto conosciuto.I grandi numeri delle attività cinofi le si hanno sulle esposizioni di bellezza, che , con poco sforzo, portano a risultati sul piano economico per gli allevatori. Altro settore che è molto praticato nel mondo della cinofi lia è quello della caccia, ma in questo caso il “protagonista” non è il cane o la coppia uomo-cane, ma solo il cacciatore, che “usa” il cane per scovare o riportare prede abbattute, il che non si può defi nire propriamente uno sport cinofi lo. Attività che invece ricreano la caccia in modo ludico e non cruento sono presenti, ma poco diffuse in Italia, come Tana e Ludotana, Huntering, Coursing.
Ma quali problemi incontra un proprie-tario che vuole praticare uno sport cino-fi lo? Innanzitutto, il fatto che decida di farlo può essere dato da una sua esperienza con un corso di educazione base o avanzata, durante la quale ha scoperto che fare at-tività col proprio cane è divertente ed appagante per entrambi, infatti è molto diffi cile che si arrivi alla pratica di uno sport cinofi lo senza essere prima passa-ti attraverso questo percorso. In questo modo però si possono sfrut-tare il consiglio e la guida di un istrut-tore cinofi lo che sono molto impor-tanti, sia nella scelta dello sport che
nella pratica. La scelta infatti non può comprendere tutti gli sport presenti, il fatto, ad esempio, di avere un Border Collie piuttosto
che un Rottweiler restringono la scelta a sport più indicati per la razza.
Alcuni sport possono essere praticati da chiunque, come l’ Obedience, la Rally Obedience o la Dog Dance, mentre altri sono preclusi a razze non appropriate per evidenti limiti fi sici e comportamentali.
Ma quali problemi incontra un proprie-tario che vuole praticare uno sport cino-fi lo?Innanzitutto, il fatto che decida di farlo può essere dato da una sua esperienza con un corso di educazione base o avanzata, durante la quale ha scoperto che fare at-tività col proprio cane è divertente ed appagante per entrambi, infatti è molto diffi cile che si arrivi alla pratica di uno sport cinofi lo senza essere prima passa-ti attraverso questo percorso. In questo modo però si possono sfrut-tare il consiglio e la guida di un istrut-tore cinofi lo che sono molto impor-tanti, sia nella scelta dello sport che
nella pratica. La scelta infatti non può comprendere tutti gli sport presenti, il fatto, ad esempio, di avere un Border Collie piuttosto
Infatti se un Carlino può raggiungere discreti risultati nella Rally Obe-dience, lo stesso non si potrebbe dire se praticasse Utilità e difesa. Così come gli sport invernali, ad esempio lo sleddog, che sono quasi esclusiva
dei cani Nordici o incroci di cani nordici e da caccia, la cui pratica con cani diversi è inappropriata o addirittura impossibile. Nella scelta dello sport cinofi lo va poi tenuto in considerazione il proprietario, le sue attitudini, il suo stato fi sico. Una signora anziana non molto attiva, in coppia con un Border collie potrebbe pra-ticare con più soddisfazione Obedience piuttosto che Agility, in quanto quest’ulti-mo richiede uno sforzo fi sico non indifferente anche da parte del conduttore.
Ci sono poi sport la cui pratica richiede la consulenza di un buon istruttore, in quanto comprendono, oltre ad esercizi di obbedienza e ricerca, anche componenti di attacco fi sico verso sconosciuti minacciosi, come Utilità e difesa e Mondioring, dove la violenza e l’autocontrollo sono fattori molto importanti e in questi casi il fai-da te può essere addirittura pericoloso. Di solito questi sport vengono praticati da persone con cani dalla fi sicità piut-tosto importante, come Pastori tedeschi, Rottweiler, Dobermann, nel cui DNA è presente una componente di violenza che, con la pratica frequente, può portare a derive comportamentali pericolose e incontrollabili. Infatti è molto facile convin-cere queste razze a mordere un manicotto o inseguire una persona, più diffi cile è incanalare questo comportamento in un ambito ludico e contestualizzato all’atti-vità stessa.
Un autodidatta sarebbe in grado di garantire che il proprio cane non attacchi sconosciuti per strada causando pericolo? In questo caso, come già detto, un buon supporto tecnico può fare la differenza.Nella scelta dello sport va tenuto in considerazione anche lo stato di salute del cane, in quanto non è appropriato che cani anziani o con problemi alle articolazioni svolgano attività troppo fi siche, come disc-dog o agility, con salti che potrebbero nuocere alla sua salute in modo molto evidente.La pratica di alcune attività può aiutare a risolvere alcuni piccoli problemi com-portamentali, in quanto, a volte, questi sono causati dall’inattività o dalla semplice noia. Ciò potrebbe essere utile a scaricare le energie in eccesso e ad insegnare un po’ di disciplina, distraendo il nostro compagno dalla solita routine quotidiana.
L’altro lato della medaglia nella pratica degli sport cinofi li ad alto livello potrebbe essere rappresentata dalla eccessiva “voglia” del conduttore nel vincere compe-tizioni per dimostrare di essere il migliore, cosa che invece non interessa ai cani. Questo potrebbe spingere il proprietario a focalizzare tutto il tempo dedicato al proprio compagno all’allenamento ed al perfezionamento nell’esecuzione degli
80 81
esercizi rendendo il cane un campione, ma forse trascurando aspetti dell a relazione più im-portanti, come il gioco, la socialità con altri soggetti, trasformandolo in un “atleta” che da il meglio di se solo durante le gare, ma che, a conti fatti, nella gestione quotidiana è un susse-guirsi di problemi.In questo ambito, come in tutte le cose, ci vuole equilibrio e buon senso, innanzitutto va garantito il benessere del nostro amico a quattro zampe, non va forzato a fare cose a lui non gradite, lo sport deve diventare un momento da passare insieme, magari vincendo delle gare, ma sempre divertendosi. Questi sport possono essere degnamente sostituiti da altre attività altrettanto appaganti e meno impegnative, come il semplice gioco. Il lancio di una pallina o del freesbe sono un buon diver-sivo dalla semplice passeggiata, così come piccoli salti, la ricerca di oggetti nascosti magari in casa od in giardino, il trekking o l’insegnamento degli esercizi di base, che oltre ad essere utili aumentano l’autostima del cane.Tutte queste attività possono essere eseguite da chiunque e con l’aiuto di un educatore qualifi -cato e responsabile si possono imparare delle semplici regole che durante il gioco andrebbero rispettate, si possono imparare nuovi giochi che renderanno la relazione col proprio amico cane migliore e speciale, un cane che gioca infatti, è un cane felice, visto che il gioco non può essere imposto o forzato in nessun modo. Il Disc Dog è la più spettacolare e “fricchettona” delle discipline sportive in ambi-
to cinofi lo, difatti la nascita di questo incredibile e coinvolgente sport avviene per capriccio, “freak”, come dicono gli americani.
Negli anni 70 il giovane intraprendente universitario dell’Ohio Alex Stein e il suo inseparabile whippet Ashley invadono il Dodger Stadium a Los Angeles durante la diretta televisiva nazionale della partita di baseball Dodgers e Cincinnati Reds.
La “leggenda” vuole che per ben 8 minuti in diretta televisiva nazionale Alex e Ashley improvvisarono il loro show. Con lanci spettacolari, formidabili prese al volo dei dischi ad un’altezza di oltre due metri ed a una velocità di circa 60 km/h dell’atletico levriero, conquistarono il pubblico coinvolgendo addirittura il com-mentatore della partita che fece la telecronaca di tutta l’esibizione. Alex fu allonta-nato e arrestato, ma ormai il DiscDog era sotto gli occhi di tutti.
Nei mesi che seguirono i due amici furono invitati a numerosi programmi televi-sivi per spiegare questa nuova e affascinante disciplina, ottenendo addirittura di aprire il XII Super Bowl con una nuova esibizione. Così nacque uffi cialmente il DiscDog. Da allora sono nate molte “federazioni” UFO, SkyHoundz, AWI, USDDN ed ul-tima nel 2007 la FIDD (Federazione Italiana Disc Dog), ognuna con i suoi rego-lamenti.
Ai giorni nostri con il termine DiscDog si intende un insieme di attività che utiliz-
DISC DO
G
di Christian Stella
82 83
zano i dischi. Dal Distance/Accuracy dove lo scopo è lanciare il disco più lontano possibile, facendolo prendere al volo dal cane, al DartBee, dove dopo aver preso il disco, il cane dovrà atterrare con le zampe anteriori in diversi settori concentrici, ma sicuramente la disciplina più affascinante e famosa è il Freestyle, dove il binomio deve esibirsi in fi gure acrobatiche su basi musicali.
Link utiliwww.discdogitalia.itwww.petpassion.tv/webserie/show/lezioni-di-disc-dog/55www.usddn.comwww.skyhoundz.com
Come noi umani, i cani si orientano anzitutto con la vista, in aggiunta, si affi dano in larga misura al loro sofi sticato olfatto. Di solito però l’olfatto non è il primo sen-so scelto dal cane affamato in cerca di cibo: il cibo più economico è quello più vici-no, ossia individuabile con la vista. Se non c’è niente di commestibile ben in vista, allora il cane cerca di ascoltare se sente il rumore della potenziale preda. Solo se nessuno di questi due sensi gli è di aiuto per procurarsi il pasto, il cane mette in moto l’olfatto. Innanzitutto annusa il vento in cerca di qualche informazione utile, ma se neanche questo serve, mette il naso a terra in cerca di una traccia. I cani vivono in un mondo fatto di odori, mentre gli esseri umani sono immersi in un mondo di immagini. Noi il mondo lo vediamo, loro lo fi utano. Dire che il cane vive con il naso e per il naso, non è certo un’affermazione molto distante dalla realtà. Infatti il cane è praticamente costruito in modo da sfruttare al massimo questo senso. Perfi no il suo cervello si è evoluto in modo da elaborare e decodifi care per-fettamente gli stimoli recepiti.Nei cani la porzione di cervello riservata all’olfatto è quattro volte più estesa e complessa di quella umana. Secondo i ricercatori, il naso di un cane contiene quasi 220 milioni di cellule ol-fattive, una quantità in grado di coprire all’incirca la superfi cie di un fazzoletto. L’uomo, per contro, ne possiede solo 5 milioni, l’equivalente di un francobollo. Il cane può fi utare una pista lasciata anche più di 300 ore prima. E’ noto che alcuni Bracchi, individuata una traccia, sono in grado di seguirla per 210 km.I cani amano moltissimo annusare, che si tratti di una traccia odorosa nell’erba, di un nuovo oggetto, della testa o del posteriore di un loro simile. Questo perché sono
NOSE W
ORK
dal gio
co al
lavoro
di Mirela Lipkowska
84 85
in grado di distinguere gli odori a livelli che noi possiamo solo immaginare. Annusando un ciuffo d’erba non solo sanno riconoscere quali altri animali vivono nella zona, ma sono anche in grado di dedurne l’età, il sesso, lo stato di salute e da quanto tempo sono passati di lì. Il ricordo di un odore dura una vita intera e può infl uenzare quasi completamente il suo com-portamento.La capacità del cane di annusare il mondo che lo circonda e di interpretare questi odori dipen-de da un complicato sistema chimico-sensoriale. In primo luogo esso possiede narici mobili che lo aiutano a determinare la direzione dell’odore. In secondo luogo è dotato di fi uto, quella meravigliosa capacità di disgregare l’aria con un modello regolare di respirazione che appare strutturato in una serie di tre-sette sniffate.
FIUTO e OLFATTO – due termini che vengono spesso usati come sinonimi per indicare la stessa funzione, ma in realtà ne indicano due diverse. L’olfatto è la capacità di saper intercet-tare e discernere emanazioni odorose disperse nell’aria.Questo tipo di lavoro si chiama TELEOLFATTO. Per fi uto si intende la capacità di saper intercettare e discernere emanazioni odorose provenienti da terra. Questo si chiama MEGA-OLFATTO. I cani a teleolfatto intercettano nell’aria le particelle olfattive come se usassero un telescopio, i cani a megaolfatto scrutano a terra le particelle olfattive come se usassero un microscopio.L’uomo ha cercato di sfruttare l’olfatto del cane in tutti i modi possibili, dato che in certe at-tività nessun strumento è riuscito fi nora ad eguagliarlo. Prima tra tutte: la ricerca di persone scomparse, intesa come ricerca sia in superfi cie che in profondità (cioè sotto cumuli di neve o macerie). In questo tipo di lavoro, vengono utilizzati entrambi i metodi di ricerca, sia a te-leolfatto che a megaolfatto.L’addestramento dei cani da ricerca si estende a varie specializzazioni: ricerca dei dispersi in superfi cie, nei boschi, sotto le macerie o neve, annegati, vittime di esplosioni o incendi deva-stanti e corpi sepolti. Attualmente i cani da ricerca sono il miglior strumento conosciuto per questo lavoro, spiacevole ma necessario.Con il fi uto, sono in grado di analizzare campioni di aria prelevati da strade, container o automobili e segnalare se, nel posto da cui sono stati prelevati i campioni, ci sono esplosivi, droghe, mine, avorio o altre cose. Le persone allergiche possono addestrare il loro cane a controllare se il cibo è privo di sostan-ze per loro pericolose.Ci sono cani che riescono a fi utare l’arrivo di una crisi in persone epilettiche e ad avvertirle con minuti di anticipo, abbaiando o guaiendo: in tal modo riescono a proteggere il padrone da incidenti o ferite concomitanti all’attacco epilettico. Prima della crisi, l’organismo del paziente subisce dei cambiamenti chimici ed ormonali che modifi cano un odore che il cane riconosce.Ci sono cani addestrati a riconoscere, annusando l’urina dei pazienti, il cancro alla vescica, a riconoscere il cancro al polmone dall’aria espirata ed altri ancora che sanno riconoscere un melanoma maligno con una precisione e rapidità superiore a quella di uno specialista onco-logo.
MECCANISMI DI APPRENDIMENTO NEL LAVORO IN PISTALa prima pista, la prima ricerca delle persone, di animaletti o di funghi
sono le esperienze più importanti nella vita del cane. Il modo in cui il cane esegue il compito la prima volta sarà il metodo che sceglierà nella vita quando incontrerà problemi in situazioni simili, non importa quanti mesi o anni di addestramento siano passati.
CERCARE I BOCCONCINIUn ottimo esercizio propedeutico per cominciare il training è la ricerca del cibo, perché abitua a cercare con entusiasmo e precisione. Questo gioco è per tutti, gran-di e piccoli e si fa in casa, in giardino, al parco, nei campi o nei boschi. Senza che il cane ci veda, nascondiamo dei bocconcini di diverse dimensioni e la-sciamo che lui usi il fi uto per ritrovarli; deve cercare da solo, senza il nostro aiuto. Per molti cani è di grande soddisfazione cercare e trovare il cibo. Una volta im-parato il gioco, potranno impegnarsi in un’area anche più ampia. Alla fi ne il cane starà disteso e tranquillo perché una sessione di ricerca di bocconcini è di gran lunga più stimolante di una di jogging o obedience.
CERCARE GLI OGGETTIUn gioco molto simile alla ricerca dei bocconcini è la ricerca degli oggetti. Occor-re trovare qualcosa a cui il cane sia molto interessato e affezionato, un oggetto che gli piaccia molto tenere in bocca. Questo, deve essere per lui il “tesoro” che noi nasconderemo e che lui dovrà andare a cercare e sarà poi entusiasta di trovare; in ciò consiste la sua gratifi cazione. Non è importante che ci riporti il gioco, ma che lo cerchi e lo trovi usando il naso.
LE PISTEUna pista è un impatto sul terreno lasciato da qualcuno o qualcosa che si è spostato.Tutto ciò che si muove lascia una traccia, che sia una persona, una bici, un topo o un insetto. Non tutte le tracce, cioè i segni di tale impatto, sono visibili ai nostri occhi, ma questo non signifi ca che non ci siano. La vegetazione viene schiacciata, gli insetti o gli altri piccoli animali rimangono uccisi o feriti, il terreno stesso viene compresso e rilascia il gas contenuto nelle sacche sotto terra. Di solito non siamo in grado di sentire l’odore proveniente dai nostri passi, i cani invece ci riescono.
Sono tre i tipi di odore che il cane usa quando segue una pista:• Terreno calpestato e disturbatoIn una pista fresca, fi no a due ore, l’odore di terreno disturbato è molto forte. Le parti rotte delle piante ricrescono, gli insetti morti vengono mangiati e il gas che fuoriesce dalle sacche nel terreno scompare.• Odore delle specie
86 87
E’ quella parte della traccia che trattiene le informazioni di quale specie sia passata di lì. Era un essere umano, una bici, una gallina o un cane? L’odore delle specie è dato dalle molecole che perdiamo mentre ci muoviamo.• Odore degli individuiOgni singolo individuo ha il suo odore particolare, simile alle impronte digitali. Oltre a sapere che la pista è quella di un suo simile, il cane è in grado di leggerne età, sesso, stato (calore), salute, ecc…
Due metodi per fare le prime pisteTutti i cani sono in grado di seguire una pista, è una capacità innata..• Per la prima pista di un cane, giovane o anziano che sia, leghiamo un bocconcino gustoso(un wrstel, un pezzo di carne o di formaggio) ad una corda e lo trasciniamo dietro di noi. In questo modo il cane si concentra sulla cosa che saltella e rimbalza per terra invece che sulla persona che si allontana e, allo stesso tempo, vede sparire qualcosa a cui è molto interessato.• Pestare l’erba formando un quadrato (circa 1x1 m2) e seminarla con dei bocconcini
DISCRIMINAZIONE OLFATTIVA
Discriminazione olfattiva signifi ca distinguere tra diversi odori e sceglierne uno in mezzo ad altri.Un cane antidroga riconosce l’odore di quella particolare droga in mezzo a mille altri odori: cibo, sudore, cuoio, olio, tabacco e qualsiasi altra cosa.La discriminazione olfattiva è una disciplina che necessita di diversi elementi: volontà di cer-care, capacità di segnalare e consapevolezza di cosa si cerca. Quindi il cane deve sapere cosa deve trovare, dove cercarlo e come comunicare il ritrovamento. E importante: il cane deve anche avere la voglia di lavorare per noi.
Per la maggior parte dei cani è un gran divertimento e un vero arricchimento avere l’occasio-ne di utilizzare le loro doti naturali e le capacità del loro fi uto per cercare leccornie nascoste o altri oggetti diventando così più equilibrati e contenti.
“….TUTTO CIÒ CONFERMA LA MIA IDEA CHE L’UNICO LIMITE ALL’UTILIZZO DELL’OLFATTO DEI CANI SIA IL NOSTRO CERVELLO. NOI NON SIAMO IN GRADO DI CAPIRE IN TUTTE LE SUE SFACCETTATURE LA PORTATA DI QUESTO INCREDIBILE STRUMENTO E PER QUESTO SIAMO INCAPACI DI VEDERNE TUTTI I I POSSIBILI USI…”
ANN LILL KVAM
Non c’è patto che non sia stato rotto,non c’è fedeltà che non sia stata tradita,
fuorché quella di un cane veramente fedele.
Konrad Lorenz, L’anello di Re Salomone, 1949
Un cane anziano non dev’essere considerato fi nito, in pensione, né un cane che debba passare le proprie giornate solamente a sonnecchiare, certo avrà bisogno del giusto riposo ma durante la giornata è bene che il cane svolga delle attività di vario tipo.L’invecchiamento è soggettivo per ogni cane, per alcuni soggetti arriva prima, per altri più tardi.Molto dipende dalla vita che hanno vissuto, dalle malattie che hanno incontrato, dall’alimentazione e soprattutto da fattori genetici.Nei cani di taglia piccola si possono notare i primi segni d’invecchiamento intorno al dodicesimo anno d’età.Nei cani di taglia media intorno al decimo anno di vita.Nei cani di taglia grande e gigante, già intorno all’ottavo anno.
Con l’invecchiamento udito e vista diminuiscono, il pelo imbianca, soprattutto sul muso. Il cane sembra perso nel suo mondo, è più lento nelle azioni e adora sonnec-chiare ininterrottamente sulla sua cuccia.I ritmi sonno/veglia potrebbero alterarsi quindi è importante avere una corretta gestione della routine giornaliera per garantirgli un adeguato riposo diurno e il completo riposo notturno.
IL CAne
ANZIAN
O
di Margherita Lerede
88 89
Bisogna evitare attività incentrate sulla dinamicità e concentrasi su attività alternative, sopra-tutto se il cane mostra diffi coltà di movimento e prova dolori arteriosi e muscolari. Queste attività danno benefi cio in ogni periodo della vita di un cane e, sopratutto in questo momento, sono molto importanti.
Mobiltydog: è un’attività molto utile per i cani anziani, offre loro grandi stimoli a livello mentale e fi sico e può essere svolta da ogni proprietario. Si tratta di un percorso ad ostacoli che può essere praticato in un campo attrezzato o improvvisato con oggetti di uso comune come panchine, pali, paletti o tronchi di alberi. Fare questo genere di attività rinforza la rela-zione tra cane e proprietario e aumenta le capacità cognitive (il cane deve ragionare e mettersi in gioco sfruttando al massimo le sue competenze), sociali (è un’attività che si svolge insieme al proprietario, accresce la fi ducia) e fi siche (aumenta la consapevolezza del proprio corpo nell’ambiente e sugli attrezzi).
Altra attività da proporre al cane senior è “l’attivazione mentale” o “problem sol-ving”: si propongono una serie di giochi che il cane dovrà risolvere in piena autonomia. Si inizia con giochi molto semplici per poi aumentare gradualmente le diffi coltà. É un’attività che si può praticare con gli oggetti più semplici, nascondendo un bocconcino prelibato sotto un bicchiere, oppure sotto un coperchio di una pentola, o ancora all’interno di una scatola.Dietro quest’attività sono nascoste tante piccole e grandi soddisfazioni per il vostro cane. Troppo spesso si dimentica che il cane ha una mente oltre che un corpo. Diciamo che è l’a-nimale più intelligente ma spesso si preferisce la pallina e la corsa frenetica a un momento di attivazione mentale e di ragionamento.
Lavorare con il fi uto: sensi come l’udito e la vista sono diminuiti o addirittura per alcuni total-mente svaniti ma l’olfatto rimane comunque il senso più importante e sviluppato.Si può spargere la pappa o qualche croccantino o pezzo di carne sul pavimento o nel prato in modo che il cane li cerchi e li trovi usando il naso.All’inizio bisogna aiutarlo mettendo i bocconcini proprio sotto il muso e tra le zampe poi, man mano che prende confi denza, potete metterli sempre più lontano. Bisogna procedere gradualmente altrimenti il cane perderà l’entusiasmo e si potrebbe stufare.Usando il fi uto si rilasserà, avrà fatto attività di ricerca e soprattutto si sarà divertito un mondo.
Semplici esercizi di ginnastica
Esercizio per la colonna vertebrale: mettere davanti al naso del cane un bocconcino e poi spostarlo leggermente a destra, poi a sinistra in modo che ruoti il collo da una parte e poi dall’altra. Si può andare con la mano più indietro fi no a far compiere al cane un giro su se stesso, si deve svolgere molto lentamente e a volte occorrono molte ripetizioni graduali prima di arrivare alla rotazione completa.Poi, dalla posizione terra, bisogna farlo rotolare in modo molto rilassato prima da una parte e
poi dall’altra. Il cane per fare questo esercizio dovrà trovarsi in un posto dove si sente a suo agio.
Camminare indietro: sempre con un bocconcino in mano, spingere leggermente la mano contro il muso del cane andando avanti anche con la gamba per far sì che si muova all’indietro spostandosi quindi con le zampe posteriori.
Il cane anziano ha bisogno di una routine incalzante, abitudinaria, far sì quindi che mantenga degli orari fi ssi nei pasti e nelle uscite.Stategli vicino il più possibile, si sentirà fragile e cercherà in voi una fi gura di ri-ferimento ora più che mai.
90 91
Chi è Linda Tellington-Jones
Nata in Canada in una fattoria, oggi vive con suo marito alle Hawaii. Ha sempre dedicato la sua vita agli animali e alle persone ponendosi l’obbiettivo di ricercare un modo per una migliore comprensione tra loro col fi ne di avere una relazio-ne basata sul rispetto reciproco. Il successo del suo lavoro con gli animali si basa sulla conoscenza, grande espe-rienza e sensibilità.Tra il 1975 e il 1978 Linda ideò il TTEAM (Tellington-Touch Equine Awareness Method, in seguito anche chiamato “Tellington-Touch Every Animal Method”) grazie agli studi intensivi con Moshe Feldenkrais ed i corsi di rieducazione per cavalli diffi cili. Il metodo Feldenkrais consiste in movimenti lievi e inconsueti che inducono il paziente ad estraniarsi dal proprio schema di pensiero e movimento e ne amplifi cano le possibilità fi siche ed emotive. Voleva trovare una via per inse-gnare ai cavalli a fare ciò che si aspettavano da loro ma senza stress, violenze o atteggiamenti di dominanza.Da sempre Linda vive con i cani, era solo una questione di tempo perché il metodo venisse esteso dai cavalli ad altri animali.
Che cos’è il TTouchIl Tellington TTouch® è un metodo, sviluppato da Linda Tellington-Jones, che si basa su movimenti circolari e non, effettuati con le mani su tutto il corpo dell’ani-male.
il meto
do
T-TOUC
H
di Sabrina Miraglia
92 93
Lo scopo è attivare la funzione delle cellule e delle terminazioni nervose. E’ un approccio particolare alla cura e all’educazione del cane; basato sulla cooperazione e il rispetto, questo metodo offre un approccio positivo all’addestramento, può aumentare le performances e la salute e mette a disposizione un metodo differente per risolvere i più comuni problemi di sa-lute e comportamento. Grazie ai TTouches, infatti, gli animali acquisiscono una nuova consapevolezza di sé e impa-rano a pensare e scegliere reazioni differenti al posto di quelle istintive di lotta, fuga o blocco. Aiuta anche ad incrementare e migliorare il rapporto tra uomo e animale, attraverso una co-municazione non verbale più profonda e basata sulla comprensione. L’obiettivo principale è quello di ottenere una fl essibilità e al tempo stesso un equilibrio nel corpo e nella mente dell’animale.Dato che le emozioni si esprimono con un atteggiamento corporeo e quindi anche motorio.
Molti di quelli che noi abitualmente consideriamo problemi del cane non sono altro che espressione delle sue emozioni, che si traducono in atteggiamenti corporei. Lavorando sul corpo del cane, indirizzandone il movimento, si agisce anche sull’emozione che sta alla base del comportamento stesso.Il TTouch è molto utile anche in caso di problemi fi sici di varia natura, traumi e operazioni ed è anche un effi cace strumento per migliorare la qualità della vita della coppia cane-proprieta-rio, ma non è da intendersi come sostituto delle cure veterinarie.
Questo metodo è indicato in caso di: • Riduzione dello stress• Masticazione e abbaio eccessivi• Tirare al guinzaglio• Saltare addosso• Comportamenti aggressivi• Paura e timidezza eccessive• Riluttanza ad essere toelettato• Eccitabilità e nervosismo• Mal d’auto• Problemi associati con l’età (reumatismi, artriti ecc)• Andatura strana• Ferite• Problemi durante le prestazioni cino-sportive
Lavoro sul corpo
Il lavoro sul corpo offre una grande varietà di movimenti particolari praticati sul corpo dell’a-nimale che lo aiutano a rilassarsi, a conoscere meglio il proprio corpo e a liberarsi di vecchi
traumi, paure e dolori. I TTouches, come vengono chiamate queste manipolazioni fi siche, ven-gono praticati con poca pressione, non lavorano su muscoli, ossa o or-
gani, vengono praticati solo in superfi cie, ma l’effetto è profondo e spesso più duraturo di quello di un massaggio.I TTouch si dividono in movimenti rotatori, sollevanti e accarezzanti distribuiti sulle diverse parti del corpo.Il movimento rotatorio della pelle consiste nel muovere la cute di un giro e un quarto in senso orario partendo alle ore 6 di un orologio con le dita o con la mano aperta. La velocità media è tra 1 e 3 secondi per ogni giro completo e la pressione da 1 a 3/4. • Poca pressione, molto leggeri• Pressione leggermente più forte3-4) pressione ancora un po’ più forte
I T-Touch con movimenti circolari sono:
Leopardo NebulosoIl leopardo nebuloso è la base su cui si sono sviluppati gli altri TTouch rotatori. Il nome deriva come tutti i ttouch dall’animale sul quale era stato praticato. Le dita appena piegate si muovono con una pressione leggera. La velocità per un cerchio è di 2 secondi con una pressione da 1 e 3. Il pollice è staccato e il medio guida il movimento, il polso sta fermo e non tocca il corpo e si controlla la respirazione. Controlliamo la risposta del cane, se non si sente a suo agio cambiamo pressione o TTouch. Questo TTouch si è dimostrato particolarmente utile per il rilassamento e l’aumen-to del benessere fi sico.Per abituarsi alle diverse situazioni della vita, come una nuova casa, un viaggio in automobile, mordacità per motivi di paura, tirare al guinzaglio.
Leopardo sdraiatoÈ una variazione del Leopardo Nebuloso, si abbassa un pochino l’arco della mano così da permettere un’area di contatto più ampia, facendo come nel precedente TTouch movimenti concentrici di un giro e un quarto cominciando dalle ore 6 fi no alle ore 8-9 e dopo una pausa di 2 secondi, scivolate sul prossimo punto.Questo TTouch si è dimostrato particolarmente utile per generare calore e rilas-satezza. Indicato per rendere più profonda la fi ducia tra voi e il vostro cane e per ridurre dolore e gonfi ore dopo una lesione.
94 95
I TTouch con movimenti sollevanti e accarezzanti sono:
La marcia di NoèQuesto TTouch inizia e conclude una sessione di trattamento del corpo. Con movimenti lun-ghi e calmanti sul pelo riuscite a prendere contatto anche con cani sconosciuti o un nuovo cucciolo. Tenere la mano morbida e fl essibile in modo da poter seguire i contorni del corpo. Si usa per “collegare” il corpo del tuo animale per una maggior consapevolezza dello stesso. Accarezzare il cane dolcemente con le dita rilassate, cominciando dalla testa coprendo tutto il corpo e le zampe fi no alla punta dei piedi.
TTouch delle orecchieQuesto TTouch calma, lenisce i dolori calma cani iperattivi ed è utile per le emergenze. È uno dei più importanti. Fin dall’antichità è noto che si può infl uenzare l’intero organismo agendo sulle orecchie, come l’agopuntura. Uno shock può causare un collasso. Passare la mano sulle orecchie dopo un incidente in attesa del soccorso di un veterinario o dopo un’operazione o l’esplosione di un petardo, può salvare la vita dell’animale. Con una mano stabilizzare la te-sta. Prendere l’orecchio, il padiglione, fra il pollice e le altre dita con il pollice sulla superfi cie superiore dell’orecchio. Fare scorrere le dita dalla base fi no alla punta. Ripetere più volte in modo da trattare tutta la superfi cie. Per i cani con orecchie dritte sarò rivolto il movimento verso l’alto, cani con le orecchie pendenti la carezza sarà verso il lato. Poi passare all’altro orecchio. Non dovete tirare le orecchie, ma fare una leggera carezza. Per cani sotto Shock passare la mano più velocemente con un po’ più di pressione. Per il ri-lassamento usare movimenti lenti e delicati.
I bendaggi del corpo o la T-shirt danno al nostro cane pauroso, ansioso e iperattivo una cor-nice che lo aiuta a sentirsi più sicuro nel suo corpo, un intenso senso e percezione della sua fi sicità. I soggetti giovani che hanno paura dei rumori forti o diventano ansiosi nei viaggi in macchina, traggono benefi cio dal bendaggio.Prendete la metà della benda elastica (che si trovano in farmacia) e fasciate il petto del cuccio-lo incrociando la benda sulla schiena. Avvolgete poi la benda intorno al corpo verso il basso e terminate facendo un nodo sulla schiena o usate una spilla di sicurezza. Assicuratevi che la benda sia ben stesa e non troppo stretta.
Lavoro a terra
Il lavoro a terra si serve di ostacoli e di attrezzi che aiutano l’animale a migliorare autocontrollo, concentrazione, fi ducia, equilibrio e coordinazione, im-parano ad imparare e a pensare anziché reagire istintivamente (attacco, fuga, bloc-co) in situazioni diffi cili.Labirinto è utile per insegnare l’obbedienza di base. Serve per migliorare la con-centrazione e la capacità di focalizzare del cane. Servono sei pali di plastica del diametro di 3-8 cm e lunghi 4 mm. Indicazione visiva per simulare un sentiero negli esercizi di condotta. Aumenta la mobilità da entrambe le parti del corpo.
Le diverse superfi ci Il training di camminare su diverse terreni è una preparazione utile per la vita quotidiana. Durante le passeggiate si incontrano griglie, tombini, superfi ci in plastica tappetti etc. Se abbiamo preparato il cane a tutto questo la vita quotidiana non sarà uno stress. I cani così imparano a camminare sicuri senza paure. Usate materiali come reti a maglia, fogli di plastica. Se vi accorgete che il cane ha paura o diventa nervoso si possono utilizzare le bende del corpo o la T-Shirt aiutando il cane a sentirsi più sicuro.
I diversi tipi di condotta al guinzaglio/lunghine ci permettono di essere molto chia-ri nel trasmettere che cosa desideriamo e questo rende più semplice la collabora-zione. La stramaggior parte degli animali non è disubbidiente, semplicemente ha diffi col-tà a comprendere ciò che vogliamo da loro.Oltre tutto questo il metodo ci offre la possibilità di vedere in che cosa dobbiamo cambiare NOI per ottenere un cambiamento stabile nel nostro animale.
Come lo si può conoscere e imparare?In Italia ci sono già diversi insegnanti certifi cati del metodo, chiamati Practitioner, i loro indirizzi si trovano sul sito uffi ciale del TTouch in Italia www.tteam.it.
Bibliografi a“Chi è Linda Tellington-Jones”, “Che cos’è il TTouch”: Dott.ssa Valeria RapezziLavoro sul corpo e a terra descrizione esercizi: “Il cucciolo e il TTouch “ Linda Tellington-Jones ED. Haqihan
96 97
Il canile è quella struttura in cui vengono accolti i cani che per svariate ragioni non hanno un proprietario. Quì si possono trovare cani di ogni tipologia, di razza o meticci, cuccioli o adulti e anche anziani e disabili. Questa struttura ha lo scopo di eliminare tutti i rischi che verrebbero da cani lasciati incustoditi, di sterilizzare e curare i cani e infi ne proporli per una adozione.In linea di massima si può affermare che il funzionamento della struttura canile si suddivide in 3 fasi, che questi cani attraversano: abbiamo i cani in entrata che sono quelli che vengono abbandonati, i cani in uscita, ossia quelli che vengono adottati e poi ci sono i rientri, quei cani che vengono riportati indietro dopo l’adozione.
LE ADOZIONI
È moto importante quando ci si reca in canile lasciare a casa i PREGIUDIZI e l’E-MOTIVITA’ proviamo quindi a sfatare alcune voci.L’età: lo cresco come voglio, se è troppo grande non impara più niente, non si affeziona più ….sono frasi che troppo spesso si sentono e vengono ripetute quasi automaticamente senza rifl ettere sulla loro validità. Riguardo alla prima affermazione occorre considerare che per crescere un cuc-ciolo in modo corretto bisogna investire un’ enorme quantità di tempo, energie e anche denaro. Bisogna avere molta pazienza nonché le nozioni corrette per farne un adulto che sia sano ed equilibrato. Per questo, la gestione di un cucciolo è un impegno così grande che non tutti hanno la possibilità realistica di affrontare. Per alcuni sarebbe quindi molto più costruttivo adottare un cane che abbia già superato la fase giovanile.
il CANI
LE
di Debora Terzi
98 99
Per smentire le altre due supposizioni pensiamo a tutto ciò che noi stessi riusciamo ad impa-rare in età adulta e alle persone a cui siamo legati in maniera affettiva; non le abbiamo certo conosciute tutte quando eravamo bambini. Per i cani vale lo stesso principioLa razza: in canile ci sono solo cani pericolosi, non ci sono cani di razza ma solo meticci, i meticci non sono intelligenti come i cani di razza. Andate in un canile e vedrete che mai nulla come queste affermazioni è più falso. Molti cani pagano con una vita passata in gabbia il loro appartenere a una razza nota solo per gravi fatti di cronaca. Moltissimi meticci hanno inoltre dimostrato di avere doti di apprendimento altissime e di riuscire ad eccellere in molte attività cinofi le sportive e di utilità. La taglia: i cani grossi soffrono a vivere in appartamento, i cani grossi non sono adatti ai bam-bini, i cani piccoli sono più facili da gestire. I cani di grossa taglia soffrono solo se confi nati in un giardino da soli perchè come avremmo tutti avuto la possibilità di notare troppo spesso vengono dimenticati li e lasciati soli tutto il giorno. Ma dato che nessun cane ha le stesse necessità di una pianta ornamentale, è probabile che si senta molto più a suo agio in casa con noi che non da solo in un prato, per quanto grande possa essere, a patto che vengano soddisfatte le necessità comuni a tutti i cani (passeggiate, libertà, gioco con gli altri).Contrariamente a quanto si pensa, gli unici cani che sono inadatti a vivere con i bambini, sono i cosi detti cani “toy”. Infatti è molto facile che il bambino, soprattutto se di età inferiore ai 6 anni, cerchi di relazionarsi col cane in modo sbagliato, e considerando che questi cani sono davvero molto delicati, potrebbe fargli male involontariamente costringendo così il cane a di-fendersi. Ammesso che i bambini devono sempre essere sorvegliati quando interagiscono con un cane, l’unico requisito che deve avere un cane per poter vivere in una famiglia con bambini è che abbia imparato a conoscerli e che stia quindi tranquillo in loro presenza! I cani di piccola taglia hanno le stesse esigenze di quelli di taglia grande e vanno quindi gestiti nello stesso modo.Chi adotta un cane deve sentire il bisogno profondo di condividere la sua vita con lui. È sba-gliato pensare di adottare un cane solo allo scopo di salvarlo! Perché così facendo, ci aspette-remo, più o meno consciamente, gratitudine in cambio dall’oggetto del nostro nobile gesto, e allora sarà facile cadere nell’errore di chiedersi; perché mi devo sforzare di capirlo? Infondo lo ho salvato.. cosa vuole di più? Questa aspettativa è il presupposto peggiore su cui fondare la relazione con il cane.
I RIENTRI
Tra le principali cause di rientro troviamo:• scarso impegno di comprensione verso il cane da parte dell’adottante
In alcuni casi i rientri possono avvenire dopo anni dall’adozione ma più comunemente è stato osservato che la decisione di riportare indietro il cane avviene nelle prime 72 ore, sono questi
infatti i momenti più critici per il cane, perchè si trova in un ambiente che non conosce insieme a persone che non conosce.
• eccessiva esuberanzaSi considera eccessivamente esuberante il cane che salta addosso, che reagisce im-mediatamente e in maniera esasperata agli stimoli. In questo caso è bene, quando si porta a casa il cane, non cercare di compensare subito le mancanze di affetto che ha subito fi no a quel momento,permettendogli di fare tutto ciò che vuole, anzi sarebbe bene cominciare fi n da subito ad aiutarlo a comprendere quali sono i limiti in modo da non confonderlo in seguito, negandogli privilegi che pensava aver già pienamente acquisito.
• distruttivitàLo stress, la noia e la scarsa capacità di elaborare il distacco dai nuovi compagni umani porta il cane a scaricare la frustrazione sugli arredi e oggetti personali. In-fatti non c’è da sorprendersi se il cane mangia i mobili in nostra assenza, spesso questo comportamento viene interpretato come un dispetto ma non è così; il cane mastica perché, non potendo leggere o guardare la televisione, per lui è l’unico modo per passare il tempo o scaricare la frustrazione creata dal distacco.
• vocalizzazioni Può anche manifestare il suo disagio abbaiando in maniera insistente diventando cosi motivo di confl itto col vicinato e nervosismo per chi convive con lui. A fronte di questi comportamenti bisognerebbe chiedersi: cosa lo spinge a comportarsi così? Qual è il suo disagio?” in modo da aiutarlo risolvendo così anche il problema. Mentre quello che tutti si chiedono è: “come faccio a farlo smettere??”
• deiezioni in casaUn cane che è vissuto nel box è abituato a sporcare nello stesso luogo dove vive e su una superfi cie molto più simile al pavimento di casa che non ad un prato quindi occorre abituarlo alla nuova possibilità i poter fare i suoi bisogni in un luogo ben diverso da quello in cui dovrà vivere. Molti dei rientri sono dovuti proprio a questo piccolo inconveniente che tutti i cani manifestano nell’arco della vita. Se non si è in grado di accettare un compromesso di così piccola entità, sarebbe opportuno rivalutare con molta più attenzione l’idea di prendere un cane.
GLI ABBANDONI
Da dove arrivano tutti questi cani?Questi cani sono quei cuccioli che sono stati regalati o messi sotto l’albero di na-
100 101
tale ad un bambino senza considerare che avrebbe richiesto tempo e delle cure che nessun bambino è in grado di dare. Sono quelli che non hanno saputo svolgere un lavoro per cui si pensava fossero adatti e tutti quelli che questi compiti li hanno svolti per tutta la vita ma sono diventati troppo vecchi e i cui proprietari hanno trovato come unica soluzione l’abbandono. E infi ne le cucciolate che vanno ad ad aggiungersi ad un numero già spropositato di cani.
La sterilizzazione è un punto cruciale della prevenzione al randagismo. Questa considerazio-ne nasce dal fatto che in proporzione le famiglie disposte ad adottare cani sono meno dei cani disponibili ad essere adottati!!! Infatti, considerando che i cani ospitati dalle famiglie italiane sono circa 6-7 milioni e che ci sono quasi 600 000 cani ospitati od ospitabili (in quanto ran-dagi) nei rifugi (fonte: ministero della salute), si capisce facilmente come la natalità debba essere molto limitata.Inoltre bisogna considerare che, se pur riuscissimo a trovare una casa a tutti i cuccioli generati dal nostro cane, avremmo comunque tolto, per ogni cucciolo nato, una preziosa possibilità di affi damento a uno dei tanti cani ospiti nei canili. Abbiamo potuto rifl ettere su tutto ciò che ognuno di no può fare per migliorare o almeno cercare di non peggiorare la diffi cile situazione dei canili. Ma l’unico vero sistema che può veramente far si che il canile, così come lo conosciamo oggi, diventi solo un ricordo, è quello di rivalutare questa struttura e considerarla per quello che è realmente; ovvero quel luogo dove andare quando si sceglie di prendere un cane!
Per molte persone queste due parole sono solo uno dei tanti neologismi anglo-sassoni che vanno di moda, che sentono usare ma di cui non conoscono l’esatto signifi cato.Letteralmente le due parole signifi cano, PET animale domestico e THERAPY te-rapia, da cui: pratica che prevede l’impiego di animali come supporto terapeutico per migliorare lo stato di salute di pazienti di qualsiasi età con problemi.La Pet Therapy è sostanzialmente considerata l’innata capacità terapeutica degli animali.Gli animali aiutano a recuperare la socialità, rallegrano i bambini ospedalizzati e anziani, intervengono con successo nelle terapie di riabilitazione dopo interventi chirurgici o dei traumi invalidanti e tanto altro ancora…
Perché è effi cace?Perché dal contatto con l’animale scaturisce un rapporto sereno, spontaneo, since-ro, corrisposto e tanto appagante da diventare un aiuto al benessere psichico e di conseguenza fi sico, specialmente in quelle situazioni in cui i contatti interpersonali sono alquanto limitati.
Categoria, campi e luoghi di utilizzoPertanto la Pet Therapy è particolarmente effi cace con le seguenti categorie di persone e di patologie:- Bambini
pet
therap
y
di Liliana Tognin
102 103
- Anziani- Cardiopatici e altre patologie invalidanti e semi invalidanti- Adulti con turbe psichiche- Diversamente abili- Criminali in manicomio- Carcerati- Tossicodipendenti
La Pet Therapy con i bambiniI bambini ricoverati in ospedale soffrono spesso di depressione, di disturbi del comportamen-to, del sonno e dell’appetito, conseguenza dei sentimenti di ansia, paura, noia che provano nel subire il trauma di un brusco allontanamento dal loro mondo, dai familiari, dalla casa, dalle loro abitudini.Si è notato come nei reparti pediatrici nei quali è attivo un programma di attività assistite da-gli animali che la gioia e la curiosità provate dai piccoli pazienti durante gli incontri con un animale, alleviano i sentimenti di disagio conseguenti al ricovero e rendono meno traumatico il loro approccio con le terapie e con il personale sanitario.
La Pet Therapy con gli anzianiPositiva è anche l’esperienze di Pet Therapy con gli anziani ospiti di case di riposo, che spesso, a causa della solitudine e della mancanza di affetti, si chiudono in se stessi e rifi utano rapporti interpersonali.Si è osservato che nei periodi di convivenza con animali si verifi ca un generale aumento del buon umore, accompagnato da maggiore reattività e socievolezza rendono più facili i contatti con i terapisti.
La Pet Therapy con i cardiopatici ed altre patologie invalidanti o semi-invalidantiLa vicinanza di una animale può aiutare anche persone con problemi fi sici gravi e meno gravi. Gli animali, con il loro spontaneo affetto, l’accettazione incondizionata anche di chi è “diverso”, il piacere del contatto fi sico e non verbale, rendono ognuno di noi più capace di esprimere le proprie emozioni e di relazionarsi con gli altri in particolar modo le persone con patologie invalidanti. La Pet Therapy fornisce ai disabili la possibilità di sperimentare un’at-tività che consenta loro di sviluppare le autonomie e le capacità relazionali, superando i limiti della disabilità.Attraverso la cura e la conoscenza dell’animale, i disabili possono fare nuove esperienze che mettono in gioco tutta la loro persona e i loro sentimenti.
La Pet therapy con adulti psichicamente o psicologicamente disagiatiPositiva anche l’esperienza fatta in strutture psichiatriche: in presenza di animali la maggior parte dei pazienti manifestavano una reazione positiva. Una buona percentuale, per esempio,
partecipava alle sedute di gruppo per aver cura, per spazzolare o accarez-zare gli animali.Si osservò anche che l’introduzione di cani e di gatti nelle corsie di un
ospedale migliorava la qualità delle reazioni nei pazienti affetti da patologie o semplici episodi depressivi.
La Pet therapy nelle carceriIn questi contesti sociali estremi, in cui spesso prevalgono sentimenti negativi come depressione, solitudine e violenza, la presenza di un animale costituisce un impegno quotidiano che allontana la noia e, donando affetto, riduce l’aggressività e i tentativi di suicidio.Per queste ed altre esperienze positive, oggi si consente ai detenuti di prendersi cura di volatili e di pesci d’acquario per incentivare la cooperazione e la collabo-razione.
Quali sono gli animali coinvolti?Gli animali più diffusi in Pet Therapy sono: cani, gatti, cavalli, asini, criceti e co-nigli, pesci, uccelli, delfi ni, mucche, capre, pecore.Tutti gli animali coinvolti devono essere valutati da un medico veterinario com-portamentalista, secondo precisi parametri riguardanti la perfetta socializzazione, l’ottimo livello di socievolezza, la competenza nella realizzazione delle attività previste e la capacità di stare nel contesto situazionale previsto.
Un soggetto ideale…Di fatto i cani sono gli animali usati con maggiore frequenza nella terapia assistita per animali per molteplici ragioni.Innanzi tutto sono animali molto socievoli, in grado di dare all’uomo un amore in-condizionato, a dispetto dell’apparenza, dell’età, della salute e dello stato sociale.I cani non giudicano, possono essere accarezzati, toccati, e il toccare, oltre ad es-sere il sistema primario di comunicazione (il tatto è il primo senso che si sviluppa nell’uomo e l’ultimo a rimanere in esso), costituisce un vero e proprio bisogno fi sico e psichico, infondendo calma e sicurezza e sconfi ggendo ansia e solitudine.Sono inoltre facilmente addestrabili e hanno una straordinaria capacità di comuni-care con l’uomo attraverso sia il linguaggio verbale che quello gestuale.Sono validissimi per le persone malate, chiuse in se stesse che spesso perdono il desiderio e la capacità di parlare con il prossimo; talvolta i cani, con un gesto, uno sguardo, una moina, riescono a rompere il muro del silenzio e a stabilire un con-tatto con queste persone.Possono essere di tutte le taglie e per questo facilmente “maneggiabili” anche da persone allettate o timorose, amano il movimento e possono essere addestrati a compiere una quantità quasi incredibile di azioni a favore dei disabili.
104 105
Pazienti che soffrono del morbo di Alzheimer con perdita di realtà, grazie ai cani possono essere riportati a focalizzare la loro attenzione sul presente.Allo stesso modo, persone con problemi di apprendimento con l’ausilio dei cani possono aumentare la loro capacità di concentrazione e, conseguentemente, imparare con maggior facilità.è bene precisare che non tutti i cani possono svolgere attività di Pet Therapy: sebbene non vi siano preclusioni di razze, prima di inserire un cane in un programma, occorre un’accurata valutazione comportamentale e temperamentale da parte di educatori cinofi li e veterinari, nonché un adeguato addestramento partendo da una buona educazione di base.
Esistono 2 tipi di Pet Therapy
AAA: Attività Assistite da AnimaliQueste attività si pongono come obiettivo primario il miglioramento della qualità della vita di alcune categorie di persone (per esempio ciechi, anziani, malati terminali ecc.) in ambito ludico e ricreativo.Si tratta di interventi di tipo educativo/ricreativo, che possono essere effettuati in vari ambien-ti da professionisti con competenze specifi che, para-professionisti e/o volontari, assieme ad animali che rispondono a precisi requisiti.
TAA: Terapie Assistite da AnimaliIn questo caso si tratta di una vera e propria attività terapeutica (quindi un’attività con carat-teristiche e fi nalità, oltre che una struttura, ben defi nite) rivolta a migliorare le condizioni di salute di un paziente mediante il raggiungimento di obiettivi defi niti, quali il superamento del disagio psichico o fi sico.Non sostituisce la terapia vera e propria, ma è una terapia di supporto che si aggiunge a quelle normalmente messe in atto per un determinato tipo di patologia.
Concludendo…Avere un cane non è solo questione di compagnia, di relax, di serenità, di amicizia, di com-plicità, di dialogo, di sorrisi, è anche una questione di benessere: fa bene all’organismo ob-bligandoci a fare movimento per assicurargli adeguate passeggiate riducendo tutti gli effetti negativi legati alla vita sedentaria, quindi difende il cuore, evitando che i problemi coronarici possano metterci a rischio più di quanto già non fanno.È un rapporto basato sulla naturalezza e la spontaneità, a volte diffi cili nelle convivenze tra esseri umani, che determina una sorta di tranquillità e di sicurezza riducendo in questo modo anche l’ansia da relazione.Ma Pet Therapy non vuol dire prendere un cane con sé o averlo semplicemente accanto, per quanto piacevole possa essere la sua compagnia, ma è una disciplina vera e propria.In quanto tale non è una panacea per tutte le patologie e deve essere applicata dopo attenta va-
lutazione: non è adatta a tutti gli individui, e solo esperti e professionisti con una specifi ca preparazione nel settore sono in grado di valutarne le possibilità e le modalità d’impiego.
Pensare di adottare un animale per avere un benefi cio terapeutico è già un modo sbagliato per iniziare la relazione con il proprio cane che, viceversa, chiede uno slancio disinteressato e una piena assunzione di responsabilità.La loro presenza nelle nostre case è una nota dolce e positiva, il relazionarsi, il comprendere, l’educare, il semplice guardare il cane può portare benefi ci a livello mentale, psicologico e fi sico, ma la Pet Therapy è una cosa ancora più seria…Non possiamo neanche minimamente immaginare a cosa può fare davvero questa disciplina: quindi diffondiamo il pensiero Pet Therapy, ma soprattutto crediamoci, come crediamo che i nostri cani ci fanno bene davvero.Insomma è una sorta di medicina naturale che stupisce e ci aiuta a vivere meglio!
Questo è il valore della Pet Therapy.