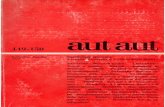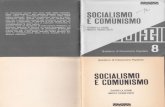L'assetto mediatico in Bulgaria dopo la caduta del comunismo
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI · La prima immagine che ci viene in mente quando...
Transcript of SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI · La prima immagine che ci viene in mente quando...
1
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI (Decreto Ministero dell’Università 31/07/2003)
Via P. S. Mancini, 2 – 00196 - Roma
TESI DI DIPLOMA
DI
MEDIATORE LINGUISTICO
(Curriculum Interprete e Traduttore)
Equipollente ai Diplomi di Laurea rilasciati dalle Università al termine dei Corsi afferenti alla
classe delle
LAUREE UNIVERSITARIE
IN
SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA
TITOLO DELLA TESI
Le donne e il comunismo, le donne contro il comunismo –
La storia del comunismo attraverso gli occhi di Anna Walenynowicz
RELATORI CORRELATORI:
prof.ssa Adriana Bisirri Marilyn Scopes
Marie-Françoise Vaneecke
Claudia Piemonte
CANDIDATA:
Agnieszka Slupska
ANNO ACCADEMICO 2012/2013
2
INDICE:
SEZIONE ITALIANA
Introduzione…………………………………………………………………...…3
1. Il lavoro………………………………………………………………............12
1.1. Le migrazioni……………………………………………………...……….12
1.2. Le nuove possibilità……………………………………………………..…19
1.3. Lo stacanovismo………………………………………………………...…25
1.4. Anna Walentynowicz………………………………………………………27
2. La vita privata………………………………………………………………..30
2.1. Il matrimonio…………………………………………………………...….31
2.2. La maternità………………………………………………………………..36
2.3. La casa e il lavoro………………………………………………………….39
2.4. Il tempo libero……………………………………………………...………43
2.5. Anna Walentynowicz………………………………………..……………..46
3. Il cammino verso la libertà di Anna Walentynowicz………………….…….51
4. La Conclusione……………………………………………………..………..74
ENGLISH SECTION…………………………………………………………..78
SECTIONE FRANCAISE…………………………………………………….107
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………...132
SITOGRAFIA…………………………………………………………………134
3
INTRODUZIONE
La prima immagine che ci viene in mente quando pensiamo alla donna nel
comunismo è una ragazza sorridente in tuta da lavoro seduta su un trattore. Pensiamo
alle donne che svolgevano i lavori maschili, pensiamo ad una sorveglianza totale e
continua come nel romanzo di Orwell.
In questo lavoro cercherò di descrivere come, nelle sue diverse fasi, il
comunismo ha influenzato la vita delle donne.
Senza alcun dubbio, la guerra fu il maggiore catalizzatore dei cambiamenti
sociali riguardanti gli aspetti più intimi della vita umana, come la famiglia, il
matrimonio e i ruoli sociali. Anche se nel caso della Polonia la guerra vera e propria
durò poche settimane, gli uomini erano spesso assenti: si schieravano con i partigiani,
venivano deportati, ecc. Senza l’uomo in casa, le donne dovettero imparare a
provvedere ai bisogni della famiglia. Diedero esempio di forza e ingegno occupandosi
della famiglia, ricorrendo spesso a mezzi illeciti, come lo spaccio, per il quale la pena
era la deportazione nei campi di concentramento o la morte. Anche dopo il ritorno dei
capifamiglia, spesso le donne dovevano continuare a lavorare, poiché uno stipendio non
era sufficiente al sostentamento della famiglia.
I ruoli non tradizionali assunti dalle donne durante la guerra hanno spinto gli
intellettuali a sottolineare l’indipendenza sociale e morale della donna in questo periodo.
Dopo un periodo di responsabilità e indipendenza le donne non volevano tornare a far
parte dei “mobilia” costosi.
Ben presto, il crescente numero di donne lavoratrici attirò l’attenzione degli intellettuali,
dei politici e della gente comune. Già Marx e Engels avevano sviluppato l’idea di una
“donna nuova”, che avrebbe trovato la propria realizzazione nella società socialista,
4
grazie al lavoro1. Era proprio il ripensamento dei ruoli sociali dopo la guerra, il sempre
crescente numero di donne lavoratrici e il tentativo dei comunisti di realizzare nella
pratica l’uguaglianza dei sessi la combinazione giusta per mettere in moto i veri
cambiamenti sociali. Queste condizioni del tutto nuove resero possibile la rottura con la
nozione di differenza di genere, secondo cui le donne erano legate al nucleo familiare e
alla famiglia e gli uomini alla vita pubblica, economica e politica.
Per comprendere quale fosse la situazione della donna nella società polacca del
dopoguerra è necessario un excursus storico. Ovviamente i cambiamenti sociali degli
anni ’40 sono cruciali per la formazione della nuova società in Polonia, per la creazione
del così detto homo sovieticus.2 Tuttavia, è necessario risalire non solo alla seconda
guerra mondiale e alla presa del potere da parte dei comunisti, fattori che sembrerebbero
determinanti per la formazione della società post bellica, bensì agli anni fra le due
guerre, quando, cioè, si svilupparono i primi pensieri femministi e diverse enti, sia
laiche che cattoliche, iniziarono ad accorgersi del sempre più importante numero delle
donne nella vita professionale, e cercarono di trovar loro un posto nella nuova società
capitalista.
Gli enormi cambiamenti politici che ebbero luogo in Europa nella prima parte del XX-
esimo secolo, toccarono anche la Polonia. Basti pensare che fu proprio in questo
periodo che la Polonia, dopo 125 anni, riacquistò la sua indipendenza, per poi
scomparire nuovamente delle mappe d’Europa nel 1939.
In seguito ai colloqui fra i paesi vincitori della Seconda Guerra mondiale (Inghilterra,
Stati Uniti e URSS), i confini della Polonia vennero molto ridotti rispetto alle frontiere
storiche del paese. Tuttavia, la conseguenza più importante della politica del dopoguerra
fu l’annessione della Polonia, insieme a tutta la parte est dell’Europa, all’URSS.
Il comunismo polacco era sostanzialmente diverso da quello dell’Unione
Sovietica. Bisogna ricordare che in tutta l’Europa dell’est, con l’eccezione di Albania e
Jugoslavia, i comunisti non presero il potere in maniera spontanea. Il regime veniva
1Cfr. C. Toledo, Il Marxismo e il problema dell’emancipazione della donna, da consultare sul
sito <http://www.alternativacomunista.it> 2 Dal latino:” l’uomo sovietico”. È un termine che ha introdotto uno scrittore russo, A. Zinowjew
nel suo libro “Homo Sovieticus”, usato per descrivere una persona priva della morale e della dignità. Il
termine utilizzato per indicare una persona cui carattere e il modo di pensare sono state formati dal
sistema totalitare, in particolar modo quello comunista.
5
imposto dall’alto e per questa ragione la sua legittimità era limitata. Per consolidare il
proprio potere, i leader dei paesi dell’est “aggiustarono” il sistema per far sì che
rispondesse alle condizioni locali. Neanche l’imposizione dello stalinismo di stampo
sovietico alla fine degli anni ’40 ebbe successo nel tentativo di creare una vita sociale e
politica uniformata.3
Il caso della Polonia è per molti versi unico. Le marcate strutture sociali e
culturali polacche, insieme alla costante minaccia da parte dell’impero russo in passato
e poi l’effettiva dominazione da parte di esso, resero la Polonia particolarmente poco
sensibile alla rivoluzione comunista ispirata dai vicini dell’Est. Il controllo sovietico era
percepito come una minaccia ai valori occidentali dei quali la Polonia si riteneva
custode fin dalle invasioni ottomane. Come scrisse nel ’53 il grande poeta polacco,
premio Nobel per la letteratura, Czesław Miłosz “Le popolazioni europee sono più
intelligenti, la maggior parte delle terre sono coltivate, il loro sistema di comunicazione
e l’industria più sviluppati. Misure basate sulla crudeltà non sono necessarie, non
hanno senso, visto che là esiste un senso più avanzato della disciplina sociale”.4
Questo tipo di atteggiamento era molto diffuso fra i Polacchi durante la Seconda Guerra
mondiale. I Sovietici, presentati alla fine del conflitto come i salvatori della Polonia,
non erano degli amici, né erano percepiti come tali dalla popolazione.
Per quasi due anni l’Armata Rossa oppresse i Polacchi che abitavano l’Est del paese, nel
tentativo di sradicare le differenze delle classi sociali (e in realtà di eliminare
l’intelligenza) e di instaurare il comunismo. Per lo più i Sovietici deportarono centinaia
di migliaia di cittadini polacchi all’interno dell’Unione Sovietica e massacrarono e
sostanzialmente eliminarono le élites intellettuali. L’azione più conosciuta è
l’esecuzione di massa di più di 20.000 ufficiali polacchi fra Aprile e Maggio del 1941,
nella foresta di Katyń (oggi Ucraina). Nel ‘44, quando Varsavia si stava dissanguando
nell’ultimo, disperato tentativo di sconfiggere i Nazisti, l’Armata Rossa, all’epoca
ufficialmente alleata con le forze armate polacche, rimase inerte, fermata da Stalin
dall’altra parte della Vistola, permettendo ai Tedeschi di decimare i soldati polacchi e
3Cfr. A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości.
Historia Polski 1918-1989,Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, pp. 207-249 4 M. Fidelis, Women, Communism and Industrialization in Postwar Poland, Cambridge
University Press, New York 2010, p. 6
6
radere al suolo la città , per non parlare delle violenze, si potrebbe dire “normali”
durante un conflitto armato, come stupri, saccheggi e omicidi.
Sui territori dominati dai Sovietici venivano arrestati i membri dell’opposizione,
gli appartenenti al così detto “paese sotterraneo”. Allo stesso tempo i Sovietici
proteggevano gli organi statali dominati dai comunisti e dai loro sostenitori, come il
PPR(Polska Partia Robotnicza- il Partito degli Operai Polacco). Il partito esisteva
ancora prima della guerra. Nel 1945 questa fazione non era numerosa: fra le sue schiere
si contavano circa 190.000 membri. I numeri, nonché una generale avversione verso gli
slogan comunisti, li costrinsero, in un primo momento, a nascondere il loro vero
programma, accentuandone allo stesso tempo le caratteristiche democratiche e
nazionali. Inoltre, contrariamente all’ideologia comunista, manifestavano
condiscendenza verso la Chiesa e i dignitari del partito partecipavano alle messe
celebrate in occasione di feste nazionali e religiose. Tale atteggiamento dei comunisti
nei confronti della Chiesa si rivelò la forza di quest’organizzazione. La Polonia del
dopoguerra era un paese praticamente omogeneo dal punto di vista nazionale e
religioso, più del 90% della popolazione si dichiarava cattolica. La necessità di
conquistare l’appoggio della società condizionò la politica verso la Chiesa.5 Per
convincere i cittadini che il paese formatosi nel dopoguerra fosse uno stato a tutti gli
effetti, il governo fece proprie alcune delle tradizioni del periodo antebellico.
Allo stesso tempo venne sviluppato un modello di repressione di stampo
sovietico. Il disorientamento della società avveniva a più livelli: si cercava di
convincere il popolo che, in quanto usurpato, il potere comunista installato in Polonia da
Stalin fosse legittimo. I comunisti nascondevano inoltre proprie intenzioni dietro la
maschera degli slogan nazionali e patriottici: mentre, apparentemente, promuovevano la
democrazia, eliminavano in realtà le strutture democratiche dalla vita politica.
A segnare definitivamente il futuro della Polonia furono le elezioni tenutesi
nell’ambito delle conferenze per la pace, dopo la guerra. Per i comunisti si trattava
un’opportunità unica per legittimare il potere sulla scena politica internazionale.
L’opposizione, invece, cercava di esaltare le debolezze dei sostenitori di Stalin in
5 Cfr. P. Osęka, Marzec ’68, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008, pp. 12-15
7
Polonia. Gli attivisti per l’indipendenza speravano che i paesi occidentali, in conformità
con le promesse di Jalta, vegliassero sull’osservanza delle procedure democratiche.
Invece, lo sviluppo dell’apparto di sicurezza, l’eliminazione dell’opposizione e la
pacificazione dell’atmosfera anti regime, condizionarono il risultato del referendum a
favore dei comunisti.
Durante il plebiscito i Polacchi dovevano rispondere alle seguenti domande: Sei per
l’abolizione del Senato? Vuoi che l’economia si basi sulla nazionalizzazione
dell’industria, mantenendo i diritti base per l’iniziativa privata? Vuoi che i confini della
Polonia siano confermati in corrispondenza del Mar Baltico e dei fiumi Odra e Nysa
Luzycka.
Il referendum ebbe luogo il 30 giugno 1946. I risultati vennero falsificati per garantire la
vittoria ai comunisti. La mancata reazione dei paesi occidentali di fronte alle
manipolazioni dei risultati furono per Stalin e i comunisti in Polonia un segnale chiaro
che sarebbe stato loro possibile truccare le elezioni dell’Assemblea Legislativa.
Le elezioni vennero precedute da un’ampia azione di propaganda e anche da repressioni
che miravano a costringere la società a votare conformemente alle aspettative dei
comunisti.
Le elezioni dell’Assemblea Legislativa ebbero luogo il 19 gennaio 1947. Durante il voto
centinaia di migliaia di persone vennero cancellate delle liste elettorali e migliaia di
persone, che avrebbero potuto votare in maniera “sbagliata”, furono preventivamente
arrestate. I voti vennero nemmeno contati, visto che i risultati erano già stati stabiliti e
imposti dall’alto. Il 31 gennaio 1947 fu annunciato che alle elezioni aveva partecipato il
90% degli aventi diritto, di cui l’80% si era espresso a favore dei comunisti e dei loro
alleati del blocco democratico.6
In un certo senso queste elezioni rappresentarono il punto di svolta. Il morale della
società era a pezzi e sotto pressione e minaccia il popolo diede il proprio appoggio al
regime. In ambito pubblico dominava la manifestazione dell’appoggio ai comunisti,
insieme alla paura di esprimere le proprie opinioni. La gestione delle emozioni della
società diventava più facile in quanto era già possibile notare i primi risultati dell’
ingegneria sociale intrapresa dai Sovietici. La nazionalizzazione della proprietà privata
6 Cfr. A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, op.cit, pp. 251-260
8
impoverì la società, e le rimanenti élites intellettuali, culturali e finanziarie vennero
marginalizzate. Le deportazioni, i trasferimenti di massa, le migrazioni, che all’epoca
non erano ancora finite, contribuirono all’indebolimento dei legami familiari e sociali di
interi gruppi locali. Questi fenomeni furono accompagnati dall’ascesa dei rappresentanti
delle classi sociali più basse al potere, nell’amministrazione e nell’apparato della
sicurezza.7
Durante la prima sessione, Sejm (la camera bassa del Parlamento) elesse il
presidente, Boleslaw Bierut, che convocò il nuovo governo, della cui coalizione
facevano parte i partiti che rappresentavano il “blocco democratico”. In realtà il potere
fu concentrato nelle mani del PPR.
Le potenze occidentali, proprio come nel caso del referendum, non reagirono dinnanzi
alla falsificazione dei risultati e il nuovo governo guadagnò il proprio riconoscimento
sul palcoscenico politico internazionale. Il che significava adempiere alle decisioni
prese in occasione delle conferenze post belliche. In altre parole si riconobbe che le
decisioni prese in occasione delle conferenze per la pace erano state messe in pratica e
che la Polonia era stata inserita nell’area di influenza dell’URSS.
Successivamente a queste disposizioni, Il Cremlino dovette uniformare lo scenario
politico e pertanto e eliminare i partiti ancora esistenti. In questo modo, nel 1948, non
esisteva praticamente nessuna opposizione importante.8
La Polonia del dopoguerra era devastata, saccheggiata dall’Armata Rossa, per la
quale, fino al ’45, le fabbriche e i latifondi del paese non rappresentarono che “cave” di
materiali e materie prime utili da trasportare in URSS.
I comunisti monopolizzarono perfino l’economia. Su ordine di Stalin venne respinta la
possibilità di partecipare al piano Marshall per la ricostruzione nel dopo guerra. Negli
anni 1945-48 vennero poste le basi per poter implementare l’economia pianificata. Il
governo mirava alla liquidazione della proprietà privata, dalle proprietà agricole alle
fabbriche e alle piccole imprese. Lo scopo era quello di sostituire il mercato libero con
un’economia pianificata e gestita dall’alto, dagli organi statali. Nel 1946, lo stato si
impossessò senza risarcimento delle proprietà tedesche e, con un indennizzo minimo,
7Cfr. W. Biernacki, Komunizm w Polsce, zdrada, zbrodnia, zakłamanie, zniewolenie,
Wydawnictwo Ryszard Kłuszczyński, Kraków 2005, pp. 73-80 8Cfr. A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał,,op.cit, pp. 207-249
9
delle imprese chiave polacche: le miniere, le fonderie, le fabbriche dell’industria tessile,
la comunicazione e i trasporti.
Negli anni 1946-1947 fu implementato il Piano dei tre anni. Secondo la propaganda, i
suoi ambiziosi obiettivi erano l’aumento dalla qualità di vita delle masse lavoratrici fino
ai valori dell’anteguerra e l’unificazione economica delle terre recuperate. In realtà,
l’obiettivo era quello di gettare le basi per la comunizzazione dell’economia nonché di
consolidare il sistema politico e di ristrutturare il sistema economico e sociale del
paese.9
Secondo fonti ufficiali, il piano fu realizzato prima del
previsto. A tale successo contribuirono fattori non
menzionati dalla propaganda. Insieme alle modifiche
relative ai confini politici del paese, aumentò il livello
di industrializzazione e quindi la possibilità di trovare
un impiego; inoltre la società, decimata dalla guerra,
risultava benestante poiché tutti i valori venivano
calcolati pro capite.10
Finalmente nel 1949 nacque dalla fusione di PPR e PPS
(Polska Partia Socjalistyczna- il Partito Socialista
Polacco), PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza- Partito Unito degli Operai
Polacco), il Partito, l’organo politico che dominerà la scena politica polacca fino al
1989. Come nell’Unione Sovietica, il Partito iniziò ad organizzare a tutti i livelli
l’amministrazione, controllata dall’alto dallo PZPR. Alla fine il sistema governativo fu
decretato nella costituzione del 22 luglio 1952. Il testo del documento fu redatto in
accordo con il Cremlino e riconosciuto da Stalin. La costituzione non conteneva
nessuna garanzia dei diritti dei cittadini. Il sistema degli organi statali fu modificato: la
carica del presidente fu sostituita dal Consiglio Statale. Le prime frasi della
costituzione contengono il nuovo nome del paese: “La Repubblica Popolare di Polonia
9Cfr. W. Biernacki, op.cit, Wydawnictwo Ryszard Kłuszczyński, Kraków 2005, pp. 73-80
10 Idem, pp. 82-83
10
(PRL- Polska Rzeczpospolita Ludowa) è una repubblica di lavoratori. La base del
potere popolare è costituita dall’alleanza fra la classe operaia e gli agricoltori”.11
L’apparente indipendenza del partito e del governo fu mantenuta ma vennero create
istituzioni fittizie subordinate al PZPR e gestite dai comunisti.
In questo lavoro vorrei occuparmi della situazione delle donne in questo contesto
sociale completamente nuovo. Il comunismo ha dato grandi opportunità alla gente dei
gruppi sociali storicamente svantaggiati, alla classe operaia, ai contadini e anche alle
donne. Queste riforme però non furono il risultato di una graduale evoluzione sociale,
bensì, si trattò di riforme imposte dall’alto, incluse nel programma del nuovo governo
rivoluzionario. E per certi versi erano rivoluzionarie. Basti pensare alle donne che
lavoravano in miniera, ai figli dei contadini che frequentavano l’università, ai
discendenti degli operai che occupavano dei posti importanti al vertice del potere. La
forza politica dei comunisti in Polonia ha reso possibile l’imposizione delle riforme e la
loro rapida messa in atto. Tuttavia, visto l’aspetto repressivo di quest’ingegneria sociale,
non tutti erano pronti ad accettare mentalmente i cambiamenti forzati che andavano
contro le proprie tradizioni e norme sociali.
Perciò, le donne, se da una parte ebbero la possibilità di emanciparsi, uscire di
casa, intraprendere un lavoro e partecipare nella vita politica, dall’altra si videro
discriminate sui posti di lavoro e travolte dal doppio lavoro: quello retribuito e quello
domestico. Con le migrazioni delle uomini, si aprì loro la possibilità del
raggiungimento dell’indipendenza economica e personale. Allo stesso, però, non
avevano la possibilità di fare carriera ecc.; avevano il diritto di aborto ma non potevano
abortire senza il permesso del medico.
In questo lavoro, cercherò di approfondire questi e altri paradossi, aiutandomi con la
biografia di Anna Walentynowicz. Subito dopo la guerra, Anna Walentynowicz arriva a
Danzica, un'importante città portuale, dove trova lavoro come saldatrice in un cantiere
navale e adempie a tutti i postulati del comunismo. Diverrà presto un’eroina del lavoro
nonché un’impegnata attivista, per poi rendersi conto di quanto il sistema fosse corrotto.
Con il passare del tempo contesterà apertamente il comunismo e si impegnerà
11
La premessa della costituzione della Polonia Popolare del 22 luglio 1952, da consultare sul sito
<http://www.staff.amu.edu.pl>
11
attivamente per combatterlo: senza Anna Walentynowicz né ci sarebbe stato
Solidarność né avrebbe avuto luogo la transizione del 1989.
Nel primo capitolo mi concentrerò sulla vita professionale. Parlerò del piano
triennale economico per la ricostruzione del paese dopo la guerra. La mancanza della
manodopera fece si che centinaia di migliaia di giovani a abbandonarono le loro case
per cercare lavoro altrove. Con un nuovo sistema economico si aprirono nuove
possibilità anche per le donne. Mi occuperò della gerarchia sul posto di lavoro e del
fenomeno dell’eroismo del lavoro.
Il secondo capitolo è invece incentrato sulla vita privata. Partirò dal matrimonio
e dalle leggi civili che regolarizzavano le unioni; tratterò del divorzio e delle sue
eventuali cause, fra cui la violenza sulle donne. Cercherò di far comprendere quale fosse
l’importanza della maternità nella società, descriverò la politica sociale, la
pianificazione della famiglia, la politica sull’aborto e la posizione della Chiesa nei
confronti delle nuove politiche sociali. Non da ultimo, tratterò del doppio fardello delle
donne: il lavoro retribuito e quello gratuito a casa che di solito era un compito
esclusivamente femminile. Parleremo anche del tempo libero, la libertà sessuale e
consumismo degli anni ‘60 durante disgelo dopo la morte di Stalin.
Il terzo capitolo sul viaggio di Anna Walentynowicz verso la libertà, a partire
dagli anni ’70 fino alla sua trasformazione, nel 1989. Parlerò delle crisi e degli scioperi
degli anni ’70 e ’80 che scoppiarono fra l’altro nel cantiere navale di Danzica.
Accennerò alla nascita di Solidarność, la risposta dello stato la quale la legge marziale,
l’attività dei dissidenti coronata dai colloqui della Tavola Rotonda e dalla
trasformazione del ’89. Nei passaggi sopraelencati il ruolo di Anna Walentynowicz
giocò un ruolo chiave e possiamo affermare che senza di lei, senza la sua visione e
tenacia, i cambiamenti non sarebbero avvenuti così presto.
12
1. LAVORO
1.1 LE MIGRAZIONI
La migrazione dalle aree rurali verso quelle urbane era un fenomeno importante già nel
XIX-esimo e all’inizio del XX-esimo secolo, in un contesto d’industrializzazione. Lo
spostamento in un ambiente diverso e l’assunzione di altri ruoli sociali contribuiva al
cambiamento dell’identità. Come scrive Małgorzata Fidelis“ transition from village to
city changed their identities.”12
Sotto lo stalinismo questa transizione mirava alla creazione di un nuovo tipo di persona,
totalmente dedita alla causa socialista, che metteva il bene sella società al di sopra del
bene personale. La donna aveva ancora più responsabilità politiche dell’uomo: a parte
costruire il socialismo, la donna era responsabile anche dell’accudire e crescere le nuove
generazioni di cittadini comunisti.
Il Partito inseriva le donne nel mondo di lavoro in grandi numeri, sia quelle che
lavoravano nell’industria già da prima della guerra, sia le nuove arrivate. Anzi,
consideravano le giovani ragazze che migravano delle aree rurali e senza nessuna
esperienza come una tabula rasa, un materiale perfetto per creare delle lavoratrici
modello per lo stato comunista.
In questa parte si prenderà ad esempio l’industria tessile di Zambrów, nel
nordest della Polonia. Dal punto di vista economico, costruire una fabbrica in un posto
non sito in prossimità di un fiume, senza nemmeno una linea ferroviaria, aveva poco
senso, ma l’industria tessile in quella regione era un’impresa ideologica. Era uno dei
punti più chiari del piano economico di sei anni, doveva portare il progresso, il
benessere e la coscienza politica in una regione storicamente agricola e arretrata. La
fabbrica di Zambrów era pubblicizzata come una delle più moderne costruzioni di
12
M. Fidelis, op.cit, p. 13
13
questo tipo in Europa. L’Unione Sovietica aiutò a finanziare il progetto, il che ha
rafforzato la natura stalinista dell’investimento.
Anche se nella vicina Białystok funzionava l’industria tessile, la regione rimaneva
un’area rurale, con più del 75% degli abitanti impiegati nelle proprie piccole fattorie. La
costruzione della fabbrica non era solamente un tentativo di industrializzare la regione,
ma anche la risposta al passato di quella piccola cittadina. Nel periodo fra le guerre, a
Zambrów si trovava una guarnigione che ospitava un reggimento di fanteria e due
collegi per cadetti. La città era popolata dall’élite militare intorno alla quale funzionava
una comunità polacco-ebrea che provvedeva ai suoi bisogni. Il passaggio quindi da
piccola cittadina militare a centro industriale che offriva lavoro e progresso,
rappresentava per l propaganda un’opportunità unica di mettere in risalto le conquiste
del comunismo. Le pubblicazioni ufficiali sottolineavano la rottura con il passato fatto
di casupole di legno costruite alla bell’e meglio, i bambini scalzi con le pance gonfie
dalla fame e le strade piene di fango e annunciavano un futuro luminoso sotto le ali
protettrici del comunismo.13
Prima ancora dell’apertura ufficiale della fabbrica nel luglio 1954, più di duecento
contadine fra i sedici e i vent’anni vennero reclutate e spedite nei centri storici
dell’industria tessile, quali Łódź e Bielawa, per l’addestramento. Come la città, così
anche queste giovani donne dovevano passare dalla povertà e l’arretramento al
progresso e al benessere. Il reclutamento per il lavoro era un punto centrale della
politica lavorativa perché in contrasto con il capitalismo, che vedeva il lavoro come un
bene che poteva essere venduto e comprato; nel comunismo il lavoro era alla base della
relazione fra lo stato e i cittadini. Era il mezzo attraverso il quale lo Stato non solamente
controllava la società, ma poteva anche trasformarla sia mentalmente che
economicamente. Così il reclutamento, l’addestramento e l’impiego delle donne a
Zambrów non era solo una strategia economica ma anche un tentativo di farne dei
cittadini socialisti a tutti gli effetti.
Il Piano di Sei Anni provocò migrazioni senza precedenti dalle campagne verso
le città. Circa 700.000 persone (il 6,5% della popolazione di allora lasciarono le aree
rurali cercando nuove opportunità in città e le donne rappresentavano più della metà
13
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp 104-107
14
della gente in movimento nella Polonia stalinista.14
Molti giovani partivano per
frequentare le sempre più diffuse Scuole di Addestramento Industriale. Di
l’addestramento durava da dodici a diciotto mesi, dopodiché gli veniva assegnato un
lavoro di due anni in una delle fabbriche di riferimento. Nell’industria tessile le donne
rappresentavano il 60% delle nuove candidate e lavoravano 200 ore mensili con uno
stipendio di circa 270 złoty (la valuta polacca). L’alloggio era gratis ma i candidati
dovevano pagare il vitto che veniva a costare all’incirca 210 zloty al mese. Il che
lasciava pochi soldi per qualsiasi altra spesa. Dopo sei mesi, i candidati potevano essere
trasferiti e svolgere un lavoro a cottimo per 700 zloty al mese circa. Durante il periodo
di addestramento i lavoratori avevano il diritto di andare a trovare la famiglia una volta
al mese, ma, viste le condizioni economiche, solo pochi fra coloro che vivevano lontano
sfruttavano questa possibilità. In certi casi alle nuove arrivate veniva data un’identità
nuova. All’arrivo, come ricorda Regina, alle reclute veniva dato un intero corredo, dalle
scarpe ai capotti, dai reggiseni ai i vestiti da lavoro, nonché la carta da pacchi e il filo
per poter spedire i vestiti vecchi e gli oggetti personali a casa.15
Non tutti coloro che migrarono lo fecero di spontanea volontà. L’associazione
Servizio alla Polonia (Służba Polsce SP) era un’organizzazione subordinata all’Unione
della Gioventù Polacca (Związek Młodzierzy Polskiej- ZMP), cioè un’organizzazione
nazionale giovanile subordinata al PZPR. La SP faceva leva sui giovani dai sedici ai
vent’anni per convincerli a frequentare le Scuole di Addestramento Industriale. Le
amministrazioni locali fornivano gli elenchi dei giovani uomini e donne che si
qualificavano per il lavoro industriale. I prescelti dovevano presentarsi alla sede locale
della ZMP e sottoporsi agli esami medici. Dopodiché venivano assegnati al lavoro o alla
scuola, secondo le loro capacità. Il reclutamento da parte della SP era uno dei tanti
stratagemmi volti a smantellare la cultura tradizionale dei contadini. L’esempio più
lampante era la collettivizzazione delle singole fattorie e il tentativo di sradicare i
contadini come classe sociale e trasformarli in operatori agrari. Era ovvio quindi che i
genitori non volevano dar via i loro figli all’organizzazione che già sfruttava le loro
comunità. Un altro fattore era il timore per la morale delle figlie. I maschi erano
14
Cfr. A. Gawryszewski, Ludność Polski w XX wieku, PAN, Warszawa 2005, pp. 140-143 15
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp. 107-109
15
sottoposti da anni alla leva militare; quanto alle figlie, tuttavia, i genitori temevano per
la loro condotta e la loro innocenza. La città era percepita come un posto di perdizione e
caduta morale e i genitori spesso rifiutavano di mandare le figlie in città anche
solamente per delle commissioni. Quanto alla SP i genitori spesso imbrogliavano
oppure semplicemente non facevano entrare gli ufficiali, scioglievano i cani ecc. C’era
però anche che nel reclutamento da parte della SP trovò l’opportunità della vita.
Esistevano tante famiglie estremamente povere che non potevano permettersi né di
educare né di mantenere le figlie. Per alcune donne il servizio per il paese rappresentò
l’unico modo di lasciare il villaggio paterno e
scappare dalla povertà estrema.
Anche se la fabbrica fu aperta nel ’54, le
sue condizioni non erano perfette così come
presentate dalla propaganda ufficiale. Fin
dall’inizio, la catena non funzionava come avrebbe
dovuto, diverse parti si rompevano e, visto che i
pezzi di ricambio erano di produzione sovietica, e i
pezzi polacchi non erano adatti, bisognava
aspettare a lungo per cambiarle; l’aria condizionata non funzionava, il che si sommava
alle pesanti condizioni di lavoro. Le condizioni di lavoro facevano sentire ancor di più
anche l’assenza dei bagni, che erano stati convertiti in magazzini.16
La fabbrica di Zambrów garantiva alloggi alle operaie nel nuovo Ostello del
Giovane Operaio (Dom Młodego Robotnika). La struttura serviva a dare alloggio alle
lavoratrici non sposate che dopo il matrimonio avrebbero dovuto traslocare negli
appartamenti dati dallo stato alle famiglie.
Secondo l’idea del Partito, i così detti Ostelli Operai dovevano essere qualcosa di più di
un semplice dormitorio. Facevano parte di un progetto più ampio di crescere e
sorvegliare i nuovi proletari. La struttura, la vicinanza con il posto di lavoro e le stanze
condivise dovevano svolgere un ruolo particolare nella vita dei giovani operai. Le
stanze erano arredate con due o quattro letti, uno specchio e un armadio. I bagni erano
16
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp. 110- 121
16
in comune, così come la lavanderia e la mensa. Le stanze non garantivano nessuna
privacy, ne richiedevano manutenzione. Dei pasti si occupava l’apposita mensa, delle
pulizie lo staff professionale, e i panni venivano lavati in una lavanderia comune.
Questo particolare ambiente era totalmente diverso dal nucleo familiare che
conoscevano le giovani operaie, dalle case dove le madri insegnavano alle figlie a
cucinare, a crescere i figli, a badare agli animali e a coltivare l’orto. Negli Ostelli
venivano alloggiate le giovani donne, senza nessun legame familiare ne doveri
casalinghi. La sospensione dei ruoli tradizionali donava loro una nuova identità, in
primo luogo di lavoratrici, senza tempo da perdere per le faccende domestiche.
La realtà però era ben diversa dalle idee socialiste. I rapporti dei rappresentanti
del Partito e degli attivisti di ZMP continuavano a descrivere le difficili condizioni di
vita negli Ostelli. I visitatori e gli abitanti si lamentavano dell’affollamento, della
sporcizia, dei i servizi sanitari non funzionanti e del cibo scadente nelle mense.
Comunque sia, stando alle memorie delle donne che lavoravano a Zambrów, in quel
periodo erano grate di poter stare là. Bisogna ricordarsi che, dopo la guerra, le
condizioni di vita in Polonia erano difficili: più della metà delle case non aveva
l’elettricità, le case erano affollate e la dieta di un contadino medio era composta di
patate, pane, farina e verdura, con la carne e lo zucchero presenti sulla tavola durante le
feste. Quindi spesso le ragazze avevano più comfort (intesi come il letto e tre pasti al
giorno) all’Ostello che alle loro case.17
Anche se ufficialmente le donne venivano incoraggiate a completare
l’educazione di livello elementare oppure a continuare gli studi alle scuole tecniche, le
vere opportunità erano limitate. Nel 1955, 207 filatrici non avevano compiuto le sette
classi della scuola elementare e, sebbene presso le fabbriche venivano organizzati corsi
per permettere loro di completare gli studi, venivano frequentati solamente da pochi
operai.
Spesso il duro lavoro impediva a molte di loro di intraprendere gli studi: dopo un turno
di lavoro, le donne erano cosi stanche da poter solamente tornare a casa, lavarsi e
dormire. Inoltre, a volte le lezioni si sovrapponevano ai turni di lavoro, bisognava o
17
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp. 122-123
17
alzarsi prima per andare a scuola prima del lavoro, oppure, dopo un turno di notte
rimanere in fabbrica per attendere le lezioni.
La cultura operaia a Zambrów si stava ancora formando, le giovani operaie
erano la prima generazione di lavoratrici industriali. Mancavano le iniziative collegate
al lavoro, come gli scioperi. Le donne erano sole, lontano dalle famiglie probabilmente
per la prima volta. Alla solitudine si aggiungeva la paura di perdere il lavoro. Per la
maggior parte dei lavoratori, e sicuramente per le giovani filatrici, il lavoro in fabbrica,
anche se molto pesante, rappresentava un’imperdibile opportunità di ascesa sociale che
bloccava qualsiasi volontà di opporsi.
In queste circostanze le giovani donne trovarono il modo di reinterpretare l’etica del
lavoro socialista. Le nuove arrivate erano per la stragrande maggioranza di origini
contadine e conciliarono in maniera unica lo stile di vita urbano con le tradizioni
contadine. Tanti impiegati erano così detti lavoratori agrari. Chi viveva vicino alla
fabbrica, combinava il lavoro retribuito con quello nella fattoria dei genitori. Nelle
regioni dominate dall’industria pesante, come Silesia, la maggior parte degli uomini
migravano verso le città viste le maggiori opportunità di trovare un lavoro, mentre le
donne rimanevano in campagna a occuparsi della fattoria. Nei terreni dominati
dall’industria tessile si verificava il fenomeno contrario. Questo schema si diffuse
ancora di più negli anni ’60, quando parte delle filatrici sposò i contadini locali. La vita
era scandita dal calendario religioso e naturale, dal susseguirsi delle stagioni, piuttosto
che dal calendario statale. Le donne cercavano di liberarsi dal lavoro durante la
mietitura o la raccolta delle patate, anche se spesso le assenze dal lavoro venivano
punite tribunale del lavoro con alte multe.18
La vita nella città dava sicuramente più opportunità alle ragazze di scoprire
nuovi modi di essere donne. La motivazione che spingeva tante giovani donne a lasciare
la casa era proprio evitare ripetere la vita delle loro madri, che partorivano un figlio
dopo l’altro e sacrificavano tutto il loro tempo per la famiglia e la fattoria.
Invece, in città, con un orario di lavoro regolare e nessun dovere familiare, le donne
scoprirono il tempo libero. Le ragazze curavano molto l’aspetto fisico, andavano spesso
dal parrucchiere, si truccavano, risparmiavano sul cibo per potersi comprare vestiti alla
18
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp. 115-116
18
moda. Uscivano insieme per andare a ballare senza aspettare che un uomo le invitasse, e
durante quelle uscite incontravano il sesso opposto. Negli Ostelli iniziarono ad aver
luogo visite da parte di “parenti” maschi, che ogni tanto continuavano fino a notte tarda.
L’emancipazione di queste giovani donne preoccupava molto gli ufficiali. Pensavano
che i dormitori separati avrebbero risolto il problema. È interessante la preoccupazione
sociale per quanto riguarda la sessualità delle donne. Erano percepite come creature da
proteggere dai pericoli del mondo e anche in gran parte da loro stesse. Con
l’industrializzazione, per la prima volta in così grande numero, gli uomini e le donne
ritrovarono a condividere gli stessi spazi. Dopo secoli di vita in due ambienti ben
distinti, la casa e il “fuori casa”, la società sentiva la responsabilità di sorvegliare le
donne nella loro recentemente acquistata libertà. Nessuno però pensò di mettere a freno
la libertà degli uomini.
Nei casi di estrema ostinatezza da parte delle ragazze, la direzione degli ostelli arrivava
a chiamare i genitori per disciplinare le colpevoli. A quanto sembra gli argomenti dei
padri erano abbastanza convincenti.19
La transizione dalla campagna alla fabbrica non era solamente geografica ma
anche politica, ideologica e materiale. Le donne di Zambrów erano economicamente
indipendenti, impegnate in tante attività non domestiche ed erano molto diverse dalle
coetanee che rimaste in campagna. Seguivano la moda, curavano il corpo, andavano a
ballare. Questi cambiamenti erano ben visti dallo Stato, se moderati, ma il nuovo
proletariato cercava di definirsi scegliendo dal modello di vita urbano e da quello rurale
elementi comunisti e non. Allo stesso tempo, le donne lavoravano e partecipavano alle
attività culturali organizzate dallo stato e si dichiaravano di fede cattolica,
abbandonavano il lavoro per aiutare i genitori in campagna. La sfida più grande per lo
Stato era la sospensione dei ruoli tradizionali. Nella loro assenza le donne cercavano di
autodefinirsi di nuovo. Le giovani donne libere dal controllo della famiglia
sperimentavano il consumo e la sessualità. In questo modo influenzarono la politica
ufficiale. Inseguendo la loro idea di emancipazione hanno sfidato la visione socialista di
una nuova società comunista.
19
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp. 127-128
19
1.2 NUOVE POSSIBILITA’
Dal punto di vista economico la prima metà degli anni ’50 era dominata dal
Piano Economico di Sei Anni. La pressione intensificata dall’industrializzazione di
stampo sovietico. Gli investimenti si concentravano nell’industria pesante e
metallurgica, con la creazione dello stabilimento modello di Nowa Huta, un intero
complesso metallurgico ai sobborghi di Cracovia che divenne una città a parte.
Secondo il Piano, il livello d’industrializzazione della Polonia avrebbe dovuto
aumentare dell’85-95%; invece, quanto all’agricoltura, ci si aspettava una crescita
del 35-45%. Il piano prevedeva la costruzione di centinaia si stabilimenti industriali,
non solo la metallurgia, ma anche l’industria mineraria, chimica e dei trasporti.
Questi investimenti dovevano contribuire alla costruzione del socialismo.20
Fu lo sviluppo dell’industria pesante a decretare il successo del piano. Tuttavia,
un’industrializzazione cosi intensa non poteva non influenzare altri rami dell’economia
nonché la vita dei cittadini. Il prezzo da pagare era una crescita limitata del livello di
vita, ridotti investimenti in altri settori, ad esempio quello immobiliare. La sproporzione
fra la domanda e l’offerta diventava sempre più marcata. Il rifornimento degli articoli di
prima necessità non era continuo e fu necessario tornare alla regolamentazione dei
prodotti alimentari (tessere annonarie).
Il Piano di Sei Anni lanciò una campagna che mirava all’introduzione delle
donne nelle professioni tipicamente maschili, chiamate le nuove professioni (nowe
zawody). Anche se le donne già erano presenti nel mondo del lavoro, questa campagna
rappresentava per loro una grande opportunità visto che si trattava di lavori qualificati
come tornitore, fabbro, muratore, conducente di mezzi pubblici, minatore ecc. . Si
trattava di un vero e proprio punto di svolta, poiché fino ad allora le donne avevano
trovato impiego in massa nelle varie industrie ma svolgevano lavori non qualificati,
malpagati e non avevano praticamente nessuna possibilità di salire di grado nella
gerarchia del posto di lavoro.
20
Cfr. A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał,, op.cit, pp. 251-299
20
La Silesia era una regione fortemente industrializzata ancor prima della guerra; la sua
ricchezza primaria era il carbone. In seguito alla guerra, alle deportazioni e alle
migrazioni nonché ad una severa politica etnica (per colpa delle tensioni politiche sullo
sfondo nazionale fra i polacchi e i tedeschi in passato, dopo la guerra questi ultimi
venivano discriminati sul posto di lavoro) in tutta la regione mancava manodopera. Le
miniere e gli stabilimenti metallurgici cercavano urgentemente figure professionali
come fabbri, tornitori, elettricisti, minatori, saldatori, affilatori ecc. Il Piano di Sei Anni
si prefissava degli obiettivi molto alti quanto all’estrazione del carbone, considerando la
scarsità del personale. Il Piano prevedeva l’estrazione di 100.000.000 di tonnellate
l’anno di carbone, aprendo undici nuove miniere e trentasei livelli di estrazione nelle
miniere già esistenti. Mirava anche all’aumento del numero degli operai qualificati da
80.000 a 100.000 nel 1955. Per rimediare alla scarsità del personale il Partito ammise al
lavoro i prigionieri politici, i soldati e le brigate giovanili di SP e ZMP. La forza lavoro
continuava a scarseggiare. In queste circostanze c’erano ancora delle donne disoccupate.
Nel 1950, l’ufficio di collocamento di Katowice stimò che il numero di donne
disoccupate era di 21.000. Se solo le donne avessero potuto occupare i posti di lavoro
qualificati, la disoccupazione femminile sarebbe stata sradicata.21
La politica delle nuove professioni aveva allora due lati: da una parte mirava a saturare
il mercato dei lavoratori per poter raggiungere gli obiettivi imposti dal Piano di Sei
Anni, dall’altra cercava di implementare un’ideologia socialista di uguaglianza. Nel
settembre del 1950, il PZPR convocò la Commissione per l’Inserimento delle Donne
nell’Industria nelle Nuove Professioni. La commissione inseriva le donne disoccupate
nel mondo del lavoro, ma le aiutava anche a farsi strada nelle posizioni lavorative
dominate dagli uomini. Si trattava di un punto fondamentale in quanto marcava la
differenza fra la posizione subordinata della donna nell’industria durante l’attuazione
del Piano di Tre Anni (1945-48) e la possibilità di avanzamento professionale un paio di
anni dopo. Malgrado l’incoraggiamento da parte dello Stato a cercare impiego nelle
nuove professioni, il Partito cercava di imporle dall’alto. Le donne dovevano si svolgere
i lavori tipicamente maschili, ma solo quelli che erano ridefiniti dagli economisti statali.
Il reclutamento era pur sempre basato sulle caratteristiche considerate in quel momento
21
Cfr. M. Fidelis, Kobiety w PRL-u, da consultare sul sito <http://www.wysokieobcasy.pl>
21
“naturali” per le donne o per gli uomini. La Commissione teneva a sottolineare che
anche se le donne fossero subentrate in tutti i rami dell’industria, sarebbe stato
necessario considerarle dal punto di vista psicofisico. Era dunque stabilito che, qualora
fosse stato possibile, le donne avrebbero dovuto essere sostituite dagli uomini ogni
qualvolta il lavoro rappresentasse un pericolo per la salute o richiedesse i turni di notte.
La Commissione propose inoltre la creazione, in tutte le industrie, di posti lavoro aperti
esclusivamente alle donne e di altri ancora le cui quote sarebbero state chiaramente
definite dalla legge. Quindi i legislatori e gli economisti vedevano la donna e l’uomo
come due esseri completamente diversi.22
Ovviamente non tutte le donne volevano lavorare nelle nuove professioni. Nemmeno
tutte erano adatte. Doveva essere un’avanguardia delle lavoratrici industriali. Donne di
carattere forte e di giusta inclinazione politica. Inoltre contava anche la salute, l’età e la
costituzione fisica. Le qualità maschili nelle candidate erano apprezzate: fisico robusto,
forza fisica e gli interessi politici. Le donne ritenute più “femminili” dovevano essere
indirizzate ai lavori meno pesanti, non necessariamente secondo le preferenze personali.
All’inizio del 1951 il Concilio dei Ministri adottò una risoluzione che limitava il
numero delle professioni proibite alle donne, fra cui il lavoro in miniera. Il Partito ha
ammesso che “there are no men’s and women’s work (…) in People’s Poland divisions
between “male” and “female” jobs have been erased. Only work results determine
professional advancement.”23
Dall’altra parte però, gli ufficiali criticavano la preferenza
di certi uomini per il lavoro leggero dicendo che gli uomini giovani in piena forza
avrebbero dovuto essere indirizzati verso lavori più “maschili”, sfruttando al massimo il
proprio potenziale e facendo in questo modo spazio a persone maggiormente tagliate per
quel tipo di lavoro piuttosto che un altro: uomo impiegato come commesso o cameriere
avrebbe fatto un torto alle donne occupando un posto di lavoro più adatto a loro.
La stampa ha trovato nelle donne approdate nelle professioni “maschili” un tema
perfetto per diffondere la propaganda ufficiale. Negli articoli venivano sottolineate le
qualità considerate “femminili” come il legame emozionale con le macchine che
operavano, con la fabbrica o la miniera che diventava la loro seconda casa, e l’affetto
22
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp. 145-146 23
Ibidem
22
per il loro lavoro. Le donne venivano lodate anche per la loro capacità di organizzare il
lavoro, l’attenzione al dettaglio, la pulizia e l’ordine sul posto di lavoro. Altro punto a
favore delle donne era il basso tasso di assenze al lavoro. Mentre gli uomini
tradizionalmente bevevano nel weekend e pertanto arrivavano tardi a lavoro o non si
presentavano affatto di lunedì, le donne erano sempre presenti al lavoro.
La sezione femminile del Partito e la propaganda si servivano delle qualità
tradizionalmente femminili per riformulare il concetto del lavoratore socialista modello
caratterizzato da grande disciplina, ottima gestione del tempo e devozione al lavoro.
Erano proprio queste le qualità delle donne nelle nuove professioni; le donne lavoravano
con la testa piuttosto che con i muscoli, curavano il posto di lavoro come se fosse la loro
casa e non lasciavano che l’alcol si intromettesse nel loro lavoro.
Nell’ordine sociale rovesciato e imposto dall’alto gli uomini non sempre si
trovavano bene. Dalle lettere scritte alle riviste emergevano contestazioni secondo cui le
donne sarebbero dovute tornare in cucina, egli uomini venivano trattati come cani,
mentre ogni parola delle donne sembrava oro ecc. Tali contestazioni indicavano che
tanti uomini avvertivano che la promozione delle donne a spese degli uomini non fosse
giusta.24
Le donne erano spesso soggette a discriminazioni sul posto di lavoro. I caposquadra gli
erano spesso apertamente ostili e le assegnavano a i posti di lavoro più difficili o le
facevano lavorare in condizioni volutamente pesanti. In questo modo impedivano che le
donne raggiungessero le quote prefissate di produzione, privandole in tal modo dei
premi. Così le donne, anche quelle qualificate, raramente svolgevano lavori più
importanti, così come non raggiungevano quasi mai posizioni manageriali. Se da un lato
si potrebbe incolpare il “bullismo” e la discriminazione da parte degli uomini, dall’altra
erano le donne stesse ad avere paura di accettare le mansioni che richiedevano più
responsabilità, non volendo essere derise dagli uomini che prendevano in giro le donne
indipendenti.
Già intorno alla metà del 1951, le miniere in Silesia assunsero 560 donne in 37
miniere. Erano donne di età compresa fra i 19 e i 50 anni. Per essere ammesse al lavoro
in miniera, le donne dovevano sottoporsi ad un esame medico, compresa una visita
24
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp. 150-151
23
ginecologica. Guadagnavano 550-650, da 150 fino a 300 zloty in più rispetto a qualsiasi
altro lavoro in superficie. Ironicamente, il lavoro sotto terra era quasi completamente
meccanizzato; inoltre, in quanto i lavoratori non erano esposti alle intemperie, risultava
molto meno pesante dei lavori svolti in superficie. Le donne che potevano lavorare sotto
terra si consideravano fortunate. Di conseguenza, ben presto il numero di candidate
superò ogni aspettativa e in alcune miniere non c’erano più posti vacanti per tutte le
donne che desideravano essere assunte.
Inoltre, negli anni ’50, anche le scuole tecniche iniziarono ad accogliere le
donne. Le miniere avevano bisogno di elettricisti, saldatori, tornitori e altri tecnici sia
sotto terra che in superficie. Questi istituti erano tradizionalmente riservati agli uomini
ma con il cambio della politica davano un’opportunità di guadagni maggiori nonché un
lavoro fisicamente meno pesante anche per le donne.25
Quelle donne che scelsero di lavorare sotto terra non erano attratte solamente dai
guadagni maggiori o da un lavoro più leggero. Nei ricordi delle minatrici di quel
periodo ritorna l’idea di svolgere un lavoro eroico, sotto continuo pericolo e anche la
possibilità di lavorare in un posto astratto, completamente staccato dalla vita di tutti i
giorni, dove vigevano altre regole. Le donne invece che invece optarono per il lavoro in
superficie argomentavano la loro scelta con sicurezza. Dicevano che il lavoro sotto terra
era molto pericoloso, gli incidenti erano frequenti. Le donne sposate, prima decidere,
dovevano consultarsi con i mariti, che erano spesso contrari. Anche la presenza dei figli
spesso influenzava le scelte delle donne.
Le attiviste delle organizzazioni femminili sottolineavano l’impatto positivo
delle donne sui colleghi e sul posto di lavoro in generale. Sostenevano che la presenza
delle donne contribuisse ad evitare, da parte degli uomini, bestemmie, battute e storie
volgari. Le donne erano anche lodate per la loro disciplina sul lavoro e la pulizia. Erano
più attenzione alle regole sulla sicurezza di quanto non lo fossero gli uomini, fattore che
contribuì al calo degli incidenti e dei danni all’attrezzatura.26
Tuttavia, le attiviste stesse, rimarcavano che tutta la campagna per le nuove occupazioni
non garantiva l’ascesa sociale delle donne su grande scala. Le donne che lavoravano in
25
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp. 154-155 26
One zdobyły nowy zawód, Trybuna Ludu, da consultare sul sito <http://www.ursynow.org.pl>
24
miniera guadagnavano si più delle loro college rimaste in superficie, ma sempre meno
dei minatori maschi che svolgevano lo stesso lavoro. Ricevevano meno assistenza da
parte dello Stato rispetto agli uomini. I manager non erano propensi a promuovere le
donne nella gerarchia, spesso si rifiutavano di spostare dal reparto cernita sottoterra
anche le lavoratrici qualificate. Un uomo e una donna con lo stesso curriculum venivano
assegnati a mansioni diverse. I due sessi venivano trattati diversamente già dalle scuole
tecniche. Mentre gli uomini facevano pratica sul campo, le donne visitavano la miniera
oppure, durante l’addestramento, veniva chiesto loro di riparare i vestiti da lavoro. Fin
dall’inizio, gli uomini venivano avviati a quei lavori considerati maschili e le donne a
quelli femminili.
Le voci che si opponevano al lavoro femminile in miniera erano quelle delle
mogli dei minatori. È necessario ricordare che la Silesia era una regione dove i valori
tradizionali erano molto forti. Nella cultura tradizionale il minatore era un eroe che
manteneva la famiglia rischiando la vita tutti i giorni. Alla donna era riservato il ruolo di
madre e moglie. Secondo il partito, il 60% delle donne capaci di lavorare non erano
interessate di intraprendere un lavoro retribuito. Queste donne difendevano i valori
tradizionali e la loro alta posizione nella società come le mogli dei minatori. Inoltre,
temevano le tentazioni sessuali alle quali, secondo loro, erano esposti i mariti. Per loro
la miniera era un non luogo misterioso dove i desideri si scatenano senza controllo.
Eppure furono pochi i rapporti su casi di promiscuità. Inoltre, come ammettevano le
minatrici stesse, le donne non resistevano a lungo sotto terra senza. Inoltre, secondo le
credenze popolari, la donna sotto terra portava sfortuna e avrebbe scatenato l’ira di santa
Barbara, santa patrona dei minatori.27
Fra tutte le nuove professioni, il lavoro delle minatrici era l’esempio più marcato
della politica economica del periodo stalinista. Per tante donne, questo tipo di lavoro
rappresentava un’opportunità per migliorare sia le proprie condizioni di lavoro, sia i
guadagni. Le donne si vantavano di guadagnare lo “stipendio di minatore” e di potersi
permettere non solo il necessario ma anche articoli extra, come i vestiti. Per altre donne,
tuttavia, si trattava di un rovesciamento dell’ordine sociale, combinato con la paura e
27
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp. 164-165
25
l’ansia riguardo al comportamento sessuale delle donne lavoratrici, ansia che
condizionerà le politiche di destalinizzazione.
1.3. STACANOVISMO
Il Piano di Sei anni prevedeva l’ingresso nell’industria di circa 1.230.000 donne
nell’ tutta la durata del programma per un numero di quasi 200.000 l’anno. L’ideologia
stalinista dava alle donne una vasta ma pur sempre limitata scelta di identità: potevano
essere lavoratrici, madri, mogli, consumatrici e attiviste. Il sistema le incoraggiava ad
adottare più identità.
Le donne quindi entravano in massa nell’industria, incoraggiate dallo Stato a
cercare lavoro nelle nuove professioni. Su trattava da una parte di necessità di
manodopera, dall’altra d’ideologia e propaganda. Il Partito era favorevole alla
tradizionale divisione dei lavori risalente all’epoca capitalista e indirizzava la maggior
parte delle donne verso lavori tipicamente femminili. Questa politica aumentò la
femminilizzazione del settore tessile nonché di quello dei servizi. Lo stato riposizionò
gli uomini impiegandoli nell’industria pesante, occupando i posti vacanti con le donne.
Anche se l’industria tessile, come già detto, era considerata un settore
tipicamente femminile e le donne rappresentavano quasi 60% delle impiegate, la
stragrande maggioranza di loro era incaricata dei lavori fisici più tediosi oppure
dell’organizzazione delle postazioni di lavoro, mentre gli uomini erano capisquadra o
meccanici. Nonostante la filatura fosse un lavoro complicato che richiedeva molta
esperienza, poiché non erano previsti corsi di preparazione, era considerato un lavoro
non qualificato e pertanto gerarchicamente basso. Nel settore tessile, le donne
guadagnavano in media il 64% dello stipendio di un uomo con lo stesso impiego.
Gli slogan del Piano di Sei anni promettevano di promuovere a posizioni
manageriali ben retribuite gli operai che sapevano lavorare duramente; tuttavia si
trattava di incarichi particolarmente difficili da ottenere per le donne. Alcune di loro,
soprattutto le impiegate nell’industria pesante, avevano più possibilità da questo punto
di vista, in quanto il Piano metteva in risalto le nuove professioni, i lavori tipicamente
26
maschili e quelli di responsabilità. Questa politica aveva comunque molto meno impatto
sui settori considerati femminili.28
Prendiamo come esempio la fabbrica tessile di Żyrardów, uno stabilimento a
circa 50km a sudest di Varsavia, costruito nel XIX-esimo secolo, dove le donne
rappresentavano più del 60% dei 6.430 lavoratori. Nel 1951, solo 255 donne
frequentavano il corso di addestramento. Solo poche donne vennero spostate ai lavori
tipicamente maschili, ai sensi del Piano di Sei anni. Solo il 15% e il 16% degli addetti
rispettivamente al controllo di qualità e ai lavori di rifinitura e il 16% dei maestri
tessitori era donna, mentre alle donne che avevano ricevuto l’addestramento spesso non
era permesso di svolgere il lavoro qualificato. Erano autorizzate a farlo solo in caso di
assenza dell’uomo.29
Nemmeno le possibilità di carriera erano tante. Sempre nella fabbrica di Żyrardów, solo
il 29% delle donne erano capisquadra. Sui 117 capibrigata, solo due erano donne.
La pratica stalinista di catapultare i lavoratori ai posti manageriali riguardò solo poche
donne. Nel ’5, a Żyrardów, le donne rappresentavano solamente il 4% degli operai
promossi. A percentuali così basse di donne con posti di responsabilità aveva
contribuito la politica per colpa della quale gli operai venivano promosse in un certo
senso a caso. Spesso non avevano né la giusta preparazione né l’esperienza necessaria in
un lavoro simile. Considerato questo, le donne a volte rinunciavano alle promozioni
oppure si ritiravano dopo pochi mesi.
Un altro modo per sottolineare il ruolo della donna nella costruzione dello
stalinismo era la propaganda, particolarmente necessaria nei diversi settori dell’industria
pesante. Il lavoro delle tessitrici, anche se molto meno celebrato di quello delle
minatrici veniva comunque chiamato “onorevole”, “lodevole”, e “indispensabile”.
Tuttavia, il metodo più semplice per eccellere nel lavoro non qualificato nel
mondo dell’industria tessile e di altri settori era lo stacanovismo, cioè la competizione
sul lavoro. Consisteva nel superare i limiti di produzione imposti dall’alto agli operai.
La competizione fra i lavoratori individuali presto si allargò fino a coinvolgere diverse
brigate, i turni nonché diversi stabilimenti in tutto il paese.
28
Cfr. J. Eisler, Polskie miesiące czyli kryzys(y) w PRL, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa
2008, pp 19-28 29
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp. 77-78
27
Nel 1951, il 50% dei partecipanti alle competizioni era donna. Nella fabbrica di
Żyrardów il 55% dei premiati per lo stacanovismo era donna. Gli incentivi economici
non erano l’unico motivo per battere i record di produzione. Il titolo di stacanovista
significava anche una certa fama e aumentava lo status sociale. Le foto degli
stacanovisti uscivano sui giornali accompagnate dagli articoli sui vincitori; in ogni
fabbrica esisteva una bacheca nella quale, accanto agli avvisi e ai limiti di produzione si
trovavano anche le foto e le note sui vincitori. Il record del 200-250% del limite
previsto era motivo di orgoglio. Per tante donne il lavoro in fabbrica rappresentava una
via di fuga dalla povertà; la loro devozione, quindi, si può anche spiegare come una
sorta di debito emozionale che hanno contratto con il loro posto di lavoro.30
Diverso era lo stacanovismo femminile nelle nuove professioni. Il solo fatto di
svolgere un lavoro maschile autorizzava le donne al titolo di stacanovista. La stampa
regalava loro più spazio, in quanto elementi con più coscienza politica e ideologica
rispetto alle donne impegnate in altri lavori. Il solo fatto svolgere incarichi non
convenzionali ne faceva delle eroine del lavoro socialista. La donna minatore più
famosa era Anna Żak della miniera Ziemowit a Lędziny. Era una madre singola di due
figli; suo marito era morto durante la guerra. La sua storia, da domestica a minatrice, era
spesso citata dalla stampa come esempio di emancipazione.
1.4. ANNA WALENTYNOWICZ
Anna Walentynowicz nacque il 15 agosto 1929 a Równe, una cittadina di 40.000
abitanti in Volinia, oggi Ucraina. Era la seconda figlia dei contadini Aleksandra e Jan
Lubczyk. Suo padre morì durante le prime settimane della guerra; la madre, sconvolta
dalla depressione, lo seguì poco dopo. La bambina di 10 anni venne adottata dai vicini
di casa. Grazie a loro, Anna sopravvisse alla guerra, nonostante i genitori adottivi, più
che una figlia, cercassero una serva. Anna Walentynowicz racconta di aver lavorato
dall’alba fino a notte fonda, sette giorni a settimana. Dopo che la Germania dichiarò la
guerra all’URSS la famiglia si spostò vicino a Varsavia. Anna lavorava sia in casa sia
30
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp. 79-80
28
come bracciante nelle fattorie dei dintorni, mantenendo così la famiglia. Dopo un
tentativo di suicidio a sedici anni decise di scappare. In cambio di vitto e alloggio presso
degli sconosciuti, lavorava nei campi, accudiva i bambini, si occupava del bucato ecc.
Finalmente arrivò a Danzica, dove trovò un posto fisso come babysitter presso la
famiglia Gładkowscy. Nel 1947, i suoi datori di lavoro, lasciarono la città e le cedono
un piccolo appartamento seminterrato a Danzica.
All’inizio del 1950, tramite un’agenzia interinale, Anna fu assunta dalla fabbrica
di margarina Amada, a Danzica.
Lei, come altre operaie, era piena di zelo e di gratitudine verso la nuova patria popolare
per l’opportunità che le è stata data. “Volevo lavorare meglio e di più per la gratitudine
verso la patria popolare che mi ha permesso di condurre una vita che prima nemmeno
sognavo, e che mi ha reso un cittadino a tutti gli effetti.”31
Il senso della missione la spinse a cercare un altro lavoro. Lubczyk sognava un
lavoro al Cantiere Navale di Danzica, il cui personale era in quel periodo insufficiente.
Le proposero diversi lavori, ma quello che le piaceva di più il saldatore. Nel novembre
del 1950 Anna fu stata ammessa al corso di addestramento per saldatori. Riempiendo il
formulario di ammissione non menzionò di aver frequentato solo quattro classi della
scuola elementare, poiché per lavorare era necessario aver frequentato le sette classi
obbligatorie della scuola elementare.
Il 7 novembre del 1950 Lubczyk superò l’esame di stato ed divenne apprendista
saldatrice, per poi diventare saldatrice professionista a febbraio del 1951. Fin dall’inizio
attirò l’attenzione dei suoi superiori per la diligenza e l’impegno che dimostrava sul
posto di lavoro. “Salda bene, è laboriosa, non si assenta dal lavoro, merita una
promozione”32
scriveva un suo superiore nell’autunno 1951.
All’inizio Anna Lubczyk si sentiva sola, le mancavano i contatti con la gente,
avrebbe voluto anche essere socialmente utile e attiva. Quando seppe dell’esistenza
della ZMP (unione della Gioventù Polacca), decise di entrare a farne parte, presso il
cantiere. Non sapeva però che l’organizzazione attraversava un momento di crisi, i
membri boicottavano gli incontri e i corsi ideologici dicendo che comunque non sarebbe
31
S. Cenckiewicz, Anna Solidarność, Zysk I S-KA, Poznań 2010, p. 38 32
Idem
29
cambiato nulla. Lei, tuttavia, aveva una grande voglia di fare, di dimostrare che non
lavorava solamente per i soldi, bensì che voleva fare qualcosa di più. Si impegnava nelle
azioni sociali, come, ad esempio, piantare foreste, contribuire all’ordine cittadino e,
ovviamente, organizzare le parate per il 1 maggio. Hanka Lubczyk, come la
chiamavano, divenne un esempio di donna lavoratrice, e i giornali locali iniziarono a
scrivere di lei.
L’atteggiamento modello di Lubczyk la fece eleggere nella rappresentanza polacca per
il Festival dei Giovani Lottatori per la Pace a Berlino a luglio 1951. A Berlino, alcuni
partecipanti polacchi scapparono e chiesero asilo politico. La reazione dei responsabili
del ZMP sorprese Anna. Durante un appello straordinario, i dirigenti proibirono ai
partecipanti di menzionare l’accaduto in Polonia, e fino alla fine del soggiorno i giovani
vennero tenuti sotto chiave.
Questi avvenimenti convinsero Anna Lubczyk ad abbandonare l’organizzazione dopo
otto mesi dal suo ingresso. “Per la prima volta ho visto (…) che vivo in un paese
poliziesco dove gli agenti di sicurezza e la milicja (la polizia comunista) controllano
tutte le aree della vita sociale (…) ho iniziato a percepire tanta ingiustizia con la quale
Hanna Lubczyk, come persona e come membro della ZMP, non poteva essere
d’accordo”.33
Dopo l’episodio della ZMP Anna Lubczyk si concentrò sul lavoro in cantiere.
Non la spaventava il lavoro monotono, la sveglia alle 5, l’inizio del lavoro alle 6. Era un
ottimo lavoratore. Dopo un anno di lavoro, Anna lavorava 420 ore mensili, per un
salario di 3200 złoty al mese, il 270% della norma. Era al primo posto della
competizione sul lavoro, e dunque un esempio per gli altri operai. Le sue foto erano
appese sulla bacheca del cantiere.
Più il suo ruolo nello stabilimento diventava importante, più si rendeva conto di
quanto lo stacanovismo fosse in realtà sfruttamento, del quale le vittime sono in primo
luogo le donne, trattate con disprezzo dalla direzione e da una parte dello staff maschile.
33
S. Cenckiewicz, op.cit, p. 45
30
2. LA VITA PRIVATA
La morte di Stalin il 5 marzo 1953 rappresentò un punto di svolta nella storia di
tutto il Blocco Sovietico. In termini generali, possiamo parlare di una maggiore libertà.
La politica economica che fino ad allora aveva favorito l’industria pesante subì dei
cambiamenti. I tentativi di aumentare il livello di vita misero in risalto l’industria
leggera e il settore dei servizi.
Anche se possiamo parlare di Disgelo già da pochi mesi dopo la morte di Stalin,
i veri cambiamenti arrivarono nel 1956. A giugno, a Poznań, la manifestazione pacifica
degli operai in poche si trasformò in scontro e lo Stato utilizzò i carri armati contri i
manifestanti, causando cinquanta morti e più di 200 feriti.34
Di fronte alla prima crisi così profonda dall’instaurazione del comunismo in Polonia, gli
ufficiali del PZPR decisero di eleggere Władysław Gomułka primo segretario del
Partito. Gomułka, negli anni 1951-53, era stato imprigionato per la sua “deviazione
verso la destra”, ed era quindi l’unica persona che godeva dell’appoggio sociale, visto
che si era opposto a Stalin. Gomułka intraprese La Strada Polacca Verso il Socialismo;
in pratica, voleva che la Polonia fosse più indipendente dall’Unione Sovietica.
Con il Disgelo, la libertà di parola era maggiore e la iniziava a condannare lo
stalinismo. L’opinione pubblica non si occupava solamente della politica o
dell’economia ma cercava, con lo scopo di costruire un socialismo umano, di indagare
sulla vita privata, sui rapporti familiari dei cittadini. Il tanto spazio dedicato all’ambito
privato, che mirava al perfezionamento del sistema comunista, era collegato con il
tentativo di tornare allo stato precomunista, quando la sfera privata della vita era
separata da quella pubblica. Le differenze di genere saranno la chiave per revisionare e
rimediare agli errori del periodo stalinista.35
34
Cfr. J. Eisler, op.cit , pp. 24-28 35
Cfr. A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, op.cit, pp. 301-312
31
2.1. IL MATRIMONIO
In prima pagina del numero di ottobre 1951 della rivista Nowa Kultura venne
pubblicato l’articolo allarmante che annunciava una grande crisi dell’istituzione del
matrimonio.36
La Polonia era al secondo posto della classifica dei paesi con il più alto
tasso dei divorzi, dopo la Germania. Tuttavia, insieme al numero di divorzi cresceva
anche quello dei matrimoni.
Nel 1931, si stimò che la percentuale di persone sposatesi nell’anno precedente era di
8,5 persone sposate, mentre nel 1951 era pari a 9,5. Inoltre si era abbassata l’età media
degli sposi: da 26,3 nel 1931 a 25,4 nel 1951. Secondo le statistiche i giovani erano più
propensi al divorzio rispetto alle persone mature. Nel 1953 il 24% delle coppie che
chiesero il divorzio, erano al primo anno di matrimonio.37
Il diritto polacco del 1950 e la sua interpretazione non spiega l’alto tasso dei
divorzi.
Il matrimonio civile obbligatorio era stato introdotto già nel 1945, come una delle prime
modifiche del codice civile. Nel 1950 la Polonia adottò il nuovo Codice della Famiglia,
che mirava alla stabilità della famiglia e del matrimonio. Zofia Wasiłkowska, un
attivista femminile scrisse “(…)the knowledge of the laws governing society and reality
teach us that it is the capitalist that is the biggest enemy of the family”.38
Il socialismo
non solo ha contribuito all’emancipazione delle donne ma ha anche rafforzato la
famiglia. “That women came out of the narrow circle of the four walls of the home did
not diminish in the least the significance of the family and marriage. On the contrary,
one needs to admit that only now marriage and the family have gained the proper
conditions to prosper.”39
Il principio dell’uguaglianza doveva assicurare che il
matrimonio non si basasse sullo scambio dei beni, bensì sull’amicizia e i sentimenti.
Il codice di Famiglia del ’51 prevedeva pari diritti per entrambi i sessi all’interno del
matrimonio e per quanto riguarda la custodia dei figli. Teoricamente, entrambi i partner
erano responsabili di provvedere ai bisogni della famiglia e alla casa. Il lavoro della
36
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp. 170-173 37
Ibidem 38
Ibidem 39
Ibidem
32
donna all’interno della casa era considerato dello stesso valore che il lavoro retribuito
fuori casa, con riguardo alla spartizione dei beni nel caso del divorzio. Inoltre la
maggiore indipendenza della donna all’interno del matrimonio era sottolineata dalla
possibilità di mantenere il cognome da nubile (mentre in Polonia si usava e si usa
ancora oggi che la donna prenda il cognome del marito).
Il divorzio, invece, non era una questione privata fra i due interessati, bensì un
affare dello Stato. Il matrimonio, quindi, non poteva essere sciolto solo grazie alla
volontà delle parti interessate. Era permesso solo in presenza di motivazioni molto serie
nonché di prove che indicassero che il divorzio era in contrasto con “la morale
socialista e che non poteva garantire delle condizioni normali di convivenza e per
crescere i figli”.40
Le lettere spedite alle riviste femminili possono rivelarci alcuni dei motivi
dell’insoddisfazione delle donne nel matrimonio. Il problema principale era la
mancanza dell’impegno del compagno nelle faccende domestiche e nel crescere i figli.
Altro motivo importante era la violenza domestica. Bisogna ricordare che in epoca
socialista non esisteva questo termine e l’uso della forza fisica in casa veniva chiamato
“il picchiare la moglie”.41
Il socialismo prometteva lo sradicamento dello sfruttamento, nonché l’emancipazione
femminile tramite l’eliminazione della subordinazione al marito grazie all’indipendenza
economica. La costituzione di ogni stato socialista garantiva la parità dei sessi, in
quanto valore alla base dell’ordine sociale sovietico. Si trattava di un documento che
poteva risultare radicale, paragonato ai rispettivi documenti degli paesi occidentali
poteva risultare anche radicale. Tuttavia, la parità dei sessi sancita dalla costituzione non
trovava nessun riscontro nella legislazione. In altre parole: non esistevano leggi che
costringessero all’osservanza del principio della parità dei sessi o pene previste in caso
tale principio venisse violato. L’impegno per il raggiungimento della parità dei sessi era
anche un argomento vincente sull’arena internazionale, e pertanto sfoggiato ai
comunisti durante la Guerra Fredda per sottolineare la supremazia dei paesi del blocco
sovietico sul mondo occidentale. Come esempio, i paesi socialisti potevano presentare
40
Cfr. S. Penn eds J. Massino, Gender, Politics and everyday life in State Socialist Eastern and
Central Europe,I. Marcus, Palgrave Macmillan, New York 2009, p. 115 41
Ibidem
33
le percentuali delle donne impiegate presso le strutture statali o nel Partito, spesso
raggiunte attraverso le quote minime d’impiego. Effettivamente, accanto a questi dati, i
rispettivi numeri/i corrispettivi dei paesi capitalisti sembravano miseri.
Nonostante la propaganda, la mentalità della società era ancora di tipo patriarcale: la
donna era sottomessa al padre e poi al marito. Lo stato promuoveva il lavoro femminile
ma le donne non occupavano quasi mai i posti manageriali ed era poco probabile che
entrassero far parte delle élites culturali o intellettuali. Il vero eroe del socialismo era
l’uomo. Per capire le disparità nel paese che promuoveva gli slogan di uguaglianza
bisogna prima approfondire i preconcetti riguardo la mascolinità e la femminilità nella
cultura socialista. Il modello di mascolinità era un lavoratore, fisicamente forte, un
leader, un eroe che costruiva la società socialista. Nell’immaginario comune, nonostante
lavorassero anche le donne, era l’uomo che, con il suo stipendio, manteneva la famiglia;
era quindi il “capo” della casa, gli altri membri della famiglia dovevano rispetto e
obbedienza.
La nuova indipendenza della donna poteva quindi essere causa di insicurezza per l’
uomo, che si sentiva minacciato nel suo ruolo tradizionale. Comunque poca attenzione
si faceva all’uomo al di fuori del lavoro, alla sua vita privata, al uomo-marito o padre.
Invece la donna, all’interno del sistema comunista, aveva un duplice ruolo: la madre e la
dipendente, anche se le era preclusa ogni possibilità avanzamento di carriera, poiché
questo avrebbe potuto rovesciare il sistema patriarcale.42
Come madre e casalinga la donna si occupava della gestione della casa, del marito e
degli anziani a carico della famiglia; in qualità di moglie doveva soddisfare anche i
bisogni sessuali del marito. Possiamo dire che secondo questo schema era l’uomo a
pretendere e la donna a soddisfare le sue richieste. La donna aveva il compito di mettere
a proprio agio il marito, se non addirittura di mostrarsi accondiscendente, a costo della
propria sofferenza. Storicamente, la predisposizione della donna alla sofferenza era
collegata alle figure bibliche di Eva e della Vergine Maria. Nella realtà socialista,
spogliata dello strato religioso, la propensione per la sofferenza era spiegata con la
capacità biologia di resistere al dolore fisico e quindi veniva attribuita alle donne anche
una gran forza psicologica nel resistere alla sofferenza.
42
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp. 176-177
34
Non soddisfare le richieste maschili poteva essere letto come una sfida verso il
capofamiglia. Culturalmente parlando l’uomo era autorizzato a “disciplinare” la
consorte per ricordarle il suo posto nella gerarchia di casa. La parola chiave nella
violenza domestica era proprio la disciplina.
Tutti sapevano dell’esistenza della violenza domestica, vigeva però una sorta di omertà.
Il silenzio era volto al mantenimento dell’onore del marito e della buona reputazione
della famiglia. Era opinione diffusa che “la donna saggia non rovina la reputazione della
famiglia e i panni sporchi si lavano in casa propria.”43
Il poco peso attribuito alla violenza domestica dimostrava l’assenza di statistiche a
riguardo. Spesso, non veniva prestata la dovuta attenzione alle denunce di violenza
domestica, tranne in casi di omicidio e mutilazioni gravi, e le donne ritiravano l’accusa
ai primi stadi dell’indagine per diversi motivi. La mancanza delle statistiche ha anche
un’ altro motivo: un alto tasso di crimini avrebbe significato il fallimento del sistema
socialista che doveva sradicare le ingiustizie e ogni forma di corruzione sociale, quindi
spesso le statistiche non venivano calcolate oppure erano falsificate. Dunque, l’alto
numero dei divorzi potrebbe suggerire la portata del problema della violenza domestica.
Di solito erano le donne a chiedere il divorzio. Le motivazioni addotte erano
l’alcolismo o la crudeltà del consorte, in pratica: la violenza domestica. L’alcolismo era
un problema diffuso all’epoca. L’uomo beveva per affermarsi come maschio forte, per
sottolineare l’appartenenza culturale e nazionale ma anche per fuggire dai problemi.
Tornava a casa ubriaco, la donna lo accoglieva furiosa mettendo così in discussione
l’autorità del consorte; il marito, allora, picchiava la moglie per difendere la sua
posizione di fronte ad una “provocazione”. Con “provocazione” si intendeva qualsiasi
reazione da parte della donna. Molto spesso la vittima veniva colpevolizzata. Inoltre,
all’epoca un uomo sotto l’influenza dell’alcol era riconosciuto come non responsabile
delle proprie azioni.44
Poiché le forze dell’ordine erano temute e rappresentavano lo Stato oppressivo, si
evitava di rincorrere all’aiuto degli organi statali come la polizia.“(…)there was
widespread, popular, ongoing resistance to state and party efforts to penetrate home
43
Cfr. S. Penn, J. Massino, op.cit, pp. 115-117 44
Cfr. .Eadem
35
and family life.”45
Inoltre il sistema legale non era né trasparente né giusto. I giudici
dipendevano dal Partito (la così detta giustizia telefonica), soprattutto nei casi criminali.
A differenza di altri paesi del Blocco Socialista, la Polonia aveva leggi contro la
violenza domestica (l’Articolo 184 del Codice Penale). Anche se l’Articolo riconosceva
come violenza domestica anche un singolo atto, era ovvio che per poter adire le vie
legali era necessario che si verificassero ripetuti incidenti. La polizia, la Procura e i
giudici erano ugualmente insensibili alle violenze contro le donne, proprio come nei
paesi dove non esistevano leggi a riguardo. I rappresentanti degli organi della giustizia
non solo ignoravano le denunce delle donne, bensì impararono anche a scoraggiarle
nei loro tentativi di ribellione alla violenza domestica. Ricordavano loro che
denunciando i propri consorti sarebbero state percepite come cattive mogli, e che, in
caso avessero deciso di portare avanti la denuncia, non avrebbero avuto alcuna garanzia
di protezione dalle violenze del marito e della sua famiglia.
L’indebolimento della posizione della Chiesa, se da una parte rappresentò per
l’opposizione una grande sconfitta, in questo contesto risultò “utile” alle donne: la
Chiesa, infatti, si opponeva alla liberalizzazione del divorzio e del diritto familiare.
Quel che non si riusciva ad ottenere tramite il codice penale, spesso si poteva
raggiungere con quello civile. Il divorzio era spesso l’unico mezzo per liberarsi di un
compagno violento e, di solito, erano le donne a richiederlo. I requisiti necessari ad
ottenere il divorzio variarono a seconda delle diverse fasi del socialismo. Sicuramente,
si rivelò molto più semplice divorziare nei periodi di liberalizzazione.
Comunque, non tutte le donne colpite dal dramma della violenza domestica volevano
divorziare. In molti gruppi sociali, infatti, il divorzio era stigmatizzante. Vigeva la
convinzione che una brava donna avrebbe saputo come gestire il matrimonio. Il divorzio
era dunque percepito come un fallimento della donna, non dell’ uomo. Inoltre, a causa
della crisi immobiliare, spesso le coppie divorziate erano costrette a vivere sotto lo
stesso tetto, per cui, in molti casi, il divorzio non significava necessariamente la fine
delle violenze.“Given housing shortages divorce was likely to result in a division of a
state-owned family flat between ex-spouses.”46
45
Cfr. S. Penn eds J. Massino, op.cit, p. 127 46
Cfr. S. Penn eds J. Massino, op.cit, p. 130
36
2.2. LA MATERNITA’
Nei primi anni del dopoguerra la Polonia, come altri paesi del mondo, attraversò un
periodo di crescita demografica enorme. Le difficili condizioni economiche nonché la
mancanza di una politica familiare mirata non scoraggiarono la popolazione ad avere
figli. Nel 1938 il tasso di crescita demografica era di 10,7 bambini per mille abitanti, nel
1950 era cresciuto fino a 19 per mille per raggiungere il picco di19,5 bambini per mille
abitanti nel 1952.
Nonostante lo stalinismo no promuovesse esplicitamente il ruolo femminile della
madre, la maternità era protetta dallo Stato. La costituzione del 1952 stabiliva che “il
matrimonio e la famiglia sono sotto la protezione della Polonia Popolare. Lo stato
tratta le famiglie numerose con un riguardo particolare”.47
Nemmeno la stampa di quel
periodo esaltava la famiglia. Piuttosto sottolineava la protezione della madre e dei figli,
sottolineava i diritti delle madri sole. Il Codice Familiare abolì il termine “bastardo”
riferito ai figli illegittimi, riferendo questo termine al capitalismo e ai meccanismi di
eredità. Per lo Stato esisteva una sola definizione: il bambino, e lo Stato prometteva di
prendersi cura di ogni bambino.
Negli anni ’50 in Polonia nascevano circa 500.000 bambini all’anno: a tale ritmo di
crescita demografica, la popolazione polacca avrebbe superato i 50.000.000. di abitanti
entro l’anno 2000.
Di fronte alla scarsità di alloggi, alla povertà della popolazione, e anche all’arretratezza
economica, dopo il 1956, il Partito abbandonò la glorificazione delle famiglie
numerose, concentrandosi piuttosto sulla stabilità del matrimonio e della famiglia.
Lo stato socialista in Polonia assunse il ruolo di un padre benevolo che tratta con
riguardo i cittadini, specie se bisognosi. In questo modo, le madri potevano contare su
una politica sociale generosa. Sussidi per le famiglie numerose, stipendi più alti per le
47
Art 5 della Costituzione della Polonia Popolare del 22 luglio 1952, consultabile sul sito
<http://www.staff.edu.pl>
37
madri sole, asili, centri di assistenza per i bambini disabili etc. Spesso lo stato
provvedeva anche ai libri di scuola. Una catena di mense popolari, i Bar Mleczny,
vendevano a prezzi accessibili pasti da asporto simili a quelli fatti in casa.
Conseguentemente a questa politica, più del 78% delle donne lavorava full time. La
donna doveva comunque dividere il suo tempo fra la casa e il lavoro, ma lo stato le
rendeva il compito più leggero.
Lo Stato si impegnava nella diffusione della pianificazione della famiglia e dell’
educazione sessuale tramite la Società della Maternità Cosciente (Towarzystwo
Świadomego Macierzyństwa), che dopo cambiò il suo nome in Società per lo Sviluppo
della Famiglia (Towarzystwo Rozwoju Rodziny). Grazie anche agli sforzi della Società,
nel 1959 venne adottata una legge che obbligava i medici a informare le donne che
avevano partorito o abortito sulle possibilità di contraccezione. Inoltre il sistema di
Sanità Pubblica rimborsava il 70% del costo della pillola e, negli anni ’60-‘70 la TRR
era solita tenere lezioni di educazione sessuale nonché sui contraccettivi moderni e i
diversi metodi di contraccezione.
Nonostante ciò, la maggior parte delle donne non usava la pillola. Preferivano i metodi
naturali: il calendario e l’astinenza periodica, anche si perché la pillola non sempre era
disponibile sia perché essendo prescritta in piccole dosi, l’assunzione della pillola
richiedeva frequenti visite mediche. Inoltre l’alto dosaggio ormonale contenuto nelle
pillole di allora provocava spesso spiacevoli effetti collaterali. Un altro fattore era la
vergogna. Spesso le donne, non volendo essere considerate delle “scostumate” si
vergognavano di comprare le pillole contraccettive sia presso anonimi farmacisti nella
capitale, sia, a maggior ragione, nei paesini più piccoli, dove tutti si conoscevano.
L’aborto era una procedura assai diffusa. Già negli anni ’30 il Codice Civile
garantiva il diritto all’aborto legale nel caso in cui la gravidanza fosse il risultato di
stupro o incesto. Serviva l’opinione di tre medici e di un ginecologo per ottenere
l’aborto per motivi medici.
Negli anni ’50, l’aborto era una pratica molto diffusa e accettata dalla società, anche se
la Chiesa, che rimaneva pur sempre una voce molto importante nel dibattito pubblico, si
38
opponeva a questa procedura.48
Nel 1956, Il Ministero della Salute, stimò il numero
degli aborti illegali ad un minimo di 300.000 l’anno; inoltre gli ospedali curavano circa
80.000 donne l’anno per complicazioni in gravidanza o conseguenti ad aborti spontanei,
in realtà probabilmente indotti in casa. Un aborto in uno studio privato costava da 1000
a 2000 złoty, ossia almeno uno stipendio mensile. Era quindi una procedura accessibile
solo alle donne agiate. Le donne che non potevano permetterselo rincorrevano all’aiuto
delle guaritrici. In ogni caso, l’aborto illegale era considerato un reato. Era, tuttavia,
molto difficile punire i medici che lo eseguivano, vista l’omertà di pazienti e medici.
L’attuazione della legge del 1956 avrebbe dovuto cambiare la situazione e
l’imitare alla quattordicesima settimana di gravidanza la possibilità di abortire
legalmente. Anche la difficile situazione economica della donna, oltre alla sua salute o
eventuali violenze sessuali era considerata una motivazione valida per ottenere un
aborto. Anche le donne madri di numerosi figli potevano richiedere l’aborto.
Questi cambiamenti spinsero le donne a richiedere in massa questo intervento. Il
risultato fu una paralisi completa degli ospedali che non erano preparati a ricevere un
numero così alto di pazienti. Inoltre, secondo la nuova legge, era il ginecologo a doversi
esprimere sulle condizioni mediche ed economiche della donna prima di eseguire
l’intervento. In caso dei dubbi, poteva temporeggiare, decidere di visitare la paziente in
casa per valutare meglio la sua situazione, facendo scadere in questo modo il termine
consentito per l’interruzione di gravidanza.
Non era possibile scegliere un medico; al contrario i medico veniva assegnato alla
paziente in base al quartiere di residenza. Questo dava al medico la possibilità di
sfruttare le pazienti: il medico poteva decidere di temporeggiare oppure rifiutarsi di
eseguire l’operazione, spesso per ragioni morali, ma altrettanto spesso per estorcere
denaro alla paziente in cambio dell’operazione o per convincerla a farsi operare presso
lo studio privato del medico, a costi elevati.49
Rendendo la procedura gratuita e diffusa in tutti gli ospedali, il numero degli aborti
legali aumentò fino a 158.000 negli anni ’60. Solo negli anni ’80, contestualmente ad un
più diffuso utilizzo dei contraccettivi moderni, aborti diminuì a 137.000. Anche
48
Cfr. S. Penn eds J. Massino, op.cit, pp. 137-138 49
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp.198-199
39
l’ingresso in massa delle donne nel mondo del lavoro provocò una diminuzione del
tasso di fertilità femminile (inteso come numero di figli per donna nell’arco della sua
vita). Nel 1960 era pari a 2,98 e nel 1989 a 2,1.
Come vedremo nel capitolo seguente la diminuzione della crescita naturale ha
rappresentato un argomento valido per poter eliminare sistematicamente le donne dal
lavoro con il pretesto della preoccupazione per la loro salute.
2.3. LA CASA E IL LAVORO
Il Disgelo significò anche una critica severa allo stalinismo, alla disumanizzazione del
lavoratore e alla discriminazione femminile. Paradossalmente, proprio in questo
periodo, le donne erano incoraggiate (a volte anche forzate) ad abbandonare il posto di
lavoro e tornare a casa. Il Partito non “mandò” a casa le donne in modo esplicito;
tuttavia, le incoraggiava ad orientarsi verso quei lavori considerati femminili. In quel
periodo, tale tendenza era diffusa in tutto il blocco socialista. Il ritorno delle donne a
casa ebbe sicuramente a che fare con la rottura totale con lo stalinismo. Da una parte la
destalinizzazione portò un cambiamento positivo, in quanto si iniziò a parlare della
discriminazione delle donne; dall’altra si trattò di un pretesto per limitare il ruolo della
donna nella sfera pubblica. In ambito pubblico, le attiviste sottolineavano le capacità
femminili, la loro abilità come casalinghe.50
Già nel 1945, era stata creata la Lega delle Donne, l’organizzazione ufficiale incaricata
della difesa dei diritti delle donne ma anche della loro adeguata educazione politica
nello spirito socialista.
Le attiviste mettevano in risalto il fatto che durante stalinismo le donne erano oberate di
lavoro, dovendosi dividere fra quello retribuito e quello casalingo. La Lega delle Donne
cercava di alleggerire il peso del lavoro femminile attraverso la riduzione dei doveri
lavorativi piuttosto che domestici.
50
A. Graff, Świat bez kobiet: płeć w polskim życiu publicznym, WAB, Warszawa 2001, pp. 56-
60
40
Nel 1956, per la prima volta, il Partito sfruttò ufficialmente l’argomento dei problemi di
fertilità femminile per eliminarle da tanti lavori, soprattutto dalle nuove professioni. Lo
stato spiegava la sua decisione dicendo di non poter tollerare che le donne svolgano
lavori che rovinano la loro salute, provocano aborti spontanei e mettono in pericolo la
vita e il benessere della prole.51
Di certo alcune donne furono contente di poter rimanere
a casa e fare le casalinghe; la maggioranza, però, non voleva lasciare il lavoro,
soprattutto se qualificato e quindi ben retribuito. Fu molto forte la resistenza delle donne
che lavoravano in miniera. Allo stesso tempo tanti lavori non qualificati erano ancora
considerati “femminili”. Non era difficile quindi incontrare donne, anche in gravidanza
avanzata, che portavano pesi o lavoravano in condizioni molto difficili: “In some cases
pregnant women work nightshifts and are in constant motion (…) when they are
transferred to supposedly lighter work, they end up lifting heavy weights.”52
La Lega delle Donne, collegata al il Partito, era il canale ufficiale di comunicazione con
le donne e, se durante lo stalinismo incoraggiò le donne a trovare lavoro nelle nuove
occupazioni e a liberarsi dai lavori femminili, propagando la collettivizzazione dei vari
servizi come le lavanderie comuni, le mense ecc., successivamente cambiò direzione,
visto anche lo scarso successo di tali iniziative. La Lega si impegnò nella
publicizzazione dell’ importanza del ruolo della casalinga. Durante il Disgelo, era
percezione comune che fosse la donna la responsabile del benessere e della felicità della
famiglia.
La Lega, oltre al lavoro ideologico, dava
anche assistenza alle donne. Il loro attivismo
sociale si concentrava sulla vita di tutti i
giorni. La Lega organizzava per corsi che
preparavano le ragazze alle mansioni
casalinghe: veniva insegnato loro come
mantenere la casa in ordine, si presentavano le novità tecniche, senza mai mettere in
dubbio i ruoli maschili e femminili all’interno della casa. Questo contribuiva alla
51
Cfr. M. Fidelis, op.cit, pp. 216-217 52
M. Fidelis, op.cit, p. 217
41
solidificazione dello schema tradizionale che vedeva la donna custode del focolare e
l’uomo come colui che mantiene la famiglia.
“[League]members underscored the need to assist women in their responsibilities as
housewives, mothers and workers(in other words their so called double burden)and
called for a new focus on practical activism which centered on the women’s rather than
party’s needs in contrast to the preceding Stalinist period.”53
In teoria, il comitato della Lega delle Donne aveva come scopo quello di alleviare il
doppio fardello delle donne: il lavoro e la casa. In pratica insegnavano loro a cucinare
pasti bilanciati, a cucire e rammendare i vestiti, a pulire la casa e renderla più
accogliente nonché a curare il proprio aspetto fisico. In questo modo, tuttavia, elevando
gli standard casalinghi, spesso non facevano che aggiungere compiti anziché eliminarli.
I comitati, non solo non respinsero l’idea diffusa che voleva la donna casalinga anziché
lavoratrice, anzi, crearono maggiori aspettative sul lavoro femminile in casa.
Una volta al mese, durante gli incontri organizzati dalla Lega, le donne potevano
imparare non solo nuove ricette ma anche, ad esempio, ad effettuare da sole l’esame del
seno.
Anche se la donna comunista, in teoria, non era interessata a cose effimere come la
bellezza (era robusta e poco diversa dall’uomo e focalizzava la sua energia
essenzialmente sul lavoro) la realtà era ovviamente diversa. Le donne cercavano di
essere piacevoli arrangiandosi con quello che avevano a diposizione per rendersi belle.
Anche qui la Lega veniva loro incontro: insegnava loro come truccarsi, quali prodotti
utilizzare per valorizzare la propria bellezza, come mettere i capelli in piega, quali
vestiti andavano di moda. Questi corsi, dunque, non servivano solo alle esigenze delle
donne lavoratrici, bensì rispondevano anche ai bisogni estetici delle donne.
Comunque al centro dell’attenzione della Lega si trovavano le iniziative
riguardanti il cibo. L’organizzazione sosteneva che le famiglie non seguivano una dieta
sana e, pertanto, era necessario che le donne imparassero a cucinare pasti bilanciati che
prevedessero il giusto apporto di vitamine, proteine e carboidrati. Le lezioni erano
spesso seguite da degustazioni volte a sottolineare l’importanza di frutta e verdura e ad
eliminare della dieta il consumo eccessivo di carne. Ciò poteva essere interpretato come
53
S. Penn eds J. Massino, op.cit, p. 49
42
una mossa politica, visto che gli anni ’80 erano dominati dalla scarsità di diversi
prodotti alimentari, primo fra tutti, la carne.54
Promuovendo un minore consumo di
carne, la Lega probabilmente veniva incontro al Partito, cercando di rimediare alla
mancanza di carne in un paese dove questo prodotto era estremamente importante.
Ciononostante, i consigli della Lega promuovevano anche una vita sana: l’aumento del
consumo di frutta e verdura, l’eliminazione dei grassi della dieta ecc., abitudini
alimentari tutt’oggi valide.55
Con l’arrivo degli anni ottanta e l’introduzione della legge marziale nell’ ‘81 e dei ticket
per l’acquisto dei prodotti alimentari, divenne impossibile comprare praticamente
qualsiasi cosa. Visto che tradizionalmente le donne erano incaricate di fare la spesa e di
organizzare la vita di casa, furono essenzialmente loro a risentire della crisi. Come
madri e mogli avevano il dovere di assicurarsi che i bisogni delle loro famiglie fossero
soddisfatti. Erano costrette a passare ore in lunghe file per comprare quel che c’era
(spesso solo senape e aceto, secondo le testimonianza). La Lega cercò di assistere le
donne durante la crisi organizzando degli incontri, parlando con le donne. I comitati si
concentravano in quel periodo su come le donne potessero adattarsi alla situazione,
piuttosto che su come lo Stato potesse migliorare la situazione.
La Lega sottolineava la capacita delle donne di adattarsi e l’arte di arrangiarsi.
Insegnava loro a risparmiare energia, a ricavare vestiti nuovi da quelli che avevano, a
preparare pasti bilanciati con quello che si trovava in commercio. Poiché le patate
scarseggiavano, impararono ad inserire nella dieta pasta e cereali e, quando mancava la
carne, sfruttavano altre fonti proteiche: latte, formaggio, uova. La Lega insegnò loro
anche a coltivare piccoli orti sul balcone, ecc.
Ma la Lega delle Donne significava anche socializzazione: gli incontri erano
un’occasione per staccare dal lavoro e dai lavori casalinghi per trascorrere del tempo in
compagnia di altre donne. Gli incontri non erano solo chiacchiere, tè e pasticcini. Si
trattava di un vero e proprio rifugio dalla vita di tutti i giorni. Le donne cucivano,
ricamavano, leggevano e si davano i consigli, facevano amicizia, organizzavano turni
per accompagnare i figli all’asilo e si aiutavano in caso di malattia.
54
Cfr. J. Eisler,op.cit. 55-56 55
Cfr.S. Penn eds J. Massino, op.cit, pp. 50-53
43
La Lega delle Donne non sosteneva gli slogan femminista, non diffondeva
l’emancipazione femminile, non cercava di alternare i ruoli sociali; però si occupava
della formazione non solo ideologica delle donne, forniva loro tanti consigli preziosi da
mettere in pratica nella vita di tutti i giorni.
2.4. TEMPO LIBERO
Parlare di tempo libero nel tempo della Polonia Popolare è un’impresa ardua,
visto che il tempo libero non esisteva o piuttosto era ridotto al minimo. Il Partito lo
guardava con sospetto al tempo libero e cercava di limitare più possibile i momenti di
svago a disposizione dei cittadini. Si riteneva che il tempo libero, in quanto causa di
demoralizzazione, doveva essere utilizzato per la formazione della morale socialista. Un
polacco, dunque, lavorava cinque oppure sei giorni a settimana. Dopo il lavoro doveva
spesso rimanere nello stabilimento per partecipare ad incontri ideologici oppure agli
addestramenti, a corsi si formazione professionale, conferenze ecc. La domenica i
cittadini erano impegnati in corsi chiamati azioni sociali. Si trattava di lavori gratuiti
svolti per il bene della società e solitamente organizzati dai posti di lavoro oppure dalle
scuole, dalle organizzazioni della gioventù e dal Partito. I lavori miravano alla
costruzione del socialismo e, sebbene da alcuni considerati superflui, servivano a
diffondere lo spirito del lavoro collettivo per la patria. Tali azioni sociali consistevano
nella pulizia degli spazi comuni, piantare foreste, costruire strade. I partecipanti alle
azioni sociali erano anche impegnati nei lavori stagionali, come la raccolta delle patate,
la mietitura ecc. In teoria, la partecipazione alle azioni era volontaria; tuttavia, in pochi
osavano non prendervi parte, poiché la non partecipazione alle azioni sociali era vista
come una trasgressione e l’assenteista in questione sarebbe potuto essere considerato
nemico del socialismo e dunque avere problemi sul posto di lavoro o, in casi estremi,
venire arrestato.56
56
Wakacje w PRl, consultabile sul sito <http://www.polska.newsweek.pl>
44
Un altro incontro obbligatorio era la parata del primo maggio. La festa dei
lavoratori era di estrema importanza nella società socialista. Dagli stabilimenti di
riferimento, con tanto di manifesti e i striscioni, i lavoratori venivano portati in pullman
fino al centro della città per manifestare il proprio affetto per lo stato dei lavoratori e,
soprattutto, per il lavoro in sé. Il 1° Maggio era in aperta opposizione con un'altra
festività, il 3 maggio, festa della Vergine Maria Regina di Polonia nonché giorno della
Costituzione, che durante il comunismo era feriale.
Una fra le più importanti iniziative del comunismo, quasi alla pari con lo
sradicamento dell’analfabetismo, fu la vacanza organizzata delle masse lavoratrici. Nel
1952, questo privilegio divenne uno dei fondamenti del regime e fu incluso nella
costituzione “I cittadini della Polonia Popolare hanno diritto al riposo (…)
L’organizzazione delle villeggiature, lo sviluppo del turismo, delle stazioni climatiche,
case della cultura, parchi e altri impianti danno la possibilità di sano riposo alle masse
sempre più ampie del popolo lavoratore delle città e della campagna.”57
Già alla fine degli anni quaranta fu creato il Fondo per la Villeggiatura Operaia, un ente
collegato con il governo, incaricato dell’organizzazione delle vacanze. Erano i sindacati
e i consigli degli stabilimenti a decidere chi dovesse partire e per dove. Tuttavia,
57
Art 5 della Costituzione della Polonia Popolare del 22 luglio 1952, consultabile sul sito
<http://www.staff.edu.pl>
45
l’ultima parola spettava al partito. Gli stacanovisti e i membri del Partito ottenevano
sempre le assegnazioni nelle località turistiche più desiderate.
Inizialmente, gli operai accolsero con sospetto l’idea di partire per le vacanze. Per la
maggior parte di loro, infatti, le vacanze erano un’abitudine sconosciuta. Chi riusciva a
ritagliarsi del tempo libero, lo sacrificava al lavoro in casa o in fattoria, oppure,
eventualmente, lo utilizzava per uscire con gli amici. Il modello di riposo che prevedeva
sport, giochi di squadra ed escursioni, per gli operai, stanchi del lavoro fisico, erano
poco interessanti. Spesso i villeggianti restavano nella propria stanza per un paio di
giorni, dormendo, e solo dopo iniziavano a partecipare alle attività previste durante la
vacanza. Le ferie organizzate costituivano anche una sorta di esperimento sociologico: i
gruppi sociali che normalmente avevano poche occasioni di incontrarsi, passavano due
settimane insieme. A colazione, potevano incontrarsi allo stesso tavolo un operaio,
un’insegnante, un architetto e un funzionario di stato. Durante questo tipo di vacanze,
non mancavano certo l’occasione per socializzare e l’opportunità di educare i cittadini
allo spirito socialista. Inoltre, tutti i partecipanti erano sotto la sorveglianza di agenti
della polizia segreta in incognito.
Un’altra invenzione del socialismo, in vita ancora oggigiorno, furono i Giardini
Condivisi (Ogródki Działkowe). Si trattava di piccoli lotti di terreno, di circa 300 mq,
dove i cittadini potevano coltivare verdura, frutta e fiori. I Giardini erano spesso siti in
46
città, a volte anche nel centro. L’amministrazione della struttura regolava con precisione
le percentuali delle differenti colture. Non appena arrivassero le belle giornate, i
proprietari dei piccoli giardini, vi si recavano con la famiglia per rilassarsi e prendersi
cura delle piante. Quest’attività aveva anche dei profitti misurabili in frutta e verdura
prodotte, profitti assai importante durante la crisi. È da sottolineare che tutta l’attività si
svolgeva sotto l’occhio attento dell’amministratore.
ANNA WALENTYNOWICZ
Anna Walentynowicz, sensibile come sempre alle ingiustizie e con una gran voglia di
fare e di aiutare le persone svantaggiate si impegnò nella commissione sociale del
cantiere ed entrò nella Lega delle Donne, per protegger e se stessa e le altre donne dallo
sfruttamento. Grazie al suo carisma divenne ben presto la rappresentate della lega
presso il cantiere. In quel periodo non aveva ancora capito che la Lega delle Donne, così
come lo ZMP, svolgeva un ruolo ben preciso nella società stalinista. Invece di fornire
un vero e proprio sostegno alle donne, le incoraggiava ad un lavoro estenuante, a
dispetto degli slogan socialisti che, insieme alla promozione del Piano di Sei Anni,
promuovevano l’idea di uno stato che si prende cura delle donne e dei bambini.
Lubczyk credeva negli slogan che Lega ripeteva da anni. La priorità dell’organizzazione
doveva essere il sostegno pratico alle madri sole e alle vedove: trovare un asilo, un
lavoro, ecc. Le parole d’ordine della Lega erano l’uguaglianza, la parità di genere e il
progresso Tuttavia non si trattava che di slogan della propaganda degli anni ’50. Ben
presto Anna Lubczyk si sarebbe resa conta che erano, appunto, solo slogan, e che
avevano poco a che fare con la realtà.
Anna, invece, credeva davvero nei valori universali come l’aiuto al prossimo,
non soltanto durante il lavoro o gli incontri dei diversi gruppi. Quando seppe che una
donna delle pulizie del cantiere stava cercando casa, decise subito di ospitarla, insieme
alla madre, a casa sua. Purtroppo, poco dopo iniziarono i conflitti e Anna fu costretta ad
abbandonare suo appartamento. Era di nuovo una senzatetto, per di più, innamorata di
un collega di lavoro che, non appena seppe della gravidanza di Anna, iniziò ad evitarla,
47
nonostante poco prima sognasse un futuro insieme a lei. Poco dopo l’uomo, che era
solito bere molto, incominciò a frequentare un’altra ragazza. Nonostante la situazione di
una madre nella Polonia degli anni ’50 fosse difficile sia dal punto di vista economico
che sociale, Lubczyk decise di crescere il figlio da sola, educandolo ai valori dell’amore
per il prossimo e per la patria. Anna affermava di non aver nemmeno pensato all’aborto,
nonostante la stigmatizzazione delle madri sole da parte della società. Anna credeva che
l’uomo che l’aveva ingannata una volta, l’avrebbe delusa sicuramente anche in futuro;
pertanto preferì crescere il figlio da sola piuttosto che dover condividere la vita con una
persona con la quale sarebbe stato impossibile creare una famiglia felice.
In quel periodo Anna si avvicinò alla chiesa. Era battezzata e da bambina era solita
andare in chiesa con i genitori; tuttavia, con il tempo aveva perso quell’abitudine e
viveva, come diceva lei, “accanto alla fede”58
. Quando era incinta ebbe coraggio di
rivolgersi nuovamente a Dio. Nel settembre 1952 diede alla luce suo figlio Janusz. Nei
primi tempi era molto confusa: si chiedeva se ce l’avrebbe fatta, se aveva il diritto di
privare il figlio della presenza paterna soprattutto visto che il padre si era accorto
dell’esistenza del figlio ed era intenzionato a portarglielo via.
Tuttavia, in quel periodo, il più grande problema di Anna era trovare una casa.
Viveva dagli amici, oppure affittava una stanza, o trascorreva periodi ospite della Casa
della Madre e del Figlio, fino a quando non decise di scrivere a Bolesław Bierut,
descrivendogli la sua situazione. Il Primo Segretario del Partito non rispose, ma la sua
Segreteria segnalò il problema alla Regione. Così, nel 1953, le fu assegnato un
appartamento a Danzica, dove visse fino alla sua morte.
La sua vita in quel periodo era divisa fra il cantiere, il figlio e l’attività sociale.
Poiché lavorava spesso durante il turno di notte, si faceva aiutare da una vicina di casa
ad occuparsi del figlio. Non rinunciò alla lotta per il miglioramento delle condizioni di
lavoro e, sempre più spesso, parlava durante gli incontri della Lega delle Donne e del
Consiglio dei sindacati del cantiere. La stima per Anna da parte dei suoi colleghi era
sincera. Nel 1953 Anna ricevette la croce d’argento al merito, per il suo lavoro
impeccabile. Divenne anche madrina di una nave. La sua posizione all’interno del
cantiere era molto forte. Fu lei ad evidenziare quanto il sistema di ripartizione dei
58
S. Cenckiewicz, op.cit, p. 47
48
sussidi sociali fosse iniquo, a sottolineare l’importanza delle regole sulla sicurezza e,
infine, non curandosi dei pericoli e delle conseguenze, a criticare il PZPR. Nonostante
era il periodo di lotta al sabotaggio, la pigrizia e scarsa disciplina al lavoro, solo il
Partito poteva criticare e indicare i colpevoli. Per questo motivo nell’autunno 1953,
Lubczyk ebbe il primo contatto con la polizia segreta (Służba Bezpieczeństwa, SB). In
quell’occasione, i funzionari vollero solo intimidirla e convincerla ad entrare nel Partito,
con la promessa di una carriera. Anna rifiutò, per via della sua fede cattolica.
Ironicamente, era sempre lei la stacanovista sorridente sulle pagine dei giornali, che
superava del 270% il limite di produzione, sacrificando la sua vita per il socialismo.
Queste caratteristiche nonché la stima dei superiori non furono sufficienti ad ottenere
una promozione: la rappresentanza dello PZPR nel cantiere non accolse la domanda si
Anna.
La situazione migliorò nel 1956. Si trattò di un periodo di riorganizzazione,
durante il quale il cantiere aumentò la produzione e pertanto il contributo di ogni
operaio qualificato divenne estremamente importante. La SB smise, dunque, di
perseguitarla. La sua diligenza era sempre apprezzata al reparto W-3 dove lavorava.
Nella primavera del 1957, ricevette la Croce di Bronzo al Merito, premiandola di cinque
anni di lavoro impeccabile e poi, nel 1961 le fu nuovamente assegnata la Croce
d’Argento per il perfetto svolto, la disciplina e la cordialità. Nel 1966, Anna ricevette la
Croce d’Oro al Merito; questa volta Lubczyk venne premiata per le iniziative da lei
intraprese che erano valse al reparto W-3 notevoli risparmi.59
Finalmente Lubczyk
decise di dedicarsi anche alla sua vita privata; infatti, desiderava sposare il suo collega
di reparto Kazimierz Walentynowicz. Per anni, prima di pensare al matrimonio,
avevano fatto parte dello stesso gruppo di amici, nutrendo grande simpatia l’uno per
l’altra. Anna, che con un figlio a carico aveva paura di risultare un peso per un uomo
che aveva tutta la vita davanti, si convinse infine a sposarlo, aiutata nella decisione dalla
futura suocera. La cerimonia ebbe luogo il 26 settembre 1964 a Danzica. Anna descrive
suo marito come una persona calma e degna di fiducia. Suo figlio aveva bisogno di una
figura maschile e Kazimierz lo trattava come avrebbe fatto il migliore dei padri. Gli
diede anche il suo cognome. La felicità dei primi anni finì con la notizia della malattia
59
Cfr. S. Cenckiewicz, op.cit, pp. 48-51
49
di Anna. Quando si inizio Quando si inizio Quando si inizio sospettare di casi di
pneumoconiosi fra i saldatori, un controllo rivelò che Anna aveva sviluppato uno stato
pretumorale all’utero. I medici le diedero al massimo cinque anni di vita, se avesse
condotto una vita sana e priva di sforzi. Lubczyk decise di sottoporsi all’intervento
chirurgico rimando sei mesi in congedo per malattia. Il marito cercò di convincerla a
richiedere la pensione d’invalidità; Anna, però, non ne voleva sapere. Aveva bisogno di
stare fra la gente ed decise pertanto di tornare in cantiere. Richiese che le venisse
assegnato un più leggero, così Anna Walentynowicz divenne operatore di gru, con una
sensibile riduzione di stipendio. Dalla ottava categoria alla quale apparteneva come
saldatrice, era passata alla sesta. Lo trovò così ingiusto che si rifiutò di firmare il
contratto. Inviò una petizione al Ministero dell’Industria Pesante, presentando non
solamente la sua causa, bensì anche quella di centinaia di lavoratori che, dopo aver
anteposto per anni il lavoro alla salute, non appena le loro condizioni, compromesse dal
lavoro stesso, non gli permettevano più di svolgere lavori a rischio, venivano assegnati a
mansioni meno importanti e sottopagati. Alla fine, Anna Walentynowicz riuscì ad
ottenere la settima categoria di retribuzione. Il suo salario, in quel periodo, a seconda
degli straordinari, oscillava fra 1900 e 2400 zloty, una paga media nell’industria
cantieristica.
Anna era sempre attiva socialmente. Reclamava sempre il rispetto per i diritti
degli lavoratori. Una volta, nel 1966 ha rischiò di perdere il lavoro proprio per questo
motivo. Quando il presidente del Consiglio del reparto W-3 perse alla lotteria 3000
zloty presi dalla cassa comune, Anna Walentynowicz fu l’unica persona che osò
parlarne ad alta voce. Anna non desiderava che venisse punito, voleva semplicemente
avere delle spiegazioni. Poiché nessuno sembrava interessato a risolvere la questione,
Anna scrisse alla televisione. Una commissione speciale arrivò da Varsavia
promettendo di occuparsi di quella spiacevole faccenda. Durante i colloqui ai quali
Anna partecipava frequentemente, i suoi colleghi iniziarono ad accusarla di disonestà
per aver comprato del vino per un incontro della Lega delle donne. Della commissione
venuta da Varsavia rimase un solo membro, e il segretario del consiglio del cantiere
insistette affinché Anna rinunciasse alla causa. Una settimana dopo le venne proibito di
parlare o scrivere di quella storia. Nel 1968, gli attivisti della sezione cantiere del partito
50
cercarono di licenziarla, sostenendo che Anna disturbava il lavoro di gruppo. In quel
momento ebbe luogo la prima protesta di gruppo nel cantiere. Sessantacinque operai
firmarono una petizione per difendere Anna Walentynowicz. Alla fine, anziché essere
licenziata, Anna venne spostata dal reparto W-3 al reparto W-2, nonostante la posizione
dei rappresentanti del partito che “volevano migliorare l’atmosfera fra le donne” e “non
avevano speranze di cambiare la situazione” visto che la cittadina Walentynowicz
“vuole agire e agirà come fino ad ora”60
. Effettivamente quella dichiarazione Anna
realizzava ogni giorno. Il lavoro nel nuovo reparto paradossalmente le lasciava più
tempo libero a disposizione. I turni degli operatore di gru duravano solo quattro ore. Nel
tempo che le rimaneva lottava per i diritti delle donne, per la spartizione equa del soldi
comuni. Nel tempo libero voleva fare qualcosa per il suo reparto. Visto che nella mensa
c’erano sempre delle file lunghissime e la gente spesso rinunciava ai pasti per evitare
l’attesa, Anna incominciò a portare il pranzo agli operai del reparto. Il capo mastro
glielo proibì, sospettando che dovesse avere un qualche interesse per prendere così a
cuore i problemi degli altri operai.
60
Cfr. S. Cenckiewicz, op.cit, pp. 54-55
51
3. IL CAMMINO VERSO LA LIBERTA DI ANNA WALENTYNOWICZ
Il 1970 venne segnato dai tragici eventi che ebbero luogo sulla costa polacca. Già un
paio di anni prima il popolo si era accorto che il modello politico e economico lanciato
dall’équipe di Wiesław Gomułka stava per crollare. Il governo intenzionato a porre fine
a queste voci, introdusse una riforma incentrata sull’aumento dei, undici giorni prima
del Natale. La notizia dell’aumento dei prezzi venne annunciata la sera prima, il 13
dicembre, quando i negozi erano già chiusi e la gente non poteva quindi rifornirsi di
prodotti a prezzi più bassi. La carne aumentò del 17,6%, la farina del 16,6%, le
marmellate del 36,2%, i cereali del 20-30%. Il carbone e la legna sarebbero aumentati
del 10-25%.61
Prima delle feste, si è soliti comprare cibo di qualità migliore, quindi più
caro, in grandi quantità. L’ “operazione dei prezzi”, come la chiamavano, colpì
innanzitutto le famiglie con redditi bassi, alle quali risultava difficile sopravvivere già
prima dell’operazione dei prezzi.
La mattina del 14 dicembre, Anna Walentynowicz stava finendo il turno di
notte. Nel reparto W-3 si era radunato un gruppo di operai per protestare contro
l’aumento dei prezzi. Presto è arrivata la notizia che lo sciopero si è diffuso in tutto il
cantiere. Poiché dirigenti dello stabilimento si dimostrarono insensibili alla protesta, gli
operai si diressero verso la sede del comitato regionale del PZPR. Per strada altre
persone, soprattutto i giovani, si unirono al corteo. Si trattava di una manifestazione
pacifica; i manifestanti cantavano canzoni religiose e patriottiche. Il loro obiettivo era il
confronto con il primo segretario regionale, quel giorno assente. La protesta pacifica
continuò per le strade di Danzica , fino a che , verso le 4 di pomeriggio, un poliziotto
non venne aggredito con dei razzi lacrimogeni. È importante sottolineare che l’episodio
ebbe luogo quasi dieci ore dopo l’inizio della manifestazione, un lasso di tempo
sufficiente per dare il via ai colloqui con gli operai. Tuttavia, poiché un autentico
dialogo sociale era sconosciuto al potere comunista, entrarono in azione le squadre di
61
Cfr. J. Eisner,op.cit , pp. 37-44
52
polizia. Nel centro di Danzica 15 mila manifestanti si scontrarono violentemente con
l’esercito e la polizia. Quel giorno le forze dell’ordine non usarono armi da fuoco, e non
vi furono vittime.
Anna Walentynowicz, insieme al marito, prese parte allo sciopero. Aiutata da altre
donne, si occupò della cucina, preparando i pasti per le migliaia di persone che
tornavano al cantiere.
Il 15 dicembre venne spiegato l’esercito, questa volta munito di mitragliatrici e
attrezzatura pesante. La mattina, quando i lavoratori uscirono in corteo dal cantiere,
l’esercito aprì il fuoco sui manifestanti. Secondo i dati ufficiali vi furono due vittime e
undici feriti. Gli operai si ritirarono nel cantiere, proclamando lo sciopero
d’occupazione, interrotto dopo solamente qualche ora. Il 16 dicembre le forze
dell’ordine causarono altre due vittime fra gli operai. Nel frattempo, l’ondata delle
proteste e gli scioperi si diffusero lungo tutta la costa. Particolarmente tragico, fu l’esito
delle proteste che ebbero luogo a Gdynia, una città portuale a 30km da Danzica, il 17
dicembre. Lì, nonostante la tranquillità dei giorni precedenti, 18 persone morirono,
uccise dai soldati che aprirono il fuoco sugli operai che, dal cantiere di Gdynia, si
dirigevano verso la stazione dei treni, per tornare a casa. Il bilancio fu di 45 morti e
1,165 feriti, dal 14 al 19 dicembre, in tutto il paese. Per schiacciare le proteste, lo Stato
impegnò 27,000 soldati, 550 carri armati, 2,100 macchine e 108 aerei. A questi numeri
bisogna aggiungere almeno 9,000 poliziotti. Dopo il periodo della Legge Marziale, nella
Polonia del dopoguerra, l’esercito non era mai stato mobilitato in numeri cosi grandi
come per sopprimere le proteste del dicembre del ‘70.
Gli eventi di dicembre, così come chiamava le proteste la propaganda, erano seguiti da
una battuta ai partecipanti dello sciopero. Gli effetti del lavoro della SB furono
impressionanti. Nei primi giorni del gennaio 1971, vennero temporaneamente arrestate
2,300 persone, 196 delle quali vennero formalmente arrestate in seguito. L’SB iniziò a
sorvegliare 1,014 persone, per “smascherare”62
i partecipanti allo sciopero e per
62
La Polizia Politica ovvero i Servizi della Sicurezza sapevano benissimo chi partecipava e chi
non c’entrava affatto nei vari avvenimenti. Quindi lo “smascheramento” come si diceva nel gergo oppure
lo “smantellamento” aveva come scopo non trovare il colpevole ma piuttosto fabbricare le prove del
“reato”.
53
prevenire azioni simili da parte delle persone attive in tal senso, che organizzavano
incontri, proteste, scioperi.
Solo nel gennaio 1971, nel cantiere di Danzica ebbero luogo 5 scioperi. I manifestanti
chiedevano l’abbassamento dei prezzi, ma con il tempo, le richieste si fecero sempre
maggiori. Si parlava anche del diritto di formare sindacati indipendenti, della punizione
dei colpevoli del massacri del dicembre 1970. La situazione non migliorò nemmeno
dopo la visita del primo segretario del Partito, Edward Gierek, a Danzica.
L’atmosfera nel cantiere era tesa e, il primo maggio, i lavoratori decisero di protestare
contro la mancata punizione dei colpevoli del Dicembre 1970. Domandavano anche la
costruzione un monumento commemorativo delle vittime. Anna Walentynowicz si
impegnò attivamente in tutte le forme di protesta, negoziava le condizioni per porre fine
agli scioperi insieme all’elettricista Lech Walesa e altri amici.
In quel periodo la SB aprì due fascicoli su Anna Walentynowicz uno sotto il criptonimo
di Arka e altro sotto quello di Autunno 70.63
Entrambi i fascicoli miravano a
documentare l’attività criminale dei lavoratori del cantiere navale di Danzica, Il
dipartimento della sicurezza aprì fascicoli su più di 3,300. L’indagine prevedeva
sorveglianza, pedinamento, controllo della corrispondenza, intercettazioni telefoniche.
Poco dopo, altre disgrazie ancora si abbatterono su Anna: il marito si è ammalò di
pneumoconiosi e, in seguito, i medici le diagnosticarono un tumore ai polmoni. La
situazione era talmente seria che Anna chiese un congedo per potersi prendere cura del
marito malato. Purtroppo Kazimierz Walentynowicz morì nell’ottobre del 1971, dopo
sette anni e quattordici giorni di matrimonio con Anna, la quale non tolse mai più la
fede nuziale.
Anna riuscì ad elaborare il lutto in pochi mesi. Ci riuscì a modo suo dedicandosi
ai bisognosi. Iniziò ad aiutare gli anziani, spesso soli e malati.
Al lavoro lottava sempre per gli stessi ideali. E, con passare del tempo, iniziò a rendersi
conto sempre di più della reale situazione in cui verteva la Polonia. Dominava
l’incertezza. Le frequenti interruzioni dei rifornimenti di prodotti alimentari incidevano
negativamente sul morale della popolazione. Anna Walentynowicz sentì su Radio
Europa Libera della nascita del Comitato per Difesa degli operai (Komitet Obrony
63
Cfr. S. Cenckiewicz, op.cit, pp. 63-64
54
Robotnikow KOR) e, successivamente, del Comitato per la Difesa dei Diritti
dell’Uomo e del Cittadino ( Komitet Obrony Praw Człowieka i Obywatela ROPCiO).
Conobbe Bogdan Borusewicz, un attivista del KOR.
Fu in questo momento che l’ingenua Anna Walentynowicz, che credeva di poter lottare
contro il sistema da sola, iniziò la sua strada iniziò la sua attività come membro del
movimento anticomunista di Danzica.
La crisi era palese. Il cantiere veniva rifornito solamente del 10% dell’energia
necessaria, perciò, anche gli operai del primo turno non potevano lavorare più di un paio
d’ore, fino a quando cioè, le macchine non smettevano di funzionare. Anche gli analisti
del PZPR ritenevano che, in mancanza di radicali cambiamenti, la catastrofe politico-
economica fosse imminente.64
L’operaio medio si sentiva demoralizzato, convinto di non avere nessun potere sulla
realtà, nemmeno al suo posto di lavoro. Era dunque convito che fosse inutile provare a
cambiare le cose. . I questo contesto, emersero fenomeni sociali negativi; il popolo non
aveva fiducia nel governo né si sentiva da esso rappresentato.
Furono questi i motivi della nascita dei Liberi Sindacati (Wolne Związki Zawodowe
WZZ). Già nel maggio 1978, Anna Walentynowicz, decise di unirsi a
quest’organizzazione. Raccolse 610 zloty fra i colleghi e si recò presso l’indirizzo
indicatole da un’amica per fare un’offerta ai WZZ. Lì incontrò persone che già
conosceva di vista o di cui aveva sentito parlare: Andrzej e Joanna Gwiazda, Bogdan
Borusewicz, Alina Pienkowska, e altri. Tutti loro erano al corrente dell’attività di Anna
Walentynowicz all’interno del cantiere, sapevano della sua onestà, diligenza, dei sui
valori, del fatto che non temeva nuove sfide. L’opposizione sapeva che se Anna
Walentynowicz si fosse impegnata nella loro organizzazione, avrebbero acquistato un
ottimo e infallibile attivista. Per Anna, era molto importante aver finalmente incontrato
delle persone a lei veramente vicine dal punto di vista ideologico, che, come lei,
sentivano di voler migliorare la situazione degli operai e il futuro della Polonia.
Inizialmente i nomi di grandi intellettuali come Gwiazda, Wyszkowski, Borusewicz,
Kaczyński la intimidivano, cosi come il livello degli argomenti trattati la paralizzava.
64
Cfr. A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, op.cit, pp. 367-407
55
Leggendo le prime dichiarazioni e testi del WZZ, Anna non ebbe più dubbi: aveva fatto
la scelta giusta entrando nelle strutture dei WZZ. I fondatori di quest’organizzazione,
Andrzej Gwiazda, Antoni Sokołowski e Krzysztof Wyszkowski, nella Dichiarazione di
Fondazione del 29 aprile 1978 scrivevano: “L’ampia democratizzazione oggi è una
necessità assoluta. La società deve ottenere il diritto di guidare il proprio paese in
maniera democratica. Tutte le sue classi devono avere la possibilità di autoorganizzarsi
e di creare delle istituzioni che garantiscano lo scrupoloso rispetto dei loro diritti.
Solamente le autentiche alleanze e società possono salvare questo paese perché solo
tramite la democratizzazione si può arrivare ad un’unificazione degli interessi dello
stato con quelli dei cittadini(…)Lo scopo dei Sindacati Liberi è l’organizzazione della
difesa degli interessi economici, legislativi e umanitari dei lavoratori. I Sindacati Liberi
garantiscono loro il suo aiuto e protezione senza distinzione di qualifica o
convinzioni.”65
Inoltre nel testo intitolato “Perché abbiamo fondato i Sindacati Liberi?”
leggiamo: “Ci rendiamo conto che non eviteremo le accuse di svolgere un’attività
politica. Nel nostro paese la portata dei problemi considerati cause politiche è molto
ampia e include quasi tutto tranne le escursioni per raccogliere i funghi. I comitati del
PZPR presso gli stabilimenti, le direzioni delle fabbriche, la polizia politica SB gridano
alla “causa politica” ad ogni tentativo di azione indipendente. La difesa degli operai
licenziati per aver partecipato agli scioperi, la pubblicazione e la diffusione del
proprio giornale, l’occuparsi di cose così importanti per i lavoratori, come la sicurezza
sul posto di lavoro, il Codice del Lavoro, gli straordinari, il lavoro notturno, la
relazione dei guadagni e il costo della vita, i prezzi dei prodotti alimentari e la loro
accessibilità, i limiti di produzione troppo alti, l’arbitrio dell’amministrazione degli
stabilimenti. Queste, che in Polonia sono considerate cause politiche, sono, in tutto il
mondo, problemi sindacali e di questo ci occuperemo. La nostra attività è legale e
conforme alla legge. Ogni persona ha un naturale diritto alla difesa, alla giustizia e ad
una vita dignitosa. Ce lo garantisce la Costituzione del PRL e le convenzioni
internazionali riguardanti i diritti umani e del cittadino.”
65
Dlaczego Założyliśmy Wolne Związki Zawodowe?, da consultare sul sito
<http://www.polskieradio.pl>
56
L’attività nel WZZ era una vera gioia per Anna, ma inizialmente fu soprattutto
un’avventura educativa. Cercava di imparare il più possibile e, quindi, durante gli
incontri si limitava ad ascoltare. Non si riteneva di potersi esprimere sulle questioni
politiche. Al contrario, la cerchia del WZZ la considerava uno degli attivisti più
importanti. Si aspettava che i suoi talenti e l’esperienza sarebbero emersi durante gli
interventi pubblici.
Anna Walentynowicz imparava in fretta: conosceva le basi della cospirazione, il Codice
del Lavoro, la storia della Polonia, le idee della resistenza anticomunista. Era una buona
allieva, idealista, attiva, coraggiosa, con un’immensa autorità su lavoro e allo stesso
tempo modesta. Parlava solo quando aveva qualcosa di importante da comunicare. In
poche parole era un acquisto così prezioso per il WZZ che in poco tempo divenne una
dei leader dell’organizzazione. Metteva la sua firma sotto le dichiarazioni e gli appelli
del WZZ, ed era un’ottima pubblicità per il sindacato. Tuttavia, Anna era rimasta
un’operaia e i problemi del lavoro le erano dunque molto vicini. L’obiettivo più
importante era quello di attivizzare e di cambiare il modo di pensare di un uomo medio,
per far si che i lavoratori si guardassero intorno e rendersi conto che i loro sforzi non
erano stati vani e, nondimeno, per omaggiare le persone perseguitate per aver protestato.
Pur lavorando nel cantiere, negli anni 1978-80, Anna Walentynowicz
partecipava a quasi tutte le azioni dirette del WZZ: faceva il corriere a Varsavia,
diffondeva la stampa indipendente, partecipava alle udienze dei colleghi ecc.66
Per l’opposizione il massacro del dicembre ’70 era un punto di riferimento, un simbolo
della protesta degli operai contro i comunisti. Durante gli anniversari manifestavano
tutti i membri della resistenza.
Invece, dal punto di vista della SB Anna Walentynowicz era pericolosa in quanto
attivista impegnata che aveva conosciuto direttamente gli eventi di dicembre. Per questo
motivo l’SB , negli anni 1978-79 perquisì la sua casa e l’arrestò preventivamente più
volte. Le motivazioni erano ogni volta le stesse: l’organizzazione di incontri fra operai e
attivisti, la distribuzione di giornali cospiratori e antisocialisti. Nel ’79, alla vigilia
dell’anniversario del Dicembre ’70, Anna venne arrestata con l’accusa di profanare le
66
Cfr. A. Baszanowska e A. Walentynowicz, Cień Przyszłości, Arcana, Kraków 2005, pp. 49-52
57
tombe.67
La SB le propose di nuovo di collaborare. Al rifiuto di collaborare la SB iniziò
a minacciare di poterla distruggere se avesse portato avanti la sua attività di attivista.
Quel primo arresto sconvolse Anna, che voleva ritirarsi della sua attività nel WZZ; i
suoi colleghi la convinsero di essere stata arresta perché temuta dalla SB. Anna non
ebbe allora più paura. Si fece coraggio e tornò a lavorare al cantiere e nel sociale.68
Il WZZ redigeva una rivista indipendente “Robotnik Wybrzeża” (l’Operaio della
Costa). Già nel secondo numero i lettori vennero informati che, accanto ad Alina
Pienkowska, Lech Walesa, Bogdan Borusewicz, i Gwiazda e Edwin Myszk anche Anna
Walentynowicz faceva parte della redazione. La rivista, come suggeriva il titolo, si
occupava dei problemi dei lavoratori e, poiché era indirizzata a persone semplici, usava
un linguaggio chiaro, che la distingueva dalle pubblicazioni statali. Era merito degli
autori, dei membri del WZZ, in gran parte maggioranza operai, e quindi immersi nelle
problematiche operaie. Anna Walentynowicz scoprì il suo talento di oratore. Nonostante
non avesse formalmente ricevuto un’educazione, Anna aveva uno stile inconfondibile
nonché la capacità di esprimere i propri pensieri con chiarezza. La rivista veniva
distribuita nel cantiere. Anna Walentynowicz propose di distribuirla apertamente nella
mensa dove, durante i pasti, si affollavano anche mille persone.
Negli anni 1979-80, le repressioni nei confronti dei membri del WZZ
aumentarono. Tutti gli venivano ripetutamente arrestati, perquisiti, e i loro incontri
disturbati. In poco tempo, i membri illustri del movimento vennero licenziati oppure
degradati.
La nuova, più severa posizione del governo, era forse dettata dagli scarsi risultati della
politica basata sull’isolamento degli “elementi antisocialisti dalle sane masse
lavoratrici”.69
Il 20 novembre 1978 Anna Walentynowicz venne chiamata dal direttore del
reparto W-2. Pensava di essere stata promossa nella categoria remunerativa più alta;
invece, il direttore le comunicò di essere stata trasferita nello stabilimento Techmor, a
67
Probabilmente non si tratta nemmeno di una provocazione della SB ma di una ridicola
coincidenza. Walentynowicz quei giorni stava raccogliendo al cimitero i contenitori vuoti dei ceri per poi
riempirle di cera e decorare con le candele accese la strada che hanno percorso i lavoratori del cantiere nel
Dicembre ’70. Qualcuno l’ha vista e l’ha denunciata. 68
Cfr. S. Cenckiewicz, op.cit, pp. 82-83 69
S. Cenckiewicz, op.cit, p. 95
58
Danzica, senza il diritto di fare appello. Anna fece ricorso al consiglio del cantiere, la
sua squadra firmò a sua difesa. Alla fine, il trasferimento, da fisso mutò in trasferimento
temporaneo, di poco più di un anno. Anna Walentynowicz venne nuovamente contattata
dalla SB. In cambio della sua collaborazione, questa volta, la SB le propose un
trasferimento immediato nel cantiere. Lei, ancora una volta, rifiutò e il suo trasferimento
venne prolungato di quattro mesi. Inoltre, le fu interdetto l’accesso al cantiere.
Al suo ritorno, la direzione fece il possibile per isolarla dai colleghi. Anna fu trasferita
di nuovo, questa volta in un lontano reparto del cantiere.
A marzo del 1980 le fu comunicato che se non avesse smesso di arrecare disturbo sul
posto di lavoro ( distribuendo le copie del “Robotnik”) sarebbe stata licenziata per
motivi disciplinari. Per punizione, Anna è fu ufficialmente rimproverata e le venne tolta
la tredicesima. Anna Walentynowicz fece appello e se, inizialmente, il suo ricorso non
sortì alcun effetto, la direzione revocò successivamente la sua decisione.70
Anna
Walentynowicz dovette dunque tornare al lavoro nel reparto W-2. In quei giorni il
direttore del reparto Gs, dove Anna era stata trasferita, chiese di rescinderle
immediatamente il contratto e che fosse cancellata della lista dei lavoratori del cantiere
motivando la su richiesta sostenendo che Anna “non lavorava e abbandonava il posto di
lavoro senza permesso”. Questa decisione le fu comunicata il 30 luglio mattina, non
appena arrivata al lavoro. Anna venne fermata dalle guardie del cantiere e lo stesso
accadde il giorno seguente. Nonostante Anna, successivamente alla denuncia
dell’accaduto, fosse in possesso di un ordine ufficiale di riassunzione, non vi fu modo di
riottenere il posto di lavoro. Il 7 agosto, fu licenziata ufficialmente: dopo trent’anni di
duro lavoro, a nemmeno un anno dalla pensione, Anna si ritrovò senza lavoro, licenziata
con l’accusa di furto, alcolismo e sabotaggio.
Nel WZZ nessuno aveva intenzione di lasciare correre l’episodio del
licenziamento di Anna Walentynowicz.. Sapevano che se non l’avessero difesa, molti
altri attivisti avrebbero subito la stessa sorte. Si trattava di una lavoratrice affermata,
impeccabile ,con 30 anni di carriera alle spalle. Il gruppo decise allora di indire uno
sciopero. Vennero così stampati dei volantini, firmati dal WZZ, che riassumevano
l’episodio e fornivano istruzioni per lo sciopero. “Ci rivolgiamo a voi, ai colleghi di
70
Cfr. A. Baszanowska e A. Walentynowicz, op.cit, pp 76-81
59
Anna Walentynowicz. Lavora nel cantiere dal 1950, dove è stata saldatrice per16 anni
come e operatore di gru nel reparto W-2, premiata con la Croce di bronzo, argento e
oro al Merito. È stata sempre una lavoratrice impeccabile, una persona sensibile alle
ingiustizie. Questa qualità l’ha spinta a lottare per l’organizzazione dei sindacati liberi.
Si è dovuta difendere da diverse forme di persecuzione; dopo due rimproveri per la
distribuzione del “Robotnik”, è stata trasferita in un altro stabilimento, al reparto
Gs(..). Ultimamente però la direzione non si preoccupa nemmeno di sembrare giusta.
Vogliamo inoltre ricordare che ad Anna mancano 5 mesi per la pensione. Anna
Walentynowicz è diventata scomoda, perché con il suo comportamento è stato di
esempio agli altri, difendeva i colleghi e poteva incitare gli altri operai allo
sciopero(…) per questo vi chiediamo di prendere le parti della gruista Anna
Walentynowicz. Se non lo farete, tanti di voi potrebbero trovarsi nella stessa
situazione.”71
Il 14 agosto, i volantini del WZZ vennero distribuiti sui treni suburbani, nella
stazione centrale e negli stabilimenti industriali più importanti. Bogdan Borusewicz si
occupò dell’organizzazione dello sciopero. Voleva che la loro causa ottenesse
l’appoggio di Lech Walesa che però, inizialmente, non intendeva aderire allo sciopero.
Lo sciopero iniziò alle 6 di mattina. Qualche ora dopo si diffuse la notizia che il cantiere
si era fermato. Era quello il momento di convincere gli altri stabilimenti di Danzica e
delle città circostanti, ad aderire all’iniziative. L’azione del WZZ si rivelò molto
efficace, e già il giorno dopo, solo sulla costa, 50.000 operai di 54 stabilimenti inclusi il
porto, i cantieri, trasporto pubblico e la raffineria avevano aderito allo sciopero.
Il licenziamento di Anna Walentynowicz fu la goccia che fece traboccare il
vaso. Già nella seconda metà degli anni ’70 la crisi economica si andava aggravando.
L’elezione a papa di Karol Wojtyla nel 1978 ed il suo pellegrinaggio in Polonia l’anno
successivo diedero coraggio al popolo polacco.72
71
S. Cenckiewicz, op.cit, p. 107 72
Cfr. J. Eisner,op.cit , pp. 50-55
60
Non era che questione di tempo prima che si verificassero episodi simili allo sciopero
organizzato contro il licenziamento di Anna Walentynowicz, a dimostrazione dello
scontento popolare. Intanto, il governo cercava arginare la drammatica situazione
economica tramite un nuovo aumento dei prezzi. Questa volta vennero alzati i prezzi dei
pasti nelle mense degli stabilimenti industriali. La decisione non venne nemmeno
annunciata. Il giorno stesso, non si fecero attendere le proteste, con alla base richieste
principalmente di natura economica. In totale .a luglio scioperarono 80.000 di persone
in tutto il paese. Fino all’ultimo, lo stato non diffuse le notizia delle “pause di lavoro”,
come erano chiamati gli scioperi nel linguaggio comunista. Quando però si fermò il
trasporto pubblico a Varsavia, non fu più possibile nascondere i fatti.
Come si è già
accennato, il punto di
svolta fu il
licenziamento di Anna
Walentynowicz e la
partecipazione del
Cantiere navale di
Danzica alle proteste. Gli
organizzatori speravano
soprattutto di riuscire a
scioperare abbastanza a lungo da attirare l’attenzione dei media internazionali.
Contavano anche sul fatto che i polacchi venissero a sapere che questa volta gli operai
chiedevano qualcosa di più di un aumento di stipendio. In ogni caso gli stessi
organizzatori dello sciopero erano molto sorpresi della portata dell’azione.
Le prime richieste degli operai, oltre alla riassunzione di Anna Walentynowicz e
l’aumento degli stipendi di 1000 zloty erano la costruzione del monumento per le
vittime del Dicembre ’70, la garanzia di sicurezza per i partecipanti, la liberazione dei
prigionieri politici ma, soprattutto il diritto di formare sindacati legali indipendenti dal
61
governo. Intanto, nuovi stabilimenti si univano alla protesta. Lech Walesa fu eletto alla
guida del Comitato per lo Sciopero.73
Il governo sembrava non capire che questa volta non sarebbe bastato soddisfare le
richieste economiche in mancanza di soluzioni politiche. L’economia polacca verteva in
pessime condizioni già da prima degli scioperi, e in una situazione di emergenza, non
faceva che peggiorare di giorno in giorno.
Sabato 16 agosto il partito decise di riassumere Anna Walentynowicz e di concedere
1500 zloty di aumento a tutti i lavoratori del cantiere. A quel punto, Walesa, decise di
porre fine allo sciopero. accolto con un applauso dai lavoratori che iniziarono a tornare
a casa. Era un momento drammatico perché senza l’appoggio del cantiere di Danzica,
dove scioperava 16.000 persone, le proteste negli stabilimenti più piccoli non avrebbero
resistito a lungo. La fine dello sciopero in quel momento significò perdere un’
occasione unica di influenzare le decisioni dello stato e di legalizzare il WZZ.
Con l’aiuto di Alina Pienkowska, Anna Walentynowicz impedì a 1200 di lasciare il
cantiere e le convinse ad unirsi allo sciopero di solidarietà con altri stabilimenti di
Danzica, Sopot e Gdynia. Le donne sbarrarono il cancello del cantiere impedendo agli
operai di uscire. Tornata la normalità, nel cantiere emerse la questione della leadership.
Come racconta Leszek Zborowski, uno dei partecipanti a quegli eventi:
“Walesa ha rovinato lo sciopero ed è sparito. Si è venuta a creare una
situazione molto complicata. I lavoratoti tornavano nel cantiere, e venivano i delegati
di altri stabilimenti. Nessuno riusciva ad ottenere informazioni. Anna Walentynowicz
teneva discorsi, faceva di tutto per riempire il vuoto (…) ad un certo punto un gruppo di
operai si è rivolto a Bogdan Borusewicz dicendogli che la gente era decisa a continuare
la protesta, l’unico problema che non avrebbero seguito una donna.”74
Quest’affermazione fu una grande sorpresa per tutti. In fretta si cercò un nuovo
leader. Serviva un operaio che facesse parte dell’opposizione e allo stesso tempo
sapesse parlare la lingua degli operai. Fra le schiere del WZZ vi erano persone con i
requisiti giusti, ma conducevano già scioperi in altri stabilimenti. In quel momento fece
ritorno Walesa. Borusewicz gli chiese di tenere un discorso, per riparare i danni da lui
73
Cfr. A. Friszke, Rewolucja Solidarności. 1980-1981, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013, p.
173 74
S. Cenckiewicz, op.cit, p. 127
62
causati. Walesa rifiutò due volte, poi quando gli operai iniziarono a scandire il suo
nome, non ebbe più scelta. La sua elezione venne ufficializzata la sera stessa.
Nonostante il WZZ non si fidasse di lui, sospettando che fosse un “collaboratore
segreto”, cioè un agente della SB, la sua elezione venne confermata vista la stima di cui
godeva fra la gente
Il 18 agosto lo sciopero scoppiò anche a Szczecin, un’altra città portuale nel
nord ovest della Polonia. Nell’arco di circa dieci ore, lo sciopero generale si diffuse
lungo tutta la Costa. Per arginare l’ondata degli scioperi, si passò all’ arresto degli
attivisti dell’opposizione. Il potere si rese conto che la situazione fosse a favore dei
manifestanti. Perciò, il 21 agosto, 64 intellettuali firmarono un appello rivolto al
governo affinché instaurasse un dialogo con gli operai per giungere ad un
compromesso. L’indomani due dei firmatari, Bronislaw Geremek e Tadeusz
Mazowiecki, portarono l’appello al cantiere di Danzica. Il comitato per lo sciopero
incaricò Mazowiecki di formare una commissione di esperti che aiutasse i delegati degli
operai in sede di colloquio.
Finalmente, il 31 agosto 1980, Walesa, a nome di tutto il Comitato per lo
Sciopero, che rappresentava più di 700 stabilimenti e istituzioni, firmò l’accordo con la
Commissione del Governo per porre fine agli scioperi. La conquista più grande fu
ovviamente il permesso di creare sindacati liberi e indipendenti con il diritto di
sciopero.75
Lunedì primo dicembre, Anna Walentynowicz tornò a lavoro: era di nuovo una
dipendente del cantiere navale di Danzica. In quei giorni, il comitato per lo sciopero si
accertava che gli accordi firmati qualche giorno prima venissero effettivamente
rispettati. Fu pubblicato il “Prontuario Sindacale”, che dava consigli su come
organizzare i sindacati indipendenti sul lavoro, come effettuare le elezioni all’interno
dei Comitati dei vari stabilimenti, e citava frammenti della Convenzione Internazionale
di Lavoro. Era molto importante di fronte ai segnali di prove di sabotaggio delle
organizzazioni indipendenti da parte delle direzioni dei diversi stabilimenti. La varietà
dei problemi di cui si occupava il comitato rese necessaria la divisione dei compiti.
Così, ad Anna Walentynowicz fu dati l’incarico di gestire le finanze e il settore degli
75
Cfr. J. Eisner,op.cit, pp. 50-55
63
interventi, ad Alina Pienkowska furono assegnati la segreteria e l’archivio, a Joanna
Gwiazda la stampa e la propaganda, ad Andrzej Gwiazda e Andrzej Kołodziej i contatti
con gli altri comitati. Della parte più importante, i contatti con il governo, si occupavano
Lech Walesa, il presidente, Andrzej Gwiazda, e Bogdan Lis, entrambi vicepresidenti e
Lech Sobieszek. Anna Walentynowicz apparteneva quindi all’élite della neonata
Solidarność.
La cerchia dei attivisti illustri del WZZ, alla quale appartenevano, fra gli altri,
Gwiazda, Borusewicz e Anna Walentynowicz, volevano che Walesa si dimettesse della
carica di presidente della nuova organizzazione. Ritenevano che vi fosse bisogno di una
persona più istruita alla guida del primo e più importante sindacato polacco. Lo
credevano anche troppo “docile” di fronte al Partito e troppo poco rivoluzionario. Non
era infondato anche il sospetto che Walesa avesse collaborato con la SB durante il
Dicembre del ’70. Avendo un motivo per ricattarlo, la polizia politica avrebbe potuto
costringere Walesa ad agire secondo le proprie aspettative; il che si sarebbe rivelato
letale per la nuova organizzazione. Queste però erano le preoccupazioni solo di una
cerchia ristretta di persone. La situazione era particolare. Da una parte una trentina di
persone conoscevano Walesa e i suoi trascorsi; dall’altra, una massa di milioni di
presone era convinta che Walesa fosse il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Alla
fine fu deciso si sospendere l’attività del WZZ e di concentrarsi totalmente su
Solidarność. La divisione interne a Solidarność non sfuggirono al governo. Il Partito era
convinto che il sindacato sarebbe imploso a breve. Il concetto fu espresso chiaramente
dal primo segretario del PZPR, Stanisław Kania durante una riunione del Partito nel
novembre 1980: “io non credo che ci siano dei timori del rovesciamento di Walesa (…)
nessuno dei suoi consiglieri oserà farlo. Walesa è indispensabile, il suo cognome è
indispensabile, è diventato un’istituzione e attraverso di lui possiamo manipolare
Solidarność.”76
La nascita di Solidarność fu proclamata ufficialmente il 17 settembre 1980, con Lech
Walesa come presidente; comunque il governo acconsentì alla sua registrazione solo il
10 novembre.
76
S. Cenckiewicz, op.cit, p. 188
64
Anna Walentynowicz era responsabile delle finanze. Durante le proteste dell’
agosto 1980, i manifestanti avevano raccolto fondi per la costruzione del monumento
delle vittime del Dicembre 1970: contribuirono in molti, raccogliendo un grande somma
di denaro. Ecco perché ci fosse bisogno di una persona di fiducia che alla gestione delle
finanze. Il ruolo di Anna Walentynowicz nel nuovo movimento era importantissimo.
Era una vera icona della svolta morale e politica. A Danzica venivano delegazioni da
tutto il paese per sentire le sue testimonianze. Anche Anna viaggiava in tutta la Polonia,
voleva condividere le sue esperienze con gli altri. La popolarità di Anna doveva
suscitare preoccupazione in Walesa, che nel primo periodo non si spostava di Danzica,
riscontrando che la popolarità della sua collega superava persino la sua. Era l’invidia era
l’elemento principale del conflitto Walesa-Walentynowicz.
Il presidente di Solidarność decise di escludere Anna Walentynowicz della delegazione
che avrebbe dovuto incontrarsi con il primo cardinale Stefan Wyszyński, a Varsavia. Il
cardinale aveva invitato sia Anna che Walesa; tuttavia, quest’ultimo proibì alla sua
collega prendere parte alla delegazione, argomentando che si sarebbe parlato di politica
e dove si parlava di politica era posto di Walesa.77
In seguito, Walesa ostacolò la mobilità di Anna Walentynowicz, in Polonia e nel
mondo. Walesa sentì il capo che non doveva fare più i conti con le strutture di
Solidarność.
La stima per Anna Walentynowicz e il suo atteggiamento impassibile irritavano sempre
di più anche i comunisti. I rappresentanti del governo suggerivano durante gli incontri
con i delegati di Solidarność che Anna Walentynowicz non avrebbe dovuto partecipare
ai colloqui perché ostacolava il raggiungimento di un’intesa. Si intensificò anche il
conflitto fra Walesa e Anna Walentynowicz. A dicembre si discusse apertamente per il
monumento commemorativo del Dicembre ’70. Inizialmente avrebbe dovuto avere il
nome di Monumento delle vittime del Dicembre ’70, mentre Walesa approvò il nome di
Monumento di riconciliazione, visto che durante quegli eventi erano morti anche dei
poliziotti. Anna Walentynowicz si oppose con decisione. La voce del litigio arrivò fino
al segretario regionale del partito e, in seguito, Walesa tentò di costringere Anna
Walentynowicz a dare le proprie dimissioni da Solidarność per aver sollevato la
77
Cfr. A. Baszanowska e A. Walentynowicz, op.cit, pp. 105-106
65
questione. Alla fine, fu Anna a vincere la causa del monumento. Sul monumento sono
riportati solamente i nomi dei lavoratori del cantiere morti durante la rivolta del
Dicembre ’70. Anna, tuttavia, non fu invitata all’inaugurazione della statua.
Il 31 marzo 1981, la sottocommissione di Solidarność del reparto W-3 si rivolse alla
Commissione di Solidarność del cantiere proponendo l’espulsione di Anna
Walentynowicz delle strutture di Solidarność a Danzica, motivando la richiesta con
l’accusa di rovinare il buon nome di Walesa, scarsa attività delle strutture
dell’organizzazione e frode. Dopo un’iniziale verdetto affermativo, fu accolto il ricorso
di Anna Walentynowicz, che fu ritenuta non colpevole dalla commissione speciale che
doveva valutare la causa. Questo evento ha smascherato le intenzioni della leadership di
Solidarność riguardo ad Anna Walentynowicz. Poco dopo, nel luglio 1981, alla vigilia
dell’assemblea generale di Solidarność, Anna Walentynowicz scoprì che il cantiere non
le aveva assegnato il mandato di partecipazione. Anna decise, tuttavia, di partecipare
all’incontro durante il quale avrebbe annunciato il suo ritiro dal movimento, pur essendo
ferita dalle decisioni di Solidarność. La sua decisione scatenò proteste; Anna chiese di
non pensare alla sua causa, bensì ad altre, più urgenti,di natura politica. Da quel
momento in poi, Anna Walentynowicz divenne un membro fondamentale di
Solidarność. Continuò a viaggiare, anche se privatamente. Ovunque andasse veniva
ricevuta come un rappresentante ufficiale, cosa che ancora turbava Walesa. Durante
l’estate e l’autunno 1981 Anna andò in Spagna, Francia, Inghilterra. A Parigi fu ricevuta
da François Mitterrand, a Oxford da Leszek Kołakowski.
La SB cercava in tutti i modo di limitare la sua mobilità e allo stesso tempo la
sua influenza su Solidarność. Era pericolosa perché parlava apertamente della situazione
all’interno di Solidarność, degli intrighi e del tradimento degli ideali dell’Agosto ’80.
I comunisti si preparavano alla distruzione di Solidarność. A novembre e
dicembre la situazione si fece sempre più tesa. Le proteste ripresero e i comunisti
mostravano volentieri la loro forza. Il 13 dicembre 1981, Wojciech Jaruzelski, ministro
della Difesa, proclamò la legge marziale. Era il momento perfetto. Era la notte tra
sabato e la domenica, quando la maggior parte degli stabilimenti non lavorava, il che
rendeva quasi impossibile lo scoppio degli scioperi, o almeno lo ritardava di qualche
ora. In quei giorni, a Danzica, si svolse un’assemblea nazionale alla quale prese parte
66
tutta la direzione di Solidarność. La notte vennero isolati i telefoni e effettuato l’arresto
di attivisti importanti. Per sedare eventuali proteste lo Stato spiegò 30.000 funzionari di
polizia, 70.000 soldati, 1750 carri armati e centinaia di aerei ed elicotteri.78
Anna Walentynowicz evitò l’internamento soltanto perché era in viaggio.
Appena tornata si diresse in cantiere. Lì, dopo 24 ore circa di proteste, l’esercito fece
sgomberare il cantiere. Il 18 dicembre, Anna Walentynowicz fu arrestata e incarcerata
nella prigione di “Fordon” a Bydgoszcz. Lì incontro le colleghe Joanna Gwiazda, Alina
Pienkowska e Joanna Wojciechowska. In prigione ricevette la notizia della nuova
politica di internamento della regione di Danzica per chi avesse compiuto azioni
destabilizzanti che portano l’anarchia nella società. Il 9 gennaio 1982 le donne vennero
trasferite a Gołdap, dove si trovava un campo di isolamento per le donne. Le condizioni
erano dignitose; il campo era sorto su una struttura pensata per la villeggiatura. Le
prigioniere avevano accesso alle cure mediche, mangiavano bene, potevano ricevere la
corrispondenza e le visite della famiglia. Presto però quella vacanza obbligatoria
divenne deprimente.
Durante il periodo di reclusione, Anna Walentynowicz si incontrò un paio di volte con i
funzionari della SB che facevano pressione perché collaborasse, offrendole in cambio la
leadership di Solidarność. Ancora una volta, Anno rifiutò.
L’internamento ebbe fine il 24 luglio 1982. Durante tutto quel tempo, la SB di Danzica
si era preparata per il processo all’operatore di gru del cantiere. Si trattava della sua
attività illecita durante le proteste scoppiate subito dopo l’introduzione della legge
marziale.
Il 26 luglio Anna Walentynowicz tornò a lavoro. Il suo ingresso nel cantiere mise tutti
in agitazione. I lavoratori volevano vederla, parlarle. Poco dopo, Anna Walentynowicz
scoprì che la direzione aveva prepararto la documentazione necessaria per la pensione.
Lei non firmò i documenti; richiese, invece, le ferie fino al 21 agosto. Il 23 agosto, non
appena arrivata al lavoro, fu convocata dalla direzione. Questa volta le offrirono la
giusta retribuzione, senza scioglimento del contratto, a patto che non venisse al lavoro.
Questa volta firmò.
78
Cfr. J. Eisner, op.cit, pp. 55-61
67
Il 30 settembre, Anna fu arrestata di nuovo. Questa volta per aver organizzato un
digiuno di solidarietà per la liberazione dei prigionieri politici.
Il 1 settembre vennero formulate le accuse contro di lei, in un processo formale. Era
accusata di aver utilizzato le macchine dei pompieri fra il 14 e 16 dicembre 1981 contro
la polizia e l’esercito. Venne trasferita nella prigione di Grudziądz. Non aveva la
possibilità di contattare l’avvocato, né di vedere la famiglia o di ottenere i vestiti caldi.
In quelle condizioni il suo stato di salute peggiorò e Anna fu spostata al reparto
ospedaliero della prigione. Dalla prigionia scriveva appelli al presidente, lettere aperte,
ricorsi ufficiali, difendeva altri prigionieri.
Il 2 dicembre 1982 fu licenziata dal lavoro, vista l’assenza al cantiere.
Il processo contro Anna Walentynowicz ebbe inizio il 9 marzo 1983. Anna fu giudicata
colpevole, ma, poiché il tempo passato nell’arresto le fu scontato dalla sentenza, Anna
era, di fatto, libera.79
La sua situazione era grave. Era rimasta disoccupata e senza diritto alla
pensione, che avrebbe acquisito il 15 settembre 1984; suo figlio era imprigionato e lei
non riusciva sapere dove. Durante l’anno 1983 si susseguirono una serie di arresti e
accuse, archiviate grazie all’amnistia per i prigionieri politici del luglio 1984. La sua
salute però peggiorò. A maggio si sottopose a una serie degli esami oncologici ed
rimase in ospedale per un paio di mesi.
All’inizio dell’agosto 1984, Anna tornò a casa e, nel giorno del suo
cinquantacinquesimo compleanno acquisì finalmente il diritto alla pensione.
Nonostante le difficoltà e i dispiaceri Anna non si arrese. Possiamo definire la
sua attività di quel periodo possiamo come patriottica, culturale e sociale. Organizzava
le messe per i soldati della seconda guerra mondiale, le vittime del dicembre ’70 e della
legge marziale, organizzava le mostre. Un legame particolare la univa unita al giovane
prete Jerzy Popiełuszko, cappellano di Solidarność. La notizia della sua scomparsa e
poco dopo, del suo omicidio sconvolse Anna Walentynowicz e tutto il popolo. Anna
pensava che quell’atto bestiale avrebbe risvegliato il popolo aprendo i loro occhi sulla
vera natura del comunismo, e che tanti attivisti di Solidarność avrebbero capito che non
esiste la strada del dialogo con il potere. Anna credeva che organizzare una grande
79
Cfr.S. Cenckiewicz, op.cit, pp. 316-317
68
protesta contro il regime fosse un obbligo sociale. Insieme agli amici firmò un “Appello
agli abitanti della regione di Danzica”: “il rapimento e l’omicidio di Jerzy Popiełuszko
ha scosso l’opinione pubblica. Una persona conosciuta e rispettata in tutto il paese è
diventata vittima del banditismo politico. La vittima è stata scelta non a caso, per
spaventare diversi gruppi: la città, la campagna; tutti gli schieramenti politici e anche
la gente che sta alla larga della politica (…) Proponiamo il modo più pacifico di
rendere omaggio alla memoria di padre Jerzy. Facciamo appello alla partecipazione a
cerimonie religiose nonché ad indossare il lutto sotto forma di larghe fasce nere sul
braccio(…) la vittima era un eroe, una persona attiva, un prete e un patriota la sua vita
era un esempio per tutti. Saremo fedeli agli ideali per i quali ha sacrificato la propria
vita.”80
Il 20 Novembre, in segno di protesta, Anna Walentynowicz si recò di persona
presso la cancelleria del Consiglio di Stato per restituire tutte le medaglie e le
onorificenze che le erano conferite in passato per meriti sul lavoro. Di questo gesto
scrissero anche le agenzie di stampa internazionali. Anna Walentynowicz spiegò i
motivi della sua decisione ai giornalisti stranieri accreditati in Polonia. Teneva ad
attrarre l’attenzione del mondo sull’omicidio di Popiełuszko nonché sulle sistematiche
violazioni dei diritti umani nella Polonia Popolare. Non credeva che il comunismo
potesse cambiare e mise in allerta in proposito i paesi occidentali.
“Quello che sta succedendo in Polonia è una prova per tutto il mondo di come è
fatto il socialismo. È un’introduzione al comunismo, che porta con sé la miseria e il
terrore(…)pensate alle gente repressa e ammazzata laddove arriva lo spettro del
comunismo. Pensate ai nemici padre Popiełuszko, agli attentatori alla vita del Papa. È
il prezzo che le nazioni pagano per la verità, la giustizia e la libertà. Vi auguro di
mantenere questi valori. L’uomo non si può distruggere, si può solo ammazzarlo.”81
Nell’ anno 1986, la situazione politica ed economica in Polonia peggiorò
ulteriormente. Di fronte alla catastrofe ecologica di Chernobyl, Walesa e i suoi
sostenitori espressero la volontà di dialogare con i comunisti. Come segno di buona
volontà fecero appello al governo statunitense affinché annullasse le sanzioni
80
S. Cenckiewicz, op.cit, p. 352 81
Idem
69
economiche imposte dagli Stati Uniti in risposta all’introduzione della legge marziale
nel 1981.
Anna Walentynowicz non nascondeva l’indignazione. Per lei quell’appello era un
tradimento dei polacchi. L’amministrazione americana sottolineava sempre che le
sanzioni era un atto di lealtà nei confronti della società polacca. Il gesto di Walesa era
puramente simbolico. Il leader di Solidarność, ormai illegale, appoggiava in maniera
indiretta la politica del regime.
La polizia segreta, in quel periodo, iniziò a perdere interesse per Anna
Walentynowicz. La osservava, ma non la perseguita. Le autorità si erano rese conto che
il suo licenziamento aveva contribuito alla maggiore mobilità di Anna Walentynowicz
che, in quel periodo, consacrava quasi tutto il suo tempo all’attività pubblica.82
A cavallo fra il 1986 e il 1987, di fronte alla grave crisi economica in tutto il blocco
sovietico, i comunisti polacchi si stavano preparando alle riforme, insieme
all’opposizione moderata. Cercavano di allacciare il dialogo con i rappresentanti di
Solidarność. I radicali, come Anna Walentynowicz, volevano tornare ai valori del WZZ.
Walesa sapeva che i comunisti non si sarebbero mai confrontati con un gruppo radicale,
anche se il Gruppo Operativo Solidarność, come si chiamava il nuovo movimento, non
era contro il dialogo. Voleva solamente che le riforme arrivassero dal basso, dalla
società. Anna Walentynowicz tentò nuovamente di convincere Walesa ad aderire, ma
era, ormai, solamente un’icona.
Anna, però, non smise mai di impegnarsi per la società. Nel 1988 ha inaugurò
una serie di conferenze intitolata Della Preoccupazione Per la Casa Paterna, che
facevano la luce sui vari settori di vita: l’educazione, l’agricoltura, la salute, l’ecologia.
Le conferenze si rivelarono un successo e Anna Walentynowicz continuò ad
organizzarle fino alla fine della sua vita.
La visione di un’intesa delle élites di Solidarność con i comunisti suscitava
comprensibili emozioni. L’abbozzo generale era il seguente: la prima tappa avrebbe
consistito nei colloqui diretti con Lech Walesa, senza nessun prerequisito da parte del
governo. successivamente, una rappresentanza della società, scelta nel corso delle
elezioni dai membri di Solidarność, avrebbe dovuto iniziare i colloqui diretti con i
82
Cfr. A. Baszanowska e A. Walentynowicz, op.cit, pp. 172-175
70
rappresentanti del potere per stabilire le condizioni delle riforme economiche e
politiche. Alla fine si sarebbe dovuto formare un governo di esperti per mettere in atto
tutti i progetti.
La prima tappa ebbe luogo il 31 agosto 1988 a Varsavia e poi a Magdalenka, tra la fine
del 1988 e l’inizio del 1989, quando Walesa hanno incontrò il generale Czeslaw
Kiszczak e una parte del governo comunista ai colloqui segreti. In seguito, nel gennaio
1989 Solidarność formò un gruppo di coordinatori per organizzare i colloqui ufficiali.83
I dibattiti della Tavola Rotonda si svolsero dal 6 febbraio al 5 aprile 1989, e portarono
una serie di cambiamenti. Innanzitutto la carica di presidente venne reintrodotta. In
secondo luogo furono previste elezioni parlamentari (con il 65% dei mandati alla PZPR
e Solidarność e il 35% per altri candidati).
Le elezioni al Parlamento ebbero luogo il 4 giugno 1989. Anche se il Partito cercava di
mantenere, in apparenza, eterogeneità politica, la maggioranza dei candidati erano i
membri del PZPR oppure strettamente collegati con i comunisti. In ogni caso le elezioni
si rivelarono un grande successo dell’opposizione.
In quel periodo Anna Walentynowicz si trovava negli Stati Uniti, per una serie
di conferenze sulla situazione politica in Polonia. Oltre oceano, gli avvenimenti
polacchi andavano di moda, purtroppo a colpa del suo radicalismo Anna
Walentynowicz spesso incontrava se non ostilità, almeno una certa incredulità.
La Polonia che trovò al suo ritorno non era sicuramente il paese che sognava. Serbava
un autentico rispetto per le persone che durante le elezioni non votarono per i comunisti,
ma era rimasta comunque un critico severo delle élites di Solidarność. Sapeva
benissimo che la posizione dei leader di Solidarność sulla divisione dei mandati aveva
poco a che fare con le libere elezioni. Non si identificava né con il “primo governo non
comunista”, né con il presidente Wojciech Jaruzelski, lo stesso che nel 1981 aveva
introdotto la legge marziale. Non poteva accettare lo stato in cui “i nostri” (cioè i
rappresentanti di Solidarność) partecipavano ai festeggiamenti pubblici per
l’anniversario della rivoluzione di ottobre e difendevano pubblicamente l’adesione al
Patto di Varsavia o lodano Jaruzelski come garante di democrazia.
83
Cfr. A. Friszke,op.cit, pp. 817-820
71
L’elezione a presidente di Lech Walesa non cambiò molto il paesaggio politico
postcomunista. Il ministro degli interni dichiarò apertamente che “per ragioni
legislative, sociali, politiche e morali non avrebbe mai svelato i nomi degli agenti
segreti e dei funzionari della SB.”84
Anna Walentynowicz, anche se non sentiva di avere grandi speranze di poter cambiare
qualcosa, tenendo presenti le sue passate esperienze, continuava a dire apertamente che
la Polonia era governata da un agente segreto della SB. Andrzej Gwiazda affermava
invece che:
”gli eventi fino ad ora sono andati così come volevano le élites. I partiti
considerati di sinistra, che potevano rappresentare l’interesse sociale, erano stati
compromessi in precedenza. I “liberali” sono un branco di ladri, non un partito
politico. Hanno sempre saputo quale fosse il loro compito: proporre ai comunisti che
perdevano importanza, di dividere il potere.(…)la Polonia è come un mercato dove due
gang si sono divise le loro influenze.”85
L’opinione negativa che aveva Anna Walentynowicz su Walesa le fece rifiutare
il titolo di cittadino onorario di Danzica nell’ anno 2000. Evitava anche gli
anniversari ufficiali di Solidarność. Se ne gli anni ’90, Anna Walentynowicz
considerata persona non gradita, in occasione del decimo anniversario della
nascita di Solidarność, Anna non venne nemmeno nominata.
Nell’ottobre del 2003 Anna decise di partecipare ad un incontro organizzato
dall’Istituto della Memoria Nazionale (Instytut Pamięci Narodowej, IPN). In occasione
della riunione organizzata dall’ IPN si incontrarono Anna Walentynowicz, Lech
Walesa, i Gwiazda, Bogdan Borusewicz, Jan Karandziej, Krzysztof Wyszkowski e
Mariusz Muskat. Durante quel incontro Anna Walentynowicz accusò nuovamente
Walesa di aver collaborato con la SB. Walesa giurò che non era vero :
“ho attraversato un paio di momenti difficili. Ad esempio, in occasione
dell’incontro con Edward Gierek. (…) il giorno dopo la SB stava da me(…) “Ci
aiuterà? Collaborerà nella ricostruzione della Polonia?”- “Lo farò” ed effettivamente
mi chiedevano di collaborare, ma mai come un agente, mai mi hanno chiesto di
84
S. Cenckiewicz, op.cit, p. 413 85
S. Cenckiewicz,op.cit, p.414
72
denunciare i colleghi(…) quando mi resi conto che non lavoravano per il bene della
Polonia, che il comunismo non è riformabile, allora dissi ”Signori: niente discorsi,
niente incontri, lì è la porta”.86
Nel 2005 i membri di un’organizzazione americana commemorativa
delle vittime del comunismo, la Victims of Communism Memorial Foundation, donò a
Anna Walentynowicz la Medaglia della Libertà di Truman-Regan per il coraggio e la
forza di mantenere vivo il desiderio di una vita in libertà. Sei mesi dopo, il presidente
polacco, Lech Kaczyński, la decorò con Medaglia dell’Aquila Bianca, la più alta
decorazione polacca per l’attività di trasformazione democratica in Polonia.
La biografia di Anna Walentynowicz è la storia di Polonia Popolare. È un
ritratto degli operai che si sollevarono per ribellarsi contro il comunismo. Ha sempre
visto la sua vita come un servizio, un lavoro per gli altri. Con la posizione che aveva
all’interno del cantiere prima e poi nei primi tempi di del Solidarność dei primi tempi,
sarebbe potuta diventare famosa, ed entrare nel governo. Nonostante ciò, non volle mai
entrare in politica, in quanto non tollerava il distacco della politica dalla moralità. Anna
rimase sempre fedele ai suoi ideali di patriottismo e solidarietà. Proprio per questo,
86
S. Cenckiewicz,op.cit, p.419
73
forse, ebbe così tante delusioni, spesso proprio da parte di coloro che considerava amici,
che le si rivoltarono contro.
Il piano di cancellare la figura di Anna Walentynowicz dalla storia non ebbe successo. Il
mondo si ricorda che gli operai del cantiere navale di Danzica hanno scioperato per lei
nel 1980. Come Anna disse una volta “la verità anche se nascosta e disprezzata
troverà sempre una strada”.87
Dopo la sua morte un pubblicista americano l’ha chiamata la donna di ferro.
Anna Walentynowicz muore il 10 aprile 2010 durante il suo ultimo viaggio.
Insieme al presidente della Polonia, Lech Kaczyński, ministri e un gran numero dei
rappresentanti delle élites culturali e intellettuali polacchi e doveva partecipare nella
commemorazione del massacro di Katyń, dove, durante la Seconda Guerra Mondiale,
gli ufficiali sovietici sterminarono più di 20.000 ufficiali e soldati polacchi. L’aereo
presidenziale non arrivò mai a destinazione, cadendo in circostanze poco chiare, poco
prima di atterrare all’aeroporto di Smoleńsk.88
Dopo il 10 aprile, che ha profondamente segnato la società polacca,
l’atteggiamento del popolo si fece più radicale; i cittadini incominciarono a riflettere
sulla situazione politica del paese e a porsi domande in proposito.
Nella Polonia di oggi si parla sempre di più di quegli eroi dimenticati oppure
taciuti nei primi vent’anni dopo la trasformazione. Ancora oggi viviamo in un paese
postcomunista dove al potere vi sono spesso politici la cui carriera è iniziata proprio fra
le fila del PZPR; un paese dove il governo, grazie a strumenti come i mass media
plasmavano la realtà anziché raccontarla. Grazie a persone come Anna Walentynowicz,
però, ogni cittadino ha almeno il diritto di parlarne, di porre domande. E, cosa più
importante, ha la possibilità di trovare le risposte.
87
Cfr. S. Cenckiewicz, op.cit, p. 420 88
Cfr. A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, op.cit, pp. 127-134
74
CONCLUSIONE
Il lato puramente storico del comunismo e abbastanza conosciuto. Molti
ricercatori hanno lavorato e lavorano ancora per far luce sul periodo che ha
condizionato la realtà in cui viviamo. La Rivoluzione d’Ottobre, la falce e martello, la
Guerra Fredda, Solidarność o la caduta del Muro di Berlino sono tutti simboli di cui
ognuno di noi ha sentito parlare e che, oggi, sono diventati pop.
Tuttavia, al di la di questa moda superficiale, è importante ricordare le importantissimi
decisioni politiche che per cinquant’anni influenzarono la vita di circa quaranta milioni
di persone in Polonia.
Lo scopo di questo lavoro è innanzitutto quello di avvicinare il lettore alla
situazione delle donne durante il periodo del comunismo nonché sottolineare come la
questione della parità di genere divenne un potente strumento politico. Attraverso
adeguate strategie politiche, lo Stalinismo garantì manodopera femminile a basso costo
per suoi piani di industrializzazione di un paese la cui economia basava, fino ad allora,
sull’agricoltura. Le donne, cogliendo un’imperdibile occasione di emancipazione,
risposero in massa agli appelli di propaganda. Nel 1950, le donne rappresentavano
appena il 30% dei lavoratori. Alla fine del periodo comunista, questa percentuale era
aumentata fino al 45.6%. Secondo l’ideologia comunista, era proprio il lavoro retribuito
la via per raggiungere l’emancipazione femminile. Tuttavia, gli stessi leader comunisti
posero dei limiti all’emancipazione, attraverso la segregazione sul posto di lavoro e non
permettendo alle le donne di fare carriera. È importante ricordare che, anche durante il
suo periodo più severo, sebbene incoraggiasse l’emancipazione femminile attraverso il
lavoro, lo Stalinismo controllava tale fenomeno, affinché non oltrepassasse determinati
limiti. In altre parole, l’emancipazione femminile non doveva ribaltare i ruoli sociali
tradizionali.
75
Negli anni settanta, gli obiettivi del governo cambiarono. L’amministrazione del
Primo Segretario, Gierek, pose l’accento sull’innalzamento degli standard di vita e
sull’aumento del tasso di nascita. Le pari opportunità non erano più il tema centrale del
dibattito pubblico. Più precisamente, le pari opportunità erano intese in quel periodo
come il diritto della donna di potersi occupare della casa e dei figli. Gli osservatori si
concentravano piuttosto su come le donne avrebbero contribuire al progresso sociale ed
economico e alla razionale organizzazione della società basata sulla differenza di
genere. Alcuni ritenevano che dare alle donne la possibilità di svolgere le professioni
maschili fosse disumano nonché segnale dello sfruttamento del lavoratore. Questo
atteggiamento era anche un tentativo da parte del governo di rompere definitivamente
con il periodo stalinista e con le sue atrocità.
Contestualmente ai messaggi della propaganda, che promuovevano il ruolo della
donna madre e casalinga come modello ideale di donna comunista, cambiarono anche le
politiche sociali. Lo stato assicurò il congedo per maternità retribuito alle donne. Già nel
1968, il governo aveva adottato una legge che prevedeva il congedo per maternità non
retribuito di un anno per le madri dei figli sotto i 4 anni. Nel 1972, il congedo, divenne
di tre anni, mentre, il già esistente congedo per maternità retribuito di tre mesi, passò a
quattro. Nel 1981, il Concilio dei Ministri adottò introdusse il congedo famiglia
retribuito al 50-100% a seconda del reddito familiare. Entro la metà del 1982, più del
90% delle lavoratrici qualificate approfittarono di tale possibilità. Ne emerge, dunque,
che le politiche sociali ed economiche influenzarono la vita delle donne,
incoraggiandole sempre all’emancipazione.
Insieme ai cambiamenti della vita lavorativa delle donne, mutava anche
l’approccio dello stato in tema pianificazione della famiglia e contraccezione.
Prendendo in considerazione tutto il periodo comunista in Polonia, si può affermare,
che, paradossalmente, nei periodi di terrore le politiche che regolavano l’aborto e la
contraccezione erano più liberali che nei tempi di distensione politica, durante i quali,
invece, l’accesso ai contraccettivi moderni e all’aborto legale era limitato se non negato.
Questo fenomeno era condizionato dalla posizione della Chiesa Cattolica, da sempre
contraria al controllo delle nascite. A differenza dello stato, la chiesa considerava il feto
(già dal suo stato embrionale) un essere umano a tutti gli effetti.
76
La chiesa, anche se perseguitata durante il comunismo, mantenne sempre il suo ruolo
chiave. Era un’organizzazione di fondamentale importanza, considerata dal popolo,
quasi interamente cattolico, come istituzione in opposizione al regime comunista.
Godeva quindi di grande autorità fra i fedeli.
Durante la crisi, lo stato cercò quindi l’appoggio della Chiesa, con la quale era disposto
ad allearsi.
Dopo la transizione, la Chiesa affermò il suo potere e iniziò a fare sempre maggiore
pressione sulla politica sociale dello stato, in particolar modo relativamente alla
questione dell’aborto. Da questo punto di vista, quando, negli anni novanta, le donne
videro gradualmente sfumare il loro diritto a decidere della propria vita e gravidanza, in
molte si sentirono ingannate. Oggi, in Polonia, l’aborto è legale fino alla ventiduesima
settimana di gravidanza, solamente in caso di gravi deformazioni del feto o seri rischi
per la salute o la vita della madre.
La transizione dal comunismo ad un sistema di libero mercato ebbe influenzò
notevolmente la vita dei lavoratori. La nuova struttura economica incise sull’attività
economica del paese, che non si basava più sull’industria. Paradossalmente, furono
proprio gli operai, che si erano attivamente impegnati per abolire il comunismo, a
risentire maggiormente della trasformazione. Oggi, in piena realtà postindustriale, gli
operai non sono la classe sociale privilegiata. Nel 2007, i lavoratori industriali erano
solamente il 25,8% di tutti gli impiegati. Le donne rappresentavano il 35,6% di questa
percentuale. I centri industriali di Katowice, Zambrów e Żyrardów, che una volta erano
l’orgoglio del sistema socialista, vennero chiusi o privatizzati. Il Cantiere Navale di
Danzica fallì. Furono le miniere in Silesia a dover affrontare probabilmente le sfide più
difficili. Dei cambiamenti risentirono soprattutto le donne che lavoravano in superficie o
nell’amministrazione. Negli anni 1990-94 il 77% dei minatori licenziati era donna. Un
volta licenziate, in quanto poco istruite, incontravano difficoltà nel trovare un nuovo
impiego. Lo status dei minatori uomini, invece, non subì danni cosi gravi. Diversi
programmi miravano ad offrire assistenza gli operai che avevano perso il lavoro,
garantendo loro facilitazioni per la pensione, risarcimenti ecc. Queste soluzioni, tuttavia,
non erano accessibili alle donne. Le donne licenziate in seguito ai tagli del personale
nella fabbrica tessile di Łódź negli anni novanta, ricevettero un risarcimento venti volte
77
inferiore rispetto ai minatori uomini licenziati. Con l’adesione all’Unione Europea nel
2004 la Polonia adottò le leggi europee sulle pari opportunità di carriera per donne e
uomini, superando così la divisione netta fra mestieri maschili e femminili. Le nuove
leggi non erano il frutto dell’ingegneria sociale o dell’esigenza d’industrializzazione del
paese, bensì espressione dei diritti umani e dei valori democratici. Basti pensare che nel
maggio del 2008, il governo polacco consentì nuovamente alle donne di lavorare in
miniera. Come negli anni cinquanta, i minatori e i leader dei sindacati opposero
resistenza e alcuni giornalisti paragonarono il ritorno delle donne in miniera agli abusi
dello stalinismo. Come disse Bozena Diably, portavoce del ministro del lavoro,
“Nessuno può vietare ad un’altra persona di diventare un minatore soltanto perché
donna. Si tratterebbe di discriminazione di genere(…)nessuno ora inizierà a gridare:
“tutte in miniera!”, ma l’accesso al lavoro deve essere uguale per uomini e donne.”89
Purtroppo la realtà lascia a desiderare. Le donne risentono ancora le
discriminazioni al posto del lavoro. Come cinquan’anni fa hanno maggiori problemi di
trovarlo e guadagnano meno degli uomini sia svolgendo un lavoro fisico sia ai posti
manageriali.
Un grande problema è reinserimento delle madri nel mercato di lavoro. Spesso i datori
di lavoro licenziano le donne quando scoprono che le loro dipendenti aspettano un
bambino. Poche donne trovano l’impiego dopo il cobgedo maternità che è causato dalla
scarsità dei lavori flessibili, molto diffusi nei paesi scandinavi pe esempio.
Abbiamo ancora molta strada da fare per arrivare ad una vera emancipazione, il
pensiero che ci rende speranziose è che oggi ci sono sempre più donne che partecipano
nel dibattito publico, al seno del governo. E chi meglio delle donne potrà prendersi di
loro?
89
M. Fidelis, op.cit, pp. 252
78
ENGLISH SECTION
The first image that springs to mind when we talk about women and Communism is a
smiling female worker wearing overalls and driving a tractor. We think about women
doing a man’s job and about total control just like in Orwell’s novel. In this dissertation
I will try to describe how different periods of Communism influenced women's lives in
postwar Poland.
Without any doubt World War II was the biggest catalyst of social change
including the most private aspects of human life like family, marriage and social roles.
Although actual fighting lasted only a few weeks in Polish territory, the men were often
away from home for long periods, they became partisans, and were deported etc. The
women found themselves on their own and had to learn how to make ends meet and to
provide for their families. They were a great example of courage and resourcefulness
while taking care of their families. Even after the men returned, many continued
working because one salary was not enough to maintain a family. Besides, after a period
of responsibility and independence women did not want to be treated simply like an
expensive piece of furniture.
Soon a growing number of working women attracted the attention of politicians,
intellectuals and ordinary people. Marx and Engels had already developed a theory of
the “new woman” that would fulfill herself through work. However, real changes were
possible only under the specific circumstances that the war provided. Unprecedented
conditions like a growing number of working women and the Communists’ attempts to
put into practice gender equality, made it possible to break with the notion of gender
difference where women were tied to the family and men were destined to public
sphere: work, politics, economy.
To understand the condition of woman in postwar Poland we should remember
about the experience of the Second World War and the Communist takeover. The events
of the ‘40s were crucial for the formation of a new Polish society and for the creation of
the so-called homo sovieticus.
79
Polish Communism differed totally from its Soviet counterpart. Firstly, in Poland the
Communist takeover was not a spontaneous process like in Albania or Yugoslavia. The
system was imposed from above and that is why its legitimacy was limited. In order to
consolidate their power, the leaders tried to establish a system that would fit in with
local conditions. Polish people always considered themselves and their country as being
on the border of the civilized world and had always feared danger from the East. In fact,
from the end of the 18th
century to 1918, Poland was divided between Russia, Prussia
and Austria, and so Soviet soldiers were not perceived as saviors at the end of the war.
For almost two years, the Red Army oppressed Polish citizens in an attempt to eradicate
social classes although what they were really doing was eliminating the intelligentsia
and introducing Communism. The URSS started the Sovietisation of the Polish territory
during the war. The cultural and political élite and any opposition was systematically
eliminated. At the same time, the repression apparatus was being developed and the new
Communist power tried to convince the population that it was legitimate by spreading
nationalistic and patriotic slogans.
The event that would mark the future of Poland was the referendum imposed by
the post-war Peace Treaties. It was the only opportunity for the Communists to legalize
their power internationally, but the opposition hoped that western countries would
guarantee democratic procedures.
The referendum – known as the “three times YES referendum - comprised three
questions that the population had to answer: if they were for or against the abolition of
the Senate, for or against the nationalization of industries and for or against new
borders.
The referendum took place on 30 June 1946. The results were rigged but since western
countries did not react, it was a clear sign for Stalin that he could continue his work in
Poland and go ahead with the parliamentary elections. They were held on 19 January
1947; thousands of people who may have voted in the “wrong” way underwent
preventive arrest, hundreds had been cancelled from electoral lists and votes were not
even counted. A statement issued on 31 January 1947 announced that over 90% of
citizens with the right to vote had participated in the referendum and 80% were in favor
of the Communists and their allies from the Democratic Block. Once again, lack of
80
reaction from the West meant that Communist lead Poland was recognized as a legal
country and decisions taken during postwar peace conferences were considered to be
fulfilled.
In a way, it was a turning point. The people were terrorized and afraid to express their
real opinions. The nationalization of private propriety made society grow poor.
Moreover, deportations, mass transfers of people and migrations weakened the family
and social bonds of entire groups.
Although the country had been devastated by the war, Stalin ordered Poland not to
participate in the Marshall Plan. Instead, between 1945 and ’48, the Three Year Plan
was implemented to form a solid basis on which to reconstruct the nation’s economy.
Besides eliminating private ownership, the government aimed at replacing the free
market with a planned centralized economy.
The political scene had been unified which meant that only one party remained -
the PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza- Polish United Workers’ Party - the
organization that was to monopolize Polish political life until 1989.
Finally, the Constitution of the People’s Republic of Poland was passed on 22 July
1952. The content of this document was created in collaboration with Moscow and
acclaimed by Stalin. The Constitution guaranteed no human rights and the office of
president was replaced by the Council of State.
In this dissertation, I will write about the condition of women in this entirely
new social context. Communism offered great opportunities for historically
disadvantaged social groups, the working class, farmers and women. These reforms
though were not the result of a social evolution; they were imposed, included in a
revolutionary program of a revolutionary government. One only has to think about
women working in mines, farmers’ children going to university and workers that were
becoming important in government. They were all things considered an essential factor
of this social engineering, but not everybody was ready to accept changes that went
against tradition and social norms.
Consequently, on one hand women had a unique opportunity to emancipate, have a
career, decide about their life, and earn money, while on the other they were
discriminated at work, and had a double burden: their professional life and housework.
81
I will try to examine those and other paradoxes with the help of the biography of
Anna Walentynowicz, a welder and hero of Socialist Labor turned dissident who
became a Polish free trade union activist. We can say that without Anna Walentynowicz
we would not have had the Solidarność movement and the 1989 transition.
2. PRIVATE LIFE
Stalin’s death on 5 March 1953 marked a turning point in all soviet countries.
We can talk about greater liberty. The economy, until then focused on heavy industry
underwent change. Attempts to increase living standards underscored the importance of
light industry and the services sector.
Even though we can talk about the Thaw immediately after the death of Stalin, real
changes in Poland arrived in 1956. In June in Poznan, a peaceful workers’
demonstration in a few hours was transformed into violent clashes between the police
and civilians. The State used tanks against the protesters killing 50 people and
wounding over 200.
Finding themselves having to face the first serious crisis since the establishment of
Communism in Poland, the officials of the PZPR decided to make Władysław Gomułka
First Secretary of the Party. From 1951-52, Gomułka had been imprisoned for his “right
wing drift”, so he was the only person that enjoyed social support because of his open
criticism of Stalin and the Soviet line. Gomułka started “The Polish Way to Socialism”.
Poland was to be more independent from the Soviet Union.
With the Thaw, freedom of speech was greater and in the press the first voices
condemning Stalinism started to appear. The public was not interested only in politics
or the economy any more but, in order to build socialism with a human face, was trying
to inquire into private life, in the family relationships of citizens. Plenty of room was
given to the private sphere of life, and this was due to an attempt to go back to the pre-
Communist state when public and private domains were separated. It was an attempt to
improve the Communist system. Gender differences would be a key to reviewing and
remedying errors.
82
2.1. MARRIAGE
In 1951, on the front page of the October issue of Nowa Kultura magazine, an
alarming article about a huge crisis in marriages appeared. According to the magazine,
Poland ranked second behind Germany. A peculiar detail was that along with the
number of divorces the number of marriages was also growing.
In 1931, for every 100 people 8.5 had got married the previous year while in 1951 this
rate was 9.5. What is more, the average marrying age had decreased from 26.3 in 1931
to 25.4 in 1951. According to statistics, it was the young people who were more
inclined to divorce. In 1953, 24% of the couples that filed for divorce did it in their first
year of marriage.
Polish law and its interpretation could not explain such a high divorce rate.
Compulsory civil marriage was introduced in 1945 as one of the first changes to the
Civil Code. In 1950, Poland adopted the new Family Code that aimed at the stability of
the family and of the marriage. Feminist activists and official propaganda started to
underline that capitalism was the biggest enemy of the family whereas socialism not
only positively contributed to women’s emancipation but also strengthened the family.
The principle of equality was to guarantee that the marriage would not be based on
exchange but rather on feelings and friendship.
The Family Code from ’51 attributed equal rights to both genders within the marriage
and as far as their children were concerned. Theoretically, both spouses were to provide
for the family’s needs. A woman’s work in the home was considered as important as
remunerated work outside the home and particular attention was given to the separation
of property in the event of divorce.
Divorce was not a private matter between the two parties directly involved but a
State affair. That is why a marriage could not be dissolved only because the parties in
question wanted to dissolve it. It was only allowed if there were serious causes and in
presence of evidence indicating the marriage was in contrast to socialist ethics and
could not guarantee conditions compatible with living under the same roof and raising
children.
Letters sent to women’s magazines reveal some of the reasons for women’s
dissatisfaction with their marriage. The biggest problem was the lack of help from their
83
husbands regarding housework and looking after the children. The other cause was
domestic violence at the time known as “wife beating”.
Socialism promised to eradicate the exploitation of women, emancipation, and the
elimination of women’s subordination thanks to economic independence. Despite the
propaganda, the mentality of society remained patriarchal and women were subjugated
first by their father and then by their husband. The State promoted women’s jobs but
they almost never occupied managerial positions, and were not likely to be part of
intellectual or cultural élites. The real socialist hero was the man. A worker, an example
of masculinity, physically strong, a leader, a hero that was building socialism. In the
collective imagination the man worked to support his family, therefore he was the head
of the family and deserved respect and obedience from the other members of the family.
The new, independent woman could make a man feel insecure; he could have felt that
his traditional role of breadwinner was threatened. Still, little attention was given to men
outside the workplace, to their private life or their father-husband role so we have few
written sources that deal with men’s everyday life.
Women had a double role in the system: mother and employee even if at work they had
little opportunity to advance their career as this could have overturned the patriarchal
society.
In her role as mother and housewife, the woman took care of the children, her husband
and the home. In her role as wife, she also had to satisfy her husband’s sexual needs,
thus respecting men’s rights. We can say that in this family model, the man demanded
and the woman satisfied. Women were expected to keep their husband comfortable even
at the cost of her own suffering. Any failure on her part was interpreted as a challenge to
the head of the household. We can say that men were authorized to discipline their
wives to remind them where their place was in the household hierarchy. The key word
in domestic violence was “discipline”.
Everybody knew about the existence of domestic violence but there was a kind of code
of silence. Silence aimed at maintaining the husband’s honor and the family’s good
name. The widespread opinion was that “it’s better to wash your dirty laundry at home”,
i.e. it is better to deal with unpleasant situations at home. The fact that there are no
criminal statistics regarding this problem shows how little attention was paid to
84
domestic violence. Denunciations of domestic violence often were not taken seriously,
except cases of murder and severe mutilations and women often withdrew charges in
the first stages of the inquiry. There was another reason for the lack of statistics: high
crime rates would mean that the Socialist system had failed. That is why the statistics
were not kept or were falsified. In this case, the number of divorces may suggest to
some point the extent of the domestic violence problem. Usually, it was the women who
filed for divorce and the reasons they gave were alcoholism or cruelty that in reality
meant violence. Alcoholism was a widespread problem at that time. The men drank to
demonstrate their masculinity, to underline their cultural and national identity but also
to escape from everyday problems. Let us imagine a man who comes home drunk and is
welcomed by a furious wife who calls his authority into question. The man beats her to
affirm his position in front of her “provocation”. Here we must add that the provocation
could have been any reaction on the part of the woman. Very often, the victim was
blamed for anything at all and, what is more, it was acknowledged that a man under the
influence of alcohol was not responsible for his actions.
Since the Security Forces were dreaded and represented the oppressive State,
people avoided resorting to the authorities for help. Moreover, the legal system was
neither clear nor just. Judges depended on the Party (the so-called telephone justice)
especially in criminal cases.
Unlike other countries of the Socialist Bloc, Poland had laws against domestic violence
(Article 184 of the Penal Code), but although the Code recognized violence even as a
single act, it was obvious that to commence legal proceedings more than one incident
was needed. The police and prosecution were as indifferent to domestic violence as in
those countries where such regulations did not exist. Representatives of the Authorities
not only ignored the voices of women but they also learned to dissuade them. They
reminded them that if they denounced their husbands they would be seen as
disreputable, that the police could not protect them from their violent husband, nor from
his family if they decided not to withdraw charges.
The weakening of Church’s position can be interpreted as a defeat of the
opposition but for women somehow it proved to be a turning point. The Church was
85
against the liberalization of divorce and of the Family law in general. With less
influence of the Church, laws that were more secular could be adopted.
What the Penal Code could not obtain the Civil Code often could. Divorce was
sometimes the only way to get rid of a violent partner and usually it was women who
filed for divorce. The requirements to obtain a divorce varied depending on the period
but it was always easier to divorce in more liberal limes.
In any case, not all women who were victims of domestic violence wanted to divorce. In
many social groups divorce was stigmatizing. The opinion that a wise woman knows
how to deal with her husband and her marriage was still popular so often divorce was
perceived as the woman’s and not the man’s failure.
Another factor that must be taken into account is the real estate crisis and although
divorced couples were often forced to live together this did not put an end to the
violence.
2.2. MOTHERHOOD
In the early post-war period, Poland like other European countries experienced a huge
population growth. Difficult economic conditions and lack of a real family policy did
not dissuade the population from having children. In 1938, the population growth rate
accounted for 10.7 children for every thousand people. In 1950, it grew to 19 per
thousand and peaked at 19.5 children every thousand people in 1952.
Even though Stalinism did not promote the woman’s role as mother in a particular way,
motherhood was protected by the State. In the 1952 Constitution, there is a passage
about family and marriage under the protection of the People’s Poland. The State treated
large families with special care. The press did not extol the family either in that period;
it concentrated more on the care for mother and child, underlining the rights of single
mothers. The Family Code abolished the term bastard to describe illegitimate children
connecting this notion to Capitalism and inheritance mechanisms. From 1952 on, the
State acknowledged only one definition – child - and it pledged to take care of every
single child.
86
In the fifties in Poland, about 500,000 children were born every year, and if the
population were to grow at this rate, Poland’s population would have exceeded
50,000,000 by the year 2000.
When faced with a housing shortage, widespread poverty, lack of kindergartens,
schools and economic backwardness, after 1956 the Party abandoned the policy of
extolling large families and began to concentrate more on the stability of marriage and
family. The State committed itself to promoting family planning and sexual education
through initiatives of the Society of Conscious Motherhood (Towarzystwo Świadomego
Macierzyństwa), that afterwards changed its name into Society for the Development of
the Family (Towarzystwo Rozwoju Rodziny). Thanks to the Society’s efforts, in 1959 a
law was passed that obliged physicians to inform patients who had just given birth or
had had an abortion on birth control. The State refunded 70% of the cost of
contraceptive pills and the Society held a series of lessons about birth control methods
and sexual education in the ’70s and ’80s.
The majority of women did not use the pill. They preferred natural family planning –
the calendar method and periodic abstinence. This choice was also governed by the fact
that the pill was not always available; moreover, it was prescribed in small doses that
made frequent visits to their doctor necessary. Also high level of hormones in the early
pills often caused unpleasant side effects. We must not forget another factor: shame.
Women did not want to be seen as dissolute and were ashamed to buy pills even at an
anonymous pharmacist’s in the capital not to mention how it could be stigmatizing in a
small village where everybody know each other well.
The most common contraceptive method, if we can call it as such, was abortion.
Already in the ’30s, the Civil Code gave women the right to abort if the pregnancy was
a result of rape or incest. Opinions of three physicians and a gynecologist were needed
to obtain an abortion on medical grounds.
In the ’50s, abortion was a common practice even though the Church, still an important
voice in public debate, was against it.
In 1956, the Ministry of Health estimated the number of illegal abortions in Poland at a
minimum of 300,000 a year. Moreover, hospitals received about 80,000 patients a year
with complications due to pregnancy or abortions induced at home. As a private
87
abortion cost 1000-2000 zloty, the equivalent of an average month’s wages, it was
available only for wealthy women. Those who could not afford one resorted to healers.
In any case, abortion was considered a crime but it was extremely difficult to discover
and punish people who were performing them since there was a kind of code of silence
between patients and doctors.
The update of the Civil Code in 1956 was to change that situation and limit the
number of illegal abortions. To obtain a legal abortion up to the fourteenth week of
pregnancy not only the mother’s health or possible sexual violence but also a difficult
economic situation of the family were recognized as valid reasons. Even the mothers of
many children could ask for an abortion.
This modification of the law drove women en masse to ask for an abortion and resulted
in the complete paralysis of hospitals that were not prepared to receive so many patients
all at once. One disadvantage of the new law was the possibility of corruption.
Gynecologists had to assess not only the physical state of the patient but also had to
express themselves on her economic conditions before performing the operation. In the
case of doubt, they could play for time, pay the patient a visit at home to better
understand her situation etc. and sometimes this way the time allowed to interrupt the
pregnancy expired. Patients were not allowed to choose their gynecologist; they were
assigned one according to the district. This gave doctors a way to exploit their patients
and the practice of playing for time or refusing to perform the abortion in order to obtain
a bribe were common.
After making the procedure free and obtainable in every hospital, the number of legal
abortions reached 158,000 in the ’60s. Only in the ’80s did it drop to 137,000, a figure
that coincided with the more common use of modern contraceptives.
The mass entry of women on the job market also caused a decrease in the fertility rate
(the expected number of children born per woman in her childbearing years) of women.
In 1960 it accounted for 2.98, in 1989 it had dropped to 2.1.
As we will see in the next chapter, the decrease of the fertility rate was a valid argument
to systematically eliminate women from work under the pretext of concern for their
health.
88
2.3. HOME AND WORK
The Thaw brought with it severe criticism of Stalinism, of the dehumanization of
workers and the discrimination of women. Ironically, in this period, women were
encouraged and sometimes forced to leave work and go back home. The Party did not
openly “send” them back home but encouraged them to choose traditional women’s
jobs. This trend could be observed throughout the Eastern Bloc in the Thaw period.
Women’s return home without any doubt had a lot in common with the break with
Stalinism. On one hand destalinization brought positive changes, talk of gender
discrimination was heard for the time, but on the other it was a pretext to limit women’s
role in the public domain. For example, the press started to underline the ability of
housewives, and the activists were talking about their feminine qualities.
The official women’s organization - Liga Kobiet (the League of Women) -
responsible for defending women’s rights but also their correct political education in the
Socialist spirit - was established in 1945. The activists tended to underline that during
the Stalinist period women had far too many duties what with housekeeping and
remunerated work. The League tried to make their lives easier by diminishing their
paid-work duties rather than the domestic ones.
In 1956 for the first time, the Party used the argument of reproductive problems in
women to eliminate them from many occupations, above all from new occupations. The
State justified its decision by saying it could not tolerate the fact that women performed
many jobs that impaired their health, provoked miscarriages and put their life and their
children’s well-being at risk. For sure some women were happy to go back home but the
majority was against leaving their jobs all the more so if they were qualified and well
paid. The opposition of women working underground in mines was particularly strong.
At the same time, many unqualified jobs were considered “female”, so it was not
unusual to meet a woman in her eighth month of pregnancy carrying heavy objects or
working in difficult conditions.
The League of Women as an organization subordinated to the Party was the
official channel of communication with women. Therefore, when Stalinism encouraged
them to contribute and work in new occupations and wanted to liberate them from
89
household chores, the League promoted the collectivization of different services like
public laundry services, cafeterias etc. Nonetheless, those ideas never gained popularity
and the organization changed direction and committed itself to publicizing the role of
the housewife. In the prospective of the Thaw women were responsible for the well-
being and happiness of their family.
The League, apart from its ideological work, assisted women practically. Its social
activism focused on everyday life. The League organized courses that prepared young
women for household chores: how to keep a house clean, and familiarizing them with
technical novelties and the latest appliances etc. never calling into question the male and
female roles within the family. It contributed towards strengthening traditional concepts
where the woman looked after the home and the man was the breadwinner.
In theory, the League’s efforts aimed at making women’s life easier, at alleviating their
double burden. In practice, activists taught them how to prepare balanced meals, how to
sew, mend clothes, clean the house, to make it nicer, and how to care about their
appearance. This way they reached high standards, but often by adding tasks rather than
eliminating them. Not only did they not cancel the image of the housewife, but they
also created greater expectations of what a woman should do in the home.
During meetings organized by the League once a month women could learn not
only about recipes or diets, but also for example how to perform a breast self-exam.
Even though a Communist woman should not care about her looks, she should have
been strong and only slightly different from a man, and concentrated only on her work
only, the reality was of course different. Women, as always, tried to look nice and they
managed with what they had at their disposal to be pretty. Even in this, the League
helped them; they were taught how to put make-up on, which products were the best to
highlight beauty, how to curl their hair, and what the latest fashion was etc. Those
courses did not respond to workers’ needs but rather to the esthetical needs of every
woman.
However, at the center of the League’s interests were initiatives regarding food.
The organization claimed that families did not follow a healthy diet and that women had
to learn how to prepare balanced meals with the correct proportions of proteins,
carbohydrates and fats. Lessons, often followed by degustation, underlined the
90
importance of fruit and vegetables, and tried to reduce the quantity of meat on the menu.
The last point could be interpreted as a political move since the ’80s were dominated by
the shortage of various products of which meat was the most important one. By
promoting a reduced consumption of meat, the League probably wanted to assist the
Party by trying to remedy the lack of meat in a country where this product was
extremely important. Nevertheless, the League’s advice promoted a healthier lifestyle –
a bigger consumption of fruit and vegetables, the elimination of fat from diets etc.,
eating habits that are still promoted today.
In December 1981, Martial Law was introduced and buying anything became
impossible. Women were traditionally in charge of grocery shopping and organizing the
household schedule so they particularly resented the crisis. As mothers, they had to
make sure their families’ needs were satisfied. They had to spend hours in long queues
to buy whatever was available (often only mustard and vinegar) but they had to get by
somehow.
The League tried to help women by organizing meetings and speaking to them. The
League committees focused on how women could adapt to a new situation rather than
how the State could improve the situation. The League used to underline women’s
capacity to adapt themselves and they praised the art of getting by. They taught them
how to save energy, how to remake clothes, and how to prepare balanced meals with
what was available on the market. Due to a shortage of potatoes, they were introducing
pasta and grains into meals, and when no meat was available, they taught them how to
use alternative sources of proteins, milk, cheese, and eggs. They also instructed them on
how to cultivate a small vegetable garden on a balcony.
However, the League was also an organization that gave woman space to socialize. A
place that was neither home nor workplace where they could meet other women. They
did not only drink tea and eat biscuits; it was a chance to escape from everyday life.
Women sewed, repaired clothes, advised one another. Sometimes they would take it in
turn to accompany children to school or to kindergarten.
The League of Women did not sustain the feminists’ slogans, it did not advocate
the emancipation of women, and did not want to reverse social roles, but it took care of
91
women’s education, both in ideological and practical terms, and gave them precious
advice they could put into practice every day.
2.4. FREE TIME
It is hard to talk about free time in Socialism, as free time was almost inexistent.
Or rather, the State did everything possible to limit the time at citizens’ disposal. It tried
to organize people’s days so only a bare minimum of leisure time was left. Not leaving
space for thinking was safer for the system. The opinion that free time led to
demoralization while it could be used for the formation of a Socialist conscience was a
common opinion.
Therefore, citizens worked six days a week and after a regular shift, they had to stay
behind to attend ideological, training and, organizational meetings. Sunday was not a
free day either. To some extent to prevent people from going to church but also to
organize their free time there were the so-called social actions, which were activities
aimed at building Socialism. In could be planting trees, building new streets, cleaning
surroundings etc. Theoretically, participation was not obligatory but few people dared
not to come since their absence was considered an offence and they could be seen as an
enemy of Socialism and have problems at their workplace, be arrested or imprisoned.
Another obligatory appointment were the parades held on 1 May. People were
picked up from different workplaces and accompanied by coach to where the parade
was going to be along with their banners and fliers to display their love for their
country, for the Socialist state and above all for work. This holiday was in open
opposition to two festivities that fell on 3 May, Constitution Day and the feast day of
the Virgin Mary, Queen of Poland, one of the most important Catholic and democratic
Polish holidays.
However, society did not have the culture of free time and did not know what to
do with it. Until the instauration of Communism those who had a farm worked on their
farm so had free time only to rest. Capitalist workers worked from dawn to dusk and
had little time as well. That is why the men usually drank during the weekend and
92
holidays while the women continued to tend to the family. At Christmas or on
birthdays, people used to pay a visit to one another but nothing more.
Moreover, the Party wanted to avoid individual initiatives. Organized holidays
for the working masses were to be an achievement equal to eradicating analphabetism.
In 1952, this privilege was enshrined in the Constitution. Already in the ’40s, there was
a Workers’ Holiday Fund. The idea was to send people working in various sectors to
different regions of Poland and sometimes to friendly countries of the Soviet Bloc for
holidays. The workers used their free time for resting and regaining their forces but also
for indoctrination. For the majority of them holidays were an unknown habit. The
relaxing pastimes of the intelligentsia like sport, trips, and open-air activities were not
suitable for the workers who, above all, wanted to rest after months of tough physical
work. Sometimes holidaymakers would not leave their rooms for a day or two, sleeping
mostly and only afterwards would they start their holiday.
This type of organized holiday was a social experiment as well since all social classes,
that otherwise would not have an opportunity to meet mingled and during meals a miner
would sit next to a writer, a shop assistant next to a surgeon and so on.
Another invention of Socialism, that by the way has survived to this day, were
Allotment Gardens (Ogrodki Dzialkowe). They were small plots of land, of about
300m2 where citizens could grow vegetables, fruit and flowers. The gardens were often
located in the city, sometimes even near the center. The administration of the gardens
regulated precisely the percentage of different types of plants and constructions allowed.
From the beginning of spring, the owners of these little fields passed their free time in
the open air, taking care of plants. This activity produced material gains; even a small
harvest made a difference during a crisis, and even more important, everything took
place under vigilant eye of the administration.
1.4. ANNA WALENTYNOWICZ
Anna Lubczyk was born on 15 August 1929 in Równe, a small town of 40,000
inhabitants in today’s Ukraine. She was the second daughter of peasants, Aleksandra
93
and Jan Lubczyk. Her father died during the first weeks of the war, and her mother,
struck down with depression followed him a few weeks later. Anna was 10 when her
neighbors adopted her. Thanks to them, Anna survived the war even though her
adoptive parents treated her as a servant rather than a daughter. Anna worked from early
morning to late at night seven days a week. When Germany declared war on the URSS,
the family moved near Warsaw. Anna was still working at home and now also as a day
laborer in the fields of surrounding farms to keep her new family.
After a suicide attempt at 16, she decided to escape. To pay for her room and board she
worked in the fields, looked after children, and took laundry in. Eventually she arrived
at Danzig where she found a job as a baby-sitter in a family. In 1947, the Gładkowski
family, her employers, decided to move to another city and left her a small basement
apartment in Danzig.
At the beginning of 1950, she went to a work agency to find a stable job. She
was sent to the “Amada” margarine factory in Danzig. Her application was accepted and
Anna started to work in the factory. Like other workers, she was full of zeal and
gratitude towards the new, people’s homeland. She wanted to work better and more for
the glory of her country that was giving her opportunities that she could not have even
dreamt of before, and for making of her a complete citizen.
A sense of mission pushed her to look for another job. Lubczyk dreamt of
working in the Danzig shipyard that in that period badly needed to increase its
workforce. She was hired and was offered various jobs in the shipyard but she really
wanted to become a welder. In November 1950, she was accepted for a welding training
course. When she filled in the application she did not admit that she had completed only
four classes of primary school since at least seven classes were required to work in the
shipyard.
On 7 November 1950, Lubczyk passed the State exam and became a trainee
welder, and in February 1951, she became a fully qualified welder. Right from the start,
she attracted the attention of her superiors because of her diligence at work. When
writing about her, one of her superiors wrote that she welded well, was laborious, was
never absent and deserved a promotion.
94
At first, Anna Lubczyk felt lonely, she missed having contact with other people,
and she wanted to be active and useful for society, so when she heard about the ZMP
(Union of Polish Youth) she decided to enter the shipyard’s section of the organization.
She was unaware that the ZMP was going through a period of crisis. Its members were
boycotting meetings and ideological courses saying that it would not change anything in
the end. On the other hand, she wanted to do something concrete, show that she did not
work only for money but that she wanted to give something more. She became involved
in social actions like planting forests, cleaning the city and of course the 1st-May
parades. Hanka Lubczyk, as she was called, became an exemplary model of a working
woman, and local papers started to write about her.
Thanks to her model behavior, she was elected and entered the Polish representation for
the Festival of Young Fighters for Peace in Berlin in July 1951. Before leaving, the
participants were instructed on how to behave and what to say. In Berlin, many Polish
participants defected and sought political asylum. Her superiors’ reaction surprised
Anna. During an extraordinary meeting supervisors forbade the young people to
mention the whole event in Poland and until the end of their stay, the participants were
kept locked in their rooms.
The Berlin events convinced Anna to leave the organization after 8 months of
membership. As she said, she realized she was living in a police state where security
agents and the milicja (Communist police) controlled every area of social life. Her
perception of a great injustice was incompatible with being a member of the ZMP.
After the episode in the ZMP Anna Lubczyk focused completely on her work at
the shipyard. She was not afraid of monotonous work nor of her working hours -
waking up at 5 am, at the shipyard by 6 am. She was the perfect worker. After a year,
she was working 420 hours a month and receiving a wage of 3200 zloty. She was
working 270% of the production’s limit. Lubczyk was ranked first in the work
competition, an example to other workers. Her photos were displayed on the shipyard’s
notice board. However, the more she counted in the shipyard, the more she started to
understand that Stakhanovism was all about exploitation of which women were the first
victims, treated with disregard by their fellow male workers and by the management.
95
To combat this situation she became involved in the activity of the shipyard’s social
commission and she joined the League of Women to protect herself and other women
from injustice. Her charisma soon won her the position of chairperson of the shipyard’s
League of Women sector. At the time, she did not realize that the league, exactly as the
ZMP, had a precise role to play in Stalinist society. Instead of helping the women who
were forced to perform exhausting work, many speeches were given on how the
people’s state took care of working women and their children and encouraged them to
fulfill the Six-Year-Plan. Lubczyk believed in those phrases about helping the weak and
the League kept talking on the subject for years. The organization’s priority was helping
single mothers and widows: finding a kindergarten for their children, helping them to
find a job etc. since women and men were equal the women should not live in
backwardness like before. All typically alluring slogans of propaganda in the‘50s,
Lubczyk was soon to realize that it had little to do with reality.
She believed in helping people not only at work; when she discovered that a cleaning
lady from the shipyard was looking for a flat she decided to let her and her mother stay
for some time in her apartment. Soon conflicts started and Anna was forced to leave her
flat. She was homeless again. To make things worse she fell in love with a colleague.
They were planning to live together but when he found out she was pregnant he started
to avoid her. He drank too much and started to go out with other women.
Anna decided to raise the child alone; she did not want to live with an irresponsible
person. She was of the opinion that a person, who let you down once, would do it again.
It was a brave decision. At that time, single mothers had to have a lot of strength and
courage, and not only to provide for the child but also to endure social criticism.
Luckily, she received a lot of support from her friends. She found comfort in her faith
and the Church. She was a Christian but had never really practiced her faith. During her
pregnancy, she rediscovered God and never abandoned her religion.
Her biggest problem remained the lack of an apartment. She was that determined
that she wrote to Boleslaw Bierut, and asked for a flat for herself. Stalin’s representative
did not respond but his secretariat informed the regional offices about the problem and
in 1953, the shipyard council gave Anna a 37m2 flat in the center of Danzig.
96
She divided her life between the shipyard, her son and social activity. She often did
night shifts, and a neighbor helped her with her son. Being a perfect worker, she was
awarded the Silver Cross of Merit and became the godmother of a ship. She had a very
high position in the shipyard structure and among other workers. She was the one who
remarked about the unjust system of granting social subsidies, the one who reminded
her fellow workers to observe work safety regulations; she even criticized PZPR
management. She did not realize how dangerous that could be. Although it was the
period of fighting sabotage, laziness and low work discipline but only the Party could
indicate the responsible for that situation. In the autumn of 1953, for the first time she
met the security services (SB, secret police). They threatened her and then asked her to
join the PZPR to have the possibility of a career. She refused saying that she was a
Christian. Though in official Party magazines she was portrayed as a successful
proletarian sacrificing her life for socialism, who beat production records and who
performed on average 207% of the production limit, this was not enough when she
asked for a higher shipyard grade. The Shipyard’s PZPR refused her even a small
promotion.
Her situation improved a bit in 1956. It was reorganization time, the shipyard
started producing more ships and had to increase employment limits. In that situation,
every qualified worker was important. The SB stopped calling her for questioning and
left her to work. Her diligence was still much appreciated at the W-3 section where she
worked. In spring 1957, she received the Bronze Cross of Merit for five years flawless
work and then in 1961 for very good work, discipline and cordiality the Silver Cross of
Merit. In 1966, after calculating the savings that the W-3 section made thanks to her
attitude she was awarded the Gold Cross of Merit.
At last, Lubczyk decided to organize her personal life. She decided to get
married. She chose Kazimierz Walentynowicz, a colleague from the same shipyard
section. They had been part of the same group of friends for years before they started to
think about marriage. On 26 September 1964, Anna Lubczyk and Kazimierz
Walentynowicz became husband and wife. Anna’s son liked him a lot and Kazimierz
gave him his last name. He was the best father that a teenager could have wanted. They
were really happy all together but a year later Anna was diagnosed with
97
pneumoconiosis and while having a check-up a pre-cancerous state was detected in her
uterus. Physicians gave her a maximum of five years on the condition that she led a
calm life. Anna decided to undergo surgery and after was on sick leave for six months.
Her husband tried to convince her to retire but Anna did not want to hear about that
solution. She wanted to be among people and so she went back to the shipyard. She
asked to be transferred to a lighter job; a Social Medical Commission supported her
request and she became a crane operator. The change of position meant she was now
doing a lower paid job; in fact as a welder she been at the 8th
level while now as a crane
operator she was at the 6th
. It was so unfair that she did not sign her new contract. She
petitioned to the Ministry of Heavy Industry and not only about her case. She wrote in
the name of all the workers that had been sacrificing their health for years and when
because of their condition they were no longer able to perform hazardous work they
were moved to less important jobs and their salary was cut. Finally, she obtained a pay
rise. In that period, depending on how many hours she worked, she earned about 1900-
2400 zloty a month; the average wage in the shipbuilding industry.
She was always active where social issues were concerned matters and during
meetings still urged for workers’ rights to be respected. Once, in 1967, she almost lost
her job. The leader of the W-3 section’s Council took 3000 zloty from the Common
Fund and lost the entire sum on the lottery. Walentynowicz was the only person who
dared to talk about the incident aloud. She did not want a punishment but an
explanation. When no one would answer her, she wrote to the television after which a
representative of the authorities from Warsaw came and forbade her to talk or write
about the matter. In 1968, Commission leaders decided that she was disturbing people’s
work and tried to fire her. In her defense, the shipyard workers organized their first
mass protest. The protest worked and Walentynowicz instead of losing her job was only
transferred from W-3 section to W-2. This decision was justified by the need to
maintain a calm atmosphere among the women workers, and the impossibility to
improve interpersonal relations in the W-3 section since Walentynowicz was not afraid
to say what she wanted and would have continued to behave in the same way.
98
Ironically, she had more time to dedicate to social work with her new job. As a crane
operator she only really worked 4 hours a day. The rest she dedicated to people. She
fought for women’s rights, for equality and justice in the division of social money.
The end of 1970 was marked with tragic events on the Polish Coast. On 12
December, the government informed the population of an imminent price increase of
many items, food included. It was a blow for an already impoverished and tired society.
The price of meat was to increase by 17.6 %, flour by 16.6%, jams by 36.2%, and grain
by 20-30%. Coal and wood were also to increase by 10-25%.
On 14 December, Anna Walentynowicz was finishing her night shift. At the same time
at shipyard’s entrance, the W-3 team was gathering to protest against the price rise. In
no time at all the protest had spread to the entire shipyard. Anna remained there all day
long. At about 10 am, 10,000 people marched to the headquarters of the local PZPR.
They were not let in and they were told that there was no one inside. The protesters
returned to the shipyard to hold a peaceful protest. The next day the protests continued
and in many places workers clashed with security forces. On 15 December, the State
sent the police, and soldiers armed with machine guns and heavy equipment to suppress
the protests. People were dying in regular fights with the police but the security forces
opened fire on peaceful workers at the Danzig shipyards while they were trying to go
home. The army gave the protesters an ultimatum: if they did not leave the shipyard in
four hours, they would be facing an air raid. Only then did the workers surrender.
Clashes along the entire coast lasted until 19 December, but the largest number of
victims was reported in the nearby industrial city of Gdynia where 18 people were
killed. In all during that December on the Polish coast, 45 people were killed and 1165
wounded. To suppress the riots the State used about 27,000 soldiers, 550 tanks, 108
airplanes and helicopters, and 21,000 vehicles. To these numbers we must add more
than 9000 police offices, and it is estimated that, apart from the introduction of martial
law in 1981, it was the biggest military mobilization in postwar Polish history.
Following those events, more than 2300 people were arrested and a further 2630 were
closely monitored by the SB and the secret police opened files on them. Strikes and
protests continued through January and February 1971. Finally, in March the
government revoked the price rises.
99
In that period, Danzig’s SB was working on the case of Anna Walentynowicz as she
had been one of the organizers of the December protests and winter strikes.
In spring 1971, Kazimierz Walentynowicz was diagnosed with the same disease
that his wife had had a few years before. Unfortunately, in addition to pneumoconiosis,
the physicians also diagnosed him with lung cancer. The situation was so serious that
Anna asked for time off from work to take care of her ill husband. Kazimierz
Walentynowicz died in October 1971. Anna never took off her wedding ring.
Meanwhile, the situation in Poland was getting worse; food and other things were
becoming scarce in the shops and in 1976 another wave of strikes struck Poland.
Anna Walentynowicz realized that she could do nothing on her own. She heard on the
Free Europe Radio that a Workers’ Defense Committee had been created in Danzig;
then she heard about the Students’ Solidarity Committee and the Movement for the
Defense of Human and Workers’ Rights. It was a sign that something was changing,
that there was hope for a better Poland. This was the period in which a formerly naïve
Anna who thought that she could fight the procedures and bureaucracy became an
aware anticommunist activist.
The crisis continued and was more than evident. In the Danzig shipyard, drastic cuts in
energy supplies were introduced, and even on the first shift, workers could not perform
their jobs because many machines were not working. Even PZPR analysts knew that a
turning point was close. The average worker was convinced that he/she could do
nothing to change things in the country, nor even in his/her workplace, so it was no use
even trying. Different social phenomena were negatively assessed; people did not trust
the government that did not represent Polish society.
In 1978, the Free Trade Unions of the Coast (Woln Związki Zawodowe Wybrzeża-
WZZ) were created. Anna Walentynowicz decided to join the organization with 610
zloty that she collected from her colleagues. She went to a meeting where she met many
important opposition workers like Joanna and Andrzej Gwiazda, Alina Pienkowska and
Bogdan Borusewicz. They all knew about Anna’s activity and that she was a person of
great moral value and charisma. They knew that if Walentynowicz cooperated with
them in their work, it would be a victory. For Walentynowicz the most important thing
was that she finally had met people that felt as she felt, people who wanted to improve
100
workers’ lives for real and people who cared about the future of Poland. Initially, great
names such as Gwiazda, Borusewicz or Kaczynski made her feel ashamed of her lack of
education, as did the importance of the issues they dealt with. While reading WZZ
statements and articles Walentynowicz realized that this organization was what she had
been waiting for for years. In the statute of the WZZ it was written that radical
democratization was an absolute necessity and that the population must fight for the
right to rule democratically in its own country, that every social class must have the
right to create organizations that would truly represent citizens. The WZZ was created
to protect workers who were fired for protesting or striking, to deal with important
matters such as labor law, safety in the workplace, overtime, night shifts, wage/cost of
living ratio, and high production regulations etc.
WZZ activity was a real joy for Anna but above all, it was an educational
journey. She wanted to learn as much as she could, that is why during meetings she
rarely spoke. She did not feel authorized to express her opinion on political matters. In
the WZZ milieu she was considered one of the top activists. She learned fast, she was
very brave, enjoyed great authority at work but at the same time was uncommonly
modest, which is why in a short time she became one of the leaders. The organization
published a magazine, Robotnik Wybrzeża (The Coastal Worker) and Anna
Walentynowicz discovered she had a talent for writing. Despite her lack of formal
education, she had an inimitable style that enabled her to express her thoughts clearly
and articulately. It was a magazine, as the title suggested that dealt with workers’
problems and was addressed to simple people so all the authors who wrote for it used
simple and clear language that differed from the language used by mainstream media.
Between 1979 and 1980, the repression of WZZ members increased. They were all
repeatedly arrested, searched, and prevented from meeting. In a short time, prominent
members of the movement were fired, transferred to different workplaces or
downgraded.
A new, harsher strategy may have been introduced because the previous policy based on
isolating “antisocialist elements from the healthy working masses” had not produced the
desired for effect. In 1980, the government realized there was the possibility of an
101
outburst of public discontent and began preparing the secret services to deal with an
emergency.
1980 was also the year in which the shipyard’s stratagem against Walentynowicz
entered in its decisive phase. After publishing an article about how she was being
persecuted due to her membership in the WZZ, Anna Walentynowicz was transferred to
another factory for a year as punishment. The authorities wanted to extend her exile but
thanks to the help of WZZ friends, she won her case and came back to the shipyard. She
was arrested several times during her working hours and every time she was late, it was
counted as an absence from work by the shipyard’s management. In March, she was
threatened with losing her job if she did not stop handing out copies of “Robotnik
Wybrzeża” at work. That threat came true on 7 August 1980. Anna Walentynowicz was
fired for the serious violation of her work duties, just 5 months before she was due to
retire.
The WZZ did not even think about accepting this situation. Her transfer to another plant
had already been a serious matter, the dismissal of an expert worker was even worse.
They wanted to organize a strike to defend Walentynowicz’s rights. WZZ activists
printed and distributed more than 8000 flyers in al Danzig, Sopot and Gdynia, nearby
cities where they wanted to convince people to start a protest. They were convinced that
if the shipyard went on strike, other plants would follow. WZZ leaders did their best to
convince Lech Walesa to participate in the strike. He was another icon, after
Walentynowicz, of the resistance. Walesa was not particularly interested but he gave his
support and on 14 August 1980, the Danzig shipyard workers staged a strike. The next
day 50,000 workers from 54 plants followed suit.
The extent of the strikes surprised both Walentynowicz and the organization. The first
demands of the strikers was the return of Walentynowicz to the shipyard, a 1000-zloty
pay rise and bonuses because of the high cost of living. Only afterwards was the list
extended. The workers also wanted a guarantee of safety for all protesters, a promise to
build a monument to commemorate the victims of the December 1970 protests, higher
family subsidies and most importantly, the possibility to create legal trade unions.
On 15 August, the shipyard management agreed to reemploy Anna Walentynowicz;
they even agreed to give every worker a 1500-zloty pay rise. Then Lech Walesa decided
102
to end the strike. However, without the shipyard’s support, the strikes in smaller plants
would be lost; the WZZ activists knew that another occasion like this might never occur
again, and they wanted to fight for the right to set up legal trade unions. Walesa was
accused of egoism, because after hearing the management had decided to agree to a pay
rise he wanted to call the strike off. There is a lot of evidence that confirms the first
three days of the strike were controlled by the secret police in the hope that it would end
quickly and without any important decisions taken.
Anna Walentynowicz, Alina Pienkowska, Bogdan Borusewicz and other activists urged
that the strike be continued firstly for a question of solidarity with other establishments
and secondly to obtain the right to create legal trade unions. That night only about 1000
workers remained in the shipyard and the next day, thanks to the heroic speeches of
Walentynowicz and the efforts of all WZZ activists, the strike was saved. They had to
choose a leader. Walentynowicz seemed a logical choice but simple workers may not
have followed a woman. Therefore, they started to look for another charismatic leader.
It was decided that since Walesa had spoiled the strike, he should remedy his action and
become the leader. Although the WZZ did not trust him anymore, it had little choice if
it wanted to continue the strike. Walesa became the leader of the interfactory strike
committee.
Walentynowicz interpreted her activity on the Committee as a service for the people.
She was everywhere: she made sandwiches, collected money for the monument to the
victims of December 1970, and gave interviews for foreign newspapers. She became the
icon of August 1980.
The Party agreed to fulfill almost every social demand of the strikers: a 1500-zloty pay
rise, no work on Saturdays, increase meat rations per person, and extend paid maternity
leave up to three years. A part of the staff decided to accept the government’s offer and
stop striking. The situation was becoming dramatic. With a forceful speech,
Walentynowicz managed to transform a strike originally staged for everyday issues,
into a solidarity strike in support of other striking establishments. Solidarity become the
leitmotiv of the August 1980 protests. By 20 August 304 plants had downed tools, in a
week the number had grown to 692.
103
Finally, on 31 August, an agreement was signed and the government recognized the
right to organize free trade unions. The Signatories of the Danzig Agreement had taken
an unprecedented step for the Soviet Bloc, they had undermined the managerial role of
the PZPR in Poland. They could not however openly fight the system and formulate
their real goals: independence and democracy. They chose a compromise. Obtaining the
right to create free trade unions cost the first Secretary of the Party, Edward Gierek, his
career and put the system in real difficulty. Even a number of Communists maintained
that the success of the August 1980 strikes was not due to support from the
counterrevolutionary forces from the West but to the government’s arrogance and their
betrayal of workers’ values.
As Anna said, she was the straw that broke the camel’s back. The strike burst out not
only because she was fired, but also because of increasing production regulations, the
high cost of living and lack of democracy. The WZZ won but became divided. Lech
Walesa started to demonstrate his independence from the organization thanks to which
he had become popular. He lost the WZZ’s confidence and Walentynowicz’s circle
wanted him to give up the idea of becoming the leader of the new organization being
set up, Solidarnosc. They suspected that Walesa had collaborated with the secret police
in the ’70s but were not willing to say it aloud so as not to create further splits in the
organization and shipyard. Moreover, the public saw Walesa as a revolutionary leader.
Solidarnosc - not only a trade union but also a social movement that involved the whole
of Poland - was formally founded on 17 September.
Anna Walentynowicz became the treasurer and was responsible for interventions. It was
an onerous role since during the August strikes the protesters had collected more than 2
million zloty for the construction of the monument to the December 1970 victims.
However, her role was important above all because she was the icon of the August
strikes, an example for all Polish women and a symbol of Solidarnosc. She was
receiving people from all Poland, she was giving speeches, and she represented
Solidarnosc.
Her popularity made Lech Walesa fear for his leadership and he started to reduce
Anna’s visibility in the organization. Their conflict became open when Walesa
approved the idea of calling the monument the Monument of Reconciliation and not that
104
of the Victims of December 1970 and inscribing the names of the police officers that
had died then on it. This was too much for Walentynowicz. Walesa threatened to expel
her from Solidarnosc one day. In fact, in April 1981, the shipyard’s Solidarnsc
commission unanimously accused her of agitation against Walesa. Although her friends
from the WZZ and the W-2 section from the shipyard took her side, and although a
special commission found her not guilty of all the charges that Walesa had advanced,
her destiny in Solidarnosc was decided.
The sixteen months from August 1980 to December 1981, are often called the
carnival of Solidarnosc. The government, forced by the general strike to agree to fulfill
the protesters’ demands, was meanwhile preparing for the final step to put an end to the
liberty in Poland.
On 13 December 1981, martial law was introduced in Poland. The night before
many prominent activists were arrested and tanks were sent into the streets. Once again,
the Danzig shipyard staged a protest strike. Walentynowicz was there with the people
until 16 December when the army pacified the shipyard and arrested Anna. She was
taken to Goldap to a camp for political prisoners where she stayed until 24 July 1982.
After her return, the management tried once again to fire her although in the end she
was just banned from the shipyard but continued to be paid regularly. A month later, she
was arrested again and she remained in prison until March 1983. When she was
released, she learnt that she could not work in the shipyard anymore nor had she the
right to her pension after 30 years of work. The reason for this decision was that she did
not reached 55 years of age and she had to wait until 1984. In that period, she worked
for the Church and collected signatures for a petition demanding the liberation of
political prisoners.
When an opposition priest, Jerzy Popieluszko, disappeared and was found dead, killed
by the secret police, Walenytnowicz renounced all the awards and titles she had
received for work during her career in the hope that this would attract the world’s
attention to the systematic violating of human rights in Poland.
In the second half of the 1980s, the situation worsened and in February 1988 the
government increased prices once again; the nation responded with another wave of
strikes all over the country. It was a surprise both to the Communists and to the
105
opposition. When other strikes were staged, this time in Silesia in the mines, the
establishment said it was willing to dialogue with the opposition. First, the Minister of
Internal Affairs, Czeslaw Kiszczak, had secret talks with Lech Walesa after which the
opposition started regular talks with government representatives. In January 1989,
Solidarnosc formed a group of coordinators to organize official talks. Round Table
sessions took place from 6 February to 5 April 1989. Among other things, it was
decided to reinstate the office of president, and to hold new parliamentary elections
(with 65% of mandates for the PZPR and Solidarnosc and 35% for all other candidates).
The parliamentary elections took place on 4 June 1989. Although the Party attempted to
keep up the pretense that the candidates in the election were from different political
backgrounds, in reality the vast majority of candidates were members of the PZPR or
people closely tied to the Communists. However, the elections were a great success for
the opposition.
In that period, Anna Walentynowicz was in the United States on a lecture tour to speak
about the about Poland’s political situation. The new situation in Poland was not what
she had dreamt of. She respected people for not voting for the Communists but was a
severe critic of Solidarnosc élites as she knew that they had shared out the mandates
with the PZPR during the Round Table talks. Walentynowicz could not accept the new
president, Wojciech Jaruzelski, the same person that had introduced martial law in 1981
in Poland. For her it was a continuation of the People’s Poland behind a democratic
façade.
She supported opposition movements but never wanted to enter politics as she was
totally committed to social work.
In 2005, the Victims of Communism Memorial Foundation, an American organization
that commemorates victims of communist ideology gave her the Truman-Regan Medal
of Freedom for her extraordinary courage. In 2006, the Polish president, Lech
Kaczynski, decorated her with the White Eagle Medal, only awarded to the most
distinguished Poles.
Anna Walentynowicz died 10 April 2010 in an air crash while she was going to
Smolensk, Russia with the Polish president, Lech Kaczynski, ministers and many
106
prominent representatives of the Polish political scene to participate in the anniversary
of the Katyn massacre of Polish officers during World War 2 by the Soviets.
Her biography is like a portrait of workers who get up from their knees to rebel against
the Communist government. She always saw her life as service to the weak; she fought
for justice and for the truth. The attempt to cancel her from Polish history failed
because, as she once said, “even if the truth is hidden and despised it always comes to
light”.
107
SECTION FRANCAISE
INTRODUCTION
La première image qui nous vient à l’esprit quand on pense aux femmes à
l’époque du communisme, c’est la femme sur un tracteur, souriante et vêtue en
combinaison de travail. Dans cet essai, je voudrais montrer comment la position de
la femme dans la société socialiste a évolué en fonction des changements politiques
en Pologne après la guerre.
Sans aucun doute, la Seconde Guerre Mondiale a été la plus grande locomotive
des changements sociaux, incluant les aspects les plus personnels de la vie humaine
comme la famille, le mariage et les rôles sociaux.
Même si les combats réguliers ont duré seulement quelques semaines sur le territoire
polonais, les hommes étaient souvent absents : ils s’unissaient aux partisans ou
étaient déportés etc. Seules, les femme restaient présentes, devant apprendre à faire
face aux besoins de la famille. Elles ont donné un grand exemple de courage et
d’astuce en s’occupant de leurs familles. Quand les hommes sont revenus, elles ont
continué à travailler car un seul salaire n’était pas suffisant pour maintenir la
famille. En plus, après une période de responsabilité et d’indépendance, les femmes
ne voulaient plus être traitées comme des accessoires.
Bientôt, le nombre des travailleuses a attiré l’attention des hommes politiques,
des intellectuels et des gens ordinaires. Déjà Marx et Engels ont développé une
théorie d’une nouvelle femme mais de vrais changements étaient possibles dans les
circonstances spéciales que la guerre a fournies. Les conditions sans précédent
comme le nombre croissant des travailleuses et les efforts des communistes pour
mettre en œuvre l’égalité entre femmes et hommes, ont rendu possible la rupture
avec le concept de différence entre les femmes liées à la famille et les hommes
108
destinés au domaine public.
Pour comprendre la situation de la femme dans la Pologne de l’après-guerre il
faut se souvenir de l’expérience de la Seconde Guerre Mondiale et de la prise de
pouvoir par les communistes. Les évènements des années 40 ont été déterminants
pour la formation de la nouvelle société polonaise et pour la création d’un homme
soviétique.
Le communisme polonais s’est distingué totalement de ses autres formes. Tout
d’abord en Pologne, la prise de pouvoir n’a pas été spontanée comme en Albanie ou
en Yougoslavie. Le système a été imposé et sa légitimité a été limitée. Pour
consolider le pouvoir, les leaders ont essayé d’ajuster le système selon les conditions
locales.
Les Polonais ont toujours considéré leur pays comme la frontière du monde civilisé
et ont toujours vu le danger à l’est. Pendant la guerre, les soldats de l’Armée Rouge
n’ont pas été perçus comme des sauveurs. Pendant presque deux ans, les soldats
soviétiques ont opprimé les citoyens polonais en essayant d’éliminer l’intelligentsia
et d’introduire le communisme. L’URSS a commencé son action de soviétisation du
territoire polonais déjà pendant la guerre. Ils éliminaient systématiquement les élites
culturelles et politiques et même l’opposition. En même temps, ils développaient
l’appareil de répressions et le nouveau pouvoir communiste essayait de persuader
les gens de sa légitimité.
L’événement qui aura marqué le futur de la Pologne a été le référendum imposé par
les traités de paix. Ce fut la seule opportunité pour les communistes de légaliser leur
pouvoir au niveau international, tandis que l’opposition espérait que les pays
occidentaux garantissent les procédures démocratiques.
Pendant le referendum, les citoyens ont dû se prononcer sur les questions suivantes :
l’abolition du Sénat, la nationalisation de l’industrie et la vérification des nouvelles
frontières.
Le référendum a eu lieu le 30 juin 1946. Les résultats ont été falsifiés mais les pays
occidentaux n’ont pas réagi. C’était un message de Staline pour continuer son travail
en Pologne, et organiser les élections pour l’Assemblé Législative. Le 19 Janvier
1947, des milliers de personnes qui auraient pu voter « de manière incorrecte » ont
109
été arrêtées préventivement, des centaines d’autres ont été retirées des listes
électorales et les votes n’ont pas été comptés. Dans la déclaration officielle, il a été
annoncé que plus de 90% des citoyens ayant droit de vote ont participé aux
élections. 80% d’entre eux étaient favorables aux communistes et leurs alliés du
bloc démocratique. Encore une fois, le manque de réaction de l’ouest signifiait que
la Pologne dirigée par les communistes avait été reconnue comme un pays légal et
les décisions des conférences de la paix avaient été considérées accomplies.
D’une certaine façon, ce fut un tournant. Le peuple était terrorisé, et avait peur
d’exprimer ses vraies opinions. La nationalisation de la propriété privée a appauvri
la société. En outre, les déportations et les migrations de masse ont affaibli les liens
familiaux et sociaux de groupes entiers.
Le pays fut ravagé par la guerre mais Staline ordonna de ne pas participer au
plan économique de Marshall. Entre 1945 et 1948, un plan économique de trois ans
fut mis en œuvre pour construire l’économie planifiée. Le gouvernement, en plus
d’avoir éliminé la propriété privée, remplaça le marché libre par l’économie
planifiée.
La scène politique fut unifiée, c’est-à-dire qu’un seul parti- PZPR (Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza- le Parti Ouvrier Unifié Polonais) est resté. C’était
l’organisation qui aurait monopolisé la vie politique polonaise jusqu’à 1989.
Enfin, le nouveau système fut confirmé le 22 Juliet 1952. Le contenu de ce
document fut créé en collaboration avec Staline. La constitution ne garantissait pas
les droits de l’homme et la fonction de président fut remplacée par le Conseil d’État.
Dans ce travail, je voudrais décrire la situation des femmes dans un contexte
social complétement nouveau. Le communisme offrait des opportunités uniques aux
personnes traditionnellement défavorisées : les prolétaires, les paysans et aussi les
femmes. Les changements n’étaient pas le résultat d’une évolution sociale. Au
contraire, elles étaient imposées, incluses dans le programme révolutionnaire d’un
gouvernement révolutionnaire. Il suffit de penser aux femmes employées dans les
mines, aux enfants des paysans qui allaient à l’université ou aux ouvriers qui
devenaient des figures importantes dans le gouvernement. Si on considère le facteur
obligatoire de cette ingénierie sociale, il est clair que tout le monde n’était prêt à
110
accepter les changements contre la tradition et les normes sociales.
Cela a conduit les femmes à s’émanciper, à avoir une carrière, et à décider de
leur vie mais souvent elles furent discriminées au travail.
J’essaierai d’examiner ces paradoxes à l’aide de la biographie d’Anna
Walentynowicz, une soudeuse, stakhanoviste qui décida de lutter contre le système.
On peut dire que sans elle, le mouvement de Solidarnosc et la transformation en
1989 n’auraient pas existé.
1. TRAVAIL
1.1. MIGRATIONS.
Les migrations des régions rurales aux villes furent un phénomène important
déjà en XIXème siècle, en ce qui concerne l’industrialisation. Les déplacements
dans un milieu différent et les nouveaux rôles sociaux ont changé l’identité
humaine. Pendant l’époque staliniste, cette transition visait à la création d’une
nouvelle personne, pleinement dédiée à la cause socialiste, une personne qui aurait à
cœur la prospérité de la société plus que son bien-être personnel. Dans cette
nouvelle réalité, la femme avait plus de devoirs que l’homme parce que non
seulement elle devait construire le socialisme mais aussi mettre au monde et élever
de nouvelles générations de communistes.
Le Parti essaya d’introduire un plus grand nombre de femmes dans le marché du
travail. Les travailleuses matures, avec l’expérience acquise déjà entre les deux
guerres aussi bien que les jeunes filles migrantes de la campagne étaient bien vues.
Le gouvernement a été plus intéressé par la deuxième catégorie parce que les
personnes sans aucune expérience montraient plus de réceptivité à l’égard des
changements. Elles représentaient un matériel idéal pour forger des travailleuses
modèles.
Dans cette partie, je prendrai à titre d’exemple l’industrie textile de Zambrów,
dans le nord-est de la Pologne. D’un point de vue économique, la construction d’une
111
usine loin d’un fleuve, sans même la voie ferrée n’avait aucune raison d’être, mais
l’industrie textile dans cette région était un projet idéologique. L’usine de Zambrów
était un des points les plus brillants du Plan Économique de Six Ans et devait
apporter l’avancement, le bien-être et la conscience politique dans cette région
agricole et historiquement rétrograde.
Avant l’ouverture en juillet 1954, plus de 200 paysannes entre seize et vingt ans
furent recrutées et envoyées dans les centres textiles historiques de Łódź et Bielawa
pour leur formation. Comme pour les villes, ces filles devaient devenir des
citoyennes modernes. Le recrutement dans le travail fut la part la plus importante de
la politique staliniste de l’emploi. Contrairement au capitalisme, pour lequel le
travail était un bien à vendre et à acheter, dans le communisme, il se trouvait à la
base de la relation entre l’État et le citoyen. Ce n’était pas seulement l’outil de la
surveillance de la société mais il devait la transformer mentalement et
économiquement. Donc, le recrutement, la formation et l’emploi des jeunes femmes
à Zambrów, ont été non seulement un plan économique mais également un essai afin
de les transformer en nouvelles citoyennes socialistes.
Plusieurs jeunes ont émigré pour suivre les cours des écoles professionnelles
(Szkoły Przysposobienia Przemysłowego). D’habitude, ils étaient en formation entre
douze et dix-huit mois, ensuite ils avaient droit à une mutation de deux ans dans
une usine. Dans l’industrie textile, les femmes représentaient 60% des débutants et
travaillaient 200 heures par mois pour un salaire de 270 złoty (monnaie polonaise).
Les logements étaient gratuits mais les apprentis devaient se nourrir eux-mêmes, ce
qui coûtait environ 210 złoty par mois. Les candidates n’avaient plus rien pour les
autres dépenses. Après six mois, les candidates pouvaient être transférées et
accomplir le travail à la pièce pour un salaire pouvant atteindre 700 złoty. Même si
les apprentis étaient autorisés à visiter leurs familles une fois par mois, peu d’entre
eux pouvait se le permettre.
Une nouvelle identité était parfois donnée aux candidates. À leur arrivée, les recrues
recevaient une nouvelle tenue et du papier-emballage pour envoyer leurs effets
personnels à la maison.
Quelques migrants, n’ont pas agi selon leur volonté. Le Service pour la Pologne
112
ou SP (Służba Polsce) était une organisation subordonnée à ZMP (Związek
Młodzieży Polskiej- l’Union de la Jeunesse Polonaise, l’organisation officielle des
jeunes) qui recrutait les jeunes de seize à vingt ans pour les envoyer dans des écoles
professionnelles. Le recrutement du SP fut l’une des nombreuses stratégies mises en
place pour détruire la culture traditionnelle paysanne. L’exemple le plus connu de
cette politique est la collectivisation de l’agriculture dans les années 40, visant à
l’élimination des paysans comme classe sociale et à leur remplacement par des
opérateurs agraires d’État. Alors, les parents des régions rurales ne voulaient pas
donner leurs enfants à l’État. Une autre motivation qui rendait les parents méfiants
était leur souci quant à la vulnérabilité sexuelle de leurs filles. Les gens étaient
habitués à la conscription des jeunes hommes mais c’était une nouveauté d’inscrire
des femmes. En outre, la ville était vue comme un endroit immoral et les parents
souvent n’envoyaient pas leurs filles seules pour faire des commissions.
D’un autre côté, malgré l’opposition de la majorité il y avait des jeunes, surtout des
femmes impatientes de laisser leurs villages natals. Beaucoup de familles touchées
par la pauvreté extrême, ne pouvaient pas se permettre de les éduquer ou de les
nourrir. Pour de nombreuses femmes, le service pour le pays a été la seule façon de
quitter leur village et d’échapper à la pauvreté.
L’usine de Zambrów a donné un toit aux ouvrières dans une nouvelle Maison de
Jeunes Ouvriers (Dom Młodego Robotnika). Selon le Parti, les dortoirs étaient plus
qu’un simple logement, ils étaient une partie d’un projet qui servait à éduquer et
surveiller les prolétaires. L’architecture, la proximité du lieu de travail et les
chambres divisées devaient jouer un rôle très important dans la vie de la jeune
travailleuse. Les chambres étaient meublées avec des lits, un miroir et une armoire.
Les sanitaires et le service de laverie étaient partagés. Il n’y avait aucune intimité
dans les chambres et elles n’avaient pas besoin de maintenance. Une cantine
fournissait les repas et le personnel professionnel faisait le ménage. Cet arrangement
était complètement différent par rapport aux espaces familiaux traditionnels connus
par les nouvelles ouvrières. Chez elles, les mères leur enseignaient à cuisiner, à
s’occuper des enfants etc. alors que dans les hôtels, les femmes vivaient sans lien
familial ni tâches ménagères. La suspension des rôles traditionnels donna une
113
nouvelle identité aux femmes. Elles étaient surtout travailleuses et activistes.
Même si officiellement, les femmes étaient encouragées à poursuivre et à
compléter leur éducation au niveau élémentaire ou à continuer dans les écoles
techniques, les opportunités réelles étaient limitées. En 1955, plus de 200 fileuses de
l’usine de Zambrów n’avaient pas fini les sept classes de l’école élémentaire. Sur
leur lieu de travail, elles pouvaient suivre des cours mais peu y assistait. Souvent ce
dur travail les empêchait d’aller à l’école. Elles étaient si fatiguées, qu’elles ne
pensaient qu’à rentrer chez elles et dormir.
La culture prolétaire était en cours de formation, les jeunes ouvrières formaient
la première génération de travailleuses industrielles. Aucune initiative, comme les
grèves, n’existait pour empêcher cette exploitation. Elles étaient seules, loin de leurs
familles pour la première fois. La solitude mélangée à la peur de perdre leur travail
bloquait n’importe qu’elle action collective. Pour la majorité des fileuses, le travail
dans l’usine, même s’il était usant, était une opportunité d’avancement social et
éliminait efficacement l’opposition.
Le style de vie urbain a donné sans aucun doute plus d’opportunité afin de
découvrir les différentes façons d’être une femme. La motivation de nombre d’entre
elles d’abandonner leurs familles, était de ne pas répéter la vie de leurs mères qui
élevaient les enfants les uns après les autres, sacrifiant leurs vies à la famille et à la
ferme.
Dans la ville, avec des horaires réguliers, sans aucune tâche ménagère, ces femmes
ont découvert le temps libre. Elles mettaient beaucoup de soin dans leur apparence :
se maquillaient, allaient chez coiffeur, suivaient la mode. Elles sortaient sans
attendre l’invitation d’un homme. Elles allaient danser et pendant les soirées
rencontraient des hommes. L’émancipation de ces jeunes femmes inquiétait les
fonctionnaires du Parti. Il était très intéressant de voir combien la société était
anxieuse à l’égard de la sexualité féminine dans cette période. Elles étaient perçues
comme des créatures fragiles qui devaient être protégées des dangers de la vie et
d’eux-mêmes. L’industrialisation pour la première fois a permis la rencontre de
l’homme et de la femme. Après plusieurs siècles de vie dans deux domaines
séparés : la maison et le monde, les hommes et les femmes devaient partager les
114
mêmes espaces.
Dans le cas de Zambrów, les fonctionnaires pensaient que les dortoirs séparés
auraient résolu le problème de la promiscuité sexuelle. Ils surveillaient la sexualité
des femmes mais personne ne pensait à contrôler les hommes aussi. Dans les cas
d’une obstination particulière, quand des méthodes de l’éducation échouaient les
officiers du ZMP recouraient à l’aide des parents des fileuses. Il semble que leurs
méthodes de discipline étaient plus efficaces vu que c’était une technique courante.
La transition de la campagne à l’usine, n’était pas seulement un déplacement
géographique mais aussi politique, idéologique et économique. Les femmes de
Zambrów étaient indépendantes, engagées dans plusieurs activités non-domestiques.
Elles étaient différentes des femmes du même âge qui étaient restées à la campagne.
Elles soignaient leur apparence, suivaient la mode. L’État était satisfait des
changements sociaux s’ils ne devenaient pas trop radicaux. avec modération. Le
problème était que le nouveau prolétariat essayait de se définir en choisissant le
style de vie traditionnel et urbain, les éléments communistes et autres. Les femmes
travaillaient et participaient aux activités organisées par l’État tout en déclarant leur
foi Catholique et aidaient leurs parents à la ferme.
Le plus grand défi de l’Etat fut la suspension des rôles traditionnels. À défaut de ces
nouvelles règles, les femmes voulaient définir toutes seules leur place dans la
société . Les jeunes femmes, libres de la surveillance des familles, expérimentaient
la consommation et la sexualité. Poursuivant leur idée d’émancipation, elles ont
défié la vision socialiste d’une nouvelle société communiste.
1.2. NOUVELLES POSSIBILITÉS
Du point de vue économique, la première moitié des années 1950 fut dominée
par le Plan Économique de Six Ans. L’intensification de l’industrialisation était au
premier plan. Presque tous les investissements étaient concentrés dans l’industrie
lourde et sidérurgique. Selon le Plan, le niveau de l’industrialisation devait
augmenter de 85-95%. Ces investissements devaient contribuer à la construction du
115
socialisme en Pologne.
Le Plan de Six Ans a lancé une campagne visant à l’introduction des femmes
dans les professions typiquement masculines, appelées les nouvelles professions
(nowe zawody). Même si les femmes étaient déjà présentes sur le marché du travail,
cette campagne était une vraie opportunité, puisque l’objectif était d’inclure les
femmes dans des travaux qualifiés comme tourneurs, serruriers, maçons,
conducteurs, mineurs etc. Ce fut un tournant car les femmes travaillaient dans des
industries différentes mais elles faisaient principalement des tâches non-qualifiées et
mal payées, en plus elles n’avaient presque aucune possibilité de carrière.
Concernant le travail dans les mines, il ne fut recruté que mille femmes,
néanmoins leur cas représente à la perfection la politique staliniste des sexes avec
tous ses avantages et ses inconvénients. Les communistes n’étaient pas les premiers
à employer les femmes dans les travaux typiquement masculins. Ce phénomène
s’était présenté déjà pendant la seconde guerre mondiale quand les femmes étaient
entrées dans les emplois masculins pour contribuer à l’effort de la guerre. À la fin,
elles sont rentrées s’occuper de la maison. Par opposition, les communistes ont relié
les travaux masculins pour les femmes aux mêmes droits et émancipation que les
hommes.
Malgré l’encouragement pour les femmes à entrer dans les nouvelles
professions, le Parti essaya de contrôler toute l’action. En bref, les femmes étaient
autorisées à exercer des professions traditionnellement attribuées aux hommes mais
seulement celles autorisées par l’État.
Il est évident que certaines femmes ne souhaitaient pas travailler dans l’industrie, et
toutes n’étaient pas adaptées à ce genre de travail. Les femmes dans les nouvelles
professions devaient représenter l’avant-garde des travailleurs industriels. Les
femmes d’un caractère fort, des opinions politiques correctes. La santé, l’âge et la
constitution comptaient aussi. Les femmes considérées féminines devaient être
dirigées vers des travaux légers.
Au début de 1951, le Conseil des Ministres adopta un changement de la
législation du travail en diminuant le nombre des professions interdites aux femmes,
y compris le travail nocturne et le travail sous terre. Le Parti admit qu’en Pologne
116
Populaire, il n’y avait pas de division entre les hommes et les femmes et que seuls
les résultats devaient déterminer la carrière.
Les femmes étaient souvent sujettes à la discrimination sur le lieu de travail. Les
chefs d’équipe leur étaient hostiles et attribuaient aux femmes les travaux difficiles,
dans de rudes conditions. Il était donc presque impossible que les femmes arrivent
aux quotas de production requis, ce qui les privait de bonus. En même temps, les
travailleuses qualifiées étaient autorisées à jouer des rôles importants et arrivaient
rarement aux positions de direction.
Déjà en 1951, les mines de charbon en Silésie employaient 560 femmes dans 37
mines. Elles avaient entre 19 et 50 ans. Pour être admises à travailler dans une mine,
elles devaient subir une visite médicale. Elles gagnaient 550-650 złoty, ce qui
représente 150-300 złoty de plus que ce qu’elles auraient gagné dans n’importe quel
travail en surface. Paradoxalement, le travail sous terre était presque totalement
mécanisé, il était alors plus léger que les autres travaux. C’est pourquoi celles qui
travaillaient sous terre se considéraient heureuses.
Les femmes qui ont accepté de travailler dans les mines n’étaient pas seulement
attirées par la plus forte rémunération ou le travail plus léger. Un facteur très
important était l’héroïsme, la possibilité de faire quelque chose pour la patrie, pour
le socialisme.
Les activistes féminines remarquaient l’impact positif des femmes sur leurs
collègues et sur leur lieu de travail en général. Elles disaient que les femmes
contribuaient positivement à la réduction de l’utilisation des jurons parmi les
mineurs, elles étaient louées pour leur discipline et propreté au travail. De plus, elles
respectaient les règles de sécurité, ce qui provoqua la baisse des accidents.
Néanmoins, ces mêmes activistes soulignaient que la campagne des nouvelles
professions ne garantissait pas une pleine avancée sociale des femmes. Ces dernières
commencèrent à travailler sous terre et améliorèrent leurs conditions, mais
gagnaient toujours moins que leurs collègues hommes. De plus, elles recevaient
moins de subventions de l’État. Les chefs d’équipe n’étaient pas prêts de
promouvoir les femmes dans la hiérarchie de la mine, souvent ils refusaient de
déplacer les femmes qualifiées sous terre. S’ils avaient un homme et une femme
117
avec les mêmes qualifications, l’homme était choisi.
On peut dire que les groupes sociaux qui s’opposaient le plus contre les femmes
mineurs étaient les femmes des mineurs. En réalité, seul un petit pourcentage de
femmes travaillait dans les nouvelles professions, 60% d’entre elles étaient des
femmes au foyer. Il est important de rappeler que la Silésie était une région avec de
fortes traditions où l’homme était le soutien de la famille et la femme s’occupait de
la maison.
Parmi les nouveaux emplois, le mineur a été le symbole le plus fort de la
politique économique staliniste. Pour de nombreuses femmes, un travail masculin
était une opportunité d’améliorer leurs conditions de travail et leur salaire. Ces
femmes se vantaient de gagner le salaire d’un mineur et disaient qu’elles pouvaient
se permettre d’acheter non seulement des articles nécessaires mais aussi des cadeaux
comme les vêtements etc. Pour les autres femmes, l’inversion des rôles sociaux
produisirent l’anxiété du comportement sexuel des mineurs sous terre. L’anxiété qui
aurait conditionné la politique de la déstalinisation.
1.2. STAKHANOVISME
Grâce au Plan de Six Ans, plus de 1.230.000 femmes devaient entrer dans
l’industrie. L’idéologie staliniste a donné beaucoup de possibilités aux femmes mais
elles étaient toujours limitées : elles pouvaient être des mères, des travailleuses, des
femmes, des activistes. Le système les encourageait à choisir plusieurs identités à la
fois. Alors, les femmes entraient dans l’industrie. Mais le Parti appuyait une division
traditionnelle des rôles et dirigeait la majorité de femmes dans des professions
typiquement féminines. Ce type de politique a augmenté la féminisation dans les
secteurs considérés féminins comme l’industrie textile ou services. En même temps
l’État a transféré les hommes dans l’industrie lourde pout libérer les postes de travail
léger aux femmes.
Même si le secteur textile était considéré comme une industrie féminine, les femmes
représentaient plus de 60% des employées, la majorité exerçait un travail physique,
118
tandis que les hommes étaient les chefs d’équipe ou des mécaniciens. Le filage était
réputé une tâche compliquée mais, étant donné qu’il n’existait aucun cours de
formation, il était considéré comme un travail non qualifié et se trouvait en bas de la
hiérarchie. En plus, dans ce secteur les femmes gagnaient en moyenne 64% du
salaire d’un homme se trouvant au même poste.
Le slogan du Plan était de promouvoir les travailleurs voués aux positions
managériales. Ce défi était particulièrement difficile pour les femmes.
Prenons comme exemple l’usine di Żyrardów, à 50 km de Varsovie. Dans cet
établissement, plus de 64% des 6.430 employés étaient des femmes. En 1951,
seulement 225 femmes étaient en cours de formation ; bien peu parmi ces femmes
faisaient les travaux typiquement masculins. Seulement 15% d’entre elles étaient les
contrôleurs de qualité, 16% maîtres-filateurs ou occupaient d’autres postes
importants. Les femmes qui avaient reçu la formation n’étaient pas autorisées à
effectuer le travail qualifié, sinon pendant l’absence des hommes.
Les possibilités de carrière étaient limitées. Toujours à Żyrardów, seulement
29% des femmes étaient chefs d’équipe ce qui veut dire que sur 117 personnes, il
n’y avait que deux femmes. La politique staliniste de l’avancement social, qui
consistait à catapulter les ouvriers à des positions de direction a touché un petit
nombre de femmes. En 1951, les femmes représentaient seulement 4% des promus
dans les établissements industriels.
En tout cas, la meilleure manière d’exceller dans le travail non qualifié était le
stakhanovisme, c’est à dire la compétition dans le travail. Cela consistait à dépasser
les quotas de production imposés par le gouvernement. La compétition entre les
travailleurs s’est bientôt répandue et a impliqué différentes équipes, brigades et
usines. En 1951, 50% des participants étaient des femmes. A Żyrardów, 55% des
gagnants des compétitions étaient des femmes. Les bonus économiques n’étaient pas
les seuls motifs de battre les records de production. L’héroïne du travail était un titre
qui donnait la célébrité et augmentait le statut social. Les photos des héros du
travail étaient publiées dans les journaux. Dans chaque usine, il y avait des tableaux
d’affichage où à la fois, en plus et à part les annonces et les quotas de production, se
trouvaient les photos des héros du travail accompagnées de notes biographiques.
119
Les records de 200-250% par rapport aux quotas étaient un motif d’orgueil. Pour un
grand nombre de femmes, le travail dans l’industrie a représenté une aide pour fuir
la pauvreté extrême. Leur dévotion peut alors être justifiée car il s’agit d’une espèce
de dette émotive envers leur usine.
Le stakhanovisme dans les nouvelles professions a été une autre question. Déjà
le fait de travailler dans un secteur masculin donnait accès au titre de stakhanoviste.
La presse leur donnait beaucoup d’espace comme aux éléments dotés de conscience
politique et idéologique par rapport aux femmes employées ailleurs. Le seul fait
d’exercer un travail peu typique pour les femmes en faisait les héroïnes du
socialisme. La stakhanoviste la plus connue fut la femme mineur Anna Żak. La
mère seule de deux enfants, son mari étant mort pendant la guerre. Son parcours de
domestique à mineur était un exemple parfait des mêmes opportunités et de
l’émancipation que le socialisme donnait à chaque citoyen.
2. LA VIE PRIVEE.
La mort de Staline, le 5 mars 1953 a été un tournant dans l’histoire des pays de tout le
Bloc Soviétique. Parmi les changements qui ont eu lieu les années suivantes, le plus
important a été la liberté majeure dans tous les domaines de la vie, et surtout une
indépendance de l’Union Soviétique pour la Pologne. La révision de la politique, visant
à perfectionner ce socialisme, devait être soulignée par une rupture presque totale avec
les solutions stalinistes. A part l’industrie, les changements les plus grands ont concerné
la politique sociale et les femmes.
2.1. LE MARIAGE
Le code Familial de 1945 a introduit le mariage civil obligatoire pour tous. Ce
même code, en 1951 a donné les mêmes droits aux hommes et aux femmes dans le
mariage ainsi que la garde des enfants. En théorie tous les deux devaient pourvoir à
l’entretien de la famille. Le travail de la femme dans la maison était considéré de
120
même valeur que le travail rétribué du mari. Le principe de l’égalité de la femme et
de l’homme assurait que le mariage était fondé sur l’échange des biens matériels,
ainsi que sur l’amitié et l’amour. De toute façon, le taux des divorces avait augmenté
dans les années 1950 par rapport à la période d’avant-guerre. Par ailleurs, la courbe
de l’âge moyen du mariage avait baissé et les jeunes avaient plus de probabilité de
divorcer. Pourtant, le divorce n’était pas une question entre les parties intéressées
mais une affaire de l’État, seulement autorisé pour des raisons très importantes,
indiquant que le mariage était en contraste avec la Morale socialiste et ne remplissait
pas les conditions de cohabitation et d’éducation des enfants.
Les femmes pouvaient être insatisfaites dans le mariage parce que les maris ne
participaient pas aux travaux ménagers et à l’éducation des enfants mais le motif le
plus important des divorces était la violence domestique appelé alors « frapper la
femme ».
Il y avait différentes causes de violence. L’État socialiste voulait changer la société
grâce aux lois et à la politique mais la mentalité était restée patriarcale, la femme
était soumise d’abord au père et ensuite au mari. Malgré la propagande, les
nouvelles professions et les opportunités pour les femmes, le véritable héros du
socialisme restait l’homme. Il pourvoyait aux nécessités de la famille et méritait
alors le respect de sa femme. Une femme indépendante pouvait causer l’insécurité
chez l’homme. Pour les femmes, le système communiste gardait un double rôle :
celui de la mère et celui de la travailleuse. Comme la femme au foyer, elle devait
satisfaire les besoins de la famille, notamment ceux du mari. Si elle échouait dans
quelques mesures, le mari avait le droit de la discipliner pour lui rappeler sa place
dans la hiérarchie. Le mot clé dans le cas de la violence domestique était la
discipline.
En général, tout le monde connaissait la pratique de la violence envers les
femmes mais il y avait une espèce d’omerta en vigueur. Le silence visait au
maintien de l’honneur du mari et au respect du nom de la famille.
Même si en Pologne il existait des lois contre la violence, le manque de statistiques
à l’égard de ce problème a fait comprendre combien cette question restait sans
attention. L’Article 184 du Code Pénal reconnaissait la violence comme un seul
121
acte, toutefois il était évident que pour saisir la justice, il fallait des incidents
continus. Souvent les dénonciations n’étaient pas prises au sérieux, mises à part les
cas d’homicide ou de blessures graves. De plus, les femmes retiraient fréquemment
la plainte dans les premières étapes de l’enquête. En outre, le système légal n’était ni
juste ni transparent. Les représentants de la justice avaient appris à décourager les
femmes. Ils leur rappelaient qu’ils ne pouvaient pas les protéger de leurs maris
violents si les femmes voulaient insister.
La plupart du temps, le divorce était la seule façon de se libérer d’un
compagnon violent et les femmes étaient en majorité à le demander. Quoiqu’il en
soit, toutes les femmes ne choisissaient pas le divorce en cas de violence. Au sein de
nombreux groupes sociaux, le divorce était stigmatisant. L’opinion était qu’une
femme sage savait gérer son mariage. Le divorce, était alors considéré comme
l’échec de la femme, pas de l’homme. De plus, face à la crise immobilière, le couple
devait souvent vivre sous le même toit après le divorce, ce qui ne mettait pas fin à la
violence mais pouvait engendrer plus de problèmes.
2.2. LA MATERNITÉ
Le stalinisme ne promouvait pas particulièrement le rôle de la mère, la maternité
était protégée par la constitution de la Pologne Populaire et l’État traitait les familles
nombreuses avec un égard particulier. Les mères célibataires étaient protégées par la
législation, le terme de bâtard pour indiquer les enfants illégitimes avait été aboli,
associant ce mot au capitalisme et aux mécanismes de l’hérédité. La constitution
reconnaissait une seule définition : l’enfant, et l’État promettait de soigner et de
défendre tous les enfants.
Dans les années 1950, on comptait environ 500.000 naissances par an. Si la
population devait augmenter à ce rythme, en l’an 2000, ce chiffre aurait dépassé les
50.000.000 habitants. Face à la pauvreté de la population, le recul économique et le
manque de logements, l’État a abandonné la glorification des familles nombreuses,
se concentrant sur la stabilité de la famille et du mariage et a décidé de détruire les
idées de la maternité consciente. La Towarystwo Świadomego Macierzyństwa (la
122
Société de la Maternité Consciente) a vu le jour en 1956. Elle a organisé de
nombreux cours concernant les méthodes contraceptives et l’éducation sexuelle dans
les années 1960 et 1970. Grâce aux efforts de la Société, l’État remboursait 70% du
coût des contraceptifs. L’obligation était pour les médecins d’informer les femmes
qui venaient d’accoucher ou qui avaient subi un avortement, sur les possibilités et
les méthodes de contraception ; cela a conduit à une autre réussite de la Société.
Néanmoins, la majorité des femmes préféraient les méthodes naturelles, par crainte
des effets collatéraux de la contraception hormonale, un accès limité et la honte de
l’acheter. En réalité la méthode, si on peut l’appeler une méthode, la plus populaire
était l’avortement. Déjà dans les années 1930, il était légal si la grossesse était le
résultat d’une violence sexuelle ou d’inceste. Il était donc presque impossible de le
subir légalement.
En 1956, le Ministère de la Santé a estimé le nombre des avortements illégaux à un
taux de 300.000 minimum, en plus chaque année environ 80.000 femmes étaient
admises à l’hôpital avec des complications suite à la grossesse ou à des avortements
provoqués à la maison. Un avortement illégal coûtait environ 1000-2000 złoty, avec
le salaire moyen de 1000 złoty peu de femmes pouvaient se le permettre. Et quand
bien même, c’était un crime, il était presque impossible de punir les médecins qui
les exécutaient, vu l’omerta entre les patientes et les médecins.
L’actualisation de la loi de 1956 devait changer la situation et limiter le nombre des
avortements illégaux. La nouvelle règle prévoyait un avortement légal avant la
14ème semaine de grossesse pour des raisons de santé et également dans le cas de
situation économique grave de la famille ou dans le cas des familles nombreuses.
La nouvelle loi a poussé les femmes en masse vers les hôpitaux à demander
l’avortement, les structures sanitaires n’étaient pas préparées à recevoir un si grand
nombre de patientes et a paralysé totalement les hôpitaux.
En plus, la loi a ouvert la voie à la corruption. Les médecins devaient s’exprimer à
propos de la santé et de la situation économique des patientes, par conséquent ils
pouvaient refuser le service dans un hôpital public pour recevoir un « pot-de-vin » ,
ou exécuter l’avortement dans un cabinet privé.
En pratiquant l’avortement gratuit et accessible dans les hôpitaux publics, le nombre
123
des avortements légaux a augmenté et est arrivé à 150.000 par an dans les années
1960. Ce n’est que dans les années 1980 que ce taux a diminué grâce à la diffusion
de la contraception moderne. . D’autre part, le taux de fertilité a aussi baissé parce
que les femmes sont entrées en masse dans le monde du travail et ont fait moins
d’enfants. La diminution de la croissance naturelle a été un argument pour éliminer
les femmes de leurs occupations professionnelles justifiant une nouvelle politique
avec la préoccupation pour la santé féminine.
2.3. LA MAISON ET LE TRAVAIL
La fin du stalinisme a apporté une vague de critique de la déshumanisation de
l’ouvrier et de la discrimination des femmes. Paradoxalement pendant cette période,
les femmes étaient encouragées et à la fois forcées à abandonner leur lieu de travail
et à rentrer à la maison. Le parti n’a pas « renvoyé » les femmes chez elles
ouvertement, mais les a dirigées vers les professions considérées féminines.
L’organisation officielle des femmes chargée non seulement de la défense de leurs
droits, mais aussi de leur éducation politique dans l’esprit socialiste avait déjà été
formée en 1945. Liga Kobiet (la Ligue des Femmes) essayait d’aider les femmes
dans la vie quotidienne en demandant la diminution des devoirs professionnels afin
d’exécuter les tâches ménagères.
En 1956, le Parti a utilisé pour la première fois l’argument des problèmes
reproductifs chez les femmes pour les éliminer des nombreux métiers.
La Ligue était une organisation liée au Parti, qui suivait la propagande officielle
de l’État, c’est pourquoi dans cette période-là, la Ligue s’était engagée à promouvoir
le rôle de la femme au foyer.
Mais la Ligue se concentrait surtout sur l’activisme social et l’assistance quotidienne
aux femmes. L’organisation préparait des cours pour les femmes au foyer, présentait
des nouveautés techniques sans jamais douter sur les rôles masculins et féminins.
Même si le grand objectif de la Ligue était de libérer les femmes du double fardeau
de la maison et du travail, en pratique, on enseignait comment ranger la maison,
cuisiner, raccommoder les vêtements, comment soigner son apparence etc.,
124
l’organisation a marqué de nouveaux standards et a créé de nouveaux espoirs pour
les femmes.
Pendant les rencontres, les femmes pouvaient apprendre non seulement des
nouveautés sur la cuisine mais aussi sur la santé, par exemple comment effectuer
l’examen du sein chez elles.
Quoiqu’il en soit la nourriture se trouvait au centre de l’attention de la Ligue.
Elle affirmait que les familles ne suivaient pas un régime équilibré et que les
femmes devaient apprendre comment composer des repas sains avec une juste
quantité de vitamines, de protéines et de graisses. Les leçons, suivies de
dégustations soulignaient l’importance des fruits et des légumes et essayaient
d’éliminer l’excès de viande dans l’alimentation. Cela pouvait être une manœuvre
politique, vu la pénurie des produits alimentaires, et en premier lieu de la viande. La
ligue probablement voulait venir en aide à l’État en essayant de remédier au manque
de viande dans un pays où ce produit était extrêmement important.
Dans les années 1980, avec l’introduction de la loi martiale et des bons alimentaires,
il est devenu presque impossible d’acheter quelque chose. Traditionnellement, aller
faire les courses était une tâche féminine, c’est ainsi que les femmes ont fortement
ressenti la crise. Les mères devaient être sûres de satisfaire les besoins de la famille.
La Ligue essayait de les assister. Elle soulignait la capacité des femmes à se
débrouiller, leur enseignait comment coudre de nouveaux vêtements à partir
d’anciens, comment économiser l’énergie, comment préparer des repas équilibrés
avec les produits existant sur le marché etc.
En bref, la Ligue des Femmes ne faisait pas la promotion de slogans féministes,
ne diffusait pas l’émancipation des femmes, ne voulait pas alterner les rôles sociaux
mais s’était engagée dans la formation idéologique, en plus de fournir des conseils
pratiques précieux dans la vie de tous les jours.
2.4. LE TEMPS LIBRE
Le socialisme n’était pas seulement un ordre politique mais il était aussi social.
L’État voulait organiser toute la vie des citoyens pour leur éviter de réfléchir. Parmi
125
toutes les activités, il n’y avait plus de temps libre. Le pouvoir regardait le temps
libre avec méfiance, de crainte que trop de temps à disposition des citoyens ne
conduise à la démoralisation tandis qu’il pouvait être utilisé pour la formation de la
conscience sociale.
Les citoyens travaillaient donc six jours sur sept et après le travail devaient souvent
y rester pour assister aux rencontres idéologiques, formatives, organisationnelles etc.
Le dimanche, ils se rencontraient aux soi-disant actes sociaux pour la construction
du socialisme, par exemple pour ranger des espaces publics, aider à la construction
des nouvelles routes, planter des arbres etc. En théorie la participation n’était pas
obligatoire mais personne ne se risquait à être absent, afin de ne pas être considéré
comme un ennemi de la patrie et subir des problèmes sur le lieu de travail, la
surveillance de la part des services de sécurité et l’arrestation.
Les parades du 1ère
mai, suivies de danses étaient les rares occasions de s’amuser.
Elles étaient toujours obligatoires comme les actes sociaux et en plus, en opposition
ouverte avec la fête du 3 mai, jour de la constitution et en même temps de la Vierge
Marie, la reine de la Pologne. Pour les premières, les institutions, les usines et les
différents lieux de travail organisaient le transport, les affiches et des attractions
pour attirer les personnes. Pour la seconde, l’absence du travail pendant ce jour de
fête comptait comme une absence non justifiée.
De toute manière, la société n’avait pas la culture du temps libre et ne savait pas
toujours l’utiliser. C’est pourquoi, les hommes se consacraient d’habitude, le
dimanche, à l’alcool et les femmes après la messe continuaient les tâches
ménagères.
Plusieurs d’entre elles considéraient les rencontres de la Ligue des Femmes comme
leur temps libre. Un moment pour elles sans enfants ni devoirs, un moment pour se
détendre, parler avec d’autres femmes, boire un thé etc.
En général, le Parti voulait éviter les initiatives individuelles. Les vacances
organisées pour les masses ouvrières devaient être une des réussites les plus grandes
du socialisme après l’éradication de l’analphabétisme. En 1952, ce privilège a été
inclus dans la constitution. Déjà dans les années 1940, la Caisse des Vacances des
Travailleurs avait été créé. C’était une organisation subordonnée qui organisait les
126
vacances pour les employés des différents secteurs. La détente servit non seulement
au repos et aussi à l’endoctrinement. Pour la majorité des ouvriers les vacances
étaient une habitude inconnue. S’ils avaient du temps libre ils le sacrifiaient pour les
travaux à la maison, à la ferme ou les rencontres avec des amis. Les modèles de
détente de l’intelligentsia : le sport, les excursions etc. n’étaient pas aimés par les
ouvriers, qui au début voulaient se reposer après des mois de travail physique.
Parfois les vacanciers ne sortaient pas de leurs chambres pendant deux ou trois
jours, dormaient tout le temps et c’est après seulement que leurs vacances
commençaient.
Une autre invention du socialisme, existant encore à ce jour, sont les petites parcelles
appelées Ogrodki Dzialkowe (Les Jardins partagés). Chaque citoyen pouvait demander
et recevoir un petit terrain, d’environ 300 m2 où il pouvait cultiver des fruits, des
légumes et des fleurs. L’administration des Jardins régulait avec précision le
pourcentage des différentes cultures et des types de constructions admises. Dès les
premiers beaux jours, alors le propriétaire des parcelles passait son temps libre en plein
air, soignant ses plantations. Cette forme d’activité donnait aussi des gains matériels,
des récoltes considérées importantes en cette période de crise.
ANNA WALENTYNOWICZ
Anna Walentynowicz-Lubczyk est née le 15 août 1929 à Równe, une petite ville
dans l’actuelle Ukraine. Elle était la deuxième fille des paysans Aleksandra et Jan
Lubczyk. Son père est mort pendant les premières semaines de la guerre, sa mère,
totalement perdue après la perte de son mari, est décédée quelques semaines plus tard.
Les voisins ont adopté la petite Anna. Grâce à eux, Anna a survécu à la guerre même si
ses parents adoptifs cherchaient plus une domestique qu’une fille. Dans ses mémoires,
Anna parle d’un travail de l’aube au crépuscule, sept jours par semaine.
Pendant la guerre, la famille déménagea à proximité de Varsovie où Anna continua son
travail « d’esclave ». A seize ans, après une tentative de suicide, elle décida de
s’échapper. Elle fut nourrie et logée en échange de petits travaux pour des personnes
127
inconnues. Finalement elle arriva à Danzig où elle trouva un poste fixe comme baby-
sitter chez la famille Gładkowscy. En 1947, ses employeurs déménagèrent et lui laissent
un petit appartement au sous-sol.
Au début de 1950, elle alla dans une agence pour l’emploi afin de trouver un
travail. L’agence l’envoya à l’usine de fabrication de la margarine. Mais Anna Lubczyk
avait une mission, elle voulait être utile. Son objectif était de construire le communisme
et elle voulait travailler au chantier naval de Danzig. Elle présenta sa candidature et
commença un cours de formation pour soudeurs. En remplissant le formulaire
d’admission, elle mentit en affirmant avoir fait les 7 classes de l’école élémentaire alors
qu’elle en avait suivi seulement quatre. Le 7 novembre 1950, Anna Lubczyk réussit
l’examen final et commença l’apprentissage pour devenir, en 1951 une soudeuse
qualifiée. Dès le début, elle reçut des opinions positives de ses supérieurs pour sa
diligence et son application.
Bientôt, elle devint une stakhanoviste avec 420 heures mensuelles de travail.
Elle faisait 270% de la norme qui lui donnait la première place dans la compétition de
travail. Anna Lubczyk était un exemple pour les ouvriers et ses photos apparaissaient
non seulement dans le tableau d’affiches du chantier mais aussi dans les journaux.
Mais plus elle travaillait sur le chantier, plus elle commençait à comprendre que le
stakhanovisme représentait l’exploitation des femmes qui en étaient les premières
victimes, traitées avec mépris par la direction et par les hommes.
En 1950, elle connut un homme, un collègue de travail, avec qui elle imaginait
l’avenir mais quand il sut que Anna était enceinte, il échappa. Anna Lubczyk décida
d’élever l’enfant toute seule. Il faut se rappeler que la décision ne pouvait pas être facile
dans la Pologne des années 1950. La célibataire avec un enfant devait avoir du courage
pour affronter la vie et la société.
Dans cette période, le travail était une fuite pour Anna, elle se réveillait à 5 heures du
matin, portait son fils à la crèche, soudait, soudait… restait pour une réunion du
collectif, récupérait son fils à la crèche, faisait les courses et retournait encore au
chantier.
En 1953, on lui décerna la Croix d’Argent du Mérite pour son attitude au travail, elle
devint aussi la marraine d’un bateau. Bref, elle avait acquis une haute position aux yeux
128
de l’équipe. Elle faisait attention aux injustices quant à la division de l’argent de la
Caisse Sociale, rappelait aux ouvriers de maintenir l’hygiène et la sécurité sur le poste
de travail. Elle se mit à critiquer la direction et les secrétaires du PZPR du chantier, ne
se rendant pas compte que ce comportement pouvait être dangereux. En effet, c’était
une période de lutte contre le « sabotage », le manque de discipline et la chute de la
productivité ; mais, seul, le Parti pouvait critiquer et désigner les coupables.
En 1953, elle rencontra pour la première fois la police secrète, c’est-à-dire la
Służba Bezpieczeństwa ou SB. Toute la société était infiltrée par la SB, leurs cellules se
trouvaient dans chaque entreprise, chaque usine. Les fonctionnaires voulaient lui faire
peur, et essayaient de la convaincre d’entrer dans le Parti. Anna Lubczyk refusa cette
fois-là et les fois suivantes. Pendant ce temps, ses photos continuaient à être publiées,
elle fut toujours un exemple pour tout le chantier. Dans les années 1950 et 1960, elle
reçut d’autres Croix du Mérite pour son travail.
En 1964, elle décida d’épouser un collègue du chantier Kazimierz
Walentynowicz après dix ans d’amitié. Mais le bonheur ne dura pas longtemps. Les
médecins découvrirent un état précancéreux et lui donnèrent cinq ans de vie. Elle subit
une intervention chirurgicale et après six mois de congé maladie, elle reprit le travail
mais demanda un déplacement à un poste plus léger. Anna Walentynowicz devint un
grutier.
En décembre 1970, le gouvernement augmenta considérablement les prix des
produits alimentaires. Cette décision fut un coup très dur pour la société déjà misérable.
Lundi matin, le 14 janvier, l’équipe de la nuit décida de protester contre les
augmentations. En peu de temps la protestation se propagea sur tout le chantier: 10.000
de ouvriers allèrent au siège du Comité Régional du PZPR à Danzig. La manifestation
pacifique se transforma en un affrontement avec la police et l’armée : 7 personnes
moururent, des centaines furent blessées, et plus de 2300 arrêtées.
Après les évènements sanglants de décembre 1970, A. Walentynowicz perdit la
foi dans le communisme en Pologne. Elle commença sa recherche de la justice.
L’héroïne du travail, l’employée modèle était devenue une dissidente. En 1978, elle
rejoignit le milieu de l’opposition de Joanna et Andrzej Gwiazda, Bogdan Borusewicz,
129
Lech Wałęsa, Alina Pienkowska et Andrzej Kołodziej. Tous ensembles, ils créèrent les
Syndicats libres de la Côte (Wolne Związki Zawodowe-WZZ).
Anna Walentynowicz était une simple ouvrière, elle n’avait terminé que quatre
classes d’école élémentaire et ne se considérait pas comme la personne appropriée pour
discuter de politique mais elle était toujours à côté des autres, prête à aider. Au sein des
Syndicats, elle était responsable de la distribution de la gazette clandestine Robotnik
Wybrzeża (L’ouvrier de la Côte) sur le chantier. Elle défiait ouvertement les supérieurs
par son comportement.
Pour sa participation à un syndicat illégal, elle fut licenciée seulement cinq mois
avant la retraite, le 7 août 1980. Cette décision de la direction fit réagir ses collègues des
syndicats qui mobilisèrent le Chantier de Danzig ainsi que les autres usines et
entreprises de la région. Déjà le deuxième jour de la grève, plus de 50.000 ouvriers ne
travaillaient plus dans 54 usines.
Les premiers postulats des ouvriers concernaient la retour d’Anna Walentynowicz au
travail et l’augmentation des salaires de 1000 złoty. Bientôt la liste des postulats
s’allongea avec la demande de construire un monument pour commémorer les victimes
de décembre 1970, légaliser les syndicats indépendants, augmenter les subventions des
familles, à tous les niveaux de la société, à savoir les familles, les policiers mais aussi la
libération des prisonniers politiques et la sécurité pour les participants de la grève.
Le troisième jour de la grève, la direction garantit les augmentations de salaires.
LechWalesa voulait stopper la grève à ce moment-là. Mais Anna Walentynowicz et
Alina Pienkowska réussirent à fermer le portail du chantier et à garder à l’intérieur
quelques ouvriers. Elles voulaient continuer la Grève en acte de solidarité avec d’autres
usines de la Côte qui, sans l’appui du Chantier, risquaient les répressions. La grève
continua et le 31 août 1980, les Accords d’Août furent signés. Le point le plus important
était le droit d’organiser des syndicats libres en Pologne. Ce fut le premier accord de ce
type dans le bloc soviétique. Quand Solidarność fut légalisé peu après, on comptait
presque un million de membres.
Le « carnaval » de Solidarność n’a pas duré longtemps.
Le 13 décembre 1981, la loi martiale a été introduite en Pologne. Le chantier a
été pacifié, Solidarność désintégré et Anna Walentynowicz avec les autres activistes
130
politiques, Joanna Gwiazda, Alina Pienkowska et Joanna Wojciechowicz ont été
arrêtées et transportées dans un camp pour prisonniers politiques à Gołdap.
L’emprisonnement a duré six mois, jusqu’au 24 Juillet 1982. Le 31 Août, elle était
arrêtée à nouveau et licenciée pour absence au travail, à cause de son arrestation. A.
Walentynowicz était accusée d’activité illégale au sein des syndicats après le 13
décembre 1981, et de la participation à la grève sur le Chantier de Danzig les 14-15
décembre 1981. Même si elle était considérée coupable, elle n’a pas dû aller en prison;
les arrestations qu’elle avait subies, avaient couvert le verdict.
Anna Walentynowicz a été arrêtée encore plusieurs fois, mais la conséquence la plus
importante des évènements des années 80 a été la fragmentation de la Solidarność. Lech
Wałęsa a pris le pouvoir dans l’organisation, même si elle était délégalisée. Avec le
soutien de l’ouest, Walesa a créé la première structure légale de Solidarność au temps
de la loi martiale, le Conseil Temporaire de Solidarnosc.
Walentynowicz a critiqué Wałęsa de prendre trop de mérite personnel, sans reconnaître
que le triomphe de Solidarność était l’effort d’un groupe, un effort qui a impliqué des
millions de personnes.
Dans cette période, Anna Walentynowicz est restée active mais s’est trouvée en
contraste avec l’opposition de la nouvelle Solidarnosc de Walesa. Elle condamnait la
transformation et la chute du communisme en 1989. Les accords de la Table Ronde ont
été précédés par des accords secrets entre Walesa et le gouvernement communiste,
durant lesquels, ils ont décidé comment diviser le pouvoir au sein d’un nouveau
système. Les négociations officielles ont commencé le 6 février 1989 et se sont
terminées le 4 avril avec la signature des accords qui ont légalisé les syndicats et ont
introduit le président et le Sénat.
Les sessions de la Table Ronde ont été une étape très importante pour la future vie
politique en Pologne et en Europe communiste.
Anna Walentynowicz n’a jamais accepté la nouvelle réalité dans laquelle les
communistes se sont accordés avec l’opposition. Elle a refusé de participer aux
anniversaires organisés par la nouvelle Solidarnosc, mais n’a jamais renoncé à la lutte
pour la justice sociale. Elle avait l’impression que la nouvelle organisation avait
abandonné les simples citoyens.
131
En 2003, elle a demandé la compensation du gouvernement pour les persécutions des
années 1980. Elle a versé pratiquement toute la somme aux nécessiteux.
Jusqu’à la fin, elle a stigmatisé les injustices, a critiqué sévèrement la mauvaise
conduite du parti Platform Civile, et est intervenue dans différentes affaires sociales.
Anna Walentynowicz est morte lors d’une catastrophe aérienne près de
Smolensk, en Russie où elle se rendait avec le président Lech Kaczynski et plusieurs
éminents leaders polonais afin de participer aux célébrations de l’anniversaire du crime
de Katyn.
132
BIBLIOGRAFIA
A. Baszanowska, A. Walentynowicz, Cień przyszłości, Arcanra 2009
W. Biernacki, Komunizm w Polsce, zdrada, zbrodnia, zakłamanie, zniewolenie,
Wyd. Ryszard Kłuszczyński, Kraków 2005
S. Cenckiewicz, Anna Solidarność, Zysk I S-KA, Poznań 2010
A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do
niepodległości. Historia Polski 1919-1989, a cura di Jacek Karnowski, Instytut
Pamięci Narodowej, Warszawa 2010.
W. Fidelis, Women, Communism and industrialization in Postwar Poland,
Cambridge University Press, New York 2010
A. Friszke, Rewolucja Solidarności. 1980-1981, Wyd Znak, Kraków 2013
A. Graff, Świat bez kobiet: płeć w polsi życiu publicznym, Wab, Warszawa 2001
B. Gawryszewski, Ludność Polski w XX wieku, PAN, Warszawa 2009
S. Koper, Kobiert władzy PRL, Czerwone i czarne, Warszawa 2010
G. Orwell, 1984, Mondadori, Milano 2002
P. Osęka, Marzec ’68. Wyd. Znak, Kraków 2008
S. Penn eds J. Massino, Gender politics and everyday life in State Socialist Eastern
and Central Europe, a cura di Shana Penn e Jill Massino, Palgrave Macmillan, New
York 2009
A. Zinowjew, Homo Sovieticus, trans. Charles Janson, Boston 1985
J. Tischner, Etyka solidarności oraz Homo Sovieticus, Wyd Znak, Kraków 1992
134
SITOGRAFIA
http://www.alternativacomunista.it/
http://www.ank.gov.pl/
http://www.archiwa.gov.pl/
http://archiwa-ipn.blogspot.com/
http://www.gutenberg.org/
http://www.ipn.gov.pl/
http://www.jstor.org/
http://www.newsweek.pl/
http://www.polskieradio.pl/
http://www.rp.pl/
http://www.staff.edu.pl/
http://www.ursynow.org.pl/
http://www.wysokieobcasy.pl/