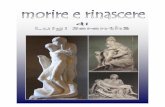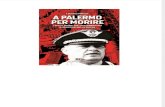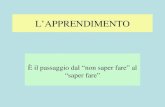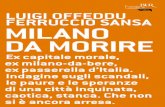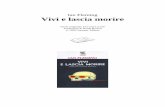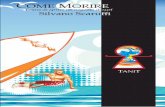Saper Morire Per Gian Domenico Borasio
-
Upload
ppablo-lima -
Category
Documents
-
view
16 -
download
2
description
Transcript of Saper Morire Per Gian Domenico Borasio

L’OSSERVATORE ROMANOpagina 4 giovedì 24 settembre 2015
Sul Marlowe di John Banville
Chissàche avrebbe dettoChandler
di GABRIELE NICOLÒ
Chissà come avrebbe reagito RaymondChandler nel vedere la sua folgorantecreazione — il detective privato PhilipMarlowe — resuscitata per manodell’irlandese John Banville (che usa lopseudonimo Benjamin Black) nell’indagineintitolata La bionda dagli occhi neri ( Pa r m a ,Guanda, 2014, pagine 299, euro 17,50).L’impresa, di certo, non è delle piùagevoli, dovendo l’autore misurarsi conuno dei più grandi scrittori di noir che, tral’altro, ha fatto la felicità degli attori piùcelebri e dei registi più acclamati una voltache si decise di curare la trasposizionecinematografica delle opere meglioriuscite. Basti pensare a The big sleep(1946), per la regia di Howard Hawks conun indimenticabile Humphrey Bogart nelruolo di Marlowe. Ebbene Banville superal’esame a pieni voti, grazie a una scritturaal contempo scattante e raffinata, in gradodi creare un’ammaliante atmosfera dove ilcrimine, la paura, la violenza, l’amore el’odio s’intrecciano nel segno di unacoinvolgente polifonia. Marlowe, si sa, èun duro: ne ha viste tante e ne ha passatetante. Eppure, anche perché sedotto dalconturbante fascino dalla bionda dagliocchi neri, si scopre quanto maivulnerabile nella girandola di avvenimenti— in una ruvida Los Angeles resa roventedalla calura estiva — che lo porteranno,più di una volta, di fronte al rischio divenire ucciso. Ma quella di Marlowe è unadebolezza che conquista il lettore: lo rendeinfatti più umano, più credibile, nonchépiù disincantato e lucido al cospetto delleinsidie che la vita sa tessere a discapito siadei buoni che dei cattivi. L’intreccio ècomplesso, ma mai oscuro: alla fine risultaassai avvincente. Il detective è alla ricercadi un personaggio misterioso che si pensasia morto ma che qualcuno ritiene avervisto camminare, di buon passo, lungo levie di San Francisco. E intorno a questoelusivo personaggio fioriscono accadimentilegati, in filigrana, da un elementocomune: la solitudine della persona.Banville, per bocca del suo Marlowe,dispensa durante la narrazione perle diilluminante saggezza sui diversi aspetti,anche quelli solo apparentemente banali,dell’esistenza quotidiana. In realtà mai unavolta la riflessione del protagonista sisofferma esplicitamente sulla solitudine.Ciononostante, la robusta impressione chesi ricava, una volta terminata la lettura, èquella di un grande vuoto che avvolge idiversi attori della vicenda, dopo che sognie speranze sono stati infranti. Ci sono, ecerto non potevano mancare, vittime. Maanche chi è riuscito a sopravvivere, haperso qualcosa di importante: è morto, asuo modo. E, in questo senso, quelloscritto da Banville è un noir con tutti icrismi. Chissà, allora, che cosa avrebbedetto Chandler se avesse seguito levicende che scaturiscono, a ritmoincalzante, dalla magnetica presenza dellabionda dagli occhi neri. Certo lo scrittorenon era un giudice tenero: si dice infattiche avesse osato criticare, anzi sferzare,illustri colleghi del calibro di DorotySayers e Agatha Christie.
Un discutibile libro sui progressi delle cure palliative
Saper morire
A una lettura attentail volume lascia perplessi in vari passaggiTanto da far temere persinoche una così grande linearità e chiarezzasiano veicoli efficacidi informazioni fuorvianti
Edito da Deutsche Grammophon il nuovo cd della Cappella musicale pontificia
La corale più antica
Ciò che il Vaticano II chiedeè una ricollocazione intelligentedel repertorio storico
Dispiace che chi si definisce«cattolico praticante»si riveli spesso lontano dall’amore di veritàche dovrebbe invece contraddistinguerel’uomo di scienza
Jacques-Louis David, «La morte di Socrate» (1787)
di FERDINAND O CANCELLI
Q uattro anni dopo l’uscita inlingua tedesca con il titolo diÜber das Sterben è ora statotradotto in italiano il libro diGian Domenico Borasio,
neurologo e palliativista, direttore dellacattedra di medicina palliativa dell’Uni-versità di Losanna. Saper morire ( To r i n o ,Bollati Boringhieri, 2015, pagine 208, euro16,50), così la traduzione del titolo, è ope-ra solo in apparenza semplice e dalla qua-le emergono molteplici intenti. Alternan-do casi clinici e parti esplicative, l’a u t o reconduce alla scoperta del mondo dellamedicina palliativa dapprima esponendo-ne in modo lineare i principi e la pratica esuccessivamente addentrandosi nello spe-cifico di alcuni fra i più importanti e scot-tanti temi etici che ruotano attorno allafase di fine vita.
Il mistero anche biologico della morte,l’ospedalizzazione della stessa, i cambia-menti della moderna società, le paure deimalati e le pretese della medicina sono trale tematiche che permettono a Borasio dispiegare con chiarezza le possibili rispo-
nel panorama delle cosiddette “cure pal-liative integrali”.
Il dottor Borasio più volte ripete chel’eutanasia dovrebbe restare vietata machiaramente si mostra favorevole al suici-dio assistito per quelle persone che «desi-derino avere un’alternativa migliore rispet-to al gettarsi sotto un treno o legarsi unacorda al collo». Sorprende a questo pro-posito che chi come l’autore ha così a lun-go lavorato a contatto con i malati in faseavanzata di malattia non abbia percepitol’evidenza che il desiderio di morire suici-di in tali pazienti è ridottissimo. Sarebbesenza dubbio valsa la pena di sottolinearequesto dato con forza e di dire chiara-mente che il fatto di proporre il suicidioassistito come una delle alternative possi-bili non fa altro che indurre i pazienti afarvi ricorso, illudendoli di mantenere ilcontrollo fino alla fine sulla propria vitache stanno comunque inesorabilmentep erdendo.
Il fil rouge del controllo a tutti i costifino alla fine pervade molte pagine del li-bro ma ciò che più dispiace è che chi nel-la biografia del risvolto di copertina si de-finisce «cattolico praticante» mostri poi
la citazione tra virgolette dei due terminipesantissimi riferiti come in qualche modopronunciati o scritti dal “Va t i c a n o ”, il dot-tor Borasio avrebbe dovuto, come pocodopo fa puntualmente con la citazione diun quotidiano, indicare il documento o lafonte. Se si pensa che in quei giorni terri-bili Lucetta Scaraffia scrivendo su questogiornale (La dignità della morte, 8 febbraio2009) parlava di «toni esaltati ed esibiti,talora con accenti eccessivi (...) proprioquando sono così importanti la pacatezzae l’equilibrio», non si può non restare co-sternati nel constatare che quei toni esisto-no ancora nonostante i propositi di fac-ciata.
L’occhio del palliativista può restareperplesso anche su altri passaggi. Si sotto-linea che occorre essere precisi quando siparla di “malato terminale” o di “fine vi-ta”. Borasio afferma ad esempio che «lanutrizione e idratazione artificiale nel finevita non dovrebbe di norma essere effet-tuata» per garantire che il tutto avvenganel modo «più naturale e sereno possibi-le» ma senza precisare in termini precisicosa si intende per “fine vita” o “malatoterminale”. L’affermazione, posta così,può essere pericolosa.
Immagino uno dei miei studenti chepotrebbe chiedermi se allora sia lecito nonidratare o nutrire un paziente affetto dauna neoplasia, ad esempio della laringe,incurabile: immediatamente lo porterei ariflettere sul fatto che tutto dipende dalla
prognosi. Se la morte dipende dal fattoche non lo idratiamo o non lo nutriamo, enon dal fatto di avere un tumore incurabi-le, bisognerà considerare tale supporto. Eancora bisogna essere precisi, molto cautie onesti quando si vuole parlare del prin-cipio del doppio effetto: l’autore lo fa, main modo piuttosto maldestro.
Dopo averlo liquidato come una «con-gettura etica» da far risalire a san Tomma-so d’Aquino, Borasio, pur sottolineandoche l’uso moderno dei farmaci rende tale
principio quasi superfluo, dimentica com-pletamente che sessant’anni fa Pio XII inalcune risposte radiofoniche agli anestesi-sti in congresso considerava lecito sommi-nistrare analgesici ad alte dosi pur di leni-re il dolore dei sofferenti accettando il fat-to che la vita potesse esserne abbreviata.Non è quindi vero che «per decenni» ciònon fosse ritenuto lecito o almeno occor-reva dire che il Vaticano pareva in quelcaso precorrere i tempi.
nei fatti di essere spesso lontano dall’amordi verità che dovrebbe comunque contrad-distinguere l’uomo di scienza. A parte lacompleta dimenticanza della millenariatradizione cristiana della meditatio mortis,sbrigativamente oggidì sostituita da benpiù inconsistenti “spiritualità” a buonmercato, non si può non commentarequanto l’autore afferma a proposito delcaso Englaro.
Borasio scrive che «il Vaticano descrisseripetutamente la richiesta del signor En-glaro di lasciare che la figlia (...) morissedi morte naturale in seguito all’i n t e r ru z i o -ne della nutrizione e idratazione artificialecome un “abominevole assassinio”». Vista
«Spesso serpeggia la convinzione che laChiesa cattolica, con la riforma della li-turgia voluta dal concilio Vaticano II,abbia rinunciato al suo grande patrimo-nio musicale» scrive Massimo Palom-bella nella presentazione del cd CantateDomino. La Cappella Sistina e la musicadei Papi, registrato per la DeutscheGrammophon dalla Cappella musicalepontificia sotto la volta della CappellaSistina. Il disco sarà in commercio dal25 settembre.
«Occorre però onestamente affermare— continua il maestro direttore dellaCappella musicale pontificia — che solouna conoscenza superficiale e ideologicadella riforma liturgica può portare a taligratuite affermazioni». E il nuovo cd,che sarà presentato nel pomeriggio del29 settembre con un concerto nellaCappella Sistina, vuole contribuire asmentire questo pregiudizio.
Tutta la musica contenuta nel disco èoggi usata regolarmente dalla Cappellamusicale pontificia nelle celebrazionidel Papa, spiega Palombella. «Ciò chela riforma liturgica del Vaticano II chie-de è un’intelligente ricollocazione dellostorico repertorio musicale nell’attualeliturgia, ricollocazione che deve avvenirecon una “specifica attinenza celebrati-va”». Questo «esige — continua Palom-bella — riflessione, studio, conoscenzadelle fonti e insieme serio dialogo conla cultura contemporanea per operarequella vitale sintesi che la liturgia inogni momento storico ha attuato».
La Cappella musicale pontificia, me-glio nota come Sistina, è la più anticaistituzione corale del mondo e ha segui-to la vita liturgica del papato in tutti isuoi storici sviluppi. In un momentoparticolare del Rinascimento ha avutotra i suoi cantori Giovanni Pierluigi daPalestrina, Luca Marenzio, Cristóbal deMorales, Costanzo Festa, Josquin De-sprès, Jacob Arcadelt e Gregorio Alle-gri. Il luogo dove ordinariamente laCappella svolgeva il suo servizio eral’Oratorio annesso al Palazzo apostoli-co, fatto costruire da Sisto I V, noto co-me Cappella Sistina e famoso per gli af-freschi di Perugino, Pinturicchio, Signo-relli, Botticelli, Ghirlandaio, nonché perla parete di fondo con il memorabileGiudizio universale e la Volta di Miche-langelo.
Proprio in questo Oratorio, spiegasempre Palombella presentando il cd, èstato eseguito tanto repertorio rinasci-mentale composto per le celebrazionipapali, repertorio scritto quindi per unpreciso ambiente acustico assolutamenteparticolare e unico. Il disco si prefiggedi riunire le più alte forme espressivedel Rinascimento romano, cosa che si
pone anche come un’interessante sfidaper il recupero di una certa pertinenzaestetica della vocalità rinascimentale co-me del canto gregoriano.
«Infatti — continua il maestro Palom-bella — cantare nel luogo dove il Rina-scimento si è manifestato nella sua for-ma compiuta, in affreschi con intensi einsieme delicati colori, un repertorioscritto per la Liturgia — una realtà viva,che in ogni momento storico ha sempreoperato una sintesi culturale — obbligaa ricercare con attenzione gli elementi
del Rinascimento allontanandola decisa-mente da una visione in bianco e nero— tipica di molte esecuzioni del nordEuropa — e da una tardo romantica,operistica, nella quale per molti, troppi,anni la Cappella musicale pontificia si èidentificata, credendo di trasmettere aiposteri l’unico vero stile della scuola ro-mana».
Anche per il canto gregoriano, mon-do complesso e denso oggi di tanti di-battiti talora anche sterili, chiosa Palom-bella, durante la registrazione del discosi è cercato di applicare la semiologiasolo quando questa migliora il prodottomusicale attenendosi sempre e soloall’edizione ufficiale del Graduale roma-no, senza quindi operare la «restituzio-ne delle note».
I brani musicali contenuti nel cd se-guono il cammino dell’Anno liturgicodella Chiesa Cattolica, dal tempo di Av-vento alla preparazione alla Pasqua.Troviamo così l’introito gregoriano Ro-rate coeli e l’offertorio Ad te levavi ( Pa l e -strina), tipici del tempo di Avvento; ilMa g n i f i c a t VIII toni (Orlando di Lasso) el’antifona gregoriana Lumen ad revelatio-nem gentium alternata alla polifonia (at-tribuita a Palestrina) che caratterizzanoil tempo di Natale, il mottetto Superflumina Babilonis (Palestrina), l’offerto-rio della Domenica delle Palme I m p ro -perium expectavi cor meum (Palestrina), ilfamoso M i s e re re di Allegri (nella versio-ne originale, secondo il Codice Sistinodel 1661), il Graduale gregoriano Chri-stus factus est e la seguente versione po-lifonica di Anerio, il Popule meus (D aVittoria) e l’Adoramus te Christe a vocipari (Palestrina), due brani che caratte-rizzano profondamente il tempo liturgi-co della Quaresima.
estetici che costituivano essenzialmentequesto particolare tipo di musica. Ciòha condotto lentamente la Cappellamusicale pontificia, in questi ultimi an-ni, all’eliminazione dei contralti, sosti-tuiti da un gruppo di tenori che cantada altus, con la conseguente applicazio-ne della regola rinascimentale del tra-sporto che permette a ogni voce di can-tare nella tessitura più consona e quindicon una vocalità leggera; all’uso di untactus dinamico che, oltre ad assicurareun doveroso corretto rapporto tra prola-zioni, evidenzia plasticamente il testo; aun’attenzione meticolosa e orizzontaleal fraseggio, che permette una sapientearticolazione dei suoni; all’uso degli “af-fetti” e delle “messe di voce”, aspettiestetici che, usati e disciplinati esclusiva-mente a servizio del testo, conferisconovita, pulsazione, colore alla musica sacra
re persino che una così grande linearità echiarezza siano veicoli efficaci di informa-zioni discutibili. A partire dalla definizio-ne di cure palliative dell’O rganizzazionemondiale della sanità (Oms), riportata so-lo parzialmente ma senza dichiararlo, l’au-tore evita di scrivere ad esempio che talicure intendono accompagnare il morente,secondo l’Oms, senza «né accelerare néritardare il decesso». Manca così al lettorefin dall’inizio una pietra miliare per com-prendere l’estraneità alla medicina palliati-va di concetti come eutanasia o suicidioassistito, concetti che invece sempre piùqualcuno vorrebbe forzatamente integrare
ste, spesso sconosciute per lamaggior parte delle persone,che i progressi delle curepalliative offrono. Nonostan-te il taglio più attinenteall’area tedesca nella qualel’autore ha a lungo lavorato,le considerazioni sono quasicompletamente aderenti an-che alla realtà italiana.
Eppure, a una lettura at-tenta, il libro lascia in nonpochi passaggi piuttostoperplessi, tanto da far teme-
La copertina del cd