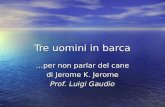Riassunto Parlar Figurato
description
Transcript of Riassunto Parlar Figurato
-
BICE MORTARA GARAVELLI IL PARLAR FIGURATO MANUALETTO DI FIGURE RETORICHE.
1. Le figure del discorso
Le figure del discorso (dal latino figura, configurazione, schema) riguardano i procedimenti discorsivi e hanno una struttura regolare; sono forme astratte disegnato da immagini in movimento, riconoscibili perch eseguite con regole precise, sebbene con innumerevoli variazioni stilistiche. Nella tradizione della retorica classica il parlar figurato apparteneva allambito della elocutio. Cicerone le aveva dette lumi del parlare e del comporre, fiori, colori (retorici) abbellimenti per dare vivacit al discorso. Si parla infatti di Ornatus Verba Res (ornamento verbale dei contenuti). Assistiamo per anche alla contrapposizione di due concezioni riguardo ornatus del discorso; infatti da una parte si ha una concezione delle figure retoriche come semplici abbellimento del contenuto, mentre dallaltra una configurazione di espressione affiancata ad una organizzazione del pensiero. Riguardo le figure retoriche si soliti distinguere tra figure grammaticali (relative allespressione) e figure logiche (relative al contenuto). Nellinsieme delle figure retoriche si distinsero i tropi. Si ha un tropo quando unespressione viene trasferita dal contenuto che le si riconosce come proprio a un altro e si applica per estensione ad altri oggetti, ovvero quando si verifica una deviazione e trasposizione di significato. Secondo una definizione recente un tropo unirregolarit di contenuto messa in rilievo. Esempio: Il vocabolo stella significa sia astro che attrice cinematografica famosa, per estensione. Allinterno dei tropi si soliti distinguere tra FIGURE DI PENSIERO, che sono appunto i tropi veri e propri, e FIGURE DI PAROLA.
2. Significati complessi
LA METAFORA Con metafora si intende la sostituzione di una parola con unaltra il cui senso letterale ha una qualche somiglianza col senso letterale della parola sostituita. Allinterno della metafora troviamo diverse classificazioni: - Metafore duso (cfr. catacresi): La catacresi determinata dalla necessit dovuta a una mancanza nel lessico di una lingua, ricorrendo ad un neologismo o alluso estensivo di un termine gi esistente: le gambe del tavolo, il collo di bottiglia, la catena montuosa, il letto del fiume, il ramo del lago. - Metafore dinvenzione: Cartella clinica della salute delle borse, La notte li inghiott. - Metafore nominali: Luigi (coraggioso come) un leone, Marta (furba come) una volpe. - Metafore verbali: Sono metafore che non modificano lazione, ma cambiamo in significato dei nomi connessi al verbo. Metafora come similitudine abbreviata, basata sullanalogia tra due entit. (Quel ragazzo uno scoiattolo = agile e sveglio). La similitudine abbreviata si verifica mediante la scomposizione in tratti e si muove nella differenza tra denotazione e connotazione. La denotazione lidentificazione di un referente da parte di un segno linguistico, mentre la connotazione si ha quando lattenzione posta sugli attributi di quanto denotato. Ad esempio la denotazione di volpe mammifero dei canidi con la testa piccola ed il muso lungo e appuntito, mentre la sua connotazione riguarda unidea accessoria di furbizia (Marco furbo come una volpe!). Lunico limite della metafora come similitudine abbreviata limpossibilit di condensazione di ogni paragone in una metafora: Infatti si pu dire Luigi intelligente come suo padre ma non Luigi suo padre. La metafora utile anche come costruzione del pensiero, infatti esistono schemi metaforici che riflettono la concezione della realt, come Guardare avanti introduce una concezione lineare del tempo e Fare progressi una concezione della vita umana come viaggio. Nella metafora troviamo due entit: il metaforizzato (il ragazzo), ed il metaforizzante (lo scoiattolo). La figura nasce dallintersezione dei caratteri che le due entit, si suppone, abbiano in comune (nellesempio lagilit, lessere svegli).
LA CATACRESI Si ha una catacresi quanto oggetti e situazioni che si designano normalmente facendo un uso figurato dei termini che serve a nominarli. La catacresi determinata dalla necessit dovuta a una mancanza nel lessico di una lingua, ricorrendo ad un neologismo o alluso estensivo di un termine gi esistente. Risponde quindi ad esigenze di economia
-
Esempio: Il collo della bottiglia, le gambe del tavolo, il letto del fiume, il ramo del lago.
LA SINESTESIA La sinestesia quel tipo di metafora che consiste nel trasferire un significato dalluno allaltro dominio percettivo. Esempio: Avere un carattere ruvido, odorare un profumo dolce (olfatto + gusto), avvertire un silenzio glaciale, suono morbido.
LE METONIMIE Si ha una metonimia consiste nel sostituire una parola con un'altra che abbia con la prima una certa relazione, ad esempio di contiguit logica o materiale. Ci si serve della metonimia quando si nominano lautore per lopera (ascoltare Beethoven, leggere Leopardi), il proprietario per la cosa posseduta (a Via Roma c Luigi, per dire la casa di Luigi) il contenente per il contenuto (ne ho bevuto una bottiglia), lo strumento fisico per quello morale (cervello per dire intelligenza), il simbolo per la cosa simboleggiata (armi per dire guerra), ledificio ospitante per lorganismo (Il Quirinale per dire la Presidenza della Repubblica).
LA SINEDDOCHE La sineddoche consiste nellesprimere una nozione con una parola che denota unaltra nozione, e questa ha con la prima un rapporto quantitativo: ovvero quando si nomina una parte per il tutto, il singolare per il plurale o la materia di un oggetto per loggetto stesso. Esistono due tipi di sineddoche: la sineddoche generalizzante, ove si nomina il pi per il meno (Es.: Ieri ho letto Pinocchio, per dire alcune pagine del libro di Pinocchio) e la sineddoche particolarizzante ove si nomina la parte per indicare il tutto (Es.: Arrivano le vele, per dire che arrivano le navi). Esempio: Ferro al posto di spada, felino per gatto.
LA POLISEMIA La polisemia una relazione paradigmatica in cui a un unico significante corrispondono pi significati. E spesso difficile distinguela dallomonimia, e la differenza sta che nella polisemia ragioni etimologiche inducono a pensare alla stessa parola (seppur con estensioni di significato), mentre nellomonimia si hanno diversi significati per lo stesso significante. Es.: Collo significa sia parte anatomica del corpo umano che unit di un carico di merci.
LA METALESSI La metalessi consiste nella sostituzione di un termine con uno traslato prodotto da passaggi impliciti attraverso pi nozioni che rimangono sottointese. La metalessi una combinazione di figure come sineddoche, metonimia e metafora. Esempio: Guadagnarsi il pane col sudore della fronte, dove sudore sta per fatica e fatica per lavoro.
LANTONOMASIA Con antonomasia intendiamo la sostituzione di un nome con un epiteto o una perifrasi atti a esprimere una caratteristica considerata distintiva dellindividuo. Esempio: La capitale del cinema, linquilino del Colle (per dire il Presidente della Repubblica), Einstein (per dire una persona intelligente), La tigre della Malesia.
LE PERIFRASI La perifrasi un giro di parole che sostituisce un unico termine con una definizione o con una parafrasi. Pu essere considerata come un sinonimo a pi termini ed il principio che la governa lequivalenza di senso. Il parlare odierno incline alle perifrasi; non si parla di sordi ma di non udenti. Esempi: non vedenti per ciechi, operatori ecologici per netturbini, decima musa per il cinema.
LE IPERBOLI Con iperbole si intende lesagerazione nellamplificare o nel ridurre la rappresentazione dei connotati di ci che si comunica, mantenendo tuttavia col vero una qualche lontana somiglianza. E il contesto a determinare linterpretazione. Esempi: Scrivere due righe, Non avere un briciolo di cervello, Essere accecato dallira, Arrivare in due minuti, Ti aspetto da un secolo.
DARE A INTENDERE: ENFASI, ALLUSIONE Con enfasi intendiamo lesagerato calore nella voce e nei gesti per far intendere allinterlocutore di andare oltre allaccezione pi immediata di un termine, in quella pi profonda. Lallusione un velato accenno a ci che non si vuole nominare apertamente. Riguarda un parlare insinuante, dando ad intendere e facendo appello a conoscenze vere o supposte del destinatario, senza nominare loggetto del discorso ma riferendosi a tratti capaci di caratterizzarlo. E una figura che ha un forte bisogno del contesto per essere riconosciuta, in quanto non ha nessuna particolarit di struttura sintattica o morfologica.
FIGURE DI MITIGAZIONE/ATTENUAZIONE: LITOTE, ATTENUAZIONE, EUFEMISMO, ASTEISMO, DISSIMULAZIONE, SIMULAZIONE LITOTE: Negare il contrario per affermare. Esempio: Non piccolo per grande, non nego per affermo. ATTENUAZIONE: Minimizzare fatti e circostanze, ridimensionare apprezzamenti. Es.: non si vorr dire.. in fondo non che...
-
EUFEMISMO: Sostituire unespressione diretta di idee ritenute sgradevoli con espressioni velate. Es.: male incurabile per cancro. ASTEISMO: Arguzia delicata grazie alla quale si loda o si lusinga sotto lapparenza del rimprovero. Es.: Non doveva disturbarsi... DISSIMULAZIONE E SIMULAZIONE: Atteggiamenti complementari forme della dissimulazione e del parlar coperto sostituendo un modo di dire colorito con unespressione neutrale.
LANTIFRASI Lantifrasi una forma di ironia considerata pi aggressiva e pi esplicita, e si ha quando unespressione viene usata per dire lopposto di ci che significa. Si riconosce dal contesto e dal tono di voce. Esempio: Bella giornata, oggi! per dire brutta giornata, o Bravo bene per rimproverare.
ENANTIOSEMIA In linguistica, la condizione semantica di un vocabolo che nel suo svolgimento storico ha assunto un significato opposto a quello etimologico. Es.: laggettivo feriale che, derivato del latino feriae giorni di riposo, significava in origine festivo mentre oggi vuol dire lavorativo.
LIRONIA Lironia la figura retorica grazie alla quale si sgonfia lenfasi e si ridimensiona il mondo; si pu fare attraverso battute superficiali, riflessioni amare, umorismo demenziale, cinismo e sarcasmo.
LOSSIMORO Un ossimoro si forma quando uno dei due componenti esprime una predicazione contraria rispetto al senso dellaltro, al quale strettamente unito. Ha lo scopo di sorprendere e stimolare lattenzione attraverso la sorpresa. Esempio: Insensato senso, La vita morte, Ferisco senza ferire, Affrettarsi lentamente.
LALLEGORIA L'allegoria la figura retorica per cui un concetto viene espresso attraverso un'immagine. Esempio: Dante nel primo canto dellInfermo rappresenta nelle tre fiere tre vizi capitali. Leone, lonza e lupa sono lallegoria di superbia, lussuria e avarizia.
LA PROSOPOPEA (o personificazione) La prosopopea una figura retorica che si ha quando si personificano, si parlare oggetti inanimati o animali, come se fossero persone. La troviamo spesso nelle fiabe e nella favolistica. Esempio: il Pinocchio di Collodi, La Fattoria degli Animali di Orwell.
3. La sinonimia I sinonimi sono parole diverse con significato equivalente. Gli effetti dovuti alluso dei sinonimi sono diversi: si rende pi colorita unespressione, si eliminano ripetizioni superflue, si evitano fastidiose rime prosaiche, e dal punto di vista di eleganza formale si uniformano le scelte lessicali ai registri e agli stili del discorso. Va precisato che di norma non esiste una perfetta intercambiabilit di tutti i significati in tutti i contesti possibili. Dal punto di vista delle figure retoriche la sinonimia un elemento dellornatus, che serve alla variatio, in opposizione alla repetitio. Serve, quidi, ad assicurare la ricchezza espressiva. Esempi: mamma/madre, pap/padre. Ci sono molte parole che possono avere pi sensi, ovvero termini per i quali esistono sinonimi che sono sinonimi di altri termini. (esempio: spirito pu avere come sinonimo alcool o fantasma senza questi ultimi siano sinonimi tra loro). w LA DITTOLOGIA SINONIMICA Il meccanismo della ripetizione si nasconde anche nella sinonimia, e da vita alla dittologia sinonimica, ovvero allaccumulo di termini sinonimi tra loro che si dispongono in maniera binaria o ternaria in un enunciato per produrre ridondanze (esempio: congiunge e unisce, grande e grosso, vivo e vegeto). w CLIMAX E ANTICLIMAX Il climax unintensificazione graduale utilizzata quando si vuole esprimere una progressione (esempio: troppo bella, troppo perfetta, troppo ideale. Lanticlimax lo stesso procedimento al contrario, in gradazione discendente (esempio: terra, fumo, polvere, ombra, niente).
-
4. Le somiglianze w LANALOGIA Lanalogia la somiglianza di entit che vengono confrontate una con laltra. La struttura dellanalogia esprimibile con una formula matematica A:B=C:D Esempio: Una vita senza sosta come un viaggio senza pause. w IL PARAGONE Il paragone una figura retorica che si divide in due specie: la similitudine e la comparazione. La similitudine prevede il confronto tra esseri animati, inanimati, atteggiamenti, azioni in uno dei quali si colgono caratteri somiglianti e paragonabili a quelli dellaltro. Esempio: La vita passa come lombra di una nube La comparazione un paragone reversibile, in quanto i due termini posso scambiarsi di ruolo. Esempio: E tanto bella quanto buona/E tanto buona quanto bella.
5. I giochi di parole w I METAPLASMI Il metaplasmo la trasformazione, il cambiamento che si impone ad una parola sopprimendo, aggiungendo, o scambiandone elementi. (Esempi: Elisione, troncamento). Altri metaplasmi sono aggiunte ripetitive che alterano la composizione di vocaboli (Esempio: Vivaaaaa lItaliaaaa). w PAROLE MACEDONIA, ACROSTICI, AGGIUNTE RIPETITIVE, SOSITUTIZIONI Parole macedonia: sono tipi di abbreviazioni ottenute mettendo insieme pezzi di parole. Es.: Confindustria (CONFederazione dellINDUSTRIA), Cobas (COmitati di BAse), Smog (Smoke + fog). Parole sandwich: introduzione di vocaboli intatti allinterno di altri. Es.: Cefalnebbialgia. Acrostici: lartificio che consiste nel formare parole o frasi con iniziali di parole o di versi. w GLI ANAGRAMMI Si verifica un anagramma quando si cambia di posto agli elementi di una parola ottenendone unaltra. Es.: Velo/Levo, Volgarit/Travaglio/Giravolta, Salustri/Trilussa. w PALINDROMI E BIFRONTI I palindromi sono i vocaboli che si possono leggere indifferentemente da destra a sinistra. Es.: Oro, Ingegno.
I bifronti sono quei vocaboli per i quali una lettura retrograda da una parola di senso diverso. Es.: Roma/amor. w ANFIBOLOGIA Lanfibologia un costrutto grammaticale che si pu interpretare in modi diversi, grazie allambiguit del testo e allutilizzo delle boutade nella pubblicit. Es.: Lo slogan Per piacere (che significa sia affinch piaccia, che se vuoi piacere). w PARANOMASIA La paranomasia una combinazione di parle che hanno fra loro variazioni minime di suoni, ma notevoli di significato. Es.: Chi non risica non rosica, Dalle stelle alle stalle, Fischi per fiaschi. w MALPROPISMO Un malpropismo un errore nato da somiglianza di forma nelle parole. Es.: Appetitivo per aperitivo. w FIGURA ETIMOLOGICA Con figura etimologica intendiamo la ripetizione della radice di un vocabolo. Lo troviamo negli slogan. Es.: Vietato vietare, Vita vissuta, Amar damore. w POLITTOTO Con polittoto intendiamo una costruzione del discorso in frasi fatte. (es.: Gli occhi negli occhi, Stare con le mani in mano.)
6. Il silenzio Nella comunicazione ci sono tante specie di silenzio, come ad esempio i puntini di sospensione, il prolungamento di effetti sonori, o un rallentamento del ritmo. Ci sono poi i puntini usati al posto di unespressione sconveniente, i puntini allusivi o quelli ironici. La forza comunicativa del silenzio grandissima e a volte pi eloquente della parola, pu essere offensivo, ostentazione di disinteresse, umiliazione, imbarazzo, commozione o insinuare rispetto.
-
7. Parlare in breve
w CONCISIONE (o BREVITAS) O LACONISMO Il discorso ideale quello a cui non si pu togliere nulla senza renderlo oscuro e a cui non necessario aggiungere nulla per renderlo pi chiaro. I mezzi della concisione sono figure che si ottengono sopprimendo qualcosa. Da qui il termine laconismo, che significa ridurre un discorso allessenziale. E importante per lefficacia incisiva. w LA PERCURSIO Con percursio intendiamo una rassegna rapida ed essenziale di fatti e avvenimenti, spesso introdotta da formule come una rapida scorsa. w ELLISSI Lellissi unespediente per snellire il discorso sopprimento parole o sintagmi per evitare ripetizioni. Es.: Ho comprato due libri e te tre [libri].
w PRETERIZIONE La preterizione la rinuncia dichiarata a soffermarsi su argomenti che si indicano appena, mentre se ne parla facendo mostra di non volerne parlare. Es.: Non qui il caso di dilungarsi... Per non parlare di.. Non ti dico.. w APOSIOPESI O RETICENZA Linterruzione improvvisa di un discorso quando gi un tema stato annunciato o avviato. E un espediente che mira ad affidare allascoltatore/lettore il compito di intenderne li sviluppi impliciti. La reticenza comprende anche forme di autocensura che contirbuiscono a sfumare il ricordo di unesperienza lontana.
8. Il parlare sentenzioso w SENTENZA, MOTTO, PROVERBIO. La sentenza un termine generico per una variet di figure: la massima, a cui si attribuisce validit generale (come i principi giuridici), il motto, il proverbio
w LEPIFONEMA E una sentenza posta a conclusione di un discorso, una riflessione vivace e breve che per la sua generalit o per il suo oggetto si distacchi nettamente dal contesto.
w LAFORISMA Laforisma una sentenza dotata di capacit definitoria. E spesso concentrata in una sola proposizione.
9. Mettere davanti agli occhi La tradizione retorica raggruppa gli espedienti della descrizione in diversi termini: -Topografia: descrizione di luoghi; -Cronografia: descrizione di circostanze, di tempo; -Prosopografia: descrizione di qualit fisiche, aspetto, movimenti; -Etopea: descrizione di qualit morali, vizi e virt; -Parallelo: due descrizioni consecutive o mescolate che mettano in evidenza somigliaze e differenze; LATTO LINGUISTICO DEL DESCRIVERE Il descrivere un atto linguistico e lo si pu compiere oralmente o per iscritto, in stili diversi a seconda degli scopi del descrivere: informare, persuadere, abbellire, creare lo sfondo di fatti.
10. Indugiare, rifinire, spiegare Loratoria si occupa anche dellesigenza di spiegare per filo e per segno un dato argomento. w COMMORATIO: indugio ripetitivo sulle idee comunicate; w EXPOLITIO: insistere, girando e rigirando intorno a una nozione o a unidea gi espressa; w INTERPRETATIO: accostare a un enunciato un altro equivalente, col risultato di chiarire o arricchire il pensiero gi espresso.
-
11. Laccumulazione In un discorso si possono aggiungere elementi o mettendone insieme diversi, cio accumulandoli, oppure ripetendo i medesimi in varie posizioni. Si ha accumulazione quando si aggiungono gli uni agli altri, mediante coordinazione o subordinazione. w CLIMAX: Bravo, bravissimo, eccellente; w LENUMERAZIONE: lelencazione dei presenti, gli indici, le ricapitolazioni, le voci di una nota spese; w ENDIADI: Usare due espressioni coordinate al posto di unespressione. Es.: Nella strada e nella polvere = nella strada polverosa, la notte e il buio = la notte buia. w EPITETI: Sono locuzione aggiunte che hanno funzione puramente ornamentale. Tendono a diventare stereotipici. Es.: Achille pi veloce.
12. Parentesi e digressioni Gli enunciati parentetici possono avere funzione esplicativa o aggiuntiva: questultima risponde al compito di aggiungere al testo notizie, commenti, spiegazioni, riflessioni. Possono avere posizione incidentale o didascalica. Al cambiamento del tono di voce nella lettura corrisponde uno sdoppiamento nel discorso, e quindi nella formazione di due discorsi paralleli e contemporanei. w LESEMPIO Un esempio serve a dare fondamento ad una regola, ad illustrare i risultati dellapplicazione di una regola conosciuta, o attirare lattenzione e fissare nella mente dellinterlocutore il concetto illustrato.
13. Drammatizzazione del discorso Drammatizzare significa inserire in un discorso elementi che facciano sentire la viva voce del narratore, che trasformino il narratore in attore. w LAPOSTROFE: Distacco dalla linea del discorso, provocata nellatto in cui chi parla si rivolge direttamente ad una persona diversa da destinatario naturale del discorso stesso. E utilizzata per suscitare pathos, ovvero per provocare la partecipazione emotiva delluditorio. Es.: Ricorditi, lettor, se ma ne lalpe. w DOMANDA RETORICA: Domanda che non attende altra risposta se non la conferma di ci intorno a cui si
interroga. Ha la struttura di interrogativa totale ed a risposta obbligata. w DUBITATIO: Domanda rivolta a s stesi per esprimere incertezza tra due o pi possibili interpretazioni di un fatto, come i dubbi di Dante. w SERMOCINATIO: Dare la parola ad un altro, citare in forma di discorso diretto enunciati altrui.
14. Anomalie sintattiche e semantiche w IPALLAGE L'ipllage una figura retorica che consiste nel riferire grammaticalmente una parte della frase a una parte diversa da quella a cui dovrebbe riferirsi semanticamente.
w ZEUGMA Lo zeugma la dipendenza irregolare con unimmagine. Es.: parlar e lagrimar vedrai insieme (sono entrambi aggiogati da un verbo che esprime percezione visiva e non auditiva).
w SILLEPSI Consiste nel far concordare due o pi elementi secondo un senso logico e non sintattico. Ci sono una serie di cose di cui vorrei parlarti.
15. I suoni
w FONOSIMBOLISMO Quando si percepiscono i suoi come simboli si ha il fonosimbolismo.
w ONOMATOPEA Lonomatopea limitazione dei suoni naturali in espressioni del linguaggio articolato. Parliamo di composizione di parole che riproducono il suono di rumori e li trascrivono secondo le convenzioni fonologiche. Es.: Chicchirich, miagolare, tintinnare.
-
16. Ripetizione Ci sono ripetizioni di cui non si pu fare a meno e che servono a rendere chiaro e preciso un discorso, e ce ne sono altre che lo abbelliscono. Servire alla chiarezza del discorso significa evitare ambiguit di senso e di riferimenti, agevolare i collegamenti tra parti di testo e facilitare la comprensione nellinsieme. w ANAFORA [/x../x../] Una o pi parole ripetute allinizio di segmenti successivi. E tipica delle preghiere e delle invocazioni. Figlio lalma t scita, / figlio de la smarrita, figlio de la sparita, / figlio attossecato. Elemento ripetuto anaforicamente con congiunzione coordinativa: Polisindeto; Elemento ripetuto anaforicamente senza congiunzioni: Asindeto. w EPIFORA [/..x/..x/] Una o pi parole ripetute alla fine di un enunciato. E tipica delle esclamazioni e delle formule (amen). w SIMPLOCHE [x..y/x..y] Linizio e la fine di un enunciato che diventano inizio e fine di uno o pi enunciati successivi. w EPANADIPLOSI [x..x] Si ha unepanadiplosi quando parole con cui si inizia un enunciato vengono ripetute alla fine dello stesso enunciato. Es.: Piace alla gente che piace, Bugie su bugie, Rovine su rovine. w EPANALESSI [xx..] Si ha unepanalessi quando si raddoppia unespressione, ripetendola o allinizio, o al centro, o alla fine d un segmento testuale. Es.: In verit, in verit vi dico.
w EPIZEUSI [xxxx.. xn..] Ripetizione multipla, ovvero ampliamento dellepanalessi per indicare intensit emotiva. w ANADIPLOSI [..x/x..] Si ha unepanadiplosi quando lultima parte di un segmento compare nella prima parte del segmento successivo. Es.: E il vento,/il vento che fa musiche bizzarre. w LA CLIMAX [..x/x..y/y..z/z..] E unanadiplosi continuata, e consiste nel procedere per scalini. w ALLITTERAZIONE Ricorrere di vocali, consonanti e sillabe uguali allinizio di due o pi parole successive. Es.: la vita vera va vissuta. w OMOTELEUTO Si ha un omeoteleuto quando due o pi parole hanno terminazione uguale o simile. Es.: avaro amore amaro. w ISOCOLO Si ha un isocolo quando coppie di frasi corrispondono perfettamente nellampiezza e nella struttura, sintattica e ritmica.
17. Cambiamento nellordine delle parole w ANASTROFE Lanastrofe linversione nellordine abituale di due o pi parole Es.: de lAlpi schermo, il di lei fratello, w IPERBATO Liperbato consiste nellandare oltre un qualche elemento posto in mezzo. E un interposizione che produce discontinuit allinterno di un sintagma. Una variante delliperbato lepifrasi, che consiste nello spostare un gruppo di parole al
termine di un enunciato per definirne meglio il significato. w HYSTERON PROTERON Si tratta di un procedimento narrativo che consiste nel sovvertire lordine cronologico dei fatti per anteporre linformazione pi importante. Es.: moriamo precipitiamoci nella mischia. w IL PLEONASMO SI ha un pleonasmo (aggiunta, riempitivo) quando un pronome riprende un sintagma gi presente con la stessa funzione. Es.: A me questo non me lha
mai detto nessuno. w ANACOLUTO Lanacoluto la figura retorica in cui non rispettata volutamente la coesione tra le varie parti della frase. quindi una rottura della regolarit sintattica della frase. w CHIASMO Nel chiasmo si crea un incrocio immaginario tra due coppie di parole, in versi o in prosa, con uno schema sintattico di AB,BA. Es.: Uno per tutti/tutti per uno, Vizi privati e pubbliche virt.
18. Gli opposti in parallelo Lantitesi come schema discorsivo la contrapposizione di idee in costrutti che si corrispondono nei membri opposti. Lefficacia del contrasto alimenta massime, aforismi e proverbi. Es.: tutto/nulla, semplice/complesso.