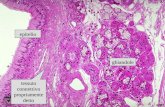Riassunto - Fioriti Editore · paziente. È chiaro che ci possa essere una reciproca influenza tra...
-
Upload
truongxuyen -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Riassunto - Fioriti Editore · paziente. È chiaro che ci possa essere una reciproca influenza tra...
26
Cognitivismo Clinico (2012) 9, 1, 26-40
PAZIENTE DEPRESSO E RELAZIONE TERAPEUTICA
Giovanni Fassone*, Floriana Lo Reto**
* psichiatra e psicoterapeuta, socio didatta SITCC** psicologa e psicoterapeuta, socio ordinario SITCCCorrispondenza: [email protected] Centro di Psicoterapia Cognitiva, Via Leone IV, 38 - 00192 Roma
RiassuntoAttraverso la descrizione di sei casi clinici si affronterà il tema della relazione terapeutica con i pazienti
depressi i quali spesso sono etichettati come tali, a scapito della complessità della loro condizione non solo clinica ma anche personale ed esistenziale. Nel tentativo di rendere un quadro d’insieme delle possibili implicazioni relazionali e dei relativi ostacoli che il paziente depresso manifesta nel corso del trattamento si è suddivisa la popolazione di pazienti depressi in 4 macrocategorie: la prima riguarda le forme depressive maggiori, unipolari e bipolari e le forme depressive più lievi come le distimie; la seconda è rappresentata dai quadri depressivi secondari ad altro disturbo in asse I, la terza riguarda i quadri depressivi associati ad alcuni disturbi di personalità (cluster B e C in particolare) mentre la quarta include le condizioni depressive legate a particolari condizioni esistenziali, come effetto di eventi di vita negativi. Queste 4 macrocategorie, cliniche in senso lato, possono dare un’idea della variabilità delle situazioni depressive e delle problematiche che il paziente con depressione mostra o mette in atto nella costruzione e nel mantenimento della relazione terapeutica.
Avvalendosi degli esempi clinici si vuol sottolineare il ruolo cruciale di una buona capacità di comprensione e gestione delle dinamiche relazionali e intersoggettive che sempre si attivano nel corso della terapia.
Parole chiave: depressione, relazione terapeutica, comorbilità, suicidio.
DEPRESSED PATIENT AND THERAPEUTIC RELATIONSHIP
AbstractThrough the description of six clinical cases the theme of therapeutic relationship with depressed
patients will be discussed. Too often depressed patient are labeled as such, regardless to their complex personal and existential condition. This paper will tentatively describe obstacles and possible relational implications in the treatment of “depressed patients”, that will be categorized into 4 groups: unipolar and bipolar depression; depression due to other Axis I disorder; depression in comorbidity with personality disorders; depression that occurs along with particular life events or condition.
Key words: depression, therapeutic relationship, comorbidity, suicide
Paziente depresso e relazione terapeutica
27
“The depressed person was in terrible and unceasing emotional pain, and the impossibility of sharing or articulating this pain
was itself a component of the pain and a contributing factor in its essential horror”
David Foster Wallace “The depressed person”, 1998
IntroduzioneLa citazione di David Foster Wallace, scrittore americano contemporaneo, morto suicida nel
2008, è lì a ricordarci quale sia uno degli aspetti centrali della sofferenza del paziente depresso. Ma è stata scelta anche per un altro motivo. Il brano, insieme ad altri dello stesso autore, è stato selezionato da una paziente che nell’inviarlo al terapeuta in un momento di grave stallo della terapia, ha sottolineato le seguenti parole: “the impossibility of sharing or articulating this pain was itself a component of the pain and a contributing factor in its essential horror”. L’intenzione della paziente era quella di dare voce alla propria esperienza depressiva, non tanto in relazione agli aspetti sintomatici, quanto piuttosto rispetto ai vissuti che la paziente ha sperimentato e sperimenta nella relazione con l’altro allorché si trova a descrivere il suo mondo. La solitudine, la percezione della impossibile condivisione, l’orrore di sé rappresentano insieme ad altri vissuti, alcuni degli aspetti più significativi della esperienza depressiva e – al contempo – uno degli ostacoli più ardui che il terapeuta si trova ad affrontare nel trattamento del paziente depresso.
Già. Ma di quale paziente depresso parliamo? Un primo aspetto da considerare quando si affronta il tema della relazione del paziente
depresso è legato alla tipologia di paziente con la quale ci si confronta. È infatti innegabile che dietro la definizione “paziente depresso” si celino condizioni molto diverse tra loro, soggetti che differiscono moltissimo a livello clinico, rispetto ai tratti di personalità e – non ultimo – su un piano esistenziale, in relazione agli eventi di vita e alle risorse che il paziente è in grado di mobilitare. Senza alcuna pretesa di esaustività, si può tuttavia provare a tracciare una breve descrizione di questa casistica, in modo da introdurre già da questa prima parte iniziale il tema che sarà sviluppato nel corso del lavoro. È evidente difatti che di fronte a pazienti affetti da diverse condizioni depressive è necessario formulare come prima cosa un corretto inquadramento del caso e poi una riflessione sulle dinamiche relazionali che i pazienti in ciascuna condizione possono mettere in atto nel corso della terapia, nelle sue diverse fasi.
È di tutta evidenza che una condizione depressiva più o meno pronunciata sul piano sintomatologico possa manifestarsi in quasi tutti i quadri clinici. Ai fini della nostra discussione è utile suddividere la popolazione di pazienti depressi in 4 macrocategorie. La prima riguarda le cosiddette forme depressive maggiori, unipolari e bipolari, che siano o meno in trattamento farmacologico. A queste condizioni si aggiungono forme depressive più lievi, anche se con andamento cronico, come le cosiddette distimie; una seconda categoria è rappresentata dai quadri depressivi secondari ad altro disturbo in asse I, per esempio la depressione secondaria a disturbo da attacchi di panico o al disturbo ossessivo-compulsivo; una terza riguarda i quadri depressivi associati ad alcuni disturbi di personalità (cluster B e C in particolare) mentre la quarta include le condizioni depressive legate a particolari condizioni esistenziali, come effetto di eventi di
Giovanni Fassone e Floriana Lo Reto
28
vita negativi, soprattutto se protratti nel tempo in termini di implicazioni e conseguenze per il paziente. È chiaro che ci possa essere una reciproca influenza tra quadro clinico o nosografico propriamente detto (per esempio una depressione maggiore unipolare) ed eventi di vita, ma ai fini della nostra discussione si richiede di fare uno sforzo particolare nel distinguere gli aspetti primari del disturbo da quelli secondari o successivi, proprio perché nella dinamica relazionale, questa distinzione a nostro parere assume una rilevanza sempre maggiore nell’impostazione e soprattutto nella prosecuzione della terapia.
Queste 4 macrocategorie, cliniche in senso lato, possono dare un’idea della variabilità delle
situazioni depressive e delle problematiche che il paziente con depressione mostra o mette in atto nella costruzione e nel mantenimento della relazione terapeutica. Come accennato in precedenza, è molto difficile se non fuorviante generalizzare e standardizzare questa variabilità entro categorie definite, rispetto alle quali rappresentare in modo più o meno prevedibile gli schemi relazionali che il paziente di questo o quel gruppo adotterà nel corso della terapia. Quello che ci pare ragionevole fare è di fornire un quadro d’insieme che sia sufficientemente coerente ma che non appiattisca la realtà clinica in categorie eccessivamente rigide, poco fruibili per la cura delle persone. Un aiuto in tal senso ci giunge come sempre dalla clinica, ed è per questo che cercheremo di fornire alcuni esempi clinici un po’ più approfonditi nel tentativo di rendere un quadro d’insieme delle possibili implicazioni relazionali e dei relativi ostacoli che il paziente depresso manifesta nel corso del trattamento, cercando di formulare degli esempi che siano in qualche misura rappresentativi di ciascun gruppo, senza la pretesa di voler essere in nessun modo esaustivi.
1) Forme depressive maggiori unipolari o bipolariAgata: è una donna di 52 anni, intelligente e vivace su un piano sociale e relazionale, che
viene in terapia dopo una buona esperienza di trattamento farmacologico e psicoterapeutico con un collega cognitivista, con il quale ha avuto una buona relazione di cura durata 4 anni. Agata è una paziente con una depressione maggiore unipolare ricorrente, con episodi che si susseguono ogni 12-18 mesi, di una certa gravità, nel corso dei quali non riesce a lavorare, a prendersi cura della sua persona e della sua vita per un periodo di almeno 2-3 mesi. Sebbene la prima richiesta fosse quella di una valutazione farmacologica, contestualmente la paziente formula anche una richiesta di psicoterapia, avendo interrotto la precedente per un problema relazionale con il collega. In particolare, la paziente riferirà di non essersi sentita accolta e adeguatamente compresa e sostenuta in un ambito della propria vita di relazione: la possibilità di mantenere e sostenere una doppia relazione, quella con il marito, a cui è molto affezionata ma con il quale non ha rapporti sessuali, e quella con un altro uomo, a cui è legata da alcuni anni da una fortissima attrazione fisica ed una forte complicità. La rottura della precedente relazione terapeutica, si era sostanzialmente consumata su questo punto, e cioè sul fatto che il collega, non senza una buona dose di buon senso, aveva cercato di dissuadere la paziente dal proseguire questo ménage, a suo parere troppo complicato su un piano personale ed oneroso rispetto alle risorse di cui la paziente poteva disporre, anche in relazione alla sua condizione di paziente depressa unipolare ricorrente. Dunque, quello che agli occhi del precedente terapeuta sembrava un intervento – inscritto in una buona cornice relazionale – senz’altro protettivo e conservativo rispetto al quadro clinico depressivo, è stato invece vissuto dalla paziente come un rifiuto. In particolare questo rifiuto riguardava a suo dire una parte essenziale e molto vitale del suo modo di essere e di stare al mondo.
Paziente depresso e relazione terapeutica
29
L’esempio appena discusso permette di evidenziare bene le continue transizioni tra piani diversi della terapia: dal piano strettamente clinico a quello – per così dire - più esistenziale della paziente. Nel “censurare” quest’aspetto, il collega pur non assumendo in nessun modo una posizione moralistica o giudicante, aveva di fatto negato alla paziente il diritto a esistere di questa parte che invece rappresentava per la paziente stessa un aspetto fondamentale e fortemente vitalizzante a cui non voleva in nessun modo rinunciare. In altre parole, il terapeuta senza volerlo ha invalidato l’importanza di una esperienza emotiva su un tema di vita di grande rilevanza per la paziente.
Ai fini delle implicazioni relazionali nel trattamento del paziente depresso, ci pare importante evidenziare una linea di demarcazione piuttosto netta e significativa: quella che divide le cosiddette forme depressive con una componente biologica, che necessitano almeno in alcune fasi di un trattamento farmacologico adeguatamente valutato e monitorato nel tempo, da quelle forme in cui la componente depressiva “biologica” non sembra giocare un ruolo decisivo nell’influenzare il decorso del disturbo e quindi della psicoterapia. Perché è importante questa linea di demarcazione? Per un motivo molto semplice. Ci sono forme depressive unipolari, e ancor più nello spettro bipolare, in cui la variazione dell’umore in senso depressivo avviene in modo molto imprevedibile, non di rado repentino. Il paziente che ne soffre riferisce spesso di un rapido cambiamento del suo modo di sentirsi, di vedere le cose e le sue relazioni, che si realizza nel giro di pochi giorni, a volte non più di una settimana appena. In alcuni casi non rari, il paziente descrive come un click nel cervello, “come un interruttore che spegne la mente” e ne azzera la vitalità, dalla sera alla mattina del giorno dopo. Il tutto può apparentemente avvenire senza un motivo, senza un evento scatenante degno di nota e senza un preavviso che possa essere utilizzato anche solo per mettere in pre-allarme paziente e terapeuta. È facile comprendere come questa condizione, frequente in questa categoria di pazienti, introduca un primo grande problema nella costruzione da parte del paziente di una solida alleanza terapeutica. Il fatto che la propria vita mentale possa essere annichilita nel giro di pochi giorni e che si possa passare da una condizione di relativo benessere ad una condizione depressiva che si aggrava nel giro di una o due settimane, rappresenta un ostacolo non indifferente alla costruzione di senso rispetto al lavoro terapeutico.
Il paziente trae da ciò il rinforzo al proprio convincimento tipicamente depressivo che tutto è inutile, che nulla abbia senso e che non ci sia nulla di sensato da fare per modificare queste sue convinzioni. Per lo psicoterapeuta questa è una delle sfide più ardue e faticose da affrontare. Appare infatti molto difficile smentire il paziente, sempre che non gli si voglia negare il senso dell’esperienza depressiva così come è stata descritta in precedenza. Al contempo è assai complicato intervenire su un paziente la cui condizione è quella di una devitalizzazione della propria esistenza, in cui il senso stesso della propria vita e della propria quotidianità è messo radicalmente in discussione. Il terapeuta, soprattutto se giovane e relativamente inesperto, può facilmente sperimentare un senso di impotenza e di frustrazione che spaventa il paziente se non altro perché gli conferma le proprie convinzioni/percezioni di sé, degli altri, del mondo come entità prive di senso e di valore. In questi momenti il paziente può essere tentato di abbandonare la psicoterapia, assumendo una posizione di ritiro tanto sofferente dall’indurlo a rinunciare a chiedere aiuto o – nei casi più gravi – elaborare progetti suicidari come extrema ratio per alleviare o cancellare una condizione di sofferenza e di perdita di significato che non è più tollerabile. In questa categoria di pazienti il drop-out dal trattamento psicoterapico si realizza più di frequente in queste fasi delicate in cui il senso della terapia è messo a dura prova dalle oscillazioni del
Giovanni Fassone e Floriana Lo Reto
30
tono dell’umore che tendono a travolgere come un’onda di tsunami le costruzioni di significato faticosamente elaborate nelle sedute e nei mesi precedenti.
L’esempio clinico di Agata, che nella sua storia clinica ha molte volte sperimentato il click nel cervello che la spegne e la devitalizza, permette tuttavia di fare un’altra riflessione relativa agli ostacoli che il paziente “depresso” può frapporre fra sé e la costruzione e il mantenimento di una buona relazione terapeutica. Questa riflessione riguarda non solo i pazienti con forme depressive maggiori, ma anche pazienti con forme depressive secondarie ad altri disturbi in asse I. Come per il caso di Agata, non bisogna mai perdere di vista gli aspetti personali, esistenziali del paziente anche quando questi appaiono relativamente marginali rispetto al primato della clinica, dei sintomi e del trattamento per i medesimi. Un approccio cognitivo-comportamentale moderno, pur non rinunciando ai principi fondanti che lo ispirano, non può a nostro parere prescindere da una attenzione alle dinamiche personali e relazionali che si sviluppano nella terapia a partire dal paziente. Appare, infatti, di fondamentale importanza la capacità di cogliere – al di là degli aspetti più squisitamente clinici o di organizzazione cognitiva – anche gli aspetti unici e irripetibili che ciascun paziente rappresenta in terapia in modo diretto o più frequentemente indiretto o implicito e che sono alla base della sua maggiore o minore capacità di costruire un legame significativo. Il caso seguente può fornire un valido esempio.
Paola, 47 anni, lavora come funzionario presso un ente pubblico; vive da sola e non ha relazioni sentimentali importanti e stabili da 13 anni. Richiede aiuto per il ‘crollo psico-fisico’ avuto negli ultimi mesi, che l’ha portata a prendere qualche giorno di malattia al lavoro perché non riusciva più a concentrarsi. La crisi segue un periodo di incomprensioni e conflitti con il capo. Le tensioni sul lavoro si fanno così forti che le prestazioni professionali calano e Paola non lo accetta. Lamenta disturbi del sonno, riduzione dell’appetito, astenia, perdita di interessi, rimuginio, ritiro sociale, bassa autostima, disperazione, senso di inutilità. Sul piano clinico si rileva un disturbo depressivo maggiore con ansia marcata, e le viene prescritto: Efexor, Xanax e Dalmadorm in aggiunta a tre mesi di sospensione dell’attività lavorativa.
Durante i primi incontri Paola ribadisce di non essere mai stata così depressa e che sente di non potercela fare ad uscire da questo stato di sofferenza atroce. Chiede continuamente rassicurazioni aspettando consigli e soluzioni al problema da parte del terapeuta, ma svalutando allo stesso tempo sia il terapeuta che la psicoterapia (la richiesta paradossale è: aiutami, ma non mi puoi aiutare): “… la prego, mi dica che ce la posso fare ad uscire da questo orrendo tunnel, mi sento persa... Non so come lei, oltretutto anche giovane, possa aiutarmi a riprendere a vivere; nessuno mi può aiutare, sono solo io la soluzione del problema...”. Paola si descrive come una persona che fino al momento della crisi era stata molto autonoma e in grado di affrontare bene le varie situazioni di vita (perdita dei genitori quando era giovane, vari problemi fisici debilitanti, la solitudine); ritrovarsi a chiedere aiuto perché non in grado di farcela da sola era difficile e fonte di vergogna “… me la sono cavata sempre da sola nella vita, ritrovarmi qui a chiedere aiuto mi fa sentire sconfitta e mi vergogno di farmi vedere in questo stato”.
Le rappresentazioni iniziali che Paola ha del terapeuta e della terapia rendono difficile la costruzione di una buona alleanza terapeutica. Sfiducia e scetticismo della paziente coesistono con l’idea del terapeuta ‘mago’ che dà consigli e soluzioni; tutto ciò ostacola la realizzazione di quel piano di collaborazione tra paziente e terapeuta essenziale per la terapia. Qualche elemento di storia della paziente ci può aiutare a capire meglio.
A 13 anni Paola, primogenita di due figli, perde il padre in un incidente stradale e si ritrova ad accudire la madre e il fratello. Trascorre tutta l’adolescenza tra gli impegni scolastici e
Paziente depresso e relazione terapeutica
31
casalinghi, poiché la madre non era più in grado di prendersi cura dei figli. Considerando le esperienze di precoce maturità che Paola ha vissuto, potremmo ipotizzare che queste la portano a sperimentare il ruolo di “paziente”, ovvero di persona bisognosa di cura e sostegno, come un qualcosa di degradante per la sua autostima. Da un lato la terapeuta è considerata come incapace di aiutarla ad apprendere qualcosa di nuovo su se stessa, dall’altro ha un disperato bisogno di qualcuno che rivesta il ruolo del mentore che gli fornisce quella guida che non ha ricevuto nell’adolescenza.
Dopo il primo mese di terapia farmacologica i sintomi più acuti iniziano a regredire e la paziente si mostra più collaborativa. Il percorso procede verso un netto miglioramento e in quattro mesi la crisi sembra rientrata. Un difficile momento di impasse si ha dopo un anno (gli incontri si erano diradati) quando la paziente ha di nuovo problemi sul lavoro e inizia a lamentare difficoltà di concentrazione. Questo campanello di allarme scatena una reazione emotiva intensa, tanto da far temere alla paziente una nuova crisi. Nel volgere di pochi giorni, Paola sta di nuovo molto male e si interroga su quanto fatto fino a quel momento, mettendo in discussione tutto il percorso di cura ed in particolare la terapeuta. Si ripropongono i temi relazionali paradossali dei primi tempi della terapia “aiutami, ma non mi puoi aiutare”. La paziente mette nuovamente e ripetutamente alla prova la terapeuta con dei test relazionali volti a saggiare inconsapevolmente la disponibilità della terapeuta ad accogliere la sua sofferenza e ad aiutarla e – soprattutto – la sua capacità “di reggere” al peso di quella che sembra una nuova ricaduta depressiva. Si profila il rischio di una rottura dell’alleanza terapeutica, così come si era verificato nei primi tempi del trattamento. La terapeuta, tuttavia, forte dell’esperienza fatta nella prima parte della terapia, supera i test relazionali sulla base della convinzione di poter lavorare efficacemente sulle credenze patogene della paziente e sulla fiducia nel trattamento. L’esperienza già vissuta permette ad entrambe – paziente e terapeuta – di superare in minor tempo e con meno fatica, il rischio di una frattura dell’alleanza e la sua successiva ricostruzione.
2) Quadri depressivi secondari ad altro disturbo in asse IGli esempi clinici seguenti evidenziano come sia possibile e a volte necessario imprimere
un salto di qualità al lavoro con il paziente depresso, che come in questi casi, manifesta un quadro clinico di comorbilità in asse I, unitamente a una storia di sviluppo gravata da esperienze traumatiche, compatibili con uno stile di attaccamento di tipo disorganizzato. In questi casi l’ostacolo alla relazione da parte del paziente non è solo rappresentato dalle tematiche tipiche del paziente depresso (mancanza di senso, inutilità, sfiducia) ma dalla impossibilità di concepire una relazione in cui possa sentirsi al sicuro, accolto anche e soprattutto nel momento di maggiore vulnerabilità.
Roberto: è un signore di 58 anni, sposato con tre figli ormai grandi, sofferente da molti anni di disturbo di panico con agorafobia, disturbi depressivi con andamento intermittente non meglio specificati e trattati negli anni con antidepressivi e benzodiazepine, con risultati alterni sia sulla sintomatologia depressiva che su quella primaria del disturbo di panico. Il paziente mostrava anche una notevole quota di rabbia, che in terapia si manifestava nei confronti del terapeuta in forma di critica sugli interventi, desiderio di contrapporsi al ruolo del terapeuta percepito come soverchiante e competitivo, nella sostanziale incapacità di affidarsi anche solo in parte ad una figura da cui potesse avere cura e conforto.
Nella sua storia riferiva di altri due interventi psicoterapici, rivelatisi fallimentari sul piano
Giovanni Fassone e Floriana Lo Reto
32
della efficacia e di una corretta gestione della relazione terapeutica da parte dei colleghi. Il paziente riferiva inoltre una storia di eventi traumatici, rappresentati da numerosi episodi di violenza e umiliazione da parte del padre (il padre picchiava il figlio se tornava sudato a casa o in ritardo dopo aver giocato con i suoi amichetti oppure per punizione lo legava ad una gamba del letto lasciandocelo anche per diverso tempo) e, da parte della madre, un atteggiamento di ansiosa impassibilità e inaccessibilità affettiva. In questo caso, in cui la depressione derivava da intensi vissuti di solitudine ed abbandono unitamente all’esperienza emotiva ripetuta del trauma e della umiliazione, la chiave di volta della terapia è stata rappresentata da due episodi distinti, verificatisi a distanza di alcuni mesi l’uno dall’altro. Nel primo, il paziente ha avuto modo di sottoporre il terapeuta ad un classico test relazionale allorché ottenuto un certo apprezzabile miglioramento clinico manifestava l’intenzione di lasciare la terapia, concordandone un po’ frettolosamente la chiusura.
La sensazione netta del terapeuta era che il paziente avesse certamente ottenuto un miglioramento clinico, ma che questo avesse nel frattempo lasciato del tutto inalterato il modello operativo interno di attaccamento (disorganizzato, compensato da una strategia controllante punitiva). Il paziente non aveva avuto modo di fare attraverso la terapia un lavoro specificamente orientato sulle sue tematiche profonde di abbandono e solitudine. Non senza una fase di negoziazione, il terapeuta decide quindi di proporre la prosecuzione della terapia, rappresentando al paziente queste sue considerazioni e affrontando una fase di ridefinizione degli obiettivi, che venivano dunque orientati da un piano strettamente clinico (la sintomatologia di panico) a quello delle dinamiche relazionali. Questa scelta del terapeuta, a cui il paziente ha aderito non senza qualche difficoltà, ha permesso con il tempo di approdare ad un livello di maggiore capacità autoriflessiva, di entrare più in profondità rispetto alla natura delle esperienze di attaccamento.
Ciò ha permesso con il tempo di creare le condizioni di sicurezza e fiducia, affinché il paziente potesse superare la paura dell’umiliazione e dell’abbandono in situazioni di vulnerabilità, permettendogli di rievocare e condividere con il terapeuta nuovi ricordi significativi, che permettono al paziente di ridefinire la figura del padre, non solo come aguzzino, ma anche come una persona capace di tenerezza e di autentico interesse nei suoi confronti. Il paziente ricorda – piangendo ‒ un episodio in cui il padre teneramente e pazientemente insegnava al figlio a suonare uno strumento musicale. D’altro canto, l’esperienza della solitudine e della inaccessibilità materna, persistente e invariante nel corso degli anni al punto da configurare una condizione di neglect fisico ed emotivo, viene rievocata dal paziente in numerosi episodi che permettono al terapeuta di restituire senso alla esperienza di solitudine e di ridefinire le origini del suo disturbo, sia in relazione alla cosiddetta ‘depressione̕ sia rispetto agli attacchi di panico.
In questo caso, l’ostacolo più grande alla costruzione e al mantenimento della relazione terapeutica era rappresentato dall’idea che la fonte di cura non potesse essere altro che un persecutore da cui difendersi, e – in una seconda fase – dalla radicata quanto inconsapevole convinzione che la dolorosa esperienza di neglect non fosse in alcun modo condivisibile o comprensibile da nessuno. In questo contesto relazionale, la validazione di queste emozioni attraverso l’esperienza emotiva correttiva ha rappresentato il punto di svolta del trattamento e il primo passo verso una radicale modificazione del rapporto terapeutico ed una successiva fase di conclusione della terapia.
Paziente depresso e relazione terapeutica
33
Anna, 30 anni, lavora come architetto presso uno studio privato. È fidanzata da 10 anni e da poco ha acquistato una casa con il compagno per poi sposarsi. Decide di intraprendere una psicoterapia perché la psichiatra alla quale si è rivolta per degli strani pensieri associati ad esaurimento le consiglia un ‘doppio percorso’. I problemi che porta Anna sono molteplici: pensieri ossessivi sulla propria identità sessuale (sarò omosessuale?), preoccupazioni intense per la salute, estrema insoddisfazione e delusione per la sua carriera lavorativa, una visione negativa della vita unitamente ad un profondo stato di tristezza con perdita di interessi, insonnia, ritiro sociale, riduzione dell’appetito, difficoltà di concentrazione. Si descrive come una persona precisa, molto responsabile, rigida e a volte testarda, che spesso si mette in competizione sul piano estetico con le donne e sul piano del successo professionale con gli uomini. Clinicamente Anna soddisfa i criteri per un disturbo ossessivo-compulsivo e per un disturbo depressivo secondario. La psichiatra nel frattempo le prescrive Cipralex. Anna esprime apertamente il suo scetticismo rispetto ai possibili effetti benefici del farmaco e della psicoterapia “non credo che con un farmaco o che con lei io possa risolvere i miei problemi, ma sono qui perché non ho più scelta; sto troppo male e rischio che il mio fidanzato si stufi di me se continuo così…” e porta a sostegno delle sue idee anche il fallimento dei 10 incontri fatti con una sessuologa “… La psichiatra mi ha dato quel nominativo e sono andata, ma io non sono preoccupata per il fatto di non avere l’orgasmo, io ho il dubbio e la paura che mi possano piacere le donne…”. Anna dice alla terapeuta che stare davanti a lei la fa sentire sconfitta e fallita, così come si sente quando lavora o rimugina sul fatto che sta svolgendo un’attività che non corrisponde a ciò che desiderava, paragonando il suo insuccesso al successo della terapeuta “penso che lei sia riuscita nel suo intento: studiare tanto per poi fare un lavoro che le piace e la fa guadagnare bene, io non ce l’ho fatta, ho sbagliato facoltà, e ora mi ritrovo a stare tutto il giorno in uno studio privato per guadagnare uno stipendio da fame. Quei pochi soldi che guadagno non mi permettono di essere autonoma economicamente, devo continuare a dipendere dai miei genitori a 30 anni!!...”
La paziente si rappresenta la terapeuta come una professionista di successo, che è riuscita a realizzare i suoi sogni e che quindi può essere indipendente. L’attivazione continua del sistema agonistico rende difficile la costruzione e il mantenimento dell’alleanza terapeutica poiché la paziente, nel confrontarsi con la terapeuta, si sente spesso una fallita e vittima.
Dopo circa cinque mesi Anna mostra un miglioramento della sintomatologia ossessivo-compulsiva e una stabilizzazione del tono dell’umore, da attribuirsi agli effetti dei farmaci, al lavoro cognitivo-comportamentale sul DOC e alla costruzione di una buona relazione terapeutica. Anna infatti inizia ad accogliere le osservazioni e riflessioni della terapeuta, ad aprirsi e a parlare anche di aspetti di sè inizialmente non condivisi. Le parole della paziente sono esplicative di questo cambiamento: “... inizialmente non credevo di potermi sentire meglio parlando dei miei problemi con un estraneo, ora invece aspetto il nostro incontro per potermi confrontare con lei, ascoltare le sue parole per poi ragionarci insieme. Prima era mia madre l’unica confidente, ma mi sto rendendo conto della differenza, lei dottoressa non mi dice cosa devo o non devo fare, ma mi aiuta a capire e questo mi fa sentire più libera di dire tutto quello che mi passa per la testa e come mi sento…”. Questo cambiamento di prospettiva aiuta la terapeuta, in accordo con Anna, a spostare l’attenzione su argomenti fino a quel momento rimasti volutamente nell’ombra: a breve Anna avrebbe affrontato un importante cambiamento di vita (l’imminente matrimonio e il desiderio di avere un figlio), senza essere ancora riuscita a trovare un lavoro stabile e sicuro, così come invece avevano fatto i suoi genitori prima di “mettere su famiglia”. È su questi temi che la terapia ha proseguito per i sei mesi successivi.
Giovanni Fassone e Floriana Lo Reto
34
3) Disturbi depressivi associati a disturbi di personalitàQuesta categoria, molto eterogenea, è rappresentata dai pazienti che hanno dei vissuti
profondamente depressivi, quando non degli episodi veri e propri, all’interno di un quadro clinico compatibile con un disturbo di personalità, in particolare del cluster B e C. Per definizione, questi i vissuti depressivi e gli episodi che ne derivano, si inscrivono in un quadro più complesso in cui la rete delle relazioni, il livello dell’adattamento psicosociale, la capacità di sviluppare o migliorare funzioni metacognitive, sono l’oggetto complesso e articolato dell’intervento terapeutico. In queste situazioni l’ostacolo alla costruzione di una relazione terapeutica non è il prodotto di una condizione depressiva primaria, ma è soprattutto il frutto delle caratteristiche di personalità del paziente, della gravità del quadro clinico, del livello di funzionamento e di adattamento sociale e – non ultimo – delle risorse che il paziente è in grado di rendere disponibili per la terapia.
Eleonora è una paziente molto grave, con un disturbo borderline di personalità, pregresso di abuso di cocaina e di alcol, episodi depressivi ricorrenti e comportamenti parasuicidari e suicidari, che l’hanno portata nella sua vita a mettere in atto tre gravi tentativi di suicidio (in realtà dei suicidi mancati). Per avere un’idea, l’ultimo di questi episodi, si verifica dopo una massiccia inalazione cocaina, a cui ha fatto seguito una insufficienza respiratoria su base vasculopatica secondaria all’effetto vasocostrittivo della cocaina, coma, polmonite ab ingestis e la comparsa di crisi epilettiche su base ipossica. La paziente è stata 3 settimane in coma e 2 mesi in rianimazione e successivamente ricoverata in SPDC e poi in clinica per altri 3 mesi. Nel caso di Eleonora come di altri analoghi, l’ostacolo più grande alla relazione, si manifesta nei momenti in cui si ritrova “disperata e depressa” nel breve volgere di 3-4 giorni. È la comparsa di un senso di vuoto che potremmo definire cosmico, la perdita totale dei confini che annulla, letteralmente, il senso di tutto. Il deserto delle relazioni che la circonda fa il resto e contribuisce in modo decisivo a rendere intollerabile la sua condizione depressiva e accentua i vissuti di vuoto e perdita dei confini di sé. Quello che resta è solo un senso di angoscia pervasiva e indifferenziata, che rende impossibile anche la mera comunicazione della sofferenza, compreso dunque il mantenimento del dialogo con il terapeuta.
È in questo contesto generale che maturano anche gli episodi depressivi secondari, che il terapeuta/psichiatra si trova a dover affrontare, in una situazione relazionale in cui la paziente perde il contatto da sé e quindi anche con il terapeuta. L’ostacolo, uno dei tanti in questo caso, alla costruzione e al mantenimento di una relazione terapeutica salda anche nei momenti di difficoltà è rappresentato dalle rappresentazioni di sé frammentate e disorganizzate, che si traducono in comportamenti e relazioni caotiche e disordinate, il cui leit motiv inconsapevole può essere riassunto così “dentro e intorno a me deserto e desolazione”. Anche la terapia in questi momenti fa parte del paesaggio desertificato e desolato, e per un lungo periodo il terapeuta si dibatte tra l’inefficace contenimento dei comportamenti di abuso e delle spese folli, il tentativo di dare un senso di continuità alla terapia continuamente minacciata, e la costruzione di una relazione dotata di senso e significato agli occhi della paziente. In un caso del genere, obiettivamente ai limiti della trattabilità, se la terapia va avanti lo si deve probabilmente ad una molteplicità di fattori, alcuni dei quali del tutto indipendenti dall’agire terapeutico. Un episodio che però vale la pena di citare, e che ha sicuramente influenzato sia la paziente che – soprattutto – il terapeuta è il seguente. È il momento in cui il terapeuta si reca in visita alla paziente mentre è ricoverata in
Paziente depresso e relazione terapeutica
35
rianimazione, una volta dichiarata fuori pericolo di vita. Il terapeuta entra in reparto, si avvicina al letto e la paziente che era addormentata, viene delicatamente svegliata da una infermiera. La paziente non sapeva che il terapeuta sarebbe venuto a trovarla. Nel vederlo lo riconosce dopo un breve attimo di esitazione (era coperto con gli indumenti protettivi che si usano per entrare nei reparti di rianimazione) e subito manifesta una immediata reazione di commozione, che tenta di esprimere a parole senza riuscirci. La paziente è intubata. Allora sorride, piange, si agita un poco cercando di liberare la mano dalle bendaggi e dalle flebo per stabilire il contatto con la mano del terapeuta, cercando di spiegargli a gesti – semmai ve ne fosse bisogno – che non può parlare indicando il respiratore. Il terapeuta le si rivolge ‒ non senza commozione ‒ dicendole di essere contento di ritrovarla viva, e dopo qualche breve scambio, si congeda.
Nel panorama desolato del mondo di relazioni della paziente, fatto di spacciatori, cocainomani e approfittatori, l’episodio descritto rappresenta una novità assoluta e inaspettata per la paziente. Per il terapeuta, d’altro canto, è stato descritto come uno dei momenti più intensi e toccanti della propria vita professionale, e ha rappresentato un potente rinforzo della sua figura di curante, permettendogli di rinnovare su una base nuova e più vincolante, il patto di cura con la paziente.
Simone ha 37 anni, lavora come capo contabile presso una società francese ed è single. Fra le motivazioni che lo inducono a iniziare un trattamento ci sono la difficoltà a stabilire e mantenere relazioni sentimentali e amicali, una profonda tristezza per la sua solitudine e per il sentirsi invisibile Sin dall’infanzia è presente un evitamento attivo delle relazioni sia sociali che intime per il timore di essere disapprovato o rifiutato, ma anche per la paura di essere esposto alla vergogna. C’è in Simone il forte desiderio di amore e accettazione ma il suo sentirsi inadeguato, brutto, socialmente inetto e inferiore agli altri lo porta ad evitare le relazioni fino a quando non si sente molto sicuro di essere accettato. È stata la sua unica amica a spingerlo a chiedere aiuto ed è al suo primo trattamento terapeutico. Sul piano clinico si rileva un disturbo di personalità evitante e un disturbo distimico.
La prima fase della terapia è caratterizzata dalla grande sfiducia che Simone nutre verso la possibilità di essere aiutato “… ho difficoltà a relazionarmi da quando ero piccolo, è il mio carattere e non ho speranze di poter cambiare questa cosa... penso che a nessuno interessino i miei problemi…” e dalla difficoltà di mostrare l’intensità della sua disperazione per timore di essere giudicato negativamente dal terapeuta e quindi abbandonato “… se dicessi a lei e alle poche persone che frequento come mi sento nel profondo capireste come sono veramente e potrei rimanere ancora più solo…”. Queste problematiche sono maggiormente comprensibili se si considera che i primi anni di vita di Simone sono caratterizzati da ripetute e dolorose esperienze di distacco dai genitori i quali, per motivi di lavoro, delegano totalmente l’accudimento del figlio alla nonna materna che vive a 100 Km di distanza. Quando Simone ha 3 anni nasce il fratello e la madre lascia il lavoro per accudire il neonato mentre lui rimane con la nonna fino ai suoi 6 anni. Tornato a vivere con i genitori non riesce ad inserirsi in quella famiglia alla quale sente di non appartenere e si adatta a quel sistema familiare mettendosi in un angolo con l’intento di non disturbare. Anche a scuola, con i coetanei, Simone ha molte difficoltà di socializzazione poichè teme di essere preso in giro e di non essere all’altezza degli altri; con il trascorrere degli anni il distacco difensivo per la paura dell’umiliazione e del rifiuto è così forte che Simone si isola a tal punto da non avere nessun amico con il quale parlare. Con l’avanzare dell’età aumenta anche il suo senso di invisibilità, incapacità e inutilità, rinforzato pure dai feedback genitoriali che lo appellano come un inconcludente perchè non riesce a gettare le basi per raggiungere l’obiettivo
Giovanni Fassone e Floriana Lo Reto
36
(secondo loro) più importante della vita: avere una moglie e dei figli. La madre è descritta come anaffettiva ma molto controllante e il padre succube e “servo della madre”.
Nonostante la sofferenza e il bisogno di aiuto siano intensi, le convinzioni e i vissuti di Simone rendono difficile la costruzione e il mantenimento dell’alleanza terapeutica. Il tema della speranza e della fiducia è infatti centrale in ogni processo di cambiamento e, quando l’esperienza di vita è stata tale per cui si hanno scarse o nulle aspettative sul fatto che gli altri possano desiderare o essere in grado di aiutare, il processo attraverso cui sviluppare la speranza di cura diventa il problema centrale della psicoterapia. In molti casi la gravità dell’amarezza e della disperazione (tipica del paziente depresso) rende impossibile trovare conforto in un altro essere umano e lascia gli altri frustrati nei loro sforzi di prendere contatto con lui o di essergli utili. Spesso questi pazienti nascondono agli altri l’intensità della loro disperazione perché temono che gli altri possano esserne allontanati e la nascondono anche a se stessi perché troppo doloroso prenderne atto pienamente.
Durante i primi mesi di trattamento Simone inizia, con scarsa motivazione, anche una farmacoterapia con antidepressivi che smette dopo cinque settimane affermando di non trarne giovamento. La terapia è in quel periodo focalizzata sulla costruzione della fiducia, e sembra che si stia facendo un buon lavoro quando, dopo circa sei mesi dall’inizio, Simone annulla un appuntamento e non chiama per un mese. Apparentemente non c’erano stati problemi tra terapeuta e paziente e Simone non aveva dato spiegazioni del suo allontanamento. La terapeuta lo chiama per poterne parlare ma lui chiede di essere lasciato in pace e dice che si farà vivo presto. L’incontro che segue all’interruzione è focalizzato su quanto accaduto. Emerge che nella settimana precedente all’interruzione Simone era stato molto male per il fallimento di un tentativo di apertura verso una ragazza, e questo lo aveva gettato in un grande sconforto “…sto molto male, sono un fallito e poi sono anche tanto arrabbiato perché non riuscirò mai a cambiare”. La terapeuta decide di esprimere a Simone i suoi sentimenti di impotenza e rabbia provati dal momento dell’interruzione improvvisa “… durante questo mese di suo silenzio ho sentito che non potevo aiutarla in alcun modo perché c’era un muro molto alto tra noi. Lei in quel momento ha deciso di non condividere con me quanto le stava accadendo e io, oltre alla preoccupazione, ho provato rabbia nei suoi confronti. Rabbia perché non stava rispettando gli accordi presi, avevamo stabilito che nei momenti di difficoltà avrebbe dovuto chiamarmi, e invece lei ha fatto l’esatto contrario. Simone spiega la sua reazione “… Quando sto così mi chiudo perché nessuno deve vedere che schifo che sono, non voglio vedermi neanche io. Non l’ho chiamata perché mi vergognavo ma anche perché tanto non avrebbe potuto fare nulla. In quei momenti la terapia non mi è di aiuto perché sprofondo in un buco nero. Però la prego, non mi abbandoni!!!…”
Questo passaggio evidenzia almeno due aspetti importanti per la relazione terapeutica. Prima di tutto il fatto che un paziente con difficoltà a provare pienamente e a esprimere la tristezza continuerà a sentire mancanza di sintonia con gli altri rispetto a tale sentimento; questo può a sua volta creare una barriera nella relazione che lo lascia deprivato e arrabbiato. Come conseguenza gli altri, compreso il terapeuta, potranno essere allontanati da tale atteggiamento e non riuscire ad empatizzare con questa rabbia.
In secondo luogo quando un disturbo depressivo è associato a un disturbo di personalità è quest’ultimo che gioca un ruolo primario nella costruzione e nel mantenimento della relazione terapeutica. Simone infatti, con la sua personalità evitante, sentendosi in difetto si distacca in
Paziente depresso e relazione terapeutica
37
modo difensivo dalla relazione terapeutica soprattutto per la paura dell’umiliazione e del rifiuto. Senza un intervento terapeutico che prenda in considerazione le caratteristiche di personalità del paziente, le sue risorse e il suo livello di funzionamento e di adattamento sociale si corre il rischio di non riuscire a ‘ricucire’ fratture terapeutiche come quella appena descritta.
4) Disturbi depressivi legati a particolari condizioni esistenzialiInfine, la quarta categoria di pazienti depressi è costituita da quelle forme di depressione
che sono il risultato di un percorso di vita particolarmente ostico, di una esistenza in cui per una concatenazione di eventi, il paziente non è stato in grado o non ha potuto realizzare alcuni obiettivi minimi ritenuti fondamentali. Sono quadri che si presentano in genere sulla soglia della terza età, con caratteristiche cliniche spurie, un decorso altrettanto atipico, e problematiche relazionali sui generis, ivi compreso il tema del suicidio, in questo caso da intendersi non come massima espressione della disperazione depressiva, ma come un atto di ribellione e di rifiuto nei confronti di un destino particolarmente avverso. Verrà a tale proposito descritto un caso che ben rappresenta questa particolare condizione.
Laura è una donna di 69 anni, che viene inviata al terapeuta per una valutazione clinica, per una diagnosi di “depressione”. Laura sta per andare in pensione dopo più di 40 anni di brillante carriera nella pubblica amministrazione, ove ricopre un ruolo di grande responsabilità. È laureata in legge, è una donna intelligente, con capacità superiori alla media, alle prese con un difficile passaggio di vita. La madre, con la quale ha vissuto negli ultimi 30 anni, è morta da circa due anni, e Laura che non si è sposata e non ha figli si ritrova a fare i conti con il tema della solitudine, sulla soglia della vecchiaia e di un importante cambiamento di vita come la pensione. È una donna stimata, apprezzata e dai molteplici interessi. A fronte di un aspetto austero, a tratti ruvido, di donna del nord, che non si perde in inutili convenevoli e atteggiamenti di circostanza, Laura esprime anche una fortissima e inaspettata carica vitale, testimoniata dalla sua partecipazione attiva presso un’associazione di difesa dei diritti umani, dall’aver partecipato alla fondazione di un importante partito politico italiano alla cui vita partecipa attivamente, una passione per il poker e in seguito anche per il bridge che pratica con grande diletto a livelli semi-professionali. Sul piano delle relazioni, Laura evidenzia un problema di solitudine, non tanto in relazione ai rapporti sociali (Laura infatti ha amici e conoscenti con cui ha relazioni di buona qualità), quanto piuttosto su un piano personale. A questo proposito vale la pena riprendere il tema degli eventi di vita avversi come elemento centrale nella genesi di alcuni disturbi cosiddetti depressivi ma che depressivi sono solo in apparenza. Laura perde il padre in età giovanile, e benché volesse iscriversi a medicina, è costretta dagli eventi a ripiegare – per così dire – su giurisprudenza per avere un più rapido accesso al mondo del lavoro. Non ha fratelli e la madre, che non si risposa, vive con lei. Laura si laurea e inizia a lavorare, continuando a vivere con la madre. Non abbandona il sogno di fare medicina, studia di notte insieme ad un amico, e con lui si laurea in gran segreto in medicina all’età di 31 anni, dopo aver trascorso i 6 anni precedenti a studiare rinunciando a qualsiasi svago o vacanza. Poco dopo l’esame di stato, viene chiamata per prendere servizio presso un reparto ospedaliero. Poche settimane prima di prendere servizio, le viene diagnosticato un carcinoma mammario. Questo comporta un intervento chirurgico demolitivo, trattamento chemioterapici invasivi e un lungo periodo di cure e convalescenza al termine della quale si ritrova viva ma gravemente menomata nel fisico e nello spirito, “deturpata” come donna e privata all’improvviso di qualsiasi possibilità
Giovanni Fassone e Floriana Lo Reto
38
di recupero dei propri progetti e delle proprie aspirazioni. Rinuncia a perseguire il progetto di fare il medico, chiude per sempre questo capitolo della sua vita dicendosi che “evidentemente non era destino” e che anzi in qualche modo “se l’era cercata”, sfidando le avversità e facendo enormi sacrifici per soddisfare quello che ora sembra essere stato “solo il suo capriccio di fare il medico”. Laura ritiene con ciò anche prematuramente conclusa la sua vita di relazione e non si avvicinerà più ad un uomo per i successivi 35 anni.
Quando giunge all’osservazione, la paziente è in terapia con farmaci antidepressivi, soffre di insonnia, e lamenta tristezza e demoralizzazione. La terapia farmacologica, si mostra di nessuna efficacia, e le viene modificata almeno altre 3 volte, sempre con farmaci diversi, senza un apprezzabile effetto se non sul sonno. Con l’andare del tempo il tema della solitudine e della vecchiaia si affacciano con sempre maggiore insistenza, unitamente alle preoccupazioni di poter rimanere vecchia, sola e invalida come lo era stata la madre negli ultimi 7 anni della sua vita, con la differenza che Laura non avrebbe avuto nessuno ad occuparsi amorevolmente di lei. È in questa occasione che Laura manifesta l’intenzione di prevenire tale evenienza togliendosi la vita finchè era ancora autonoma e libera di poterlo fare. Nel frattempo le viene prolungato l’incarico di lavoro con una consulenza che le permette di mantenere vivi i contatti lavorativi. Conosce nel corso della terapia un uomo un po’ più giovane di lei con cui, sorprendentemente, intraprende una relazione molto intensa e coinvolgente, anche da un punto di vista sessuale. Laura vive questa esperienza come qualcosa a cui stenta a credere, che paradossalmente marca ancora di più il senso di solitudine che l’ha accompagnata per tutta la vita. Descrive sentimenti molto ambivalenti, di colpa e desiderio, il senso dell’ineluttabilità e al contempo della imprevedibilità del destino, che le riserva una relazione affettiva molto intensa in una età in cui la maggior parte delle persone si prepara ad attraversare l’ultima parte della propria vita accompagnati da affetti consolidati da tempo.
La terapia aveva proceduto sino a quel momento nella direzione di un possibile recupero di una dimensione intima e personale delle relazioni amicali e poi anche affettive, in una situazione generale in cui alcuni amici erano nel frattempo venuti a mancare (dopo i 70 anni questa diventa un’evenienza frequente che gioca un ruolo non secondario nella genesi dei disturbi depressivi della terza età). La qualità della relazione è buona, così come è buono il livello di compliance farmacologica e rispetto alle sedute, a cui Laura non manca mai, nonostante manifesti in più occasioni l’inutilità degli sforzi profusi. Il terapeuta sente il persistere di una distanza, di un solco che lo separa dalla possibilità di stabilire con Laura un maggiore livello di complicità e collaborazione. Queste sensazioni vengono esplicitate e affrontate in terapia e Laura confida di nutrire una sostanziale sfiducia nella possibilità di alleviare le sue angosce di solitudine, nonostante manifesti in vario modo stima e apprezzamento per il lavoro fatto insieme.
La relazione con quest’ uomo si interrompe dopo circa 6 mesi e nonostante Laura viva questo evento con sentimenti contrastanti di colpa e sollievo, nelle settimane successive manifesta un dolore per la perdita che a stento riesce a contenere. Nel frattempo, una cugina di Laura, l’ultima parente ancora in vita della sua famiglia muore all’improvviso. Laura non sembra poter sostenere l’impatto di questa nuova perdita, ancor più significativa perché sancisce la fine di tutti i legami affettivi e familiari che aveva. Nel frattempo, era anche andata definitivamente in pensione.
Dopo circa 4 mesi Laura, senza alcun segno che potesse mettere il terapeuta e la psichiatra curante in avviso, mette in atto un tentativo di suicidio, molto cruento, che non si conclude solo perché la modalità adottata aveva spaventato Laura che aveva a un certo punto chiesto aiuto. Viene soccorsa da un amico vicino di casa e poi dal terapeuta e da un collega chirurgo
Paziente depresso e relazione terapeutica
39
che provvede a suturarle le profonde ferite. Laura sembra riprendersi dallo shock, riprende le sedute, continua i farmaci, continua a mantenere vivi i suoi interessi (tornei di bridge, partite di poker, qualche uscita con le amiche, l’attività presso l’associazione di difesa dei diritti civili). Con l’arrivo dell’estate l’anno successivo si pone di nuovo il problema di come trascorrere le settimane di agosto, dove e con chi andare. Laura tranquillizza tutti, amici e terapeuti, prenotando un soggiorno in montagna, dove era già stata l’anno precedente. Acquista i biglietti, colloca il cane e i due gatti che nel frattempo aveva preso con sé, saluta tutti con un caloroso arrivederci.
Quello che non dice è che ha anche depositato un testamento, ritirato i soldi per le sue esequie e dato disposizioni in merito molto precise, e che si è infine procurata dei sedativi. Si toglie la vita per asfissia con un sacchetto di plastica legato al collo, dopo essersi stordita con alcol e farmaci.
Questo caso, molto sui generis e non a caso scelto per questa breve rassegna, evidenzia molto bene le problematiche che si possono incontrare in questa categoria di pazienti. Non si può dire infatti che non siano stati profusi sforzi e risorse da parte di terapeuta, psichiatra curante e paziente, per cercare di modificare un percorso di vita, che sembrava, in particolare agli occhi della paziente, impossibile da modificare. Sono stati effettuati incontri a tre, sono state conosciute le amiche e valutate tutte le risorse a disposizione, nel tentativo di alleviare il peso della condizione esistenziale in cui questa paziente si è trovata. Non si può neanche dire che la relazione terapeutica sia stata inficiata in modo evidente o che non fosse di buona qualità. In un biglietto rinvenuto dalla polizia, Laura ringrazia il terapeuta per gli sforzi profusi ed esprime parole di affettuoso commiato nei suoi confronti come nei confronti di alcune altre figure a lei legate. Che dire dunque? Che cosa non ha funzionato? Ci sono stati degli ostacoli che la paziente e il terapeuta non sono riusciti a superare rispetto alla relazione terapeutica? Possiamo forse dire che la condizione di Laura appartenesse più che alla clinica, agli effetti della imprevedibile capricciosità del destino, che in alcuni casi sembra prendersi beffa dell’uomo e di tutti i suoi sforzi? È difficile rispondere, ma nel descrivere questo caso abbiamo voluto dare voce ad una condizione che per la peculiarità del caso e la tragicità degli esiti, non trova facilmente posto nelle casistiche discusse negli articoli scientifici. I motivi possono essere molteplici: un senso di pudore da parte di chi ne è stato coinvolto in prima persona, un sentimento di colpa e inadeguatezza per come sono andate le cose, il timore del giudizio dei colleghi, e non ultimo – forse – un senso di rispetto per il paziente che non c’è più. Riteniamo tuttavia prevalenti su queste considerazioni, quand’anche siano in parte vere, le riflessioni che possono scaturire dalla condivisione delle difficoltà che si incontrano nel trattare pazienti con queste caratteristiche, il senso di impotenza e solitudine che sperimenta il terapeuta chiamato a prendersi cura di casi complessi e difficili come quello descritto.
ConclusioniLe conclusioni che possiamo trarre sono a questo punto ridotte ad alcune brevi considerazioni.
I pazienti “depressi” spesso, e a volte con troppa facilità, sono etichettati come tali, a scapito della complessità della loro condizione non solo clinica ma anche personale ed esistenziale. Un approccio cognitivo-comportamentale moderno ed attuale, non può prescindere dal considerare in modo attento ed approfondito, nonché “tecnicamente” aggiornato le implicazioni derivanti dalla gestione delle dinamiche relazionali, anche quando si intende procedere con il più classico
Giovanni Fassone e Floriana Lo Reto
40
degli approcci cognitivi standard. Questa osservazione forse è più importante per il terapeuta in formazione e nei primi anni della sua attività, quando l’ansia rispetto alle proprie competenze e la paura di non essere capace, tendono a farlo ripiegare su schemi di intervento codificati e manualizzati. In questo caso, il protocollo di intervento manualizzato o codificato conferisce un senso di padronanza e di competenza al terapeuta, che ha quindi l’impressione, talvolta anche giusta, di saper gestire meglio il corso della terapia.
Lungi dal voler svalutare in questa sede il ruolo e l’importanza rispetto alla conoscenza e alla applicazione di modelli di intervento evidence-based, validati ed efficaci, si vuole tuttavia sottolineare la fondamentale importanza di una buona capacità di comprensione e gestione delle dinamiche relazionali e intersoggettive che sempre si attivano nel corso della terapia. Come abbiamo visto nei diversi casi presentati, sebbene sia possibile tracciare un profilo delle dinamiche che più frequentemente si attivano nella relazione con il paziente depresso, non è affatto facile descrivere una casistica esaustiva degli eventi relazionali che con i diversi pazienti e nel corso delle varie terapie si attivano tra terapeuta e paziente. In tal senso un ruolo fondamentale è svolto dall’esperienza che si matura nel tempo e dalla conoscenza da parte del terapeuta delle proprie dinamiche interne, o per dirla in modo più cognitivo, della propria organizzazione cognitiva, affinata magari da un’esperienza di terapia personale. Nel frattempo però, potrebbe non essere inutile approfondire lo studio di molti e importanti contributi allo studio della relazione terapeutica che provengono da ambiti teorici affini al cognitivismo. Anche molti autori e scuole di pensiero ed orientamento ‘cognitivista’ ormai da tempo sottolineano (Di Maggio e Semerari 2003; Liotti 1994; Liotti e Monticelli 2008; Safran e Muran 2000; Semerari 2000, 1991; Weiss 1993) che per raggiungere l’obiettivo del sollievo dei sintomi bisogna passare attraverso uno studio approfondito della relazione terapeutica, delle sue dinamiche e motivazioni interpersonali nel paziente come nel terapeuta, per approdare al cambiamento e tendere asintoticamente alla guarigione.
BibliografiaDimaggio G, Semerari A (2003). I disturbi di personalità. Modelli e trattamento. Laterza, Roma.Liotti G (1994). La dimensione interpersonale della coscienza. Nuova Italia Scientifica, Roma.Liotti G, Monticelli F (2008). I sistemi motivazionali nel dialogo clinico. Il manuale AIMIT. Raffaello
Cortina Editore, Milano.Safran JD, Muran JC (2000). Negotiating the therapeutic alliance: A relational treatment guide. Guilford
Press, New York. Tr. it. Teoria e pratica dell’alleanza terapeutica. Laterza, Roma 2003.Semerari A (2000). Storia, teorie e tecniche della psicoterapia cognitiva. Laterza, Roma.Semerari A (1991). I processi cognitivi nella relazione terapeutica. Carocci, Roma.Weiss J (1993). How psychotherapy works: Process and technique. Guilford Press, New York. Tr. it. Come
funziona la psicoterapia. Bollati Boringhieri, Torino 1999.