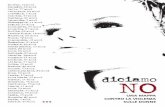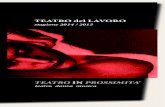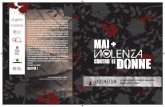Relazione Unità B Università della Calabria “Violenza ... · violenza di prossimità e le sue...
Transcript of Relazione Unità B Università della Calabria “Violenza ... · violenza di prossimità e le sue...

Relazione Unità B Università della Calabria “Violenza, relazioni di genere e intimità nel comprensorio cosentino” Riunione Roma 5-6 luglio 2012
Componenti del gruppo di ricerca: Giovanna Vingelli, Franca Garreffa, Sabrina Garofalo, Donatella Viola, Donatella Barazzetti. Osvaldo Pieroni Responsabile dell’unità locale: Giovanna Vingelli
1. Obiettivi Il programma di ricerca ha inteso analizzare alcuni dei processi attraverso cui si creano le condizioni dello scatenarsi della violenza tra adulti nell'ambito delle relazioni di prossimità e le questioni che i rapporti violenti pongono al processo di trasformazione delle identità di genere, alla ridefinizione degli equilibri tra i sessi, e più in generale alla possibilità di disegnare nuovi spazi di libertà e di cittadinanza per uomini e donne. La violenza di genere interroga queste categorie su piani molteplici e mette in questione l'inadeguatezza di analisi (e di politiche) che tendono a ridurla a un problema di sicurezza, e di ordine pubblico, o a ricondurla a specifiche dinamiche devianti senza cogliere la portata generale che essa riveste nella ridefinizione di alcuni caratteri fondanti della modernità. In particolare la violenza di genere, incidendo sui processi di democratizzazione del privato e dell'intimo, influenza la ridefinizione dei significati, delle gerarchie e dei confini tra dimensione pubblica e privata, tra dentro e fuori. Abbiamo scelto due campi di ricerca particolarmente significativi:
- le donne immigrate presenti negli ambiti della relazionalità domestica: una presenza che ci interroga sulla molteplicità delle forme e dei significati della violenza: come componente delle relazioni con la società di accoglienza, come componente nelle relazioni con il proprio gruppo di appartenenza nell’emigrazione e come componente delle relazioni nei paesi di origine;
- i maschi adulti, le loro rappresentazioni, interpretazioni ed eventuali esperienze di violenza L'indagine mira a comprendere le trasformazioni relative alle identità e ai ruoli maschili nell'ambito delle relazioni di intimità e a cogliere il nesso tra queste e l'emergere di differenti forme di violenza.
Risultati attesi Gli esiti della ricerca possono costituire un utile supporto tanto sul piano della conoscenza, che su quello della produzione normativa e dell'agire istituzionale. I risultati dei due ambiti di ricerca dovrebbero consentire di tematizzare come la violenza di genere possa incidere nei processi di trasformazione della cura e del privato in una dimensione globalizzata e di mettere in luce la molteplicità dei significati e delle forme di violenza che accompagnano percorsi altamente segnati dalla ridefinizione delle identità, delle appartenenze, dei riferimenti materiali e culturali. Inoltre ci attendiamo di gettare luce sulla percezione e sulle rappresentazioni relative a coloro che agiscono la violenza.

2. Metodologia adottata Per quanto riguarda l’indirizzo di ricerca relativo all'analisi delle rappresentazioni, interpretazioni ed eventuali esperienze di violenza di genere nei maschi adulti, la metodologia scelta è quella delle interviste a uomini non direttamente o non esplicitamente coinvolti in episodi di violenza. A differenza delle donne che subiscono direttamente violenza, infatti, la possibilità di intervistare uomini adulti che abbiano avuto comportamenti violenti riconosciuti è particolarmente difficile. Abbiamo ipotizzato perciò di utilizzare come strumento d'indagine interviste in profondità raccolte tra uomini eterosessuali e omosessuali (questi ultimi, in particolare, come gruppo "di riscontro" rispetto ai percorsi di costruzione e di percezione della violenza di genere da parte di soggetti maschili, nel caso in cui la violenza non si eserciti sulle donne, ma su altri maschi). La difficoltà di individuare una traccia di intervista ha suggerito al gruppo di lavoro di avvalersi preliminarmente dello strumento del Focus group. L’analisi dei risultati dei Focus group è stata la base per le nove interviste in profondità realizzate successivamente. Le persone intervistate appartengono a fasce di età differenziate con una prevalenza di 30/45enni, e svolgono attività lavorative differenti (avvocato, poliziotto, barista, ingegnere, preside, agente di commercio, disoccupato). L’analisi dei FG e delle interviste è riportata nel paragrafo Risultati conseguiti/nodi teorici Per quanto riguarda le donne straniere, nel nostro paese le ricerche e gli studi sul fenomeno della violenza subita in ambito domestico dalle donne italiane è a buon punto1. Diversamente, risultano scarsi gli studi e le analisi relative alle violenze subite sul posto di lavoro così come nelle coppie omosessuali e la violenza alle donne straniere, trascurate se non addirittura ignorate o studiate abitualmente in quanto vittime di tratta. Nell’ambito dell’unità di ricerca dell’Università della Calabria inserita nel progetto Prin abbiamo iniziato a colmare questa carenza che ha fatto si che le donne straniere (non solo quelle vittime di violenza) siano spesso conosciute attraverso false rappresentazioni, e modi di pensare mai verificati. La violenza consumata contro queste donne non solo dentro le pareti domestiche, è nascosta e raramente è stata materia di riflessione nelle molte ricerche e statistiche nazionali. Le rare analisi soprattutto da parte dei media frequentemente interpretano e riferiscono la violenza contro le donne straniere come espressione di culture arretrate, scontro di civiltà e fondamentalismo religioso, senza prendere in considerazione che vi sono paesi in cui la condizione della donna è peggiore rispetto all’Italia come anche paesi in cui è di gran lunga migliore.
Quali donne abbiamo avvicinato? Abbiamo chiesto l’intermediazione dell’Associazione Baobab di Cosenza che riunisce e rappresenta un coordinamento di associazioni riunitesi per la promozione dei diritti dei migranti. Al suo interno sono presenti rappresentanti di associazioni di migranti, tra cui diverse donne sia straniere che italiane provviste di qualifica di mediatrici culturali. Sono state le mediatrici culturali di questa associazione a consentirci i contatti.
Chi sono le immigrate che abbiamo incontrato? Abbiamo intervistato 14 donne che sono partite dal Nord Africa, est Europa e Sud America. Immigrate che provengono sia da zone agricole, ma anche da grandi città. Diverso è il loro livello di scolarità, alcune sono analfabete, altre non solo hanno già conseguito una laurea nel paese di origine ma sono a Cosenza anche per motivi di studio. Molto diverso ed eterogeneo risulta, in loro, l’attaccamento alla tradizione e a determinate norme culturali, non si possono riferire caratteristiche omogenee. Abbiamo ascoltato donne che si sono ribellate a matrimoni imposti ma anche donne che in genere sono state complici della tradizione e del bisogno di matrimonio come realizzazione sociale da affermare anche nel ruolo di madre.
Cosa accomuna queste donne così diverse tra loro? quello che raccontano. Mariti che picchiano, che se la prendono con le mogli per futili motivi, che si ubriacano sistematicamente e vivono in casa in uno stato
1 Cfr. Indagini Urban Rete antiviolenza e Rafforzamento Rete antiviolenza condotte in 26 città italiane e le indagini Istat sulla sicurezza dei cittadini.

di alterazione mentale – che non rispettano in generale le donne e pretendono di fare sesso oltre fare accettare alle mogli donne che frequentano fuori casa o che prendono il loro posto quando la violenza induce le mogli ad emigrare. Qualche donna ha scoperto che mentre era in Italia a lavorare, il marito l’aveva rimpiazzata con un’altra donna anch’essa mantenuta con le rimesse mandate dalla moglie dall’Italia. Queste donne, tradite sistematicamente, anche se non amano più i mariti, non accettano tranquillamente tale condizione e soffrono per essere seconde in tutto, soprattutto nella sfera degli affetti oltre ad essere schiacciate dai pregiudizi e dall’atteggiamento di disprezzo dei loro mariti.
Poiché il contributo delle donne che subiscono violenza è fondamentale per la comprensione del fenomeno, per lo sviluppo e l’empowerment non solo delle donne vittimizzate ma anche dei servizi deputati a sostenerle, attraverso le interviste a donne che avevano dichiarato di aver subito violenza, abbiamo cercato di comprendere possibili modalità di contrasto del fenomeno.
3. Risultati conseguiti/nodi teorici Abbiamo ritenuto particolarmente utile il suggerimento teorico di Consuelo Corradi di leggere la violenza di prossimità e le sue implicazioni più generali a partire da tre livelli di analisi: quello micro, meso, e macro. 3.1 Gli uomini adulti Per quanto riguarda la dimensione del maschile, l’impostazione della ricerca, rivolta a maschi adulti non direttamente coinvolti in episodi di violenza, non ci consente di individuare elementi di analisi a livello micro. Le interviste consentono di mettere in luce le rappresentazioni che della violenza di prossimità hanno le persone intervistate, e più in generale le rappresentazioni e le percezioni che essi hanno dei rapporti di genere e della violenza come dimensione complessiva, ma non danno indicazioni su percorsi ed esperienze concretamente attraversate. Tra i molti suggerimenti interpretativi proposti dal documento di Consuelo Corradi due soprattutto sembrano particolarmente rispondenti ai contenuti della nostra ricerca: a) A livello meso chi sono i “soggetti percepiti come deboli”; b) a livello macro quali processi di trasformazione sociale si presentano come generatori di violenza agli occhi degli intervistati. Alcune importanti parole chiave sembrano emergere nel nostro percorso di ricerca: vulnerabilità/fragilità e potere/ perdita. Come vedremo in modo più articolato, le categorie di vulnerabilità/fragilità mettono a tema l’articolazione e la complessità delle rappresentazioni attraverso cui vengono “costruiti” e individuati i “soggetti deboli” implicati nella violenza di prossimità, soggetti non sempre o non necessariamente identificati solo con le donne. La vulnerabilità appare un carattere legato soprattutto alle donne e a una idea di potenzialità inscritta nel femminile, la fragilità emerge invece come un vissuto del maschile legato a una specifica condizione del presente, ai processi che sembrano mettere in discussione la centralità sociale del maschile stesso. La perdita riassume e sintetizza un sentire diffuso che identifica la dimensione della violenza, e non solo della violenza di genere, come componente interna al cambiamento profondo tra un recente passato e il presente. Alcuni intervistati individuano questo cambiamento come rottura del sistema di valori, delle regole, spesso dell’ordine sociale precedenti. Altri lo interpretano come interazione tra mutamento e continuità. In entrambi i casi la violenza è sentita come una espressione intrinseca a questo percorso. La perdita è messa in tensione con il ‘potere’ che però non viene o viene difficilmente tematizzato e riconosciuto come tale.

LIVELLO MESO a) Vulnerabilita/fragilità
La vulnerabilità è, nelle scienze sociali, una categoria interpretativa che rimanda alla dimensione della “potenzialità”: non necessariamente si traduce in una condizione concreta di svantaggio, di violenza, di subordinazione. Rimanda però a condizioni sociali, economiche, culturali, simboliche, individuali che espongono il soggetto (vulnerabile) alla caduta e alla perdita. Vulnerabilità è appunto ciò che ci espone alla potenzialità della ferita. Come dice uno degli intervistati “Alla fine siamo tutti vulnerabili, …… ma ci sono persone che fanno in modo che la loro vulnerabilità sia più protetta e altri invece che sono più esposti . Ad esempio gli uomini sono allenati a nasconderla (…) mentre le donne sono messe là e giudicate” . (Massimo, barista, 30 anni) Possiamo dunque pensare le donne come soggetti vulnerabili rispetto alla violenza di prossimità? In che misura le rappresentazioni dei rapporti di genere che emergono dalle interviste le “costruiscono” come soggetti vulnerabili? E quando questa condizione potenziale si può tradurre concretamente in violenza agita? La vulnerabilità femminile che emerge dalle interviste è densa di contraddizioni e di ambivalenze, ed entra in tensione con le rappresentazioni della fragilità maschile. I “soggetti deboli” sembrano moltiplicarsi e non appaiono immediatamente identificabili solo con il femminile. Forse uno degli elementi di interesse di questa parte della ricerca è rintracciabile proprio nelle modalità con cui le interviste maschili compongono il quadro della vulnerabilità femminile, che viene letta attraverso molteplici facce della collocazione delle donne: il lavoro, la famiglia e la cura, il corpo e la sessualità, l’impatto con la violenza. Ognuna di queste dimensioni è attraversata da ambivalenze e contraddizioni profonde. Il lavoro Le donne sono ormai entrate a pieno titolo nel mondo del lavoro. In termini astratti non c’è campo in cui le donne non possano entrare. Ma concretamente esse sono fortemente discriminate. E le ragioni di questa discriminazione oscillano tra il riconoscimento di profonde cause sociali e culturali e il rimando, ricorrente, a una intrinseca debolezza del femminile, a una visione che naturalizza le donne riconducendole a un loro essere meno adatte per certe attività o addirittura a elemento di disturbo per l’equilibrio delle regole del lavoro: corpi ingombranti nelle reti delle relazioni e della solidarietà maschile.
- In certe professioni, sottolinea un giovane avvocato, le donne sono discriminate: si ha meno fiducia in loro, si è diffidenti, le si tratta con minor rispetto, non si riconoscono le loro competenze, l’uomo è piu razionale e quindi ci si rivolge a lui se si vuole qualcosa in più. Anche posizioni apparentemente molto diverse che, partendo dalla propria esperienza personale, riconoscono le donne forti, presenti, e con le stesse possibilità di carriera non mettono a tema il riconoscimento di una avvenuta condizione di parità: le donne riescono perché sono privilegiate, sono esentate da certi servizi, non lavorano di notte, sono tutelate rispetto alla maternità. Sono utili, ma lo sono per caratteristiche naturali: relazionalità, gentilezza e soprattutto per l’immagine che gli altri hanno del femminile Una apparente posizione vincente delle donne non significa dunque che le donne siano vincenti sul lavoro: se lo sono è perché sono tutelate in quanto, comunque, diverse dagli uomini. Se non sono protette, sono deboli e sfruttate, e comunque non adatte per natura a svolgere certi tipi di lavoro che richiedono forza, determinazione ecc. Questa ambivalenza non ricorre solo nelle interviste dei più giovani, si fa strada anche in posizioni apparentemente politically correct di intervistati più anziani, spesso fortemente acculturati. Gli elementi del processo di naturalizzazione del femminile pongono quindi in luce non le competenze che le donne sul lavoro possiedono, ma i caratteri della natura femminile (il mammismo, la gentilezza, la relazionalità, la debolezza, la sottomissione).
- Un secondo importante elemento è il fatto che le donne in molte attività mettano in qualche
modo in crisi i codici relazionali e lavorativi instaurati tra uomini. Nell’attività commerciale di un intervistato ci sono meno donne perche “nel primo approccio il cliente è più a suo agio verso un uomo” . Ma è soprattutto a livello decisionale che nasce il problema: “tu hai bisogno di

qualcuno che ti spalleggi, che condivide… allora è più semplice una amicizia maschile, è piu semplice trovare tra uomini complicità, è una dinamica generale, dalla politica. (Luca, promotore finanziario, 40 anni) -.
- C’è però una dinamica ancora più sottile che pone interrogativi sulla presenza femminile nel lavoro. Ed è il problema della dimensione sessuale, e del suo nesso stretto con la carriera e le competenze: le donne infatti potrebbero essere più ascoltate perché usano la seduzione.
Emerge in queste interviste, pur cosi diverse tra loro, e spesso fatte a persone che potremmo definire “progressiste”, un sostrato culturale profondo in cui la donna appare un elemento di disturbo che altera le relazioni maschili nel mondo del lavoro. Molti elementi che scaturisconoi da queste interviste rimandano dunque a un inestricabile intreccio tra lavoro/corpo femminile/seduzione/svalutazione/ disturbo, mettendo in luce come le fragilità, le discriminazioni sul lavoro che le donne subiscono, siano rese ambivalenti e “scivolose” a causa di sedimenti culturali che riconducono le donne alla corporeità e allo “scandalo” che il loro corpo sembra continuare a suscitare nella dimensione pubblica. Si compone cosi un primo importante elemento che contribuisce a costruire i caratteri della vulnerabilità femminile. Non a caso in alcune interviste questo elemento viene messo in rilievo esplicitamente. Corpo, seduzione Alcuni intervistati in modo esplicito sostengono che la responsabilità di una condizione di debolezza sul lavoro e non solo e’ (anche /soprattutto?) delle donne: si tirano indietro, non entrano negli organi direttivi, si occupano di comitati pari opportunità invece che di politica o di farsi eleggere negli organi dirigenti. Ma soprattutto sono responsabili della propria immagine e del proprio decoro, per cui appaiono inaffidabili, perché non rispondenti a canoni di abbigliamento adatti alla professione. Emerge, ancora una volta, l’idea del corpo femminile come “scandalo” o come “provocazione” cosa che sarà ulteriormente ribadita rispetto agli omosessuali (altri corpi che fanno scandalo): per essere riconosciuti e accettati occorre rendere invisibile la propria diversità, soprattutto quella inscritta nei corpi. Questi aspetti ci paiono rilevanti nel ripercorre le modalità con cui gli intervistati “costruiscono” la vulnerabilità femminile. Rimandano al corpo come luogo per eccellenza della potenzialità del vulnus (la violenza materiale, le torture, l’annientamento dell’umano, la razzizzazione dell’altro si inscrivono nella corporeità – Siebert, Guillaumin, Levi). E’ in questo senso che il corpo femminile porta impressa, nelle modalità con cui viene socialmente costruito, la potenzialità della violenza, la sua vulnerabilità (Guillaumin, de Beauvoir, Pateman, Butler, Cavarero). Il corpo femminile non viene costruito come vulnerabile in astratto, viene costruito come tale nella concretezza dell’agire quotidiano, in primo luogo agli occhi degli uomini, e per rispecchiamento agli occhi delle donne stesse che “si socializzano” a questa costruzione. Anche quando gli aspetti della debolezza femminile vengono ricondotti alla disparità dell’organizzazione sociale, quello che colpisce è la ricorrenza con cui, in ogni intervista, accanto alle dimensioni socio/economiche emergano - quasi incontrollati - gli elementi di un destino incardinato nella natura femminile. “se non ci sono gli asili nido lei non può lasciare il figlioletto, è un cordone ombelicale e la donna a un certo punto è costretta a rinunciare all’incarico. Questa mancanza di attività collaterali di sostegno alla famiglia fanno si che poi la donna ne paga le conseguenze. (…) Il maschietto il cordone ombelicale non ce l’ha, è un fattore.” (Giulio Preside, 63 anni) La violenza Con riferimento specifico alla violenza, nelle interviste e nei focus group questa non è generalmente tematizzata nelle sue implicazioni di genere. Il discorso assume connotati di forte astrazione, si

intellettualizza e ricorre al ‘sapere esperto’, sottolineando una presa di distanza dall’argomento. La violenza è soprattutto psicologica, quella fisica non è messa a tema, o viene immediatamente tacitata, cambiando discorso. La violenza per strada esiste, ma secondo gli intervistati è ignorata per paura e per mancanza di solidarietà, un valore che si è perduto. Soltanto uno degli intervistati (Antonio, ingegnere, trentenne) fa riferimento alla conoscenza diretta di un caso di violenza (la famiglia del vicino che per tutta la vita ha usato violenza contro la moglie e le figlie), caso che viene però proposto come “scelta” della donna che decide di accettare la sua condizione, per paura ma soprattutto per fede religiosa - non è possibile mettere in crisi valori e legami familiari. In ogni caso una situazione che richiede di non giudicare o intervenire in quanto scelta della donna. Per un altro intervistato (Antonio, avvocato, 35 anni), la violenza contro le donne nasce dalla mancanza di parità e dalla loro debolezza sul lavoro, che è la causa diretta della discriminazione e di un trattamento ‘inadeguato’. Per contrastarla occorrono punizioni adeguate perché è importante proteggere chi è in condizione minus. In questo senso è interessante il cortocircuito che si crea tra violenza-protezione-inferiorità: la violenza non è accettabile perche colpisce chi è in stato di inferiorità e dunque bisognoso di protezione, come le donne. Anche da parte di chi per mestiere (poliziotto) viene concretamente a contatto con la violenza sulle donne - soprattutto quella tra le pareti domestiche - e tematizza la violenza fisica, psicologica e lo stupro, la concretezza della violenza - fisica e sessuale - la sua drammatica pesantezza nei confronti delle donne non è veramente messa a tema. Viene piuttosto riportata a dimensioni che non hanno al centro del discorso le donne e l’offesa loro arrecata: di questa violenza le donne sono in parte responsabili. Le più esposte sono soprattutto le giovani che hanno modi di vestire e comportamenti che le espongono al rischio della violenza. Il richiamo generazionale rispetto al tema della violenza è invocato molto sovente: la violenza è in generale messa in connessione con la perdita di valori, con la mancanza di controllo e autocontrollo da parte dei giovani, con la libertà dei loro costumi: cosa che espone soprattutto le giovani donne al rischio della violenza. Molto importante è il nesso con la perdita di valori, della disciplina insiti nel carattere maschile tradizionale: di fatto le donne erano più garantite in una condizione di forza del maschio. Infine, per un altro intervistato, la discriminazione e la violenza si situano a livelli diversi, c’è la violenza evidente, dichiarata che uccide e violenta, ma c’è anche una violenza più subdola, che non uccide ma avvelena la vita delle persone attraverso l’inferiorizzazione e il disconoscimento. La fragilità maschile Le interviste rimandano non soltanto ai percorsi di trasformazione del femminile, ma ai cambiamenti che segnano nel presente la figura maschile. Ne emerge un quadro molto variegato che si gioca intorno alla diversa percezione del nesso tra rottura e continuità. Un intervistato (Giulio, preside, 63 anni) individua la crisi profonda della figura maschile soprattutto nelle giovanissime generazioni. Sono i ragazzini che appaiono disorientati, senza riferimenti a fronte a un maschile tradizionale tramontato e a coetanee più brave, determinate, proiettate verso una propria realizzazione. Il ragionamento tuttavia è continuamente attraversato da un confronto maschile/femminile fortemente contraddittorio. Il maschio tradizionale, la figura patriarcale, il potere maschile nella famiglia non ci sono più e tuttavia questo potere non era fino in fondo sostanziale, poiché nella casa tradizionale chi aveva giurisdizione reale sul vivere quotidiano erano le donne. L’uomo si illudeva di gestire un potere, veniva rappresentato come “potente” , ma era la figura femminile al centro della famiglia. Quello che si è spezzato e renderebbe difficile oggi posizionarsi per i giovanissimi uomini è il dissolversi di questo modello ambivalente: Ma i ragazzi si trovano esposti anche a un altra e forse ancor più difficile trasformazione, quella delle ragazze ormai preminenti nella scuola. Qui non si tratta solo di perdita di riferimenti simbolici, si tratta di un confronto quotidiano nella concretezza della vita scolastica: Sono aspetti noti e messi in luce da molteplici ricerche. Emerge però qui, nella costruzione del discorso, un elemento che abbiamo visto ricorrere ampiamente nelle interviste. La preminenza femminile non è fino in fondo vista come una vera conquista, non è il riconoscimento pieno di nuove capacità, se mai è una maggiore capacità di adattarsi ad un contesto conoscitivo più

scadente, a cui “sono stati tolti i contenuti”. I ragazzi sono meno capaci di adattarsi: sono più rozzi forse ma, persi nelle loro fantasie, ‘in fondo’ si sottraggono alla mediocrità. Il problema appare la maggiore complessità del mondo contemporaneo, che richiede probabilmente strumenti diversi da un contesto un tempo lineare, in cui ruoli e appartenenze erano chiari e semplici. Oggi la confusione è soprattutto intergenerazionale. La separazione di ruoli e funzioni, cosi evidente nel passato, oggi è andata in frantumi soprattutto nel passaggio tra generazioni diverse. L’aspirazione ad una “eterna giovinezza” delle vecchie generazioni confonde confini e limiti. Per altri la fragilità maschile non è un dato generalizzabile. Si è fragili quando si ha la consapevolezza di non avere la forza che si crede di avere (ad esempio nel lavoro, nel raggiungere il successo). Esiste però un altro elemento problematico: la dimensione sessuale. “Nell’uomo la sessualità spesso si manifesta come possesso della donna, il possesso, la proprietà, essendo la sessualità legata all’istinto. Ad esempio che cosa è che ti attira anche in uno che non conosci? quindi è difficile che ci fosse il secolo scorso la crisi dell’uomo” …” (Luca 40 anni) L’intervistato lo ha scoperto grazie a un film che gli ha aperto gli occhi. Emerge qui un elemento chiave intorno a cui ruota una parte importante delle rappresentazioni della fragilità maschile quello appunto della sessualità, che assume aspetti molto articolati: la difficoltà a riflettere su questo terreno come esperienza personale, il carattere naturale, istintuale che viene attribuito alla sessualità. Attrazione, possesso si inscrivono in una naturalità che ne giustifica le implicazioni: era difficile che ci fosse crisi dell’uomo nel secolo passato, - afferma un intervistato - perché è solo adesso che questa naturalità viene messa in discussione come problematica. La sessualità maschile si confronta inoltre con il percorso di emancipazione delle donne che ha cambiato le regole del corteggiamento. E’ sul piano del controllo delle relazioni di intimità che si pone il problema; fondamentale appare definire chi detiene il “diritto di approccio”. La perdita di questo diritto mette in scacco gli uomini che non sono più in grado di disporre di codici ‘sedimentati e testati’. Per un intervistato i maschi sono cambiati ‘in peggio’, hanno perso un po’ della loro sicurezza, hanno perso l’egemonia; la mancata elaborazione di questa perdita produce paura e nel vuoto si insinua la violenza. La perdita di egemonia avrebbe dunque un nesso fondamentale con la trasformazione dei costumi sessuali e con la libertà sessuale femminile. I rapporti sessuali – secondo alcuni - diventano un confronto a distanza, tutto giocato in termini fantasmatici e non reali, con gli altri uomini che lei ha conosciuto ‘prima’. Attraverso il corpo femminile passa il confronto con gli altri maschi, non solo in termini di concorrenza per la conquista di un corpo femminile, ma sul piano del paragone - concretamente inciso nella memoria e nella intimità di quello stesso corpo. Si è costretti al confronto senza poterne sondare e controllare l’arbitraggio. In questo passaggio sono soprattutto i più giovani, la generazione dei 30/35enni che si percepisce “déplacè”: “È una generazione strana. Perché risente di quella precedente ma cerca di aprirsi a quella nuova. Per quanto mi riguarda, con difficoltà. Perché io a volte dico di essere Clark Kent che viene da una cripta perché non mi trovo su tante cose. Adesso, come dicevamo prima, i più giovani, quelli della mia fascia d’età hanno un comune sentire perché più o meno vengono da genitori che appartengono e che hanno dato delle indicazioni, più o meno., hanno la coscienza formata, con delle idee, più o meno giuste però…. Le nuove generazioni, però sono cambiate ed io penso anche per le figure dei genitori che sono cambiate. Questo forse anche per il movimento femminista e questa voglia di emancipazione della donna, ecco. Forse il tentativo di emanciparsi troppo dimentica alcune cose. (…) E quindi credo che i giovani, la fascia d’età dai 20 21, 23 anni sono abbandonati a se stessi, cioè privi di questi valori, di indicazioni, di percorso: il rispetto degli altri, l’educazione in senso stretto, l’amicizia, l’amore” ( Antonio avvocato 35 anni.) L’immagine di Clark Kent è particolarmente calzante: spiazzato, un po’ impacciato, frastornato dall’appartenenza a un altro mondo, ma sotto questo aspetto incerto si nasconde pur sempre Superman!

LIVELLO MACRO a) Perdita/potere Per quanto riguarda le dinamiche sociali più ampie, emergono posizioni contraddittorie con riferimento al rapporto pubblico/privato. La consapevolezza che, per le donne, la parità sia problematica nell’ambito del mercato del lavoro e dei luoghi decisionali si accompagna spesso a una visione del privato come luogo tradizionalmente e per eccellenza del potere femminile. Il potere – e le relazioni di potere – tuttavia non sono nominate, o non sono tematizzate come oggetto di discussione e di riflessione. Le discriminazioni subite dal genere femminile sono oggettivate (attribuite astrattamente alla società), mentre non sono messe a tema le dinamiche di conflitto, di legittimazione e di subordinazione L’assenza di una riflessione sui rapporti di potere comporta che le relazioni di genere siano interpretate come una articolazione di funzioni (in particolare nel privato) in cui prevale il carattere di complementarità Emerge, in ogni caso, la consapevolezza di un processo di trasformazione sociale in atto, a partire dagli anni ‘60. Le interviste registrano i mutamenti nei ruoli di genere, esprimendo, allo stesso tempo, la difficoltà di interpretare questi mutamenti in una dimensione relazionale; la non individuazione del nesso tra pubblico e privato è il sintomo per eccellenza di questa difficoltà. Inoltre, il cambiamento è tematizzato soprattutto rispetto ad un modello maschile pensato come universale, a cui le donne fanno riferimento per ‘emanciparsi’. Nelle generazioni precedenti la donna aveva molto più potere in famiglia e soprattutto i valori presenti proteggevano la donna o comunque ritualizzavano la violenza nel senso di una regolazione rigida dei comportamenti tra uomini (e dei comportamenti femminili), mentre nelle nuove generazioni non esistono più valori, c’è incertezza, non esiste più una ‘ritualizzazione’, un disciplinamento dei comportamenti: questo rende la violenza incontrollabile non solo rispetto alle donne, ma come componente sociale generalizzata. In un certo senso si sarebbe rotto quel processo di civilizzazione (Elias) che fa coincidere civilizzazione e imbrigliamento della violenza sia livello sociale che nell’intimo (Freud – la civiltà possibile solo imbrigliando le pulsioni; Marcuse - eros e civiltà). E’ da questo punto di vista che il modello “repressivo” (Stella) che rendeva residuale la violenza (Elias, Freud) renderebbe difficile mettere in luce come la violenza sia oggi una componente intrinseca ai processi di trasformazione in atto. Questo processo di trasformazione viene percepito e letto dai nostri intervistati in modi differenti a seconda dell’età. I meno anziani, che si percepiscono come “generazione di mezzo”, la vivono come rottura di equilibri generazionali, (in questo senso la “generazione di mezzo” si colloca tra i valori dei genitori/nonni e i non valori le nuove generazioni di giovanissimi), rottura di trasmissione di valori, dissoluzione delle regole e dei modelli sessuali tradizionali, con una conclusione sorprendente: in qualche modo le donne la violenza se la vogliono, in passato perche colpiva chi trasgrediva il modello vincente, adesso perché la libertà di comportamenti porta inscritto al proprio interno il rischio. In questo senso la vulnerabilità femminile oggi viene inscritta da questi uomini nella dimensione della libertà femminile. La stessa fragilità maschile si inscrive nel processo di liberazione femminile, che rende gli uomini incerti nella definizione di sé. Un tema questo che richiederebbe il confronto con le narrazioni che della violenza subita fanno le donne. Da molte ricerche con donne intervistate sulla violenza ciò che viene messo a tema non sembra essere il nuovo rapporto con la dimensione pubblica che le donne attraversano; la violenza resta soprattutto uno scacco femminile nell’intimità – intesa non solo o non tanto come il privato o la famiglia, in quanto dispensatrice di cura, dove il cambiamento in meglio è comunque evidente, ma nell’ambito della “fisicità” delle relazioni. Quello che cambia rispetto al passato, probabilmente, è il fatto che la visione della violenza passi da condizione sentita come “naturale”, connaturata alla condizione di sottomissione delle donne, a

componente socialmente costruita, e antagonista alla collocazione femminile. In un certo senso, prima ancora di essere interpretata come una reazione degli uomini alla perdita di potere maschile, è interpretata come segnale del processo di de-naturalizzazione del femminile operato in primo luogo dal femminismo, ma non ancora elaborato da molta parte del maschile, come ci dicono le interviste maschili di questa ricerca .
3.2 Le donne straniere che hanno subito violenza nel paese di origine e nella migrazione I fenomeni migratori espongono qualsiasi individuo a grandi cambiamenti: divisioni familiari e in particolare dai figli, difficili condizioni materiali di vita, incertezza del futuro. Vi sono dunque difficoltà concrete relative all’inserimento in un nuovo paese ma anche difficoltà legate all’esigenza di elaborare valori e modelli culturali diversi e contemporaneamente lo sforzo di giocare continuamente una duplice appartenenza. All’interno di questa analisi, seguendo la proposta teorica di Consuelo Corradi si propone una lettura dei livelli macro, meso e micro attraverso i concetti chiave di vulnerabilità/fragilità. La violenza è un tema che attraversa le storie di vita, anche quelle riconoscibili come positive, delle donne migranti intervistate. Dai loro racconti a) risulta utile mettere a tema la trasversalità della dimensione della sofferenza e del dolore, che si manifesta e si riconosce in diverse modalità e situazioni. b) è possibile distinguere: - Violenze di bassa intensità ma attese e abituali che si esplicitano con atteggiamenti e idee di inferiorità delle donne, interazioni ed espressioni che per quanto a livello pubblico non trovano più accoglienza non sono invece scomparse nelle coscienze individuali: sono molti, tra gli uomini descritti, coloro i quali nel privato delle pareti domestiche continuano a dichiararsi e comportarsi in maniera sessista. Una donna dell’est Europa definisce il suo ex un “vampiro psicologico” che risucchia le sue energie e fa in modo di farla sentire sempre in colpa: qualsiasi cosa tu faccia è sempre quella cosa sbagliata, solo loro hanno ragione e tu invece sei nulla…”. - Violenze di elevata intensità e inattese anche se non sempre riconosciute come tali dalle intervistate. A fronte di molti racconti di tale grado di violenza e prevedibilità, la definizione dipende dell’esperienza individuale. Inaspettato è per una donna brasiliana, lo sguardo del suo patrigno che faceva il carabiniere, quando ha iniziato a guardarla diversamente, con uno sguardo che non era quello di un padre. L’uomo le parlava spesso di cose erotiche, lasciava la porta del bagno aperta perché lo vedesse nudo mentre si masturbava. - Violenze di bassa intensità e inattese come quelle riferite da una ragazza africana che usciva con uno studente universitario italiano che inaspettatamente fermò la macchina, chiuse tutte le sicure dell’auto ed iniziò a baciarla, allungare le mani, sfilarle contro la sua volontà la maglietta. Più lei provava a distoglierlo, più lui diventava nervoso: sbatteva le mani ai sedili della macchina, sullo sterzo, diventava troppo nervoso, sudava, addirittura … finché non ho cominciato io a piangere … Poi io gli dicevo <<tu sei uno stupratore>>, e poi lì ha smesso lui ….In quel momento la ragazza ebbe la sensazione di non riconoscere più quel ragazzo all’apparenza gentile, che parlava, chiacchierava, dalla mentalità aperta, umile, che cercava di capire con disponibilità ed apertura la sua cultura. - Violenze di elevata intensità e attese come quelle che più di una intervistata contestualizza nella sua famiglia. In particolare una di queste donne asserisce che nel suo paese di origine era normale. Racconta che il padre la picchiava spesso, vi erano giorni in cui era ubriaco, ma anche quando non beveva era ugualmente violento e alzava lo stesso le mani, senza alcun motivo: ogni minima cosa lo potesse irritare, ogni minima cosa... Ricorda i racconti delle sue compagne di scuola che subivano e soffrivano le stesse violenze che vedevano protagonista in casa sua tutti i giorni il padre. In Italia conosce un ragazzo italiano che all’inizio sembrava solo un po’ geloso, dopo invece … più tardi, quando per un motivo pure banale, lui aveva degli scatti … E’ come se qualcosa avvenisse nella mente di lui, che non si capiva che cosa era. A livello interpretativo, l’approccio seguito è quello intersezionale, includendo analiticamente la costruzione sociale delle differenze di genere, etnia e classe sociale. Tale approccio permette di

considerare le esperienze delle donne migranti differenti da quelle italiane, in quanto emergono caratteristiche peculiari legate allo stesso processo migratorio ed alle dinamiche di accoglienza. Abbiamo ritenuto opportuno combinare i tre livelli di analisi (micro-meso- macro) con tale approccio, così da poter evidenziare elementi riconducibili al binomio vulnerabilità/fragilità. LIVELLO DI ANALISI MICROSOCIALE Nelle relazioni di prossimità, a livello micro, la relazione vulnerabilità/fragilità risulta strettamente connessa alle diverse esperienze personali che sono quindi anche migratorie. Il luogo in cui più frequentemente si manifesta la violenza nei confronti delle intervistate è soprattutto la famiglia, indipendentemente dalla classe sociale, dal livello culturale, dalla religione. Laddove la violenza fisica diventa una forma comunicativa e di relazione pressoché quotidiana, si riscontrano dinamiche simili tra le donne intervistate. Da un lato vi è una continuità rispetto alla violenza subita nei paesi di partenza, e in quelli di arrivo; tra le coniugate, a tal proposito, in diverse situazioni il marito esercitava violenza sulla donna già nel paese di origine. In particolare queste donne riferiscono dei pregiudizi, sospetti su relazioni extraconiugali e violenze che molto spesso continuano con la migrazione. In taluni casi il maltrattamento rappresenta un’accettata modalità di relazione e di conseguenza alcune intervistate erano poco consapevoli dell’abuso di cui erano vittime. D’altro canto, invece, la migrazione rappresenta per alcune l’opportunità per rompere con la violenza del partner, ma non con la prosecuzione di esperienze di violenza (che a volte si ripresentano semplicemente cambiando compagno). Anche laddove vi è una rottura definitiva con la relazione di coppia violenta, alcune donne che hanno scelto di emigrare spesso continuano a vivere comunque nella paura, sottoposte a continue intimidazioni e ricatti. Una donna minacciata seriamente di morte, dopo un anno dal matrimonio abbandona la Nigeria per salvare la sua vita dalle violenze costrette a subire dal marito: non sono qui per lavoro … sono una richiedente asilo, ho bisogno della protezione di questo Stato, ammette la donna. La fuga repentina dalla Nigeria è dettata dal fatto che il marito si appiglia per vendicarsi d’essere stato lasciato, alla relazione omosessuale della moglie che non è presunta o inventata ma veramente intrattenuta dalla donna prima di conoscere il marito e il rischio per Rosemary sembra davvero serio perché avere una relazione con un’altra donna in Nigeria è proibito dalla legge, non si può, è una situazione complicata (…) Possono arrestarti e sottoporti ad un processo, da noi non è accettato. Tuttavia, pur essendo state particolarmente esposte a forme di violenza e discriminazioni, molte appaiono non solo vulnerabili ma anche protagoniste della loro esistenza. Si espongono con coraggio e alcune offrono una immagine di donna capace di opporsi al disciplinamento e violenza maschile e familiare. Forse perché in quanto straniere si sono trovate in circostanze talmente disperate, a confronto con problemi e ristrettezze che hanno colpito loro e i figli e quindi costrette a darsi coraggio. Quindi la scelta di emigrare per porre fine alla violenza in alcuni casi è solo una strategia temporanea quando le medesime dinamiche di coppia violente si ristabiliscono a seguito del ricongiungimento familiare con il partner in Italia o con il ritorno momentaneo in patria di queste donne. Sempre nel livello micro, ulteriore dinamica si riscontra nel mancato riconoscimento della violenza in quanto tale. Dai racconti emerge come, all’interno delle relazioni di prossimità una delle difficoltà sia quella di riconoscere le situazioni di violenza, legittimando come normale un certo atteggiamento e modo di fare. Alcune considerano connaturato all’essere donna il maltrattamento da parte degli uomini, persuase che la violenza faccia parte delle cose inevitabili della vita. Questo pone importanti interrogativi sui significati attribuiti alla violenza e sulle sue percezioni. Bourdieu ci dice che sia il dominio degli uomini, sia l’assoggettarsi delle donne (alcune donne), sono l’effetto della “violenza simbolica” che si esercita in modo invisibile essenzialmente attraverso itinerari simbolici della comunicazione che pre-muniscono la struttura di pensiero attraverso cui riconoscere, comprendere e distinguere l’universo. Alla base di tali schemi c’è un rapporto sociale di dominio che si è affermato storicamente e che si regge su una costante riproduzione del modello di strutture sociali ordinate secondo la divisione sessuale del lavoro. In questo senso, potremmo ipotizzare che il potere sia durevolmente in-corporato in alcune di queste donne sotto forma di disposizioni adattate [Bourdieu, 1998]. Le interviste tuttavia lasciano emergere significati molto differenziati della violenza che sembrano suggerire dimensioni interpretative non immediatamente riconducibili a questo

riferimento teorico. La percezione della violenza assume un significato differente non solo a seconda delle norme che viola ma anche delle modalità attraverso cui la donna la percepisce. Le intervistate, infatti, raccontano la violenza in maniera differente e a partire dell’esperienza vissuta. Ragionando dunque sul binomio fragilità/vulnerabilità a livello micro, in base alle interviste condotte si possono rintracciare alcune peculiarità relative alle esperienze delle donne migranti. Una prima caratteristica che determina situazioni di fragilità è la continuità con le violenze subite nei paesi di partenza. E la scelta migratoria spesso diventa un’aggravante della dimensione della fragilità, laddove vengono meno le certezze dettate dai contesti in cui si è precedentemente vissuto. Tale considerazione porta altresì a riflettere sulla percezione e riconoscimento della violenza, intesa come tutte quelle azioni e comportamenti che mortificano le donne, nella loro dimensione fisica, ma anche emotiva e relazionale. La situazione delle donne migranti nei contesti di arrivo, risente delle diverse dinamiche di potere e di dominio che si traducono nel mondo del lavoro e della sfera economica. La fragilità è in tal senso intesa come difficoltà di essere autonome ed indipendenti nella vita quotidiana, quando la presenza di figli e l’assenza di una dimensione lavorativa, impediscono di allontanarsi da un uomo violento; dall’altro lato, il possesso di un lavoro ed il guadagno possono diventare uno strumento di controllo da parte maschile, che mortifica ancora le donne. Tali considerazioni a livello micro, devono comunque essere connesse alle singole esperienze, che risentono dei legami precedenti alla partenza, ma anche al livello di consenso della violenza nei paesi di partenza, nonché alla costruzione delle differenze dei ruoli di genere e delle dinamiche di potere nelle relazioni di prossimità. Chi sono questi uomini? Profiling dell’aggressore
Molti degli uomini violenti rappresentati dalle loro vittime avevano la tendenza a minimizzare le proprie azioni e a trovare giustificazioni esterne: una provocazione della partner “voleva dividere la responsabilità con me. Io, per forza mi dovevo prendere una parte della responsabilità … , la trasgressione di regole religiose e culturali o il consumo di alcool. I comportamenti aggressivi legati all’alcol sono molto comuni in diverse nazionalità anche se l’alcol non provoca da solo la violenza ma faciliterebbe semplicemente l’azione violenta come è accaduto nei nuclei familiari delle donne straniere intervistate in cui si sono verificati episodi di maltrattamento in danno sia di mogli che di figli. Oltre l’alcool, altri problemi correlati alla violenza riscontrati dal racconto delle intervistate sono: difficoltà economiche, povertà, mancanza di un’abitazione adeguata, ritmi lavorativi molto duri o disoccupazione. Il quadro è quello di uomini che se lavorano rifiutano la responsabilità di mantenere i figli negando soldi per la famiglia e che però di fronte alle ristrettezze economiche, se la moglie decide di capovolgere i ruoli lavorando fuori casa, si sentono disonorati e picchiano. Sono dunque uomini ambigui e confusi perché nonostante la gelosia, allo stesso tempo non lasciano altra scelta alla propria moglie se non quella di cercare lavoro. Ed è proprio quando le donne si conferiscono finalmente la responsabilità economica della famiglia difendendo questa scelta, che questi uomini picchiano con modalità sempre più violente quanto più questa decisione è difficile da contrastare. In taluni casi i conflitti fra marito e moglie hanno raggiunto livelli di violenza fisica brutale e nonostante l’incapacità o il peso da parte maschile di mantenere una famiglia, alcuni continuano a non preoccuparsi della nascita di altri figli, rifiutando di contemplare o l’astensione da rapporti intimi o l’uso di mezzi contraccettivi. Quando alcune di queste donne sono rimaste incinte, hanno vissuto da sole il dramma di una gravidanza non desiderata e costrette a ricorrere persino ad aborti clandestini. Del partner una donna bulgara racconta: mi picchiava senza motivo, mi faceva tante paliate che cadevo a terra, non vedevo niente, solo vedevo le stelle, faceva male, mi lasciava per terra, mi dava pure calci, io rimanevo per terra e lui usciva e se ne andava, io rimanevo giù, però non ho pensato di fare una denuncia alla polizia, non ho pensato mai.... Ancora racconta Anna: una volta sono rimasta incinta quando mi sono messa con lui, dopo non ci sono rimasta più, perché io di quattro mesi e mezzo, mi sono andata dalla casa mia in un’altra città, c’è una distanza di ottanta chilometri, me ne sono andata, mi sono cacciata gli anelli e la collana e le ho regalate al dottore. Il dottore mi ha fatto abortire e mi ha operato, le mie trombe sono chiuse, io figli non ne posso avere più, io ho rischiato per la mia vita, perché era troppo grande, quattro mesi e mezzo. Questo dottore mi ha detto se ti succede qualcosa per morire, io non c’entro niente. Ho

parlato con il dottore, ho detto io mai voglio avere altri figli, allora il medico dice <<io ti faccio una cosa che ti ricordi di me fino a che muori che tu incinta mai più rimani>>, e così mi ha chiuso le trombe. Si, gli ho dato tutto il mio oro. Alcuni uomini che temevano di essere abbandonati, hanno instaurato ancora di più una relazione opprimente non per amore, ma per timore di perdere la propria identità. In questi rapporti, anche un minimo cambiamento teso a mettere a repentaglio la “stabilità” della coppia, ha indotto l’uomo a reagire con violenza [Hirigoyen, 2006, 127] Di fronte alle difficoltà della potenza appresa culturalmente da parte maschile, donne troppo attive, re-attive e indipendenti suscitano rancore che può sfociare in violenze che aumentano progressivamente in intensità. Questi uomini, che modelli culturali continuano a descrivere potenti, spesso non si sentono all’altezza, e di fronte a donne che sollecitano cambiamenti quali quello di cercare lavoro, decidono di demolire l’identità della partner al solo scopo di valorizzare se stessi. Colpiti dalla trasformazione di determinate condotte - prescritte generalmente per il femminile - che fino a quando rispettate hanno esercitato un’importante azione di contenimento della violenza, reagiscono con aggressività. Qualunque proposta di cambiamento nella dinamica tradizionale di coppia è vissuta come una minaccia anche per molti uomini italiani; per tale motivo sentono il bisogno di controllare ancora di più la partner racchiudendola in una situazione di coppia assolutamente totalizzante. Alcuni uomini sono ben inseriti a livello sociale. La loro violenza è insidiosa e non è nascosta ed è assolutamente strumentale, volta ad uno scopo preciso, fin’anche distruggere la capacità di pensare della partner. Per loro la donna non è una compagna ma una rivale che bisogna annientare servendosi prevalentemente della violenza psichica e se reagisce, anche violenza fisica. Vi sono anche uomini che sono eccessivamente violenti non solo all’interno della famiglia ma anche all’esterno. In particolare gli uomini italiani descritti dalle intervistate sembrano destabilizzati dal comportamento troppo “libero” della donna straniera. Da una intervista emerge ad esempio, che i motivi dei litigi con il partner italiano potevano essere: la sera volevo tornarmene a casa mia invece che rimanere a casa sua...; perché ho incontrato un amico e siamo andati a prenderci un aperitivo. Tuttavia, sovente è proprio la condizione di bisogno che risospinge molte donne straniere ad adottare “minori precauzioni” rispetto al femminile in generale, a indurle a vivere e a muoversi con maggiore libertà. E’ la ricerca di un lavoro (dettata primariamente dalla necessità e non dalla scelta) entro minori e limitate opzioni a indurre le straniere a non selezionare orari di lavoro, ambienti consoni e datori di lavoro. L’autonomia, l’indipendenza economica, la libertà di movimento per alcune rappresentano una necessità prorompente quando si è deprivate economicamente e in termini di risorse familiari e sociali in senso lato.
LIVELLO MESO
L’arrivo in un paese straniero può comportare modifiche o inversioni dei ruoli all’interno della famiglia solitamente basati sul potere e l’autorità dell’uomo (marito, padre, fratelli). Mettere in discussione le regole della famiglia semplicemente attraverso capovolgimenti di ruolo, a volte genera sensi di colpa che trovano entrambi, uomini e donne, impreparati. Affrontare tali trasformazioni, rappresenta di per sé una situazione capace di alimentare tensioni, conflitti, che possono risolversi in manifestazioni di violenza volte a recuperare potere e autorità, soprattutto quando la cultura, i costumi, le tradizioni e in alcuni casi le norme contemplano l’uso della violenza per il ripristino dell’autorità familiare. Per alcuni uomini, al mutamento di ruoli familiari che direttamente li hanno coinvolti a seguito della scelta di migrare da parte della partner, è conseguita la forte sensazione di perdere il dominio che esercitavano. E nel timore di non essere più riconosciuti come capofamiglia, hanno esasperato un atteggiamento di violenza come ultima strategia di dimostrazione del loro ruolo. In maniera speculare, per le donne che hanno fatto la scelta di emigrare provando faticosamente a conquistarsi un nuovo modo di essere donna, moglie, madre, la difficoltà di condurre la propria vita in un paese straniero associata alcune volte all’intensificazione delle divergenze con il partner, mette in conflitto anche con

se stesse. Tale conflitto è connesso agli sforzi che queste donne hanno fatto per inserirsi nella società di accoglienza. Anche intervistate che sono emigrate con il partner, si sono trovate ad assumersi responsabilità di reddito, sebbene entrambi ritenevano fossero obblighi attribuiti per cultura al maschio. Se da parte della donna, questo cambiamento non è scelto ma subito per necessità, viene gestito e recriminato come difetto e mancanza maschile. Quindi, la migrazione ha comportato per molte donne intervistate la ridefinizione e riformulazione degli equilibri familiari, non solo quando figli e mariti sono rimasti nella terra d’origine ma anche quando la famiglia è vicina. Non va sottovalutato inoltre che lasciare il proprio paese comporta un ripensamento della propria appartenenza e attaccamento alle tradizioni e valori della cultura di origine, idee sui ruoli di genere e di famiglia, identità e ruolo della donna, della madre, dell’uomo, del padre, dei rapporti di potere tra uomini e donne, ideologie del ruolo sessuale, modelli di genitorialità, regole dei legami familiari. Nel livello meso, il discorso si articola dunque sui ruoli delle migranti e dei networks familiari, ma anche sulla costruzione e percezione della femminilità e mascolinità. Sempre in questo livello, ritroviamo un forte cambiamento dei ruoli all’interno delle relazioni di prossimità che variano in base alle due situazioni prima definite: se a partire è la coppia, il cambiamento radicale si ha con l’ingresso della donna nella sfera pubblica, essenzialmente l’ingresso nel mercato del lavoro. Sempre sul piano della costruzione sociale si gioca la dinamica all’interno delle coppie formate da una donna migrante ed un uomo italiano: l’aspettativa è sempre quella della donna totalmente corpo che viene collocata dall’uomo, in una situazione di dominio. Il riconoscimento dell’autonomia (non solo economica) di queste donne causa, in base alle interviste, reazioni in cui si manifesta la volontà di ristabilire l’equilibrio di potere. Ancora, si riscontra vulnerabilità che potremmo definire affettiva, che lega la donna esclusivamente nella sfera privata tanto più quanto non vive sfera pubblica. Non più chiuse nella domesticità ma “esposte” al pubblico, nelle situazioni lavorative, le straniere in un modo alquanto particolare sono viste come prede da “adescare”.
LIVELLO MACRO
Nel livello macro, la coppia di concetti fragilità/vulnerabilità ci porta a riflettere sulla condizione della donna migrante anche nei paesi di partenza, considerando tutti i meccanismi di costruzione dell’alterità. Genere, etnia e classe sociale diventano elementi imprescindibili della costruzione di percorsi e di esperienze che determinano situazioni di vulnerabilità. Fattori culturali, sociali ed economici hanno determinato le condizioni di sottomissione e dipendenza nelle quali versavano o sono ancora immerse alcune intervistate e che costringono ad accettare diverse forme di maltrattamento alle quali sono sottoposte. Modelli educativi che vedono la donna subordinata all’uomo e dipendente, sommati a comportamenti maschili aggressivi (anche quelli sessuali) - giustificati perché connaturati alla natura dell’uomo rappresentano uno straordinario squilibrio di potere che comporta il non riconoscimento della violenza. Nella misura in cui istituzioni e pratiche sociali incoraggiano e tollerano la violenza nei confronti delle donne il contrasto al fenomeno può scaturire non tanto dalla punizione dei singoli (che deve esserci ma non incide sul fenomeno in generale ma solo nei suoi atti particolari) ma da un mutamento delle rappresentazioni culturali che riproducono nei gesti della vita quotidiana relazioni di dominio. Ipotizzando l’esistenza di una violenza strutturale, costitutiva di un ordine che coinvolge le relazioni di genere, non necessariamente queste relazioni si nutrono di una oppressione cosciente e intenzionale da parte di un gruppo contro un’altro. Foucault [1976] propone di guardare al funzionamento del potere come effetto di pratiche. Le cause della violenza nei confronti delle donne sembrano radicate in prescrizioni, simboli, pratiche e negli assunti che sottendono regole consuetudinarie che anche se messe in discussione istituzionalmente, non evitano le conseguenze collettive derivanti dal seguire comunque tali regole. Scarse relazioni sociali, dinamiche escludenti, l’abitudine a rapportarsi agli altri con diffidenza, paura, sono indicatori non solo della gravità della violenza e delle sue conseguenze nella vita di alcune di queste donne, ma anche della scarsa possibilità di ribellarsi alla violenza. Viceversa, un buon numero

di relazioni, possibilità di rapportarsi agli altri con atteggiamenti improntati alla reciprocità, all’empatia, alla solidarietà sono indicatori della possibilità di sganciarsi dalla violenza subita. La violenza contro le donne è aggravata dal giudizio e dallo stigma sociale, in particolare dalla vergogna di denunciare che è connessa alla mancanza di aiuto e protezione e all’assenza di mezzi di varia natura (economici, culturali) che contribuiscono alla perdurante presenza di tale violenza e che influenzano negativamente non solo le donne vittimizzate ma la comunità in generale. Il grado di relazioni sociali che la donna mantiene durante e/o dopo gli episodi di maltrattamento fornisce la misura del livello di diffusione e tolleranza dei comportamenti offensivi e degli abusi. L’isolamento è, allo stesso tempo, causa e conseguenza dei maltrattamenti subiti: accade spesso che l’intera cerchia dei conoscenti venga manipolata, spaventata dal maltrattante. A un certo punto, sarà la donna a interrompere qualsiasi rapporto con l’esterno per non sentirsi ulteriormente giudicata. Come afferma Hirigoyen, una donna che sta subendo violenza spesso sente il vuoto intorno, isolata dal contesto sociale, amicale e affettivo [2006, 25]. Spesso la comunità straniera di riferimento in Italia ha ricoperto un ruolo ambivalente esercitando una pressione sulla donna per aderire a canoni di comportamento della società di origine, legittimando in questo modo i comportamenti del maltrattante. Alcune hanno confessato di essersi sentite scoraggiate ad avviare una separazione dal marito per il timore di essere giudicate ed emarginate dalla propria comunità, rifiuto che configura anche una rottura con le proprie radici e la propria cultura. E’ anche questo tipo di sofferenza e la spinta a risolvere tale disagio che a volte fa ricadere nella violenza pur mutando partner. Alcune, confrontatesi con nuovi modelli di vita hanno messo in discussione il potere patriarcale così come la propria cultura. E’ anche vero che condividere modelli culturali, costumi e regole di vita che non coincidono più con quello del gruppo di appartenenza per alcune donne ha contribuito a far esplodere ulteriore violenza ma l’esperienza della migrazione modifica le reazioni alla violenza domestica. Le donne che hanno fatto esperienza con la realtà di accoglienza di un riconoscimento della condizione della donna maggiormente paritario si sono poste nei confronti degli episodi violenti in modo differente, arrivando a definire “violenza” atti che nel passato avevano subito sistematicamente. Rimane però, tuttavia, una difficoltà estrema a reagire a violenze subite anche quando si raggiunge la consapevolezza che tali comportamenti non sono “normali”, “corretti” o perlomeno “tollerabili”. 4. Punti problematici della ricerca Per quanto riguarda l’indirizzo di ricerca relativo all'analisi delle rappresentazioni, interpretazioni ed eventuali esperienze di violenza di genere nei maschi adulti, riteniamo che la riflessione relativa al livello macro richieda maggiore approfondimento e riflessione. In generale ci sembra che un ulteriore apporto di interviste sia necessario, in particolare vorremmo ampliare le interviste a omosessuali, che consentono di far emergere in modo più chiaro i caratteri di quella zona limite in cui si incontrano le rappresentazioni della violenza e la violenza agita. Per quanto riguarda le donne immigrate si ritiene importante approfondire il confronto tra donne immigrate che hanno dichiaratamente subito violenza e immigrate che non si trovano in questa condizione. Per questo sono state realizzate otto ulteriori interviste con donne provenienti da paesi dell’Est (in quanto presenza consistente nel comprensorio casentino), coniugate con uomini italiani e che non hanno, (almeno dichiaratamente) subito violenza. Queste interviste richiedono di essere ora interpretate e messe a confronto con le precedenti. Abbiamo scelto “coppie miste” intese come unioni in cui i due partner appartengono a comunità culturali differenti [Allievi, 1994], per la complessità delle tematiche che dischiudono: l’unione mista è un luogo in cui è necessaria la negoziazione e l’adattamento, dato che tale coppia è chiamata a negoziare le differenze inerenti i valori, le aspettative sociali, i ruoli da ricoprire e il “diverso modo di essere coppia” [Tognetti Bordogna, 1996]. Le differenze culturali possono costituire non solo un ostacolo ma anche una risorsa che crea legami e quindi unità [Scabini, Regalia, 1993]. E poi vi è la società che ospita (ed osserva) e l’opinione pubblica che definendo le differenze, segna socialmente. Il

matrimonio misto è un fatto pubblico perché sollecita l'immaginario collettivo e le reazioni della gente [Tognetti Bordogna, 1996]. La diversità culturale, religiosa, di modelli familiari, di tradizioni e costumi dei due coniugi esprime al contempo debolezza e forza. Debolezza perché spesso la diversità accentua le difficoltà e viene usata per giustificare la fatica di comprendersi, confrontarsi, negoziare e conciliare le aspettative e le esigenze dei coniugi. Forza perché se i componenti la coppia riescono a rispettare e a valorizzare la diversità, questa diventa un’importante risorsa familiare e i partner possono cominciare un percorso di accrescimento individuale e reciproco. La stesura del rapporto di ricerca (mesi 19-23) e il contributo al Convegno di chiusura della ricerca nazionale e di presentazione dei risultati concluderà l’iter della ricerca.