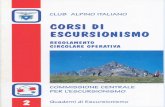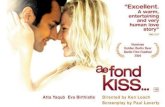Relazione Don Tonelli - Parlare Di Dio Agli Uomini - 2 Conv Naz AE Assisi 2008
-
Upload
paolo-m-grossholz -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
Transcript of Relazione Don Tonelli - Parlare Di Dio Agli Uomini - 2 Conv Naz AE Assisi 2008
-
8/9/2019 Relazione Don Tonelli - Parlare Di Dio Agli Uomini - 2 Conv Naz AE Assisi 2008
1/5
PARLARE DI DIO AGLI UOMINI:CATECHESI ED EDUCAZIONE ALLA FEDE
IN STILE NARRATIVOAGESCI 2 Convegno Nazionale AE Assisi, 29 gennaio 2008
Relazione di don Riccardo Tonelli
ALLA SCUOLA DI GESU
Si pu parlare di Dio in molti modi perch quella di Dio una esperienza fondamenta-le della esistenza umana. Vogliamo farlo per in modo corretto perch sarebbe triste parlarmale di Dio. Fa pensare la constatazione del Concilio che attribuisce al modo con cui i cristianihanno parlato di Dio una delle cause dellateismo.
Per questo, ci confrontiamo con Ges. Non solo pretende di avere lunico modo auten-tico di parlare di Dio (nessuno conosce il Padre se non il figlio); ma stato persino accusato econdannato per questa pretesa e ha accettato la morte, quando poteva scamparla. Sarebbe tri-
ste parlar male di Dio, mettendoci dalla parte dei suoi accusatori e capita spesso.
1.1. La proposta
Ges suggerisce tre cambi di prospettiva per parlare bene di Dio:
Perch parlare di Dio: solo in Dio possiamo avere vita e speranza. Dunque parliamodi Dio per produrre vita. E lontana dalle intenzioni di Ges ogni preoccupazione diproselitismo (la reazione di Ges nei confronti dei due discepoli, felici dei buoni risul-tati della loro predicazione).
Cosa dire su Dio: Ges ci rivela che Dio un padre (pap, lo chiamava lui) che ac-coglie, perdona, provoca: ama per primo e senza guadagnarci nulla e chiede di resti-tuirgli il suo amore riversandolo negli altri.
Come parlare di Dio: pi fatti che parole e i fatti sono sempre dalla parte dellavita anche quando si trattava di andare contro quello che sembrava intoccabile (ilsabato).
1.2. Ununica prospettiva
Meditando con il Vangelo in mano questi cambi di prospettiva, mi sono progressivamenteconvinto di una constatazione che desidero condividere per la sua fondamentale importanza: i trecambi di prospettiva, che fanno la novit della prassi di Ges su Dio, sono vissuti e realizzati in
Ges in modo decisamente unitario. Luno richiama laltro.Questo significa uno stile globale fondamentale: Ges parla di Dio per aiutare a vivere co-loro a cui offriva questa proposta. Non solo lo faceva mediante contenuti speciali, ma assicura-
va un modello comunicativo che fosse capace di restituire responsabilit e speranza al suo interlo -cutore.
Questo modello comunicativo era il primo e pi eloquente fatto, che aiutava a scoprire lapaternit di Dio.
PARLAREDIDIOAGLIUOMINI - AGESCI - CONVEGNO NAZ.LE AE 2008 D. RICCARDO TONELLI PAG. 1 -
-
8/9/2019 Relazione Don Tonelli - Parlare Di Dio Agli Uomini - 2 Conv Naz AE Assisi 2008
2/5
LA PROPOSTA DI UN MODELLO: LA NARRAZIONE
La proposta della narrazione come modello qualificante e originale per parlare di Diocerca di tradurre in un modello comunicativo coerente questa constatazione di fondo.
Ricordo alcune caratteristiche per forza di cose rapidissime, rimandando uno sviluppoorganico al mio saggio pi articolato (TONELLI R., La narrazione nella catechesi e nella pastorale
giovanile, ElleDiCi, Leumann 2002).
1.3. Un modello comunicativo originale
Sollecito a riflettere su quello che riferisce il cap. 15 del Vangelo di Luca. E importantepartire proprio dalle righe introduttive, perch suggeriscono il modello comunicativo speciale, chepercorre tutta la redazione dei Vangeli.
Il contenuto noto: le tre parabole della pecorella smarrita, della moneta persa in casa edel padre che accoglie nel suo abbraccio il figlio che torna a casa, dopo le tristi avventure in terra
lontana. Importante la nota che introduce i racconti. Gli esattori delle tasse e altre persone dicattiva reputazione si avvicinavo a Ges per ascoltarlo. Ma i farisei e i maestri della legge lo criti-cavano per questo. Dicevano: Questuomo tratta bene la gente di cattiva reputazione e va a man-giare con loro. Allora Ges raccont questa parabola (Lc., 15, 1-3).
Come si nota, Ges risponde ad una questione calda, raccontando storie. Luca dice diraccontarne una che poi sono tre. E evidentemente una scelta e non un incidente di percorsoDel resto ogni tentativo di organizzare i fatti raccontati nel Vangelo in uno schema rigidamentelogico e o cronologico destinato al fallimento.
E i discepoli lhanno capito bene, un poco alla volta. E hanno utilizzato questo modellocomunicativo per raccontare la grande storia di Ges (Vangeli) e la vita della prima comunit ec-clesiale (Atti degli Apostoli).
1.4. Verso una fedelt perduta
Il Vangelo ci consegna un modo speciale di parlare di Dio.Credo sia urgente ritrovare condizioni di fedelt, proprio ai due livelli in questione: la veri-
ficabilit del contenuto e lautorevolezza del comunicatore.
1.4.1. Tre esigenze irrinunciabili
Il confronto con la prassi della comunit apostolica ci aiuta a scoprire che chi parla di Diorealizza sempre una comunicazione speciale:
Comunicazione dell'esperienza di colui che narra e di coloro a cui la storia narrata:cfr. introduzione alla 1 lettera di Giovanni.
Comunicazione che spinge alla sequela perch sollecita ad una decisione di vita: docu-mento conclusivo del Concilio di Gerusalemme (Atti 15).
Comunicazione che anticipa nel piccolo quello che annuncia nella speranza: la storiadi Pietro e lo zoppo (Atti 3 e 4).
PARLAREDIDIOAGLIUOMINI - AGESCI - CONVEGNO NAZ.LE AE 2008 D. RICCARDO TONELLI PAG. 2 -
-
8/9/2019 Relazione Don Tonelli - Parlare Di Dio Agli Uomini - 2 Conv Naz AE Assisi 2008
3/5
1.4.2. Una fonte impegnativa di autorevolezza
Il parlare di Dio chiama in causa decisamente colui che parla di Dio. Ha bisogno di auto-revolezza. Dove la ritrova?
Pensiamo a quello che combina Pietro quando, dopo lassunzione della responsabilit pie-na della comunit dei discepoli di Ges, chiede di trovare il successore di Giuda.
Nessun gli contesta il diritto a dirigere nonostante i gravi tradimenti di cui si macchia-to.Propone un doppio criterio di scelta, per assicurare autorevolezza al candidato:
uno che abbia conosciuto Ges disposto quindi a considerarlo il Signore, in assoluto (con-tro ogni idolo)
impegnato a diventare testimone della resurrezione (la logica nuova che governa la storia).
1.5. Una storia a tre storieNello stesso racconto si intrecciano tre differenti storie: levento di Dio che si fa vicino a
ciascuno di noi, per la nostra vita e la nostra speranza, le attese e le esperienze delle persone cuiviene offerto il racconto, lesperienza, vissuta e sofferta, di chi ritrova la gioia e il coraggio di con-dividere quello che ha sperimentato nellincontro salvifico.
Questi tre dati, di peso e di significato tanto diverso, diventano una parola unica, perchl'autenticit e verit di ogni elemento richiede gli altri, in un gioco di rapporti reciproci.
Chi vuole servire la vita e consolidare la speranza non pu ridurre la sua proposta a fram-menti della propria esistenza. Nessuno pu dare la vita piena: n a s n agli altri. Dolore, incer-tezza e morte minacciano continuamente ogni pretesa di autosufficienza. Abbiamo bisogno di of-frire un riferimento pi alto e sicuro, quello dellunico nome in cui possiamo avere tutti la vita.
Levangelizzatore racconta quindi i testi della sua fede ecclesiale: le pagine della Scrittura,le storie dei grandi credenti, i documenti della vita della Chiesa, la coscienza attuale della comuni-t ecclesiale attorno ai problemi di fondo dell'esistenza quotidiana. In questo primo elemento,propone, con coraggio e fermezza, le esigenze oggettive della vita, ricompresa dalla parte della ve -rit donata. Credere alla vita, servirla perch nasca contro ogni situazione di morte, non pu certosignificare stemperare le esigenze pi radicali e nemmeno lasciare campo allo sbando della ricercasenza orizzonti e della pura soggettivit.
Levangelizzatore non riesce per a parlare come se lui non c'entrasse e fosse ormai al disopra della mischia. La vita avventura di solidariet profonda e continua, che neppure la mortefisica riesce ormai a spezzare. Questo coinvolgimento personale gli assicura l'autorevolezza di cuiha bisogno per pronunciare parole esigenti, che giudicano e inquietano con la forza di una esi-stenza riconquistata in modo riflesso. Anche questa esigenza ricostruisce un frammento della ve-rit della storia narrata. La sottrae dagli spazi del silenzio freddo dei principi per immergerla nellapassione calda della salvezza.
I suoi interlocutori non sono i destinatari passivi della comunicazione. Essi diventanoprotagonisti del racconto stesso. La loro esistenza d parola al racconto: fornisce la terza delle trestorie, su cui si intreccia l'unica storia. L'evangelizzatore parla di loro in prima persona, delle loroattese e dei loro progetti, anche quando racconta di uomini e donne sprofondati in tempi lontanio quando aiuta a decifrare il percorso della natura e della storia o quando ritesse la trama di unasolidariet che d volto a gente mai vista.
PARLAREDIDIOAGLIUOMINI - AGESCI - CONVEGNO NAZ.LE AE 2008 D. RICCARDO TONELLI PAG. 3 -
-
8/9/2019 Relazione Don Tonelli - Parlare Di Dio Agli Uomini - 2 Conv Naz AE Assisi 2008
4/5
Come nel testo evangelico, la narrazione coinvolge nella sua struttura l'evento narrato, lavita e la fede del narratore e della comunit narrante, i problemi, le attese e le speranze di coloro acui il racconto si indirizza. Questo coinvolgimento assicura la funzione performativa della narra-zione. Se essa volesse prima di tutto dare informazioni corrette, si richiederebbe la ripetizionedelle stesse parole e la riproduzione dei medesimi particolari. Se invece il racconto ci chiede una
decisione di vita, pi importante suscitare una forte esperienza evocativa e collegare il raccontoalla concreta esistenza. Parole e particolari possono variare, quando assicurata la radicale fedeltall'evento narrato, in cui sta la ragione costitutiva della forza salvifica della narrazione.
1.6. Una lingua adeguata
Questo significa la scelta di un modo speciale di comunicare: di una lingua adeguata.Una serie di fattori, che per strani motivi hanno influenzato terribilmente il processo di
evangelizzazione, hanno portato a ridurre anche il parlare di Dio, mistero santo e indicibile, aqualcosa che assomiglia ad una dotta lezione di matematica, con preoccupazioni che investivanola competenza professionale dellevangelizzatore e la verificabilit della sua proposta.
Propongo con decisione una conversione: dimenticare il matematichese come modalitcomunicativa per parlare della fede, per imparare una buona volta a parlare in amorese la lin-gua con cui diciamo ad una persona: tu sei importante per me e ti voglio bene sei un tesoro.Chi ragiona in matematichese si chiede, follemente, quanti euro?. Chi ragiona in amorese, dices ci sto, proviamo e poi vediamo.
1.7. Nel grembo di una comunit narrante
Problemi non piccoli restano e obiezioni serie non mancano.La condizione risolutiva sta in una scelta di fondo: chi parla di Dio non un solitario
che ha studiato e sa. Parliamo di Dio dentro il grembo materno della comunit ecclesiale, in cui la
differenza di sensibilit, prospettive e modelli (innegabile) diventa dono, confronto, integrazione.
1. CONDIZIONI PER UNA BUONA NARRAZIONE
Per concludere desidero annotare alcune condizioni che fanno della narrazione unabuona narrazione, capace di aiutare a vivere nellabbraccio del Dio di Ges.
1.8. Previe
Riconoscimento che la via evocativa modo corretto di chiedere attenzio-
ne alla verit e di fare proposte impegnative. Lattenzione alle persone e alla situazione di vita: non c una narrazione
buona per tutte le stagioni
Narrare non raccontare esempi per attirare lattenzione ma proporrecose impegnative ed esigenti senza bisogno di tirare la morale alla fine.
Cosa narrare? Fatti di vangelo: cio fatti della vita quotidiana pieni della lo -gica del vangelo o fatti di vita ricavati dal vangelo stesso.
PARLAREDIDIOAGLIUOMINI - AGESCI - CONVEGNO NAZ.LE AE 2008 D. RICCARDO TONELLI PAG. 4 -
-
8/9/2019 Relazione Don Tonelli - Parlare Di Dio Agli Uomini - 2 Conv Naz AE Assisi 2008
5/5
1.9. Lo stile nellatto narrativo
Assicurare ospitalit, accogliendo laltro nel racconto stesso e assicurandouna reale condivisione di esperienze.
Scatenare stupore perch la storia si conclude imprevedibilmente bene eperch nellatto stesso del narrare si producono nel piccolo le cose meravigliose che
vengono promesse.
Sollecitare alla decisione: la storia chiede il coraggio di riorientare la pro-pria vita e non solo lacquisizione di nuove informazioni.
1.10. Poi
Nasce la voglia di continuare a narrare perch la vita cresca: una catenadi narratori.
E nasce lesigenza di ripulire la prassi religiosa e il nostro linguaggio reli-gioso pieno di espressioni davvero tristi su Dio.
PARLAREDIDIOAGLIUOMINI - AGESCI - CONVEGNO NAZ.LE AE 2008 D. RICCARDO TONELLI PAG. 5 -