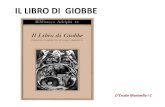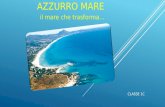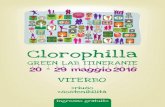Programma Lab 1C
-
Upload
guido-bruzzi -
Category
Documents
-
view
3.862 -
download
0
description
Transcript of Programma Lab 1C
-
Dipartimento di Architettura Pescara Programma delle attivit didattiche CORSO DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 1 A.A. 2014/15 (10+4) CFU docente: Alberto Ulisse collaboratori: Maura Mantelli, Tommaso Sciullo
Contenuti e tema
ANCORA UNA VOLTA SI TORNA A LAVORARE IN CITT - Il Corso di Composizione Architettonica 1 (C) ha come attore non protagonista un frammento della citt costruita (o meglio, i tasselli del mosaico urbano sono cinque: Civico 10-18 Viale Gabriele dAnnunzio / San Cetteo, Civico 24-25 Viale Gabriele dAnnunzio / Piazza Garibaldi, Civico 67 Via dei Bastioni / Mercato coperto, Civico 25 Via Ennio Flaiano / Centro storico, Civico 60 Via dei Bastioni / Palazzo Monti). La questione architettonica si misura tra lesistente e il progetto proposto, attraverso la definizione di un programma duso determinato (casa: volume entro il quale si svolge la maggior parte delle attivit delluomo: lo spazio domestico, lambiente lavorativo, il cortile, la porzione di strada antistante la propria casa caratteristiche: spazio articolato, organizzato in sottospazi con qualit specifiche: aperto, chiuso, interno, esterno. Esiste una relazione mediata tra corpo umano e spazio, determinata da una serie di gesti quotidiani come entrare, uscire, salire, scendere. Il movimento necessario, tendenzialmente rettilineo e continuo: mi muovo da A a B senza interruzioni. La percezione visiva parziale: c la necessit di utilizzare altri sensi (udito, tatto ..). Luso della memoria parziale, in quanto si tende a svolgere una sequenza ininterrotta di azioni e movimenti che si ripetono cronicamente (attraversare un corridoio, recarsi da una stanza allaltra ecc..) richiesta: abitazione per 3-5 persone, inventando il committente) per lesplorazione di modelli spaziali possibili (attraverso plastici/maquette, sezioni urbane, analisi di parti e componenti, schemi quantitativi/qualitativi, ) capaci di indagare, raccontare e rappresentare nuovi modi dellabitare.
UNA CASA TRA LE CASE Il progetto richiama uno dei temi che ha caratterizzato la storia dellarchitettura italiana costruire sul costruito, con il costruito, -tra il costruito; gli studenti saranno chiamati a riflettere sulle questioni del rapporto tra un contesto urbano consolidato, presente e fisicamente incombente e un nuovo oggetto: una casa costretta a guardare il cielo, a misurare la sua partitura esterna (facciata) con i fronti prossimi, a dipanare il suo programma funzionale su diversi livelli (o piani), ad esser introspettiva ma nel contempo parte di un contesto collettivo ben pi ampio: la ridefinizione di un fronte urbano ordinario (sapiente rapporto tra interno/esterno).
Il progetto di un innesto (edificio che si infila un tessuto esistente) la sintesi di una doppia posizione critico-progettuale, sempre pi attuale (anche alla luce del tema scelto per il Padiglione Italia da Cino Zucchi: innesti/grafting attualmente in esposizione alla 14. Mostra Internazionale di Architettura la Biennale di Venezia curatore Rem Koolhaas); se da un lato la scelta di porre limiti/condizioni di svantaggio porta a riflettere sulle possibili soluzioni di temi fondamentali dellarchitettura (quali il tema della luce, del rapporto tra gli spazi serventi e serviti, del sistema di distribuzione, delle parti/ambienti/spazi di una casa, della necessit di costruire una continuit/discontinuit della partitura dei fronti, di un rinnovato senso della domesticit, del rapporto con il marciapiede, con la strada, con la piazza, dellesigenza di dover progettare/immaginare lo spazio in sezione...), dallaltra avrebbe la facilitazione (ancora tutta da verificare) di dover pensare un oggetto fortemente contestualizzato e relazionato con il suo intorno ordine di metodo inteso come antitesi nei confronti di una libert e una creativit fondata esclusivamente sul sentire soggettivo. Si tratta di considerazioni elementari che non concedono spazio a ragionamenti di tipo teorico-filosofico, ma che indirizzano questa ricerca verso lindividuazione degli archetipi tradizionali della casa, cio verso quei fattori della costruzione che non mutano con il tempo e che no possono essere intaccati dai cambiamenti del gusto.
Il tema applicativo si misura con una piccola casa unifamiliare da carattere singolare (specificit e vocazione a scelta dello studente, cos da influenzare larchetipo o la configurazione possibile; ad esempio: casa-studio, casa-laboratorio, casa-orto, casa-casa, casa per uno scrittore pazzo, casa per la sarta de il Diavolo veste Prada, casa per un pittore senza tela, casa per un falegname autodidatta, casa per i Fratelli Karamazov, ). Laggettivo piccola viene qui usato per identificare al meglio il soggetto applicativo, cio la casa, la cui dimensione domestica, per lappunto piccola, legata a pochi bisogni che ampliano le esigenze primarie delluomo, del tipo istintivo e fisiologico (ripararsi, proteggere, scaldarsi, scrutare lesterno, conservare, dormire, preservare, accudire la prole ecc). A questi fattori costanti, primitivi e giusti, si
-
affiancano fattori che disciplinano la conformazione dello spazio e ne definiscono le regole compositive dello spazio. La compresenza di questi fattori accomunano luomo primitivo a quello contemporaneo. Parole chiave: elementi/fundamentals spazio struttura materia luce forma corpo .
una crisi del modello insediativo o il progetto urbano in cerca di nuova identit e risposte alle mutate esigenze contemporanee?
MODELLI DI CASE Una bibliografia di 100 progetti di case (dal Moderno al Contemporaneo) accompagner gli studenti allinterno dello studio e della scoperta delle varianti ed invarianti dellarchitettura. Il sito di riferimento del corso nella sezione MODELLI DI CASE contiene un elenco di circa 100 case di autori dal moderno al contemporaneo; ciascun studente sar impegnato nello studio dello spazio, della distribuzione interna, dei materiali, della struttura del rapporto tra parti piene e parti vuote, delle facciate esterne ecc.. a partire da almeno 3 diverse case. Verranno proiettati in aula alcuni dei film di Jacques Tati ed altri video-interviste ad architetti.
Testi di riferimento
1. tra amore e professione: vocazione - Amate larchitettura Gi Ponti, Rizzoli 2010 - Pensare architettura Peter Zunthor, Electa - Che cos larchitettura? intervista a Renzo Piano, La repubblica/Lespresso 2010 - video 80 2. tra edificio e citt: luogo - Progettare un edificio. Otto lezioni di architettura Ludovico Quaroni, Kappa 2001 - Le variazioni dellidentit Carlos Mart Aris, CittStudi 1990 - Larchitettura della citt Aldo Rossi, Clup, 1978 3. tra sogno e realt: spazio - Mr Gwyn Alessandro Baricco, ed Feltrinelli 2011 - Specie di spazi George Perec, Bollati Boringhieri 2009 - La vita istruzioni per luso George Perec, Rizzoli 2012 4. tra struttura e architettura: wall - Perch gli edifici stanno in piedi Marcello Salvadori, Bompiani 2009 - Ex Libris Giovanni Corbellini, 22Publishing, 2007 - Piccolo Manuale dUso per larchitettura contemporanea Massimiliano Giberti, 22Publishing 2013 5. tra storia e critica: architettura - Spazio, Tempo ed Architettura Siegfried Giedion, Hoepli 1984 - Storia dellarchitettura moderna Leonardo Benevolo, Laterza 2005 - Storia dellarchitettura moderna Bruno Zevi, Einaudi 2004 6. tra regola ed eccezione: fundamentals - Fundamentals. Catalogo 14 Mostra Internazionale di Architettura (Ve), a cura di Rem Koolhaas, Marsilio 2014 - Il Nuovissimo Manuale dellArchitetto Luca Zevi, Mancuso editore 2003 2012 - Manuale dellArchitetto C.N.R., Sapere 2000 edizioni 2010
Obiettivi formativi
Il corso di composizione al primo anno si prefigge come obiettivi formativi: - la capacit critica e conoscitiva di elementi di base per la composizione architettonica; - la costruzione di un percorso logico/progettuale che possa chiaramente dare allo studente un metodo di approccio al progetto architettonico ed urbano; - la definizione di alcuni riferimenti teorici e progettuali che possano contribuire ad iniziare ad accrescere le conoscenze e possano essere utile supporto alla costruzione del tema d'anno; - la sensibilizzazione rispetto a temi legati alla qualit e vivibilit degli spazi abitativi, alla definizione di modelli abitativi adattivi e alla costruzione di un apparato di strumenti capaci di assicurare un progetto sempre pi connesso e responsabile rispetto ai concetti di razionalit ecologica; - la consapevolezza delle differenti problematiche e figure che concorrono alla definizione di un possibile progetto architettonico almeno ci si prova;
-
- la lettura di progetti di architettura simili gi realizzati MODELI DI CASE; - la selettivit e la costruzione di un apparato tematico-progettuale che possa mutuarsi in riferimento alle capacit ed inclinazioni espressive dello studente.
Prerequisiti
Studente iscritto al primo anno del Corso di laurea in Architettura. Conoscenza del proprio corpo, della propria citt, dello spazio della propria abitazione/dimora/stanza. Si auspica una conoscenza e capacit tecnica e del disegno a mano (e al computer), unabile manualit nel costruire maquette ed un ESAGERATA CURIOSIT pertinente ed attiva. Necessaria la visita alla 14. Mostra Internazionale di Architettura la Biennale di Venezia curatore Rem Koolhaas.
Metodi didattici
Il corso sar sviluppato attraverso comunicazioni e lezioni tematiche (su architetti ed architetture a partire da temi di architettura e fundamentals). Verranno presentati modelli abitativi a partire dagli edifici contenuti in Modelli di case; verranno indagati temi di progetto rispetto ai quali incardinare le esercitazioni progettuali; ci saranno ospiti (cinque) capaci di dare il giusto contributo sul tema danno, a partire da diversi aspetti (strutturali, allevoluzione abitativa, materiali, energetico-bioclimatici, normativi ) importanti da tener sul tavolo di lavoro del progetto.
Altre informazioni
Il corso si compone di due parti: primo semestre LABORATORIO (10 CFU), secondo semestre WORKSHOP (4 CFU); lesame verr validato (a giungo 2015) solo con la presenza assidua e la valutazione dei materiali redatti sia nel LABORATORIO (primo semestre) che nel WORKSHOP (secondo semestre). necessaria ed obbligatoria la presenza al corso durante tutto lanno (LABORATORIO e WORKSHOP). Ciascuno studente lavorer singolarmente, esercitandosi disegnando/pensando/progettando a mano; gli elaborati di esame saranno composti da tavole redatte a mano, con laggiunta di una tavola-manifesto da predisporre attraverso il supporto informatico/computer. Sar necessario (obbligatorio) indagare e progettare lo spazio del progetto attraverso maquette di studio. Verranno costruiti maquette di studio sia del progetto danno che dei progetti di riferimento alle differenti scale. Altre informazioni verranno comunicate direttamente in aula durante le ore di lezione/esercitazione; i materiali necessari saranno scaricabili dal sito del corso.
Modalit di verifica dellapprendimento
Verranno svolte esercitazioni e consegne intermedie (quattro step, durante tutto l'anno) durante le settimane di corso per verificare lo stato di avanzamento dei progetti e della capacit di applicazione delle nozioni e dei temi del programma; saranno effettuate attraverso consegne intermedie di confronto e crescita dello studente per la verifica dell'avanzamento del progetto architettonico; per quanto riguarda i materiali del progetto architettonico si richiederanno materiali di progetto come planimetrie, sezioni, fotoinserimenti, dettagli tecnico-materici, spaccati assonometrici o prospettici, plastici, modelli concettuali e strutturali; per la parte teorico-applicativa si richiede allo studente di costruire un apparato di riferimento ed orientamento teorico - per le scelte del progetto - a partire da almeno due dei testi indicati in bibliografia. Verranno costruiti maquette di studio sia del progetto danno che dei progetti di riferimento alle differenti scale. Agli studenti verr consegnato rispetto ad un format uguale per tutti lelenco elaborati e materiali utili al confezionamento del progetto come sintesi degli argomenti presentati al corso e necessari per il conseguimento dellesame. Lesame verr svolto sia dal corpo docente che da un giury esterno che valuter le capacit di ciascuno studente a partire da un colloquio sui temi di progetto.