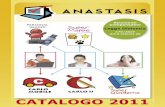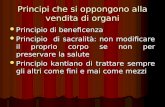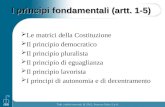PRINCIPIO DI RECIPROCITÀ
description
Transcript of PRINCIPIO DI RECIPROCITÀ

PRINCIPIO DI RECIPROCITÀ

Bibliografia
Caritas in Veritate 3, 8, 34,35,36,37,38,39.L. BRUNI, L’impresa civile, Università Bocconi editore, Milano 2009.S. ZAMAGNI, Per un’economia a misura di persona, Città nuova, Roma 2012.

REGALI E DONO
I regali ed i doni sono atti umani diversi, convivono gli uni accanto agli altri ma non
vanno confusi tra loro.

REGALIobbligo
Joel Waldfogel ha dimostrato che i regali di Natale distruggono il 20% del valore dei beni regalati, poiché se le persone scegliessero i propri regali invece di riceverli dagli altri, la loro soddisfazione sarebbe maggiore. Questo economista propone di regalare denaro, è una via più semplice, ma questi regali in denaro non sono un dono.
Convenzioni sociali
DONOGRATUITA’ BENI RELAZIONALI
SORPRESA
meritato

DONOc’è bisogno di un investimento di tempo, di entrare in profonda sintonia con l’altro, di creatività, fatica, e rischiare anche l’ingratitudine. Quando il dono si esprime con un oggetto donato, quel dono incorporerà per sempre quell’atto di amore, quel bene relazionale da cui è nato e che a sua volta fa rinascere.

COSA DISTINGUE UN DONO DA UN REGALO
Non c’è dono senza un biglietto
personale e accurato che lo accompagni.
La forma conta come la sostanza: in un dono vale non
solo il che cosa ma anche il come, il quando, il dove il
dono viene donato – ricevuto.
La consegna del dono non è mai anonima né frettolosa: è essenziale saper sprecare tempo, e la
conpresenza di chi dona e di chi riceve.

IL PRINCIPIO DI SCAMBIO DI EQUIVALENTI
qualunque cosa un soggetto A faccia o dia a B, con il quale ha liberamente deciso di
entrare in rapporto di scambio, deve essere controbilanciato dalla corresponsabilità da
parte di B di qualcosa di egual valore.
prezzo c’è libertà ante scambio ma non post
una volta negoziato non si può non adempiere all’accordo/contratto.

IL PRINCIPIO DI RECIPROCITA’A si muove liberamente verso B per aiutarlo in
qualche modo e forma sulla base dell’aspettativa che B
farà altrettanto, in un tempo successivo, nei suoi
confronti o nei confronti di C.
Nella reciprocità non solo non vi è accordo previo ma neppure un’obbligazione a
carico di B di reciprocare.
A formula solamente un’aspettativa e se
questa andrà delusa ciò che potrà accadere è che A interrompa o modifichi
la relazione con B.
una relazione intersoggettiva fragile
Il valore di quanto B darà non deve essere equivalente a quanto
ha ricevuto da A, la reciprocità postula la proporzionalità non
l’equivalenza.

IL PRINCIPIO DI RECIPROCITA’La reciprocità inizia sempre da un atto di
gratuità
A va verso B con l’atteggiamento di chi vuol fare un dono, non di chi vuol stringere un affare.
famiglia, cooperativa,
impresa sociale, associazioni
Il progresso civile ed economico di un paese dipende basicamente da quanto diffuse tra i suoi cittadini sono le pratiche di reciprocità

ECONOMIA CIVILEXII - XIV secolo
una civiltà dove i mercati erano alleati del bene comune e le città erano i nodi di una rete europea di scambi non solo economici.
Nell’umanesimo civile del quattrocento si diffonde un modello di ordine sociale
chiamato economia di mercato: è lo scambio a consentire una grande diversità genetica
nelle popolazioni umane. Lo scambio consente di includere anche chi è più
relativamente meno forte ma diverso.
Francesco

ECONOMIA CIVILE
XII - XIV secolouna civiltà dove i mercati erano alleati del bene comune e le città erano i nodi di una rete europea di scambi non solo economici.
FEDE CRISTIANA
UNITA’COMUNIONE
VALORI COMUNI
RIFORMA PROTESTANTE

ECONOMIA CIVILEscandalo della gratia ciò che ha un valore infinito diventa merce di scambio economico.
RIFORMA PROTESTANTE
netta distinzione
individui senza comunità
MERCATO
DONO
CAPITALISMO FILANTROPICO
l’individualismo diviene la principale malattia del modello anglosassone.

ECONOMIA CIVILE
il mercato non è mai decollato veramente, perché bloccato e invischiato nelle trame dei legami forti della comunità e della famiglia. Mafia, totalitarismo, paternalismo di stato sono le malattie tipiche del modello comunitario
CONTRORIFORMA Reazione contro
LIBERTA’ INDIVIDUALE
INIZIATIVA PRIVATA
Comunità senza individui
PATERNALISMO DI STATO
MODELLO COMUNITARIO

DISSIDIO
dissolvere la soggettività nel collettivo
esaltano la soggettività riducendo il sociale a mera aggregazione di preferenze individuali
STATALISTI
LIBERISTI

GRATUITA’
STATALISTI LIBERISTI
PRIVATO
al fine del benessere bastino
i contratti, gli incentivi e ben definite, e fatte
rispettare, regole del gioco
per realizzare nella pratica la solidarietà
basti lo stato sociale, il quale può bensì
appellarsi alla giustizia ma non certo alla
gratuità.

La sfida della Caritas in Veritate
restituire
Il principio di gratuità
alla sfera pubblica

DICOTOMIA PUBBLICO PRIVATOI beni privati e i beni pubblici
condividono un comune trattoquello di non presupporre per il loro
consumo un azione comune, né la conoscenza dell’identità delle persone
coinvolte.
opposto dell’idea di relazione e di bene comune tipico della
tradizione classica
La produzione dei beni relazionali non può avvenire secondo le regole di produzione dei beni privati, né di fornitura dei beni pubblici.
Una scienza economica che non vede le relazioni ma solo individui, non è capace
di vedere i beni relazionali.
che sono il cemento che tiene assieme le nostre
società

BENI RELAZIONALI
è il bene che può essere prodotto e fruito soltanto assieme e simultaneamente da coloro i quali sono gli stessi produttori delle relazioni che li coinvolgono.
Amicizia, fiducia, felicità, rapporti familiari sono altrettanti esempi di ambiti caratterizzati dal ruolo essenziale dei beni relazionali.

IL DONO è una cosa molto seria, faccenda politica, fonda e rifonda le civiltà e la vita: non saremo sopravvissuti alla nascite se qualcuno non ci avesse donato attenzione, cura ed amore. E nessuna istituzione e comunità umana nasce e rinasce senza doni.
I REGALI sono manutenzione di un rapporto, ma non li sanano, trasformano, ricreano. Il dono è uno strumento fondamentale se non indispensabile per curare, riconciliarsi, per ricominciare.

Tre sono le modalità di rapporti interpersonali
INFORMAZIONE: è un rapporto unidirezionale da A a B. Quando A trasferisce un messaggio a B, non c’è ritorno. B non ha la possibilità di intervenire, può solo decidere se accettare o meno l’informazione e poi cosa farne.
RELAZIONE: né A né B detengono alcun potere, dal momento che esso si alterna continuamente tra i due soggetti. La relazione postula il dialogo, che non è mera conversazione, poiché nel dialogo ciascun partecipante deve impegnarsi eticamente a tener conto del punto di vista dell’altro, il che non accade nella comunicazione e tantomeno nella informazione.
COMUNICAZIONE: è un rapporto bidirezionale, dove il termine chiave è quello di ascolto. Prima di decidersi a comunicare A si chiede cosa pensa B; deve dunque ascoltarlo. Nella comunicazione c’è reciprocità perché anche B deve ricevere gratificazione dalla partecipazione al processo comunicativo. Comunicare è più impegnativo che informare; si tratta di mettere qualcosa in comune con qualcun altro.