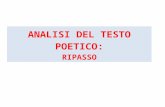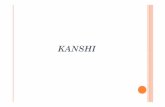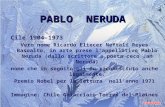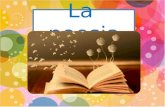Poesia
-
Upload
mariaderisi -
Category
Documents
-
view
555 -
download
7
description
Transcript of Poesia
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 1
Il testo poetico Cosa e il testo poetico
La poesia e un particolare tipo di testo in cui lautore esprime in versi (dal latino vertere = andare a capo ) i propri pensieri, sentimenti, emozioni e il suo particolare modo di vedere la realt. La poesia strettamente collegata alla musica. Nellantichit, i poeti accompagnavano la recitazione dei loro versi con il suono di strumenti musicali. Il testo poetico presenta alcune caratteristiche specifiche:
- il ritmo - le rime - i versi - la musicalit
La poesia fondata sul ritmo e sulla musicalit e per ottenerli il poeta si serve di rime ( due versi che terminano con un gruppo di lettere uguali),della lunghezza dei versi,della scelta delle parole e degli accenti ritmici.
Ninna nanna, ninna oh,
che pazienza che ci vuol.
Col mimmino non c pace, la pappetta non gli piace.
Ninna nanna, ninna oh,
questo bimbo a chi lo do?
Lo dar alluomo nero, che lo tenga un anno intero.
Lo dar alluomo bianco che lo tenga tanto tanto.
Lo dar alla Befana,
che lo tenga una settimana.
Lo dar a un esquimese,
che lo tenga mezzo mese.
Lo dar al suo pap,
quando a casa torner.
Ninna nanna, bambinello,
aspettiamo il tuo pap,
che ti porta un giocarello,
e un vestito alla mamm
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 2
I testi poetici pi facili sono : - le filastrocche - le ninne-nanne - le conte
La filastrocca e un breve componimento in versi, giocoso e dal contenuto divertente e fantasioso. Essa ha origini antiche e popolari e,tramandata oralmente, ha subito varie modificazioni. Lo scopo principale per cui sono state inventate le filastrocche e quello di far addormentare i bambini,di farli divertire, giocare o mangiare. I principali elementi sono:
La rima,solitamente baciata
Il ritmo
La ripetizione di suoni,parole o interi versi
Filastrocca solitaria G. Rodari
Filastrocca solitaria,
voglio fare un castello in aria
pi su delle nubi, pi su del vento
un castello doro e dargento.
Con una scala ci voglio salire
per sognare senza dormire
e su un cartello far stampare:
le cose brutte non possono
entrare..
o filastrocca solitaria
si star bene lass nellaria:
ma se un cartello scritto cos
lo mettessimo anche qui?
Comprensione
1. Che cosa vuole fare il poeta? Perch? 2. Che cosa far stampare su un castello? 3. Come si star lass? 4. Che cosa si propone di mettere anche qui?
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 3
Analisi del testo 1. Evidenzia le rime con colori diversi. 2. Trova cinque parole che rimano con vento/argento - salire/dormire 3. Scegli altre due parole presenti nella filastrocca e per ciascuna trova sei
parole in rima. Il contenuto Perch stata inventata questa filastrocca?
Filastrocca marzolina G.Rodari
Filastrocca di primavera, come tarda a venire la sera. L'hanno vista ferma in un prato dove il verde rispuntato, un profumo di viole in fiore l'ha trattenuta un paio d'ore, ha perso tempo lungo la via presso un cespuglio di gaggia, due bimbi con un tamburo di latta hanno incantato la sera distratta. Adesso tardi, lo so bene: ma per la sera non viene
La regola del testo poetico: la metrica Mentre i testi in prosa seguono le regole della grammatica e della sintassi, i testi poetici si basano su un insieme di regole che costituiscono la metrica (dal greco metron =misura ).Gli elementi della metrica sono: le sillabe, i versi, il ritmo, le rime e le strofe. Le regole della metrica sono state seguite scrupolosamente dai poeti della nostra tradizione letteraria fino allOttocento; da allora in avanti gli autori hanno sostituito a queste regole altre tecniche.
Il verso Il verso e linsieme di parole contenute in una riga di poesia.
1. Qual e il titolo della filastrocca?
2. Chi e lautore? 3. Evidenzia con colori
diversi le rime presenti nel testo.
4. Qual e largomento trattato?
5. Da quali elementi e distratta la primavera?
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 4
Le parole che formano il verso sono,a loro volta,formate da sillabe, a seconda del numero di sillabe,il verso prende un nome diverso(binario,ternario.) . Un gruppo di versi forma una strofa. Nella poesia italiana esistono vari tipi di versi, ognuno dei quali prende il nome dalla sua lunghezza, cio dal numero di sillabe da cui formato. Dal verso pi breve, di sole due sillabe, si arriva al pi lungo, quello di undici sillabe, di dodici sillabe o pi. Va sottolineato che per ogni tipo diverso gli accenti tonici hanno una posizione fissa come ti viene illustrato nella seguente tabella.
Verso Numero di sillabe
Posizione degli accenti
Esempi
Bisillabo 2 Un solo accento sulla prima sillaba
Dietro
qualche
vestro
qualche
viso
bianco (A. Cesareo)
Trisillabo 3 Un solo accento sulla seconda sillaba
Si tace,
non getta
pi nulla,
non sode rumore
di sorta
(A. Palazzeschi) Quadrisillabo 4 Due accenti
sulla prima
e sulla terza sillaba
Ecco il mondo
vuoto e tondo
scende, salza gira, balza (Boito)
Quinario 5 Due accenti: uno sulla prima o
seconda e uno sulla
quarta sillaba
Viva la chiocciola,
viva la bestia
chunisce il merito alla modestia (G. Pascoli)
Senario 6 Due accenti: uno sulla seconda,
laltro sulla quinta sillaba
Cal nel suo regno
con molto fracasso
le teste di legno
fan sempre del chiasso (Giusti)
Settenario 7 Due accenti: uno fisso sulla sesta e
laltro mobile su una
delle prime quattro
La nebbia aglirti colli piovigginando sale,
e sotto il maestrale
urla e biancheggia il mar; (G. Carducci)
Ottonario 8 Due accenti: sulla terza e sulla settima
Quant bella giovinezza che si fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto sia
di doman non c certezza. (Lorenzo il Magnifico)
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 5
Novenario 9 Tre accenti: sulla seconda, quinta ed
ottava
Venivano soffi di lampi
da un nero di nubi laggi
veniva una voce dai campi:
chi (G. Pascoli)
Decasillabo 10 Tre accenti: sulla terza, sesta e
nona
Soffermati sullarida sponda volti i guardi al varcato Ticino
tutti assorti nel nuovo destino
certi in cor dellantica virt (A. Manzoni)
Endecasillabo 11 Tre accenti: uno costantemente
sulla penultima,
la decima;gli
altri due possono
variare
posizione:
sulla 4a e sulla
8a,
oppure sulla 4a e
7a
Ne pi mai toccher le sacre sponde
ove il mio corpo fanciulletto giacque,
Zacinto mia, che te specchi nellonde del greco mar da cui vergine nacque
Venere
(U. Foscolo)
Le sillabe metriche Le sillabe metriche non sempre coincidono con le sillabe grammaticali, per determinare con esattezza il numero delle sillabe di un verso occorre quindi tener conto delle figure metriche. Le pi ricorrenti figure metriche sono: Sinalefe o elisione Dialefe Sineresi Dieresi La sinalefe consiste nel contare come una sola sillaba metrica la vocale finale atona di una parola e la vocale iniziale della successiva:
Nel verso preso come esempio, dunque, grazie alla sinalefe le quindici sillabe diventano undici, formano cio un endecasillabo:
So/ lo e/ pen/ so/ so i / pi/ de/ ser/ ti /cam/ pi. La dialefe consiste nel considerare due vocali di parole vicine come sillabe metriche separate; ci succede anche nel caso in cui una delle due vocali ha laccento tonico.
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 6
Che/ la/ di/ rit/ ta/ v/ a/ e/ ra/ smar/ ri/ ta La sineresi consiste nel contare come ununica sillaba due vocali vicine(iato) allinterno della stessa parola che avrebbero pronuncia separata: Ed-er-ra-lar-mo-nia-per-que-sta-val-le La dieresi consiste nel computare come due sillabe metriche diverse due vocali che allinterno della stessa parola avrebbero pronuncia unita(dittongo). Solitamente la dieresi segnata da (due puntini) sulla vocale interessata: For-se-per-ch-del-la-fa-tal-qu-e-te Occorre anche tener presente che,alla fine del verso,le parole sdrucciole (crepscolo,solitdine..) vengono calcolate come se avessero una sillaba in meno,mentre le parole tronche (citt,per..) vengono calcolate come se avessero una sillaba in pi.
Le strofe Un gruppo di versi forma una strofa. Le strofe assumono nomi diversi in base al numero di versi che le compongono (terzine,quartine..). Le strofe sono separate luna dallaltra da uno spazio bianco. Le strofe principali sono:
il distico: strofa di due versi in rima baciata
Nella Torre il silenzio era gi alto. Sussurravano i pioppi del Rio Salto. (G. Pascoli)
la terzina: strofa di tre versi
Amor condusse noi ad una morte: Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. (Dante)
la quartina: strofa di quattro versi in rima alternata o incrociata:
Oh! Valentino vestito di nuovo, come le brocche dei biancospini! Solo ai piedini provati dal rovo porti la pelle dei tuoi piedini (...) (G. Pascoli)
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 7
Attivit Esercizio n.1 La danza della neve Ada Negri
Sui campi e sulle strade silenziosa e lieve volteggiando, la neve cade danza la falda bianca nellampio ciel scherzosa, poi sul terren si posa,stanca in mille immote forme sui tetti e sui camini, sui cippi e sui giardini dorme. Tutto dintorno pace; chiuso in oblo profondo, indifferente il mondo tace.
la sestina: strofa di sei versi in varie combinazioni di rima
Signorina Felicita, a questora scende la sera nel giardino antico della tua casa. Nel mio cuore amico scende il ricordo. E ti rivedo ancora e Ivrea rivedo e la cerulea Dorae quel dolce paese che non dico. (G. Gozzano)
Ottava: strofa di otto versi, i primi sei in rima alternata, gli ultimi in rima baciata; la strofa tipica dei grandi poemi cavallereschi del Rinascimento italiano.
Afflitto e stanco al fin cade ne lerba e ficca gli occhi al cielo, e non fa motto. Senza cibo e dormir cos si serba che l sole esce tre volte e torna sotto. Di crescer non cess la pena acerba che fuor di senno al fin lebbe condotto. Il quarto d, da gran furor commosso, e maglie e piastre si stracci di dosso. (L. Ariosto)
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 8
Rispondi alle seguenti domande:
1. Qual largomento della poesia? 2. Cosa fa la neve? 3. Cosa fa il mondo? 4. Da quante strofe composta la poesia? 5. Da quanti versi composta ogni strofa? 6. Come si chiamano le strofe? 7. Dividi in sillabe ciascun verso. 8. Evidenzia le figure metriche presenti.
Esercizio n.2 Uccelletto Arturo Graf
In cima a unantica pianta, nel roseo ciel del mattino, un uccellino piccino (oh,com piccino!) canta. Canta? Non canta;cinguetta. Povera, piccola gola, ha in tutto una nota sola, e quella ancora imperfetta. Perch cinguetta? Che cosa lo fa parer s giulivo? Sallegra desser vivo in quella luce di rosa. Rispondi alle domande:
1. Chi il protagonista della poesia? 2. Come luccellino? 3. Dove si trova? 4. Cosa fa? 5. Perch contento? 6. Quante sono le strofe della poesia? 7. Quanti versi sono presenti in ciascuna strofa? 8. Le strofe sono delle.. 9. Fai la divisione in sillabe della poesia. 10. Elenca le figure metriche presenti.
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 9
La rima I versi possono essere legati da rime, cio da ripetizioni di suono nella parte finale delle parole. Un testo poetico,infatti, presenta la rima quando le ultime parole dei versi, a partire dalla sillaba su cui cade laccento tonico, presentano la stessa successione di lettere: ci crea unidentit di suono fra versi ora successivi ora alternati e via dicendo. Le principali rime sono:
La rima baciata
La rima alternata
la rima incrociata
Rima incatenata o terza rima. la rima impiegata da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Come dice la parola, una rima a catena, cio intrecciata in modo da legare uninsieme di strofe. Nel mezzo del cammin di nostra vita A mi ritrovai per una selva oscura B che la diritta via era smarrita. A
Rima baciata: i versi rimano fra loro a due a due: O cavallina, cavallina storna, A che portavi colui che non ritorna; A oh! due parole egli dov pur dire! B E tu capisci, ma non sai ridire. B
( G.Pascoli)
Rima alternata:
il primo verso rima col terzo; il secondo
con il quarto:
Dovera la luna? che il cielo A notava in unalba di perla B ed ergersi il mandorlo e il melo A
parevano a meglio vederla B
(G. Pascoli)
Rima incrociata:
il primo verso rima col quarto, il secondo col
terzo:
Quando lanima stanca e troppo sola A e il cuor non basta a farle compagnia B
si tornerebbe discoli per via, B
si tornerebbe scolaretti a scuola. A
(Marino Moretti)
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 10
Ahi quanto a dir qual era cosa dura B esta selva selvaggia e aspra e forte C che nel pensiero rinova la paura! B Tant amara che poco pi morte; C ma per trattar del ben chi vi trovai D dir de laltre cose chi vho scorte. C (Dante Alighieri, Inferno Canto I )
Pi rara delle rime precedenti la cosiddetta rima interna: si ottiene quando la parola finale di un verso rima con una parola interna al verso successivo: Passata la tempesta: odo augelli far festa e la gallina (...) (G. Leopardi)
Le rime imperfette Esistono anche delle rime dette imperfette, in quanto non hanno un suono uguale, ma simile. Sono di due tipi, lassonanza e la consonanza. Lassonanza si ha quando le sillabe finali di due versi presentano uguali vocali ma consonanti diverse: Il mare tutto azzurro il mare tutto calmo. Nel cuore quasi un urlo di gioia. E tutto calmo. (S. Penna) La consonanza, al contrario, si ha quando le sillabe finali dei versi presentano consonanti uguali, ma vocali diverse: ... e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia... (E. Montale)
Lo schema metrico Per rappresentare il tipo di rima impiegato in un testo poetico si adopera lo schema metrico, costituito da una serie di lettere maiuscole, scritte accanto ai versi, che mettono appunto in evidenza la successione delle rime. Indicato il primo verso con la A, la prima lettera dellalfabeto, si contrassegnano i versi che seguono con le successive lettere dellalfabeto (B, C, D...). Le rime uguali
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 11
saranno contrassegnate con la stessa lettera dellalfabeto. Eccone un esempio . .
Il giorno fu pieno di lampi; A ma ora verranno le stelle B le tacite stelle. Nei campi A c un breve gre gre di ranelle B Le tremule foglie dei pioppi C trascorre una gioia leggiera. D Nel giorno che lampi! che scoppi! C Che pace, la sera! D (G. Pascoli)
Il verso libero A partire dalla seconda met dell800 in poi, i poeti italiani a poco a poco abbandonarono le rigide regole che imponeva la tradizione poetica e cominciarono a scrivere dei testi formati da versi di varia lunghezza, privi del tutto, o in parte, della rima e non pi riuniti in strofe dal numero fisso di versi. Nacque, cos, la poesia in versi liberi o sciolti, non vincolati, cio, da rigide leggi di numero di sillabe, di rime, di strofe, in cui il ritmo e la musicalit sono raggiunti attraverso un liberissimo gioco di disposizione delle parole e dei suoni.
Gi la pioggia con noi, scuote laria silenziosa. Le rondini sfiorano le acque spente presso i laghetti lombardi, volano come gabbiani sui piccoli pesci; il fieno odora oltre i recinti degli orti. Ancora un anno bruciato, senza un lamento, senza un grido levato a vincere dimprovviso un giorno.
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 12
Attivit Esercizio n.3 Leggi le tre poesie, sottolinea le rime,scrivi lo schema metrico e indica di quali rime si tratta.
Acquazzone Di nubi grigie a un tratto il ciel fu sporco: e il tuono brontol con voce d'orco. Si cacci avanti, lungo lo stradone, carta foglie ed uccelli il polverone. Si udirono richiami disperati, tonfi d'imposte e d'usci sbatacchiati. Si vider donne lottare in un prato con gli angeli impauriti del bucato. Il grillo Son piccin cornuto e bruno; me ne sto fra l'erbe e i fior: sotto un giunco o sotto un pruno la mia casa da signor. Non d'oro e non d'argento, ma ritonda e fonda ell': terra il tetto e il pavimento, e vi albergo come un re. Se il fanciul col suo fuscello fuor mi trae dal mio manier, in un piccolo castello io divento il suo piacer ! Uccelletto In cima a un'antica pianta nel rosso ciel del mattino, un uccelletto piccino oh, come piccino! canta. Povera piccola gola, ha in tutto una nota sola, e quella ancora imperfetta. Perch cinguetta? Che cosa la fa parer s giulivo?
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 13
S'allegra d'esser vivo in quella luce di rosa! Esercizio n.4 Leggi la poesia e rispondi alle domande Nella casa della paura Nella casa della paura sembra inchiostro lacqua pura sembra un pipistrello il fiore i minuti sembrano ore. Nella casa dello spavento sembra molle il pavimento sembra un rospo la saliera e un serpente la ringhiera. Luned da casa mia la paura andata via e le cose sembran cose e le rose sembran rose. Marted dalla mia casa se n andato lo spavento: cento amici lhanno invasa han portato luce e vento.
1. La poesia composta da.strofe 2. Ogni strofa composta da..versi ,perci una 3. Scrivi lo schema metrico della poesia. 4. Nelle prime tre strofe c una rima. 5. nellultima strofa la rima .. 6. Nella casa della paura cosa sembra lacqua pura? 7. Nella casa dello spavento cosa sembra la saliera? 8. n quale giorno la paura andata via? 9. In quale giorno lo spavento andato via? 10. La casa di quanti amici stata invasa?
Esercizio n.5 Canzonetta Le ragazze moderne non sono eterne.
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 14
Oh,che bella novit, ma danno fresco alla citt. Luna nellaltra laltra nelluna chi si fa scaltra non ha fortuna. Oh,che bella sciocchezza, ma insieme fanno la giovinezza. Il rosso le veste di blu lazzurro le veste di rosa, un poeta non sa pi quale scegliere per sposa. Sceglier la pi bella? Nessuna tutta brutta nessuna tutta bella. Sceglier la pi caduca, sceglier la passeggera della fresca primavera col nastrino sulla nuca. Rispondi
1. Da quante strofe composta la poesia? 2. Come si chiamano queste strofe? 3. Trascrivi lo schema metrico della poesia. 4. Trascrivi,traendoli dal testo,un esempio di rima baciata,uno di
rima alternata e uno di rima incrociata 5. Trova cinque vocaboli in rima con giovinezza. 6. Trova almeno tre vocaboli n assonanza e tre in consonanza.
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 15
Suoni e immagini del linguaggio poetico Le figure di suono Il poeta, oltre che alla rima, ricorre alluso di altre tecniche che contribuiscono alla musicalit del testo e che hanno in particolare la funzione di comunicare al lettore delle sensazioni acustiche. Queste tecniche costituiscono le figure di suono. Ricordiamo lallitterazione e lonomatopea. Lallitterazione la ripetizione di una vocale o di una consonante oppure di una sillaba intera in parole di uno stesso verso o di versi consecutivi . Lo scopo quello di stabilire legami tra suoni e significati. Esempio: Fresche le mie parole ne la sera ti sien come il fruscio che fan le foglie. ( G.DAnnunzio) In questo caso ,la ripetizione dei suoni f-r-s-sc richiama il frusco delle foglie mosse dalla brezza serale.
Lonomatopea una parola che riproduce il verso di un animale o un suono o un rumore della realt. Esempio: Don.DonE dicono,Dormi! mi cantano,Dormi!sussurrano, Dormi! bisbigliano,Dormi! (G.Pascoli)
Lespressione Don Don riproduce il suono delle campane, mentre le parole sussurrano e bisbigliano,con la ripetizione della s,creano leffetto di parole mormorate a bassa voce. Frequente ,infatti, pure luso di parole dette onomatopeiche che, con la loro struttura, imitano un suono o un rumore o il verso di un animale: tintinnio, scricchiolio, scroscio, sussurro, bisbiglio, fragore, schiamazzo, belato, cinguettio, ruggito... Queste parole vengono impiegate per comunicare sensazioni diverse, ora cupe e tetre (singulto, ululato, rimbombo...) ora serene, liete (scampanellio,
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 16
campanella,argentino...).
La posizione delle parole Mentre nei testi in prosa la disposizione delle parole e delle idee deve obbedire alle regole della grammatica e della sintassi, i poeti possono capovolgere completamente queste regole e seguire, nellordine delle parole e delle frasi, la pi assoluta libert. Questa variazione dellordine grammaticale propria dei testi poetici si ottiene attraverso luso di tecniche chiamate figure retoriche di ordine. Ecco le pi comuni e semplici da riconoscere. Enjambement: il termine, di origine francese, significa letteralmente scavalcamento; si ottiene lenjambement quando una frase iniziata in un verso termina nel verso successivo. Esempio: Il mare tutto azzurro, il mare tutto calmo. Nel cuore quasi un urlo di gioia. E tutto calmo.
......il tuono rimbomb di schianto:
rimbomb, rimbalz, rotol cupo,
( G. Pascoli)
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 17
a Anafora: la ripetizione di una parola o di un insieme di parole realizzata allinizio di versi o di strofe consecutivi; il poeta, in tal modo, vuole mettere in particolare evidenza un concetto,una sensazione. Inoltre, la ripetizione di parole e quindi di suoni identici influisce sul ritmo e sulla musicalit dei versi: Esempio: sentivo il cullare del mare, sentivo un fru fru tra le fratte; sentivo nel cuore un sussulto, comeco dun grido che fu (...) (G.Pascoli)
Lenjambement costituito, in questi versi ,dalla separazione delle parole di gioiadalla frase del verso precedente, di cui sono la conclusione. Perch questo stacco? Allo scopo di mettere in evidenza una parola (gioia) su cui il poeta vuole attirare lattenzione, perch esprime lintensa sensazione di felicit che gli suscita il paesaggio e che vuole comunicare al lettore; isolando questa parola ci riesce, perch le conferisce un maggior risalto.
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 18
(G. Pascoli)un grido
Figure retoriche di significato In un testo in prosa le parole sono adoperate generalmente nel loro significato letterale,quindi semplice coglierne il senso. Al contrario, in un testo in poesia le parole sono per lo pi usate in senso simbolico e vanno quindi interpretate, per comprenderne il significato in cui lautore le ha impiegate. Il linguaggio poetico quindi un linguaggio particolare, poich il poeta vi adopera delle espressioni, dei modi di dire che rispecchiano le sue emozioni, le sue sensazioni e che siano capaci di arrivare alla sensibilit del lettore. Queste forme espressive particolari sono dette figure retoriche di significato. Esaminiamo le pi semplici. Similitudine: un paragone fra due termini o fra due situazioni, realizzato mediante le espressioni come, quale, quali. Nel linguaggio di ogni giorno tutti noi usiamo in continuazione dei paragoni che rendono pi chiari e incisivi i nostri discorsi; diciamo bella come il sole, sciocca come una gallina o forte come un toro e cos via. I poeti, naturalmente, non usano dei paragoni cos comuni e banali;
Ripetizione: come lanafora, una ripetizione di termini o gruppi di parole che per pu trovarsi in una qualsiasi posizione del testo. Ha lo stesso scopo dellanafora e pu creare degli effetti musicali molto suggestivi, come nei versi che seguono:
Lenta la neve fiocca, fiocca, fiocca
(...)
La neve fiocca lenta, lenta, lenta.
(G. Pascoli)
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 19
i loro confronti sono per lo pi suggestivi, insoliti, talvolta strambi, ma comunque capaci di comunicare ai lettori le originali associazioni di idee da cui sono nati. Come in questi versi: Personificazione: consiste nellattribuire a elementi della natura aggettivi o verbi che normalmente vengono riferiti agli esseri umani.Come la similitudine, anche la personificazione nasce da sensazioni e associazioni didee che il poeta intende comunicare al lettore. una tecnica fra le pi suggestive: Metafora: definita un paragone abbreviato, infatti si presenta come una similitudine priva del come che la introduce. un modo di dire che impieghiamo con grande frequenza nei nostri discorsi di tutti i giorni. Quante volte diciamo, ad esempio, Franco una volpe? E tutti comprendono che intendiamo dire Franco furbo come una volpe. Antitesi : consiste nella contrapposizione di parole o frasi di significato opposto; in questa maniera il poeta vuole mettere in evidenza sensazioni, sentimenti o immagini in contrasto fra loro.
Ossimoro : laccostamento di due termini - generalmente un sostantivo e un aggettivo - di significato diametralmente opposto.
La neve sulle case come una
parrucca bianca
(C. Govoni)
Il pomeriggio distratto si
vestiva di freddo (G. Lorca)
Non ho voglia
di tuffarmi
in un gomitolo
di strade.
(G. Ungaretti)
tutto ei prov: la gloria
maggior dopo il periglio,
la fuga e la vittoria,
la reggia e il tristo esiglio.
(A. Manzoni)
Sentia nellinno la dolcezza amara
de canti uditi da fanciullo (...)
(G. Giusti)
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 20
Metonimia: la sostituzione di un termine con un altro a esso legato per affinit logica o materiale; si realizza in diversi modi: indicando la causa per leffetto o leffetto per la causa (vivere del proprio sudore); il contenente per il contenuto (bere un fiasco, scolarsi un bicchiere); lautore per lopera (ho visto un Picasso autentico); la materia per loggetto di cui fatto (combattendo con i ferri affilati).
Attivit Esercizio n.6 La fontana malata Aldo Palazzeschi In questa lirica, lautore si propone di infrangere le regole della poesia tradizionale e lo fa, sul piano formale, con un trionfo di suoni, di onomatopee, di ritmi. In questo modo costruisce una specie di filastrocca, dove i numerosissimi versi di tre sillabe, quasi inesistenti nella poesia tradizionale, imitano i getti della fontana malata.
Clof, clop, cloch, cloffete, cloppete, clocchete, chchch gi, nel cortile, la povera fontana malata; che spasimo
1!
Sentirla Tossire. Tossisce, tossisce, un poco si tace di nuovo tossisce.
Io gli studi leggiadri
talor lasciando e le sudate carte
(G. Leopardi)
1 spasimo: dolore, struggimento
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 21
Mia povera Fontana, il male che hai il cuore mi preme. Si tace, non getta pi nulla. Si tace, non sode romore di sorta, che forse che forse sia morta? Orrore! Ah! No. Rieccola, ancora tossisce. Clof, clop, cloch, cloffete, cloppete, clocchete, chchch La tisi
2
luccide. Dio santo, quel suo eterno tossire mi fa morire, un poco va bene, ma tanto Che lagno! Ma Habel! Vittoria! Andate, correte, chiudete la fonte, mi uccide
2. tisi: tubercolosi, malattia polmonare che un tempo mieteva molte vittime. La voce roca della fontana, personificata, viene cos assimilata alla tosse continua e stizzosa di una persona tubercolotica.
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 22
quel suo eterno tossire! Andate, mettete qualcosa per farla finire magari magari morire. Madonna! Ges! Non pi! Non pi. Mia povera fontana, col male, che hai, finisci vedrai, che uccidi me pure. Clof, clop, cloch, cloffete, cloppete, clocchete, chchch
COMPRENDERE
1. Qual la malattia della fontana? 2. Dove si trova la fontana malata? 3. A chi si rivolge il poeta per chiedere di far tacere la fontana? ANALIZZARE
1. La poesia divisa in strofe? 2. Da quante sillabe sono composti quasi tutti i versi? 3. Come si chiamano? 4. Ci sono delle rime? Se s,sottolineale. 5. Quali suoni utilizza il poeta per imitare la voce della fontana? (indica con
una crocetta la risposta esatta). -Suoni privi di significato -Suoni strani -Suoni onomatopeici
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 23
Esercizio n.7 Palloncini Sylvia Plath La poetessa osserva i movimenti dei palloncini e ne sente il suono quando vengono toccati dai suoi due bambini.
E da Natale che vivono con noi, ingenui e trasparenti, animaletti-anima ovali, occupano met dello spazio, si muovono e strusciano sulle seriche1
invisibili bave daria, mandano uno strillo e un pop se aggrediti,poi scappano via e si fermano tremando appena. Testa di gatto gialla,pesce azzurro- con che strane lune viviamo al posto di mobili morti!2
Storie di paglia,pareti bianche e questi erranti globi daria sottile,rossi,verdi, che danno gioia al cuore come i desideri o liberi pavoni benedicenti3
un vecchio terreno col dono di una penna forgiata in metalli stellati4. Il tuo fratellino fa stridere il palloncino come un gatto. Sembra vedere dallaltra parte un buffo mondo rosa da mangiare e morde, poi cade seduto, brocchetta grassa, contemplando un mondo chiaro come lacqua. Nel pugnetto un brandello rosso.
1.seriche: luminose
come la seta
2.morti: i palloncini
sostituiscono
larredamento usuale che,per la poetessa
privo di vita
3. benedicenti: che
rallegrano
4.stellati: lucenti come
stelle
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 24
Comprensione 1. Da quando vivono in casa i palloncini? 2. Quale sentimento comunicano i palloncini? 3. Quali forme hanno i palloncini? A che cosa assomigliano? 4. La poetessa si rivolge alla figlioletta. Che cosa le dice? 5. Che cosa fa il figlio? 6. Al piccolo che cosa resta in pugno?
Analisi del testo
1. Trascrivi lonomatopea presente nel testo 2. Sottolinea e trascrivi alcune parole onomatopeiche.
Produrre Da piccolo hai giocato anche tu con i palloncini? Che forme avevano? Come ti sembravano quando si muovevano nellaria? Ne hai visto scoppiare qualcuno? Racconta.
Esercizio n.8 Il tuono G.Pascoli
Il silenzio della notte rotto dal rimbombare di un tuono,ma la paura sfuma nella serenit. E nella notte nera come il nulla, a un tratto, col fragor darduo dirupo che frana1,il tuono rimbomb di schianto: rimomb, rimbalz, rotol cupo, e tacque,e poi rimaneggi rinfranto2, e poi van. Soave allora un canto sud di madre,e il moto di una culla. Comprensione
1. Che cosa descrive il poeta nella prima parte della poesia? 2. E nella seconda? 3. Quale suono si mescola a quello del canto materno?
Analisi del testo 1. Evidenzia con colori diversi le parole che rimano tra loro. 2. Individua le allitterazioni legate al rumore del tuono.
1.frana: precipita a valle
2. rimaneggi rinfranto:
il rumore del tuono
simile a quello dellonda che che si infrange contro
gli scogli
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 25
3. Trascrivi le parole onomatopeiche che evocano il rumore del tuono. 4. Il rumore del tuono paragonato a un altro fenomeno naturale. Quale? 5. Nei versi finali prevalgono suoni duri o dolci? Che cosa evocano?
Produrre Prova anche tu a descrivere un fenomeno naturale,cercando di inserire il maggior numero possibile di parole capaci di evocare suoni. Esercizio n.9
Se il termometro sale Giovanni Raboni
Se il termometro sale (37.38.39) non prenderti paura. Non c niente d male. Magari,oltretutto piove. E una faccia sudata non pi brutta n pi scura di una faccia asciutta. Un bambino malato non lo si butta via soltanto perch scotta. Non mica un peccato un po di malattia. Comprensione
1. Quale invito rivolge il poeta al bambino? 2. Che cosa non si fa a un bambino malato?
Analisi del testo.
1. Quali parole rimano tra loro? Evidenziale con colori diversi. 2. Che tipo di rima butta/scotta?
a. assonanza b. consonanza 3. Quale avverbio viene ripetuto? 4. Come si chiama la ripetizione di una parola allinizio del verso? 5. Segna tutti gli enjambements.
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 26
Esercizio n.10 Crepuscolo Ada Negri
La luna incanta un bimbo che guarda ammirato
La luna appena sorta splende tranquilla dietro il deodara1. Venuta per narrargli novelle del paese delle stelle; ma c un bimbo in giardino che guarda e ascolta-e non esiste al mondo ora,per lui,che quella grande luna color di rosa dietro il deodara. Comprensione
1. Dove splende la luna? 2. Chi c in giardino? 3. Cosa fa? 4. Cosa esiste solamente al mondo, per lui, nel momento incantato che
sta vivendo? Analisi del testo
1. Che cosa bimbo/giardino? a. assonanza b. consonanza 2. Segna gli enjambements. 3. Quali parole vuole mettere in evidenza la poetessa con gli
enjambements? 4. Riscrivi il terzo verso collocando le parole in un ordine pi comune. 5. Sottolinea le ripetizioni presenti nella poesia.
1.Deodara: variet di cedro
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 27
Produrre 1. Osserva questo dipinto e descrivi in un breve testo in poesia la
situazione e le sensazioni che suscita.
Esercizio n.11 2. Utilizzando similitudini che ti si presentano in modo spontaneo alla
mente,completa. Caldo come. Freddo come Fresco come
Alcune delle frasi che seguono contengono metafore. Individuale e spiegane il significato.
1. Il sole e una stella che illumina il nostro pianeta. 2. Il sole e un occhio luminoso. 3. La sera e una coperta di stelle. 4. Di sera e possibile vedere le stelle. 5. Il mio compagno di banco e una volpe. 6. Il mio compagno di banco sa sempre cavarsela.
Vincent Van Gogh, Contadini in siesta
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 28
Esercizio n.12 Marzo G. Caproni Il poeta ci fa sentire la freschezza e lallegria della primavera.
Dopo la pioggia la terra un frutto appena sbucciato. Il fiato del fieno bagnato pi acre,ma ride il sole bianco sui prati d marzo a una fanciulla che apre la finestra.
Comprensione 1. In quale momento il poeta osserva la natura primaverile? 2. Su quali particolari si fissa la sua attenzione?
Analisi del testo
1. Con quale parola allinterno del verso rima in modo perfetto bagnato? 2. Che tipo di rima imperfetta formano bianco/marzo? 3. Segna gli enjambements. Quali parole il poeta ha messo in evidenza
usando questa tecnica? 4. Nella poesia presente una metafora. Individuala e spiegala. 5. Quali elementi personifica il poeta? Quali azioni compiono?
Produrre Scrivi tre similitudini ispirate alla terra bagnata dalla pioggia e dopo trasformale in metafore. Similitudini Metafore Dopo la pioggia la terra come Dopo la pioggia la terra
Esercizio n.13 Prato daprile Ada Negri La poetessa ci fa immaginare un prato primaverile con fiori che sembrano farfalle e farfalle che sembrano fiori.
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 29
Cera un prato:con folte erbe,frammiste a bianchi fiori, e gialli, e violetti; e fra esse un bruso di mille piccole vite felici; e se sullerbe e i fiori spirava il vento,con piegar di steli tutto il prato nel sol trascolorava. E volavan farfalle,uguali a petali sciolti dai gambi;e si perdean rapiti i miei pensieri in quellaerea danza ove lala era il fiore e il fiore lala. Comprendere
1. La poetessa ricorda un prato ad aprile. Comera? 2. Che cosa sentiva tra le erbe? 3. Che cosa faceva il vento? 4. In che cosa si perdevano i pensieri della poetessa?
Analisi del testo
1. La poesia composta da versi sciolti. Sono presenti,per,delle rime imperfette. Evidenziale e indica se sono consonanze o assonanze.
2. Individua lallitterazione che evoca i rumori del prato. 3. Trova le parole onomatopeiche presenti nella poesia. 4. A che cosa sono paragonate le farfalle? 5. Nellultimo verso sono presenti due similitudini o due metafore?
Sottolineale. Esercizio n.14 Risveglio del vento Rainer Maria Rilke Il poeta rende il vento,le case e le piante personaggi di una scena notturna carica di mistero.
Nel colmo della notte, a volte, accade che si risvegli, come un bimbo, il vento. Solo,pian piano,vien per il sentiero, penetra nel villaggio addormentato. Striscia guardingo, fino alla fontana; poi si sofferma, tacito, in ascolto.
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 30
Pallide stan tutte le case intorno, tutte le querce-mute. Rispondi alle domande
1. Chi penetra nel villaggio addormentato? 2. Quando? 3. Quali elementi del villaggio vengono nominati? 4. Il vento viene visto dal poeta come una persona. Quali aggettivi lo
umanizzano? 5. Quali azioni compie? 6. Evidenzia la similitudine presente nella poesia. 7. Quali allitterazioni evocano il rumore del vento? 8. Cosa significa lespressione nel colmo della notte?
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 31
Come si procede
Le fasi da seguire per mettere in costruzione un testo poetico sono le seguenti:
a) leggere un intero periodo o frase; b) individuare verbo, cio l'azione; c) individuare il soggetto, cio chi fa l'azione; d) individuare leventuale oggetto, cio chi o che cosa subisce lazione; e) collocare poi le altre informazioni;
f) inserire le parole mancanti o sottintese.
Parafrasi o costruzione diretta di un testo poetico Il testo poetico, scritto in versi, spesso risulta difficile da comprendere.
La parafrasi o versione in prosa consiste proprio in una sorta di traduzione di un testo poetico allo scopo di favorirne la comprensione del significato letterale; proprio per questo deve essere il pi possibile precisa e completa.
Va da s che il testo darrivo sar in prosa, quindi la divisione in versi e in strofe scompare!
A differenza di quanto si fa in un riassunto,vanno rispettate le persone e i tempi scelti dallautore.
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 32
In generale puoi seguire questo schema: soggetto - verbo - complemento - seguiti da eventuali altre informazioni. Per esempio: 2 7 6 4 1 3 5 "...molte anzi tempo all'Orco / generose travolse alme d'eroi" "...(l'ira) travolse molte alme generose d'eroi all'Orco anzi tempo". Dopo aver svolto la costruzione diretta del brano in esame, si fa la parafrasi o versione in prosa. Come? a) Sostituendo ai termini poetici espressioni e vocaboli di uso comune. b) Ampliando il testo, se necessario, con congiunzioni, soggetti sottintesi e altre parole che rendano pi chiaro e scorrevole il periodare. Per compiere questo esercizio sono utili le note esplicative ai testi e il dizionario.
ESEMPIO DI PARAFRASI
Pianto antico - G. Carducci
Testo poetico L'albero a cui tendevi La pargoletta mano, Il verde melograno Da' bei vermigli fior
Nel muto orto solingo Rinverd tutto or ora, E giugno lo ristora Di luce e di calor.
Tu fior de la mia pianta Percossa e inaridita, Tu de l'inutil vita Estremo unico fior,
Sei ne la terra fredda, Sei ne la terra negra;
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 33
N il sol pi ti rallegra N ti risveglia amor.
Testo parafrasato
Lalbero verso il quale tendevi la mano piccolina,il melograno verde dai bei fiori rossi,nel giardino deserto e silenzioso, tornato a coprirsi di foglie verdi da poco tempo e giugno lo ristora con la sua luce e con il suo calore. Tu,fiore della mia pianta colpita e inaridita,tu ultimo e unico fiore della mia vita inutile,ora sei nella terra fredda,ora sei nella terra nera,il sole non ti riscalda pi e lamore non ti risveglia.
Comprendere il significato di una poesia.
Quando leggi una poesia ti senti coinvolto dalle sensazioni che essa suscita in te. Ma possibile una lettura pi approfondita per comprendere il significato globale del testo e scoprire gli strumenti usati abilmente dal poeta. Per analizzare un testo poetico puoi seguire delle fasi ben precise:
1. Leggi attentamente e con espressione a poesia 2. Fai la parafrasi della poesia 3. Individua largomento di cui si parla 4. Fai un breve riassunto della poesia 5. Individua gli elementi metrici presenti nel testo: quante strofe ci
sono,quanti versi,di quante sillabe sono composti i versi,quali rime sono presenti,si tratta di versi liberi,c la presenza di rime imperfette o di enjambement; quali figure retoriche ci sono: onomatopee,metafore, similitudini
6. Fai un commento personale (quali passi ti hanno maggiormente colpito,quali emozioni hai provato leggendo la poesia,su cosa ti ha fatto riflettere) .
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 34
LA POESIA
UN TESTO IN CUI LAUTORE ESPRIME LE
PROPRIE EMOZIONI,STATI
DANIMO E PENSIERI
HA
STRUTTURA
COMPOSTA DA
VERSO
RIMA
STROFA
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 35
LA STROFA
UN INSIEME DI VERSI
LEGATI DA
RIMA
DOTATI DI
SENSO COMPIUTO PU
ESSERE A
SCHEMA FISSO
SCHEMA LIBERO
DISTICO
TERZINA
QUARTINA
SECONDO LE INTENZIONI
ESPRESSIVE DEL
POETA
IL VERSO
LUNIT FONDAMENTALE
DEL TESTO POETICO
COSTITUITO DA
UNA SERIE DI SILLABE TONICHE ATONE
ACCENTATE NON
ACCENTATE
HA
LUNGHEZZA VARIABILE
CHE DIPENDE DAL
NUMERO DI SILLABE CHE LO COMPONGONO
BISILLABO
TRISILLABO
OOOOOOOOOOO
ENDECASILLABO
DECASILLABO
.
.
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 36
PARTICOLARIESPEDIENTI LETTERARI
SONO
LE FIGURE RETORICHE
SERVONO AD
ACCRESCERE IL VALORE
COMUNICATIVO DEL
MESSAGGIO E DEL
LINGUAGGIO DEL POETA
LA RIMA
LIDENTIT DI DUE SUONI O PI PAROLE NELLA PARTE FINALE
DI UN VERSO A PARTIRE DALLULTIMA VOCALE ACCENTATA
CREA
RITMO E ARMONIA
PU ESSERE
BACIATA INCROCIATA ALTERNATA
AABB ABBA ABAB
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 37
E E E
LE FIGURE RETORICHE
ALLITTERAZIONE ONOMATOPEA
LA RIPETIZIONE DI SUONI
IDENTICI IN PAROLE
DIVERSE ALLINTERNO DI
UN VERSO O DI VERSI
SUCCESSIVI
LA RIPETIZIONE DI UN SUONO
SIMILITUDINE PERSONIFICAZIONE METAFORA
UN PARAGONE TRA DUE TERMINI CHE PRESENTANO EVIDENTI
SOMIGLIANZE
LATTRIBUZIONE DI QUALIT E AZIONI UMANE AD UNIDEA ASTRATTA O AD UNA COSA
IL TRASFERIRE AD UN VOCABOLO IL SIGNIFICATO DI UN
ALTRO VOCABOLO
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 38
Laboratorio di scrittura GIOCHIAMO CON LE PAROLE
Con il loro
Crea un rimario con il tuo nome,seguendo lesempio
Leonardo
Benedetta
Leopardo Marionetta
Ghepardo Fretta
Stendardo Soletta
Ritardo Stretta
Petardo Bicicletta
Per ogni nome prova a creare due versi utilizzando le rime del tuo rimario,
cos:
Leonardo accende un petardo
e arriva un po' in ritardo
Benedetta in bicicletta
corre e frena in tutta fretta
Se ora leggi in sequenza i versi che hai creato, ti troverai una divertente
filastrocca sui nomi dei tuoi compagni.
Con la loro
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 39
ACROSTICO
Sempre usando il nostro nome, possiamo costruire un ACROSTICO come
nellesempio:
MOLTA
AMICIZIA
TI
TRASMETTO
E
ONESTA
CREA UN ACROSTICO CON IL TUO NOME. CREANE ANCORA
UNO CON LA PAROLA POESIA.
IL CALLIGRAMMA
Ti puoi divertire anche creando un calligramma
Il calligramma una composizione poetica in cui le parole sono
disposte in modo da riprodurre loggetto di cui si parla. Il nome
deriva dal titolo di una famosa raccolta di poesie del poeta
francese Guillaume Apollinaire.
Eccone alcuni esempi:
O mio fratellino giocoso, che vivi contento nel tuo regno azzurro. Tutto il giorno giochi, salti, guizzi, ti nascondi con le amiche onde. O mio fratellino divertente, azzurro nel dorso, blu nel corpo, trascorri i tuoi giorni nel profondo del mare.
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 40
TU
CHE
NE DICI
O SIGNORE
SE IN QUESTO
NATALE FACCIO
UN BELL'ALBERO
DENTRO IL MIO CUORE
E CI ATTACCO, INVECE DEI
REGALI, I NOMI DI TUTTI I MIEI
AMICI? GLI AMICI LONTANI E VICINI,
GLI ANTICHI ED I NUOVI, QUELLI CHE VEDO
TUTTI I GIORNI E QUELLI CHE VEDO DI RADO
QUELLI CHE RICORDO SEMPRE E QUELLI CHE ALLE
VOLTE, RESTANO DIMENTICATI,QUELLI COSTANTI E
QUELLI INTERMITTENTI QUELLI DELLE ORE DIFFICILI E
QUELLI DELLE ORE ALLEGRE. QUELLI CHE, SENZA VOLERLO, HO FATTO
SOFFRIRE. TUTTI QUELLI CHE CONOSCO PROFONDAMENTE E QUELLI DEI QUALI
CONOSCO SOLO LE A PPARENZE. QUELLI CHE MI DEVONO POCO E QUELLI
AI QUALI DEVO MOLTO. I MIEI AMICI SEMPLICI E I MIEI AMICI I MPORTANTI
I NOMI DI TUTTI QUELLI CHE SONO GI PASSATI NELLA MIA VITA.
UN ALBERO CON RADICI MOLTO
PROFONDE, PERCH I LORO NOMI
NON ESCANO MAI DAL MIO
CUORE. UN ALBERO DAI RAMI
MOLTO GRANDI PERCH I NUOVI
NOMI VENUTI DA TUTTO IL
MONDO SI UNISCANO AI GI
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 41
ESISTENTI. UN ALBERO CON
UN'OMBRA MOLTO GRADEVOLE
AFFINCH LA NOSTRA AMICIZIA
SIA UN MOMENTO DI RIPOSO
DURANTE LE LOTTE DELLA VITA!
INVENTANE UNO A TUO PIACERE
Con il significato
Scegliamo una parola- chiave, per esempio
PRIMAVERA Scegli laggettivo qualificativo che ti sembra pi adatto da associare alla parola primavera, per esempio FRESCA
Forma poi la famiglia dei nomi partendo dalla parola chiave, per esempio:
PRIMAVERA, prati, fiori, sole, rondini,vento, farfalle,soffio
Costruisci una similitudine completando la frase:
La primavera come
Per esempio: La primavera come un soffio di vita nuova.
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 42
Costruisci ora una poesia seguendo lo schema dato:
Se io fossi ...
LA PRIMAVERA
Fresca primavera,
prati, fiori, sole,
rondini,vento,
farfalle Sei come un soffio
di vita nuova.
(schema)
TITOLO
Agg. Qualificativo + parola
chiave,
famiglia dei nomi similitudine
SE FOSSI Se fossi il vento Ti scompiglierei i tuoi capelli belli Se fossi il maestro Vi direi non fate i monelli Se fossi il mare vi bagnerei i castelli di sabbia Se fossi il fuoco brucerei tutta la rabbia Se fossi la terra farei giocare i bambini Se fossi la mammali riempirei di bacini. Se fossi Matteo, come sono, cercherei di fare meno capricci
e di essere pi buono
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 43
Prova a completare le seguenti frasi, indicando la conseguenza della sua nuova
identit:
Gatto, Topo, Contadino, Pescatore, Vento, Gelo, Mago, Ladro
Scopo del gioco terminare sempre con il proprio nome e una rima
divertente.
Se fossi un gatto mangerei formaggio
Se fossi topo ne farei un assaggio
Se fossi contadino pianterei un albero
Se fossi pescatore pescherei un gambero
Se fossi vento soffierei pi piano
Se fossi gelo farei un caldo strano
Se fossi mago magie farei
Se fossi ladro non ruberei
Se fossi Roberto, come sono infatti, sarei amico di cani e gatti
ORA PROVACI TU!
Haik
L'haik un breve componimento giapponese (non pi di sei versi), nei primi due o tre versi vengono espresse sensazioni derivanti dall'osservazione della natura. Gli altri versi esprimono invece i sentimenti che la natura ha suscitato nell'autore. L'haik contiene molti aggettivi e pochi verbi, non compaiono rime,parlano di un ambiente ristretto, ci sono metafore e similitudini. Eccone alcuni esempi:
1.
2.
Piove: Le nuvole grigie e tuonanti spandono per la citt LA LORO ACQUA
Il sole illumina Il piccolo sentiero destate Rigoglioso di colori
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 44
Osserva attentamente l immagine che segue,descrivila e poi seleziona le frasi che potrai utilizzare per la composizione del tuo haik.
Osserva attentamente l immagine che segue,descrivila e poi seleziona le frasi che potrai utilizzare per la composizione del tuo haik.
Soffia il vento: si tengono forte i boccioli di pruno
L'aria calda e leggera il respiro del sole una gioia immensa invade il mio cuore
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 45
CREARE UN LIMERICK
Il Limerick un particolare "nonsense".
composto da cinque versi con rima AA BB A. Questo vuol dire che il primo verso fa rima con il secondo, il terzo fa rima con il quarto, il quinto verso fa rima ancora con il primo.
un tipo poesia inventato dal poeta inglese Edwar Lear.
Il nome Limerick quello di un villaggio irlandese.
Se vuoi crearne uno,segui queste regole:
1. Il primo verso presenta un personaggio (umano o animale) ed inizia cos: Cera una volta
2. Il secondo verso indica che cosa fa di buffo questo personaggio.
3. Nel terzo verso interviene un nuovo personaggio (umano o animale).
4. Il quarto deve fare rima col terzo.
5. Il quinto ripete il primo, con in pi un aggettivo che descrive il personaggio. Le rime presentano questo schema metrico: 1-2; 3-4; 5-1. Esempi: Cera un pidocchio Cera una volta un pidocchio che credeva dessere un ranocchio, un giorno incontr una rana vera ed insieme andarono in crociera. Cera una volta un tenero pidocchio. Il fantasma strano Cera una volta un fantasma Che aveva sempre lasma. Un giorno incontr un pastore che fingeva di essere un dottore. Cera una volta uno strano fantasma
-
Scuola Media Statale Rosso di San Secondo Pagina 46
Il pipistrello matto Cera una volta un pipistrello che usava sempre il rastrello. Un giorno incontr una talpa Che mangiava tanta papa. Cera una volta un simpatico pipistrello. La tigre Cera una tigre tutta tigrata Che mangiava linsalata: la mangi e fu ammalata di insalatine fulminata quella tigre tutta tigrata. Ora crea tu dei limerick