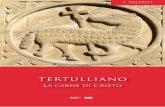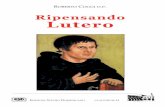PERIODICO DI INFORMAZIONE H an o clb r t:A esd P ih , Se ...contro il razzismo 2 editoriale Marco De...
Transcript of PERIODICO DI INFORMAZIONE H an o clb r t:A esd P ih , Se ...contro il razzismo 2 editoriale Marco De...

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
Se vuoi commentare gli articoli o scaricare i numeri della rivistaNEAR in pdf vai sul sito:www.retenear.it Se vuoi segnalarci delle iniziative o farci delle domande scrivi a [email protected]
PERIODICO DI INFORMAZIONE A CURA DELL’UNARANNO 2 - N. 7SETTEMBRE/OTTOBRE 2013AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI ROMAN. 32/2012 DEL 13/02/2012
Direttore responsabilePAOLA DI LAZZARO
RedazioneMARCO BUEMI, ROBERTA COCCHIONI, CECILIA CRISTAUDO, EDOARDO FONTI,GIAMPIERO FORCESI, ANTONIO GIULIANI, VALERIO SERAFINI
Responsabile del progetto FABIO CAPOCCIArt director TULLIO CAPOCCI
Hanno collaborato: Alessandro Pistecchia,Roberta Lulli, Maria Valentina Tora, CristianaRusso, Vanni Piccolo, Irma Melini, MaurizioAlfano, Teresa Napoli, Paola LongobardiContributi fotografici: © UNICEF Italia/2011/Lombardi, Massimo Ankor, Roberta Lulli, AlbertoGuidi, Marco Buemi, Maurizio Alfano, Francesco De Rosa, Francesco Paolo, Umberto Battista, Attanasio Finiguerra,Meyem Maktoum Foto di copertina: Campagna “IO come TU”promossa dal Comitato italiano per l'Unicef© UNICEF Italia/2011/LombardiRealizzazione grafica e stampa:L.G. Soc. Coop. - RomaVia delle Zoccolette 2500186 Roma - 06 68211616n R
+vicini+uguali
A
numero 7 rivista di diritti umani e lotta alla discriminazione
primo pianola sfida della scuola, italiana e multietnica
approfondimentoguarire da bullismo e omofobia
dibattito: luca sofri e gianni riottainternet e hate speech una relazione pericolosa?
reportagetransnistria, il paese che non esiste
raccontola controra, una giornata a foggia
Post
e It
alia
ne S
.p.A
. - S
ped
izio
ne in
ab
bon
amen
to p
osta
le -
70%
Rom
a Q
Ayt
. n. C
/RM
/12/
2012
7ne RA
primo piano
editoriale
reportage
scuola e disabilità
approfondimento
Marco De Giorgi Verso un Piano Nazionale contro il Razzismo 2Giampiero Forcesi Intervista a Vinicio Ongini 4I numeri della scuola multiculturale 10Alessandro Pistecchia Quando il compagno di classe è uno zingaro 12università e studenti stranieriRoberta Cocchioni Prendi la laurea e scappa 14Paola Di Lazzaro Gli omofobi sono un problema sociale. Ma si possono curare 18Roberta Cocchioni Razzismo, omofobia, discriminazione: i pretesti del bullo 23Valerio Serafini Quale integrazione per gli studenti con disabilità 26Roberta Lulli e Maria Valentina Tora“Dik i na bistar!” Per rivivere la storia e raccontarla 30Giampiero Forcesi 16 ottobre 1943: La deportazione degli ebrei di Roma 32Marco Buemi Transnistria il paese che non esiste 34Edoardo Fonti Hate speach. Una relazione pericolosa?Luca Sofri / Un’insensata battaglia contro il politically correctGianni Riotta / Siamo diventati più incivili. Il web lo rende solo più evidente 38Campania / Maurizio Alfano Se il luogo prescelto è una discarica. La vergogna del campo Rom di Giugliano 42Calabria / Teresa Napoli e Meryem MaktoumL'Azienda sanitaria di Catanzaro e gli immigrati. L'importanza di acquisire competenze transculturali 43Puglia / Irma Melini L'integrazione passa dalla Fiera del Levante. A colloquio con Ugo Patroni Griffi 44Sicilia / Paola Longobardi Ciao Sorella sono sopravvisuto. Il ruolo di Croce Rossa Italiana a Lampedusa 45RACCONTO Antonio Giuliani La controra. Una giornata a Foggia 46CINEMA Edoardo Fonti Intervista a Daniele Gaglianone il regista de “La mia Classe” 50
la scuola italiana e multietnica
sommario
guarire da omofobia e bullismo
cultura
memoria
dibattito
regioni obiettivo convergenza

I l 30 luglio alla presenza della mi-nistra Cécile Kyenge Kashetu e del-la viceministra Maria Cecilia Guer-
ra, davanti ad una platea formata daoltre un centinaio di associazioni, sisono ufficialmente avviati i lavori perla stesura di un Piano nazionaled’Azione contro il razzismo, la xeno-fobia e l’intolleranza che vada dal 2013al 2015.Con questa iniziativa la Ministra perl'Integrazione, di intesa con la Vice-ministra del Lavoro e delle Politichesociali con delega alle Pari opportu-nità, intende porre in essere un im-portante e significativo Piano di mi-sure pluriennale volto a rendere si-stematico ed effettivo il principio diparità di trattamento e non discrimi-nazione, avvalendosi dell'UNAR - Uf-ficio Nazionale AntidiscriminazioniRazziali. Il Piano rappresenta il primoesempio a livello nazionale di una ri-sposta dinamica e coordinata delle isti-tuzioni e della società civile al feno-meno razzista, in crescente aumentonegli ultimi mesi.Il lavoro che ci si è proposti di fare, in-sieme alle associazioni, alle altre Am-ministrazioni e a tutti gli stakeholdermaggiormente coinvolti in tale ambi-to, è di contribuire alla attuazione diuna strategia che possa essere di sup-
porto alle politiche nazionali e localiin materia di prevenzione e contrastodel razzismo, della xenofobia e del-l’intolleranza, nel rispetto degli ob-blighi assunti a livello internaziona-le ed europeo, e con l’obiettivo di va-lorizzare una società multietnica emulticulturale che sia aperta, demo-cratica e dinamica.Tenendo conto delle osservazioni edelle raccomandazioni formulate dalComitato delle Nazioni Unite perl’eliminazione della discriminazionerazziale (CERD), dal Relatore Specia-le delle Nazioni Unite contro il Raz-zismo, dalla Commissione contro ilrazzismo e l’intolleranza razziale delConsiglio d’Europa (ECRI) e dal-l’Agenzia per i diritti fondamentali del-l’Unione europea (FRA), a partire dalmese di novembre 2012, l’UNAR hacostituito un apposito Gruppo di la-voro che ha elaborato una prima boz-za del Piano, individuandone meto-dologia e struttura. Per quanto riguarda la metodologia,al fine di garantire una più ampiacondivisione del Piano, si è deciso,traendo ispirazione dal Processo didialogo strutturato attuato dal-l’Unione Europea, di adottare un si-stema di governance multilivello, checoinvolga tutti gli attori a vario ti-
Verso un Piano Nazionalecontro il razzismo
2
editoriale
Marco De Giorgi direttore UNAR
Al piano stanno lavorano assieme all'Unar, Amministrazioni, associazioni e stakeholder
Dal 2013 al 2015 per la primavolta in Italia un piano pluriennale che adotta misureconcrete di intervento

tolo interessati alle politiche in ma-teria di prevenzione e contrasto del-la discriminazione per motivi razzialied etnici. Si tratta, quindi, di un mo-dello articolato e integrato che pre-vede l’azione sinergica delle istitu-zioni, centrali e locali, della societàcivile e delle parti sociali.
Per quanto riguarda la struttura, il Pia-no si propone di affrontare le discri-minazioni basate sulla razza, sul co-lore della pelle, sull'ascendenza, sul-l'origine nazionale o etnica, sulleconvinzioni e le pratiche religiose, inadesione a quanto previsto sia dal D.lgs215/2003 che dall’art.43 dell’ex Leg-ge 40/1998. Inoltre si prenderà in con-siderazione il diverso impatto che lestesse forme di discriminazione pos-sono avere su donne e uomini, non-ché l’esistenza di forme di razzismo acarattere culturale. Una sezione del Piano è dedicata aduna panoramica sul quadro legislati-vo internazionale e nazionale sulle di-verse forme di discriminazione primaaccennate, allo scopo di approfondi-re alcuni elementi normativi richiestidalle raccomandazioni formulate dal-le istituzioni internazionali e europeee suggerire modificazioni legislative.
Un’altra sezione è invece rivolta al-l’analisi statistica e alla dimensioneevolutiva delle potenziali vittime di di-scriminazione, con una particolare at-tenzione all’elaborazione di specificiindicatori di discriminazione. Infine, tenendo conto dei casi di di-scriminazione rilevati dal ContactCenter dell’UNAR, delle relazioni alParlamento nonché degli ambiti di in-tervento indicati dall’Unione europeacome prioritari per il contrasto e la ri-mozione delle discriminazioni, il Pia-no nella sua ultima parte individua al-cuni Assi (o Aree prioritarie), al fine diproporre specifiche azioni da metterein atto nel prossimo triennio. Il meeting del 30 luglio, cui hanno par-tecipato oltre 200 persone in rappre-sentanza di 106 associazioni, è statoarticolato in un momento di confrontocon tutte le ong in seduta plenaria, enell’organizzazione di 5 gruppi di la-voro secondo gli Assi di intervento in-dividuati. Successivamente, è statochiesto alle associazioni del GruppoNazionale di Lavoro di inviare il pro-prio contributo sia in merito agli Assiindividuati, sia relativamente agliobiettivi e alle azioni da proporre an-che agli altri soggetti istituzionalicoinvolti nell’elaborazione del Piano,tenendo conto dei risultati raggiuntidall’Ufficio nella rimozione della di-scriminazione, delle best practice in-dividuate e messe a sistema, delle cri-ticità evidenziate nella rimozione del-la discriminazione e della valutazio-ne delle azioni positive già adottatedall’UNAR e da altre istituzioni. A seguito del processo consultivo, av-viato anche on line ed ultimato nellaprima fase il 10 settembre, sono statiampliati gli Assi di intervento, cia-scuno dei quali sarà declinato per am-biti strategici, obiettivi operativi e mi-sure positive concretamente attuabi-
li a legislazione vigente. Gli Assi de-finitivi sono i seguenti:
- Occupazione - Alloggio - Educazione e Istruzione;- Sport- Mass Media, campagne e comuni-
cazione - Forze di polizia- Rapporti con la pubblica ammini-
strazione- Salute
Attualmente sono attivi otto gruppi dilavoro, coordinati dall’UNAR, chestanno sintetizzando una prima pro-posta operativa relativa ai singoliAssi, nonché procedendo ad un ap-profondimento normativo e statistico.Nelle prossime settimane, si procede-rà alla consultazione degli altri sog-getti coinvolti nell’elaborazione delPiano. A cominciare dagli altri mini-steri competenti in materia (Ministe-ro dell’Interno, Ministero del Lavoro edelle Politiche Sociali, Ministero del-l’Istruzione dell’Università e della Ri-cerca, Ministero della Salute, Ministerodella Giustizia, ecc.), dagli attori isti-tuzionali territoriali già attivi sultema della lotta al razzismo, a parti-re dalle Reti territoriali dell’UNAR (co-stituite da Regioni, Province e Comu-ni con i quali l’UNAR ha stipulato spe-cifici accordi), e, infine, le Parti Sociali. Confidando, con l'impegno e la sen-sibilità di tutti, di giungere alla defi-nizione del Piano entro la fine del-l'anno non resta che augurarsi un buonlavoro!
3
Otto gli assi di intervento previsti

4
primo piano la scuola multietnica
Sono circa 800.000 gli alunni con cittadinanzanon italiana. Di questi il 45% è nato in Italia.
Percentuale che sale all’80% nelle scuole di infanzia.
a colloquio con Vinicio Ongini
di Giampiero Forcesi
La nuova Italia nascetra i banchi di scuola
LA SCOMMESSA DEL PAESE CHE VERRÀ SI GIOCA GIÀ OGGI NELLE CLASSI DOVE BAMBINI
“ITALIANI” E “STRANIERI” CRESCONO ASSIEME

V inicio Ongini è stato maestronella scuola elementare e dal1996 lavora al Ministero del-
l’Istruzione in un ufficio che si occu-pa dell’integrazione degli alunni stra-nieri. Ha coordinato il gruppo tecni-co che nel 2006 ha redatto le “Lineeguida per l’accoglienza e l’integrazio-ne degli alunni stranieri”. Cura da mol-ti anni il Rapporto nazionale sulla pre-senza degli “alunni con cittadinanzanon italiana” nelle scuole, che ogni
anno offre dati statistici e approfon-dimenti. L’ultimo rapporto, uscito allafine del 2012, riguarda l’anno scola-stico 2011-2012; per il secondo annoil Ministero lo ha pubblicato in colla-borazione con la Fondazione ISMU(Iniziative e studi sulla multietnicità). Inoltre, Ongini ha organizzato inizia-tive di formazione per insegnanti e di-rigenti e progetti di scaffali e di bi-blioteche multiculturali per enti localie scuole. Ha scritto numerosi libri, tracui: Una classe a colori. Manuale perl’accoglienza e l’integrazione deglialunni stranieri, edito da Vallardi nel2009, Il mondo nel pallone. Lo sporte l’educazione interculturale (Unicef,2001), Chi vuole fiabe, chi vuole? Vocie narrazioni di qui e d’altrove (Idest,2002), Noi domani. Un viaggio nellascuola multiculturale (Laterza, 2011)e, per bambini: Le altre Cenerentole.Il giro del mondo in 80 scarpe (Sin-nos, 2009).In piena estate, lo sono andato a tro-vare nel suo ufficio, nel celebre palazzoumbertino di Viale Trastevere. Stavapreparando un importante convegno,che si sarebbe poi tenuto a metà set-tembre a Piacenza: “Prove di futuro.Integrazione, cittadinanza, secondegenerazioni”. Sei sessioni di lavoro,esperienze pilota da tutta Italia, 500partecipanti. Ci sono andato per por-gli il seguente interrogativo: “Checosa fa la scuola di fronte alla presenzanelle aule di tanti bambini stranieri?”.Ne è seguito un lungo colloquio, chelui ha gestito con passione e con mol-to rigore, anticipando le mie doman-de o obiezioni e puntando diritto ver-so ciò che gli stava a cuore comuni-care. E cioè che la presenza degli stu-denti stranieri nelle nostre scuole è unasfida positiva: costringe la scuola a rin-novarsi ed è un potenziale, grande, ar-ricchimento per tutti.
Costa Volpino non è l’Italia
A intervista già fatta, in settembre, pro-prio alla vigilia del convegno di Pia-cenza, i giornali italiani hanno datomolto risalto a due episodi. Il primo èsui quotidiani dell’8 settembre: a Co-sta Volpino, un paesino del Bergama-sco, i genitori italiani decidono di ri-tirare i figli dalla prima elementare acui li avevano iscritti perché, su 21iscritti, 14 erano stranieri. Il secondosu quelli dell’11 settembre: a Landio-na, piccolo comune in provincia di No-vara, dodici famiglie italiane decido-no di togliere i loro bimbi dalla scuo-la elementare perché ci sono troppibambini rom. E’ così che ho richiamatoOngini, un venerdì pomeriggio, sul tar-di. Era ancora in ufficio. Mi dice chei giornali ad ogni inizio di anno sco-lastico mettono in prima pagina uncaso o l’altro di genitori che protesta-no. E l’immagine che ne esce è di unascuola ingestibile, di un disagio che at-traversa tutto il Paese. “Ma non è così”,dice Vinicio Ongini. “Certo, c’è CostaVolpino, c’è Landiona. E certo i geni-tori bisogna sempre ascoltarli. L’ascol-to è il primo passo di ogni percorso dacompiere. Ma Costa Volpino e Lan-diona non sono l’Italia”.Torniamo dunque al nostro colloquiodei primi di agosto. “Da 12 anni il no-stro ministero – mi aveva detto Ongi-ni – scatta una fotografia molto det-tagliata del paesaggio multiculturaledella scuola italiana: provenienze, pre-
5
© UNICEF Italia/2011/Lo
mbardi

senza nelle diverse tipologia di scuo-le, esiti, e così via. L’ultima che abbia-mo fatto è per l’anno scolastico 2011-12. Ci parla di quasi 800.000 alunni concittadinanza non italiana. Questa – sot-tolinea – è la dicitura esatta che uti-lizziamo; cioè in questa cifra nonsono compresi, per esempio, i figli dicoppie miste o i bambini adottati,perché questi hanno tutti acquisito lacittadinanza italiana. In questi nostridati conta la cittadinanza. In questa fo-tografia, una grande novità, emersa ne-gli ultimi anni e a cui diamo molta im-portanza, è la distinzione tra alunni concittadinanza non italiana nati in Italiae alunni che sono arrivati qui per l’im-migrazione recente dei loro genitori. E’necessario distinguere bene gli uni da-gli altri, e dunque evitare di fare comefanno spesso i media che mettono tut-to dentro un unico calderone, così chesembra che tutti siano appena venutie che tutti abbiano molte difficoltà, per-ché non parlano la lingua, eccetera.Mentre non è così”.
La vera difficoltàsono i nuovi
arrivati, specie seadolescentiOngini tiene moltoche si faccia questa
distinzione. “Abbiamo– dice – questi due dati
molto ben distinti: da unparte, quasi il 45 per cento degli
800mila alunni stranieri sono nati inItalia; dall’altra parte, c’è un 5 per cen-to di alunni che sono arrivati in Ita-lia nell’ultimo anno; l’altro 50 per cen-to, ovviamente, è fatto di ragazzi chenon sono nati in Italia, ma che nonsono neppure venuti troppo di recen-te. “Dunque – prosegue Ongini – lagran parte di quel 45 per cento di natiin Italia parla l’italiano, alcuni anche
con accento dialettale. Ed è un datoin aumento. Poi va detto che questo 45per cento è una media: nelle scuoledell’infanzia i bambini non italianisono all’80 per cento nati in Italia; poi,via via, il dato è decrescente”. “E que-sto – aggiunge, dopo una pausa – èun dato importante anche per la di-scussione politica che è in corso:quella sulla cittadinanza”.“Per quel 5 per cento, cioè per chi è ap-pena arrivato in Italia, i problemi cisono – dice Ongini -. Tra questi alun-ni, che noi chiamiamo NAI (nuovi ar-rivati in Italia), c’è il massimo delle dif-ficoltà, sia per lo studente che per l’in-segnante. Pensiamo, ad esempio, a chiè venuto in Italia da adolescente,dopo aver studiato molti anni nel suopaese: non conosce la lingua italiana,magari proviene da paesi dove non siparla una lingua latina, si trova iscrit-to in terza media, deve già decidere checosa fare dopo quel suo primo anno discuola in Italia, decidere del suo futuro… Insomma, qui ci sono tante difficoltàche si sommano una all’altra”.
“È questo segmento del 5%, o del 10%, se si considera chi è arrivato da dueanni – prosegue Ongini - che ha as-solutamente bisogno di aiuto, di ri-sorse. Sono questi i ragazzi ai quali sideve dare una mano subito. Sono loroche hanno bisogno di corsi di linguaitaliana”. La fotografia della situazione reale,con dati precisi alla mano, dice Vini-cio Ongini, “ci serve a capire, a di-stinguere, per non fare di tutte le erbeun fascio. Ci serve a vedere i bisognidiversi: quelli del bambino nato qui,ben inserito, e quelli di chi invece èappena arrivato, ed è spaesato”. “Que-sti dati – insiste - ci servono per de-cidere le azioni da fare, gli investi-menti, le politiche”.
È vero che ci sono tanti abbandoni
Solo dopo aver chiarito questo sce-nario, Ongini si lascia fare la doman-da che riguarda i successi e gli insuc-
primo piano
66
“NOI DOMANI”
Dalle montagne del cuneeseai quartieri perifericidi Torino, Milano e Roma,dalle scuole dei piccoli indiani sikh,nei paesi della pianura padana,agli esercizi di patriottismocostituzionale nel Salento.Dalla radio libera in un asilomultietnico di Bolognaai viaggi in Cina di studentie professori toscani,alle maestre poliglottedel quartiere Ballarò a Palermo:un’inchiesta originalesulla scuola che verrà.
Pubblicato nel 2011, Noi domani, il viaggio nella scuola multiculturale di Vini-cio Ongini è un libro affascinante. Dove la scoperta del nuovo, di esperienzeimpreviste e insospettate, è continua, mutevole, ma sempre anche impastatacon la memoria di come eravamo, di com’era la scuola prima, delle nostre ra-dici. Una domanda sembra porsi incessantemente l’autore, nel suo viaggio,parlando con tanti maestri e insegnanti, presidi e genitori: la scuola con tantiragazzi “stranieri” dentro è uno svantaggio o un vantaggio? E ancora: la scuolamultietnica è una scuola di qualità o no? E la risposta che egli ricava dalleesperienze che incontra è che, sì, se si ha coraggio, se si accetta la sfida, se cisi lascia interrogare e stimolare e anche scombinare da queste presenze e daiproblemi che lì per lì sorgono, allora si capisce, si sperimenta che la scuolacon dentro tante culture diverse è un vantaggio, per tutti, e la scuola che sicostruisce con loro è una scuola davvero di qualità.
�
�
Editori LaterzaEDITORI LATERZA
VINICIO ONGINI
NOI DOMANIUN VIAGGIO NELLA SCUOLA
MULTICULTURALE
E

cessi, cioè la riuscita scolastica, dei ra-gazzi stranieri. Ammette che la real-tà degli abbandoni è preoccupante, an-che se non si hanno dati precisi. I daticerti, sulla riuscita scolastica deglialunni stranieri, sono tre. Primo: sono molto numerosi i ragaz-zi che scelgono gli istituti tecnici e pro-fessionali. Sono il doppio degli italia-ni. E’ in queste scuole che si concen-tra un gran numero di ragazzi stranieri,ed è qui che si concentra anche un’al-tissima percentuale di altre tipologie didiversità: i disabili, i ragazzi cosiddettidifficili. “E’ evidente – commenta On-gini – che c’è qualcosa che non va inquesta scelta”. Secondo: i bambini stranieri presen-tano un forte ritardo scolastico, cioèsono molti quelli che hanno uno o piùanni di ritardo rispetto ai compagni discuola. E questo è un indubbio segnaledi difficoltà. Nel primo anno delle su-periori questo ritardo riguarda il 70 percento degli studenti stranieri: 7 su 10hanno uno o più anni di ritardo ri-spetto ai compagni italiani. Terzo: Il dato delle bocciature è net-tamente più alto nei ragazzi stranie-ri. Ed è molto alto nelle due prime: pri-ma media e prima superiore. “Questoè un dato molto utile – osserva Ongi-
ni – perché indica che lì ci sono duescalini, due ostacoli. Sapere che lì cisono delle forti difficoltà aiuta a faredelle scelte mirate”.Dunque, di nuovo Ongini sottolineache conoscere i dati nel dettaglio per-mette di capire dove sono le situazio-ni di difficoltà e dove, dunque, è piùnecessario intervenire. Ma non semprepoi accade che le scelte siano prese…
I bambini rom nellescuole sono troppo pochi e si perdono per strada“Da pochi anni – mi racconta il nostrofunzionario ministeriale – nel Rappor-to abbiamo un capitolo sui bambinirom. Lo facciamo forzando un po’ lecose perché il Rapporto è dedicato aglialunni con cittadinanza non italiana, ei Rom sono per metà italiani… Ma cer-to hanno una diversa appartenenza cul-turale – aggiunge – ed è questo in re-altà che noi cerchiamo di definire coni numeri. E i numeri, in questo caso par-lano molto chiaro: per quanto riguar-da i Rom che vivono in Italia, le cifreballano, ma il numero dei ragazzi rom(rom e sinti) iscritti alle scuole questoè ben definito”. Ongini spiega che nel
modulo di iscrizione ad ogni ordine discuole c’è una domanda sull’apparte-nenza alla categoria dei “nomadi”. Unavoce non del tutto corretta, dice, ma cheviene comunque usata.Dunque, il numero dei bambini e ra-gazzi rom iscritti è poco meno di12.000. E’ pertanto evidente che sonopochi i bambini che vanno a scuola,dal momento che la popolazione rome sinti stimata è di circa 150.000. Nonsolo. “C’è un salto fortissimo – ag-giunge Ongini – tra gli iscritti allascuola primaria e quelli iscritti allascuola media, e ancora di più tra quel-li iscritti alla media e gli iscritti alle su-periori. Dai 6.400 iscritti alla scuola pri-maria si passa ai circa 3.400 della scuo-la media. Di questi, poi, alle superio-ri ne troviamo soltanto 150, uno suventi”. Anche se forse sono di più, mispiega, perché alcuni non si dichiara-no come “nomadi” dal momento cheappartengono a comunità di lungo in-sediamento. “Tuttavia è un dato indi-cativo – dice Ongini -.Vuol dire che siperdono per strada quasi completa-
77
© UNICEF Italia/2011/Lo
mbardi

mente. E poi c’è da aggiungere che, coni Rom, il dato dell’iscrizione noncoincide con quello della frequenza,anche se sulla frequenza non abbiamodati statistici. Risulta, infine, che il nu-mero dei Rom iscritti è addirittura indiminuzione. Questo, allora, ci diceun’altra cosa: mette in discussione lestrategie adottate, gli impegni istitu-zionali che sono stati presi. Vuol direche certi progetti non funzionano, cer-ti investimenti non danno risultati”. “Inumeri parlano - insiste Ongini -. Sonoimportanti per capire bene e poi per de-cidere le azioni da compiere”.
Dalla fotografia della realtà alle azionimirate per affrontare i veri problemi
Fatta, dunque, la fotografia della si-tuazione, passiamo alle azioni priori-tarie da compiere. Innanzitutto sul pia-no nazionale. Ongini parla di una azio-ne riguardante direttamente gli studenti, e cioè l’insegnamento della lingua ita-liana, e di due azioni “di sistema”, cheriguardano invece molteplici attori. L’insegnamento della lingua italiana èrivolto in modo specifico agli alunninuovi arrivati che fanno la terza me-dia. E’ un’azione ben circoscritta. Le ri-sorse non sono tantissime, dice Ongi-ni, e abbiamo deciso di concentrarle suquesta fascia di alunni stranieri: la piùvulnerabile. Si interviene sulle scuo-le che hanno le percentuali più alte dialunni stranieri nuovi arrivati; e si de-cide dove intervenire anche in base alleprovenienze. “E’ importante - mi spie-ga - sapere che in una data scuola c’èuna percentuale alta di cinesi e indianiarrivati da poco… Lì, allora, interve-niamo. Abbiamo individuato 75 scuo-le che hanno questa situazione”.Le azioni di sistema. La prima riguar-da la formazione dei docenti. Se si vaa vedere il sito del ministero ci si fa
un’idea di quanto lavoro si faccia inquesta direzione. “All’interno dellastrategia della formazione – mi diceOngini – abbiamo poi fatto una scel-ta: quella della formazione dei dirigentidelle scuole con alto tasso di multi-culturalità. La consapevolezza e lacompetenza del capo d’istituto è indi-spensabile per poter intervenire in unascuola, perché in quella scuola ci siaun clima effettivamente di accoglien-za, perché si sia aperti al dialogo conle altre istituzioni, perché si sia attentia evitare che una scuola diventi ‘lascuola degli immigrati’ e quella accantoinvece no…”. Ongini insiste su questo punto. Sui di-rigenti. Devono essere capaci di dialo-gare tra loro, e di fare patti con il quar-tiere, con le associazioni del territorio.Se non c’è questo, finisce che tutti i ra-gazzi stranieri si concentrano in unascuola e che poi le famiglie italiane sitrovino a disagio e spostino i propri fi-gli in altre scuole. Ci vogliono presidiin grado di gestire queste situazioni. On-gini mi dice che queste indicazioni sonogià parte, dal 2007, di un importante do-cumento del ministero, di cui va mol-to fiero. Si chiama “La via italiana perla scuola interculturale e l’integrazio-ne degli alunni stranieri”.L’altra azione di sistema riguarda quel-le scuole e quei quartieri che hanno unafrequenza particolarmente alta di stu-denti stranieri. Qui si tratta di investi-re sul contesto. Evitare la marginalitàdi queste scuole. Ma si tratta anche –e questo, dice Ongini, è un obiettivomolto ambizioso – non solo di difen-dersi per evitare di diventare unascuola di serie B, che pure è già unbuon risultato, ma di cercare di valo-rizzare il dialogo interculturale e di faresì che queste scuole, dove sono presenti
una molteplicità di culture, divengano,in qualche modo, e positivamente,“scuole internazionali”. Si tratta di in-trodurre in queste scuole elementi ingrado di valorizzare le diversità, cosìche quello che in genere percepiamocome difficoltà, come ostacolo, comecomplicazione, divenga invece un fat-tore di arricchimento, un fattore di di-namismo per le scuole. “Questa è lascommessa culturale che noi facciamo”,dice con forza Ongini.Qui, davvero, come dice il titolo delconvegno di Piacenza, si fanno le “pro-ve di futuro”.
La scommessa culturale:capire che la presenza di tanti ragazzi stranieriarricchisce la scuola e la spinge a rinnovarsi
Ma non è solo futuro. E’ già, in moltiluoghi, il presente. Ci sono esperienzein corso in scuole del nord, del centroe del sud d’Italia. Certo, sono esperienzepilota. Ma non sono poche. “Ci sonodelle scuole – racconta Ongini – chehanno saputo invertire la tendenza ne-gativa, cioè il fatto che la presenza dimolti alunni stranieri abbia indotto lefamiglie italiane a togliere i propri fi-gli e a portarli altrove. Gli insegnantisi sono organizzati. Hanno comincia-to col tenere aperte le scuole fino allasera. Hanno messo in piedi tante atti-vità, a cominciare da quelle sportive,dando spazio agli sport dei ragazzi del-le diverse nazionalità e facendoli co-noscere a tutti. Hanno istituito corsi dilingua cinese a cui possono partecipa-re non solo i ragazzi cinesi nati in Ita-
primo piano
8
© UNICEF Italia/2011/Lo
mbardi

lia, i cui genitori desideravano che im-parassero la lingua d’origine, ma anchei ragazzi italiani. Si è cercato di valo-rizzare le competenze in matematica deiragazzi cinesi e indiani e di metterle inqualche modo a disposizione anche de-gli altri. Gli esempi sono tanti”. Sono davvero tanti, gli esempi, e se netrova uno straordinario campionarionel libro che l’ex maestro elementareVinicio Ongini ha scritto nel 2011: “Noidomani. Un viaggio nella scuola mul-ticulturale”. Basta scorrere l’indice. Se lo si affronta bene, il fatto che lescuole si riempiano di bambini stranieriè un vantaggio per tutti. E’ questa la“scommessa culturale” di cui parlaOngini. Il nostro maestro, oggi ispira-tore tenace al Ministero di un orienta-mento che si sta faticosamente facen-do strada nella scuola, ha scritto ancheun decalogo di questi vantaggi. “Lascuola italiana - mi dice -, lo sappia-mo, non va bene; i pedagogisti sonoscomparsi. Non va bene il Paese … Lascuola ha bisogno di rinnovarsi, di ri-prendere fiducia. E questo a prescinderedalla presenza di alunni stranieri. Maquello che oggi si sta cominciando a ca-pire è che la presenza di questo sot-toinsieme, non piccolo, di quasi 800milaalunni stranieri è una grande occasio-ne, con le difficoltà che comporta, conlo spaesamento che crea, per cominciarea cambiare la scuola. E’ una grande oc-casione di confronto, di scoperta di mo-dalità diverse di fare scuola”. Ongini porta un esempio concreto: l’in-segnamento della matematica. “Non èuna leggenda – dice - la grande bra-vura in matematica dei ragazzi cine-si. In Cina la persona colta è quella chesa fare bene i calcoli. Fin da piccoli icinesi giocano facendo calcoli orali.Ogni momento di pausa, al lavoro e
per strada, è utilizzato per fare giochimatematici. E’ anche la lingua cinese,con i suoi 5000 caratteri, a richiede-re un grande sforzo di memoria che in-fluenza le capacità matematiche”. Edunque, dice Ongini, in molte scuoleitaliane, dove ci sono bambini cinesi,si sta cercando di puntare sulla lorobravura in matematica per affascina-re anche i nostri bambini e per modi-ficare il modo stesso di insegnare lamatematica.
Assumere la diversitàcon gli occhi della normalitàOngini mi segnala anche un altro ele-mento di novità che si va sperimen-tando nelle scuole dove ci sono mol-ti stranieri: il fatto diutilizzare un compa-gno di scuola piùgrande, già inserito,come aiutante, tutor,di un ragazzo appenaentrato nella scuola.Le seconde genera-zioni che aiutano leprime. E’ la cosiddet-ta peer education,l’educazione tra pari,che già in passato èstata usata, talvolta,da insegnanti illumi-nati per sostenere i ra-gazzi più deboli e cherisulta molto appro-priata per il sostegnoai ragazzi stranierinella fase del loro primo inserimentonella scuola. Questo metodo fa sì chegli stessi ragazzi più grandi, i tutor,nell’aiutare gli altri, si responsabiliz-
zano e imparano meglio loro stessi. E’questa , della peer education, un’altralinea di azione prioritaria che il Mi-nistero proporrà quest’anno nellescuole con molti ragazzi stranieri.Altro elemento di dinamismo nellascuola è il ruolo dei genitori. La pre-senza di un forte numero di alunni stra-nieri spinge i genitori, quelli stranierima anche quelli italiani, a offrire unimpegno volontario per tenere apertala scuola fino alla sera, utilizzare tut-ti gli spazi, averne cura e cercare le ri-sposte alle tante nuove esigenze. “Insomma - conclude Ongini – quelloche sta avvenendo è proprio un capo-volgimento dello sguardo”. La scuola staimparando a non vedere solo quello chenon ha, ma a valorizzare meglio quel-lo che ha. In questo caso le diversità deiragazzi e delle loro famiglie. Si tratta
di vedere nella differenza anche gli ele-menti positivi, gli elementi di trasfor-mazione. “La presenza di bambini figlidi immigrati stranieri – mi dice – puòessere, e noi ci impegniamo che sia, unasorta di ‘evidenziatore’ per i nostri mo-delli e stili educativi. Cioè un’occasio-ne per rivedere i nostri comportamen-ti e ridare significato al fare scuola nelnostro tempo”.
la scuola multietnica
9
I Bambini che avete visto
Le foto del primo piano sulla scuola multiculturale così come la foto di co-pertina sono state scattate in una scuola di Bologna e ci sono state gentilmenteconcesse dall’Unicef Italia che le ha realizzate nell’ambito della campagna “IOcome TU” promossa dal Comitato Italiano per l’UNICEF per la promozionedel diritto alla non discriminazione dei bambini e degli adolescenti di originestraniera che vivono in Italia.
Le foto dei bambini Rom a pagina 12 e 13 sono invece state scattate da Mas-simo Ankor in una scuola elementare di Torino nell’ambito del progetto: “Ita-lia, scuola d’integrazione 1861|2011”, a cura di Idea Rom Torino.
© UNICEF Italia/2011/Lo
mbardi

Una stima per l’anno scolastico2013/2014I dati conosciuti si riferiscono all’annoscolastico 2011/2012 (cfr. il rapporto na-zionale Alunni con cittadinanza non ita-liana. Approfondimenti e analisi,Miur/Ismu, 2013, in www.istruzione.it).Sulla base dell’andamento degli ulti-mi due anni, è possibile tuttavia fareuna stima sulle presenza degli alunni“con cittadinanza non italiana” (que-sta è la definizione che usa il sistemastatistico del Miur) nell’anno scolasticoappena iniziato, il 2013 /2014.Il numero complessivo potrebbe es-sere di circa 840.000 e la percentualedel 9,4%.
Anno scolastico 2011/2012: quantisono. Si è passati da 196.414 alunnidell’anno scolastico 2001/2002 (conuna incidenza del 2% sulla popolazionescolastica complessiva) alle 755.939unità del 2011/12 (8,4% del totale).
Presenze nei diversi ordini e gradi.L’aumento più significativo ha ri-guardato le scuole secondarie di se-condo grado: nel 2001/2002 acco-glievano il 14% degli studenti con cit-tadinanza non italiana, mentre nel2011/2012 ben il 21,8%. Nell’ultimo de-cennio il peso della scuola primaria èdiminuito passando dal 42,8% al35,5%. Anche per il 2011/2012 siconferma la tendenza dell’utenza stra-niera a rivolgersi più all’istruzione pro-fessionale (frequentata dal 39,4% deltotale degli stranieri) e tecnica (38,3%),seguita a distanza dall’istruzione licealeo artistica (22,3%).
Sono i rumeni i più numerosi. Glialunni con cittadinanza rumena siconfermano, per il sesto anno conse-cutivo, il gruppo nazionale più nume-roso nelle scuole italiane (141.050 pre-senze), seguono gli albanesi (102.719)e i marocchini (95.912). Tra le cresciteannue più rilevanti si registrano quel-le degli alunni moldovi (+ 12,3%) neidiversi livelli scolastici, e ucraini (+11,7%) nelle primarie e filippini nelle se-condarie di primo grado (+8,5%) e disecondo grado (+11,2%).
La regione con più alunni stranieri,in valori assoluti, è la Lombardia; indati percentuali è l’Emilia Romagna.La Lombardia si conferma la prima re-gione per il maggior numero di alun-ni con cittadinanza non italiana(184.592). Seguono il Veneto, (89.367),e l’Emilia Romagna con (86.944), il La-zio (72.632) e il Piemonte (72.053). Laregione con la percentuale più alta èl’Emilia Romagna, con il 14,6%.Nelle province di Prato, Piacenza, Man-tova, la percentuale si avvicina al 20%.
Crescono i nati in Italia: nelle scuo-le dell’infanzia sono 8 su 10. Nell’anno scolastico 2011/2012, glialunni stranieri nati in Italia sono334.284 e rappresentano il 44,2% sultotale degli alunni con cittadinanzanon italiana. Cinque anni fa eranomeno di 200mila, il 34,7%. Nellescuole dell’infanzia i bambini stranierinati in Italia sono l’80,4%, più di ottosu dieci, ma in alcune regioni la per-centuale è ancora più alta: superal’87% in Veneto, l’85% nelle Marche,l’84% in Lombardia e l’83% in EmiliaRomagna. Mentre non raggiunge il50% nel Molise e lo supera di poco inCalabria, Campania e Basilicata. Ne-gli ultimi cinque anni gli studenti stra-nieri nati in Italia sono cresciuti del60% nelle scuole dell’infanzia (dove
hanno raggiunto le 126mila unità, apartire dalle 79mila del 2007/2008) enelle primarie (145mila), mentre sonopiù che raddoppiati nelle secondarie diprimo grado (46mila) e di secondo gra-do (17mila). I dati sugli studentinati in Italia e il loro progressivo au-mento possono fornire un utile con-tributo alla comprensione di una del-le questioni oggi maggiormente in di-scussione in tema di immigrazione:la riforma della normativa sull’ac-quisizione della cittadinanza.
Sono 415 le scuole nelle quali la pre-senza degli alunni stranieri superail 50%. In totale le scuole in cui è maggiore lapresenza di alunni stranieri sono 415(corrispondenti allo 0,7% delle scuole),10 in più dell’anno scolastico prece-dente. Due terzi delle province italia-ne hanno almeno una scuola a mag-gioranza di alunni stranieri. Le scuoledell’infanzia con almeno il 50% deglialunni stranieri sono 233. Le provincecon il maggior numero di scuole con al-meno il 50% di alunni stranieri sonoMilano (55), Torino (34), Brescia (32).
Alunni rom, sinti e caminanti: di-minuiscono gli iscritti. Sono 11.899 glialunni rom iscritti nell’anno scolasti-co 2011/2012, il numero più basso de-gli ultimi cinque anni, in diminuzionedel 3,9% rispetto al 2010/2011. Si os-serva un calo degli iscritti nella scuo-la primaria -5,7% rispetto ai cinque anniprecedenti, e nelle scuole dell’infanzia,-5,8%, mentre risulta leggermente increscita il numero di iscritti nelle scuo-le secondarie di primo grado. Un for-tissimo calo di iscrizioni si registra giànel passaggio dalla scuola primaria allascuola secondaria di primo grado: solola metà degli alunni rom prosegue glistudi pur essendo nella fascia dell’ob-bligo di istruzione.
primo piano
10
Alcuni numeri sul paesaggio multiculturaledella scuola italiana

la scuola multietnica
11
DA
tI P
RIN
cIP
Al
IANNO scOlAstIcO 2011/2012
caratteristiche generali
Gli alunni con cittadinanza non italiana 755.939
L’incremento rispetto all’anno scolastico precedente + 45.676
L’incidenza degli alunni CNI sul totale degli alunni 8,4%
Il livello scolastico con l’incidenza più elevata Primarie: 9,5%
Le scuole con il maggior aumento rispetto all’a.s. 2010/2011 Infanzia: + 12.433
La nazione più rappresentata tra le provenienze Romania: 141.050
Numero di cittadinanze straniere 193
Le scuole superiori con una maggiore presenza di stranieri Istituti professionali 64.852
Le scuole superiori con l’incidenza più elevata Istituti professionali 12,1%
Presenze e dinamiche territoriali
La regione con il maggior numero di alunni CNI Lombardia: 184.592
La regione con l’incidenza più elevata Em. Romagna: 14,6%
La provincia con il maggior numero di alunni stranieri Milano: 69.801
La provincia con l’incidenza più elevata Prato: 18,8%
Associazioni tra cittadinanza e provincia più rilevanti 1. Ecuador-Genova
2. Tunisia-Trapani
3. Cina-Prato
4. Ucraina-Caserta
5. India-Cremona
scuole con elevata concentrazione di alunni stranieri
Le scuole con almeno un alunno con cittadinanza non italiana 44.716,
il 77,7% del totale
Le scuole con almeno il 30% di alunni con cittadinanza non italiana 2.499,
il 4,3% del totale
Scuole con almeno il 50% di alunni stranieri 415
Scuole dell’infanzia con almeno il 50% di alunni stranieri 233
Province con il maggior numero di scuole con almeno il 50% di alunni stranieri 1. Milano (55),
2. Torino (34),
3. Brescia (32)
Alunni rom, sinti, caminanti
Gli alunni rom 11.899
Rom nelle scuole secondarie di secondo grado 134
Femmine tra gli alunni rom 47,3%
Prime 3 regioni per alunni rom 1. Lazio (2.277),
2. Lombardia (1.727),
3. Piemonte (1.316)
Primi 3 comuni per alunni rom 1. Roma (2.027),
2. Milano (575),
3. Torino (516)
Nati in Italia
L’incidenza dei nati in Italia tra gli alunni con cittadinanza non italiana 44,2%
Le regioni con le maggiori percentuali di allievi nati in Italia Lombardia e Veneto: 50,9%
Nati in Italia tra gli stranieri nelle scuole dell’infanzia 80,4%
Nati in Italia tra gli stranieri al V anno delle sec. II grado 7,2%
La regione con la % più alta di nati in Italia nelle scuole dell’infanzia Veneto: 87,2%
La regione con la % più alta di nati in Italia nel V anno sec. II grado Sicilia: 15,0%
Ritardi, esiti
Stranieri iscritti in ritardo scolastico a 11 anni 27,6%
Stranieri iscritti in ritardo scolastico a 15 anni 70,9%
Stranieri ripetenti nel I anno di sec. II grado 12,3%

L a tutela dei diritti fondamenta-li delle categorie vulnerabili ri-vela secondo molti lo stato di
salute della democrazia di un paese,costituisce il barometro che segnal’equilibrio dei rapporti sociali di unterritorio. Nell’Europa del ‘13, dove persolide ragioni storiche e politiche l’at-tenzione alla condizione delle mino-ranze conserva un posto privilegiato,può sorprendere scoprire l’esistenza diclassi speciali per bimbi appartenentia gruppi minoritari. E’ ciò che anco-ra avviene in Slovacchia, dove i romcostituiscono circa il 9% della popo-lazione. Secondo recenti rapporti , i mi-nori appartenenti a questo gruppo sa-rebbero vittima di pratiche di segre-gazione scolastica, inclusi in pro-grammi didattici distinti e riservati aalunni con disabilità psichiche o nonspecificati ritardi cognitivi.In Italia le classi speciali, nate per con-trastare la dispersione scolastica deiminori rom e sinti, nacquero nel 1965da una Convenzione tra il Ministerodella Pubblica Istruzione, l’Istituto diPedagogia dell’Università di Padova e
l’Opera Nomadi. Il progetto prevede-va la creazione di classi speciali peralunni cosiddetti “zingari”, funzionantiall’interno delle scuole statali, con at-tività di mediazione e sensibilizzazio-ne delle famiglie e un servizio di tra-sporto degli alunni. Le LacioDrom(buon viaggio, in lingua romanì) si tra-sformarono negli anni ’70 in percor-si propedeutici all’inserimento ordi-nario degli alunni Rom, Sinti, Cami-nanti (di seguito RSC) nelle classi. Ul-teriori convenzioni, stipulate ad hoc percontrastare l’evasione scolastica e ri-durre i gap didattici dei minori RSCprevedevano interventi di sostegno peralunni con difficoltà di apprendimen-to attraverso l’assegnazione di inse-gnanti di sostegno. Con la CircolareMin. 207/1986, tali supporti doveva-no essere calibrati sulla base di progettieducativi mirati. L’osservazione del fe-nomeno in prospettiva diacronica fapensare ad un’evoluzione significati-va nell’approccio alla questione: dal-la sperimentazione emergenziale del-le LacioDrom ai progetti misurati sul-la cornice dei bisogni individuali. Parallelamente, nel contesto europeoil Consiglio d’Europa emanava una se-rie di risoluzioni e raccomandazioni sultema, proponendo la valorizzazione del
capitale linguistico-culturale delle po-polazioni romanì quale patrimonio del-la cultura del Vecchio Continente,rafforzando le iniziative nel settoreeducativo e scolastico.La questione dell’inserimento scolasti-co di bimbi stranieri (spesso nati in Ita-lia, e solo in alcuni casi non italofoni)emerge dirompente in diversi contesti,dalle periferie delle grandi aree urbanealle piccole comunità rurali. Spesso siacuisce, questa tensione, quando lo stra-niero è un bimbo rom o sinto, o quan-do l’inserimento di alunni rom e sinti siconcretizza in proporzioni ritenute ec-cessive per un “lineare” andamento deiprogrammi didattici delle classi.
Ma lo si sa che almeno la metà dei bambini Rom e Sinti sono italiani?
La contraddizione esplicita è che i bim-bi sinti sono bimbi italiani, parte di unaminoranza (mai riconosciuta de iure)che registra una secolare presenza inItalia (dal XIV secolo); parimenti, an-che tra i rom di più recente immigra-zione vi sono minori con cittadinan-
12
“ZINGARO”
L’istruzione è uno dei quattro cardini della politica di inclusione per Rom e Sinti
di Alessandro Pistecchia
* http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR72/001/2013/en/cce46ddf-7674-4cd1-b91d-9f649c2b8d3f/eur720012013en.pdf
Quando il compagno di classe è uno
Foto di M
assimo Ank
or - Ide
a Rom
Torino

za italiana, ma qualificati a volte nelsistema scolastico come alunni “no-madi”, in particolare laddove siano in-seriti in progetti di scolarizzazione fi-nanziati dagli Enti locali e attuati daassociazioni del terzo settore.Da una lettura analitica della complessaquestione rom/istruzione emergonoalcuni elementi degni di riflessione, ge-neralmente ritenuti legati alle proble-matiche più frequenti nella scolarizza-zione dei rom (l’elevata dispersione sco-lastica, lo scarso accesso ai livelli su-periori di istruzione, la limitata fiduciae partecipazione delle famiglie nei per-corsi scolastici dei minori):- Carenza di strumenti e risorse ade-guati proposti dalle scuole per l’ot-tenimento di risultati efficaci: fru-strazione di insegnanti non forma-ti e/o poco sostenuti nell’attuazionedi piani individualizzati;
- Difficoltà attribuite a complessità edifferenze linguistiche, oralità dellacultura romanì, ecc.(approccio cul-turalista);
- Problematiche sociali, a volte ste-reotipate, riguardanti la condizioneabitativa (circa la metà dei RSC vivein campi, di diverse dimensioni econdizioni), le difficoltà di accessoai servizi territoriali, l’elevato tassodi analfabetismo degli adulti, ecc.;
- Discontinuità di approcci, strategieassistenzialiste, scarsa sinergia tra isoggetti attuatori.
Si ricorda come le politiche scolasti-che rivolte alle comunità romanì fos-sero storicamente impostate in chiaveinclusiva-assimilativa, con diversigradi di coinvolgimento e coercizione.
Dalle politiche del dispotismo Illumi-nato asburgico del XVIII secolo al-l’opera postbellica di alfabetizzazionedi missionari e religiosi, dai piani in-clusivi delle repubbliche popolari neidecenni del socialismo reale ai progettidi scolarizzazione attuali, ricorre unacarenza di risultati concreti in mate-ria di formazione scolastica per i RSC.
Coinvolgimento dei genitori e prospettivainterculturale: gli strumenti per sostenere lascolarizzazione dei Rom
Va menzionata, tuttavia, l’esistenza dipercorsi virtuosi tesi all’autonomia eallo stimolo della genitorialità, diesperimenti interculturali mirati e tesial coinvolgimento del gruppo classe. Lavalorizzazione dei diversi modelli inprospettiva interculturale rappresentaun efficace strumento di contrastoalle discriminazioni e al pregiudizio an-tigitano, fortemente radicato, oltreche un ostacolo all’auto-svalutazioneidentitaria del minore, evitando feno-meni di rigetto della cultura di origi-ne. Anche il problema della dispersio-ne scolastica richiede percorsi proget-tuali mirati e attività di mediazione diesperti nel settore interculturale, atto-ri pronti a intervenire in contesti sco-lastici complessi come agenti di con-trasto all’etnocentrismo culturale. Da questi approcci, sempre più condi-
visi, è necessarioimpostare un’azionearmonica di inte-razione tra istitu-zione scolastica econtesti familiari,valorizzando real-mente il patrimonioculturale, il romanìcome idioma dina-mico e come linguad’Europa, patrimo-nio di un popoloeuropeo, presentein tutti gli stati eu-ropei e protagonistadel cambiamento
che ha storicamente caratterizzato ilVecchio Continente.Tornando ai temi introduttivi, l’inte-grazione nel sistema scolastico dialunni con determinate caratteristichesocio-culturali - evitando etnicizza-zioni del problema e classificazioni inmacrocategorie fuorvianti (alunni stra-nieri, alunni nomadi) - deve prevede-re una distribuzione omogenea nelleclassi e la possibilità di modularepiani formativi calibrati sui cosiddet-ti bisogni educativi speciali, concettointrodotto recentemente nella pro-grammazione ministeriale. Dopo (se-colari) tentativi di inclusione scolastica,la nuova prospettiva tende a evitarepolitiche scolastiche ad hoc per alun-ni rom/sinti, ma non può prescindereda un coinvolgimento sempre mag-giore delle famiglie, nel rispetto del-l’organizzazione sociale e parentale deigruppi. Sistema romanes e istituzionescolastica dei gagé (i non rom), spes-so distanti, hanno il dovere di dialo-gare evitando conflitti: la scuola nonpuò rappresentare una realtà esterna,minacciosa e competitiva rispetto almodello educativo tradizionale, ma unluogo di incontro e dialogo tra le mu-tevoli identità che ne fanno parte. Siamo nella fase di attuazione dellaStrategia Nazionale di Inclusione deiRSC, adottata il 24 febbraio 2012 dalGoverno e di cui l’UNAR è Punto diContatto Nazionale. La Strategia nascein un’ottica di superamento definitivodella logica emergenziale e di politichepreconcette sui RSC. L’istruzione rap-presenta uno dei quattro assi (con oc-cupazione, salute e alloggio) individuatiquali prioritari dalle Istituzioni UE econtiene diversi obiettivi specifici:promozione dell’accesso non discri-minatorio nel sistema scolastico, con-trasto alla dispersione, promozionedel confronto tra istituzioni scolastichee comunità, formazione di docenti e di-rigenti scolastici. L’auspicio è che, per questa via, si riescaa ridurre ledistanze tra i mondi rom e gagé.
la scuola multietnica
13
Foto di M
assimo Ank
or - Ide
a Rom
Torino

Prendi la laurea
e scappa
Ancora troppo pochi. E ancora troppo poco considerati
A fronte delle migliaia di diplo-mati e laureati italiani cheogni anno rimpolpano le sta-
tistiche dei “cervelli in fuga” dal nostroPaese, esiste un flusso contrario di ra-gazzi stranieri che scelgono di studia-re e specializzarsi nelle università ita-liane. Si tratta, secondo gli ultimi dati
del Ministero dell’Istruzione, di ol-tre 79.000 studenti, inclusi i
figli di immigrati sog-giornanti in Italia
(circa un terzodel tota-
di Roberta Cocchioni
Foto di R
oberta Lulli

le). Una vera miniera di opportunità perquesto nostro Paese in affanno, consi-derato che si parla di giovani con altolivello di istruzione, motivazione evolontà di inclusione, assai disponibi-li al sacrificio personale e familiare purdi sviluppare il proprio talento ed af-fermarsi in termini professionali e di ri-conoscimento sociale.Sarebbe sbagliato non considerarequesti 79.000 studenti stranieri comeponti privilegiati sia per lo sviluppodelle relazioni politiche ed economi-che con i loro Paesi di origine, checome chiave per la costruzione di unavera società multiculturale in Italia.Questi giovani contribuiscono alladiffusione internazionale della no-stra lingua, fanno da richiamo e dapunto di riferimento per l’inserimen-to positivo di altri stranieri in Italia epotrebbero essere inseriti e valorizza-ti dopo la laurea come lavoratori spe-cializzati, portatori di un grande va-lore aggiunto in termini di competenzelinguistiche, propensione alla mobili-tà e capacità interculturali.Ma l’incontro con alcuni di loro rivelauna realtà forse non ben conosciuta.Iyed Zahed e Osama Al Saghir sono en-trambi di origine tunisina. Il primo è ar-rivato quattro anni fa dalla Tunisia perstudiare Scienze della Comunicazione aLa Sapienza di Roma, il secondo è cre-sciuto in Italia da rifugiato politico edè laureato in Scienze Politiche presso lastessa università. Tutti e due si trovanoa studiare in Italia non per scelta, ma pernecessità personali o familiari, e si di-cono pronti a giurare che quasi tutti glistudenti stranieri che frequentanoun’università italiana lo fanno permancanza di alternative migliori. Se-condo la loro esperienza, la metà di quel-li che riescono ad iscriversi non termi-na il percorso di studi: alcuni si metto-no a lavorare, altri tornano nel loro Pae-se oppure restano in Italia da clandestini.L’altra metà, quella che si laurea, appe-na ne ha l’occasione, a loro avviso, scap-pa. Scappa per trovare lavoro altrove op-pure per specializzarsi in un altro Pae-se, come la Francia o la Germania, dovele condizioni di studio e di vita per glistudenti stranieri sono migliori che inItalia.A confermare, almeno in parte, la loroopinione è anche il risultato della ri-
cerca recentemente condotta da Eu-ropean Migration Network Italia su1200 studenti universitari stranieri, chemostra come solo il 40% degli inter-vistati sia intenzionato a restare nel no-stro Paese.
Ma quali sono gli ostacoli che in-contra un ragazzo straniero che sce-glie l’università italiana?È Iyed il primo a parlarne e ci tiene aprecisare che le difficoltà inizianogià prima dell’arrivo, quando lo stu-dente si rivolge agli istituti italiani dicultura all’estero per tutte le praticheche riguardano l’iscrizione al test diammissione universitario, il visto el’apprendimento della lingua. Secon-do la sua esperienza, c’è una scarsis-sima cooperazione tra le università ita-liane, i sistemi regionali di diritto allostudio e gli uffici diplomatici italiani.Ci racconta che i corsi di lingua italiana
sono insufficienti per il li-vello richiesto dalle nostreuniversità e che gli uffici di-plomatici non fornisconoinformazioni adeguate sul-le modalità di accesso alleborse di studio o ai posti al-
loggio riservati agli studenti stranie-ri, cose che si scoprono troppo tardiuna volta arrivati in Italia. Per di più,non di rado, il visto di ingresso vienerilasciato un paio di giorni primadella data del test di ammissione,
con vari problemi organizzativi per lostudente, che vanno dal trovare unvolo aereo libero al reperimento di unalloggio in pochi giorni. Alcuni nonsuperano il test d’ingresso a causa diproblemi burocratici o linguistici e per-dono così la possibilità di iscrizione edi permesso di soggiorno, diventandoclandestini.
università e studenti stranieri
15
Secondo i dati del Miur sono 79.000 studenti, inclusi i figli di immigrati soggiornanti in Italia.
Foto di R
oberta Lulli

Nei casi in cui il test viene superato (pergli stranieri c’è un punteggio minimodi 20/30 da raggiungere, che non è ne-cessario per i cittadini italiani), inizianoaltre difficoltà. La prima, e forse la piùincredibile, è la totale mancanza di ac-coglienza, orientamento ed informa-zione specifica per gli studenti stranieri,riscontrata da Iyed a Roma così comeda altri suoi compagni in altre sedi uni-versitarie. I servizi di segreteria perstranieri si limitano a ricevere docu-menti, gli operatori spesso non parla-no altre lingue al di fuori dell’italia-no e non danno informazioni utili sucome risolvere i problemi principalidello studente straniero, che sono: tro-vare un posto letto a basso costo, im-parare la lingua, accedere a borse distudio, trovare un lavoro per sostenersi,trovare i libri di testo usati o gratuiti.Lo stesso sembra valere per le asso-ciazioni studentesche e per gli altri ser-vizi di informazione presenti negli ate-
nei, che non tengonoconto delle esigenzespecifiche degli stu-denti stranieri.Il risultato è il com-pleto smarrimentoquando si arriva inItalia, a cui si aggiun-gono le normali diffi-coltà di inserimentosociale e di otteni-mento e rinnovo deipermessi di soggiorno.La soluzione adot-tata fino ad oggi è lacollaborazione in-formale tra studentidello stesso Paese, cosa che lo stessoIyed sta facendo con gli altri tunisiniche arrivano alla Sapienza. Mi raccontail caso emblematico di un ragazzo chesi è rivolto a lui recentemente, arrivatoin Italia per studiare con 500 euro intasca, frutto della vendita da parte del-la sua famiglia in Tunisia del loro uni-co terreno agricolo. Questo ragazzo,giunto troppo tardi per accedere allegraduatorie dei posti alloggio e delleborse di studio regionali, ha speso tut-ti i suoi soldi in una settimana per sog-giornare in un hotel della capitale.
Quello del costo dello studio uni-versitario, infatti, è il secondo gran-de ostacolo da affrontare. La Fon-dazione Leone Moressa nel 2012 ha sti-mato in 15.400 euro annui l’ammon-tare della spesa media per ciascuno stu-dente straniero in Italia. I dati OCSE sulla qualità dei sistemi diistruzione mostrano l’Italia al penul-timo posto nella classifica europea del-la spesa pubblica in questo settore. Glistrumenti finanziari di sostegno per glistudenti universitari, italiani e stranieri,si dimostrano inadeguati rispetto al nu-16
Dal colloquio con Iyed ed Osama,studenti di origine tunisina esce l’immagine di uno Stato respingente nei confronti degli studenti stranieri, che ostacola il loro percorso di studi in varimodi ed applica diverse forme di discriminazione diretta e indiretta nei loro confronti.
Foto di R
oberta Lulli

17
mero di studenti in condizioni di di-sagio economico. Basti dire che i po-sti letto gratuiti disponibili copronosolo il 2,8% della popolazione uni-versitaria. La maggior parte degli stu-denti stranieri che arrivano in Italia haun reddito inferiore rispetto a quellodichiarato (necessario per poter entrare)e non riesce a proseguire gli studi perproblemi economici.Le soluzioni ci sarebbero e non com-portano necessariamente un aumentodella spesa pubblica, che pure è ne-cessario. A proporle è proprio Osama,oggi cittadino italiano, trasferitosi al-l’estero dopo la laurea per specializzarsiin relazioni internazionali.Osama è convinto che lo Stato italia-no dovrebbe investire più risorse peril sostegno economico degli studentistranieri, abbassando eventualmente laquota di studenti ammessi, ma pun-tando a sostenere davvero e a tratte-nere in Italia quelli che entrano. Altresoluzioni risiedono nella semplifica-zione burocratica, ad esempio sosti-tuendo uno sconto sulle tasse univer-sitarie alla pratica farraginosa dellaconcessione delle borse di studio. Iyedfa l’esempio della Francia, dove anzi-ché concedere dei posti alloggio, checomportano anche spese di gestione,lo Stato concede direttamente ed inqualsiasi periodo dell’anno un rimborsodel 60% sull’affitto pagato dallo stu-dente. Dal colloquio con Iyed ed Osa-
ma ne esce l’immagine di uno Stato re-spingente nei confronti degli studen-ti stranieri, che ostacola il loro percorsodi studi in vari modi ed applica diverseforme di discriminazione diretta e in-diretta nei loro confronti. Osama miporta l’esempio del divieto di accessoalle scuole di specializzazione per chinon ha la cittadinanza italiana, oppuremi spiega come lui stesso, a causa diproblemi di durata e rinnovo del per-messo di soggiorno, non abbia mai po-tuto partecipare ad opportunità appa-rentemente aperte a tutti, come l’Era-smus.Tutto questo, lungi dal creare ricono-scenza ed attaccamento, non fa che ali-mentare un rapporto di sfiducia e diconflitto tra gli studenti stranieri e leistituzioni dello Stato italiano. E la ri-
sposta degli studenti stranieri, fino adoggi, sembra essere, come per moltilaureati italiani, la fuga.PS. Peccato che la notizia di una buo-na iniziativa per gli studenti stranie-ri iscritti nelle università italiane sia ar-rivati tardi dopo il nostro colloquio: undecreto del Governo ha stabilito chenon dovranno più rinnovare di annoin anno il permesso di soggiorno e chetale permesso è stato esteso a tutta ladurata degli studi.
Foto di R
oberta Lulli
Foto di R
oberta Lulli
Foto di R
oberta Lulli

N el mese di Settembre l’Ordinedegli Psicologi del Lazio hapromosso un convegno dal ti-
tolo “Omofobia sociale e interiorizza-ta: come curarla”. Il titolo della gior-nata nasce da una constatazione, quel-la che oramai, il “problema” da capi-re e possibilmente da curare, non sia,Come per buona parte del secolo scor-so si è assurdamente creduto, l’omo-sessualità, bensì l’omofobia. Per ap-profondire i molti risvolti della que-
stione ne abbiamo parlato con Anto-nella Montano e Antonio Zagaroli. Laprima è la direttrice dell’Istituto A. T.Beck, un centro di terapia cognitivo-comportamentale che ha sede a Romaed è intitolato al dott. A.T. Beck, fon-datore, negli anni ’60, di questa psi-coterapia, oggi adottata nella praticaclinica da numerosi psicoterapeuti inEuropa e nel mondo. E’ una terapia dibreve durata e rivolta a risolvere i pro-blemi del presente. Antonio Zagaroli,
membro del-l’Istituto, è il re-sponsabile di unprogetto, deno-minato “Educarealla diversità ascuola”, com-missionato re-centemente dal-l’Unar all’Istitu-to Beck.
Vorrei iniziarequesta intervi-sta sofferman-domi sulla pa-rola “omofobia”.L’omofobo è“colui il qualeha paura dellepersone Lgbt”.Non manca in
approfondimento
Gli omofobisono un problema sociale.Ma si possonocurare
a colloquio con Antonella Montano e Antonio Zagarolidell’istituto A. T. Beck
a cura di Paola Di Lazzaro
«Non si nasce omofobi:lo si diventa attraversol’educazione,i messaggi, diretti e indiretti, che la famiglia, la politica, la Chiesa e i media, ci trasmettono»

questa parola tutto ciò che questapaura produce in termini di violen-za? Esiste una parola più appropria-ta in questo senso?“Omofobia” è un termine coniato dal-lo psicologo George Weinberg, per de-finire la paura irrazionale, l’intolleranzae l’odio nei confronti delle personeomosessuali da parte della societàeterosessista. Noi all’Istituto Beck la de-finiamo “quell’insieme di pensieri cheprovocano emozioni quali ansia, pau-ra, disgusto, disagio, rabbia, ostilità neiconfronti delle persone omosessuali”.Fin da bambino, l’omosessuale haacquisito, infatti, convinzioni e valo-ri da una cultura omofoba che gli sonostati presentati come assolutamentegiusti e legittimi. Molto prima, dunque,di avere una reale comprensione dicosa significhi la parola omosessuali-tà, i bambini ricevono un set di in-formazioni che vengono codificatenella convinzione che essere gay siaqualcosa di assolutamente sbagliato,innaturale e contrario alle norme delvivere comune.Il termine “omofobia”, di etimologiagreca, utilizza il suffisso “fobia”, si-nonimo di paura, insieme al prefisso“omo”, che qui perde il suo significa-to originario di “stesso” per trasformarsinell’abbreviazione di “omosessuale”.Come lei giustamente fa notare, in ge-nere il termine clinico “fobia” indicauna paura, un’incapacità, un limite per-sonale, che il singolo individuo si tro-va a vivere e che cerca di superare percondurre un’esistenza più piena. Nelcaso dell’omofobia, invece, per citare
ancora Weinberg, ci troviamo di fron-te a una “fobia operante come un pre-giudizio”. Tale caratteristica implica chegli effetti negativi siano avvertiti nonsolo (e in questo caso non tanto) da co-lui che ne è affetto, quanto da coloroverso cui questo pregiudizio è rivolto:le persone omosessuali, appunto.Una parola che meglio potrebbe espri-mere le caratteristiche di ostilità rivolteverso gli omosessuali potrebbe essere,ad esempio, “omoavversione”. Tutta-via, ormai il termine “omofobia” è en-trato nell’uso comune e la componenteviolenta di questo pregiudizio è pur-troppo ben nota a tutti.
Ma da cosa scaturisce l’omofobia?Perché le persone sono omofobe?Sulla risposta a questa domanda sisono scritti interi volumi a stampo psi-cologico, sociologico, politico o reli-gioso. La prima cosa che vorremmochiarire è che non si nasce omofobi;lo si diventa attraverso l’educazione,i messaggi, diretti e indiretti, che la fa-miglia, la politica, la Chiesa e i media,ci trasmettono. Tale educazione è per-vasiva e inizia da subito, attraverso at-teggiamenti, credenze, comportamen-ti discriminatori. Ci investe a ogni li-vello e dipende anche dal posto an-tropologico in cui nasciamo e cre-sciamo. In particolare in Italia (non a caso unodei pochi paesi occidentali dove ancoranon ci sia alcun riconoscimento del-le coppie dello stesso sesso), la Chie-sa esercita un’alta ingerenza sulle fa-miglie, sulla politica e sulla capacità
legislativa conseguente. Sintetizzando,potremmo dire che la posizione uffi-ciale della Chiesa cattolica accoglie gliomosessuali, solo a patto che questirinneghino se stessi, riconoscendo il di-sordine e il male della propria condi-zione di vita, accettando la castità e lacostrizione come elemento perma-nente dell’intera loro esistenza. Le pres-sioni esterne sono così alte che nonpossono non sfociare nell’omofobia in-teriorizzata al punto che è elevata l’in-cidenza statistica dei suicidi tra gliomosessuali adolescenti, soprattutto secredenti.Il difficile cammino parlamentare del-la legge sull’omofobia, con il sub-emendamento Gitti che ne snatura inbuona parte il senso, affermando chenon costituiscono atti di discrimina-zione le condotte delle organizzazio-ni di natura politica, sindacale, cultu-rale, sanitaria, di istruzione ovvero direligione o di culto, se assunte all’in-terno dell’organizzazione, è un altromessaggio omofobo molto chiaro chearriva alla società nel suo complesso.Bisogna rendersi conto che, tanto perfare un esempio, quando un cardina-le o un politico fanno l’equazionegay=pedofilo, senza alcuna conse-guenza personale per aver diffuso unconcetto stupido e falso (il 95% dei pe-dofili è eterosessuale, secondo uno stu-dio del 1994), questo fa aumentarel’omofobia.In aggiunta a tutto questo, va consi-derato che la paura del “diverso” èqualcosa di radicato nell’animo uma-no. Nella storia del mondo occidenta-le è successo più volte che individui o
19
discriminazioni e bullismo
«La cura è liberarsi dai pregiudizi»

gruppi sociali che si differenziavanodalla maggioranza dominante, adesempio per il colore della pelle, per ilcredo religioso, per il sesso, siano sta-ti vittime di fenomeni di oppressione,di un atteggiamento generalizzato didiffidenza o disprezzo. Per di più, vaconsiderato che i cambiamenti socia-li a cui assistiamo (maggiore integra-zione razziale, maggiore visibilità de-gli omosessuali, legalizzazione deimatrimoni gay in larga parte delmondo occidentale) possono stimola-re ulteriormente la paura del cambia-mento e rendere, perciò, alcuni indi-vidui più sospettosi e ostili e, quindi,più inclini a sviluppare sentimentiomofobici. Naturalmente, come per al-
tre forme di pregiudizio (razzismo esessismo in primis), un fattore di rilievoperché un individuo sia omofobo è co-stituito da una componente persona-le di chiusura mentale e rigidità.Quindi, per riassumere, diremmo chel’omofobia scaturisce da tutti quei mes-saggi negativi nei confronti degliomosessuali, frutto dell’educazioneche abbiamo ricevuto, che dipendonoovviamente non solo dalla nostrasingola famiglia, ma anche dal postoantropologico in cui siamo nati ecresciuti e dalle principali istituzionidella nostra società, quali la scuola, loStato e la Chiesa. Tali messaggi nega-tivi formano quelle che in psicotera-pia si chiamano credenze intermedie,cioè gli atteggiamenti con cui ci ap-procciamo al mondo, le regole con cuiviviamo, le assunzioni che abbiamo.Si può parlare di cure?
Nel 1971 in Germania è uscito il film Itis not the Homosexual who is perver-se, but the society he lives in (Non èl’omosessuale a essere perverso, ma lasocietà in cui vive). Nel 1972 Weinbergha pubblicato Society and the healthyhomosexual (La società e l’omosessua-le sano). Nel 1973 l’American Psychia-tric Association ha rimosso l’omoses-sualità dalla lista delle malattie mentali,definendola “una variante non patolo-gica dell’orientamento sessuale”. Che ilproblema non sia più l’omosessualità,dunque, dovrebbe essere chiaro da al-meno 40 anni, sebbene ancora ci sia chiparla, senza alcun appoggio scientifi-co, di terapie riparative.Il problema, come lei giustamente
nota, è l’omofobia.Brevemente, pos-siamo dire che esi-stono due tipi diomofobia: quellaa cui ci riferiamodi solito è l’omo-fobia sociale; l’al-tra forma è quellainteriorizzata, cioè
l’ansia, il disprezzo e l’avversione chegli omosessuali provano nei confron-ti della propria omo-sessualità e di quel-la di altre persone.L’omofobia interio-rizzata, come giàdetto, è frutto di tut-ti i pregiudizi, com-portamenti e opi-nioni discriminatoriee incide profonda-mente, come agentepatogeno, sul be-nessere dei pazienti.L’ostilità appresa fasì che la formazionee l’asserzione dellapropria identità ses-suale costituiscanoper l’individuo gay elesbica un processoimpegnativo chenon potrà non ri-flettersi sul senso disé in età adulta.Per quanto riguardal’omofobia sociale,possiamo dire che la
cura principale consiste nell’educazionedi tutti i cittadini al rispetto degli al-tri e all’apertura mentale, o meglio nel-la contro-educazione rispetto a tutti imessaggi “educativi” ricevuti che cihanno proposto l’equivalenza gay=ma-lato, peccatore, deviato, minaccia perla società, contro-natura. Certamente,in questo quadro, un progetto politicoche si impegnasse in tal senso (ad esem-pio, approvando leggi favorevoli aunioni/matrimoni omosessuali, pro-muovendo campagne pubblicitarie,includendo le tematiche del rispetto edell’apertura nei programmi scolasti-ci) potrebbe fare moltissimo. Ognivolta che si organizza un “familyday”, o si parla di “minacce alla fami-glia tradizionale”, si contrappone unmodello di famiglia da pubblicità allefamiglie omosessuali, come se l’inten-to di gay e lesbiche non fosse avere unriconoscimento del loro amore e di tut-ti i diritti conseguenti, ma quello di sov-vertire la società come noi la cono-sciamo. Questi sono messaggi profon-damente omofobici, che discriminanotra cittadini a cui sono concessi dei di-ritti e altri a cui non sono concessi acausa del loro orientamento sessuale.
20
approfondimento
La società si comporta come se gli omosessuali non esistessero e,quindi, i genitori e gli insegnanti sono in genere totalmente impreparati a confrontarsi con un figlio o con uno studente omosessuale

Per quanto riguarda l’omofobia inte-riorizzata, più che di una cura, c’è bi-sogno di prendere consapevolezza deipregiudizi che la singola persona hametabolizzato nel corso della propriaesistenza e che, magari, ne condizio-nano i pensieri e le scelte. Da quandonasciamo, i nostri genitori prima e lasocietà poi ci bombardano con mes-saggi educativi, che sono delle vere eproprie frecce che si vanno a confic-care nella nostra mente. Il primo è chedobbiamo rispettare e obbedire aun’autorità superiore (famiglia, poiscuola, e infine Chiesa e Stato). Il se-condo è che il sesso è peccato (e quin-di il sesso “contro-natura” è doppia-mente peccato). E poi impariamo chei gay sono effeminati e le lesbiche ma-scoline, che i gay non sono veri uo-mini, che gli omosessuali si possonoderidere, insultare ed eventualmentepicchiare, che “frocio” è un insulto mil-le volte peggiore di “stronzo”.Tutti questi messaggi negativi, cosìpervasivi, possono avere un impatto pro-fondo sull’individuo, facendolo sentiresbagliato e causando bassa autostima,difficoltà di tipo relazionale, isolamen-to e autoesclusione sociale, sensi di col-pa e vergogna, sintomi di tipo depres-sivo o ansioso, angoscia. Tutto ciò puòsfociare in pensieri suicidi e attività adalto rischio (ad esempio, sesso non pro-tetto o abuso di alcool o sostanze stu-pefacenti). Sono diversi gli studi che mo-
strano che adolescenti gay e bisessua-li hanno più alte probabilità di tentareil suicidio, come abbiamo già detto. In questi casi, può essere, comunque,di grande aiuto una psicoterapia co-gnitivo-comportamentale, con un te-rapeuta che conosca a fondo queste te-matiche. Ci tengo a sottolineare que-sto punto (parla la dott.ssa Montano):ho scritto un libro nel 2000, Psicote-rapia con clienti omosessuali, proprioperché ritengo che la preparazione delterapeuta su queste tematiche sia fon-damentale. Crescere e vivere da per-sona LGBT in Italia è molto diverso checrescere da eterosessuale, il terapeutadeve essere informato sulle sfide spe-cifiche che l’individuo LGBT si trovaad affrontare.
Esistono tante varianti dell’omofobia:private, politiche, religiose, da stra-da, a scuola, a lavoro, in famiglia,etc. Ma si può tracciare un profilo del-l’omofobo?Negli Stati Uniti sono stati condotti di-versi sondaggi per tracciare un simi-le profilo. Noi stessi all’Istituto Beck ab-biamo realizzato uno studio in tal sen-so. L’omofobo è più spesso di sesso ma-schile, di età avanzata e scarsa cultu-ra. Inoltre, l’omofobia è più pronun-ciata verso l’omosessualità maschileche femminile. Ovviamente si tratta di una miscela difattori caratteriali, sociali e culturali. La
tendenza all’autoritarismo, il livello direligiosità e di rigidità mentale costi-tuiscono elementi importanti da tene-re presenti nel tracciare il profilo di unindividuo omofobo. È evidente, inol-tre, che i tratti appena indicati a merotitolo esemplificativo non solo rendo-no più probabile che un individuo siaomofobo, ma anche che coltivi dentrodi sé altre forme di pregiudizio.
A un ragazzo vittima di bullismoomofobico come consigliereste dicomportarsi?Innanzitutto lo inviteremmo a chie-dere aiuto. Bisogna tenere presenteche spesso la vittima non ha il co-raggio di denunciare i suoi aggressori,non solo per paura di ritorsioni (cheè un elemento tipico del bullismo ingenerale), ma anche per evitare dimettere ancora di più al centro del-l’attenzione pubblica la propria omo-sessualità, vera o presunta, la propriadiversità. Soprattutto di fronte alla fa-miglia. Purtroppo gli adolescentiLGBT spesso non trovano nella pro-pria famiglia un porto sicuro, ma anzinascondono il proprio orientamento,i dubbi sui propri gusti sessuali, per
21
discriminazioni e bullismo

timore di non essere più amati o ac-cettati. Questo avviene perché la società è ete-rosessista e dà per scontato che l’orien-tamento sessuale delle persone sia ete-rosessuale o che comunque la cosa piùgiusta è essere eterosessuali. Baste-rebbe, invece, che nei corsi pre-partovenisse detto ai genitori: “Signori, unapercentuale tra il 5% e il 10% della po-polazione è omosessuale. Tenete pre-sente che potrebbe esserlo anche vo-stro figlio” e che poi venisse fornito unminimo di educazione in merito, che
venisse normalizzato l’eventuale orien-tamento omosessuale del nascituro. In-vece, la società si comporta come se gliomosessuali non esistessero e, quindi,i genitori o gli insegnanti sono in ge-nere totalmente impreparati a reagirea un figlio o a uno studente che vie-ne deriso o picchiato a scuola perché“finocchio”. Allo stesso modo gli ado-lescenti che avvertono dentro di sé sen-timenti e pulsioni omosessuali sonospaventati, perché nessuno ha dettoloro da bambini che un principe puòinnamorarsi di un altro principe, e unaprincipessa può volersi fidanzare conun’altra principessa. Inoltre, diremmo al ragazzo di impa-rare a sviluppare un atteggiamento as-sertivo. Tuttavia, se c’è un potenzialepericolo (magari perché uno dei bulliha un’arma o perché i bulli sono piùdi uno), chiedere aiuto è sempre la so-luzione migliore.È chiaro che a questo punto, però, do-vrebbero essere le famiglie e la scuo-la a sapere come intervenire, cosa che,purtroppo, accade di rado.
E quale approccio dovrebbero usaregli insegnanti in classe per preveni-re, ma anche eventualmente inter-venire, in caso di episodi di bullismoomofobico?Le citiamo un dato. In un sondaggioitaliano del 2012 è risultato che i do-centi - secondo l’85% degli intervistati- pur essendo consapevoli delle di-scriminazioni di carattere sessualecompiute dai propri studenti, nonhanno assunto iniziative a difesa de-gli alunni discriminati. Dati non dis-simili risultano purtroppo anche da
studi condotti in altre re-altà, talvolta percepitecome più avanzate ri-spetto a quella italiana,come dimostra il recen-te “The School Report”(2012), condotto da Sto-newall nelle scuole del-
la Gran Bretagna. Gli insegnanti, in-vece, dovrebbero essere la risorsa piùdisponibile nei contesti scolastici peraiutare gli studenti a comprendere e af-frontare il proprio orientamento.Questo non solo non avviene, ma tal-volta gli insegnanti, pur disponibili,non sono in possesso delle competenzeper contenere e arginare il bullismo,frutto dell’omofobia. Non è pertantosufficiente essere gay-friendly (ami-chevoli nei confronti di gay e lesbiche),ma è necessario essere gay-informed(informati sulle tematiche gay e le-sbiche).Affrontare l’omofobia e il bullismoomofobico può essere difficile perqualche insegnante. Questi può sentirsiinsicuro a portare avanti tali temati-che, o addirittura minacciato da unpunto di vista personale e professio-nale. Ciò avviene perché le questioniriguardanti l’omosessualità, soprat-tutto in Italia, sono permeate di con-dizionamenti culturali e sociali del-l’ambiente esterno e non vengonoinsegnate tra i banchi di scuola.
L’Istituto Beck, su incarico dell’UNAR,ha realizzato il progetto ‘Educare alladiversità a scuola’ ci raccontate qual-cosa di questa iniziativa?Nel 2008, in California, Larry King,uno studente quindicenne, fu ucci-so da un altro studente a cui Larry
aveva chiesto un appuntamento peril giorno di San Valentino. Questoè un esempio, estremo, delle conse-guenze dell’omofobia sulla vita del-le persone, anche e soprattutto quan-do sono molto giovani e senza dife-se. Dopo tanti anni a occuparci diomosessualità, all’Istituto Beck ab-biamo capito che la cosa più impor-tante è educare le persone all’omo-sessualità. Come si può ottenerequesta educazione? Parlando di omo-sessualità, mostrandone la normali-tà, insegnando che le persone sonomolto di più del loro orientamentosessuale, che questo orientamento èsolo una parte.Lo scopo del progetto è, dunque, didare agli insegnanti e alle scuole unostrumento che consenta loro di ac-quisire le conoscenze necessarie per af-frontare gli argomenti del bullismo edell’omofobia, così da poter diventa-re “educatori dell’omofobia”.Il progetto, fatto su misura per i diversicicli scolastici, si compone di tre parti:• Schede informative rivolte agli in-
segnanti. Tali schede mirano afornire conoscenze aggiornate epuntuali sui temi dell’identità e del-l’orientamento sessuale, dell’omo-fobia sociale e interiorizzata e delbullismo omofobico.
• Una cassetta degli attrezzi. In que-sta sezione sono presentati una se-rie di strumenti utili per l’imple-mentazione di una politica di pre-venzione e lotta al bullismo.
• Lezioni da tenere in classe. Le le-zioni sono pensate per dare aglistudenti di ogni ciclo scolastico lapossibilità di comprendere i temi delbullismo, della diversità, del-l’omofobia, in maniera attiva, nonteorica.
Il fine del progetto è di rendere le scuo-le più aperte e accettanti, scuole del-le pari opportunità, che consentano efavoriscano lo sviluppo sano di tutti iragazzi, indipendentemente dal-l’orientamento sessuale. Quello che ciprefiggiamo con quest’intervento è diriuscire a prevenire e combattere il bul-lismo omofobico, così pervasivo nel-le realtà scolastiche e, speriamo, di con-tribuire a costruire una società più ri-spettosa e inclusiva.22
approfondimento
A un ragazzo vittima di bullismodiciamo di chiedere aiuto. Ma anche di imparare a non subire in silenzio i soprusi

S ubire violenze, minacce o ag-gressioni, fisiche o verbali, daparte di un coetaneo, è un’espe-
rienza che tocca un numero semprecrescente di bambini e di ragazzi intutta Europa. Si tratta di episodi chedai banchi di scuola e dalle strade sistanno trasferendo in maniera cre-scente su internet e sugli altri mezzidi comunicazione elettronica, congravi conseguenze sulla crescita emo-tiva e sociale delle giovani vittime, chein alcuni casi vengono spinte ad attidi autolesionismo e di suicidio. La di-namica della prevaricazione che en-tra in gioco negli atti di bullismo col-pisce soprattutto i ragazzi più debo-li, cioè i ragazzi con disabilità fisicheo psichiche, i ragazzi appartenenti aminoranze etniche o i giovani e le gio-vani con orientamento sessuale di-verso dall’etero sessualità. Sebbene ladiversità non sia l’unica causa scate-
nante dei comportamenti violentimessi in atto dal “bullo”, essa è in-dubbiamente un fattore cruciale percomprendere la dinamica del feno-meno, le forme in cui si manifesta eper individuare i metodi più efficacidi prevenzione e contrasto.Ne abbiamo parlato con la psicolo-ga Anna Costanza Baldry, docentepresso il Dipartimento di Psicologiadella Seconda Università degli Stu-di di Napoli e coordinatrice del pro-getto europeo TABBY (Threat As-sessment of Bullying Behavior: Va-lutazione della minaccia di cyber-bullismo nei giovani).
23
Razzismo, omofobia, discriminazione: i pretesti del bullo
intervista adAnna Costanza Baldrydel Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli
di Roberta Cocchioni

Perchè si parla molto di bullismosolo da pochi anni? Si tratta di unfenomeno recente oppure identifi-cato recentemente?E’ vero, il bullismo fra ragazzi è espe-rienza anche dei nostri nonni e for-se bisnonni. In Italia se ne è comin-ciato a parlare solo negli anni ’90,grazie ai primi studi scientifici con-dotti nelle scuole. Questi studi han-no infatti svelato la vastità del fe-nomeno, mostrando che un ragazzo
su quattro/cinque, nel corso delproprio anno scolastico, era ogget-to di prepotenze. Allora, solo fra noiaddetti ai lavori si usava il termine‘bullismo’, derivazione diretta del ter-mine anglosassone ‘bullying’. Oggi inItalia questo termine è molto diffu-so nell’opinione pubblica e sui massmedia, ma nonostante questa cre-scente attenzione, manca ancora, an-che a livello istituzionale, una stra-tegia di intervento univoca e siste-matica nel tempo. Una cultura con-tro il bullismo dovrebbe far parte ditutti i curriculascolastici, voltaanche e soprat-tutto alla pre-venzione, quin-di all’educazionesulle emozioni,
alla valorizzazione delle differenze eal rispetto delle stesse, come mo-mento di crescita e di condivisione.Gli interventi ‘spot’ e una tantum nonservono un gran che, e non vannoalla radice del problema. Solo un ap-proccio ‘globale’ può ritenersi efficaceper ridurre e prevenire il bullismo ele sue conseguenze, coinvolgendo lefamiglie, le associazioni, i gruppisportivi, chiunque ha a che fare conragazzi.
Qual è il livello di diffusione del fe-nomeno stimato in Italia?La stima sulla diffusione del bullismodipende dallo strumento che si uti-lizza per misurarlo: il questionarioanonimo auto compilato, la nominadei pari, l’osservazione sul campo. Lastima può cambiare anche in base alperiodo che si sceglie di prendere ariferimento per chiedere agli studentise sono stati protagonisti come vit-time o come attori di episodi di bul-lismo. Fatte queste premesse, i datiraccolti indicano che una quotaoscillante tra il 10 e il 25% dei ra-gazzi dai 9 ai 17 anni subisce o agi-sce degli atti di bullismo. Per i ma-schi sono più numerosi gli atti direttie fisici, per le femmine quelli indi-retti e psicologici, come l’esclusionedal gruppo, la diffusione di notiziefalse o diffamatorie ecc.
I dati raccolti indicanoche una quota oscillantetra il 10 e il 25% dei ragazzi dai 9 ai 17anni subisce o agiscedegli atti di bullismo
V settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione
Dal 9 al 15 ottobre torna la Settimana Nazionale con-tro la violenza e la discriminazione. L'iniziativa frutto
di un protocollo di intesa tra Miur e Dipartimento PariOpportunità coinvolgerà anche quest'anno tutte lescuole di ogni ordine e grado in attività di sensibilizza-zione, informazione e formazione sulla prevenzione e ilcontrasto verso tutte le forme di violenza, bullismo ediscriminazione.

Che tipo di legame esiste tra culturadiscriminatoria (razzismo, omofo-bia, discriminazione verso le per-sone con disabilità) e bullismo?Quando si parla di bullismo si fa ri-ferimento a un insieme di prevari-cazioni dirette e indirette, reiterate,commesse da un singolo (ragazzo oragazza) o da un gruppo nei con-fronti di un altro ragazzo o ragaz-za più debole e vulnerabile. Il lega-me con la cultura e gli atteggiamentidiscriminatori è quindi assai forte.Qualsiasi elemento di ‘diversità’,infatti, viene usato dal bullo comeragione per prendere in giro, mole-stare, minacciare. Ogni differenza di-venta un pretesto di prevaricazionee violenza, per sancire una presun-ta dominanza su chi viene percepi-to come più debole, come inferiore.Nell’atto di bullismo la diversità è ilmotivo addotto per infierire sull’al-tro, il quale, spesso, ha meno pos-sibilità di chiedere aiuto, di difen-dersi, di reagire. Ma se la differen-za è il pretesto scatenante per l’eser-cizio della violenza, che viene cosìa presentarsi come un atto, violen-to, di discriminazione, la causa èspesso più profonda e risiede nel-l’insicurezza del ragazzo autore dibullismo, il quale soltanto attraver-so le prepotenze si sente forte, vin-cente, ammirato.
Quando la vittima di discrimina-zione diventa autore di atti di bul-lismo, perché succede?Il meccanismo per cui le vittime di di-
scriminazione possono trasformarsi aloro volta in agenti di prepotenze o divere e proprie aggressioni, si potreb-be spiegare come un tentativo, distortoe disfunzionale, di rispondere alle ag-gressioni subite, anche a livello sociale.Non è un caso che si tratta spesso diaggressioni che vengono perpetrate ingruppo. Nelle baby gang, ad esempio,il singolo ragazzino trova nel gruppouna rete sociale (deviante) con cui cer-ca conforto e protezione e con cui siidentifica. Il fenomeno per cui una vit-tima si trasforma in bullo è stato no-tato anche nel cyber bullismo, dove i
ragazzi, unendosi magari a gruppi dichat, gruppi sociali, si sentono protettidal filtro informatico, rassicurati e raf-forzati. A quel punto, quegli stessi ra-gazzi che vengono vittimizzati ascuola, si vendicano su altri coetaneiin rete, non necessariamente verso glistessi da cui subiscono la violenza inclasse.
25
discriminazioni e bullismo
Gli strumenti di contrasto attivati dal MIUR
Il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) ha avviato nel 2007una campagna Nazionale contro il Bullismo, che offre diversi stru-
menti di informazione, prevenzione e partecipazione rivolti agli insegnanti, aglistudenti e ai loro genitori, tra cui il numero verde 800.66.96.96, il sito inter-net smontailbullo.it e l’indirizzo di posta elettronica [email protected] questi canali vengono raccolte le segnalazioni di casi di bullismoa scuola, con lo scopo di fornire informazioni, ascolto, supporto e consu-lenza.Da settembre 2012 a giugno 2013 il numero verde ha ricevuto 1380 chia-mate, mentre la casella di posta elettronica ha registrato 1050 richieste. Icasi di bullismo seguiti dal MIUR dall’inizio della Campagna sono stati com-plessivamente 693.A chiamare sono soprattutto i genitori (70%) seguiti dai ragazzi (20%) e dagliinsegnanti (10%). Nella maggior parte dei casi si tratta di segnalazioni di of-fese verbali o prepotenze fisiche (75%), seguite da richieste di informazionisul servizio o sulle attività organizzate dal MIUR nelle scuole.La Campagna nazionale comprende anche l’attivazione di Osservatori re-gionali sul bullismo e la realizzazione di numerose iniziative di ricerca, sensi-bilizzazione e prevenzione. Tra queste, segnaliamo i progetti “Open Eyes:safenet use” e “Nausicaa”, realizzati rispettivamente a Milano e a Caserta indue immobili confiscati alla mafia, che offrono sostegno alle giovani vittime distalking, cyberstalking, e cyber bullismo. Negli interventi degli Osservatorisono stati coinvolti oltre 5.000 studenti (di cui il 53% ragazze) con un’etàmedia di 15 anni. Dai dati raccolti risulta che il 99,1% dei giovani usa rego-larmente Internet e l’89,3% ha un profilo su un social network. Preoccupanti le cifre del cyber bullismo: ben il 12,5% del campione ricono-sce di avere utilizzato i social network per diffondere messaggi offensivi ominacciosi nei confronti di coetanei; il 13,6% dei maschi e l’8,1% delle ra-gazze dichiara di avere ‘umiliato’ altre persone con la diffusione di materialioffensivi e insinuazioni diffamatorie. Ancora più preoccupanti i dati relativi alfenomeno subito o di cui i ragazzi sono testimoni: il 12% dei maschi e il 16%delle femmine dichiara di essere stato vittima di insulti, aggressioni verbali eminacce; il 31,4% degli intervistati è stato testimone o è a conoscenza di altristudenti partecipanti a gruppi on line a sfondo razzista o omofobo; il 30% èa conoscenza o è stato testimone diretto della diffusione di messaggi di mi-naccia da parte di altri studenti.
link utili:- progetto TABBY: www.tabby.eu- progetto Open Eyes: www.openeyes.it- progetto Nausicaa: www.sara-cesvis.org
Gli interventi ‘spot’ e una tantum nonservono un gran che, e non vanno alla radicedel problema. Solo un approccio globale e che coinvolge tutte le agenzie sociali chehanno a che fare con i ragazzi può ritenersiefficace per ridurre e prevenire il bullismo

D al 1986 Donata Vivanti èmadre di due gemelli autisti-ci e la sua esperienza perso-
nale - unita alla formazione medica(laureata in Medicina, è specializzatain Ematologia Clinica e ha condottoattività di ricerca e di clinica presso ilPoliclinico Universitario di Milano) -l’ha portata ad impegnarsi a tempopieno nelle associazioni di advocacyfino ad assumere ruoli di primo pia-no in ambito europeo all’internodi Autism-Europe e dell’EDF (Euro-pean Disability Forum), di cui oggi èvicepresidente, oltreché in altri pro-getti. Con lei parliamo della questio-ne dell’inclusione scolastica delle per-sone con disabilità.
Lei è madre di due figli autistici. Qua-le è stata la sua esperienza con i suoifigli nell’inserimento a scuola? Checosa direbbe a genitori, insegnanti eresponsabili politici dell’istruzione inItalia per impostare negli anni a ve-nire l’inserimento dei ragazzi autisticinella scuola?Sull’esperienza scolastica dei miei figlistenderei un pietoso velo. I miei figli conautismo hanno 27 anni, la loro espe-rienza di integrazione in una scuola che,a quei tempi, era del tutto imprepara-ta ad accogliere alunni con gravi disa-bilità dell’apprendimento è stata rovi-nosa. Benchè abbiano quasi sempre ot-tenuto, a causa della gravità della lorodisabilità, un numero di ore di sostegnodel tutto congruo, la mancanza di
competenze dei docenti, di continuitàdidattica e di impegno da parte degli in-segnanti curricolari hanno reso il loropercorso scolastico una vera tortura, perloro e per noi, benchè abbiamo investitoenormi energie e risorse per organizzarecorsi di formazione. A scuola sono com-parsi i primi problemi di comporta-mento, e non solo gli apprendimentierano scarsi, ma succedeva che anchequello che imparavano da noi a casa eraspesso vanificato da interventi in sen-so opposto degli insegnanti. I pochi in-segnanti di sostegno competenti chehanno avuto se ne sono andati dopo unanno di sostegno, perché soppiantati daaltri docenti in graduatoria o per con-flitti con i docenti curricolari o con ladirigente. Benchè infatti le scuole chehanno frequentato disponessero di in-segnanti di sostegno di ruolo, a loro ve-nivano sempre assegnati insegnanti pre-cari, poiché gli insegnanti più “anzia-ni” preferivano scegliersi alunni menodifficili. Agli amministratori pubblici e re-sponsabili politici raccomanderei dicredere e investire nel potenziale del-le persone con disabilità migliorandola loro istruzione, offrendo pari op-portunità di apprendimento attraver-so le strategie educative e i mezzi dicomunicazione appropriatati nel si-stema scolastico ordinario e ricorde-rei che l’interesse degli alunni, nonquello dei docenti, deve essere il focusdelle politiche per l’istruzione e per tut-ti i servizi di interesse generale.26
scuola e disabilità
a colloquio con con Donata Vivantivicepresidente dell’European Disability Forum
Quale inclusioneper gli studenti con disabilità
Le leggi sono ottime.L’amministrazione scolastica molto meno
di Valerio Serafini
«L’esperienza dei mieidue figli autistici è stata rovinosa»

Quali sono, secondo lei, i punti diforza e le carenze maggiori nellascuola Italiana dal punto di vistadella normativa sull’inclusione sco-lastica?Il punto di forza di forza dell’inclusionescolastica in Italia è una legislazionearticolata, finalizzata ad assicurare l’in-clusione nel sistema generale d’istru-zione a tutti gli alunni e studenti condisabilità. Il diritto all’inclusione sco-lastica trova pieno riconoscimentonella Carta costituzionale del 1948 (ar-ticoli 2, 3, 34 comma 1, e 38 comma3) e nelle leggi ordinarie: la Legge517/77, che stabilisce presupposti,condizioni e strumenti per l’integra-zione scolastica degli alunni con di-sabilità; la Legge-quadro 104/92 perl’integrazione sociale delle persone condisabilità, che assicura il diritto deibambini e dei giovani con disabilità al-l’accesso alle classi comuni della scuo-la materna e delle scuole di ogni or-dine e grado, e alle istituzioni univer-sitarie; il DM n. 141/99, che discipli-na il numero massimo di alunni (20)nelle classi che accolgono ragazzi insituazione di handicap; la legge n.17/99, che garantisce agli studenti uni-versitari con disabilita� sussidi tecnicie didattici, servizi di tutorato e trat-tamenti individualizzati agli esami. L’efficacia di tale legislazione nel pro-teggere e promuovere il diritto all’in-clusione scolastica degli alunni con di-sabilità è dimostrata dai numerosi ri-corsi contro le pubbliche ammini-
strazioni e le scuole che, sulla base diqueste leggi, vengono presentati daparte delle famiglie per inadempi-menti nel sostenere adeguatamentel’inclusione, e che in genere sono ac-colti da sentenze favorevoli ai recla-manti, tanto da obbligare l’ammini-strazione scolastica ad incrementarel’intensità del sostegno.
Non basta aumentare le ore di sostegno…
Tuttavia le nostre leggi, se garantisconol’integrazione nella scuola dell’obbli-go, non garantiscono l’educazione intermini di efficacia nell’acquisizione diapprendimenti utili all’inclusione so-ciale e lavorativa in età adulta. Que-sto avviene sostanzialmente per lescarse competenze degli insegnanti (siacurricolari che di sostegno) in mate-ria di educazione speciale e per la man-canza di continuità, dovuta all’alter-narsi degli insegnanti di sostegno an-che più volte l’anno con uno stessoalunno. Le centinaia di ricorsi controle pubbliche amministrazioni e lescuole da parte delle famiglie deglialunni con gravi disabilità dell’ap-prendimento, per la mancanza di unnumero di insegnanti di sostegnocongruo e costante a livello naziona-le, evidenziano le difficoltà che que-sti alunni esperimentano e che le fa-miglie sperano di risolvere aumentandole ore di sostegno.
Finita la scuoladell’obbligo, le stradedell’apprendimento e dell’inclusione si chiudono
Inoltre, benchè il diritto alla formazio-ne professionale dei cittadini disabili siariconosciuto dalla Costituzione Italia-na all’art. 38 e dalle leggi (la 118/1971,la L.845/78 e la L.104/92), nella realtà
intervista a donata vivanti
27

dopo la scuola dell’obbligo per i giovanicon gravi disabilità dell’apprendimen-to l’unica opzione è l’inserimento incentri socio-educativi o socio-riabili-tativi, che tuttavia non sono vincolatidai criteri di accreditamento esistenti pergarantire percorsi educativi e formati-vi. Infatti, secondo il rapporto del Cen-sis “La dimensione nascosta della di-sabilità” (2013), mentre la quasi tota-lità delle persone con autismo delcampione studiato con meno di 14 annifrequenta la scuola, il dato scende al67,1% tra i 14 ed i 20 anni e arriva al6,7% tra chi ha 21 anni o più. Tra chinon frequenta la scuola, l’attività piùfrequente è rappresentata dalla fre-quentazione di un centro diurno
(13,2%). Risulta significativamente altala quota relativa a quanti non svolgo-no nessuna attività e rimangono in casao in istituto per tutto il giorno: il datoraggiunge il 21,7% tra gli adulti 21ennie oltre, ma rimane significativo anchetra gli adolescenti (13,9%).
L’inserimento dei giovani e degli adul-ti con disabilità nei corsi di formazioneprofessionale pubblici e privati è de-mandato dalla legislazione vigente alleregioni, e non esistono meccanismi dicontrollo a livello nazionale per mo-nitorarne l’applicazione. Per le perso-ne, poi, con grave disabilità dell’ap-prendimento i corsi sono praticamen-te inaccessibili per le scarse compe-tenze dei docenti nell’uso di strategieeducative e strumenti di comunica-zione aumentativi appropriati.
La disabilità è un mondo variegatoe di difficile analisi. In che modo pen-sa si debba procedere per superare lediscriminazioni e gli stereotipi sul-le persone con disabilità?Si devono seguire gli stessi percorsi chesono stati fatti per superare, almenoparzialmente, le discriminazioni e glistereotipi su altre fasce di popolazio-ne, in primo luogo le donne e le per-sone di colore. Non ci sono scorciato-ie possibili, l’unica strada è un’azionecoerente e coordinata di un movimentounitario di persone con disabilità cherivendichi pari diritti e dignità. Tale ri-vendicazione richiede anche un’operadi sensibilizzazione, che riguarda tut-ti, comprese le persone con disabilitàe le loro famiglie, ai concetti di egua-glianza, di dignità e di valore umanointrinseco di ogni persona umana.
Che cosa ne pensa della recrudescenzadi episodi di bullismo e maltratta-menti nei confronti delle persone condisabilità? E quali sono le strategiepiù valide, sperimentate in Europa,per contrastare il fenomeno?Non essendo una sociologa, non mi pro-nuncio sulle cause del bullismo né suuna sua recrudescenza. Mi sembra pro-babile che gli alunni diversi e più debolisiano le vittime predestinate del bulli-smo, perché la diversità spaventa, e l’in-capacità di difendersi istiga alla violenza.
Quando la violenzaviene dagli educatori…
Tuttavia trovo più sconvolgenti gli epi-sodi, relativamente frequenti, di abu-si da parte di insegnanti che dovreb-bero invece prendersi cura degli alun-
ni con disabilità, come nel caso re-centemente venuto alla ribalta di quel-lo studente con autismo di 15 anni cheper mesi è stato insultato, umiliato, pic-chiato dall’insegnante e dall’educatri-ce nella scuola che avrebbe dovuto in-vece educarlo e includerlo. Questo è po-tuto succedere perché l’alunno era unragazzo mite, incapace di reagire e diraccontare quello che gli succedeva, eforse nemmeno sapeva che la scuolanon è insulti e botte, e che le maestrenon sono orchesse malvagie. Anche seavesse reagito, probabilmente avrebbeottenuto l’etichetta di aggressivo o ilmarchio di ineducabile, e magari sa-rebbe stato trattato con psicofarmaci.Ma le persone con autismo non na-scono aggressive, se lo diventano è inrisposta a comportamenti che nonsanno decifrare e che li spaventano. Non sono al corrente delle strategie eu-ropee per affrontare il fenomeno. Poiché,però, il sistema prevalente in Europa èquello delle scuole speciali, non mi risultache il fenomeno del bullismo nei con-fronti di alunni con disabilità sia diffu-so. Le scuole speciali, semmai, possonoaumentare il rischio di abusi da parte didocenti ed educatori per la difficoltà de-gli alunni con disabilità, specie se intel-lettiva, di riconoscere e riferire tali abu-si. Esistono, infatti, nei paesi anglosas-soni, codici di condotta per prevenire laviolenza nelle scuole speciali per alun-ni con disabilità, che vietano che un alun-no con disabilità resti solo con un adul-to fuori dal controllo di altri adulti. In ogni caso sarebbe ingiustificato chel’esigenza di protezione dal bullismoprevalesse sul diritto dei bambini e deigiovani con disabilità di crescere e ap-prendere insieme ai compagni. La se-gregazione nelle scuole speciali non ècomunque accettabile in una prospet-tiva della disabilità basata sul diritto.
Cosa spinge secondo lei dei ragazzia mettere in atto tali comportamen-ti nei confronti di persone con disa-bilità? E che cosa si può fare per fron-teggiare questo problema?Ritengo che la scarsa stima di sestessi sia uno dei fattori che spinge ibulli a cercare conferme esercitandoprepotenze verso i più deboli. Se cosìè, l’alunno con disabilità è la vittimapredestinata dei bulli. 28
scuola e disabilità

L’integrazione scolastica non può pre-scindere da questo fenomeno, cheessa non potrà mai contrastare se nonsi focalizza maggiormente sulla propriamissione e sui doveri verso gli studentipiuttosto che concentrarsi sui proble-mi e proteggere prioritariamente i di-ritti acquisiti del personale scolastico.Questo purtroppo è quanto succede inItalia e in generale nei paesi latini, doveè poco sviluppata la cultura dei servi-zi, dove scuole e università, e non solo,non sono considerate come istituzio-ni a disposizione innanzi tutto degliutenti e della società. Poiché poi gli abusi sono incoraggiatie indotti dalla consapevolezza di poterliesercitare senza essere scoperti, gli
alunni che non sono in grado di rac-contare episodi di bullismo o addiritturadi riconoscerli come abusi non do-vrebbero mai essere lasciati con i com-pagni senza la sorveglianza, per quan-to possibile discreta, di un adulto.
Quali sono secondo lei gli strumenti ne-cessari per costruire una scuola migliorein futuro nel contesto della disabilità?A quali organismi competenti possia-mo rivolgerci per ottenere una mag-giore attenzione sulle esigenze educa-tive delle persone con disabilità?Il sistema scolastico dovrebbe render-si capace di rispondere adeguatamen-te alle necessità educative speciali(quelle che riguardano i disabili), sen-
za rinunciare all’inclusione. Non c’è ra-gione per cui l’educazione speciale nonpossa essere applicata in un ambienteinclusivo. Ne beneficerebbero anche glialtri alunni e i docenti, che non do-vrebbero più confrontarsi quotidiana-mente con insuccessi e frustrazione.
Nove cose da farePer migliorare l’efficacia dell’istruzio-ne per le persone con disabilità, sen-za rinunciare all’inclusione nella scuo-la di tutti, sarebbe necessario:- rendere obbligatoria la formazione
iniziale di tutti i futuri docenti e ditutti i docenti curricolari sulle di-dattiche per gli alunni con BisogniEducativi Speciali (BES) e disabili-tà dell’apprendimento;
- istituire due nuovi ruoli per i do-centi: per il sostegno didatticonella scuola dell’infanzia e prima-ria e nella scuola secondaria;
- fissare e disciplinare l’obbligo di for-mazione in servizio di tutti i docentisulle didattiche per gli alunni condisabilità dell’apprendimento;
- realizzare una effettiva continuitàdidattica, almeno per i docenti disostegno;
- individuare indicatori di qualità del-l’istruzione e dell’inclusione;
- assicurare la formazione professio-nale per gli alunni con disabilità;
- riformare i sistemi di controllo del-la qualità dei servizi per adulti condisabilità inserendo la verifica del-l’esistenza e dell’efficacia di percorsidi apprendimento permanente;
- normare il principio di “accomo-damento ragionevole”;
- definire un piano di adeguamentoe progettazione di tutti gli edifici eplessi scolastici in conformità conla normativa relativa all’abbatti-mento delle barriere architettoniche.
Sono queste le principali richiesteche la FISH ha indirizzato al MIUR, ilquale sta elaborando un disegno dilegge governativo che le faccia proprie.
intervista a donata vivanti
29Foto di A
lberto Guidi, con
corso Diversità Urbana

E sistono storie silenti, pregne didolore e sentimento, che aspet-tano solo di essere raccontate.
Ne esistono altre dimenticate, cheaspettano solo di essere ricordate.Parole leggere e pesanti, che portanocon sé morte e devastazione: “Porraj-mos” è il termine in lingua romanì concui Rom e Sinti indicano lo sterminiodel proprio popolo da parte dei nazi-sti durante la seconda guerra mondiale.Parole al contempo piene di vita, di-gnità e coraggio se pronunciate dai po-chi sopravvissuti a quell’orrore. L’UNAR ha dato la possibilità a 40 ra-
gazzi della Rete NEAR (Network Gio-vanile Antidiscriminazione Razziale) diformare una delegazione italiana chepotesse prendere parte al “DIK I NA BI-STAR! Look and don’t forget!”, ilprogramma d’iniziative previste per lacommemorazione del genocidio deiRom e dei Sinti vittime dell’Olocausto. L’iniziativa si è svolta a Cracovia. E’stata organizzata dal TernYpe – In-ternational Roma Youth Network - eda Romà Onlus, associazione costituitada mediatori linguistici e interculturalirom e sinti. La delegazione della Rete Near ha par-30
memoria
Quaranta ragazzi della Rete NEAR hanno visitato i campi di sterminio della Polonia
«Dik i na bistar!». per rivivere la storia
e raccontarladi Roberta Lulli e Maria Valentina Tora
Foto di R
oberta Lulli

tecipato così a workshops interattivicon esperti, incontri con i sopravvis-suti, gruppi di lavoro sull’attivismo gio-vanile e, infine, il 2 agosto ha presoparte alla cerimonia commemorativaufficiale ad Auschwitz-Birkenau, as-sieme ad altri 400 ragazzi, provenientida ogni parte d’ Europa.Per comprendere questa storia, bisognaconoscere le origini della tragedia e sa-pere che la persecuzione del popolo rome sinti parte da lontano. Come da lon-tano arrivano anche gli stereotipi cheancora oggi ci portiamo dentro il ba-gaglio dei nostri viaggi, dei nostri in-contri, dei nostri pensieri. Siamo atterratia Cracovia con una valigia piena di pre-giudizi e luoghi comuni, ma a volte persmontare la retorica di uno stereotipobasta condividerlo con le stesse perso-ne che ne sono oggetto e vittime.In questa tragedia gli stereotipi sonostati motori delle più grandi atrocitàdella storia: già all’inizio del ‘900, inGermania e Austria, molti di loroavevano dimore stabili e impieghiregolari, ma ciò non riuscì a sfatare ilmito di Rom e Sinti come popolo ditruffatori, mendicanti e indovine.Come accade ancora oggi. Fu così che la politica di ostracismo na-zista trovò terreno fertile e non fece al-tro che istituzionalizzare la loro cri-minalizzazione, facendone motivo ne-cessario di esclusione dalla comunitànazionale. Nei confronti degli “zingari” importantiesponenti della polizia nazista fecerocome avevano fatto già per i disabili:ritennero che l’essere membro di queldeterminato gruppo generasse auto-maticamente criminalità. Ma la classificazione doveva avere ri-gore scientifico, così Rober Ritter, lo“scienziato della razza”, venne prestoscelto per sovrintendere alla loro clas-sificazione, giungendo così alla con-clusione che i Rom fossero un grup-
po deviante e degenerato e che la de-vianza, così come il nomadismo, ave-vano carattere ereditario. L’8 dicembre 1938, Heinrich Himmlerprovvide a promulgare un editto per la“lotta contro la piaga degli zingari”. Inuna lettera al capo della polizia del1939, ordinava: “Gli zingari devono es-sere sistemati in campi di raccolta spe-ciali fino al momento della loro defi-nitiva evacuazione”.Nel 1942 i nazisti decretarono che tut-ti i Rom e Sinti dovessero essere rin-chiusi in campi di concentramento, condestinazione finale Auschwitz. Molti diloro erano di nazionalità italiana.Nel giugno 1939 più di 2.000 Rom eSinti venivano arrestati e deportati:440 donne a Ravensbrueck e circa1.500 uomini a Buchenwald.Quando la Germania, l’1 settembre1939, invase la Polonia, le SS delle Ein-satzgruppen massacrarono intere po-polazioni, così come nelle altre nazionioccupate dalle armate naziste. I Rome Sinti vennero rastrellati ed inviatidapprima in appositi campi di lavoro.Dalla primavera del 1941 la destina-zione divenne Auschwitz. Nel marzo1943 a Birkenau, venne istituito lo spe-ciale settore a loro riservato, denomi-nato “Zigeunerlager”. Nella notte tra il 2 ed il 3 agosto 1944,2.897 fra uomini, donne e bambini dietnia Rom e Sinti furono costretti adentrare a forza nella camera a gas nu-mero 5 di Auschwitz, dove furono ga-sati ed i loro corpi poi bruciati nei for-ni crematori. Nel gennaio del 1945 gli zingari rimastiad Auschwitz erano pochissimi. L’olocausto dei Rom – il Porrajmos -contava ormai più di 500.000 vittime.Ci sono memorie che rimangono con-segnate alla storia, scandendone inmodo significativo il suo divenire: essevanno ricordate al fine di valorizzarela coscienza di un passato storico co-
mune e di restituire loro una memo-ria condivisa.La nostra visita nei lager è stataun’esperienza estrema, una discesa ne-gli abissi dell’umanità, inconcepibileper chi come noi ritiene che la storiadebba essere un progressivo camminodi evoluzione e civiltà.
Questa toccante esperienza ci ha aper-to le porte a mille riflessioni sul comee perché possano essere state perpetratesimili atrocità, senza dimenticare chefatti del genere avvengono ancora oggiin numerosi angoli del mondo. Vici-ni e lontani, conosciuti e dimenticati.
31
il genocidio di rom e sinti
Foto di R
oberta Lulli
Foto di R
oberta Lulli
Foto di R
oberta Lulli
Foto di R
oberta Lulli

È il 24 settembre 1943 quandoviene l’ordine da Berlino di“trasferire in Germania” e “li-
quidare” tutti gli ebrei “medianteun’azione di sorpresa”. A riceverel’ordine è il tenente colonnello Her-bert Kappler, comandante delle SS aRoma. L’Italia di Mussolini aveva giàmesso in atto le leggi razziali, a par-tire dal settembre del 1938; ma nellaloro città, che era stata dichiarata “cit-tà aperta”, gli ebrei romani si sento-no al sicuro; e poi il quartiere ebrai-co, il “ghetto”, dista solo poco più diun chilometro da San Pietro. Inoltre,
la richiesta fatta il 26 settembre daKappler alla comunità ebraica di con-segnare 50 chili d’oro, pena la depor-tazione di 200 persone, li ha illusi chetutto quello che i tedeschi vogliono siaun riscatto in oro.Del resto, le notizie sul destino degliebrei in Germania e nell’Europa del-l’Est sono ancora scarse e imprecise.Ma, invece, accadde quello che nes-suno proprio si aspettava. A Via delPortico d’Ottavia, quasi di fronte allaSinagoga, all’alba del 16 ottobre, si ra-dunano i camion e i 300 soldati addettialla “Judenoperation”, e ha inizio il ra-32
memoria
16 ottobre 1943In un secolo di storia, la giornata più triste per Roma
di Giampiero Forcesi

strellamento di tutti gli ebrei di Roma.Nel vecchio ghetto ne abitano molti,ma altri sono sparsi negli altri quar-tieri della città. Tutti vengono rastrel-lati. Le SS hanno tra le mani gli elen-chi dei nominativi degli ebrei fornitidall’Ufficio Demografia e Razza del Mi-nistero dell’Interno. Ha raccontato Riccardo Di Segni, rab-bino capo di Roma: «Era sabato mat-tina, festa del Succot, il cielo era dipiombo. I nazisti bussarono alle por-te, portavano un bigliettino dattilo-scritto. Un ordine per tutti gli ebrei delGhetto: dovete essere pronti in 20 mi-nuti, portare cibo per 8 giorni, soldi epreziosi, via anche i malati, nel cam-po dove vi porteranno c’è un’infer-meria». L’azione è capillare: nessunebreo deve sfuggire alla deportazione.Uomini, donne, bambini, anziani am-malati: tutti vengono caricati a forzasui camion. “I tedeschi bussarono, poi non aven-do ricevuto risposta sfondarono le por-te. Dietro le quali, impietriti come seposassero per il più spaventosamentesurreale dei gruppi di famiglia, stava-no in esterrefatta attesa gli abitatori,con gli occhi daipnotizzati e ilcuore fermo ingola”, ricordaGiacomo Debe-nedetti.Nessun quartieredella città fu ri-sparmiato: ilmaggior numerodi arresti si ebbea Trastevere, Te-staccio e Monte-
verde. Alcuni si salvarono per caso,molti scamparono alla razzia nascon-dendosi nelle case di vicini, di amicio trovando rifugio in case religiose,come gli ambienti attigui a S. Barto-lomeo all’Isola Tiberina. Alle 14 lagrande razzia era terminata.Alla fine di quel sabato le SS registranola cattura di 1024 ebrei romani. Tra diloro ci sono 207 bambini.Tutti sono stati rinchiusi nel collegioMilitare di via della Lungara. a pochipassi da qui. Due giorni dopo, lunedì 18 ottobre, iprigionieri vengono caricati su un con-voglio composto da 18 carri bestiamein partenza dalla Stazione Tiburtina.Il 22 ottobre il treno arriva ad Au-schwitz. Dei 1024 ebrei catturati il 16 ottobrene sono tornati solo 16, di cui una soladonna (Settimia Spizzichino). Nessu-no degli oltre 200 bambini è soprav-vissuto. Nel biennio 1943-1945 le perdite del-la popolazione ebraica in tutta Italiafurono all’incirca 7750, pari al 22% deltotale della popolazione ebraica nel no-stro Paese.
la deportazione degli ebrei di romaNoi dobbiamo testimoniare.L’impegno dell’UNARper ricordare la Shoah
I l museo Yad Vashem, o Museo del-l'Olocausto, a Gerusalemme, è stato
fondato nel 1953 in applicazione dellaLegge del memoriale approvata dalparlamento israeliano. Nel 2005 il mu-seo ha pubblicato un’importante ope-ra, con cui ha documentato, attraversola sua stessa storia, il periodo piùdrammatico vissuto dal popolo ebrai-co Il libro, edito in inglese, si intitola "ToBear Witness" (Per testimoniare). E’ lapiù completa ricostruzione della storiadell'Olocausto.L’UNAR, lo scorso anno, ne ha curatola traduzione in italiano. Il volume, conil titolo "Testimonianza-Memoria dellaShoah a Yad Vashem", è stato presenta-to a Milano lo scorso 27 gennaio in oc-casione della Giornata della Memoria2013. L’edizione italiana presenta un ca-pitolo conclusivo di Liliana Picciotto sul-la Shoah in Italia.Con questa importante pubblicazionel’Italia ha colmato un vuoto, percepitofino ad oggi dai visitatori italiani dello YadVashem, i quali finalmente potranno tro-vare accanto alle versione inebraico, inglese, francese, tedesco, rus-so, spagnolo e turco del libro, anchequella in italiano.In Italia il libro, che è stato stampato dal-l’Unar in 5.000 copie, sarà ora reso di-sponibile per le biblioteche pubbliche egli istituti scolastici, come strumento diformazione per le giovani generazioni af-finché siano rafforzate nella consape-volezza di quanto storicamente accadutoe della eventualità che tutto ciò possaripetersi.Perdere la memoria del passato signi-fica perdere il futuro. La memoria del-l'Olocausto serve per il presente e peril futuro, forse non per insegnarci qual-cosa ma per ricordarci quali siano le so-glie che non si possono oltrepassare."For the dead and the living, we mustbear witness" (Elie Weasel).
� ���������
� ���������
����� � ���� ����� � �� �����
#��� �� ��������� ������� ����� ��������!���� � �������� ������ �� ����������
������ ������������� ����������������� ������������ ��� �������� ����������
��� �� ������ ������ �� � �� ������ �� ���� �� ������������ ������� ��� ���
� ��� � ����� � ������� �� ��� ����������� �� �� ��� �� �� �����������"
�� ���������� ��� ������� ������ ����������� ��� ������������������
�� ���� ����� ������ ���� ������������������ ��� ��� �$
������� �������������
�������� ������������������������� ����������� ���"$� ����'$%��������#'�$���!��� ���!%&$!�����&�&��%'���$&��! !����� ����%���(�� ����$(�&� ������!���)�! �������'%�!��*�$&�����������%���

Q uando nomini la Transnistria,la maggior parte delle per-sone ti domandano cos’è?
dove si trova? Mai e poi mai pense-rebbero ad un paese che appartenevaall’ex URSS, ubicato in una piccolazona dell’Europa dell’Est, fuori da tut-te le rotte turistiche e commerciali. Dal 1990, la Transnistria, uno stato in-dipendente di fatto che si estende suuna piccola striscia di terra, non ri-conosciuto a livello internazionale(essendo considerato ufficialmentecome parte della Repubblica di Mol-davia), ma appoggiato economica-mente dalla Russia, situato tra l’Ucrai-na e la Moldavia, vive in una condi-zione di forte isolamento politico,economico e culturale, ricco di pre-senze iconografiche di Lenin nelle
piazze e nei monumenti storici dellesue due città più importanti, Tiraspole Bender. Davanti al Palazzo presi-denziale troneggia una gigantescastatua di Lenin, e sul mausoleo dedi-cato ai morti della guerra civile del ’92si erge un carro armato diventato ilmonumento-simbolo di una repubblicacostruita sulla mistificazione del pas-sato e del presente. Questo paese rap-presenta un curioso esperimento di re-gime politico formalmente “sovietico”ma con un sistema economico quasitotalmente privatizzato, quindi so-stanzialmente di tipo capitalistico. Anche se non esiste politicamente, laTransnistria ha le caratteristiche di unnormale paese con le sue dogane, lasua bandiera, i suoi passaporti, la suamoneta, il suo esercito e corpo di po-34
reportage
Transnistriail Paese che non esiste
testo e fotografie di
Marco Buemi

lizia, il suo governo e parlamento, econ una popolazione di circa 550.000persone, cittadini di un paese che uf-ficialmente non c’è. La Transnistria ri-lascia i suoi passaporti, ma la quasi to-talità della popolazione possiede unpassaporto moldavo o russo, visto chesia Chisinau che Mosca concedonosenza problemi il proprio passaporto
ai transnistriani che ne fanno richie-sta. Questo fa sì che, nonostante l’iso-lamento teorico, in pratica la Tran-snistria registra un’intensa mobilità deisuoi abitanti e floridi commerci in-ternazionali, che avvengono spessosotto forma di contrabbando, in genereattraverso il confine con l’Ucraina, par-
ticolarmente permeabile. Per circa vent’anni, dal 1990 in poi,cioè da quando la Transnistria si è au-toproclamata indipendente con unaguerra civile contro i cugini moldaviche ha causato molti morti e feriti, ilpaese è stato guidato da Igor Smirnov,ex direttore di una ditta russa ai tem-
transnistria
Anche se non esistepoliticamente, laTransnistria ha le suedogane, la sua bandiera,i suoi passaporti, la suamoneta, il suo esercitoe corpo di polizia

pi dell’URSS, che si è impossessato delpotere al momento della nascita del-la Transnistria, nel 1990.Smirnov è riuscito a creare, negli anni,un culto della personalità attorno allasua proclamata grandezza come li-beratore della regione, diventando ilpadre padrone del popolo della Tran-snistria. Nel contem-po è riuscito a darevita a un proprio do-minio dinastico ac-quisendo assieme aisuoi figli il controlloe il possesso di molterisorse industriali delpaese e delle impresedi Stato di successo.La più importanteazienda del paese è la“Sheriff”, un’aziendache ha il controllovirtuale sull’econo-mia dell’intera regio-ne, dalla squadra di
calcio della capitale,FC Sheriff Tiraspol, edel relativo stadio re-centemente costruito,alla catena di super-mercati e di distributo-ri di carburante pre-senti in tutta l’area, dauna casa editrice aduna distilleria, da uncasinò ad un canaletelevisivo e un’agenziapubblicitaria. Anche se la Moldavia el’Ucraina impongonoregolarmente diversesanzioni economichecontro la Transnistria,che poi però sistemati-camente rimuovono pervia del perpetuo stallonelle negoziazioni che
riguardano la regione, il quadro poli-tico della Regione è notevolmentecambiato negli ultimi due anni.Infatti, nel 2011, in questo territorio lacui indipendenza non è riconosciutainternazionalmente, per le elezioni po-litiche si sono presentati alle urne ol-tre 200.000 cittadini, che dopo ven-
t’anni di autoritarismo hanno boccia-to Igor Smirnov, scaricato dalla Rus-sia a causa di brogli finanziari, e han-no eletto presidente Yevgeny Shev-chuk.Yevgeny Shevchuk, che è visto da mol-ti come il rappresentante di una nuo-va generazione che vuole meno cor-ruzione e una maggiore stabilità eco-nomica, apertura all’esterno e libertà,ha avviato un processo di rinnova-mento generazionale nel governo e hadimostrato segni di distensione edapertura nei confronti delle iniziativedi OSCE e Unione europea.Le pretese di indipendenza della Tran-snistria sono in realtà assai fondate, siadal punto di vista etnico-linguistico (lagran maggioranza della popolazioneè russa) sia dal punto di vista storico,visto che la regione non ha pratica-mente mai fatto parte della Romaniaed è stata per diversi secoli sotto il con-trollo dell’impero russo prima e del-l’Unione sovietica poi, venendo ac-corpata al resto della Moldavia soltantonel 1945, nell’ambito dell’URSS. Com-prensibile quindi che i suoi abitanti sisentano più vicini a Mosca che a Bu-carest, e anche che le autorità russe sia-
36

no assai poco inclini a lasciar scivo-lare questo territorio nella sfera di in-fluenza occidentale. Ecco perché lagran parte degli abitanti della Tran-snistria spera di andare in Russia; par-lano nostalgicamente dei loro paren-ti che hanno già fatto il grande pas-so e hanno trovato in Russia fortunae successo. Dal 1992, anno della fine delle ostili-tà con la Moldavia, in Transnistria èpresente un reggimento russo confunzioni di peacekeeper e di garantenei confronti della popolazione loca-le, una piccola presenza, ma che haprovocato non pochi problemi nei ne-goziati con la Nato per la riduzionedelle forze convenzionali in Europa.L’attuale missione di peacekeeping,creata nel 1992 nella zona di sicurez-za tra Moldavia e Transinistria, al ter-mine del conflitto fra Chi�in�u e Tira-spol, è composta da 1.200 soldati Rus-
si, Moldavi e della Transnistria e di-versi osservatori ucraini.Secondo un rapporto del “Global con-flict prevention”, a tutt’oggi in Tran-snitria, pur in presenza di qualchecambiamento, si continua a vivere inuna situazione che si caratterizza peruna combinazione di corruzione, po-vertà e conflitto: una corruzione mol-to diffusa in tutti gli strati sociali, unconflitto con la Moldavia che è fini-to sulla carta ma che non ha prodot-to alcun accordo politico, ed una po-vertà visibile realmente al mercato im-provvisato, e spesso sotto forma di ba-ratto, della piazza centrale di Tiraspol.Inoltre, in questo paese che ufficial-mente non esiste, proliferano daglianni ‘90 continue violazioni dei di-ritti umani e attività illegali legate altraffico delle armi e degli esseri uma-ni, al contrabbando e alle attività di ri-ciclaggio di de-naro. Il paeseche non c’ècontinua a nonesistere per nes-suno e ad esse-re un luogo dacui tutti i gio-vani voglionoscappare perpoter esistererealmente edavere un futuro.

Dopo aver moderato lo scorso 10giugno alla Camera, il semina-
rio promosso dalla presidente Bol-drini, “Parole libere o parole d’odio?Prevenzione della violenza online”,per la campagna del Consiglio d’Eu-ropa No Hate Speech, che idea ti seifatto su come viene trattato il temaa livello istituzionale?Il seminario è stato un quasi primo ap-puntamento di confronto tra alcune per-sone esperte di internet e alcuni poli-tici che vorrebbero occuparsene seria-mente. Ma ci si sono messe dentro trop-pe cose: le questioni che riguardano tee-nager minorenni, le violenze su di loroe le loro fragilità ed il come tutelarli ri-spetto ad un ambiente decisamente nuo-vo e complicato come internet; le que-stioni del razzismo sul web; i problemidi alcune personalità politiche, più omeno esposte, che rischiano di subire
gogne o forcaiolismi attraverso la rete. Per quel che riguarda i politici, pen-so che il problema sia una mancanzadi competenza, causata da una diffe-renza generazionale e scarsa cono-scenza del mezzo. Quando la tua for-mazione è ormai radicata, per entra-re dentro nuove culture, nuovi modidi comunicare, nuovi modi di capirele cose, devi intervenire sulla tuavita, sovvertirla; e non è facile. Cre-scendo, si diventa meno elastici e ri-costruire tardivamente una compe-tenza sulle cose della rete all’altezzadella rete stessa è quasi impossibile. Inrealtà diffido anche dei molto giova-ni, quelli che non sono in grado di fareil confronto con lo stato delle cose“prima” e con le cose come sono tut-tora in alcune parti del mondo. Inoltre, la politica richiede degli impe-gni molto intensi che ti sottraggono al38
dibattito
LUCA SOFRI
L’INSENSATA BATTAGLIA CONTRO IL POLITICALLY CORRECT
Nei mesi di maggio e giugno, in seguito alle minacce via web alla presidente della Camera Laura Boldrini e al caso, di qualche settimana prima, dell’adolescente suicidatasi a Roma, si è accesso un dibattito serrato attorno alla diffusione del cosiddetto “hate speech”, il discorso dell’odio, sul web. La stessa Boldrini il 10 giugno scorso ha promosso un seminario presso la Camera dei Deputatisull’argomento. Near ha incontrato Luca Sofri, che moderò quell’incontro, e Gianni Riottache è da poco in libreria con il suo nuovo libro “Il web ci rende liberi?”, interrogandoli sulla natura di internet e la sua funzione sociale rispetto a questi temi.
di Edoardo FontiIl webe l’hate speech, una relazione pericolosa?

resto. Ho l’impressione che non si abbiala piena possibilità di affinare gli stru-menti o approfondire la conoscenza delmezzo. Inevitabilmente accade che lepersone chiamate a prendere delle de-cisioni su questi temi non li hanno stu-diati. Sono magari sinceramente convintidi avere la comprensione della questio-ne perché ci sono passati (“mi hanno in-sultato in rete e quindi conosco il pro-blema”; ma no, non è così. Se ti hannoinsultato in rete, hai un’esperienza per-sonale del problema, ma il problema ge-nerale su cui si deve discutere è una cosamolto più complicata. Le tue ragionisono le ragioni della vittima, non sonole ragioni dell’esperto. Come in tutte lealtre questioni dell’amministrazionedella giustizia, non si decidono le penee le sentenze chiedendo alle vittime, magiudicando sulla base di valutazioni diprincipio più estese che coinvolgonomolte altre questioni.
Vittorio Zambardino nel raccontarepolemicamente quella giornata suWired ha usato un aneddoto: “Ri-penso a un ragazzino di dodici anni,in una scuola in provincia di Napo-li, pestato ogni giorno. Gli dicevano“ricchione”. Lo pestarono fino aquando lui imparò a difendersi. Par-larne ai genitori o ai professori sa-rebbe stato solo moltiplicare la con-danna e le botte”. Le considerazioni generali basate suisingoli aneddoti mi convincono sem-pre poco. Potrebbero esserci tanti al-tri aneddoti dove uno ha provato a di-fendersi e lo hanno pestato il triplo.Certo, imparare a difendersi è sicura-
mente meglio; ma cosa facciamo conquelli che non imparano a farlo? E’ giu-sto insegnare a difendersi, insegnare lasolidità, la consapevolezza e la sicu-rezza di sé, la capacità di sopportare leavversità della vita. Dopodiché, però,bisognerà prendere atto che questo nonè possibile sempre, non è possibile atutti. E a quelli non ce la fanno non èche possiamo smettere di pensarciperché gli avevamo insegnato a resi-stere e loro non ne sono stati capaci...
In che termini oggi si può parlare di weblibero, alla luce delle recenti rivelazio-ni sulla privacy, e delle proposte di cir-costanziarne la libertà di espressione?In genere sono diffidente di tutte le di-scussioni che partono da categorie eschematismi, quindi non mi sento ingrado di parlare di web libero o non li-bero. Se è vero, da una parte, che tut-te le libertà sono regolate e regola-mentate e conoscono dei limiti, dal-l’altra il significato stesso della paro-la libertà ha, in fondo, definizioni di-verse. Partendo da questi presuppostipenso che si debbano applicare in in-ternet almeno gli stessi principi del“fuori internet”, e, di conseguenza, qua-si sempre le stesse regole. Dico quasisempre, perché inevitabilmente i con-testi implicano accorgimenti, assesta-menti ed interventi pratici diversi, mache non devono mai essere basati surevisioni radicali dei fondamenti.
Da dove nasce secondo te questa ne-cessità di esprimere opinioni e cer-care consenso a tutti i costi, violen-za compresa, che pare essere non solo
il motore dei social network, ma atratti, del web tutto?In un sistema di valori e di cultura comeil nostro, che premia tantissimo l’af-fermazione di sé, la competizione e so-prattutto il riconoscimento del succes-so, ma che nello stesso tempo accrescecostantemente le nostre insicurezze e lenostre insoddisfazioni, la ricerca dimicro affermazioni, micro vittorie e mi-cro competizioni diventa qualcosa a cuidedichiamo davvero troppe energie. Avolte lo facciamo anche non volendo,non riuscendo quasi a trattenerci. Nonsolo c’è l’opportunità di potersi esprimereovunque, e le opportunità general-mente si tendono a cogliere, ma c’è pro-prio la febbrile necessità dell’afferma-zione dell’esistenza di sé e del ricono-scimento da parte degli altri. Tutto ciòin realtà si rivela minimamente pre-miante: non sono certo i piccoli successidi una battuta ben assestata o la di-mostrazione di saperla più lunga, o difar finta di saperla più lunga, che poi cifaranno ottenere quella sicurezza checerchiamo. Anzi, spesso tradiranno ainostri stessi occhi la piccolezza e la ba-nalità dei nostri interventi. Questo,ahimè, è un fenomeno che si è diffusomoltissimo in questi ultimi decenni, daquando ci siamo andati convincendoche tutti quanti potevamo avere i no-stri 15 minuti, poi 15 secondi, poi ap-
39
Il webe l’hate speech, una relazione pericolosa?

punto le centoquaranta battute, di ce-lebrità.
Come possono difendersi le personesul web?Intanto mettiamoci in testa che èmolto difficile, che la situazione è com-plicata e che presenta moltissimi rischi.E che comunque sono problemi con iquali avremo sempre a che fare. Nes-suno pensa di risolvere la criminalitàdefinitivamente, nei paesi civili e le-gatari. Questo vale anche per i nuoviproblemi nati su internet. Non si ri-solvono certe questioni. La violenzaesiste, i cretini e i razzisti esistono.Quello che dovremmo fare è lavoraresu una cultura e una consapevolezzadiversa, a partire dalla scuola. Ma so-prattutto lavorare sulla costruzione dimodelli comportamentali diversi. Negli ultimi anni in Italia, non soloabbiamo accettato espressioni stupi-de, aggressive, violente, che primanon c’erano, ma abbiamo distrutto ilsistema condiviso di ciò che è buo-no e di ciò che è cattivo. Grazie allosdoganamento di certe persone cheabbiamo considerato come dei mo-delli, ed i politici sono tra questi, ilcattivo stesso è diventato il modello.
Dietro c’è stata tutta l’appassionatabattaglia contro il politically correct,o il buonismo presunto. Si è tratta-to di un processo che ha permesso ai“cattivi” di irridere la bontà e le cosegiuste, appiccicandogli delle eti-chette ridicolizzanti. Ma il political-ly correct è una cosa sacrosanta, cheesprime effettivamente la correttez-za dei comportamenti.Replicato e duplicato su internet, il fe-nomeno ha lo stesso effetto. Ovvia-mente tutto ciò è all’interno di questionimolto più grandi, come, per esempio,il modo in cui gli italiani scelgono i pro-pri rappresentanti politici e la mancanzain Italia di un elemento fondamentaleper il funzionamento corretto della de-mocrazia: l’informazione..
A marzo l’allora ministro Idem isti-tuì un tavolo interistituzionale per lalotta all’odio e all’intolleranza sul web.Il tavolo venne creato su indicazio-ne del Consiglio d’Europa al Dipar-timento a partecipare al progetto Igiovani combattono l’istigazione al-l’odio on-line. Che consiglio ti sentidi poter dare a questo tavolo che fon-damentalmente dovrebbe produrre li-nee guida, campagne e progetti.
Non lo so, cerco di non avventurarmisu cose sulle quali non ho una direttaesperienza e competenza come i temi delrazzismo e delle violenze sociali e cul-turali di questo genere. Le mie esperienzeriguardo al web e internet sono moltolongeve ma non estese su tutto. Il lavoroche mi interesserebbe fare, e per il qua-le ero andato a quella riunione, è un la-voro che faccia comprendere, ai vari at-tori che sono interessati alla risoluzio-ne di questi problemi, le questioni cheli muovono vicendevolmente. Mi sem-bra che, per esempio, alcuni politici, sin-ceri e in buona fede, che tentano di af-frontare queste questioni, considerinole persone più esperte di internet comedegli smanettoni teorici dell’anarchia sulweb, e, viceversa, che le persone esper-te di internet vedano i politici come deigiustizionalisti manettari in cerca dibieche limitazioni delle opportunitàdella rete. La cosa auspicabile è una maggiore di-sponibilità, non dico a trovare compro-messi o a capire quello che dicono gli al-tri, ma accettare le ragioni altrui, le mo-tivazioni, capire che le obiezioni che tista facendo l’altra parte esistono e han-no un fondamento, e te ne devi in qual-che modo far carico.
40
dibattito
Cosa pensa del fenomeno dell’hatespeech su internet? E’ qualcosa
di occasionale o sempre più spessoun binomio? Nel 2010, quando ero direttore de Ilsole 24 ore, conducemmo un’inchie-sta sul lato oscuro della rete. Già al-lora cercammo di raccontare comebullismo, violenza, razzismo, omofo-bia, violenza sulle donne, ma anchel’odio politico, si annidavano in modopalese sul web. Ma ancora stamattina,pur leggendo poco i giornali italianivivendo ormai all’estero, in occasio-
ne della operazioni per la rimozionedella Concordia, leggo commenti sar-castici e volgarità riprovevoli, mentre,se non ricordo male, ci sono ancora al-cune persone seppellite lì sotto o di-sperse. Non vedo l’opportunità ditutta questa giocosità. Molti imputa-no tutto questo al web, io no. Fin da quell’inchiesta ciò che abbia-mo cercato di sottolineare è che laquestione centrale è sull’uso del mez-zo. Per fare un esempio pratico, è lasciocchezza dell’anonimato, i famositroll, il nascondersi nello scambio del
GIANNI RIOTTA
SIAMO DIVENTATI PIÙ INCIVILI. IL WEB LO RENDE SOLO PIÙ EVIDENTE

luca sofri e gianni riotta
dibattito, per insultare liberamente,che rendono non solo i dibattiti sulweb, ma anche i social network, cosìimpestati di aggressività e violenza. Ma questa non è colpa di internet.Chi lo critica non si accorge che ilrancore, l’odio, l’intolleranza l’invi-dia sociale, la volgarità, sono partedella nostra società. In Italia sonoovunque: venti anni di politica sen-za valori, idee, prospettive, ventianni di talk show, di insulti continuisui giornali ed in tv non hanno fat-to altro che alimentare questa situa-zione allucinante. Questo non vuol dire che le minac-ce online debbano restare impunite.Se uno viola il codice penale (sia on-line che offline) deve rispondere del-le sue azioni. Purtroppo l’Italia è unanazione in cui un fatto civilissimo (ilnon essere d’accordo con qualcuno)non viene più espresso nei termini deldibattito civile.Siamo diventati un paese in cuil’impossibilità di parlarsi tra perso-ne di opinioni differenti è talmentegrottesca da produrre questi episodidi violenza. È inevitabile che questoclima da guerra civile permanente siriversi sul web. Quando mancal’espressione civile del dissenso, eccoche lo scontro diventa la modalitàdominante.
Ma non pensa che strumenti come isocial network, in cui la popolaritàspesso si misura nel numero dicommenti espressi su tutto, con tut-ti e in ogni momento, incrementi-no questa comunicazione basata sul-lo scontro?Non sono persuaso che sia l’onni-presenza a farci scendere a questo li-vello di scontro, di aggressività. Hol’impressione che continuiamo aguardare alla tecnologia per trarre ungiudizio sulla nostra società sfug-gendo al fatto che è la nostra societàad essere in qualche modo malata. In fondo la tecnologia funziona comeuno specchio, noi ci preoccupiamodell’immagine riflessa sullo specchioe non del volto che si specchia. Il veroproblema è il volto, non la sua im-magine. Per la sua immediatezza,obliquità e rapidità, il web è diven-tato il luogo in cui il nostro odio si
vede riflesso in modo più limpido eil guardarlo ci mette paura.
Nell’inchiesta che mi citava del Sole24 ore quali elementi cruciali avevateindividuato come portatori di odio?E’ indubbio che l’intolleranza omo-fobica, il razzismo e l’odio politico lafacevano e la fanno ancora da pa-drona. Il problema è trovare la ca-pacità di cambiare radicalmentel’orizzonte della comunicazione. C’è la necessità di riportare, specienell’educazione, il timone su un si-stema di valori ben diversi: il rispet-to, la fratellanza, l’accettazione del-la differenza, la capacità di esprimersisempre in maniera civile anche quan-do abbiamo di fronte un interlocutorecontrario.
A questo proposito come usare ilmezzo web per combattere l’hatespeech?Per prima cosa bisogna abbandona-re la visone duale che ahimè conti-nuiamo ad avere. Ovvero che esistauna dualità tra politica e cultura edil web. Pensare per esempio che il webpossa essere il destinatario “partico-lare” di campagne o azioni, ovveroche l’uso del web possa risolverti la“bontà” del contenuto. Bisogna ab-bandonare la tipica frase “dobbiamofare di più per l’on-line”, che è chia-ramente una sciocchezza. Bisognaconsiderarlo come una piattaforma dausare. Perché il nuovo papa si è di-mostrato formidabile nella comuni-cazione web? Non è che in Vaticanohanno pianificato di essere più pre-senti on-line… No, papa Francesco hauna capacità di comunicazione effi-cace, molto più intonata ai tempi, ela sua popolarità sulla rete ne è unadiretta conseguenza. Ecco quindi chedeve essere la società, la comunità deicittadini per prima, a decidere di in-tervenire in maniera sostanziale suquesti aspetti. Avere davvero la vo-lontà di cambiare le cose. Solo allo-ra il buon utilizzo, l’efficacia del mez-zo ne sarà la debita conseguenza.
In un passaggio del suo ultimo libro“Il web ci rende liberi?” afferma cheè in qualche modo il contenuto chefa esplodere il mezzo di comunica-
zione in modo cruciale. Per il webquale idea si è fatto, quali sono icontenuti che lo rendono così rivo-luzionario per noi?Ci sono dei contenuti on-line che inqualche modo ti danno la possibili-tà di occuparti di cose che prima era-no inaccessibili, o magari aspettiche prima che non riuscivi a seguirea pieno. Il web ti dà la possibilità diintervenire in modo apparentemen-te superficiale, ma a volte efficace. Perfare un esempio, quando arrestarono i due marò ita-liani in India, ho incominciato a se-guire l’informazione di quel paese peravere più chiara la situazione, con-sultando costantemente alcuni gior-nali indiani. Grazie alla memoria diregistrazione dei siti, tutti i giorni hola possibilità di farmi un’idea suquello che succede in India o poten-zialmente nel resto del mondo. Proprio nel paese asiatico qualchesettimana fa un gruppo di cinqueuomini ha violentato brutalmenteuna fotoreporter a Mumbai, dopoaver legato il suo collega uomo nelbel mezzo della strada. La poliziainizialmente non ha mosso un dito.Da lì è partita una campagna sui so-cial network e su twitter in parti-colare, che ha messo in moto l’opi-nione pubblica di mezzo mondo, mecompreso. Io per primo mi sono vi-sto attaccare da chi vedeva questotipo di mobilitazione come un inu-tile e superficiale modo di affrontareil problema. Ebbene, solo quando lavicenda ha ottenuto in questo modol’attenzione internazionale, le forzedell’ordine hanno arrestato tutti ecinque i presunti colpevoli. Questotipo di meccanismo, che solo inter-net ha la capacità di mettere inmoto, è probabilmente l’aspetto piùrivoluzionario del mezzo, ma è soloquesto processo a renderlo tale. Sipuò dire che la condivisione, nega-tiva o positiva che sia, è sicuramentel’elemento più caratterizzante edepocale della rete.
41

42
regioni obiettivo convergenza
Lasciai un anno fa la comunità Rom di Giu-gliano. Stava proprio a ridosso degli enormi
spazi adiacenti l'Auchan. Spazi oltre modo spro-positati per le necessità, pur ragguardevoli, ri-guardanti la logistica, i parcheggi o altra esigenzain capo a tale attività commerciale. Spazi, in unasola parola, al servizio delle merci e non degli uo-mini, condizione questa, sempre più predominantenegli scenari urbani del terzo millennio. Dicontro, nessun spazio, seppur minimo per loro,le diverse etnie Rom di Giugliano, rispetto allequali le autorità locali si resero protagoniste disei sgomberi in cinque giorni, fino a che esse,esauste, scelsero lo strumento “spazio Auchan”come mezzo estremo di protesta. Accamparsi in-torno ad un santuario economico e danneggia-re gli affari, “per il numero di zingari che si ag-gira tra carrelli e macchine” come fu scritto, hasortito maggiore ascolto, rispetto alle legittime ri-chieste fino a quel momento da loro avanzate efinalizzate sempre al solo ottenimento di uno spa-zio non precario sul quale potersi insediare. Leautorità locali, di fronte alla minaccia di una ri-duzione del personale dell’Auchan, a causa delcrollo delle vendite, per altro tutto da dimostra-re, si attivarono, e questa volta in maniera solerte,per trovare un'area dove attrezzare un campo. Nonper accogliere dunque le richieste Rom, ma persoddisfare, invece, le richieste del gruppo com-merciale.Il campo Rom di Giugliano, come quello di Scam-pia, sono esempi che fanno scuola per il fallimentoistituzionale, da una parte, e per il razzismo bu-rocratico, dall'altra: politiche incomprensibiliche conducono ad una rinnovata segregazione et-nica, restringendo in un unico campo serbi orto-dossi e bosniaci musulmani qui giunti per trova-re rifugio dai rigurgiti del conflitto etnico-religiososcoppiato nei Balcani molti anni fa, nel corso delquale queste stesse persone si sono combattute.Il campo è stato attrezzato su un terreno che con-tiene miscele pericolose di gas liquidi e di rifiutitossici lì seppelliti dalla camorra. Questo è quan-to accaduto a Giugliano. Questo è quello che hotrovato un anno dopo quando sono venuto a ri-trovare le persone che conosco. Trovo il campo posizionato di fronte ad una di-
scarica di biogas: dismessa, sostengono le auto-rità locali; ma in verità, almeno per quanto ri-guarda il rilascio di gas a cielo aperto, ancora at-tiva. Attività, questa, che sta complicando lo sta-to di salute di molti bambini e bambine Rom giàdi per sé minacciato dalle precarie condizioni igie-nico–sanitarie del campo. Strani arrossamenti conuna presenza significativa di pustole sempre piùcompaiono, senza alcun evidente motivo, sullamaggior parte della pelle della popolazione delcampo, la quale, poi, racconta anche della diffi-coltà che prova al risveglio, provocate, loro dicono,da quello strano gas che respirano durante la not-te. Nonostante mesi di denunce da parte della po-polazione del campo Rom di Giugliano, tutti gliattori istituzionali coinvolti hanno sempre smen-tito qualsiasi danno alla salute della popolazio-ne, salvo scoprire, in questi giorni, quello che tut-ti già sapevano, ovvero che il campo di Giuglia-no insiste su un terreno di sicuro contaminato peril sotterramento selvaggio da parte della camor-ra di materiali nocivi e pericolosi in quantità ec-cezionali.È inaccettabile che uomini e donne, bambini ebambine, siano disumanizzati, stigmatizzati, spo-gliati di ogni diritto e tutela, e chiusi di fatto inun luogo che altro non è se non un campo di ri-confinamento. Un campo dove vedi un bambinoimmerso in un fusto di latta che ti sorride e ti diceche lì dentro sta facendo la doccia e altri bambi-ni fare la fila 'giocando' per farsi anche loro la doc-cia con acqua che arriva di un colore strano e dovelo scenario non è un bagno dentro una casa, mauno spazio aperto immerso nei rifiuti, con tantapolvere e fango. Ma più ancora è il fango di cuisi coprono quanti con la loro indifferenza pre-giudicano il futuro di bambini rei solo di esseriRom, come i piccoli di Giugliano.
La vergogna del campo Rom di Giugliano
Se il luogo prescelto è una discaricadi Maurizio Alfano

43
L’ASP di Catanzaro (l’Azienda sanitaria pro-vinciale) da quindici anni ha intrapreso uncammino di riqualificazione nell’offerta di salu-te. Nell’agosto 1997, sulle coste Joniche (Badola-to), iniziarono gli arrivi delle famose “carrette delmare”: una emergenza fino ad allora sconosciu-ta. Duemilatrecento profughi. Curdi, pakistani, cin-galesi, egiziani in fuga da drammi, che necessita-vano di supporto psico-sociale oltre che di cure me-diche. Qui nacque il bisogno di fare “rete” e si capìche gli operatori dell’ASP avevano bisogno di ave-re nuove competenze, oltre che di poter fare af-fidamento sui mediatori. Da allora, molte sono sta-te le azioni di riqualificazione del personale, di in-tensificazione dell’operatività “in rete”, di strut-turazione di strumenti multilingue per facilitare lacomunicazione, di confronto con altre metodolo-gie operative nazionali ed europee. Oggi operia-mo attraverso un settore, denominato “OrganismoImmigrazione”, che fa capo alla direzione gene-rale dell’ASP. Esso ha mansione di coordinamen-to funzionale delle attività tecnico gestionali e for-mative di area sanitaria e socio-sanitaria, dedica-te alla popolazione immigrata, ai servizi aziendalie territoriali pubblici e privati. Ciò ci permette dimantenere i rapporti con tutti i servizi dell’ASP cosìda poter supportare gli immigrati in ogni difficoltàrelativa alla fruizione di servizi. Essenziale in questo processo è il mediatore tran-sculturale, che funge da “ponte” fra gli operatorie l’immigrato. Per prevenire, decodificare, dia-gnosticare e curare, è essenziale un supporto tran-sculturale che permetta una valutazione della ri-chiesta di salute che sia coerente con la persona edil suo bagaglio culturale. Tale concezione opera-tiva prende in considerazione “la persona” nella suacompletezza, avendo cura di non frantumarla e dinon porgere attenzione solo ad una parte di essa. Così una donna che si rivolge ad un ConsultorioFamiliare per una gravidanza ha il diritto di es-sere “presa in carico” non solo per l’evento in que-stione. Va valutato il contesto dove vive e da doveproviene, così da comprendere meglio le richie-ste di cura e proporre azioni coerenti con la suapersona, con chi le vive accanto, con chi è lon-tano ma è significativo, con la sua storia, con lastoria del suo compagno, con il progetto di vita
e così via. Tale approccio può essere proposto benese un operatore sanitario o socio-sanitario ha com-petenza transculturale e se è supportato da un me-diatore culturale. Il rapporto con il medico, l’espressione dei sinto-mi, la visione della nascita, della malattia, del-l’invalidità e della morte variano a seconda del luo-go di provenienza. L’ascolto empatico e la co-municazione interculturale diventano allora stru-menti essenziali permigliorare la salute. In considerazioneche in Italia l’infor-mazione e la sensi-bilizzazione sul di-ritto alla salute e alben-essere sono an-cora poco diffuse,preminenti sono ladiffidenza e la sfi-ducia nei confrontidelle istituzioni daparte degli immigrati regolari e irregolari. Il pro-getto appena concluso (“Linee Transculturali nel-la medicina di base e nel materno infantile”) ha rag-giunto decine di persone, donne, uomini e bam-bini che avrebbero in alcuni casi visto cronicizzarsialcune patologie facilmente curabili ed ha consentitodi tutelare la salute delle donne, dei minori e deibambini, ovvero dei più vulnerabili tra gli immi-grati. Il progetto ha avuto un impatto positivo an-che sugli operatori sanitari, sul loro modo di ascol-tare, accogliere e curare. Tale progetto ha previsto l'apertura di ambulato-ri aventi anche funzione di centro di informazionee orientamento, rivolti a tutti gli immigrati in par-ticolare agli irregolari o non iscrivibili al SSR edin condizione d’indigenza. Benché le leggi miri-no a garantire il diritto alla salute per tutti, nel-la pratica quotidiana esistono barriere, che di-ventano ancora più evidenti nel caso di immigratinon regolarmente soggiornanti. È per questo cheogni realtà, sia essa locale o nazionale, passo dopopasso, deve reinventarsi e creare strumenti che rap-presentino un supporto fondamentale per le leg-gi che enunciano il principio, ma che non rego-lamentano la materia nello specifico.
L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e gli immigrati
L’importanza di acquisirecompetenze transculturali
di Teresa Napoli Coordinatore Organismo Immigrazione eMeryem MaktoumMediatore interculturale

regioni obiettivo convergenzaSICILIA
44
Si è conclusa, a Bari, domenica 22 settembre la77° Fiera del Levante. La campionaria inter-
nazionale che coinvolge espositori e visitatori pro-venienti da ogni parte del mondo. In numeri: il 2013ha visto 275 mila visitatori e 532 espositori.Il suo neo presidente, Ugo Patroni Griffi, con or-goglio parla di una Fiera che vede riunirsi espo-sitori di 50 diversi Paesi del mondo.
Presidente Patroni Griffi, cos’è la Fiera del Levante?“La Fiera del Levante è un luogo che è espressionedi un territorio. E’ un’organizzazione, è un luogo geo-grafico, è riferita ad una campionaria che si svolgein un determinato periodo temporale, ed è anche unadeclinazione di un determinato territorio perché i socisono tutti di ambito territoriale: la Camera di Com-mercio, il Comune, la Provincia e poi c’è un soggettoche non è socio, ma che ha un forte potere di indi-rizzo che è la Regione Puglia. Quindi c’è uno stret-to rapporto fra enti territoriali, Fiera del Levante eluogo e tempi in cui si svolge la campionaria.Durante la campionaria, ma anche durante altrefiere più dirette al business che non ai consuma-
tori, vi sono numerosi soggetti,imprenditori e visitatori che pro-vengono da altre culture. Questisoggetti possono avere interes-si più vari, sia come scambi com-merciali, quindi relazioni bilate-rali, che come espositori. Que-st’anno la Fiera ha accolto 520espositori stranieri che rappre-sentano ben 50 Paesi differentie questa gente vive per novegiorni a Bari, dove ha la neces-sità di sentirsi accolta”.
Si può immaginare la Fiera del Levante comeluogo di scambi di culture?“La Fiera è un luogo di scambi commerciali, e ilcommercio è un’attività votata a superare ogni tipodi divisione, quindi capace di valorizzare relazioniculturali tra i diversi soggetti coinvolti.In futuro – aggiunge il Presidente – cercheremodi fare anche un’attività pedagogica sull’inter-nazionalizzazione delle imprese. Perché, per in-ternazionalizzarsi, le imprese devono fare due per-corsi: prima fare una ricognizione dei territori, ita-
liano e dei Paesi in cui vorrebbero approdare, epoi fare un percorso di conoscenza culturale; quin-di, oltre a conoscere il sistema giuridico ed eco-nomico, occorre sapere quale è la cultura di unluogo, prima di integrarsi.
Accoglienza ed integrazione: ritiene che laFiera possa rappresentarle entrambe?“Si può essere intergrati se uno ha almeno i rudi-menti di una diversità culturale con la quale intendedialogare. Integrazione ed accoglienza sono dueconcetti non sempre coincidenti, anzi per certi ver-si antitetici. Accoglienza è la propensione a rice-vere il diverso da sé, mentre l’integrazione è un pro-cesso che non si può fare se l’altro non collabora.L’accoglienza è la capacità di una popolazione, diuna istituzione, di un ente, di una regione, di unpaese di poter ricevere persone che hanno dei va-lori, una storia, una religione ed una ideologia dif-ferente. E’ una propensione all’apertura, è una de-clinazione dell’empatia della capacità di rapportarsiall’altro, favorendo un dialogo, il che significa ave-re grande capacità di apertura mentale. L’integra-zione è un processo: l’altro, pur trovando un am-biente accogliente, deve potersi integrare. Ed è ilprocesso inverso: ovvero l’altro, entrando in un am-biente diverso dal proprio, deve avere la com-prensione e il rispetto per tradizioni che possononon essere del tutto compatibili con le proprie. Sen-za abdicare alla propria storia, alla propria tradi-zione, deve però comprendere che anche il popo-lo che lo accoglie ha un comune sentire a cui l’al-tro si deve adeguare. In questo senso, ritengo edauspico che la Fiera del Levante possa essere un vo-lano di accoglienza e, quindi, di integrazione. Que-st’anno tanti sono stati gli espositori provenientidai Paesi africani, come Kenia e Tanzania; e dal-l’Oriente, in particolare Cina, Corea e Hong Kong.Sono parecchie le esperienze di stranieri, sia comeespositori sia anche come visitatori, che si sono in-trecciate. Questa è una formula con la quale rea-lizzare una grande campionaria-evento, una sagradi popoli. La Fiera potrebbe essere il contenitore diesperienze di altri Paesi e anche di conoscenze dialtri Paesi. Così, oltre a conoscere i prodotti, po-tremmo realizzare un’apertura su un mondo geo-graficamente lontano, ma magari culturalmente piùvicino di quanto uno possa pensare”.
A colloquio con Ugo Patroni Griffi
L’integrazione passa dalla Fiera del Levante
di Irma Melini
regioni obiettivo convergenza

45
Emblema di soccorso e di accoglienza, Lam-pedusa è da anni il primo luogo di appro-
do di migliaia di migranti che, in fuga da per-secuzioni e torture, lasciano il proprio paese diorigine in cerca di un futuro migliore. Oggi, coin-volte dal fenomeno degli sbarchi, lo sono tut-te le coste del sud Italia, in particolare quelle si-ciliane, pugliesi e calabresi, che rappresentanola porta di accesso in Europa. Ma proprio l’iso-la di Lampedusa è diventata il simbolo di quan-ti emigrano e di chi è costretto a farlo. Sono migliaia coloro che giungono disidra-tati e provati da un viaggio assurdo in mare.Per molti è anche la prima volta che lo ve-dono, il mare. E neanche sanno nuotare. Pa-kistani, nigeriani, eritrei, sudanesi, congole-si, somali, siriani. Paesi diversi, rotte simili,sofferenze analoghe. Nonostante questo, laprima cosa che fanno quando toccano final-mente terra, dopo circa tre giorni interi diviaggio in mare, è sorridere. “Hi sister, I’m ali-ve!”. “Ciao sorella, sono sopravvissuto!”. È ilsaluto che pronunciano come fossero ubria-chi, barcollando, a causa delle tante ore di na-vigazione. Senza acqua, senza cibo, con unsacco nero della spazzatura che contiene ciòche di più caro riescono a portare con loro.Fotografie, libri sacri, documenti, attestati distudi. Molti di loro infatti sono giovani di cul-tura, costretti a fuggire per porre fine a per-secuzioni e torture. Pagano fior di quattrinia ‘capitani’ di bordo illegali che una volta rag-giunto il mare aperto, abbandonano ‘la nave’per non essere catturati. Croce Rossa Italiana è presente sia a Lampedusasia sulle coste della Sicilia, della Calabria e del-la Puglia, nell’ambito del Progetto Praesidiumche, ormai all’ottava edizione, è finanziato dalMinistero dell’Interno e vede la collaborazionedi tre agenzie umanitarie oltre la CRI: Save thechildren, l’OIM (Organizzazione Internaziona-le per le Migrazioni) e l’UNHCR (l’Alto Com-missariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati). La CRI ha il compito specifico di fornire infor-mazioni ed assistenza in ambito socio-sanita-rio ai nuovi arrivati, cooperando nell’indivi-duazione delle persone vulnerabili. Ciò consentedi individuare migliaia di migranti e richiedenti
protezione internazio-nale nel momento piùdelicato, ovvero al-l’arrivo, intervenendonelle fasi di avvio del-le procedure legali. Elemento di notevoleimportanza, al fine disvolgere al meglioquesto ruolo, è la mediazione interculturale, chesi pone come tramite tra i bisogni dei migran-ti e le risposte offerte dai servizi pubblici, ri-ducendo così lo spaesamento che il migrantestesso prova trovandosi catapultato in una re-altà differente dalla propria. Con il mediatore in-terculturale, i migranti ritrovano un po’ di se-renità, riacquistano il sorriso che nasce da qual-che battuta pronunciata nella loro lingua, si sen-tono compresi e accolti. Il mediatore interculturale dà voce ai migran-ti, alle loro esigenze e consente al ‘field officer’,operatore sul campo, con competenze specifi-che in tema sanitario e di migrazione, di gesti-re le relazioni interpersonali tra i migranti e isoggetti coinvolti nell’accoglienza.Tutto questo è importante. Ma la condizione de-terminante di ciò che oggi è diventata Lampe-dusa per migliaia di persone migranti, sono ilampedusani stessi che insieme agli operatoriumanitari, alla Capitaneria di Porto, alla Guar-dia di Finanza e alle Forze di polizia, rispondonocon responsabilità e umanità, all’appello di al-tri esseri umani in difficoltà e li assistono quo-tidianamente da anni.Durante lo sbarco non si ha tempo di riflette-re, ma tutti i sensi sono colpiti come un pugnonello stomaco, al quale non si fa caso perché cisi deve concentrare sulle persone ed assicurar-si che stiano bene. Ma una volta che si torna acasa, si scopre che quegli incontri, queglisguardi misti di malinconia e speranza, e atterritidalle condizioni del “viaggio”, sono scritti inmodo indelebile nella memoria. Qualsiasi azio-ne e qualsiasi parola che non sia “per” le per-sone, in quel momento, appare superflua, irri-spettosa e profana. E allora, uno sguardo, un ab-braccio, una carezza possono dire più di milleparole.
Il ruolo della CRI a Lampedusa, tra le agenzie umanitarie a tutela dei migranti
«Ciao sorella, sono sopravvissuto!» di Paola Longobardi Team Praesidium Croce Rossa Italiana

di Antonio Giuliani
M i serve una fotocopia! Beh vuoiche non trovi un tabaccaio
aperto che mi possa fare una fotoco-pia? È vero sono le 3 del pomeriggio,è agosto, siamo a Foggia ma ormai inegozi fanno tutti l’orario prolunga-to, l’Italia è aperta 24 ore su 24 cheproblema c’è…. Che problema c’è? Giro, comincio a girare, via delle Vit-time Civili, corso Garibaldi, corso Vit-torio Emanuele, via Bari, niente.. tut-to chiuso… nessuno in strada… cittàdeserta! Vabbè qualcosa vicino alla sta-zione sarà aperto, via di corsa e fac-ciamo sta’ benedetta fotocopia.Via Montegrappa, Via Trento, viaFiume, via Trieste, via Monfalcone tut-to chiuso. Ehi ma qui ci sono “i cine-si” vedrai che almeno loro sono aper-ti e che una fotocopiatrice la avranno…niente anche i cinesi sono chiusi! Por-ca miseria, sono pugliese (sebbene tra-piantato a Roma da 25 anni) conoscobenissimo la contr’ora e il suo effetto
sugli abitanti ma che anche i cinesi siadeguassero immediatamente alle con-suetudini locali non lo immaginavo!E lì improvvisamente mi accorgo chepotrei essere ovunque o meglio sonoin un mondo in miniatura: macelleriahalal, barbiere per pachistani, negozi“Tutto a 1 euro” cinesi, kebaberie
nordafricane, bar (quelli ancora tuttiitaliani) e insegne scritte con caratterisconosciuti. E che cosa accomunatutti quanti? La contr’ora! Dicesi “contr’ora” quel periodo dellagiornata che va dalle 2 del pomerig-gio circa, alle 4/4 e mezza circa (an-che oltre, se è piena estate) durante ilquale la città si svuota, le strade sonodeserte, si può sentire il silenzio, anzipiù spesso (e, lasciatemelo dire, è an-che più allegro) si possono sentire leforchette che sbattono sui piatti arro-tolando spaghetti o le bottiglie che tin-tinnano sui bicchieri. Insomma, è laparte della giornata in cui il caos piùo meno organizzato, il chiasso più omeno gioioso, l’affaccendarsi più omeno alacre tipico di tutte le città delSud sparisce: ci si riposa!Quello che colpisce è che a Foggia, lacontr’ora è forse l’unico elemento cheaccomuna tutti, italiani e non, e li met-te sullo stesso piano, senza differenze.Per il resto? Beh per farsi un’idea: aFoggia, per la precisione a Borgo
Mezzanone, c’è un CARA (Cen-tro di Accoglienza per Richie-denti Asilo) che può accogliere856 persone; lì vicino, a BorgoArpinova c’è un “campo no-madi”, in parte “autorizzato” inparte abusivo con circa 80 fa-
miglie Rom (oltre 300 persone di cui piùdi 100 sono bambini). Foggia è la ca-pitale del lavoro nero agricolo. Migliaiadi braccianti provenienti per lo più dal-l’Africa e dall’est europeo impegnatinella raccolta di pomodori, peperoni se-minati nelle immense distese di cam-pi del Tavoliere delle Puglie. Foggia èun importante nodo ferroviario che legail sud al nord e il Tirreno all’Adriaticoe, di conseguenza, è luogo di fermatain attesa di qualcosa, fermata che puòdiventare sosta e, tante volte, stop.Insomma, un concentrato di possibi-li tensioni etniche, un coacervo di pos-
sibili scontri razziali, un incrocio di vitee storie di tutte le parti del mondo cheincontrano una delle città più ingua-iate d’Italia. Eh già perché il tutto av-viene in una città che è da anni agliultimi posti della classifica italiana sul-la vivibilità stilata dal Sole 24 ore, sem-pre in coda quanto alle statistiche suiredditi pro capite, con una malavitamolto presente e che si fa sentire mapoco visibile, con indici di disoccu-pazione altissimi, quasi quanto i cu-muli di rifiuti che periodicamente siammucchiano sulle strade. Eppure… eppure si sta (in Puglia il ver-bo “stare” è quasi come il get inglese,si usa in mille modi diversi, in questocaso indica uno stato dell’essere,un’acquiescenza, un’accettazione).Mimì l’elettrauto è ormai abituato adavere come proprio vicino l’alimenta-ri/macelleria nordafricano, accantoalla gioielleria fioriscono “i cinesi” (inegozi “Tutto ad 1 euro”, giusto per ri-cordarlo), non ancora elevatisi al livelloromano di piccoli multistore, ma an-cora al livello di rivenditori di cazza-telle, giocattolini, stramberie e taroc-chi vari e poi la pizzeria San Giorgioche si contrappone (solo gastronomi-camente) al venditore di kebab. Insomma convivenza interetnica. Tranquilla? Questo non oserei dirlo.Tante piccole arrabbiature quotidiane,46
cultura
Quello che colpisce è che a Foggiala contr’ora è forse l’unico elemento che accomuna tutti, italiani e non, e li mette sullo stesso piano,senza differenze.
Una giornata a Foggia. La città è una polveriera… Eppure. Eppure si sta.
La contr’ora
Foto di Francesco De Rosa

tanti piccoli incidenti, tante bottiglie dibirra lasciate per strada, tanta puzza dipipì che si avverte in alcuni portoni epoca voglia di parlarsi e di conoscer-si. Diffidenza, paura, a volte ostilità,molti pregiudizi impediscono la cono-scenza. Senti dire: “Ma hai provato apassare per quella strada? Tu farestipassare tua figlia di sera in mezzo a tut-ti quegli uomini ubriachi?”. E vado avedere e penso “mia figlia? Non ci pas-serei neanche io per quella strada, fi-gurati mia figlia”. Ma poi mi sforzo, ac-cendo il cervello e cerco di ragionare.
Cerco di fare ciò che ognuno di noi do-vrebbe fare, operare quotidianamentesu sé stesso per non essere tutto istin-to e cuore ma anche razionalità: por-ca miseria siamouomini, il nostrocervello è più svi-luppato di quellodegli altri animaliproprio perché do-vremmo utilizzar-lo di più e forza! Eallora, tac… mi vengono in mente im-magini della mia giornata e ripenso che
nonostante i 40 (leggasiquaranta) gradi di oggisono passato in macchi-na davanti a campi di po-modori immensi, in cui sivedevano decine di schie-ne nere che riempivanocassoni enormi. Avetemai visto un campo dipomodori dopo la raccol-ta? A me fa venire inmente un campo di bat-taglia, ti aspetti di vede-re da un momento all’al-tro il corpo di qualche sol-dato caduto in combatti-mento. Un odore acido edolciastro che riempiel’aria e migliaia di resti(vegetali, per fortuna) ab-bandonati. Beh su quelcampo, qualcuno per 12
ore di seguito per un compenso di 20euro circa (in nero, qui tutto è nero, an-che il compenso) ha raccolto quintalidi pomodori, questa sì che è una
guerra. E alla fine di una giornata delgenere cosa fa, questo povero qualcu-no? Va a stare in una baracca di for-tuna in qualche campagna lì vicino,dove per più o meno la metà di quel-lo che ha guadagnato, lo fanno dormireper terra e lo fanno lavare con acquaportata dal Comune (almeno questa vie-ne data…).E poi, se questo “qualcuno” decide diandare a passare un po’ di tempo incittà, deve fare chilometri a piedi o suqualche bicicletta o automobile sgan-gherata. I bus no. I bus costano, an-che se a volte sono “riservati” a que-
47
La città è una polveriera, con una micciache sembra sempre sul punto di accendersi…Ma, nello stesso tempo, riesce sempread andare avanti, con quel fare tutto meridionalea metà fra l’ineluttabile e l’accomodamento

sti “qualcuno”. Eh già, perché c’è sta-to un periodo che è successo anchequesto: un bus tutto per i neri e un bustutto per gli italiani per fare sotto e so-pra fra il CARA e Foggia. Apartheid?Misura razzista? C’è chi vi ha visto unservizio utile messo a disposizione deirifugiati e non un divieto per i rifugiatia prendere i bus “normali”. Insomma,come al solito, chi la vede bianca e chila vede nera… bianco e nero… sempreloro, questi due colori che si rincorronoe si alternano, in una città che, inve-ce, sembra avere solo grigi.Serve come giustificazione? Vale aspiegare alcune brutture che ferisco-no la convivenza interetnica? Forseno, niente giustifica la mancanza di ri-spetto delle cose comuni, lo sfregiodelle persone e delle cose, eppure que-ste sono le stesse persone che sonobenvenute, anzi cercate per la raccoltadei pomodori che altrimenti rimar-rebbero appesi alle piante a cuocersisotto il sole e se nei campi ci sono mi-gliaia di persone che lavorano non
possiamo pensare che queste personescompaiano una volta finite di lavo-rare. Questi sono ragazzi giovanissi-
mi: 18, 20 anni, che li vedi e pensi chetu, a 20 anni, pensavi soprattutto adandare appresso alle ragazze e il tuoproblema più grande era in quale pubandare a bere una birra e non in qua-le baracca andare a dormire… eppu-
re sorridono! Quando ti rivolgi aloro, chiedi qualsiasi cosa, magari dadove vengono, così giusto per sape-re, ti sorridono e ti parlano della lorostoria, della loro fuga, bambini di-ventati troppo presto ragazzi e im-mediatamente adulti.“Certo se ci fosse anche qualche don-na…..” anche questo è un pensiero chesento spesso. Questa di Foggia èun’immigrazione molto maschile, ser-vono braccia forti per lavorare la ter-ra. Le donne semplicemente non cisono. Chi viene a Foggia non viene perfermarsi con la propria famiglia: i bam-bini, le donne tutto ciò che ingentili-sce l’immagine e che contribuisce a fa-cilitare la convivenza interetnica quinon esiste.
Uomini, solo uomini, tanti uomini!Gruppi, quasi branchi di uomini cheparlano, gridano, ridono, litigano. È difficile rispondere a coloro che tiparlano di invasione. È difficile nondare ragione ai commercianti (di
cultura
48
Eppure… eppure si sta in convivenza interetnica. Tranquilla? Questo non oserei dirlo.
Foto di A
ttanasio Finigue
rra
Foto di Francesco Paolo

qualsiasi nazionalità, in questo casoil fronte è eterogeneo) che si lamen-tano delle centinaia di venditori am-bulanti e abusivi che vendono mercecontraffatta per la strada, rendendo avolte anche difficile effettuare laclassica passeggiata pomeridiana.“Cosa rispondi?” Te lo chiedono conforza, come una sfida! E a me vengono
in mente le immagini in bianco e nerodell’emigrazione in Italia, delle scatoledi cartone che noi meridionali porta-vamo in giro per il mondo (e che nonsi rompevano mai, altro caso di ma-nifattura del passato molto miglioredell’attuale.…), dei cartelli “qui nonpossono entrare gli italiani” affissi neibar in Belgio ed in Svizzera e imma-gino che le stesse domande, tante al-tre volte nel passato e magari ancheoggi (ricordiamoci che gli italianicontinuano, anzi, ricominciano ademigrare) se le siano poste in altri luo-ghi ma con noi italiani come ogget-to. Mi vengono in mente le tante per-sone anziane che si abbarbicano allaloro “signora dell’est”, unico appigliofisico e a volte sentimentale che han-no, grandi (in tutti i sensi) donne chestanno tenendo in piedi l’intera ge-nerazione dei nostri anziani e poi (cuo-re di papà) mi vengono in mente i mieibambini, i bambini, il mio futuro, il fu-turo di tutti: i bambini che parlano congli Ahmed e con le Natalia, con le Ez-zin e con i Prasant, con i Mohamed econ i Joseph senza pensare al coloredella loro pelle. Che ci litigano e cifanno a cazzotti perché uno è della
Roma e l’altro è dell’Inter e non per-ché sono diversi, perché loro non san-no più cosa significa essere diversi…o forse non lo sanno ancora? Ma ioNON VOGLIO dover spiegare a mio fi-glio che tutte le persone sono ugualial di là del colore della pelle, VOGLIOche non sia necessario perché per lorodeve essere normale… per loro la do-
manda deve essere “perché… c’è qual-che differenza?”.Queste sono le risposte che do, questopenso quando vedo Foggia che sembrauna polveriera con una miccia che sem-bra sempre sul punto di accendersi mache, nello stesso tempo, riesce sempread andare avanti con quel fare tutto me-ridionale a metà fra l’ineluttabile e l’ac-
comodamento, fra quelli che dicono “ec’amma fà (n.d.r. e che dobbiamofare…) e quelli che dicono “e mè, chepure quisti anna magnà… (n.d.r. e for-za che anche questi devono mangiare)”.Quando vedo che l’immigrazione nonregolamentata fa male prima di tuttoagli immigrati stessi e che lo Stato nonpuò continuare a rinviare l’adozione dipolitiche reali a favore dell’integrazio-ne ma vedo, nello stesso tempo, che lavera integrazione avviene per strada, frala gente comune che va a fare la spe-sa alla frutteria del ragazzo marocchi-no perché ha la roba più buona ed è ilpiù gentile di tutti. Quando vedo il vec-chietto seduto sulla panchina a parla-re con il venditore ambulante maroc-chino, perché gli affari non vanno benee forte della sua esperienza di com-merciante gli dà consigli su come au-mentare le vendite. Quando vedo uncampetto di calcio in cui sento il forteaccento foggiano parlato da uno scu-gnizzo con la pelle così scura da nonpoter essere solo abbronzato. Penso che non è la pelle o la prove-nienza che rende un uomo cattivo opericoloso ma le circostanze, le con-dizioni di vita, la fame, i bisogni pri-mari e che, in fondo, quello che cer-ca chi viene in Italia, a Foggia, è po-tersi godere anch’esso la contr’ora, ilmomento in cui tutti sono uguali, sen-za differenze!
Foto di Francesco Paolo
Foto di U
mbe
rto Battista

In occasione della prima proiezione ro-mana de “La mia classe” di Daniele Ga-glianone, presentato nella sezione Gior-nate degli Autori al Festival del Cinemadi Venezia, abbiamo incontrato il regi-sta. Il film è un efficace ritratto di unaclasse di stranieri che studiano l’italiano,guidati dal maestro Attanasio interpre-tato da Valerio Mastandrea. Grazie ad unottimo meccanismo che lascia sospeso lospettatore tra finzione e realtà il fimeriesce ad essere una delle migliori rifles-sioni del cinema italiano sullo stato deimigranti nel nostro paese.
Il film è piuttosto originale nel fonde-re le vicende dei protagonisti della clas-se con la loro effettiva situazione di stra-nieri. Come è nata l’idea di partenza?L’idea è nata un anno fa. L’intenzione eraquella di ispirarsi, con il dovuto rispet-to, a ciò che aveva fatto De Seta con Vitadi un maestro. Abbiamo pensato di fareuna cosa simile, anziché con i ragazzi-ni del Tiburtino degli anni 70, con glistranieri, creando una situazione in cuidelle persone autentiche devono davveroimparare l’italiano ed interagire con unprofessore-personaggio. Da qui far nascere una drammaturgia cheavesse il suo punto di forza nelle lezio-ni e che non fosse sceneggiata, ma cheprevedesse semplicemente il canovaccio
dell’iterazione del professore con gli stu-denti. A tutto ciò, all’interno della fin-zione del film, volevamo inserire anchedegli eventi plausibili partendo dalla si-tuazione reale degli studenti. Parlando con gli studenti, abbiamo im-maginato che ad uno di loro venisse tol-to il permesso di soggiorno, in partico-lare quello per la protezione umanitaria,che è uno dei più labili: che si dà a chifugge da una situazione temporanea ditensione, che va costantemente vaglia-ta, per la quale è giusto dare una pro-tezione umanitaria, ma solo provvisoria. Questa persona avrebbe dichiarato che,se obbligato a tornare nel proprio pae-se, si sarebbe tolto la vita. E così c’era-vamo immaginati che il ragazzo inquestione andasse dal professore rive-landogli di avere il permesso scaduto ma,rassicurato da quest’ultimo, il ragazzocontinuasse le lezioni. Successivamen-te, fermato per un controllo casuale del-la polizia, alla fine si toglie la vita.Ma a due settimane dall’inizio delle ri-prese, ad un altro ragazzo viene tolto dav-vero il permesso di soggiorno, e noi nonpotevamo farlo lavorare, perché se fos-se arrivato un controllo avremmo ri-schiato sanzioni e la chiusura del pro-getto. Ma al di là di quello che poteva onon poteva succedere, la cosa che ci hamesso fortemente in difficoltà è stato ilfatto che in qualche modo le regole chevolevamo rispettare ci costringevano afare qualche cosa che non volevamo fare.
Era come andare contro la missionestessa del filmEsatto, come ho detto l’altra sera in oc-
casione della prima proiezione a Roma,improvvisamente, mentre sto facendo ilfilm su queste problematiche, mi sichiede di fare il secondino. Io non lo vo-glio fare. Abbiamo cercato di risolverela situazione, riuscendoci, ma il disagiovissuto non lo abbiamo buttato via, ab-biamo cercato di farne un punto di for-za del film stesso. Ci siamo chiesti cosasarebbe accaduto se questa cosa del per-messo di soggiorno fosse avvenuta du-rante le riprese e se ci fossimo compor-tati in un modo diverso, abbandonan-do il ragazzo al proprio destino. Nellamessa in scena quindi, non facciamoproseguire il film al ragazzo.Tutto ciò ci ha costretto a rendere il filmun oggetto anomalo. Lo abbiamo resomolto credibile non chiamando qual-cun’altro a interpretare il regista o le per-sone della troupe, ma mettendoci noistessi doppiamente in gioco. Abbiamocompiuto un lavoro che è forse il livel-lo di messa in scena massimo.Inoltre, abbiamo impostato il lavoro inmodo tale che gli studenti non cono-scessero l’evoluzione della storia fin dasubito, ma la recepissero passo dopo pas-so, poco prima che le cose dovessero ac-cadere. Questo poneva noi tutti nellacondizione di non sapere quello che sa-rebbe esattamente successo. Per questosembra tutto vero, perché in sostanza èvero. Ci siamo trovati tutti in bilico traquesti due territori, in un continuo slit-tamento tra finzione e realtà. Da un pun-to di vista tecnico ci sono alcune im-perfezioni, ma era la macchina da pre-sa che doveva assecondare ciò che av-veniva, non il contrario.
cultura › cinema
50
Intervista al regista Daniele Gaglionone, autore de “La mia classe”, proiettato a Venezia
«Il punto non è l’antirazzismo. È farsi delle domande diverse»
di Edoardo Fonti

Per il casting, ma anche per il meto-do dell’insegnamento come avetelavorato?Siamo andati nelle varie situazioni discuola per stranieri, sia quelle legate alleassociazioni di volontariato, sia quelle uf-ficiali per stranieri, e abbiamo seguito illavoro dei professori e la loro imposta-zione, cosa voleva dire insegnare l’ita-liano alle persone adulte straniere chehanno bisogni anche molto pratici.Contemporaneamente, in questo nostrogiro, facevamo una ricognizione ri-spetto alle persone che potevano parte-cipare al film. Sceglievamo in qualchemodo solo in base alle persone. Non sen-tivamo la preoccupazione di dover rap-presentare il planisfero. Ovvio che allafine nella classe c’è il mondo, come intutte le classi di questo tipo, ma per dire,ci sono tre curdi, tre bengalesi, ma nes-sun cinese. Ci sembrava già quello un
punto di vista sbagliato e distorto. Ci fe-cero esattamente questa obiezione, sul-l’assenza di cinesi, e lì abbiamo avuto laconferma di essere sulla strada giusta.
Che idea ti sei fatto dell’integrazione sulset, tra gli studenti, con la troupe, laproduzione?Ti posso dire una cosa che può sembra-re una battuta ma che non lo è affatto.Quelli che più hanno sentito la necessi-tà di integrarsi siamo stati noi, gli italiani,gli indigeni. È ovvio che chi viene in Ita-lia deve imparare un’altra lingua, devecambiare modo di ragionare, deve sot-tostare ad una nuova mentalità, una nuo-va legge etc etc. Però il problema del-l’integrazione è avere la capacità di ri-considerare le relazioni tra le persone, equello è più un problema nostro che loro.Loro ne hanno già tanti di problemi. Quel-lo che il film fa vivere allo spettatore, ed
è in fondo quello che è capitato anche anoi, è il ribaltamento di questo mecca-nismo, che rischia a volte di essere an-che un po’ ricattatorio, per il quale tu vedisubito delle persone in difficoltà, maga-ri appena sbarcate a Lampedusa, e che tipongono in una prospettiva dove hai duescelte, o dici chi se ne frega, possono an-che morire, oppure dici come faccio a nonessere solidale? Qui invece succede ilcontrario: nei primi trenta, quaranta mi-nuti, dove il film è anche ludico, le per-sone della classe diventano tuoi amici.Quando ti raccontano da dove arrivanoe quale inferno hanno vissuto, oppurequando vengono presi dalla polizia,non è più una cosa che capita ad un es-sere invisibile, ad un numero di qualchestatistica più meno macabra, non è piùtra virgolette, la solita storia, è un’altracosa. Sono diventate delle persone condei nomi, e anche chi guarda è chiama-
to a prendersi delle responsabilità diffe-renti. Cerchiamo di scavalcare il proble-ma del razzismo, ma non perché il raz-zismo non c’è, ma perché cerchiamo didire in modo molto semplice che in pri-ma battuta siamo delle persone, e poi tut-to il resto. Il punto non è l’antirazzismo.Il punto è che per fare due passi avantibisogna farne uno indietro, bisognafarsi delle domande diverse.
Valerio Mastandrea a fine proiezio-ne ha detto che parlare del film eraquasi inutile …In effetti il film ti pone nei tuoi con-fronti in un modo così schietto che ègià tutto lì. Poi è chiaro che è giustoparlarne, perché le cose mettono inmoto dei ragionamenti, delle riflessioni,però da un certo punto di vista il “ba-sta parlare” di Valerio non è sbaglia-to. Basta parlare perché forse sarebbe
meglio passare a fare qualcosa. Ti as-sicuro che questo immergersi com-pletamente nella contraddizione, alcento per cento, e non cercare di ri-solverla, non è da tutti. Quando nor-malmente si fa un film, si dice nonpuoi lavorare? Mi dispiace, chiamoun’altra persona.
Per gli scorsi numeri di Near abbia-mo intervistato Wu Ming 2 coauto-re del libro Timira e Daniele Vicariper il documentario La nave dolce:entrambi ponevano il problema del-la difficoltà da italiani di affrontarestorie non del tutto proprie…Io non vedo l’ora che in Italia succe-da quello che negli Stati Uniti succe-de abitualmente, per una storia com-pletamente differente. Come c’è tuttoun cinema che ha raccontato la co-munità italoamericana fatto da ita-loamericani come Scorsese e Coppo-la, o come il cinema tedesco che è tur-co, arriverà il momento in cui i com-pagni di scuola di mio figlio avrannoventi anni e cominceranno loro a
51
LA MIA CLASSE [2013 – ITA]
Regia: Daniele Gaglianone. Sceneggiatura: Gino Clemente,Claudia Russo, DanieleGaglianone. Direttore della fotografia:Gherardo Gossi. Scenografia: Laura Boni. Costumi: Irene Amantini. Interpreti: Valerio Mastandrea,Bassirou Ballde, MamonBhuiyan, Gregorio Cabral,Jessica Canahuire Laura, MetinCelik, Pedro Savio De Andrade,Ahmet Gohtas, BenabdallhaOufa, Shadi Ramadan, EastherSam Shujan Shahjalal, LyudmylaTemchenk, Moussa Toure, Issa Tunkara, Nazim Uddin,Mahbobeh Vatankhah, Remzi Yucel. Prodotto da Gianluca Arcopintoe Kimerafilm.

fare il cinema, e magari vorranno rac-contare della loro madre che ancoranon sa ancora bene l’italiano o cosavuol dire essere italiani o non esser-lo. Spero davvero che arrivi presto ilgiorno in cui siano i nuovi italiani araccontarci queste cose, non perchénon dobbiamo farlo noi, ma perchériusciranno a farlo in un modo che saràvero, nuovo e originale, e sarà davveroun grande passo in avanti. Forse chis-sà, se non succede niente di apocalit-tico come una guerra tra poveri, e sele cose continueranno più o meno così,anzi, sperando che migliorino, forse trauna decina di anni…
E secondo te questi tempi riguarda-no anche una sorta di normalizza-zione dei nuovi italiani? Ovveroquando non avremo più bisogno dischierarci tra i buoni e i cattivi?Quello secondo me è un processo unpo’ più lungo, che dovranno guidarequelli che stanno crescendo adesso eche trovano assolutamente normaleavere un compagno di banco che ènato in un altro paese, o che sa l’ita-liano male, o magari è del Congo e loparla meglio di lui. Banalmente, se ioavessi avuto un compagno di scuolanero africano lo avrei guardato con labocca aperta, mio figlio non se ne è ne-anche accorto, non gliene frega nien-te. Questa è la cosa migliore, ci si po-trà anche menare, ma i motivi saran-no altri, non certo il razzismo. Co-
munque penso che anche le società eu-ropee più avanzate rispetto a questacosa hanno sempre dei momenti di cri-si, come la Francia o il Regno Unito.In questo senso, nonostante si faccia unuso delle metafore calcistiche spesso ve-ramente ridicolo e grottesco, le nazionalidi calcio sono veramente indicative. Soloda un paio d’anni abbiamo in naziona-le Balotelli e El Shaarawy, due nuovi ita-liani. La Francia quando vinse i mondialiera credo al 60 per cento meticcia, la stes-sa Germania lo è, anche se pe un’im-migrazione meno clamorosa. In questosenso la Nazionale è un buon termo-metro, perché se un ragazzino arriva agiocare a pallone in seria A o in Nazio-nale, vuol dire che l’ha potuto fare. Credo che l’Italia abbia ancora un belpo’ di strada da fare. Anche perché ilpassato coloniale italiano, seppur fe-rocissimo è stato un fenomeno ridot-to rispetto ad altri, come appunto Fran-cia, Olanda e Regno Unito. È chiaro chelì esplodono contraddizioni sull’orgo-glio di essere francesi o non esserlo, inquesto senso forse l’Italia ha un pas-sato meno ingombrante, anche se, ri-
peto, ferocissimo. Forse alla fine l’in-tegrazione potrà essere anche superiorerispetto a questi altri paesi perché unalgerino ha nel DNA un senso di ran-core nei confronti della Francia, cosìcome un giamaicano di Brixton… Perun ragazzo egiziano che viene a viverein Italia in fondo non c’è nessun mo-tivo diretto per avere rancore neiconfronti del nuovo paese.
A meno che non sia un etiope che hastudiato la storia…Senz’altro, una cosa che non soppor-to è proprio italiani brava gente. D’al-tronde in questo paese c’è un rimos-so enorme che non riguarda solo ilpassato coloniale, ma in generale ri-guarda tutto il fascismo. l’Italia non sivuole dire e dirsi che ha inventato unadelle cose peggiori del ‘900. Se non cifosse stato il fascismo forse le cose sa-rebbero andate in altro modo sia inSpagna che in Germania. Sembrasempre che noi non abbiamo fattoniente e invece abbiamo delle gran-dissime responsabilità, forse siamo ilpopolo che ne ha di più.
52