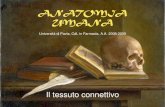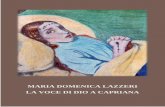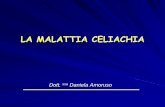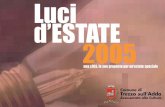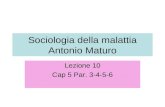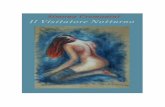Pensione: doppio Il misterioso rapporto C tra legge e verità Voce/La Voce VI-1.pdf · che il...
-
Upload
truongthuan -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Pensione: doppio Il misterioso rapporto C tra legge e verità Voce/La Voce VI-1.pdf · che il...
Periodico d’informazione culturale dell’Associazione “Gli Stelliniani” di Udine - Anno VI - Numero 1 - Luglio 2007Periodicità quadrimestrale - Spedizione in abbonamento postale - Articolo 2, comma 20/c, legge 662/96 - D.C.I. “UD”
degli Stelliniani
Pensione: doppiopunto e a capo
Per il terzo appuntamentodel progetto “Diritto e Giu-stizia”, anche quest’anno
abbinato al premio di filosofia“Sergio Sarti”, la nostra associa-zione - d’intesa con la sezione diUdine e Gorizia dell’“Unioneitaliana dei giuristi cattolici” - havoluto affrontare forse il più ar-duo dei temi possibili, per unostudioso della materia giuridica:quello del rapporto tra “Diritto eReligione”. Forse il più arduo, siè detto, ma non per questo menointeressante ed attuale, e ciò siaperché ogni legislazione devemisurarsi con una serie di princi-pi morali che la trascendono e lagiustificano, sia perché, mai co-me ora, il territorio del diritto èattraversato dal confronto tra isostenitori di una concezioneesclusivamente laica della leggee quanti invece rivendicano l’esi-stenza di una cornice di valori,che si richiamano alla comunetradizione cristiana ed interpel-lano anche la coscienza dei noncredenti. Come nelle precedentiedizioni, anche quest’anno ilprogetto “Diritto e Giustizia” sicompone di tre momenti: il con-corso dedicato alla memoria delprof. Sarti, al quale hanno parte-cipato studenti provenienti datutta la regione, impegnati nellastesura di un saggio filosofico; ilseminario di studi svoltosi il 28aprile, del quale daremo cennoin queste note, ed una rappre-sentazione teatrale, che gli stu-denti dello Stellini metteranno inscena in autunno.
Momento centrale di questa“trilogia” è stato il convegno or-ganizzato nell’aula magna delLiceo, con il contributo dellaFondazione Crup ed il patroci-nio della Provincia di Udine, alquale sono intervenuti il prof.Daniele Picierno, docente di Sto-ria e Filosofia allo Stellini, non-ché vicepresidente della nostraassociazione; il dr. Oliviero Dri-gani, presidente della Corte d’as-sise d’appello di Trieste, e l’avv.Paolo Moro, avvocato e docentedi Filosofia del diritto ed Infor-matica giuridica all’Università diPadova. Dopo le parole di ben-venuto della preside, prof.ssaGermini, ed il saluto rivolto, perconto degli “Stelliniani”, dallaprof.ssa Patti, i lavori sono statiintrodotti da una prolusione del-l’avv. Gabriele Damiani, mode-ratore del dibattito, intervenutoanche in qualità di rappresentan-te della sezione udinese dei“Giuristi cattolici”.
Ha preso quindi la parola ilprof. Picierno, che ha dibattuto il
tema Diritto e religione nel mondomoderno. Suggestiva e feconda dispunti è stata, come sempre, lasua relazione, che si è interroga-ta, fra l’altro, sul fondamento on-tologico del diritto e sulla possi-bilità di considerare la religionenon soltanto come professione difede, ma anche come “concezio-ne del mondo”, secondo la defi-nizione che ne ha dato un gran-de pensatore laico come Bene-detto Croce. L’intervento delprof. Picierno troverà, peraltro,rivisitazione più ampia in secon-da pagina, attraverso la sintesiche lo stesso relatore ci ha gentil-mente concesso.
* * *È stata quindi la volta del dr.
Drigani, che ha intrattenuto ipresenti sul tema Diritto e religio-ne: concordia e conflitto. Il relatoreha ripercorso l’evoluzione delconcetto di “uomo giusto” - chesecondo la Torah ebraica era l’os-servante della legge, mentre peril “Nuovo testamento” era l’uo-
Con il primo di settembre sarò in pensione, ben primadi avere raggiunto i limiti d’età. Qualche riflessione siimpone nel prendere commiato, non già dall’Associa-
zione, nell’ambito della quale intendo impegnarmi ancora alungo, ma dall’insegnamento.
La mia decisione non è stata certamente dettata da calco-lo economico o dal timore di un cambiamento normativo sfa-vorevole: questi criteri, peraltro razionali e corretti, possonoaver valore per altre categorie professionali, non certo per lanostra che comunque, in tal senso, ha ben poco da perdere;infatti sarebbe folle chi intraprendesse questa carriera perottenerne gratificazioni di ordine materiale! E allora, perchéandare in pensione anzitempo? Due sono le motivazioni e didiversa natura: la prima ha carattere generale, la secondainvece è strettamente personale.
Per quanto concerne la prima, mi unisco ai tantissimi do-centi che sempre più avvertono il disagio per uno status cheva perdendo velocemente il suo prestigio in una società in cuiciascuno conta in quanto ha, non in quanto è; in una socie-tà che sacrifica a miti illusori l’educazione dei giovani, privi-legiando la quantità rispetto alla qualità ed evitando agli stu-denti ogni difficoltà al motto di todos caballeros, noncurantedel fatto che ben presto gli incompetenti verranno disarciona-ti; in una società in cui chiunque si ritiene esperto e vuol dire
la propria su ogniargomento, a pro-posito e a sproposi-to; in una società incui tutti accampanodiritti senza assu-mersi alcuna re-sponsabilità: beatigli antichi che sape-vano distinguere trademocrazia e oclo-crazia! In un talecontesto è arduo perun docente mante-nere il senso dellapropria dignità e laserenità; è logoranteresistere alle pres-sioni, agli attacchi,agli insulti; è sner-vante doversi conti-nuamente rilegitti-mare. Senza tener
conto del carico di lavoro burocratico, tanto opprimente quan-to inutile, che ormai affligge il docente e gli impedisce di dedi-care il suo tempo e le sue energie all’insegnamento, che è il suovero compito.
Ma veniamo alla seconda motivazione. La mia scelta è an-che il frutto maturo di un bilancio esistenziale che già da qual-che tempo sentivo di dover fare. “Ma come” - mi dicono - “vaiin pensione? proprio tu, che a scuola un altro po’ e ti portavianche la branda?” Appunto per questo! Perchè il rischio, checorre chi come me vive la scuola in maniera totalizzante, èproprio quello di prosciugare le proprie energie. È tempo di bi-lancio, dicevo. Ebbene, la mia vita di insegnante è stata, non-ostante tutto, una meravigliosa avventura. Una vita piena disoddisfazioni professionali, di entusiasmi, e anche di allegria,di battaglie individuali e condivise, di affetti costruiti e conso-lidati nel tempo, sia con allievi che con colleghi. Una vita chele pur inevitabili delusioni, amarezze, rabbie e frustrazionihanno reso semmai ancor più densa di significato.
Certo in questi ultimi più difficili anni ho avvertito talvoltacome una nota stonata, segno inequivocabile di tempi e valo-ri mutati, di rapporti inquinati, ma bastava un solo sorrisosincero o un solo sguardo intelligente, perché il mio impegnoritrovasse pienezza di significato. Un bilancio dicevo: ebbene,tanto ho dato, molto di più ho ricevuto. Il bilancio è attivo.
E allora meglio alzarsi da tavola adesso, ancora in posses-so di risorse fisiche, mentali e psicologiche, ancora piena divitalità e di entusiasmo da spendere, piuttosto che ritrovar-mi domani stanca e ripiegata verso il passato.
Che dire di più? Qualcuno insiste ancora: “Oddio, vai giàin pensione”, quasi dicesse “scendi già nel sepolcro!” A que-sti, parafrasando il Foscolo, rispondo: “Sol chi non lasciaeredità di affetti, poca gioia ha … della pensione!”
Elettra PattiDirettore editoriale
La professoressa Elettra Patti.
Il misterioso rapportotra legge e verità
Si è svolta la terza edizione del progetto “Diritto e Giustizia”che nella legislazione comune, inparticolare nel titolo IV, libro II,del nostro codice penale, laddo-ve sono puniti i “delitti contro ilsentimento religioso e la pietàdei defunti”. Tale apparato nor-mativo è stato, a sua volta, inno-vato dalla legge n. 85 del 2006, laquale, accordando anche alle al-tre confessioni la tutela attribuitaalla religione cattolica, ha confe-rito la necessaria dignità tanto almomento soggettivo del feno-meno religioso, costituito dallaprofessione individuale di fede,quanto al momento oggettivo,rappresentato dal rilievo socialedel credo professato.
Il dr. Drigani ha quindi sottoli-neato la singolare affinità che sipuò ritrovare nel pensiero di in-tellettuali laici e cattolici, in ordi-ne al fatto che, nella società con-temporanea, il diritto sembriaver smarrito i suoi riferimentidi valore. Sul fronte laico, un giu-rista come Natalino Irti ed unoscrittore come Claudio Magrishanno infatti parlato dell’esisten-za di un “nichilismo giuridico”,che trasforma la legge in un me-ro “diritto delle procedure”, qua-si che l’unico significato dellanorma fosse quello di garantire ilrispetto di una regolarità forma-le. Sul versante teologico, unapreoccupazione di segno analo-go era stata dichiarata, in un sag-gio di alcuni anni or sono, dal-l’allora prof. Joseph Ratzinger, ilquale aveva denunciato la pre-senza di due pericoli per il dirit-to: in primo luogo, quello rap-presentato dal fatto che la leggesia intesa soltanto come espres-sione di un contingente costumesociale (“relativismo etico”); insecondo luogo, quello costituitodal fatto che assuma valore mo-rale soltanto ciò che è funzionalealla costruzione, anche violenta,di un mondo futuro (“fonda-mentalismo”). Per evitare questainvoluzione - ha concluso Driga-ni - il compito del giurista è quel-lo di recuperare la dimensionedel valore, quale fondamentoispiratore della norma, e ciò at-traverso un percorso che nonpuò non implicare, anche per unlaico, il confronto con una pro-spettiva di natura religiosa.
Andrea Purinancontinua a pagina 2
mo animato dalla fede - e ha sot-tolineato il fatto che il rapportodialettico tra religione e dirittosia iniziato proprio con il cristia-nesimo, allorché la legge di Ce-sare e quella di Dio sono stateper la prima volta collocate supiani distinti.
Esaminando la legislazionecontem poranea, il dr. Drigani haanalizzato due enunciati norma-tivi nei quali viene in rilievo ladimensione religiosa: l’art. 2 del-la dichiarazione universale deidiritti dell’uomo e l’art. 3 dellacostituzione italiana. Nel primo,è affermato il principio secondoil quale ad ogni individuo spet-tano tutti i diritti e tutte le libertàcontemplate da tale carta, senzadistinzione di credo. Nel secon-do, è proclamata l’eguaglianzadi tutti i cittadini davanti alla leg-ge, senza discriminazione permotivi religiosi.
Il riconoscimento della sferareligiosa come componente ina-lienabile della personalità uma-na è contenuto, ovviamente, an-
Personificazione della Giustizia.
LA VOCE4_07:LA VOCE 3_06 24-08-2007 9:48 Pagina 1
continua dalla prima pagina
Il testimone è quindi toccato all’avv. Paolo Moro, che ha affrontatol’argomento relativo alla Ricerca della verità del processo. L’avv. Mo-
ro ha esordito osservando come, nella civiltà greca, il diritto si con-figurasse essenzialmente quale evento processuale ed ha rilevato co-me, ai nostri giorni, è proprio nel processo - inteso come luogo di pa-cificazione e di giustizia - che si pone il problema della verità. A que-sto riguardo, il relatore si è soffermato su due concezioni antitetichedella verità processuale, che corrispondono ad altrettante scuole dipensiero: per la prima di tali teorie (del cosiddetto dogmatismo giuri-dico), la verità non soltanto esiste, ma è anche sempre conoscibile dalgiudice. Al contrario, per la seconda di tali teorie (del cosiddettoscetticismo giuridico), la verità non è conoscibile e tantomeno lo è nelprocesso.
L’avv. Moro ha affermato che entrambe queste posizioni sono cri-ticabili per il loro estremismo: l’una perché assume che la verità siasempre conoscibile nel processo, l’altra perché esclude radicalmentela possibilità di raggiungerla. Rifacendosi al pensiero aristotelico esottolineando il significato ambivalente della parola greca a-létheia(con alfa privativo preposto al verbo lanzàno, che rimanda tanto al-l’idea di “rivelazione” quanto a quella di “non-nascondimento”, co-me se la verità fosse una conquista mai definitiva), il relatore ha so-stenuto che tali opposte concezioni possono venire superate ammet-tendo che una verità esista, all’interno del processo, ma che non siadi immediata percezione e debba quindi costituire l’oggetto di un’i-nesauribile ricerca. Il metodo per attingere questa verità è il con-fronto dialettico tra le parti del giudizio, che realizza quello che imoderni chiamano “principio del contraddittorio” e che rappresen-ta uno dei postulati fondamentali della nostra legislazione. La veri-tà nel processo è dunque raggiungibile, a condizione che ciascunodei suoi attori (parti e giudice) possa interloquire con l’altro: la strut-tura dialogica costituisce quindi il necessario paradigma di un pro-cesso giusto. In tal modo, ci si accorge che il fine del processo è il me-desimo della filosofia, poiché entrambi si propongono lo svelamen-to di una verità nascosta, di cui si avverte l’esistenza e, al contempo,la difficoltà di possederla.
Da questo concetto di “verità processuale” l’avv. Moro ha tratto,infine, lo spunto per alludere ad un concetto trascendente di Verità,che ha caratterizzato l’evento giudiziario più importante della civil-tà occidentale: il processo a Gesù. Come si legge nel Vangelo di Gio-vanni, Cristo, giunto al cospetto di Pilato, si difende dicendo: Sonovenuto a rendere testimonianza della verità e Pilato, sconcertato, glichiede: Che verità è questa? Che cos’è la verità? A questa grave do-manda, Cristo non dà una risposta, anche se quel silenzio era piùeloquente di ogni parola. L’idea classica di verità - giuntaci dal pen-siero greco e dalla tradizione ebraico-cristiana - ed il concetto dellaverità nel processo rivelano, così, la loro straordinaria assonanza. Inun caso come nell’altro, la verità esiste, per quanto misteriosa, ed il
2
Diritto e Religione Religione” è una parola
comprensibile in modoproporzionale alla sua
vaghezza semantica, come suc-cede per i termini che indicano ifenomeni culturali essenziali, le“onde lunghe della storia” dicui parlava Broudel. AncheCroce considerava la religionecome la stessa cultura nel suofarsi storico, tanto che ancoraoggi il vero incontro tra popolicrea un “Pantheon” e le guerresembrano scontri di civiltà, co-me dice Hutghinton, in quantosono vere guerre di religione.
I moderni dissimulano il fat-to che le descrizioni sono sem-pre prescrittive, come ci ricordaFoucault, perché esse sonosempre prospettiche e celano al-l’interno della loro neutralitàun’ansia religiosa. Infatti giàTolstoj faceva dialogare nellasua prospettiva letteraria due te-sti concisi, il Vangelo e le operedi Voltaire, e così la sua descri-zione del mondo era in realtàuna traduzione del reale sullabase delle sue idee morali.
Che ci siano diversi giudizimorali nella storia non ci deveimpedire di esprimere anche co-me storici le nostre convinzionietiche e religiose. Infatti le mol-te opinioni morali non riduconola storia a relativismi individua-li, perché esse sono NELLASTORIA e questa è più di essi,non meno di essi: è infatti l’o-rizzonte di Senso che a ogni co-sa dona un senso. Perciò in Re-ligiositàCroce diceva che senzareligione, cioè senza eroismo ecoscienza dell’universale, nonc’è storia. Perciò tra tutte le
scienze il diritto è la più religio-sa perché attiene a colpa e inno-cenza, vita e morte, bene e ma-le dell’uomo e della sua storia.
Gli stessi greci con acumedistinguevano nel diritto il giu-sto per natura dal giusto per leg-ge, credendo nell’esistenza diuna legge naturale. Per i romaniil giusto divenne il diritto o iuse così nacquero il diritto natura-le e la norma positiva che lo im-pone. Da allora, fino ai modernicome Kelsen, il diritto è diven-tato forma e norma che esiste inquanto sanzione; anche Smith,che concorda con Kelsen, ridu-ce i diritti soggettivi e naturalialle norme oggettive che costi-tuiscono ordinamenti decisi dalpotere.
Diversa l’idea di San Tom-maso, per il quale il diritto nonè altro che la stessa cosa giusta:
e cosi lo ius dei romani diventaipsa res iusta o legge naturale,che fonda il legame oggettivotra i membri della società. Nederiva che ogni persona è dirit-to reale, unusquisque est sibi ip-se ius, ciascuno è diritto a sestesso. Perciò appare comica lapretesa dei giuristi moderni dicriticare tali idee e poi di inven-tarsi nomi diversi per dire il giàdetto. Così Rodotà parla di indi-vidualismo giusnaturalista, giu-daico-cristiano e s’inventa ungiusnaturalismo sociale che, an-dando oltre lo statalismo illumi-nista della dea “Ragione”, devefondarsi sulla natura umana esulla legge naturale. Prima con-testa San Tommaso e poi ne ri-pete i concetti essenziali combi-nando male l’idea di naturaumana, che è religiosa comepersona, con quella di giusnatu-
Il tavolo dei relatori. Da sinistra a destra: l’avv. Gabriele Damiani, il prof. Danie-
le Picierno, il D. S. prof. Anna Maria Germini e il giudice dott. Oliviero Drigani.
Da sinistra a destra: le docenti Elettra Patti e Maria Mittiga con la signora Ales-sandra Sarti attorniata dagli allievi premiati Valeria Gholizadeh, Paolo Brusa,Antino Buttazzoni e Sophia Nussio.
ralismo sociale, che è volontari-smo laico.
Ancora peggio fa FloresD’Arcais quando contesta l’i-dea di diritto naturale di SanTommaso come ipsa res iusta,perché per lui l’idea di giustiziaè relativa così come quella didiritto naturale. Conclude quin-di che la scimmia “che tutti noisiamo”, parafrasando Darwin,necessita di una qualsiasi normaperché la società funzioni. Sia-mo dunque di nuovo al dirittooggettivo di Kelsen che è nor-ma formale, la quale “funziona”spesso - sosteniamo noi - “con-tro” l’individuo, come è succes-so nei totalitarismi di destra e disinistra, ma anche nella tecno-crazia moderna che accoppia li-berismo ed edonismo.
In verità la religione non èteocrazia, ma viene da re-lego,da leghein e logos su cui nascela comunità. Essa postula l’uo-mo come finitezza, cioè creatu-ra (da creazione); è storicitàesistenziale, fragile e perciò do-tata di diritti. Possono mutare idiritti naturali, non la legge na-turale che fonda la coesistenzia-lità ontologica degli uomini. Imoderni invece confondono lalegge naturale con il diritto na-turale e, pur credendo in valoriindisponibili e non negoziabili eperciò universali, li basano sulcaso, sull’evoluzione e quindisull’arbitrio. Ma, in tale caso,dov’è il fondamento dell’idea diprogresso che è atto creativodell’uomo e perciò postula ilconcetto di creazione?
Daniele Picierno
I PROGETTI DEGLI STELLINIANI
Legge e verità
destino dell’uomo, come pure il fine ultimo della sua libertà, consi-stono appunto nel doverla cercare.
* * *
Il seminario si è quindi concluso con la consegna, da parte dellasig.ra Alessandra Sarti, dei riconoscimenti per il concorso dedicatoalla memoria del marito, il professor Sergio Sarti, che fu docente ap-prezzato nel nostro Liceo e nelle Università di Trieste e di Udine, oc-cupando un posto di rilievo nel panorama della cultura friulanacontemporanea con i suoi apporti di diverso, ampio respiro.
Il primo premio per la sezione esterni è stato attribuito a PaoloBrusa del Liceo “Dante Alighieri” di Gorizia, mentre il secondo è an-dato ad Antino Buttazzoni del “Marinelli” di Udine. Il concorso in-terno degli stelliniani ha visto, invece, classificarsi al primo postoValeria Gholizadeh e al secondo Sophia Nussio, entrambe allievedella Terza A.
Andrea Purinan
Hoc habeo, quodcumque dedi(Seneca, De beneficiis, VI, 3)
La raccolta di fondi, promossa dalla nostra associazione pres-so il Liceo “J. Stellini” a sostegno del “Raffaella Piva Fund”, ha ot-tenuto anche quest’anno un esito straordinario: abbiamo realiz-zato la cospicua somma di € 1.500,00. Potremo pertanto provve-dere anche per il 2007 al mantenimento dei cinque ragazzi di Bat-ticaloa già “adottati” l’anno scorso. Si ringraziano di cuore quan-ti, tra gli studenti, i docenti, e il personale ATA, con la loro gene-rosità hanno permesso questo atto di profonda “humanitas”. Unamenzione onorevole va in particolare alle generosissime classi IVA, V D e II E.
Per un aggiornamento sull’operato del RAFFAELLA PIVAFUND, pubblichiamo qui di seguito l’ultima lettera del presiden-te, dott. Alessandro Pasetti Medin.
IL NOTIZIARIO
Cari amici, i primi due anni di vita dell’Associazione ciconsentono un bilancio dell’attività svolta.
Il 27 febbraio scorso è stata inaugurata a Walasgala pressoTangalle (Sri Lanka), con una suggestiva cerimonia, la Navajee-vana RAFFAELLA PIVA FUND SCHOOL, dedicata ai bambinidisabili dai 2 ai 14 anni. Per gli ex allievi, ora inseriti in scuole re-golari, sono previsti corsi di sostegno pomeridiani, mentre la se-ra si terranno riunioni per i disabili adulti della zona. Il nostropartner locale, La Ong Navajeevana (= Nuova vita), attivo davent’anni nel sostegno ai disabili nella provincia meridionale delpaese, ci dà garanzia di una corretta gestione dell’edificio e di unefficace radicamento nel territorio. La costruzione è stata realiz-zata con il coinvolgimento della comunità, acquistando diretta-mente i materiali per contenere i costi ed evitare le speculazioniseguite alla catastrofe dello tsunami. Il finanziamento della Pro-vincia di Udine, esauritosi prima della fine dei lavori, è stato in-tegrato dai contributi che non ci avete mai fatto mancare. Per ul-teriori info su Navajeevana e le sue attività, cfr. il sito www.eure-ka.lk/navajeevana.
Il nostro Father Paul Satkunanayagam, missionario gesuita epsicologo, ha affrontato un lungo viaggio per incontrarci a Colom-bo, evitandoci così i pericoli di un sopralluogo a Batticaloa, doveera appena stato ferito l’ambasciatore italiano. Con la sobrietà e laforza che gli conosciamo, ci ha spiegato come si viva in guerra: po-sti di blocco e soldati ovunque, prezzi di viveri e carburanti allestelle, 100.000 profughi in condizioni difficilissime (tendopoli,mancanza di scuole per i bambini) e continui, mortali incidenti.Egli continua il suo impegno con circa 150 bambini e bambine, ra-gazzi e ragazze, traumatizzati dalla guerra e dal maremoto, allog-giati in sei case protette: le spese di 90 di essi sono coperte grazie alvostro sostegno, che garantisce la continuità dell’intervento con leadozioni a distanza. Nei mesi scorsi la Regione Trentino Alto Adi-ge si è accollata la spesa della costruzione di tre pozzi in case chene erano prive e, grazie all’aiuto del Comune di Padova, abbiamopotuto acquistare materiali e attrezzature specialmente per i corsiprofessionali rivolti agli ex bambini soldato privi di curriculumscolastico e ospitati in una struttura sicura.
Attuale obiettivo è la costruzione di una nuova casa protettaper ragazze, all’interno di un lotto già di proprietà del centro diFather Paul: grazie ai fondi privati da noi raccolti, i lavori sonogià in corso. Per ulteriori info sull’attività del Psychological Co-unseling Center, cfr. il sito www.ppccbat.org.
Infine il RAFFAELLA PIVA FUND, socio del Consorzio Eti-mos (Banca Etica), attivo nella microfinanza in Sri Lanka (su in-vito della Protezione Civile) e da poco in Cambogia, ha recente-mente contribuito all’avvio di un progetto di microcredito inquest’ultimo paese. Quasi trent’anni di guerra, un elevatissimonumero di mutilati a causa delle mine antiuomo diffuse in granparte del territorio, tassi record di AIDS e prostituzione ne fannoil paese più povero del Sud Est asiatico, con grandi difficoltà nelreperimento di capitali. Gran parte della popolazione è compostada agricoltori e non ha accesso al credito, se non privatamente acondizioni di usura. In un recente sopralluogo, abbiamo potutotoccare con mano la situazione e visitare potenziali beneficiari nelcircondario di Battambang, seconda città del paese.
Ogni somma versata al RAFFAELLA PIVA FUND (cc po-stale 62240064 - ABI 07601 CAB 01800) dà diritto ai benefici fi-scali: conservate pertanto le ricevute! Aiutateci a far sapere chesi può sostenere senza alcun onere l’associazione con il 5 x 1000,basta riportare il codice fiscale 96069530226 nell’apposita casel-la della dichiarazione dei redditi. Nel sottolineare che siamograti del sostegno fornitoci in questi due anni di attività, ricor-diamo ancora a chi dispone di indirizzo e-mail, che comunican-docelo ([email protected]) ci aiuterà a snellire il lavoro e acontenere le spese, a favore delle attività in Sri Lanka e nel Sud-Est asiatico.
Alessandro Pasetti Medin
Donandocon Raffaella“
LA VOCE4_07:LA VOCE 3_06 24-08-2007 9:48 Pagina 2
3
Ad hanc (arborem) excu-tiendam atque asportan-dam nequissimi adule-
scentuli perreximus nocte intem-pesta, quousque ludum de pesti-lentiae more in areis produxera-mus, et abstulimus inde oneraingentia… (Confessiones, II,9).…Noaltris, malcreade mula-rie, o sin lâts a dute gnot, cheo vevin passât tirant in denanta fâ mateç par lis stradis se-cont un mût di fâ vergognôs,a tirâiu jú sgurlant il arbul e apuartâiu via, e di lá o vin freâtun grum di pomis.
Mandi! Come introdurreil racconto di questa mia re-cente esperienza nel concor-so di traduzione dal latino alfriulano se non con questosaluto che deriva diretta-mente, se è corretta tale eti-
mologia, dall’augurio manediu, mantieniti a lungo, cioè“lunga vita”? La difficoltàche mi sembrava più grandequando decisi di partecipareera quella di trasformare illatino in friulano, senza pas-sare, come chiedeva il rego-lamento, attraverso l’italia-no, ma nel rendere le paroledi S. Agostino mi resi invececonto di come mi riuscisseaddirittura più facile il pas-saggio diretto al friulano.Questo sicuramente dipen-de dal fatto che anche la miamarilenghe deriva immedia-tamente dal latino, sebbeneoggi presenti molti terminitratti dall’italiano.
Il testo raccontava unascena in qualche modo quo-tidiana (il furto delle pere), equindi non si è rivelata diffi-cile la ricerca di un lessico
appropriato, perché il friula-no è una lingua parlata so-prattutto nella quotidianità.Mi pare quindi azzeccata la
scelta di questo brano per-ché i tentativi di adoperarela nostra lingua per ambitiche non sono proprio quelli
Paularo - Fraie de Vierte. Tommaso Pascolini tra i proff. Gabriele Ragogna e Ste-
fano Perini, responsabili del progetto “Traduzion leterarie da lis lenghis classi-
chis al furlan”.
della terra, del lavoro e dellavita famigliare, come si tentadi fare oggi con pubblicazio-ni scientifiche o tecnologi-che, sono forse un’eccessivaforzatura.
Proprio dal fatto che ado-pero il friulano solo comemezzo di comunicazionenella mia realtà di ogni gior-no è scaturito l’aspetto piùdivertente di questa impre-sa: quello di una traduzioneche mi suonava all’inizioquasi come una parodia deltesto latino, ricca di interca-lari tipici, non molto lettera-ri, e di parole un po’ troppo“colloquiali” che con un belpo’ di olio di gomito (il pro-verbiale labor limae) sonostate sostituite da un furlanplui leterari. Inoltre, sfogliarei vocabolari di friulano perscrivere nella “normalizade”,
cioè nella koinè, dal momen-to che il mio friulano è di de-rivazione mista (furlan di Ci-vidât, furlan di Faedis, furlandi Remanzâs) e quindi nonha una connotazione di luo-go specifica, come chiedevail regolamento, mi ha fattoconoscere termini ed espres-sioni nuove che mi hannomostrato la ricchezza di que-sta lingua.
In conclusione, l’espe-rienza culminata con la Fraiede Vierte a Paularo, dove sisono svolte le premiazioni,ha rappresentato per meun’occasione arricchente emi auguro che chist concorsal sedi fat di gnûf l’an ch’alven cun tune partecipazionplui grande di arlêfs.
Tommaso Pascolini
Cominciò a scendere su di noi, dando vita a una miriade di cristalliliquidi sui nostri capelli, impalpabile dapprima, poi sempre più
fitta e pesante…R. Burning, Inverno nelle Highlands, Liffey & Sons, Dublino, 1947.
“Non ha età. Secondo me non ha età. Ti può cogliere a dieci co-me a settant’anni.”
La voce di Nino, pur pacata, aveva un che di perentorio.“Ma dai! Posso capire che ti capiti a cinquanta, anche a settan-
t’anni, se vuoi, ma a dieci! Nino, dai! Non ti pare di esagerare?”Sergio cercò di dare alla conversazione un tono più leggero.
“Niente affatto! Credo che l’amore non distingua. Con l’età po-trà variare l’intensità dei sentimenti, ma la sostanza, quella, nonmuta. Sempre di amore si tratta.”
Il tono di Nino non era cambiato. Sembrava esprimere delle cer-tezze.
“No – incalzò Sergio – non posso credere che anche un bambi-no possa innamorarsi.”
“Come fai a esserne così sicuro? – intervenne Toni guardandoNino dritto negli occhi. – Su cosa poggia la tua sicurezza?”
Nino non rispose e distolse lo sguardo. Prese a fissare le fiammeche guizzavano, vivide, nel caminetto. Restò così a lungo. Gli ami-ci tacevano. La grossa pendola alla parete scandiva il trascorreredel tempo con battiti secchi. Lo sguardo di Nino sembrava vaga-re lontano. Poi prese a parlare lentamente, con un tono di vocebasso, profondo, come di chi sembri essere in pace con se stesso econ il mondo.
“Vi va di ascoltare una storia?...”Gli amici annuirono. Conoscevano Nino da anni e sapevano che
gli era sempre piaciuto raccontare, raccontarsi. Era accaduto altrevolte, accanto al caminetto, complice l’atmosfera accogliente diquella casa. Gabriella attizzò il fuoco da cui si sprigionarono mil-le faville leggere, subito inghiottite avidamente dall’ oscurità del-la cappa. Poi, silenziosa, versò ancora del vino nei bicchieri degliamici.
“Ricordo come fosse ora quel cielo colmo di uno strato ovattatodi nuvole. Un cielo da neve. Carico di attesa – come il mio animomolti anni fa – e che riversò per giorni sulla città tanti fiocchi sof-fici e bianchissimi. In breve i prati circostanti la mia casa ne furo-no ricoperti. Nevicò a lungo. Sembrava non voler smettere mai.Lo spazzaneve, lento ma sicuro, si apriva un varco nella coltre or-mai alta: due grosse travi disposte a triangolo, rinforzate sui latida una robusta lamiera e il cavallo davanti, paziente, l’aria cheuscendo dalle froge si condensava in sbuffi biancastri di vapore.Quell’anno – era carnevale – noi ragazzi riuscimmo a costruirecon la neve, pressandola energicamente, dei fortini dalle paretispesse e alte dietro alle quali ripararci dai tiri delle palle dei nostriavversari, pronti peraltro a rispondere alle loro bordate.
Giovedì grasso: un gruppo nutrito di noi – c’erano anche delleragazze – decise di raggiungere il cinema a due passi dal GiardinGrande. Che film proiettassero non lo ricordo. E’ ben netto perònella mente il percorso da casa mia – la “Casa dei susini”, comeamava chiamarla mio padre – fin là; e ricordo Marta. Era un po’più alta di me benché avessimo la stessa età. L’avevo conosciuta adottrina e frequentata un poco perché mia sorella la stava prepa-
io ci eravamo tenuti d’occhio discretamente – che lei, avvicinata-si, fissandomi intensamente negli occhi, mi indirizzò una frase cherimase a lungo nel mio animo – Nino sospirò profondamente –anzi, c’è ancora. A distanza di tanti anni, sembrerebbero paroledette più da un adulto che da una ragazza: “Oh! Nino… quantoabbiamo atteso questa neve!” Non so cosa risposi. Compresi peròche Marta, non tanto per il significato della frase in sé, quanto peril modo in cui la pronunciò, con un intenso, profondo sospiro,aveva trovato il modo per gettare un ponte tra noi. Eravamo peròtroppo intenti a perderci in quel vasto biancore per saper sostare.Anche se ragazzi tuttavia, sapevamo cogliere almeno l’intensità dicerte parole, sguardi, di certe emozioni lievi eppure conturbanti.Che quella frase, rivisitata a distanza di anni, costituisse una di-chiarazione d’amore delicata, appena sussurrata, di questo sonosicuro. Credo che anche lei lo sarà stata. Entrati al cinema, il buioci separò.
Crescendo, incrociatici altre volte, sentivamo un’attrazione reci-proca pur se nessuno dei due, anche più avanti negli anni, lo dissemai all’altro. Poi ci perdemmo di vista. Per quanto non abitassimolontani l’uno dall’altra, gravitavamo in zone diverse della città.
* * *
Mi capitava di tanto in tanto di scorgere le gambe lunghe, affu-solate di Marta pigiare forte sui pedali lungo le strade circostanti la”Casa dei susini”. Pedalava con energia, il sorriso dolce sempresulle labbra. Quelle pedalate non durarono a lungo. Marta avevapoco più di diciott’anni quando il Signore stese la mano – a lei co-sì buona – per chiamarla a sé . “Mal di cuore” dissero allora. Presoda altre cose, luoghi, interessi, eventi, non lo seppi subito. Quandola notizia mi giunse, ne fui costernato, addolorato, incredulo, an-che perché per la prima volta realizzavo compiutamente che il Si-gnore poteva chiamare a sé anche le persone giovani, non soloquelle in età, come fino ad allora avevo ingenuamente creduto.
Allora avrei voluto dire, chiedere qualcosa a qualcuno. A chi?Nessuno mi avrebbe capito, argomentavo, se avessi raccontatoquella che andavo rivisitando come una favola bella, piena di lu-ce solo accennata, ma densa di un’indefinibile attesa; le immagini,nitide nella memoria, costellate da una moltitudine di fiocchibianchi. Nessuno mi avrebbe creduto, se avessi raccontato che al-lora la voce dolce di Marta mi aveva aperto le porte dell’animo.Con una semplice frase. Con quello sguardo. Con le cose non det-te. Non più dette.
Dovunque sia – Marta sarà in alto, molto in alto – sono certo checonserverà il ricordo di quel febbraio in cui nevicò tanto, e di quelragazzo che era troppo timido per poterle dire quello che una vo-ce, da dentro, lo spingeva a dire. Credo tuttavia che ella colse la ri-sposta nello sguardo del suo interlocutore silenzioso e la conser-vò, cosa preziosa, fino a quell’ultimo precoce viaggio. E più in là.”
Nino tacque. Il fuoco s’era trasformato in una soffice coltre bian-castra da cui occhieggiavano le braci. Il silenzio era rotto soltantodal ticchettio, monotono ma a suo modo rassicurante, della gros-sa pendola alla parete.
Lucio Costantini
LA SCRITTURA DEGLI STELLINIANI
Eccoci a un nuovo appuntamento con Lucio Costantini il quale, com’ è noto, alterna ai molteplici impegni professionali l’attività di scrittore. Gli Stelliniani ricorderanno la piacevole serata
trascorsa in sua compagnia in occasione della presentazione del suo Mercante di piume.
L’attesa
Sant Austin al robe di gust i piruçMentre il Papa visita a Pavia le reliquie del santo, i nostri ragazzi raccontano in friulano una sua monelleria
I PROGETTI DEGLI STELLINIANI
Piazza I Maggio innevata.
rando all’esame di ammissione alla prima media. Marta prendevalezioni nel soggiorno di casa mia. Se questo fosse accaduto primao dopo quel giorno di carnevale non lo so. Il parroco, quando cirecavamo a dottrina, additava spesso Marta come una ragazza di-ligente, molto buona, generosa e capace di realizzare un gran nu-mero di “fioretti”. La guardavamo con rispetto e considerazione.
Marta mi piaceva. Mi piacevano le sue gote sempre colorite, isuoi occhi carichi di una luce intensa, la sua vivacità educata, il co-lore dei capelli, corti, d’un biondo rossastro. Come le due sorellemaggiori di lei e che cantavano nel coro della parrocchia, avevauna voce splendida. Allora non potevo sapere – lo realizzai moltotardi – che dietro quelle gote colorite si nascondeva un mago cat-tivo.
Eravamo poco più che bambini, eppure quando la guardavosentivo muoversi qualcosa di indefinito dentro di me, una sensa-zione che non sapevo comprendere, decifrare, ma che mi spinge-va a cercarla senza che riuscissi poi a trovare la forza per vincerela mia profonda timidezza e rivolgerle la parola. Intuivo vaga-mente in quei primi innocenti turbamenti dell’animo che non leero indifferente, ma lei, timida quanto me, non fece mai un gestoche potesse contribuire a spezzare il diaframma tra noi.
Quel pomeriggio però fu diverso. La strada che percorremmoper raggiungere il cinema era stata sì ripulita sul piano viario, manon ai bordi, allora del tutto privi di marciapiede rialzato, sempli-cemente marcato ai due lati della strada da un lungo, regolare cor-done di lastre di pietra piasentina che delimitava il selciato di ciot-toli bianchi e grigiastri. La neve dove posavamo i piedi era anco-ra alta, soffice e il nostro procedere lento e goffo, con gli inevita-bili scivoloni, le cadute accompagnate dalle risate dei compagni,le soste per tirarci palle di neve; le mani, abbandonati i guanti,viola dal gelo.
Fu nell’ingresso del vasto cortile antistante il cinema – Marta e
LA VOCE4_07:LA VOCE 3_06 24-08-2007 9:48 Pagina 3
4
Durante la cerimonia di premiazione, svoltasi lo scorso 5maggio nell’Aula Magna del Liceo a conclusione dellasesta edizione del Progetto Theatron, il D. S. prof. Anna
Maria Germini, ha annunciato con compiacimento che que-st’anno il prestigioso trofeo nazionale rimane allo “Stellini”. Alsecondo posto si è piazzato Francesco Bernasconi del “Petrarca”di Trieste, mentre il terzo premio è andato ad Antea Paviotti an-cora del nostro liceo.
Subito dopo la consegna dei premi i docenti Elena Fabbro eFabio Vendruscolo dell’ateneo udinese, che assieme ai professo-ri di lettere classiche Anna Maria Masutti e Gabriele Ragognacompongono la commissione giudicatrice, hanno arricchito l’in-contro con due interessanti e dotti interventi, a commento lette-rario e linguistico del passo della “Medea” di Euripide su cui sisono cimentati quest’anno i giovani grecisti.
La splendida performance dei nostri ragazzi impreziosisce conl’oro il medagliere dello “Stellini” e porta a cinque i bronzi giàottenuti nelle passate edizioni grazie a Marianna Chiozzotto(2001/2002), Martina Pressacco (2002/2003), Elisa Miniussi eSara Deotti (2004/2005).
Lo “Stellini” conquista l’oro Andrea Bandiziol al primo posto nel concorso Praemium Euripideum
I PROGETTI DELLO STELLINI
Ha avuto felice esito an-che quest’anno il labo-ratorio teatrale in rete,
la collaborazione dei licei“Stellini” e “Percoto” iniziatanel 1999 per volontà del prof.Gianni Cianchi, allora docen-te del liceo “Copernico” cheper vari anni ne ha condivisola storia.
Gli studenti, dopo un labo-ratorio pratico comune effet-tuato nei mesi di novembre edicembre, al rientro dalle va-canze natalizie si sono divisiin due gruppi, impegnandosinella preparazione di due di-stinti allestimenti, uno deiquali attinge per tacito accor-do al patrimonio classico anti-co. Questa prassi è in atto dal-l’anno scolastico 2000/2001,quando fu varato allo “Stelli-ni” il Praemium Euripideum,cui lo spettacolo del palio siaggancia su indicazione delProgetto Theatron, ideato dal-la prof. Elettra Patti anche perstimolare i giovani alla letturadel teatro classico alla ricercadei miti fondanti del pensieromoderno e alla riscoperta deivalori sui quali si basa la no-stra civiltà.
La docente, che per diecianni fu coordinatrice dell’at-tività teatrale dello “Stellini”,oltre a promuovervi corsi distoria del teatro e a ispirare ilProgetto Studenti a Teatro, siprodigò nell’organizzazionedi una Rassegna StudentescaEuropea di Teatro ClassicoAntico. Questa iniziativa, pe-rò, nonostante il notevolesuccesso della tragedia Bac-canti, con cui partecipò lo“Stellini” e che venne defini-ta “un evento” dal critico tea-trale Angela Felice, responsa-bile del palio “Città di Udi-ne”, non ebbe purtroppo unseguito. Da quell’anno, co-munque, il nostro Liceo haprodotto sempre lavori clas-sici, che sono stati talvolta re-plicati, sempre promotrice laprof. Patti, nel teatro greco diPalazzolo Acreide (SR), dovel’INDA (Istituto Nazionaledel Dramma Antico) organiz-za da una ventina d’anni ilFestival Internazionale diTeatro Classico dei Giovani.
* * *
Qualche nota sulla piecescelta quest’anno dal gruppodello “Stellini” e diretta daiproff. Monica Delfabro e Fran-co Romanelli.
Il contesto storico - La Pace,scritta nel 421 durante la Guer-ra del Peloponneso, è la prima
commedia di Aristofane in cui l’assurdo diventa il vero protago-nista della trama, quasi a significare come la ragione spesso nonsia in grado di far fronte alla follia degli esseri umani.
La commedia, scritta subito dopo la morte del guerrafon-daio Cleone, evoca l’euforia dei cittadini finalmente speranzo-si nella pace, che venne effettivamente conclusa tra Atene eSparta pochi giorni dopo la rappresentazione nelle GrandiDionisie. Il sollievo e l’esultanza generale erano tali che aldrammaturgo, sebbene il suo intuito politico lo portasse a dif-fidare del governo, sfuggì che si sarebbe trattato soltanto diuna tregua fugace.
La trama - Il contadino Trigeo alleva con focacce di sterco unenorme scarabeo affinché lo trasporti a volo sull’Olimpo. L’o-biettivo che si propone è ottenere da Zeus la pace per i Greci.Ma, una volta giuntovi, l’ardimentoso contadino trova solo Er-mes, perché gli altri dei, indignati per la furia bellica degli uo-mini, se ne sono andati altrove. Padrone del campo è rimasto
Riportiamo, qui di seguito, le impressioni di Fabio Soccorsi, stu-dente stelliniano quest’anno alla sua prima esperienza nel palio.
Eccoci qua, siamo sul palco, anzi dietro le quinte dell’Audi-torium “A. Zanon”. Il sipario è ancora chiuso e la tensione pri-ma dello spettacolo ci fa sperare che rimanga così il più a lun-go possibile. Dalla sala provengono ovattate le voci del pub-blico che attende di vederci e, ad un tratto, il tecnico ci avvisache si sta per iniziare. Piano piano cala un terribile silenzio in-terrotto solo dai battiti, sempre più frequenti, del mio cuore e,mentre i primi attori entrano in scena e ripetono quelle battu-te che ormai anch’ io so a memoria, tante sono le volte che leho sentite ripetere, davanti agli occhi mi passa in un lampoogni singolo momento dei mesi passati a preparare lo spetta-colo, quando questa serata sembrava tanto lontana.
Tutto era cominciato con una circolare in classe, una delletante che interrompono continuamente le lezioni: comunicava
Polemos, personificazione della guerra. L’orrendo mostro, mu-rata in una grotta la Pace, vuole pestare nel suo mortaio le cit-tà greche, ma gli mancano i pestelli, essendo morti Cleone e ilsuo avversario Bràsida. Mentre Polemos si assenta per co-struirne uno lui stesso, Trigeo con l’aiuto del coro di contadinilibera la Pace e, insieme a lei, Opòra (l’Abbondanza) e Teoria(la Festa). In compagnia di queste bellissime fanciulle egli ri-torna tra gli uomini dove, vinta l’opposizione di quanti aveva-no profitto dallo stato di guerra, celebra il suo successo spo-sando Opòra.
Ambra Accordi
Il D.S. prof. Anna Maria Germini.Andrea Bandiziol, ritratto tra i suoi due professori di greco (Paolo Angiola al ginna-sio e Monica De Nardi al liceo), mostra con orgoglio l’attestato appena ricevuto.
Il teatro di Dioniso ad Atene. Il teatro di Delfi.
Il teatro di Epidauro. Foto di gruppo, le Terze A/B/C ad Epidauro.
finalmente le prove e con es-se le risate suscitate dai nostrimaldestri tentativi di recitarein modo convincente e disin-volto, ma anche da quell’at-mosfera goliardica che si creasubito tra i ragazzi del labora-torio: infatti è grande il piace-re di svolgere tutti assiemeun’attività scolastica che, purrichiedendo impegno e disci-plina, permette però di esserepiù liberi e meno sottopostiallo stress di quanto non com-porti seguire le lezioni curri-culari.
L’impresa di immedesi-marci negli incredibili perso-naggi creati dalla fantasiasfrenata di Aristofane per lasua commedia La Pace è risul-tata, specialmente all’inizio,veramente ardua, per nonparlare della fatica sostenutaper imparare a memoria lebattute! Con il tempo abbia-mo superato impaccio, paurae timidezza. Un’altra difficol-tà è stata reperire il materialedi scena, le attrezzature ne-cessarie e dei costumi credi-bili: dato il non molto floridobudget ci siamo dovuti ar-rangiare, saccheggiando ri-postigli e soffitte per rinveni-re, tra gli oggetti in disuso e ivestiti dismessi, qualcosa dacombinare insieme nei piùsvariati modi.
Via via che ci avvicinava-mo al “momento della veri-tà”, gli incontri si facevanosempre più frequenti e mag-giore l’impegno richiesto, im-pegno che, a parte qualcheassenza alle prove, a cui se-guiva immancabilmente unabella tirata di orecchie daparte dei nostri coordinatori,i proff. Delfabro e Romanelli,il gruppo ha espresso sottoforma prima di voglia di faree di apprendere, poi di com-petenza.
Ed ora, dopo quattro mesidi attesa e di preparazione,eccocì finalmente qui a dare ilnostro contributo alla mille-naria arte del teatro… ma iltempo concessomi dalla pri-ma scena è terminato: riaprogli occhi e mi preparo a farela mia entrata: io, Trigeo, ilpaladino della Pace…
Fabio Soccorsi
Le foto sono state scattate du-rante il viaggio di istruzione inGrecia, che gli allievi dello“Stellini” effettuano, per tradi-zione, l’ultimo anno del liceo.
che anche quest’anno si erano resi disponibili due professoriper seguirci nell’attività teatrale in vista della partecipazione alprestigioso Palio Teatrale Studentesco “Città di Udine”.
Sebbene questo del palio non sia un progetto molto pubbli-cizzato dalle alte sfere, per gli studenti è un’occasione moltoimportante per confrontarsi e mettersi alla prova in un’arte an-tichissima come quella del teatro.
Dopo il laboratorio pratico, grazie al quale avevamo impa-rato a interagire tra di noi, a muoverci in modo consapevolenello spazio e a gestire voce e corpo, a gennaio cominciarono
Il laboratorio teatrale in rete
LA VOCE4_07:LA VOCE 3_06 24-08-2007 9:48 Pagina 4
Alle ore 20.45 di sabato 17 novembre verràrappresentato, presso la Sala Madrassidella Parrocchia di San Quirino, a conclu-
sione del progetto Diritto e Giustizia 2007, il dram-ma satiresco Il Ciclope, liberamente tratto dall’o-pera di Euripide. Allestimento a cura del GruppoTeatrale Gli Stelliniani.
IL CICLOPE
Si invitano tutti gli Stelliniani, che serbinomemorie riguardanti il Liceo, i suoi docen-ti o gli allievi e siano disposti a offrire il pro-
prio contributo alla stesura del volume, a pren-dere celermente contatto con il prof. Federico Vi-cario, cui è stata affidata la curatela del volume([email protected]).
VOLUME PER IL BICENTENARIO
5
Evoi, donna, nonperdete inutilmenteil vostro tempo, or-
dinategli una cassa di pino,perché di quercia sarebbetroppo cara per lui”… Sparìe si dileguò un essere, chenessuno difendeva, che nonera caro ad alcuno e non in-teressava nessuno […] se neera andato nella tomba sen-za aver fatto nulla di straor-dinario, un essere per ilquale, tuttavia, proprio allafine dell’esistenza era ap-parso un ospite luminososotto l’aspetto di un cappot-to che aveva per un attimorianimato quella povera vi-ta, e sul quale poi si era ab-battuta un’insopportabileinfelicità, come si abbatteanche sugli zar e sui sovra-ni del mondo (Gogol, I rac-conti di Pietroburgo).
“Veniamo tutti dal Cap-potto di Gogol” dice AshokeGanguli al proprio figlioGogol, giovane indoameri-cano a cui viene dato quelnome così impegnativo perun miracolo…
India anni ’70. Il giovaneAshoke sta viaggiando se-duto nello scompartimentodi un treno e legge Gogol, ilsuo scrittore preferito. Im-provvisamente uno schian-to tremendo… un incidentespaventoso: pochi si salva-no fra cui il giovane studen-te perché la copertina chiaradel libro che ancora stringeal petto attira i soccorritori.Il libro è proprio Il cappottodi Gogol, e il nome di Gogolper Ashoke da questo mo-mento in poi evocherà l’i-dea di un miracolo, miraco-
lo che per lui si rinnovaogni momento della sua vi-ta, anche quando sposa As-hima e con lei lascia Calcut-ta per trasferirsi a NewYork. Alla nascita del primofiglio, i genitori, appenagiunti in America, si trova-no impreparati alla doman-da dell’ufficiale dell’ana-grafe per quanto riguarda ilnome da dare al nascituro(in India, infatti, i nomi deibambini vengono scelti dal-la nonna materna, dopo at-tenta valutazione e conmolti mesi di anticipo): si
materializza allora il nome-talismano del padre, Gogol.Chiamarsi però così per ungiovane americano, tale sisente il ragazzo e nell’inti-mo e nei comportamenti,non è semplice; e così prefe-risce il più comune “Nick”.Perché in America si è liberidi mutare l’anagrafe, anchese si va contro la memoria ele tradizioni: basta pagare.
The Namesake, ovvero L’o-monimo (India e USA 2006),è la storia di un’integrazio-ne ma anche di un’educa-zione alla libertà, al di là diqualsiasi tipo di apparte-nenza, ed è questo il donoche i due genitori indianidanno ai loro due figli ame-ricani. Ma c’è anche un de-stino nel proprio nome a cuitutti noi non potremo maisfuggire e lo dimostra il fat-to che, nonostante il sognoamericano e il quasi matri-monio con una yankee, Nickcon la testa rapata va in In-dia a gettare nel Gange leceneri del padre morto. Laregista, Mira Nair (Missis-sippi Masala, Monsoon Wed-ding, Salaam Bombay), adat-tando lo struggente roman-zo best-seller di Jhumpa La-hiri, torna dopo alcuni filmsnon proprio consoni al suomodo d’essere, nel suo ter-ritorio fatto di identità e in-tegrazione. È quasi un’auto-biografia la sua con con-fronto-scontro tra radici eidentità che la regista af-fronta con il solito stile son-tuoso, con uno sguardo for-se a Bollywood e con una mi-scela di India tradizionale eStati Uniti pragmatici chesono il suo punto di forza. Ilfilm, presentato alla Festa diRoma nella rassegna di pun-ta Premiere, ha per ultimoquesto messaggio che, perme, forse è il fulcro del De-stino: “I viaggi più belli so-no quelli che riportano a ca-sa”.
Antonia Corradi
Il destino nel nomeI viaggi più belli sono quelli che riportano a casa
LE RECENSIONI DEGLI STELLINIANI
Da qualche anno a questa parte nelle sale cinematografiche assistiamo alla proiezione difilm come Goodbye Lenin, La rosa bianca, La caduta-Gli ultimi giorni di Hitler, e oggi “Levite degli altri”. Questo fenomeno, oltre a regalarci pellicole di alta qualità artistica e sto-
rica (cosa non usuale nella difficile realtà del cinema europeo contemporaneo), testimonia chel’Est sta coraggiosamente analizzando se stesso con la massima sincerità possibile. Sono finitii tempi in cui un capolavoro quale Arcipelago Gulag decretò la perdita della cittadinanza e l’e-silio per il suo autore Solzenitsyn, premio Nobel per la letteratura nel 1971; ora nell’ex Germa-nia dell’Est cresce in chi ha vissuto quegli anni la voglia di ricordare, in chi è nato dopo o è vis-suto al di qua della “cortina di ferro” quella di scoprire.
Le vite degli altri, Oscar per il miglior film in lingua straniera del 2007 e opera prima del gio-vane regista tedesco Florian Henckel Von Donnersmark, racconta con lucido sentimento laDDR degli anni Ottanta, e l’atmosfera di sottile paura in cui vivevano i suoi cittadini a causadella Stasi, la polizia segreta che divenne negli anni la più efficiente del blocco orientale.
L’inflessibile agente della Stasi Gerd Wiesler (Ulrich Muhe) viene incaricato di sorvegliareGeorg Dreyman (Sebastian Koch), noto drammaturgo fedele al regime. Ma non è in ballo la si-curezza del regime: in realtà il ministro della cultura Bruno Hempf, invaghitosi di Crista-Ma-ria Sieland (Martina Gedeck),l’attrice compagna di Drey-man, per avere campo libero èdeciso a liberarsi del rivale ac-cusandolo di “delitti contro loStato” (capo di imputazionedavvero molto diffuso nelblocco orientale). Wiesler, en-trato da nemico nelle vite deidue artisti, ne diventa col tem-po il discreto custode. A con-tatto con l’umanità, le gioie e idolori del drammaturgo, lasua dedizione alla causa co-munista si trasforma in com-passione e complicità, e daagente del regime diviene suooppositore.
Wiesler controlla e intervie-ne sulle “vite degli altri” comeun deus ex machina del teatroantico, ma senza mai venire allo scoperto. È come un regista che aggiusta e corregge lo spetta-colo che sta dirigendo, seguendo passo dopo passo questi due professionisti del palcoscenicoche si ritrovano a “recitare” inconsapevolmente la loro autentica vita ai microfoni della Stasi.
Da un punto di vista storico il film si attiene alla realtà: frutto di anni di ricerche, dipinge fe-delmente la DDR, in cui si stima che oltre il 5% della popolazione collaborasse con la Stasi (con-tro il 2% registrato nell’Urss). Dopo la caduta del muro, quando gli archivi della polizia segre-ta furono aperti alla consultazione, molti cittadini scoprirono di essere stati controllati chi dalconiuge, chi dal migliore amico; uno di questi casi è proprio quello dell’attore che interpretal’agente, il quale era stato spiato dalla consorte e da ben quattro membri della sua compagniateatrale. Anche per la dolorosa esperienza personale la recitazione di Muhe risulta intensa, pro-fonda, convincente sino all’ultimo; a dimostrazione di questa compenetrazione vita-recitazio-ne, quando alla presentazione del film in Germania gli fu chiesto come si fosse preparato alruolo, egli rispose significativamente “ho ricordato”. Un motivo in più per apprezzare un filmche affronta piaghe ancora aperte con grande sincerità di toni e sentimenti.
Valeria Gholizadeh
Scena dal film Il destino nel nome.
ANNUNCI PER I SOCI
Quote associative per l’anno sociale 2007socio sostenitore: .........................................................€ 30socio ordinario:..............................................................€ 15 socio simpatizzante: ................................................€ 15socio familiare: ...............................................................€ 10socio studente universitario: ........................€ 5
I versamenti possono essere effettuati - presso la Segreteria dell’Associazione che dallo
scorso settembre è ritornata nella sede del Liceo “Stellini” ed è aperta ogni mercoledì dalle ore 17.00alle ore 18.30,
- direttamente sul c.c.b. n° 740/4341669 P, presso laFRIULCASSA di Udine e filiali - coordinate banca-rie ABI/CAB 6340-12300 CIN V
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere al-la prof.ssa Elettra Patti, segretaria dell’Associazione,che risponde al numero telefonico 347/9241345 ognipomeriggio dalle ore 18.00 alle 19.30. Si rendono pure noti l’indirizzo di posta elettronica el’indirizzo del sito internet che sono rispettivamente: [email protected]
DAI, SPARGI LA VOCE
Il Consiglio direttivo invita tutti i neodiplomati stelliniani a una cerimonia che si svolgerà nell’AulaMagna del Liceo alle ore 17.30 di venerdì 21 settembre. Durante l’incontro agli intervenuti verrà fat-
to omaggio della tessera di socio ordinario per l’anno sociale 2008.
INCONTRO CON I DIPLOMATI
Tutti coloro che intendano rinnovare il pro-prio abbonamento teatrale o sottoscriver-ne uno nuovo sono pregati di mettersi
quanto prima in contatto con la prof. Elettra Pat-ti, segretaria dell’Associazione.
* * *
Si annuncia inoltre che una nuova opportunitàdi abbonamento teatrale agevolato è stata offertaai nostri iscritti dall’Associazione ScenAperta,fondata dal CSS (Teatro Stabile di Innovazionedel Friuli Venezia Giulia) in collaborazione conAssociazione Amici della Musica, Civica Accade-mia d’Arte Drammatica “Nico Pepe”, EuritmicaAssociazione Culturale, Teatro Club Udine. Lanuova stagione teatrale avrà quale sede privile-giata il Teatro delle Mostre.
STAGIONE TEATRALE 2007/2008
La vita degli altriQuando l’Est fa i conti con se stesso
“
L’abbattimento del muro di Berlino.
La locandina del film.
LA VOCE4_07:LA VOCE 3_06 24-08-2007 9:48 Pagina 5
6
Una borsa di studio per ricordare Stefano
Ecco un articolo che l’au-tore non avrebbe maipensato di dover scrive-
re e i lettori di dover leggeretanto meno su queste pagine.
Parliamo di Steven Allescia,un brillante ex allievo dello“Stellini” che una tragica fata-lità ha spento ancora nel fioredegli anni. Ne aveva appena33 quando un terrificante inci-dente d’auto nell’isola di Kos,dove ricopriva un prestigiosoincarico professionale nell’or-ganizzazione del turismo, lostroncò consegnando alla me-moria la bellissima immaginedi un giovane inebriato dellagioia di vivere, sulle labbra unsorriso spento nell’estremo do-lore.
Un olocausto al mito di “un’automobile ruggente più bella del-la vittoria di Samotracia” per incolpare della morte l’immaginariocollettivo? O la trasgressione di un Icaro moderno insensibile alleambasce di un padre premuroso? O l’esempio di un giovane cheoggi esclude il conto della morte dalla religione del vissuto quoti-diano?
Stefano, per l’anagrafe inglese Steven, nasce il 4 settembre del1969 nei pressi di Londra dove risiedeva, prima di sposarsi, la ma-dre Jeanny una bella ragazza di ottima famiglia ivi trasferitasi dal-la Persia.
Ma in Inghilterra rimane solo pochi mesi perché con sua madreraggiunge a Roma il padre Vittorio, un giovane promettente chi-rurgo che, seguendo le tappe della sua carriera, si trasferisce conla famiglia a Udine definitivamente.
A Udine Stefano viene su dividendo con la sorella Sammy, diqualche anno più piccola, il calore degli affetti familiari crescendodi indole buona, di carattere vivace e con accenni gradevoli di ir-requietezza, incominciando a provar gusto alla vita grazie ancheai genitori che mai esercitarono sui figli una vigilanza rigorosa.
Seguendo le orme delle tra-dizioni familiari si iscrive al Li-ceo Classico che frequenta allo“Stellini” dove compie regola-re corso di studi distinguendo-si soprattutto per l’educazionesignorile, gentilezza d’animo,disponibilità generosa all’ami-cizia suscitando intorno a séunanimi consensi di simpatia.
Conseguita la maturità siiscrive a Giurisprudenza nel-l’Università di Trieste e poi diSalerno, ospite dei suoi cugini.Ma non si trova a suo agio fracodici e pandette preferendo lafacoltà di Lingue e LetteratureModerne a lui più congenialiche frequenta nell’Universitàdi Udine non trascurando in-tanto di trovarsi un lavoro per-sino all’estero, in Inghilterra ein Grecia.
Appena laureato con l’espe-rienza che già si è fatta, la co-noscenza acquisita di lingue:spagnolo, catalano, inglese,greco, non gli è difficile ottene-re incarichi professionali di no-tevole prestigio e responsabili-tà.
Ingaggiato da un’importanteazienda turistica internaziona-le, la Columbus, incomincia agirare per il mondo spostando-si dalla Spagna alle Canarie, al-le Maldive scampando per po-co allo Tzunami e infine inGrecia, ultimamente a Kos. E aKos, ormai maturo e fortemen-
te motivato, nel corso di un pe-sante lavoro il 4 giugno del2004 incontra la morte mentresi avviava a cogliere i frutti delsuo meritato successo.
A Kos i genitori compiono ildoloroso rito di raccoglierne lespoglie per ricomporle defini-tivamente nel cimitero di Udi-ne dove alla sua tomba iniziauna sequenza ininterrotta dipellegrinaggi nel rimpianto diun fiore di giovinezza immatu-ramente reciso.
Per onorarne la memoria eadditare alle future generazio-ni la figura di uno stelliniano amodo, l’Associazione degliStelliniani d’accordo con il Li-ceo stesso e con i familiari, isti-tuisce una borsa di studio inti-tolata a suo nome per allievimeritevoli di questa scuola; eintanto è in corso di pubblica-zione la sua tesi di laurea perevidenziarne il positivo conte-nuto.
Domenico Allescia
Verrà dato pubblico bandodella borsa di studio, che saràfinanziata dalla famiglia, al-l’inizio del prossimo annoscolastico nell’Aula Magnadello “Stellini”: in tale occa-sione il prof. Domenico Alle-scia presenterà anche la tesidel compianto nipote.
Aprile 1971. Il prof. Cerroni nellaClasse I E.
Aprile 1971. Il Prof. Ballori nellaclasse I E.
Aprile 1971. Il prof. Corvo con al-cuni alunni della Classe I E.
Aprile 1971. Sergio Zannier (adestra) alunno della Classe I E.
1972. Alessandro Misdariis (alcentro) alunno della III E.
Palio 1978. Il Timoleone di Alfieri,per la regia del prof. Cerroni.
Palio 1978. Il Timoleone di Alfieri.A destra la prof. Anna Termini.
Nativo di Feltre nelCadore, da cui de-sunse il nome d’ar-
te di Cadoresi, il prof. Do-menico Cerroni si trasferìin giovane età a Udine, ra-dicandosi in seguito cosìfortemente nella vita delFriuli da impadronirsi an-che della sua lingua. Intel-lettuale impegnato edeclettico, manifestò i suoiinteressi in varie direzionima soprattutto nel campoletterario e artistico, dimo-strandosi aperto alle cor-renti più innovative e sem-pre pronto ad affrontarenuove esperienze intellet-tuali, facendosi spesso pro-motore e organizzatore dinumerose iniziative di no-tevole spessore culturale.Fu poeta, saggista, scritto-re, pittore e critico d’arte,collaborò con il Messagge-ro Veneto e il Friuli e trovòil tempo per coltivare an-che l’arte culinaria, che co-ronò scrivendo dei ricettaridi gastronomia friulana.
Svolse a lungo (dal 1957al 1982) l’attività di docen-te di Storia e Filosofia allo“Stellini” e due generazio-ni di studenti lo ricordano
Esce di scena un illustre StellinianoIntellettuale impegnato e versatile, insegnò per venticinque anni al Liceo Classico
LA MEMORIA DEGLI STELLINIANI
non solo per il valore dellesue lezioni, mediante lequali riusciva a trasmettereloro la passione per la cul-tura, ma anche per la gran-de umanità e disponibilitànei loro confronti. Autoredi teatro lui stesso, in que-sti anni svolse anche il ruo-lo di coordinatore e registadel gruppo studentesco.Durante la controversacontestazione del Sessan-totto, condividendone leidealità, egli si schierò dal-la parte degli studentiquando lo “Stellini” fu ilprimo liceo del Triveneto aessere occupato.
Una volta conclusa la fa-se dedicata all’insegna-mento, già prima fertilescrittore, intensificò la suaproduzione letteraria. Ec-co, qui di seguito, un elen-co incompleto delle suepubblicazioni e delle sueattività.
Contribuì alla collana dipoesie “Quaderni del Pro-vinciale” di Dino Menichi-ni, alla rivista “Politica ecultura” del Circolo “Cala-mandrei”, alla rivista “IlPunto” di Piero Fortuna eall’ “Enciclopedia Mono-
grafica del Friuli VeneziaGiulia”, una gigantescaopera in vari volumi, di cuiha curato per intero il capi-tolo relativo alla letteraturadel Novecento.
Negli anni Ottanta orga-nizzò due congressi inter-nazionali: il primo sulNeorealismo friulano, del-la cui poesia fu uno deimaggiori esponenti insie-
re le opere antiche, ripro-ponendo alcuni dei valoriforti della tradizione, an-che se con la frammenta-rieta di citazione tipica dell’intellettuale contempora-neo, nel tentativo di rista-bilire un dialogo tra pre-sente e passato. La conce-zione pessimistica della vi-ta e della società, il suo ni-chilismo positivo, come lui
Pubblichiamo qui di segui-to il ricordo di un ex allievodegli anni Sessanta.
Sono ormai, e purtroppo,trascorsi quasi quaranta an-ni da quando lasciai i ban-chi di scuola del nostro Li-ceo “Stellini”, ma di certonon ho dimenticato né il no-me né la personalità dei do-centi che mi hanno guidatonell’arduo e faticoso percor-so degli studi classici.
Uno dei miei due inse-gnanti di Storia e Filosofiaè stato il professore Dome-nico Cerroni; tanti sono iricordi che serbo di lui, del-la sua forte personalità,della sua vasta cultura nonsolo storica e filosofica, masoprattutto della sua dispo-nibilità e cordialità versogli studenti. Ricordo laschiettezza dei rapporti ela confidenza, a quel tem-po rarissima, che il prof.Cerroni concedeva a chi dinoi si fermava, alla finedella lezione, presso la cat-tedra per ottenerne un ap-profondimento o per espor -gli il proprio punto di vi-sta, o per chiedergli addi-rittura consigli e sostegno.
Nei difficili anni dellacontestazione studentesca,il prof. Cerroni si schieròdalla parte degli studenti,assecondandone le ansie dicambiamento e rinnova-mento: a tal proposito ri-cordo che una delle sue in-novazioni didattiche piùnotevoli fu l’eliminazionedelle interrogazioni di tipotradizionale.
Quando, dopo gli studiuniversitari, prestavo ser-vizio presso gli Uffici dellePoste Centrali, mi capitavatalvolta di incontrarlo, neiprimi anni ancora docentee in un secondo tempo or-mai in pensione, sotto iportici di via Vittorio Vene-to. Sempre grande e since-ra era in tali occasioni lasua cordialità e affettuosoil suo atteggiamento neimiei riguardi, anche se leultime volte non riusciva acollocarmi con esattezza inuna delle tante classi in cuiaveva insegnato al Liceo.
L’ultimo nostro incontroavvenne nei primi mesidello scorso anno nell’atriodell’ospedale di via Gerva-sutta: si fermò con me soloqualche minuto, il temponecessario per confidarmiche aveva dei problemi disalute, ma senza scenderenei particolari. Ci ripro-mettemmo allora di cercarequanto prima un’occasionedi incontro più propizia.Ma il destino avverso nonlo ha consentito. Addioprofessor Cerroni!
Giacomo Patti
Le fotografie ritraggono oltre al prof. Cerroni anche al-tri docenti e allievi della sezione E negli anni Settanta.Si ringraziano gli stelliniani Laura Cozzi, AlessandroMisdariis e Sergio Zannier per averci messo a disposi-zione la propria fototeca.
Stefano Allescia, raggiante di felicità e di
aspettative, il giorno della sua laurea.
stesso lo definiva, non glitolse mai la capacità di rica-ricarsi e di gettarsi in nuoveavventure intellettuali.Considerando l’apportodato da Domenico Cerronialla nostra cultura, sono inmolti a condividere l’opi-nione, espressa dall’amicoLicio Damiani, che il Friulisia stato “ingiustamenteavaro di riconoscimenti neisuoi confronti”.
Ambra Accordi
me al fratello Mario, che fului pure docente allo “Stel-lini” e scomparve precoce-mente nel 1957; il secondosull’opera di Menichini,del quale era stato grandeamico e al cui nome avreb-be intitolato nel 1996 unpremio nazionale di poe-sia.
Nel 1987 fondò, divenen-done presidente, l’Associa-zione culturale “Gran Fa-bula”, un cenacolo di arti-sti che mirava a rivitalizza-
LA VOCE4_07:LA VOCE 3_06 24-08-2007 9:48 Pagina 6
7
L’estate è arrivata anche a Pechino, i venti del nord cari-chi di sabbia e quelli dell’est carichi di pioggia attra-versano la città; il cielo da grigio diventa viola, poi
giallo, azzurro, per tornare infine grigio. La città brulica in-cessantemente di persone: lavoratori, nonni coi nipoti, stu-denti: il gruppo più sostanzioso e variegato è proprio que-st’ultimo. Alla Capital Normal University i corsi regolari so-no terminati ma il flusso di liu xueshen (studenti stranieri) èincessante: molti coreani, inglesi e thailandesi sono tornati inpatria lasciando il posto ad americani e francesi; anche i ci-nesi che hanno finito i corsi sono tornati a casa, mentre sonorimasti italiani, giapponesi, polacchi, ungheresi, greci, russi,nepalesi, iracheni, indonesiani e tedeschi.
Un tale ambiente multietnico pone il problema della co-municazione per le necessità quotidiane, e al tempo stessocostituisce un’occasione unica per la conoscenza di stili di vi-ta e mentalità tanto variegati. Se all’inizio si pensava che l’in-glese sarebbe stata la lingua veicolare per la maggior parte dinoi, ci siamo presto accorti che essa non ci permetteva di co-municare con tutti, e, visto che l’obiettivo comune era l’ap-prendimento della lingua cinese, l’abbiamo adottata comemezzo di comunicazione. D’altra parte ci capita spesso di ri-cevere richieste di lezioni di inglese da molti cinesi sia stu-denti che professori. E poiché noi vogliamo impratichircinella loro lingua parlata, ben presto ognuno di noi studentistranieri si è trovato uno o più fudao, ovvero una persona dimadrelingua che lo aiuta nello studio o con cui semplice-mente si incontra per conversare: chiunque può diventare ilfudao di qualcuno, una persona conosciuta in bus, un amicodi un amico, uno studente, un professore. E questo è certa-
Interscambio linguistico
LE SCELTE DEGLI STELLINIANI
mente uno degli aspetti piùbelli dell’esperienza di stu-dio all’estero, il libero e com-pleto scambio di conoscenze.
All’inizio, non sapendocome trovare un fudao, hochiesto a un mio docente lasua disponibilità e il profes-sor Zhao ne è stato entusia-sta, mi avrebbe aiutato incambio di lezioni di inglese.L’impegno preso è, come diregola, reciproco e gratuito.In seguito, durante una con-versazione egli ha espresso,con mia grande sorpresa, ilsuo interesse per la lingua la-tina e poco tempo dopo miha portato i libri sui qualiaveva iniziato a studiarla dasolo. Mi ha informata, scon-solato, che quei libri li avevadovuti far arrivare dall’este-ro, poiché non reperibili innessuna università della ca-pitale. In effetti l’unico librostampato in Cina con testi la-tini da me scovato è un pe-
sante tomo di citazioni dalla Bibbia in greco, latino e aramaicotradotte in cinese. Poco tempo dopo abbiamo iniziato delle le-zioni di latino in inglese, unendo così le due lingue verso le qua-
Nel giugno del 2006, men-tre frequentavo ancora laFacoltà di Lettere qui a
Udine (corso di laurea in Conser-vazione dei Beni Culturali), miiscrissi al concorso per l’ammis-sione all’Accademia per AllieviMarescialli dell’Arma dei Cara-binieri. Ero pronta a impegnar-mi con tutta me stessa pur direalizzare il sogno della mia vi-ta. E così ho studiato l’interaestate per superare il test di cul-tura generale (italiano, storia,geografia, matematica, diritto,informatica, lingua straniera, lo-gica). In settembre ci presentam-mo a questa prima selezione in45.000 aspiranti. Essendo strut-turata con domande chiuse, co-me un quiz, nonostante mi fossiapplicata con serietà allo studio,temevo di non superare questaprima selezione. Due settimanedopo, invece, mi arriva la comu-nicazione che ce l’ho fatta. Gran-de la gioia, ma eravamo ancorain 4.000!
Il 25 ottobre ero pronta ad af-frontare la seconda prova: l’ela-borazione di un testo in linguaitaliana su un argomento di at-tualità. A dire il vero, mi sentivocerta che la preparazione acqui-sita allo “Stellini” mi avrebbepermesso di superarla, ma peraverne la conferma dovettiaspettare fino all’inizio di gen-naio di quest’anno.
Tra la fine di marzo e gli inizidi aprile si sono svolte, infine, leultime prove del concorso, le piùdure ma anche le più belle dalpunto di vista umano, per unasorta di solidarietà che parados-salmente, contro ogni logica, siera venuta a creare all’internodel mio gruppo. Eravamo statiinfatti divisi in gruppi maschili ofemminili, ciascuno di un centi-naio di persone. Si trattava ditest di efficienza fisica: corsa, sal-to in alto e piegamenti sulle
braccia. La prova della corsa èstata la più difficile da prepara-re. Sapendo che la maggior par-te delle ragazze vengono nor-malmente scartate proprio per ilfallimento in questa prova, perraggiungere il tempo stabilitodal bando avevo iniziato ad alle-narmi già nell’agosto dello scor-so anno e mi sono impegnatamolto di più che per le altre, concostanza, ogni giorno, con il soleo con la pioggia. Ciò nonostanteprima di partire per Roma (an-che questa come tutte le prece-denti fasi si svolgono nella capi-tale), non ero ancora riuscita a ri-entrare negli standard imposti equesto accresceva il mio terroredi non raggiungere l’obiettivoprefissatomi. Immaginatevi quin-di la mia soddisfazione quandoil giorno 28 di marzo superaibrillantemente tutte le prove fi-
Lidia Forcini il giorno della sua lau-rea. L’abbigliamento allude goliardi-camente alla sua scelta di entrare nelComando Tutela Patrimonio Culturale(T.P.C.) dell’Arma dei Carabinieri.
siche! Nei quattro giorni seguen-ti si susseguirono le visite medi-che, i test di efficienza psicologi-ca, i colloqui con gli psicologi e,infine, gli esami orali. Nel miogruppo passammo solo in di-ciotto: a ogni prova, infatti, veni-vano eliminate molte ragazze e,dopo i momenti di difficoltà af-frontati insieme, la separazionerisultava dolorosa.
Alla fine del concorso gli ido-nei risultarono 550 tra maschi efemmine, ma questo non implica-va automaticamente l’ammissio-ne all’Accademia: giacché i postia disposizione erano solo 350.
Per aumentare il mio punteg-gio e quindi piazzarmi meglioall’interno della graduatoria, inmaggio ho affrontato la provafacoltativa di lingua straniera.
Finalmente il 19 giugno, a unanno dalla presentazione delladomanda ho ricevuto la notiziache a ottobre entrerò in Accade-mia, per frequentare il primo deidue anni di corso a Velletri, il se-condo a Firenze.
Anche se l’ultimo mese, tra-scorso in angosciosa attesa del-l’esito finale, è stato forse il pe-riodo più difficile della mia vita,nell’insieme ho vissuto una ma-gnifica avventura che mi ha per-messo di conoscere tante perso-ne provenienti da tutte le partid’Italia, con alcune delle qualiho gettato anche le basi per unrapporto di sincera amicizia. Misento pertanto di caldeggiarecon tutto il cuore questa espe-rienza: è vero la strada da per-correre è lunga e ardua, ma, se sivuole dare vita a un sogno, ègiusto lottare. So che sarà diffici-le lasciare gli amici e la famigliaqui a Udine, ma so anche che co-sì facendo potrò realizzare mestessa e rendermi utile agli altri.
Lidia Forcini
Eva Sara Molaro in abito tradizionale ci-
nese.
Il sogno della mia vitaCome diventare “marescialla” dei carabinieri e vivere felice e contenta
Benché generalmente glistudenti, una volta termi-nati gli studi liceali, evitino
con cura e a lungo anche solo dipassare davanti allo “Stellini”,quasi per una sorta di rigetto do-po tanti anni di trapianti cultura-li, capita talvolta il fine settima-na o prima delle vacanze di in-contrarne qualcuno sulla gradi-nata del Liceo al termine delle
Sì: la selezione è molto severa.Lo scorso settembre c’è stato ilprovino che consiste nel recitareun monologo o un dialogo. A se-guire ho dovuto affrontare uncolloquio attitudinale e un esa-me sulla storia del teatro. Ognianno si presentano circa 350aspiranti: ne selezionano unaquarantina, ai quali fanno speri-mentare per una settimana la vi-
ta dell’Accademia. Al-la fine ne ammettonocirca un terzo.
Come sono organiz-zati gli studi?
Ci sono corsi per at-tori, registi, tecnici dipalcoscenico, dramma-turghi, danzatori eoperatori. Il primo an-no, che ho appena con-cluso e che è incentratosullo studio delle tec-niche di base, risulta ilpiù duro. L’impegnoscolastico si protraedalle 9.00 alle 18.30,dal lunedì al venerdì.Ogni mattina si fannouna o due ore di “mo-vimento” (la materia
fondamentale): un misto di dan-za, gestualità e ginnastica; poi sipassa alle lezioni di impostazio-ne della voce, di dizione e di can-to. Il pomeriggio è dedicato ai se-minari di recitazione: fino a mar-zo abbiamo avuto come maestroKuniaki Ida, insegnante giappo-nese di fama internazionale. Daaprile abbiamo intrapreso un se-minario di recitazione sul meto-do Stanislavskij con TatianaOlear, seminario che che si con-cluderà con la messa in scena diPrimo amore di Turgeniev. Du-rante l’anno abbiamo inoltre par-tecipato come coreuti, sotto la di-rezione dell’insegnante di canto,alla preparazione del saggio didrammaturgia del terzo anno,consistente nella messa in scenadi uno spettacolo musicale.
Come ti sei trovato?
Alessandro Vasta
Ho avuto la fortuna di essereaccolto in un ambiente eccezio-nale. Essendo solo in sedici e vi-vendo praticamente tutto il gior-no insieme, siamo diventati co-me una famiglia. Anche con iprofessori abbiamo instauratoun ottimo rapporto, diversa-mente da quanto raccontano gliallievi della classe precedente.
Come mai questa scelta?Capii che volevo diventare un
attore professionista all’età di se-dici anni, alla fine del mio primospettacolo per il Palio Studente-sco, Risveglio di primavera diFrank Wedekind. È stato il paliol’esperienza che mi ha cambiatola vita, rivelandomi interessi, in-clinazione e attitudini che nonmi ero ancora accorto di posse-dere. In seguito, credendo chefosse solo un’utopia, mi orientaisulla scelta più “normale” dimedicina. Ma, conseguita la bra-mata maturità, riemerse la miaprima passione: così a metà ago-sto riposi i libri degli alfa test inun cassetto e iniziai a preparar-mi per il provino: prima di ren-dermene conto ero entrato alla“Paolo Grassi”.
Quanto ti sono serviti la forma-zione personale e il bagaglio cul-turale acquisiti allo “Stellini”?
Oggi un buon attore deve pos-sedere una solida base culturalee credo che lo “Stellini” me l’ab-bia data. Anzi, dopo un anno distudio pratico, debbo dire chesento la mancanza dello spesso-re culturale cui ero abituato. Infuturo, se potrò, mi iscriverò al-l’Università per frequentare lafacoltà di storia, disciplina chemi ha insegnato ad amare il mi-tico prof. Daniele Picierno. Aproposito, colgo l’occasione perringraziare tutti i miei insegnan-ti (anzi, quasi tutti) e, in partico-lare, per chiedere scusa ai mieiprofessori di latino e greco, chetanto ho fatto penare ma chetanto mi hanno dato.
Elettra Patti
L’esperienza del palio rivela inclinazioni e attitudini prima ignorate
li il professore provava interesse. Naturalmente la difficoltàpiù grande nell’apprendimento di una lingua iperflessivaqual è il latino per i cinesi è la sua morfologia: la coniuga-zione dei verbi, la declinazione di nomi e aggettivi e già lasemplice distinzione tra nomi maschili e femminili per lororisulta incomprensibile. La stessa cosa ovviamente capita in-segnando l’italiano: una ragazza coreana voleva avere dellebasi della nostra lingua e una delle sue prime domande è sta-ta “Perché voi dite che un tavolo è maschio e una sedia èfemmina?”
Al momento nella Capitale esiste un corso di italiano; gliiscritti sono pochi ma volenterosi e bisogna dire che gli stu-denti cinesi, una volta compreso il problema declinazione-coniugazione imparano sorprendentemente in fretta, ancheperchè sono dotati di una capacità di memorizzazione inu-suale. Inoltre tutte le lingue che si scrivono con caratteri al-fabetici, una volta superato lo scoglio grammaticale, risulta-no per i cinesi più facili da apprendere di quanto non lo siala loro lingua per noi che dobbiamo memorizzarne gli ideo-grammi. D’altra parte, se negli show televisivi e nelle canzo-ni cinesi appaiono sempre più frequentemente parole ingle-si, francesi o italiane, rivelando un interesse crescente neiconfronti delle lingue europee, è vero anche che, se la Cinacontinuerà ad espandere la sua influenza all’estero, divente-rà sempre più indispensabile per gli europei impararne lalingua, cosa che sta già avvenendo, come dimostra il nume-ro di studenti stranieri che si iscrivono a corsi ordinari, esti-vi e part-time di cinese.
Eva Sara Molaro
lezioni. Il motivo di queste mira-colose apparizioni è di varia na-tura: una botta di malinconiaper la vecchia scuola, un richia-mo amoroso, il desiderio di salu-tare gli ex compagni. È stato co-sì che ai primi di giugno ho in-contrato Alessandro Vasta chenon vedevo dai tempi in cui ave-va recitato ne La colonna infamecon il Gruppo Teatrale Gli Stelli-niani (cfr. La Voce V,1).
Sapendo che frequenta la pre-stigiosa Scuola d’Arte Dramma-tica “Paolo Grassi” di Milano,non mi sono lasciata sfuggirel’occasione di intervistarlo perLa Voce.
Mi hanno detto che stai fre-quentando con successo la Pao-lo Grassi di Milano. Bravo! Micongratulo con te. È stato diffi-cile entrare?
LA VOCE4_07:LA VOCE 3_06 24-08-2007 9:48 Pagina 7
Nel corso dell’ormai tra-dizionale uscita di pri-mavera, dedicata que-
st’anno al tema Dal Fascio all’A-quila Bicipite, la comitiva degliStelliniani, guidata dal prof. Ste-fano Perini, ha visitato lo storicostabilimento di Torviscosa, pre-giata testimonianza della capa-cità imprenditoriale di FrancoMarinotti, cavaliere del lavoro econte di Torviscosa, fondatore epresidente, per trentasei anni,della SNIA Viscosa. Lo stabili-mento si trova tra San Giorgiodi Nogaro e Cervignano nel co-mune di Torviscosa, a 35 chilo-metri da Udine.
Dove ora sorge la città vi eraun tempo una palude infestatadalla malaria. Essa venne boni-ficata mediante la costruzionedi arginature di difesa dalle ac-que esterne, collettori e impian-ti di smaltimento meccanicodelle acque meteoriche e di ri-sorgiva. L’azienda agraria è sor-ta dunque dalla bonifica dellepaludi di Torre Zuino, Fauglis,Planais e Salmastro, per la colti-vazione di pioppi e frutteti, l’al-levamento del bestiame e pro-dotti caseari. Utilizzando l’e-nergia motrice delle centralielettriche e delle dighe costruitenell’alto Meduna e sul Silisia, ildottor Franco Marinotti, affi-dandosi all’opera di due bril-lanti ingegneri, fece mettere apunto un procedimento per laproduzione di cellulosa da unapianta a ciclo annuale, “la can-na gentile” (harundo donax) e inbreve realizzò, a partire dal
LE ESCURSIONI DEGLI STELLINIANI
8
Gradisca 25 aprile 2007. Un gruppo di Stelliniani al termine dell’itinerario Dal
Fascio all’Aquila Bicipite.
1938, un considerevole com-plesso agricolo ed industrialeche rappresentò, durante gli an-ni della guerra e quelli imme-diatamente successivi, un’im-portante risorsa per sopperireal sempre crescente fabbisognoitaliano di cellulosa. In seguitoallo studio di nuove tecnologie,l’impianto fu utilizzato per laproduzione di cellulose idoneealla produzione di raion e fioc-co.
Dopo la canna gentile, furonosfruttate anche altre essenze le-gnose, come il pioppo e l’euca-lipto, per la cellulosa tessile e al-tri prodotti di uso industriale.In seguito, lo sviluppo e la dif-fusione nel mondo delle fibresintetiche indussero il presiden-te Marinotti a creare a Torvisco-
sa uno stabilimento per la pro-duzione del caprolattame, che èla materia prima per il lilion. Lostabilimento e l’azienda venne-ro poi danneggiati dalla guerrache, oltre alla distruzione degliimpianti, provocò l’allagamen-to di circa mille ettari di terreno,ma la produzione venne ripresanell’immediato dopoguerra.
Negli anni ’70, il complessodegli stabilimenti di Torviscosaera costituito da una fabbrica dicellulosa tra le maggiori d’Eu-ropa, della potenzialità di oltrecentomila tonnellate annue e daun impianto elettrochimico perla produzione del cloro, dellasoda caustica, dell’ipoclorito eacido cloridrico, nonché da unanuova centrale termoelettrica.La cellulosa è ottenuta da vari
legni di latifoglia, ma l’attivitàdi questa fabbrica ha permessol’affermazione della tecnica diTorviscosa anche fuori dei con-fini dell’Italia (Spagna, SudAfrica, Messico e Russia).
La visita è stata organizzatacon la collaborazione del Cen-tro documentazione FrancoMarinotti. Il Centro, che racco-glie vari documenti sulla storiadi questa costruzione agricolo -industriale, a partire dal 1938, èsede di una biblioteca tecnica,di una sala di esposizione deiprodotti del Gruppo in cui han-no luogo gli incontri con ilmondo internazionale, e persi-no di un piccolo museo con re-perti archeologici di arte roma-na provenienti da Aquileia.
La città di Torviscosa, che si èsviluppata intorno allo stabili-mento, mantiene la strutturadel vecchio centro abitato dallefamiglie dei lavoratori, impie-gati ed operai.
Le strade, larghe ed alberate,portano al palazzo comunale,alla chiesa parrocchiale delXVIII secolo, alla scuola ele-mentare e all’asilo Resi Mari-notti donati al Comune dal pre-sidente della SAICI SNIA.
La giornata, bellissima e ven-tilata, ha permesso di apprezza-re le bellezze naturali di questoterritorio della “bassa friulana”che, con i suoi pioppi e la sua ri-gogliosa campagna, conservaancora il fascino quasi virgilia-no degli antichi canneti.
Fiammetta Piaia
Periodico di informazione culturale
Anno VI, N. 1 - Luglio 2007
Direttore responsabileDavide Vicedomini
Direttore editorialeElettra Patti
Comitato di redazioneDaniele Picierno, Andrea Purinan
Direzione e redazioneAssociazione “Gli Stelliniani”
Ginnasio Liceo “Jacopo Stellini”Piazza I Maggio, 26 - 33100 Udine
Consiglio direttivoPresidente onorario: Lino Comand
Presidente: Andrea BergnachVice Presidente: Daniele Picierno
Segretaria: Elettra Patti
Consiglieri: Anna Maria GerminiEttore Giulio Barba, Gaetano Cola
Gabriele Damiani Pier Eliseo De Luca
Bruno Londero, Andrea PurinanFederico Vicario, Francesco Zorgno
Collegio ProbiviriPaolo Alberto Amodio
Maria Lessana, Marco Marpillero
Collegio Revisori dei ContiGino Colla, Giacomo Patti
Luciano Provini
Stampa e spedizioneCartostampa Chiandetti
Reana del Rojale
Iscrizione al Tribunale di UdineN° 27/2000 del 30/11/2000
degli Stelliniani
Due percorsi storici
I gentili canneti di TorviscosaALBUM DI FAMIGLIA
Ambra Tocco, la nipotina del prof. DanielePicierno nata il 21 gennaio 2007.
Francesca Cecchini fotografata con alcuniamici - 24 aprile 2007.
Gaia Pezzetta, la nipotina dell'avv. GabrieleDamiani nata il 3 maggio 2007.
L'avv. Heidi Biffoni con la primogenita Matildee la piccola Martina nata il 6 febbraio 2007.
La seconda laurea dell'ing. Francesco Zor-gno, qui con la moglie ing. Daniela e i figliAnastasia e Filippo. 4 aprile 2007.
Lidia Forcini - 5 luglio 2007.
Teresa Terranova - 13 febbraio 2007.
Quest’anno si è volutodare alla giornata riser-vata dagli Stelliniani al-
la visita della mostra di Illegio(il 3 giugno) una pienezzamaggiore, approfittandone,prima dell’immersione nellevisioni inquietanti dell’Apoca-lisse, per conoscere due altricentri storico-culturali dell’Al-to Friuli, quali Iulium Carni-cum e l’abbazia di Moggio.
Proprio da questa localitàdel Canal del Ferro è iniziata lavisita del nutrito manipolo diStelliniani, come sempre adu-natosi al richiamo suadentedella prof. Patti per una nuova“avventura”. Ha fatto da gui-da il prof. Stefano Perini, cheha illustrato gli aspetti storicied architettonici dell’abbazia.Essa nacque all’inizio del XII
Panorama di Moggio Udinese.
Gli scavi di Iulium Carnicum.
secolo, grazie ad un ricco lasci-to di terre fatto in precedenzadal nobile tedesco Cacelino,che aveva voluto fosse costrui-to un monastero “pro remedioanimae suae”. Il patriarca Vo-dolrico, che era stato abate del-la grande abbazia di S. Gallonell’attuale Svizzera, favorì ladedicazione della nuova crea-zione a quel santo e lo stabilir-si in essa dei Benedettini. Il ce-nobio potè prosperare con fa-cilità grazie ai vasti possessifondiari ad esso appartenenti,i privilegi e le giurisdizioni chegli spettavano, la posizionestrategica sulla via per la Ger-mania. Furono secoli di gran-dezza, poi la decadenza conl’arrivo di Venezia, fino allasoppressione avvenuta nel1773. Oggi di tanto splendore
qualcosa resta, tra l’altro benrestaurato dopo il terremotodel 1976, anzi richiamato anuova vita dallo stabilirsi nelrinnovato chiostro di suoreclarisse francescane. La chiesaattuale, su disegno dell’udine-se Luca Andrioli, è settecente-sca, voluta dall’abate com-mendatario Daniele Delfino(un famoso abate commenda-tario era stato pure Carlo Bor-romeo), mentre il chiostro ri-calca linee cinquecentesche. Difronte alla chiesa ed a lato del-la vecchia torre, forse resto diantiche fortificazioni, i restauripost-terremoto hanno fattosorgere un edificio di lineemoderne, ove è allocata la bi-blioteca del monastero, concirca 4000 volumi, alcuni mol-to antichi. L’archivio e diversimanoscritti sono conservati,comunque, presso l’ArchivioPatriarcale di Udine, mentrealtri pezzi interessanti prove-nienti dall’abbazia, sono sparsiin ulteriori biblioteche, tra cuila Blodeian Library di Oxford.
Lasciata l’altura di Moggio,il gruppo ha preso la via di unaltro percorso storico di note-vole importanza, quello checonduce al passo di MonteCroce Carnico, battuto fin daitempi antichi e particolarmen-te apprezzato dai romani percollegarsi al Norico. Per que-sto, qui, su di un precedenteinsediamento carnico, essi fon-
darono nel I secolo a.C. IuliumCarnicum, divenuto poi muni-cipio ed infine colonia. Nonpossiede certo lo splendore ela ricchezza di Aquileia, ma èinteressante per conoscere losviluppo di un centro ammini-strativo-commerciale periferi-co, con la sua vita semplice,ma comunque bene organizza-ta. Ancora il prof. Perini ha ri-percorso le vicende della loca-lità, presentando il foro, ovesono ben evidenti tutti gli ele-menti della sua vita, simili aquelli di ogni altra città roma-na: il tempio, la basilica civile,i portici per le contrattazioni...Resta ancora molto da scavare,ma la difficoltà sta nel fatto chele antiche abitazioni si trovanosotto l’attuale abitato di Zu-
glio, per cui solo lavori di ri-strutturazione permettono diaggiungere nuovi tasselli almosaico di Iulium Carnicum.Tra l’altro è emersa una basili-ca paleo-cristiana, da cui lanuova religione si diffuse intutta la Carnia. Sopra l’abitatotroneggia l’erede di quella tra-dizione, la pieve di San Pietro,ove la domenica precedente siera svolta la cerimonia del ba-cio delle croci.
Ormai, però, per usare paro-le carducciane di Carnia, “bril-lando su gli abeti il mezzodì” equalcosa di più, altre esigenzeurgevano, per cui ci si avviòverso il desinare di Illegio.
K.u.K
Da Moggio a Zuglio
Torviscosa fine anni ’30. Le canne sono diventate una distesa imponente. Sullo sfondo sta crescendo la fabbrica dove vengono lavorate.
LA VOCE4_07:LA VOCE 3_06 24-08-2007 9:48 Pagina 8