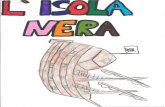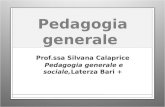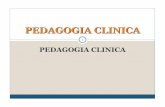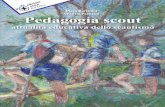Pedagogia Nera
-
Upload
luciano-celalba -
Category
Documents
-
view
407 -
download
15
description
Transcript of Pedagogia Nera
-
1
Introduzione
Pedagogia nera un termine che Alice Miller, circa ventanni fa, nel
libro La persecuzione del bambino. Le radici della violenza, riprende dal testo
Schwarze Pdagogik (Rutschky K., a cura di, 1977), il quale raccoglie una
serie di scritti di pedagogisti, per lo pi di area germanica, della fine del
Seicento fino a tempi pi recenti, nei quali sono descritti metodi di
condizionamento precoce del soggetto in generale, in particolare del bambino,
volti a non accorgersi di quanto ci stia realmente capitando (Miller, 95,
p. 10).
Essa ci parla di pedagogia nera intendendo con tale termine un
atteggiamento molto complesso e articolato sostenuto teoricamente da autori
pedagogici, e praticato e diffuso in tutti gli strati sociali, specie nei secoli
appena trascorsi, ma ancora presente di fatto al fondo di certe concezioni e
pratiche attuali (Riva, 93, p. 80).
La Miller accosta discorso educativo e psicoanalisi, arrivando a rigettarne
completamente le valenze. In sostanza, essa afferma che ognuno esercita, dal
punto di vista educativo, una strategia di potere che, ove il bambino non
disponga di una costante persona di riferimento sufficientemente buona, in
senso winnicottiano, pu uccidere la sua anima.
-
2
E a questo punto che possiamo far intervenire le analisi di Michel
Foucault, che ci aiutano a mettere in luce, da un punto di vista critico, i
meccanismi in atto nelle tecniche di condizionamento e manipolazione
proprie della pedagogia nera. Questo perch, nonostante Foucault non si sia
mai direttamente occupato di educazione o di scuola, anche noi vediamo nella
sua opera una grande rilevanza pedagogica esplicita e diretta, come
sostiene Riccardo Massa (in Mariani A., 97). Sia Foucault che Massa vanno
molto pi in l dellanalisi delleducare bene o male. Diventa necessario
vedere per culture o subculture quali sono le tattiche che vengono esercitate.
Occorre essere consapevoli che la forma concreta che queste strategie
assumono sono le cosiddette tecnologie del potere. Ed proprio a proposito di
questa consapevolezza che Massa (1997) parla di crisi della pedagogia,
delleducazione e del tramonto delleducazione, perch, secondo lo studioso,
siamo arrivati a questo per il fastidio della societ contemporanea a prendere
atto della realt di questo esercizio del potere. Attraverso le modalit che
utilizziamo per esercitare il potere, noi mettiamo in atto il dispositivo.1
Questultimo un termine introdotto da Foucault e teorizzato per la prima
volta in pedagogia da Massa, anche se oggi usato disinvoltamente in ambito
normativo e istituzionale, mentre, ci ricorda il filosofo delleducazione,
dovrebbe evocare il sistema incorporeo delle procedure in atto
nellistituzione scolastica e in qualunque situazione educativa (ivi, p. 130).
Questo studio propone un excursus sulla pedagogia moderna e
contemporanea, senza pretese di esaustivit, a partire dalle analisi del potere,
colte attraverso la suggestione dellopera foucaultiana e una disamina critico-
pedagogica della stessa, fino alle dinamiche dellabuso educativo, soprattutto
1 per una maggiore chiarificazione del concetto di dispositivo si veda: Foucault, 1976, Massa, 1997, Riva, 2000.
-
3
psicologico, con riferimento alle pratiche educative in atto nella famiglia
contemporanea.
Il presente lavoro intende pertanto rintracciare lo sfondo ideologico e
culturale che ha presieduto alla declinazione di unintenzionalit educativa in
senso autoritario ed espropriante, mettendo in evidenza come tali
caratteristiche continuino, a nostro parere, a improntare di s i modelli
formativi della societ tardocapitalistica. I cinque capitoli di cui si compone la
ricerca fanno riferimento a due grandi aree, la cui contiguit comunque
ineludibile: i primi quattro indagano la relazione tra discorso pedagogico e
strategie del potere, mentre lultimo si propone di illustrare la permanenza di
ci che viene definita pedagogia nera allinterno dei modelli educativi
odierni. Il primo capitolo getta uno sguardo critico sul dibattito culturale
relativo alla forza pervasiva delle ideologie, inteso a smascherare le collusioni
della pedagogia con il sistema di idee dominante. Il secondo capitolo esamina
lambiguit del rapporto tra pedagogia e psicoanalisi, che accusa leducazione
di dar corpo alla repressione degli istinti e delle pulsioni dellindividuo,
causandone la nevrosi. Il terzo capitolo dedicato alle analisi di Foucault
sulla metamorfosi delle strategie messe in atto dal potere per la costituzione
e il condizionamento del soggetto, mentre il quarto ne evidenzia le ricadute
sulla dimensione pedagogica. Lultimo capitolo si propone di mettere in luce
come lesercizio del potere, inscritto nel processo formativo, sia allorigine di
quel fenomeno preoccupante che labuso educativo. Si cerca, inoltre, di
rendere conto dellambiguit presente in determinate concezioni
psicoanalitiche, concentrando lattenzione su alcune controversie teoriche
significative per quanto riguarda la questione dellabuso. Successivamente, si
prendono in considerazione alcune tra le tante forme possibili di abuso
-
4
psicologico ed emotivo, sottolineandone la dimensione interattiva
transgenerazionale.
Resta il rimpianto di non essersi potuti occupare dell alterit negata del
femminile e del suo difficile travaglio verso il pensiero della differenza. In
ogni caso, pur facendo nostre le parole di Adriana Cavarero
lUomo non solo mostruoso in quanto astratto nome universale che fagocita lunicit di ogni essere umano, ma mostruoso anche per la sua pretesa di includere al contempo le donne, pur nominandosi al maschile. Detto altrimenti, lUomo contemporaneamente lintera specie umana e uno dei suoi generi. E neutro e maschile. E tutte due, nessuno dei due e uno dei due (Cavarero, 97, p. 67),
crediamo utile non appesantire i termini del discorso sottolineando con il
doppio esito della vocale o con una terminologia sessualmente differenziata
(se non l ove questo sia indispensabile per la comprensione del testo), una
duplicit di genere che, anche nel lettore, presumiamo acquisita.
Attraverso la morte di Dio, quella delluomo e della famiglia, la
crisi della scuola, la fine della pedagogia, il naufragio del Sessantotto e
altre sparizioni annunciate, questo lavoro intende collocarsi nel solco di
coloro che, disponendosi a discernere il rumore sordo e prolungato della
battaglia (Foucault, 76), attendono che la pedagogia, scrollandosi di dosso il
pesante fardello dei condizionamenti sociodominanti, faccia proprie le armi di
uneducazione alla resistenza, responsabile, critica sempre e sempre
autocritica, dotata di un solido impianto epistemologico e teorico, capace di
mantenere viva limmagine del pensiero utopico e di contrastare lidea del
dominio delluomo sulluomo.
Riteniamo doveroso segnalare che, l dove questa ricerca stata condotta
attraverso lanalisi di opere di autori stranieri, ci si serviti di traduzioni
italiane, come risulta dalla bibliografia, senza quindi la pretesa di compiere un
lavoro filologico che, daltra parte, esula dal nostro lavoro.