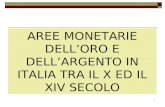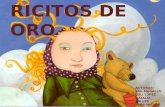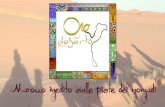Oro
-
Upload
turismo-caltagirone -
Category
Documents
-
view
217 -
download
3
description
Transcript of Oro

Sicilia Preziosa
Roberta Malandrino, Elèna Privitera, Daniela A. Tosto
SICILIA PREZIOSA
(1)

Sicilia Preziosa
La civiLtà deLL’oro in SiciLia Apporto delle religioni:
a) Dalla Phiale d’oro di Caltavuturo alla Sfera d’oro dei Padri Filippini all’Olivella;
Apporto della nobiltà e della borghesia: b) Oreficeria di Trapani e l a lavorazione del corallo.
REGIONE SICILIA Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione professionale
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione professionale
EURO.IN.FOR.MA. Associazione culturale Progetto “Formazione per il Territorio” ID N°742
Corso “Addetti all’Organizzazione e Gestione del Turismo Culturale”
cofinanziato dal Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Siciliana
Asse II Occupabilità Obiettivo specifico D Avviso 20/2011
1

Sicilia Preziosa
Indice
Introduzione 4
Parte Prima
Capitolo I. Cenni storici - Paragrafo 1. Testimonianze e gemme 6 - Paragrafo 2. Epoca antica 7 - Paragrafo 3. L’Epoca medievale e Tardo Medioevo 9 - Paragrafo 4. Il Rinascimento 12 - Paragrafo 5. L’Età Moderna 13 - Paragrafo 6. Il Manierismo 14 - Paragrafo 7. Il periodo Barocco e Rococò 15 - Paragrafo 8. L’Età dei Lumi 17 - Paragrafo 9. Il XIX secolo 18 - Paragrafo 10. Dopo l’Unità d’Italia 20 - Paragrafo 11. Il XX secolo: l’Art Déco e Art Nouveau 20
Capitolo II. Le tecniche di lavorazione dei metalli pregiati
- Paragrafo 1. L’oreficeria 26 - Paragrafo 2. La lavorazione dell’oro 27 - Paragrafo 3. La lavorazione dell’argento 28
Capitolo III. Un simbolo di sicilianità: il corallo - Paragrafo 1. La storia 31 - Paragrafo 2. La lavorazione 34 - Paragrafo 3. Gioia dei ricchi, dolore del mare 35
Parte Seconda
Capitolo I. Catania
2

Sicilia Preziosa
- Paragrafo 1. Museo Diocesano 37 - Paragrafo 2. Museo della Basilica di San Sebastiano di Acireale 39
Capitolo II. Caltanissetta
- Paragrafo 1. Museo Diocesano 39
Capitolo III. Messina - Paragrafo 1. Il Museo dell’Opera del Duomo 40 - Paragrafo 2. Museo Archeologico di Taormina 43
Capitolo IV. Trapani - Paragrafo 1. Tesoro della Madonna presso il Museo Pepoli 44
Capitolo V. Palermo
- Paragrafo 1. Il Museo della Cattedrale 46 - Paragrafo 2. Himera: il caso della Phiale Aurea di Caltavuturo 46 - Paragrafo 3. La Sfera d’Oro dei Padri Filippini 49 - Paragrafo 4. Museo del Duomo di Monreale 50
Note al testo 52 Note alle immagini 53
Bibliografia 57
Sitografia 59
3

Sicilia Preziosa
Introduzione
«Addentrarsi nel mondo delle arti decorative siciliane vuol dire ricercare maestri spesso dimenticati che hanno talora prodotto veri capolavori d’arte, vuol dire individuare
personalità di committenti colti e illuminati, nobili, alti prelati, che ne hanno indirizzato il fare, vuol dire riscoprire messaggi simbolici di un passato quasi assopito nel tempo, vuol
dire immergersi in uno scintillio di gemme, ori, argenti, coralli, avori, madreperle, tartarughe, cristalli di rocca, legni, marmi, pietre dure, preziose stoffe operate, variegati
ricami di sontuose sete, che in Sicilia hanno tutte come comune denominatore, al di là del tempo, degli stili e delle mode, una tendenza alla forte policromia, una luminosità che si lega
indissolubilmente alla solarità della sua Terra. Emerge l’attività poliedrica, talora fin qui ignorata, di maestranze diverse, impegnate ad esprimere la loro creatività in tutte i
principali centri dell’Isola»1.
La Sicilia si distingue per la straordinaria varietà e ricchezza delle arti decorative e tra esse, l’oreficeria vanta una propria identità: in primo luogo per l’ampia gamma di materie prime da poter utilizzare (per le quali sono emerse molte testimonianze archeologiche, soprattutto per le epoche antiche), in secondo luogo per la qualità della committenza che, come riporta il passo sopra citato, è stata prevalentemente religiosa, infine – ma non per ultime – le numerose e qualificate maestranze che operavano sul territorio.
Una storia dell’oreficeria siciliana viene a delinearsi, sin dagli anni Trenta del Novecento, con gli studi della storica dell'arte Maria Accascina2 e l'argomento presenta ormai una caratterizzazione storiografica sempre più chiara ed omogenea nella lettura del percorso artistico attraverso i secoli. A partire dal 1986, alcune iniziative organizzate dalla Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo, dall’Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali, dalla Direzione del Museo Regionale “A. Pepoli” di Trapani sono state rivolte alla realizzazione di mostre, pubblicazioni monografiche e studi sui principali tesori dell’Isola raccolti nei secoli: si tratta di preziosi gioielli, spesso realizzati come ex-voto e donati ai molteplici musei e fondazioni che hanno consentito la conoscenza e la divulgazione di tale specifico settore delle arti decorative di Sicilia. Ivi sono presenti, sparsi nel territorio e raggruppati per tipologia e/o collezioni, numerosi gioielli il cui valore inestimabile è tanto storico quanto artistico.
4

Sicilia Preziosa
Le arti decorative costituiscono parte del nostro passato, ormai trascorso ma tuttavia rivissuto nei “luoghi dell’Arte” – i musei, i tesori, le collezioni – dando avvio ad ambiti di ricerca ricchi e significativi della storia dell’arte. Per giungere a ciò, è necessario abbandonare la consueta distinzione tra “arti minori” e “arti decorative”. Esse, infatti, abbracciano ampi orizzonti di tecniche, materiali, committenze e soprattutto maestranze; queste ultime hanno intessuto concretamente la storia, rimanendo delle volte nell’anonimato, ma divenendo autori di stili e quindi testimoni della loro arte. Il patrimonio delle arti decorative siciliane è prezioso perché, in primis, dà prova dei materiali utilizzati, delle tecniche, delle committenze, delle maestranze ma anche per la loro sopravvivenza nel tempo, quindi vincendo la prova distruttiva di furti, fusioni, vendite, guerre e dispersioni.
Gli importanti studi svolti nel settore, dunque, ne hanno permesso la riscoperta, la valutazione e la fruizione grazie ad un continuo processo dialettico creatosi tra i centri maggiori dell’Isola (Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta, Trapani, etc) e le città minori, facendo in modo che venissero alla luce vicende ed episodi circa le singole botteghe orafe, sulle aree di produzione e le diverse committenze: si è così delineata una storia dell’oreficeria siciliana che presenta adesso una caratterizzazione sempre più chiara ed omogenea.
È importante ricordare la valenza rivestita dalla pratica della devozione verso i maggiori simulacri di Sicilia nell’ambito della cristianità: i più grandi repertori di gioielli sono sopravvissuti all’interno dei tesori dei santuari dell’Isola come gli ex voto, donati dai fedeli alla Madonna e ai Santi per grazia ricevuta o per richiederne benefici. La loro presenza permette di comprendere come questi gioielli non fossero soltanto ornamenti ma bensì rivestissero un significato apotropaico, simboli di desideri e speranze di ottenere, privandosene, un’intercessione divina seconda l’antica pratica risalente fina dalle origini dell’uomo del “do ut des”.
In Sicilia è da notare che la fruibilità effettiva di talune opere non è sempre immediata: spesso gli oggetti d’arte sono custoditi in depositi non accessibili al pubblico o comunque si tratta di strutture non adatte alle nuove normative di sicurezza; i luoghi definiti accessibili risultano, invece, difficili da raggiungere per le deficienze del sistema di trasporto isolani o carenti delle strutture d’accoglienza, d’accessibilità e didattiche.
5

Sicilia Preziosa
Parte Prima
CAPITOLO i
CENNI STORICI
«Il gioiello è spesso un simbolo, un segno distintivo, un mezzo di comunicazione. Tale simbologia è legata talora alla gemma o alle diverse pietre preziose che lo compongono,
talaltra alla tipologia in cui rientra e molte volte ad entrambe le cose. Così il gioiello diviene ora emblema di una determinata cerchia di persone, ora amuleto, strumento contro le forze
malefiche sia di natura spirituale che fisica»3.
Paragrafo 1. Testimonianze e gemme Le maggiori testimonianze relative
all’oreficeria appartengono al XVII secolo, tuttavia anche per gli esemplari più antichi – appartenenti ai secolo XV e XVI – non si può prescindere dal raffronto con la coeva produzione spagnola. Difatti, la Spagna, che dominava la Sicilia, era in quel periodo annoverata tra le potenze europee per cui le tendenze e le mode che si diffondevano all’interno della patria madrilena presto cominciavano a circolare nel bacino mediterraneo. Sull’Isola, i committenti spagnoli e filo-spagnoli sollecitavano gli argentieri e gli orafi ad imitare i prodotti spagnoli, se non piuttosto si rivolgevano direttamente ad artisti iberici.
Le testimonianze di gioielli datati XV e XVI secolo di fattura isolana sono molto rare, ciò nonostante se ne possono desumere le caratteristiche dalle opere d’arte pittorica (ad esempio quelle di
Antonello Da Messina) o dalle descrizioni presenti in taluni inventari di beni dotali del periodo. In Sicilia circolavano gioielli ornati e smaltati, la cui tradizione aveva radici lontane nel tempo: infatti, si tratta della tradizione normanna perdurata nei secoli che tuttavia non mancò di incrementare le tecniche e le metodologie. Per lo studioso Lanza di Scalea, inoltre, a ricordare le forme ed i decori dei preziosi siciliani vi sono anche alcune miniature che, seppur non attestano la veridicità della produzione orafa locale, danno sicuramente prova della circolazione di una cultura internazionale. Allo stesso modo, in alcune opere pittoriche (si pensi al Trionfo della morte presso il Palazzo Scalfani) si rinvengono testimonianze degli stili impiegati nella produzione orafa la cui ispirazione o modelli erano decisamente di provenienza internazionale.
6

Sicilia Preziosa
Emerge frattanto la
credenza delle virtù delle gemme, assai radicata nel tempo e già conosciuta tra i grandi personaggi della storia: Plinio, Vitruvio, Federico II, etc. La perla, ad esempio, oltre ad essere un dono per le spose, sia nell’oreficeria sacra che in quella profana, aveva un forte significato simbolico di purezza ed era pertanto adoperata come ornamento per la Vergine; il diamante, pietra angolare, è simbolo di Cristo; il corallo, già carico del potere apotropaico, è simbolo del sangue di Cristo; il rubino, associato nella cultura pagana al fuoco di Marte e del Sole, tenendo lontana la lussuria, diviene nella cultura cristiana simbolo della parola di Dio che illumina; lo zaffiro è portatore di pace e concordia; lo smeraldo, infine, è considerato il migliore degli amuleti. Noto era, altresì, il valore esoterico di altri materiali – come ad esempio il cristallo di rocca – i quali hanno poi assunto significati differenti in ambito religioso: il corallo, da sangue pietrificato della medusa a sangue
salvifico di Cristo. Veniva attribuito inoltre valore terapeutico non soltanto a determinate pietre e minerali ma bensì alle forme che a queste
venivano date con la lavorazione: campanellini, sonagli, animali fantastici e monili vari. Questi oggetti, la cui origine era apertamente pagana e profana, successivamente si riscontrano anche in ambito religioso. Una grande produzione di tali monili si registra tra il XVI e XVII secolo, allorquando numerose sono le donazioni fatte dai nobili – persino re e viceré – commissionati ad artigiani locali. Difatti, già in epoca normanna, la Sicilia e nella fattispecie la capitale Palermo vantava una illustre tradizione di manufatti smaltati e arricchiti da gemme. A consentire la vasta circolazione di oggetti così preziosi, che soddisfacevano pertanto le nobildonne siciliane delle varie epoche, erano indubbiamente le legiferazioni dei sovrani in materia.
Paragrafo 2. Epoca antica L’estrema rarità dei metalli preziosi ha comportato nel tempo un riutilizzo degli
oggetti eseguiti in tempi remoti i quali venivano fusi per nuove creazioni, e le poche testimonianze sopravvissute fino a
(2)
7

Sicilia Preziosa
noi interessano per lo più esemplari rinvenuti nei corredi funebri. È il caso delle opere di oreficeria provenienti dalla Mesopotamia e dall’Antico Egitto, la cui arte orafa è documentata dai reperti provenienti dalle necropoli e dalle tombe reali. Diverso il discorso per l’Antica Grecia, per la quale non ci sono pervenuti moltissimi esemplari soprattutto per la difficoltà di reperire la materia prima – almeno fino
all’Età Ellenistica – durante la quale l’espansione verso Oriente favorì l’arrivo di grandi quantità d’oro e la realizzazione di molti e vari oggetti artistici. Più numerose,
invece, le testimonianze di oreficeria etrusca, della quale meritano menzione gli oggetti realizzati con il metodo della granulazione, e quella romana, soprattutto di Età Imperiale.
L’età greca ed ellenistica,
nell’ambito dell’oreficeria, sembra aver conquistato maggiore raffinatezza nonché tecnica; si tratta di manufatti realizzati
con grande maestria e due erano le tecniche principali: la lavorazione “a filigrana” e quella “a granulazione”. Il ruolo del gioiello assume una valenza sociale, in quanto rispecchiava lo status.
I Romani non fecero un uso
regolare dell’oreficeria, poiché durante l’Età Repubblicana alcune norme ne vietavano l’uso indiscriminato a tutte le classi sociali e quindi il suo apporto cominciò più tardi. Successivamente, però, l’inevitabile diffusione della moda sollecitò delle critiche, nella fattispecie da
parte di taluni autori latini che disapprovano il lusso poiché discordante con l’austerità degli avi.
(3)
(4)
(5)
(6)
8

Sicilia Preziosa
I gioielli elaborati e vistosi realizzati con pietre dure, lisce o incise, con cammei o infine paste vitree montate su alti castoni, erano frequenti all’interno delle classi medio-alte mentre, le classi meno abbienti, si rifugiavano in una produzione più modesta che imitava la produzione costosa ed esclusiva.
Emblema di questo periodo furono gli anelli a sigillo, in possesso di quanti svolgessero attività pubblico-amministrativa o fossero imperatori. Tra il genere anelli, vi furono quelli le cui gemme incise proponevano vari temi iconografici: divinità pagane e figure mitologiche. Si annovera anche la cosiddetta collana da busto, una lunga catena indossata sul petto e fatta poi ricadere sui fianchi. Inoltre, si riscontrano corone e diademi in foglia d’oro, elaborati
orecchini e pendenti ad eroti. Non mancano i monili legati al potere apotropaico come anelli, laminette d’oro sbalzate o castoni incisi che svolgevano una funzione protettrice sia dagli spiriti che dai vivi. Con l’affermarsi del Cristianesimo, invece, vengono sempre più privilegiate le raffigurazioni di immagini e simboli appartenenti alla nuova religione: sigilli, anelli, ninnoli, collane, fibbie, gemme incise, lamine auree riportano scene evangeliche.
Paragrafo 3. L’Epoca medievale e Tardo Medioevo
La Sicilia ha subìto perdite ed espoliazioni di notevole entità dei tesori appartenuti alle famiglie nobili e agli
ordini religiosi. Ciò nonostante, il complesso delle opere preziose ancora conservate dà prova delle scelte della committenza isolana: essa risulta legata al capoluogo e alle locali botteghe orafe, tra
(7) (8)
(9)
9

Sicilia Preziosa
l’altro annoverate tra le più prestigiose. A Palermo, la toponomastica riporta ancora oggi – serbando memoria dell'importanza di esse – i nomi di alcune strade del centro storico, quali Via Dell'Oro, Via degli Argentieri, etc; il quartiere degli orafi era attestato, infatti, nel Mandamento sud-orientale dei Quattro Canti, tra le attuali Via Roma e Corso Vittorio Emanuele, verso la Marina. Le testimonianze ascrivibili a questo contesto sono per lo più di epoca medievale; difatti, l’Isola è stata per molti secoli costituita in prevalenza da centri feudali e la congiunzione tra la circolazione di una aristocrazia guerriera di varia provenienza e le fondazioni monastiche ha determinato la presenza anche di opere forestiere. Dalle
Costituzioni Melfitane del 1231 di Federico II di Svevia apprendiamo che, ad ogni modo, sin dal XIII secolo, operarono a Trapani orafi e argentieri ma si dovrà aspettare il XV secolo per parlare di una vera e propria classe di maestranze. Tra le conseguenze della politica estera di Federico si riscontra l’influenza, per i maestri orafi isolani, dell’arte appresa dagli ebrei e quindi l’impiego del corallo per la realizzazione dei manufatti. Inevitabile fu anche l’influenza della Scuola Italiana, per cui ben presto gli orafi siciliani si avvalsero di un proprio marchio: la scritta DUI, ovverosia Drepranum Urbs Invictissima, sormontata da una falce e da una corona.
Tuttavia, questi artisti rimasero ancora per molto tempo nell’anonimato ma, gelosi della loro arte, pretesero il controllo da parte della magistratura
cittadina per il loro lavoro; tra le richieste vi fu l’esclusiva sulla fusione dei metalli preziosi (oro e argento). Ciò permise che agli artigiani locali venisse autorizzata,
(10)
10

Sicilia Preziosa
quali tecniche caratteristiche, la fusione e lavorazione a freddo. La prima prevedeva la realizzazione di un prototipo in legno di bosso, o in alternativa in cera, che veniva successivamente rivestito con terra da fonderia; infine, vi versavano il metallo fuso. La seconda prevedeva, invece, la modellatura dei lamierini per mezzo di stampi in piombo e martelletti; in alternativa, venivano adoperate le presse. In entrambi i casi, si ultimava la rifinitura tramite cesellatura, incisioni, zigrinatura, brunatura, lucidatura, etc servendosi di bulini, punteruoli e resine. Nella fattispecie gli artigiani, che dapprima lavoravano presso conventi e corti, cominciarono adesso a riversarsi nelle città ormai sempre più vocate al commercio. Questo cambiamento sociale
portò alla formazione delle corporazioni di lavoro, tra le quali – nelle città italiane – quella degli artigiani cominciò a partecipare attivamente alla vita politica (XIII sec.). «Le prime notizie sull’esistenza di una corporazione di orafi ci vengono da Parigi, dove gli statuti del Corpus d’orfèvrerie situato sul grande ponte sulla Senna risalgono all’anno 1260»4. Tra i committenti tradizionalmente riscontrabili – principi e Chiesa – si aggiunsero, in epoca tardo medievale, anche la borghesia (la quale cominciava a divenire sempre più opulenta), le amministrazioni comunali e le confraternite. La novità nell’oreficeria del periodo fu l’impiego del diamante, mentre – per importanza – assumeva un ruolo da protagonista il rubino seguito dallo zaffiro.
L’esigenza dei sovrani di battere moneta riduceva, però, la possibilità di fare largo uso dei materiali preziosi; ciò nonostante, e soprattutto in ambito non
religioso, accanto alla cosiddetta “camera del tesoro” (ovverossia l’insieme di oggetti di lusso unici) si diffuse la “stanza dell’argento” la quale conteneva per
(11)
11

Sicilia Preziosa
l’appunto l’argenteria da tavola. Venne altresì a delinearsi, sul finire di quest’epoca, l’appartenenza dell’artigiano orafo non più alla bassa categoria delle artes meccanicae ma ad una più elevata categoria capace di valorizzare la creatività dell’individuo e quindi ammirarne l’artista. La trasformazione
sociale, alla fine dell’Età medievale, mantenne pressoché invariate le tecniche di lavorazione ma cambiò la tipologia delle opere commissionate: ci si rivolse all’esecuzione di arredi preziosi in onore del Santo Patrono o comunque per impreziosire il culto liturgico.
Paragrafo 4. Il Rinascimento
Gli emblemi dell’Epoca rinascimentale sono le coppe ed i calici, tra i quali si annovera la coppa nuziale (lavorata come un doppio bicchiere dai bordi raccordati e abbelliti). Inoltre, era in uso – per i nuovi adepti che entravano a fare parte di un ordine religioso o corporazione – regalare boccali d’argento che, per le decorazioni, ricordavano le professioni. La coppa d’argento era anche usata come premio durante le gare di tiro con l’arco; per la lavorazione di questi bicchieri si riscontra un registro assai ricco di immagini e raffigurazioni.
(12)
(13) (14)
12

Sicilia Preziosa
La lista degli esemplari appartenenti al genere “madonita” è davvero lunga. Il cardo spinato simboleggia la passione di Gesù, in particolar modo la corona di spine che gli cinse il capo; difatti, la presenza di tale decoro risulta assai pertinente nei calici considerati per eccellenza i custodi sacri del Sangue di Cristo. Purtroppo molte di queste testimonianze, inseguito allo scioglimento delle corporazioni e degli ordini religiosi, sono andate perdute.
Paragrafo 5. L’Età Moderna Alcuni membri delle maggiori famiglie nobili siciliane (Branciforti, Trabia, Moncada,
Galletti, etc), durante il periodo viceregio, rivestivano importanti cariche pubbliche presso la capitale Palermo. Tuttavia, era in auge possedere residenze disseminate un po’ su tutta l’Isola seguendo i confini degli antichi domini feudali. I continui spostamenti avevano anche una
Una costante, invece, della produzione orafa siciliana è rappresentata dai calici chiamati “madoniti” dalla studiosa Maria Accascina. Essi risultano particolarmente diffusi tra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI – soprattutto nell’area Occidentale e delle Madonie – e presentano tutti la stessa cifra stilistica: le foglie di cardo. Si tratta di calici con basamento polilobato (o stellato) su cui poggia un alto fregio, raccordato da una struttura nodosa dalla quale si apre la corolla del boccale.
Le foglie di cardo danno prova della grande diffusione di oggetti provenienti dal continente sull’Isola attraverso i traffici commerciali; è un decoro, difatti, riscontrato anche nei modelli barcellonesi e pisani. Su questi calici è frequente riscontrare gli stemmi delle famiglie committenti; si pensi al calice, di matrice palermitana, conservato presso i Musei Vaticani che reca lo stemma del suo committente, Fra Giovanni Francesco La Motta ambasciatore a Roma del Gran Maestro di Malta e milite in armi nel 1565.
(15)
(16)
13

Sicilia Preziosa
valenza, per così, politica: permettevano a queste nobili famiglie di intessere – tramite momenti mondani, inviti, manifestazioni religiose di Paese, etc – nuovi rapporti o mantenerne di vecchi. Erano pertanto costretti ad arredare ed impreziosire le diverse dimore, occupate periodicamente durante l’anno, nonostante la prassi di traslocare di volta in volta con numerosissimi bauli contenenti ninnoli, utensili, effetti personali nonché l’ampia schiera di aiuti e servitori. Per quel che concerne gli oggetti di lusso, «essi si servivano degli stessi argentieri anche nella dotazione di arredi preziosi delle Chiese dei loro Stati e spesso fungevano da tramite per l’affermazione dei centri minori dei loro orafi preferiti»5. In questo periodo, gli aristocratici si rivolgevano principalmente alle maestranze palermitane, moderatamente a quelle messinesi, assai raramente ai centri di Catania e Trapani.
Paragrafo 6. Il Manierismo Verso la metà del XVI secolo, in
seguito agli esiti della Guerra dei Trent’anni, la Spagna aveva allargato i propri domini nei territori dell’America. Ebbe così modo di portare nel Vecchio Continente grandi quantità di ori, argenti e pietre preziose che avevano fatto della patria madrilena la terra più ricca del mondo. Le scoperte di questi giacimenti nordamericani crearono le condizioni affinché in Occidente si sviluppasse uno stile di oreficeria nuovo ed inevitabilmente opulento, che prese il nome – ponendosi anteticamente allo stile classico – di Manierismo (stile che tuttavia coinvolse tutte le arti). L’oreficeria divenne il simbolo della cultura delle Corti
europee, con uno stile tutto sommato omogeneo per l’influenza esercitata dalla Spagna; queste condizioni furono la base affinché emergesse il genio dell’artigiano e quindi esprimersi alla “maniera” dell’artista: le difficoltà della lavorazione venivano superate con maggiore facilità quanto maggiore era la bravura dell’orafo. Tuttavia, è complessa l’attribuzione dei manufatti agli artisti per la cospicua circolazione di opere, di artigiani, di mode e di materie.
Durante il secolo successivo (XVII sec.), in Italia, la produzione orafa non religiosa è alquanto scarsa; infatti, è solo attenzionando i tesori delle chiese che si ha testimonianza di oggetti preziosi di uso profano utilizzati per le messe solenni.
(17)
14

Sicilia Preziosa
Anche in Sicilia abbiamo una ricca produzione di oggetti liturgici quali piatti da credenza, acquamanili con bacili, casse per le reliquie dei santi provenienti da lasciti e donazioni caratterizzati da un tipico stile locale, espresso in ricche ed inventive decorazioni eseguite con magistrale tecnica. Gli orafi siciliani facevano altresì uso – insieme ai metalli preziosi, con i loro innumerevoli effetti –
di smalti coloratissimi, pietre e cristalli che donavano alle opere ulteriore lucentezza, cromie e riflessi incommensurabilmente belli. Inoltre, costituisce un genere particolare, la produzione di coperture in lastre d’argento cesellate e sbalzate, non di rado arricchite da pietre preziose e dorature, chiamate in gergo “mante”, le quali rivestivano le immagini sacre.
Paragrafo 7. Il periodo Barocco e Rococò In Italia non vi fu alcun punto di riferimento per quel che concerne l’arte Barocca, a
causa della situazione politica contingente (la Nazione era all’epoca formata da una compagine di Stati). Le regioni meridionali, nella fattispecie, erano ancora fortemente influenzate, artisticamente e stilisticamente, dalla produzione spagnola.
L’uso della tecnica della smaltatura si riscontra anche nella gioielleria che presenta
principalmente i fiori, ognuno con una specifica valenza: nell’iconografia religiosa il giglio simboleggia la purezza, la rosa la Venere, il tulipano la Grazia santificatrice.
Emblema dell’oreficeria siciliana del periodo Barocco è la corona, capace di riassumere tutte le tipologie ed i motivi decorativi dei gioielli smaltati: nastri, ghirlande, fiori, volute e una forte policromia. (18)
15

Sicilia Preziosa
Tra i maggiori esempi di gioielli modaioli di
matrice spagnola troviamo pendenti a tre catene e orecchini lunghi o a girandole; inoltre, si riscontra l’uso frequente della mezza luna d’oro smaltata con perline pendenti. Assai diffusa, poi, la filigrana (XVII secolo) d’oro e d’argento ornata di gemme preziose o elementi smaltati.
La cosiddetta “moda spagnola” tramontò con la conclusione della Guerra dei Trent’anni e pertanto, a imporre nuove mode, furono le Nazioni uscite politicamente ed economicamente rafforzate, registrando una maggiore circolazione di opere – nell’arte orafa – di carattere profano. Tuttavia, nei paesi in cui la
connotazione cattolica era ormai radicata – Spagna, Italia, Francia e Germania meridionale – gli oggetti sacri, quali crocifissi, candelabri, incensieri, reliquiari continuarono ad essere commissionati per arricchire le chiese ed i conventi. Inoltre, le dimensioni di tali artefatti, seguendo un po’ quelle che vennero ad affermarsi quali linee guida dello stile Barocco, accrebbero notevolmente. Per quanto riguarda, invece, la crescita dell’oreficeria non religiosa l’emblema di questo periodo fu l’argenteria da tavola riccamente lavorata e decorata. Purtroppo abbiamo pochi riscontri poiché, quando le casse dello Stato erano
vuote, l’oreficeria profana – che a differenza di quella sacra non veniva custodita e preservata all’interno delle “camere del tesoro” – veniva fusa per fornire la materia prima destinata alla monetazione. Le decorazioni riportavano i temi ornamentali di matrice umanistica: floreale-naturalistica, mitologia ed allegoria finanche scene bibliche.
Nel più vasto scenario europeo emerse il fenomeno, non registrato in Italia e nella fattispecie in Sicilia, del passaggio dall’oreficeria preziosa del pezzo unico di lusso all’introduzione dell’oreficeria d’insieme e non più di esposizione. Due elementi decorativi sembrano così prevalere: il tulipano e le foglie d’acanto.
(19)
(20)
(21)
16

Sicilia Preziosa
Man mano cominciò a riscontrarsi l’impiego di decorazioni sempre più leggere ed eleganti, che non di rado riuscivano ad intrecciarsi con linee e curve fino all'esasperazione ed esagerazione del linguaggio artistico. È così che ebbe inizio un nuovo periodo dell’oreficeria: il Rococò, il cui nome deriva dal motivo prediletto del momento ovvero la conchiglia. Questi aspetti culminarono nel XVIII secolo e si diffusero in tutta Europa. A sostituire quella che precedentemente era l’influenza spagnola, troviamo adesso quella francese; dopo Parigi, Augusta fu il maggiore centro per la lavorazione dell’argento e contava (nel 1740) ben 275 orafi. In questo periodo i gioielli assunsero forme più leggere nelle quali la montatura, quasi esclusivamente in argento, era praticamente invisibile per la abbondante presenza di gemme; tra esse, il diamante faceva da protagonista considerati i recenti ritrovamenti dei giacimenti brasiliani.
Paragrafo 8. L’Età dei Lumi L’arte orafa siciliana, nel
Settecento, fu un po’ tardiva poiché riflesso di quella napoletana e influenzata da quella spagnola. Ciò nonostante, si annovera un fiorire di maestranze altamente qualificate e dotate di raro virtuosismo; in pieno fervore artistico
erano, in quel periodo, le città di Trapani, Palermo, Messina, Catania e Siracusa.
Per questo periodo si riscontra un gran novero di nomi di artisti attivi sull’Isola. I ritrovamenti di argenterie nel messinese ci fanno conoscere Sebastiano e Filippo Juvara, Giuseppe d’Angelo, i Donia, i Martinez; ancora messinesi, ma che operarono perlopiù a Siracusa, furono
(22) (23)
17

Sicilia Preziosa
poi Francesco Tuccio e Giuseppe Aricò, Gianneri, i Chindemi e Decio Furnò. Nel periodo dell’Illuminismo, alla fine del
‘700 circa, si superarono le forme dei gioielli rococò volgendosi verso forme più semplici e sobrie.
Paragrafo 9. Il XIX secolo
In seguito all’avvento della Rivoluzione Francese, anche gli aspetti concernenti l’oreficeria subirono una notevole trasformazione e persero il carattere di esclusività. Difatti, l’affermazione del principio di uguaglianza investì finanche gli oggetti preziosi che furono adesso alla portata di tutti, annullando l’appartenenza cetuale; «[…] andò così incontro ad una vasta secolarizzazione, cioè si ebbe un decadimento del suo uso cerimoniale e pubblico»6. Veniva ad affermarsi una tendenza già riscontrata precedentemente, cioè il tramonto della forza collettiva che aveva spinto sino a quel momento le maestranze artigianali e gli orafi. L’oreficeria sembra quindi non esprimere
alcun istinto creativo né dell’artigiano né dell’artista, riproponendosi con i modelli storici; «l’ornamento – greco-romano, neo-romanico, neo-gotico, neo-rinascimentale o neo-barocco – era ricavato da stili precedenti: è quindi pesante, esteriore»7. Inoltre, la lavorazione dei metalli preziosi iniziò ad essere statalizzata, imponendo delle norme circa la purezza dei metalli nobili contenuta nelle leghe (l’argento, ad esempio, venne segnato a 800/1000) ed avviando la cosiddetta libera concorrenza. Nello scenario europeo, con le Guerre Napoleoniche, ad imporsi fu la moda ed il modello dell’oreficeria francese ed emblema di quella che venne chiamata la “moda dell’Impero” fu il cammeo.
(24)
18

Sicilia Preziosa
In seguito al ritorno dei Borboni, la severità del modello imperiale venne man mano abbandonata e sostituita con l’oreficeria del periodo della Restaurazione, dall’indubbio fascino ma pur tuttavia dallo scarso valore materiale. Emerse, di pari passo, un crescente interesse ai modelli medievali; fonte di ispirazione furono anche le decorazioni arabesche, mediorientali e rococò che
sollecitarono capricciosamente l’estro degli artisti. «Il diamante tornò particolarmente in auge come gioiello, dopo che il gioielliere parigino Oskar Massin ebbe rinnovato negli anni sessanta le monture illusion, l’incastonatura non appariscente à jour del XVIII secolo, servendosi di un nuovo metallo, il platino8».
Nonostante la diffusa affermazione di prodotti industriali, conseguenza della Rivoluzione Industriale, non mancò di riscontrare l’indicazione “lavorato a mano” soprattutto nei manufatti preziosi; vennero così fondate alcune società che, escludendo assolutamente l’apporto delle
macchine, capaci di porre in essere dei laboratori di tipo artigianale. Quelli che ormai venivano a delinearsi come circoli di artisti, tendevano a raggiungere una nuova forma, caratterizzata da un’espressione semplice ed essenziale, che prese pertanto il nome di “stilizzazione”.
(25)
19

Sicilia Preziosa
Paragrafo 10. Dopo l’Unità d’Italia Negli biennio 1866-‘67 furono emanate le cosiddette Leggi Siccardi (dal nome del
parlamentare che le aveva promosse al Parlamento Sabaudo prima dell'Unità), cioè le Leggi di soppressione degli Ordini religiosi e indistintamente applicate in tutto il Regno. Esse erano state precedute nel XVIII secolo da quelle rivolte all’Ordine dei Gesuiti e, in epoca napoleonica, all'area lombarda nel primo Ottocento. Le Leggi Siccardi si prefiggevano la confisca, a favore dello Stato postunitario, degli enti pubblici ad esso correlati e di tutti i beni ecclesiastici appartenuti alle Corporazioni Religiose Soppresse. Inoltre, esse sono importanti poiché, al Demanio, non furono acquisiti solamente i beni immobili quali chiese e fabbricati conventuali ma anche i beni mobili di proprietà delle chiese confiscate: arredi sacri, libri antichi e manoscritti, tele, dipinti e gioielli.
I verbali di presa in carico e gli inventari registrano una sorta di dispersione di tali beni che portò, da una parte, il loro mancato ritrovamento e, dall’altro, la loro immediata conservazione. Difatti, sorsero in tutta Italia Biblioteche Civiche Comunali, Pinacoteche, Musei Civici Comunali e Musei Diocesani che spesso riuscirono a riprendere parte del materiale trafugato.
Il periodo, così complesso e travagliato politicamente, non maturò lo sviluppo di nuove tecniche e nuovi linguaggi nel settore dell'oreficeria ma si ebbero in egual modo delle significative crescite a livello artistico e culturale.
Paragrafo 11. Il XX secolo: l’Art Déco e Art Nouveau In seguito all’Unità d’Italia, anche l’oreficeria siciliana subì una battuta d’arresto. Sull’Isola vi erano presenti artigiani, orafi e argentieri dalle grandi abilità ma tuttavia non esprimevano più una realtà corale. Va rilevato, ad ogni modo, che la suddetta crisi artigianale venne causata dalla rivoluzione
industriale e si inserì all’interno del più vasto contesto europeo. «L’oreficeria in particolare vive una profonda crisi che investe non solo gli stilemi, codici linguistici e tecniche di produzione ma anche referenti di natura sociale e simbolica9».
20

Sicilia Preziosa
Insomma, questa affascinante fetta di produzione diviene rappresentativa di una società in cambiamento, indirizzata alla modernità alla quale – inevitabilmente – si piega. Tale cambiamento trova espressione nel gioiello déco il quale accende l’attenzione per il gusto, il linguaggio, l’aggiornamento figurativo: il gioiello diviene oggetto di lusso, unico, irripetibile. Si assistette,
verosimilmente, alla formazione di una nuova figura: il joailler, ovverosia l’incastonatore di pietre dure e preziose e non più soltanto orefice. In Sicilia, ciononostante, fino alla metà degli anni ’30 del Novecento, gli artigiani orafi, pur adeguandosi alle nuove tecniche e tecnologie, riuscirono a mantenere alto il livello della produzione. È così che l’oreficeria ricevette nuova vita.
L’art déco, nella gioielleria, ebbe molto successo anche grazie ad alcune innovazioni
in merito; in primo luogo, l'interesse produttivo fu rivolto a materiali pregiati e rari, impiegati alternativamente a nuovi materiali similpreziosi, capaci di simularne altri; in secolo luogo, da protagonista fecero le pietre preziose incastonate sul supporto metallico, tali da rendere il gioiello una vera e propria opera architettonica (il supporto era reso totalmente invisibile, poiché le pietre erano montate senza lasciare spazi vuoti, dotando i bijoux di straordinari giochi di luce); infine, si affermano le tinte vivide ed i giochi cromatici (il nero dell’onice, il rosso del corallo, il verde della malachite, l’arancio dell’ambra, le varietà della giada, etc).
(26)
21

Sicilia Preziosa
I gioielli di questo periodo sembrarono essere la riproduzione, in chiave moderna, di stili del passato: classico, barocco, imperiale e arte africana in genere. Si riscontrano, inoltre, elementi tipici delle avanguardie del tempo quali il cubismo, il futurismo, il suprematismo;
difatti, associate alle forme caratterizzanti i soggetti di questi accessori, vi sono delle forme geometriche quali cerchi, quadrati, triangoli, linee a zig zag. Soggetti ricorrenti erano poi: ventagli, la palmetta, le volute a ricciolo, le fontane, le piramidi, gli uccelli ed animali feroci.
A proposito delle pietre preziose incastonate, il loro grande successo fu dato dalle innovazioni e sperimentazioni dei tagli; nel 1906, con l’ausilio di nuove macchine Luis Cartier ottenne il taglio di brillante a 36 facce. Tra le innumerevoli gemme adoperate, il brillante ebbe sicuramente maggiore successo probabilmente per due motivi: l’uno di natura economica, in seguito al ritrovamento di notevoli giacimenti africani (1870); il secondo legato alle nuove atmosfere create dall’avvento della corrente elettrica che aveva, come concorrente nella creazione di luce artificiale, per l’appunto il brillante.
Assieme a Cartier, difatti, i maggiori innovatori della gioielleria déco furono i francesi: Boucheron, Fouquet, Maubousin, Chaumet, Van Cleef & Arpels.
(27) (28)
(29)
22

Sicilia Preziosa
Tutta la produzione déco italiana ebbe, invece, una comparsa di breve periodo, anche in riferimento alla produzione orafa, nonostante la presenza sempre più preponderante in occasione delle Esposizioni di Arti decorative e industriali; anche in presenza di un giudizio negativo da parte della critica, nel 1923 alla
biennale di Monza, l’oreficeria e la gioielleria ottenne una sala propria. Nel più ampio contesto internazionale e nazionale, gli artisti siciliani non furono in vista. La sezione oreficeria alla Esposizione di Monza, nel 1930, venne trasferita alla Biennale di Venezia. Emerge, tra l’altro, la presenza degli artisti siciliani non tanto con i gioielli quanto piuttosto con oggetti in argento.
In Sicilia, anche in seguito alla parentesi della Prima Guerra Mondiale, le officine orafe lavorarono assiduamente proponendo tuttavia modelli settecenteschi o riproducendo disegni provenienti dai cataloghi di vendita che rispondevano ad un target più economico e popolare. È indubbio che, durante gli anni ’20, la città di Palermo fosse la maggiore produttrice di prodotti di oreficeria; a darne conferma troviamo l’elenco per provincie dei marchi di identificazione (era stata, infatti, applicata la Legge del 5 Febbraio 1934 che disciplinava i titoli e i marchi dei metalli preziosi):
48 per Palermo; 8 per Catania; 6 per Messina; 3 per Siracusa; 2 per Trapani; 1 per Agrigento; 11 per Ragusa.
Per quanto tali numeri portino a pensare un intensa attività, lo scenario nazionale – nella fattispecie Lombardia e Piemonte – registrò numeri ben più alti: 275 per Milano, 175 per Alessandria e 101 Napoli.
(30)
(31)
23

Sicilia Preziosa
Emblema della produzione orafa di questo periodo è sicuramente la spilla; «non esiste a Palermo famiglia borghese o aristocratica che non possegga ancor’oggi un gioiello di questo periodo: spille, anelli, orecchini, sono quelli che si trovano più facilmente, bracciali e collane spesso invece sono stati smontati per dividere le pietre tra gli eredi»10. Le piccole dimensioni, la forma allungata, le pietre incastonate (spesso si tratta di smeraldi, acqua marina, ametista o zaffiro) sono caratteristiche peculiari. L’appartenenza all’arte déco è riscontrabile, inoltre, nella composizione simmetrica, nella cesellatura, nella incastonatura delle pietre in fila. Agli inizi degli anni ’30, però, le spille cominciano ad acquisire maggiori volumi, sia per le dimensioni della stessa che per quelle delle pietre, perdendo gli effetti cromatici
e assumendo forme più arrotondate e arabescate.
L’eredità di questi nuovi impulsi dell’oreficeria evidenziarono non tanto la preziosità quanto le caratteristiche intrinseche e decorative. Oltre alla costante presenza di pietre preziose, smalti, oro e argento, apparvero altri materiali tra i quali il rame e l’acciaio. L’art nouveau – che, ricordiamo, si contrappose all’art déco (definita “arte di lusso” ed avulsa da ogni motivazione d’ordine sociale, arte decorativa fine a se stessa) cercò di raggiungere ogni strato della società ed azzerare la dicotomia tra “arti minori e maggiori – può essere ricordata come l’ultimo stile, in Europa, capace di svilupparsi e promuovere proprie creazioni ornamentali. L’avvento della prima Guerra Mondiale, ponendo l’accento sulla razionalità e l’’utilitarismo, portò a voltare pagina su
(32)
(33)
24

Sicilia Preziosa
molteplici fronti; l’artigianato del dopoguerra abbandona quanto nei secoli si era tramandato, visto e apprezzato.
(34)
25

Sicilia Preziosa
Capitolo II
Le tecniche di lavorazione dei metalli pregiati «… Si può dire che la tecnica dell’arte orafa e argentaria è oggi quella già nota nel mondo ellenico e romano. Immutati sono rimasti anche gli arnesi e gli attrezzi. Quando sono
sopravvenuti i macchinari moderni e le macchine utensili, il livello artistico è rapidamente scaduto»11.
Paragrafo 1. L’oreficeria L’oreficeria è l’arte della
lavorazione dell’oro e di altri metalli preziosi, come l’argento e il platino, per ottenere oggetti artistici. L’arte orafa è strettamente correlata con la gioielleria, i cui manufatti utilizzano i metalli preziosi come leganti per la produzione di gioielli con gemme. Le tecniche di lavorazione sembrano essere rimaste immutate nel tempo; infatti, si ottengono i monili eseguendo le stesse tecniche di fusione e di lavorazione a cesello, a stampo, a sbalzo e filigrana come avveniva già anticamente.
Tre sono le caratteristiche che assurgono i metalli preziosi a materiali lavorabili per la produzione di artefatti: inalterabilità, duttilità, malleabilità.
Il mestiere dell’orafo si è tramandato di generazione in
generazione, soprattutto durante il periodo in cui erano in auge le corporazioni; difatti, l’opportunità di frequentare assiduamente una bottega orafa dava la possibilità di accostarsi a tale
arte in maniera diretta e sotto la supervisione dell’esperienza dei maestri. In seguito alla soppressione delle antiche corporazioni e
maestranze, la prassi dell’apprendistato cambiò definitivamente volto.
Gli artefatti, dopo la fusione, se non ripassati o bruniti, presentano una superficie opaca e con imperfezioni (bolle d’aria, granuli, etc); gli antichi maestri non avrebbero mai lasciato l’oggetto in questo stato, senza procedere con la lucidatura, brunitura o cesellatura; invece, i moderni orafi usano tali imperfezioni quale linguaggio artistico.
(35)
26

Sicilia Preziosa
Paragrafo 2. La lavorazione dell’oro La tradizione orafa siciliana vanta
un lontano e nobile passato. Come è noto, l’oro allo stato pure è soffice e pertanto ha bisogno di essere unito ad un altro metallo per procedere con la sua lavorazione; sulla base delle sostanze legate – rame, argento, nichel – l’oro può assumere diverse colorazioni: più gialla, più rossa, più bianca. La prima fase della lavorazione è quindi la fusione; tra i procedimenti più antichi si riscontra l’uso degli ossi di seppia (se ne ha notizia già nel 1472), che permettono – pressando su una metà dell’osso la sagoma realizzata con altro materiale – di ottenere la forma desiderata che verrà poi perfezionata a mano.
Si procede poi alla fusione del
metallo, durante la quale l’osso di seppia viene posto accanto al fuoco affinché eventuali residui di umidità si asciughino e che altrimenti provocherebbero la comparsa di bollicine sul manufatto. Inoltre, accidentali errori di cottura causerebbero una certa porosità, inficiando la resistenza dell’oggetto.
Si tenga conto che la procedura
appena descritta viene applicata dall’artista per realizzare un prodotto di tipo artigianale, e quindi unico. Per rispondere, invece, alle esigenze di mercato si sceglie un procedimento che prevede l’uso di modelli di gomma sciolta (per sagomare i pezzi) e iniettatori; è
prevista, inoltre, una seconda cottura. Quando l’oggetto è composto da più parti, queste vanno saldate; se le dimensioni sono maneggevoli si procede con un cannello tradizionale alimentato a gas la cui pressione viene regolata a fiato. Dopo la saldatura è doveroso il controllo del pezzo affinché non vi siano imperfezioni.
(36)
(37) (38)
27

Sicilia Preziosa
Si passa poi allo sbiancamento, immergendo l’oggetto in un liquido disossidante, oggi già pronto in
commercio. Prima della fase finale, si opera il lavaggio dell’oggetto.
Paragrafo 3. La lavorazione dell’argento Il ritrovamento dei giacimenti di
argento, già da tempi antichissimi, si lega ad un vasto universo mentale in cui tali materie preziose si caricavano di significati altri, quali dono attivo della Madre Terra, e non di rado religiosi. Inevitabilmente, anche i criteri valutativi dei manufatti argentei venivano a suddividersi in due ordini principali: di carattere artistico, proveniente dalle
committenze laiche; di carattere simbolico, legato al mondo religioso.
Tuttavia, soggiacciono le stesse tecniche di realizzazione per tutti i manufatti d’argento, le quali risalgono anche ad alcuni millenni a.C. e vengono ancor’oggi impiegate senza grossi cambiamenti; le uniche innovazioni riguardano l’ausilio della corrente elettrica per talune procedure di lavorazione.
È raro trovare in natura l’argento allo stato puro, laddove però ciò avvenga, esso proviene da due tipologie di giacimenti: minerali d’argento (argirosi) o minerali argentiferi (galena).
L’argento, allo stato puro – così come avviene per l’oro – è troppo tenero
(39) (40)
(41)
28

Sicilia Preziosa
per essere lavorato direttamente; viene, pertanto, unito in leghe ad altri metalli. Le principali tecniche di lavorazione, basate sulle caratteristiche intrinseche dei metalli in genere, sono:
la martellatura, piegamento e tensione del metallo; la fusione, il passaggio dallo stato liquido e poi – dopo il raffreddamento – nuovamente allo stato solido, assumendo frattanto la forma data dallo stampo. Va ricordato, infine, che esistono e
vengono applicate ulteriori tecniche di
lavorazione destinate alla rifinitura e impreziosimento del manufatto che tuttavia prescindono dalle due tecniche primarie.
(42)
(43)
29

Sicilia Preziosa
Capitolo III
Un simbolo di sicilianità: il corallo
«Sin dai tempi più remoti un alone d’ambiguità s’è accompagnato all’idea e alle fortune del corallo. […] la fiducia, ancora oggi vivente, che possedesse virtù terapeutiche e
scaramantiche. […] Fantasie che però servirono a impreziosire la storia del bizzarro fiore di roccia e dovettero suggerirne lo sfruttamento a scopo apotropaico, fino a quando non si
preferì manipolarne le forme spontanee con trapani, lime, bulini, scalpelli, e usarlo quale materiale prima di elaborate sculture e oreficerie. Così il corallo, mentre continuava a
fornire semplice collane alle fanciulle del popolo, entrò con pieno diritto nel dominio della più sofisticata arte. Restandovi fino all’odierna decadenza dovuta a fattori molteplici, non
ultimo dei quali il subentrare dell’oro come elemento di prestigio nella gerarchia degli addobbi e delle rarità artificiose. […] Ebbene, di questo universo, così come si propose sulle
sponde della Sicilia occidentale nella sua duplice secolare congiunzione mercantile e creativa, la capitale fu Trapani»12.
(44)
30

Sicilia Preziosa
Paragrafo 1. La storia Si perde nei tempi l’alone di
mistero che avvolge il corallo; sino al XVI secolo la scienza ufficiale lo decretava quale pianta marina, simile a tante altre per la natura sinuosa dei rami, capace di indurirsi una volta colto e portato in superficie. Inoltre, il colore rosso portava ad attribuire all’origine del corallo un valore mitologico: diveniva pertanto prezioso anche più dell’oro, per il potere apotropaico attribuitogli. Difatti, un livello culturale medio assai basso, portò le popolazioni – tanto dell’Occidente quanto
dell’Oriente – a vedere con ostilità la scoperta fatta dal giovane medico francese Jean-André Peyssonel (XVIII secolo) della natura animale del corallo. «Per più di dieci secoli il corallo fu panacea in tutti i mali e sinonimo ricchezza: fu impiegato come bene apotropaico (solo che si detenesse anche grezzo), in medicina, nell’edilizia, nell’oreficeria e nell’arte (sia per ricavarne oggetti sacri che per trasformarlo in simboli scaramantici o fallici)13».
Si dovrà attendere l’Età dei Lumi per trovare un punto di equilibrio tra le tradizioni popolari e i risultati scientifici sul corallo, il quale venne accreditato alla stregua di qualsivoglia tipologia di materiale. Tuttavia, l’usanza di accompagnare i bambini con piccoli monili di corallo, per proteggerli, è continuata praticamente senza interruzioni sino all’inizi del secolo ‘900.
Sin dal XVI secolo, in Occidente la lavorazione del corallo è associata alle comunità ebraiche dalle quali provenivano le realizzazioni più prestigiose; a Trapani, già nel ‘400, a occuparsi dei coralli fu la numerosa comunità ebraica che ivi risiedeva e la quale possedeva 90% dei corallari. «La fatica improba dei corallini, la pirateria, le pestilenze, le vessazioni fiscali non hanno soppiantato un’attività che ha arricchito mercanti, rimpinguato le casse dissestate dei regnanti, stimolato i traffici, contribuito a creare una classe di artisti-artigiani che tentarono (a Genova, ma soprattutto a Trapani) di sovvertire l’ordine sociale attraverso l’organizzazione di moti popolari per una
(45)
31

Sicilia Preziosa
gestione più allargata e meno oligarchica del potere»14.
Attorno al corallo è
sempre circolata molta ricchezza e opulenza, ciò nonostante i pescatori e gli artigiani del corallo – che non fossero ebrei – erano per lo
più persone indigenti: erano per tanto disposti a trasferirsi altrove per migliorare le proprie condizioni di vita. Difatti, nella storia della lavorazione del corallo si sono verificati numerosi esodi di corallari; l’ultimo, in ordine di tempo, ha riguardato Trapani, Torre del Greco e Sciacca alla fine del XIX secolo. Il grande successo del corallo non è esclusivamente legato al potere apotropaico ma per l’utilizzo, in campo artistico, in tutto il contesto Mediterraneo. L’ingresso del corallo nel mondo dell’arte ha consentito che questo venisse elevato «al rango di materia nobile, alla stregua dell’oro e dell’argento»15. L’intuizione di adoperare tale materiale è tutta trapanese, ove la genialità degli artisti locali diede loro l’opportunità di attrarre inizialmente l’attenzione via via di tutto il mondo, per più di tre secoli (dal XVI al XVIII secolo). Le creazioni giunsero gradualmente ai regnanti, ai papi, ai principi ed ai mecenati.
Ad arricchirsi con il commercio del corallo (a partire dal XV secolo sino al XVIII inoltrato), a Trapani, furono banchieri, mercanti, notai e armatori rivolgendosi soprattutto al
mercato del nord Africa e del Medio Oriente; inoltre, i trapanesi si ingegnarono per trovare altre capaci di stimolare ulteriormente il commercio. Il primato di Trapani, tra le città del corallo, si deve non tanto per le lavorazioni di rosari e collane ma per il Privilegio accordato ai maestri corallari per essere unici nella lavorazione dei rami; la città riceveva così il titolo
(46)
(47)
(48)
32

Sicilia Preziosa
“Città dei Coralli”. È assai probabile che i corallari avessero affinato la propria dimestichezza all’incisione poiché provenienti dalla lavorazione del marmo o piuttosto dal legno; pertanto, e soprattutto in un primo momento, i pezzi avevano dimensioni modeste e la fattura era grossolana e non molto accurata. «Considerato che non c’è testimonianza storico-documentale, né è stata individuata una vasta gamma di sicura scuola trapanese, c’è da desumere che questa prospera arte fosse dedita a scolpire e incidere esclusivamente pezzi di dimensioni ridotte»16.
(49)
33

Sicilia Preziosa
Paragrafo 2. La lavorazione Durante il periodo medievale la
lavorazione del corallo – dunque la trasformazione da materiale grezzo a prodotto finito – fu probabilmente incrementata dall’esigenza di allargare i mercati, nella fattispecie quello orientale ed arabo. In tale scenario, una classificazione dei pezzi di corallo veniva fatta già a monte dai commercianti e per consistenza del pezzo grezzo si intendeva il ramo ripulito dal rivestimento del tipico colore arancione tramite la pietra molara.
Per la lavorazione si cercava di lasciare quasi immutata la forma naturale dei rami di corallo e, servendosi di una lima, gli artigiani procedevano al taglio dei piccoli rametti che venivano poi adoperati nelle cosiddette filze (rosari, collane, bracciali); tuttavia, per adempiere a commissioni più particolareggiate gli artigiani procedevano anche al taglio dei rami più grossi del corallo tramite la spada ovvero una grossa lama tagliente con la quale si
praticava un taglio sul pezzo e poi – per mezzo di una tenaglia – si faceva leva e si staccava. La pietra molara, inoltre, si adoperava per arrotondare ad esempio i grani dei rosari o delle collane. Tra gli utensili impiegati, si annovera anche un fusellino manuale adoperato per forare o per incidere il corallo; un’innovazione molto particolare, grazie ad Antonio Ciminello, fu il bulino che venne assunto come spartiacque nella lavorazione, per le possibilità offerte dal suo impiego di affinare la lavorazione. Troviamo, inoltre e
soprattutto alle origini della lavorazione, attrezzi presi in prestito dagli argentieri, dagli intagliatori di legno o dagli incisori orafi. Per quanto riguarda, invece, la fase finale della lucidatura, per essa si adoperava la sabbia di Tripoli per mezzo di una ruota di palissandro o con verghe di piombo. Non di rado i corallari, per dotare i pezzi di maggiore prestigio, ricorrevano anche alla sfaccettatura.
(50)
(51)
34

Sicilia Preziosa
Paragrafo 3. Gioia dei ricchi, dolore del mare La posizione strategica di Trapani,
ad un passo dalla costa spagnola, e l’essere città a forte connotazione peschereccia ne ha fatto la naturale patria del corallo.
La raccolta di quest’ultima si combinava con il periodo della pesca del tonno, poiché era impiegata la stessa manodopera; se dapprima la raccolta avveniva celatamente, ben presto l’ormai affermatasi corporazione dei corallari prese visibilità durante la processione del Venerdì Santo in città.
L’imbarcazione tipica usata veniva chiamata corallina, ed il suo comandante era solito vendere il frutto della pesca al mastro corallaro il quale – dopo averlo lavorato – lo rivendeva agli zafaranari che si preoccupano quindi di smercialo.
I fondali del mare siciliano, rigogliosi di tale materiale, a causa delle tecniche di estrazione – nella fattispecie lo
strascico dei cosiddetti ingigni, ovvero le croci con le reti utilizzate per strappare il corallo dal fondo – in breve si depauperarono. Da un’abbondante circolazione del prodotto, quindi, si passò presto al suo uso razionalizzato. Stessa sorte, toccò poi all’Isola Ferdinandea (al largo di Sciacca) ove la scoperta di un importante banco di corallo bianco venne subito saccheggiato, con la immediata conseguenza dell’abbassamento dei prezzi. Tutto ciò, coincise nel XIX secolo con il progressivo annichilimento dell’arte dei corallari e al contemporaneo affermarsi dello stile Liberty mediterraneo. Venne così sancito il passaggio di testimone, come capitale del corallo, da Trapani a Torre del Greco (NA). Ivi il prezzo del prodotto è stato mantenuto alto, ostacolando la rinascita di tale mestiere nuovamente in Sicilia. Tuttavia, alcuni tentativi sono stati intrapresi affinché le tecniche, gli strumenti, le fogge fossero riprese e riportate allo splendore ancora goduto sino all’avvento del Secondo Conflitto mondiale.
(52)
(53)
35

Sicilia Preziosa
(54)
36

Sicilia Preziosa
Parte seconda
Capitolo i
Catania
Paragrafo 1. Il museo Diocesano Il Museo Diocesano di Catania è
collocato, adiacente alla Cattedrale,
nell’antico Seminario dei Chierici e custodisce tutto l’arredo mobile storico della Cattedrale e della sede vescovile; entrando dalla Porta Uzeda, l’edificio è situato sulla sinistra. In seguito ad un accurato restauro, il Museo venne inaugurato il 1° Febbraio del 2001 ed ospita un ricco iter sviluppato in 9 sale distribuite su tre piani; fanno mostra di sé oreficerie, arredi liturgici dal XVII al XIX secolo, paramenti sacri del XVII e del XVIII secolo, una pinacoteca e la Cappella del Palazzo Vescovile. Grazie alla sua recente realizzazione, il Museo segue le norme della moderna museologia: le luce soffuse degli ambienti, la funzionalità del design delle teche, l’accesso ai disabili ed un comodo ascensore, la Sala conferenze, il book shop, spazi per gli allestimenti temporanei ed un elegante caffetteria. Inoltre, è stata posta la giusta attenzione alla conservazione e tutela dei beni i quali, suddivisi per categorie, esigono differenti condizioni di luce e temperatura.
Nella IV sala sono collocati gli arredi impiegati durante la celebrazione del culto di Sant’Agata, come i paliotti
argentei settecenteschi, il tronetto eucaristico con l’Eterno, la porta lignea intagliata del responsorio delle Reliquie della Santa datata XVII secolo e la teca con alcuni gioielli ex-voto provenienti dal celeberrimo Busto Reliquiario della Santa Patrona.
Nella IX sala, invece, al piano terra, è conservato il Fercolo d’argento di Sant’Agata che custodisce le reliquie della Santa della città durante la festività del 5 Febbraio.
Per quanto riguarda il Busto della Santa, la sua realizzazione è attribuita all’orafo senese Giovanni Di Bartolo attivo nella seconda metà del XIV secolo e che, orbitando negli ambienti ecclesiastici, offrì i suoi servigi ai papi Urbano V e Gregorio XI. Le innovazioni stilistiche del Di Bartolo, che lo distaccano dalla scuola senese e che testimoniano le influenze nordiche, constano nell’uso di smalti policromi adoperati sia per dare una resa realistica – come nel caso dell’incarnato della Santa –, sia per decorare il manufatto – come nel caso dei dieci medaglioni raffiguranti le fasi storiche del reliquiario presenti sul basamento del Busto –. Quest’ultimo, finemente cesellato
37

Sicilia Preziosa
e sbalzato, non si può cogliere nelle sue originarie fattezze poiché oggi è interamente ricoperto da una coltre di
pietre preziose, gioielli e ori offerti, nel lungo corso dei secoli, dai fedeli.
(55)
38

Sicilia Preziosa
Paragrafo 2. Museo della Basilica di San Sebastiano di Acireale
La Basilica Collegiata di San Sebastiano è uno straordinario esempio di Barocco siciliano, nonché emblema della religiosità del popolo acese a suoi Santi patroni Sebastiano e Venera. Il Santo, come accade spesso, ha raccolto un estimabile tesoro offerto dai fedeli e custodito nel Museo della Basilica collocato all’interno della sacrestia della stessa. Il Museo è stato
inaugurato nell’Aprile del 2003 e l’inventariazione svolta ne ha permesso la sistemazione nei locali; infatti, grandi teche in vetro e metallo accolgono il ricco patrimonio composto da paramenti sacri ascrivibili al periodo XVII-XX secolo, quadri,
statue lignee e un’importante sezione di gioielleria. La caratteristica di questa sezione è la sistemazione dei monili preziosi su fasce di velluto, ben 10, esposte in processione durante la Festa del Santo. Nel Luglio del 2007, alle fasce con i
gioielli, sono stati aggiunti altri 25 pezzi inediti della Croce Pettorale di San Sebastiano.
CAPITOLO II
CALTANISSETTA Paragrafo 1. Il Museo Diocesano Il Museo Diocesano di Caltanissetta
è stato riaperto nel 2003, dopo un lungo periodo di buio, grazie al progetto voluto dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali della provincia. Esso venne fondato per volontà del vescovo Alfredo Garsia e dal monsignor Giovanni Speciale nel 1987;
composto inizialmente da un’unica sala, occupò successivamente parte del piano terra del Palazzo Vescovile: lungo un corridoio si aprono 6 ampie stanze, una delle quali è affrescata in stile Liberty.
Essendo un Museo diocesano, al suo interno sono stati convogliati beni la cui provenienza è assai diversificata:
(56)
(57)
39

Sicilia Preziosa
soppressione di ordini religiosi, esigenze conservative, lasciti e donazioni. L’inventariazione dei beni del Museo ha permesso l’ordinamento dell’intero complesso secondo una precisa cronologia ed risultata cospicua la presenza di oggetti datati dal XVI al XIX secolo di fattura siciliana. Inoltre, seguendo la prassi dettata dalla moderna scienza museografica, l’iter – con apertura alla pittura locale dal XVI al XVIII secolo – procede con sezioni tematiche.
Una di queste sezioni mostra una preziosa quanto numerosa raccolta di argenti liturgici e paramenti sacri. Emblematica la coppia di Reliquiari dei Santi Pietro e Paolo realizzati nel 1598 da Nibilio Gagini, adoperando la tecnica a cesello con parti fuse lavorate a sbalzo, quale espressione del passaggio artistico dal Gotico al Rinascimento. Non indifferente è la presenza degli artefatti orafi del periodo compreso tra il XVII e il XVIII secolo di manifattura palermitana e
messinese: calici, ostensori, pissidi, navette, turiboli, croci reliquiarie.
CAPITOLO III
MESSINA
Paragrafo 1. Il Museo dell’Opera del Duomo
Il Museo, inaugurato nel 2000 in occasione del Giubileo, accoglie opere
datate tra il XII e il XX secolo – tra le quali lo stesso arredo liturgico della Cattedrale –
(58)
40

Sicilia Preziosa
e ascrivibili alle maestranze di orafi e argentieri messinesi testimoniando il culto alla Madonna della Lettera, Patrona della città. Il Museo, dopo un travagliato excursus storico, oggi apre al pubblico con le recentissime innovazioni in ambito museologico; oltre agli accessi per disabili, le guide multilingue, la presenza di teche capaci di concretizzare i dettami della salvaguardia e tutela dei beni, stando al suo interno sembra di ritrovarsi sotto un cielo stellato grazie ai giochi di luci del soffitto. Gli ambienti constano di 4 sale, all’interno delle quali si snoda il percorso espositivo raccoglie più di 400 pezzi. Il corpus del tesoro del Duomo di Messina, dall’importante interesse storico e artistico, è strettamente collegato al suo territorio; difatti, oltre a rappresentare per la maggior parte il vero e proprio arredo della Basilica, si è andato arricchendo nei secoli in seguito alle donazioni e lasciti effettuati dai personaggi illustri della città.
È un emblema del Museo il Braccio di San Marziano, primo vescovo della città di
Siracusa nonché protomartire. La studiosa Accasciana lo ha definito «sintesi perfetta fra motivi islamici, bizantini, romanici»17. Il Braccio, in argento dorato, è coniforme (struttura assai insolita per un reliquario del genere), cesellato e lavorato a sbalzo il quale termina con una mano in posa benedicente (alla maniera greca). Tra i decori si riscontra un giglio stilizzato – simbolo di purezza, innocenza, verginità ovvero degli attributi usuali per un Santo –
racchiuso in un rombo, creatosi dal reticolo che ricopre l’intera superficie del cono; a suddividere la decorazione, è posta una lunga iscrizione – a lettere uncinate – che esplica il nome del donatore e la motivazione della donazione. L’offerente fu un personaggio illustre e influente dell’Isola alla fine del XII secolo, un certo Riccardo Palmer inglese e orbitante alla corte di Giglielmo II che ricoprì dapprima la carica di vescovo presso Siracusa e successivamente fu arcivescovo presso la Diocesi di Messina.
(59)
41

Sicilia Preziosa
Altro oggetto significativo è la
Croce in lamina d’argento, istoriata e raffigurante Gesù Crocifisso sul recto, mentre sul verso vi è la figura della Vergine orante. Quale artista del particolarissimo esemplare è stato individuato Perrone Malamorte ovvero orefice stimato da Federico II.
Tra le numerosissime opere, cospicuo è il numero dei calici e degli ostensori; tra questi ultimi, degni di nota sono i due realizzati dal maestro Gaetano Martinez (1742-1750). Entrambi in
bronzo dorato con sfera e raggi in argento, presentano l’uno l’immagine di Cristo risorto (adornato anche da smeraldi) e l’altro i simboli dei Quattro Evangelisti.
(60)
(61)
(62)
42

Sicilia Preziosa
Paragrafo 2. Il Museo Archeologico di Taormina
Il Museo, finalmente inaugurato nel 2001, ha sfruttato la trecentesca Badia Vecchia di Taormina, adagiata sulle originarie mura medievali della città, sui pendii del Monte Etna e quindi con un panorama mozzafiato sulla baia di Naxos, quale propria sede.
La sezione dedicata all’oreficeria di epoca antica – ellenistica, romana, bizantina – deve sicuramente la propria esistenza all’apporto dell’archeologo
siracusano Paolo Orsi. I reperti, per le loro fattezze, offrono l’idea dell’opulenza della città a quei tempi. Significativi sono, ad esempio, il ciondolo di età imperiale di perle intrecciate in fili d’oro raccordati da una perla pendente dalle dimensioni maggiori o ancora l’anello d’oro – datato nella prima età imperiale – impreziosito da un’incastonatura piatta in smeraldo ed, infine, il magnifico orecchino a navicella intarsiato e abbellito dal perle e pietre policrome del X-XI secolo.
(63)
(64)
(65)
43

Sicilia Preziosa
CAPITOLO IV
TRAPANI
Paragrafo 1. Il Tesoro della Madonna presso il Museo Pepoli
Il Museo è collocato di fronte al giardino pubblico e il suo ingresso è posto sul lato sinistro del Santuario dell’Annunziata, dal quale si accede ad un cortile scoperto; ivi troneggia un notevole portale marmoreo cinquecentesco, decorato a festoni, che immette nel chiostro rinascimentale composto da 80 colonne di stile dorico a sostegno del piano soprastante e delle logge. Sulla parte destra del chiostro è presente un’ampia porta, per la quale si accede alla parte coperta del Museo e dunque ai piani superiori.
Entrando nel Museo Pepoli si è accolti dal bagliore delle pietre preziose; esso ospita circa 400 oggetti d’oro e d’argento, pregevoli manufatti artigianali in corallo, avorio, tela e colla, maioliche, argenterie, tessuti ricamati, nonché una notevole collezione numismatica. La straordinarietà del Museo è data, inoltre, dalla presenza di testimonianze capaci di ricoprire un lunghissimo arco cronologico: dal Medioevo ai giorni nostri.
Il Museo Pepoli fu costruito nel 1906 e patrocinato dal conte Agostino Sieri Pepoli. Il fondatore parlò del proprio progetto con il Sindaco già nel 1875,
inviandogli una lettera con la quale esprimeva il desiderio di un museo municipale capace di ospitare opere d’arte affinché – ceduti per legge al Comune – il loro valore artistico non venisse disperso. Chiese altresì che venissero rispettate alcune clausole; tra queste, l’uso esclusivo dei locali alla destinazione museale e la restituzione dei beni al proprietario laddove il Museo fosse stato accorpato ad altri istituti.
Il sindaco di Trapani del periodo rispose, nello stesso anno (1875) con il consenso alla realizzazione del progetto, esprimendolo durante la prima riunione del Consiglio comunale. In verità passarono ben trent’un anni prima che il
(66)
44

Sicilia Preziosa
sogno del Conte venisse coronato.
Difatti, soltanto nel 1906 il Consiglio comunale autorizzò il Conte ad occupare alcuni dei locali dell’ex convento carmelitano della Annunziata e a dar vita – a proprie spese – al Museo. Con un Regio Decreto si diede il riconoscimento giuridico al Museo e, con un successivo Regio Decreto, la sua gestione passò allo Stato.
La forte devozione alla Madonna, mista a folklore, ha permesso a Trapani una importante circolazione di maestranze e artefatti. L’inventariazione dei beni ha consentito finalmente una ricostruzione lungo i secoli dell’oreficeria siciliana grazie al pioneristico lavoro della studiosa Maria Accascina. Emerge, così, l’impronta lasciata dalla nobiltà e ricca aristocrazia locale che era divenuta sempre più opulenta poiché la città
costituiva un importante snodo commerciale. Il rapporto tra committenti, destinatari e orafi nonché le vicende economiche e sociali appaiono certe grazie ai precisi elenchi compilati dai Padri Carmelitani in seguito alle acquisizioni da parte della chiesa. Quando l’ordine venne soppresso (1866), i
beni passarono al Museo Pepoli per godere di una pubblica fruizione. Difatti, un nucleo museale è composto esclusivamente da tali artefatti. Emblema è la cosiddetta pietra stregonia, dal potere apotropaico, ovverosia il corallo inciso con le sembianze della madonna, incastonata in un medaglione d’oro lavorato con smalti del diametro di 50 mm attribuito ad un orafo trapanese della prima metà del XVII secolo e donata da Donna Angiola moglie del Baronello della Mocarta nel 1647.
«La visibile ricchezza dei monili superstiti e l’esuberante discussione di quelli perduti, pure ricordati dagli inventari, consente certamente di evidenziare l’alta qualità della produzione orafa siciliana, cui non è estraneo per altro il genio di una terra da un lato piena di contrasti e dall’altro di insospettate risorse»19.
(67)
45

Sicilia Preziosa
CAPITOLO V
PALERMO
Paragrafo 1. Il Museo della Cattedrale
La cattedrale palermitana, essendo stata più volte rimaneggiata nel corso dei secoli (XIV, XV e XVI), risulta essere un indiscutibile esempio del cosiddetto eclettismo artistico; venne fondata, alla fine del XII secolo, dall’arcivescovo Gualtiero. Nell’attigua cappella di Santa Rosalia, patrona di Palermo, è custodito il tesoro della Cattedrale di Palermo, nonché uno dei più importanti patrimoni ecclesiastici della Sicilia. Esso raccoglie ed espone ori, argenti, gioielli, paramenti sacri tutti fortemente legati ai noti personaggi storici dell’Isola, dal periodo normanno sino al XX secolo. L’allestimento del tesoro fu inizialmente strutturato in un'unica sala, e solo recentemente la restaurazione degli ambienti ne ha migliorato la fruizione delle stesse sale e delle opere.
Emblema della raccolta dei preziosi è sicuramente la Corona di Costanza d’Aragona, esemplare più antico. Si tratta di una calotta emisferica, tipologia assai diffusa tra gli imperatori bizantini, chiamata anche “Kamelaukion”; la struttura è costituita da un tessuto ricoperto da perline che si alternano a lastre d’oro quadrilobate ornate da smalti
e castoni centrali di grosse gemme colorate cucite. Una raffinata filigrana aurea divide, poi, in quattro spicchi la calotta, conferendole verisimiglianza al broccato. Inferiormente alla calotta, cadono due elaborati e ricchi pendagli distanziati da tre catenelle ornate da smalti,
granulazioni ed elementi geometrici. Inoltre, solo di recente, è possibile
ammirare 18 pezzi inediti ascrivibili all’oreficeria siciliana dalla fine del XVIII al XX secolo: catene ingemmate, orecchini, anelli vescovili, spille, etc.
Paragrafo 2. Himera: il caso della
Phiale Aurea di Caltavuturo Himera fu una colonia greca
fondata nel 648 a.C., ed occupa una posizione centrale in mezzo ad un ampio
golfo – quello tra i promontori di Cefalù e di Termini Imerese – e in prossimità della foce dell’omonimo fiume che costituisce un’importante arteria di collegamento verso la Sicilia centrale. Il rapido sviluppo
(68)
46

Sicilia Preziosa
edilizio e demografico della città è documentato dai grandi impianti urbanistici realizzati a partire dalla prima metà del VI sec. a.C. e la sua organizzazione planimetrica è tra le più interessanti del mondo coloniale greco; tuttavia poco sappiamo sulla prima fase di vita, compresa tra la metà del VII e gli inizi del VI sec. a.C.. Himera fu identificata nel XVI secolo ma soltanto tra il 1926 e il 1930 vennero avviate, dalla Soprintendenza Archeologica di Palermo, le prime serie indagini sulle necropoli.
Esse erano, difatti, dislocate lungo i principali percorsi d’uscita della città: a sud, ad est, ad ovest. E’ comunque nel 1963 che venne condotto uno scavo sistematico, grazie all’Istituto di Archeologia dell’Università di Palermo. Scavi recenti hanno interessato le necropoli, risalenti al VI-V secolo a.C., dalle quali stanno affiorando resti umani in grande quantità ed un enorme corredo funerario costituito da lucerne, crateri e ceramiche di varia fattura.
Su progetto di Franco Minissi, nel
1984 venne poi inaugurato il Museo Archeologico Antiquarium. Dopo essere rimasto chiuso alcuni anni per la ristrutturazione, è stato definitivamente riaperto al pubblico nel 2001. Vi sono conservati i reperti più significativi rinvenuti dagli scavi di Himera e di altri
siti ricadenti nel territorio della polis. Lo spazio espositivo è articolato su più livelli collegati da rampe; la visita si sviluppa lungo un itinerario che ripercorre le principali dinamiche storiche e culturali della colonia greca e del suo territorio sino al periodo medievale.
(69)
(70)
47

Sicilia Preziosa
Tra i numerosi reperti custoditi
presso l’Antiquarium, ve sono alcuni provenienti dal Monte Riparato il quale appartiene al territorio del Comune di Caltavuturo. Ivi venne rinvenuta anche la Phiale Aurea, dando avvio ad una lunga controversia che ha interessato la città di Caltavuturo la quale – per godere di un esemplare a cui dà i nativi e che consolida l’importanza storica del proprio sito archeologico – non ha accettato di buon grado la decisione della Soprintendenza di destinare il prestigioso pezzo antico al Museo di Himera. Inoltre, la scoperta della Phiale è stata protagonista finanche di una difficile inchiesta giudiziaria circa il recupero del patrimonio storico- artistico che illegalmente ha lasciato e lascia
ancor’oggi l’Italia. Appena rinvenuta, nel 1980, durante alcuni lavori per la linea elettrica a Caltavuturo, la Phiale venne acquistata da un collezionista catanese che in seguito la rivendette. Poco più di un decennio dopo, la Phiale lasciò l’Isola in maniera clandestina per raggiungere la Svizzera; infine, venne rivenduta ad un miliardario newyorkese. Le indagini della Procura di Termini Imerese, districando la matassa del diritto internazionale in materia di esportazione di opere d’arte, nel 1995 chiese la restituzione della Phiale alle competenti autorità giudiziarie americane. Queste ultime, dopo aver riconosciuto gli illeciti doganali, nel ’99 consegnano il reperto allo Stato Italiano.
(71)
48

Sicilia Preziosa
Si tratta di una phiale mesomphalos, dal latino “patera umbilicata”, piatto votivo dalla forma ben documentata nel mondo greco e realizzata con diversi materiali (ceramica e metalli). La sua finzione era legata essenzialmente alle libagioni ed alle celebrazioni di riti religiosi per le offerte alle divinità, giustificando la preziosità di taluni phialai. Inoltre, si riscontrano frequentemente i motivi delle ghiande (già dalla fine del VI secolo a.C. a Cipro), le palmette, le api, i fiori di loto, i viticci (quest’ultimi diffusi soprattutto nelle produzioni di Età ellenistica). Nella Phiale Aurea di Caltavuturo, gli elementi citati sono combinati e intessuti in una elegante trama capace di esaltare la preziosità della
materia prima: si crea così una cifra decorativa armonica che vieppiù esibisce un’abile manualità. Si riscontra un’iscrizione alta circa 1 cm, in caratteri greci, databili tra fine del IV e l’inizio del III secolo a.C.. Escludendone il bordo, la vasca è interamente decorata con le tecniche a sbalzo, punzonatura e cesellatura ottenute per mezzo di microbulini dalla punta assai fine. La decorazione risulta così a rilievo sul lato esterno del piatto, formando quattro fasce concentriche. Per le decorazioni riscontrate, la Phiale Aurea “siciliana” vanta molte sorelle; tra queste la Phiale rinvenuta in Tracia ne dopoguerra e conservata oggi presso il Metropolitan Museum di New York.
Paragrafo 3. La Sfera d’Oro dei Padri Filippini all’Olivella presso il Palazzo Abatellis La Sfera d’oro è un magnifico
ostensorio che, quasi giunti al termine del nostro excursus, dà un’ulteriore prova del rapporto tra nobiltà, opulenze, religione e oreficeria. In oro e argento, smalti e diamanti, rappresenta un unicum dell’oreficeria palermitana della prima metà del XVII secolo. La sua realizzazione si deve alla donazione di Donna Anna Graffeo moglie del Conte Majno, milanesi e trasferitisi in Sicilia al seguito del viceré Emanuele Filiberto di Savoia. La
nobildonna, rimasta vedova ed in seguito alla precoce scomparsa del figlioletto, si ammalò e decise pertanto di ritirarsi in clausura. La scelta fatta portò alla donazione di tutti i suoi beni, tra i quali i preziosi. Questi ultimi – argenterie e gioielli – per opera dell’orafo Leonardo Montalbano, vennero fusi e riutilizzati, assieme alla pietre preziose, per la realizzazione della Sfera d’oro donata alla Chiesa dei Padri Filippini all’Olivella.
49

Sicilia Preziosa
Purtroppo, due secoli dopo, essa fu oggetto dello scempio di ladri che, per poterne ricavare maggiori utili, la danneggiarono frantumandola in più di 300 pezzi. Fortunatamente è stata rinvenuta e, grazie all’apporto dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, è stata ricostruita. Consci delle difficoltà oggettive delle fasi di lavoro, i restauratori dell’Opificio hanno adoperato – e
sperimentato per la prima volta – la tecnica della saldatura laser. Questa tecnica ha permessa, cosa tra l’altro complessa durante i restauri, la ricostruzione archetipa del pezzo senza interventi ipotetici. A fianco dell’Opificio, il Palazzo Abatellis, che ospita la Galleria Regionale, ha dato un grande contributo ed oggi custodisce l’ostensorio. Il Palazzo Abatellis, chiamato anche Palazzo Patella, è collocato al centro di Palermo ed è già esso stesso un importante esemplare di architettura gotico-catalana (fine del XV secolo). Residenza di Francesco Abatellis, divenne poi – per volontà testamentarie – un monastero per sole donne. Per le esigenze religiose, il Palazzo andò man mano dotandosi di opere d’arte, la qual cosa ha agevolato in seguito l’ordinamento del percorso espositivo della Galleria. Ha ricevuto alcuni interventi restauro che ne hanno concesso la riapertura al pubblico nel Novembre del 2009, mostrando nuove ali museali ed una terrazza sul tetto. Come citato prima la Sfera d’oro è in mostra a conclusione del percorso, all’interno della Sala Verde.
Paragrafo 4. Il Museo Diocesano di Monreale Il Museo Diocesano di Monreale, inaugurato nell’Aprile del 2011, è un museo di arte
cristiana che espone opere da fruire nonché testimonia la storia e la simbologia della devozione del popolo monrealese. Ospitato nel Palazzo di Arcivescovile ed è distribuito su
(72)
50

Sicilia Preziosa
tre livelli: a piano terra, è posto un lungo ingresso che conduce alla Sala di San Placido che si apre sul chiostro; al primo piano, vi sono due sale che accolgono le opere più antiche della Diocesi; al secondo piano, in due grandi sale comunicanti, l’allestimento museale – esponendo parati e suppellettili commissionati dagli Arcivescovi – testimoniano la storia della Diocesi.
Il percorso è organizzato seguendo una progressione cronologica, dando prova – per la scelta dei manufatti dall’importante interesse artistico, assai vari e con una particolare attenzione alle opere d’arte cristiana – del passaggio da un collezionismo privato che, attraverso la donazione, viene fruito pubblicamente.
Il Museo si è prestato, inoltre, come sede idonea ad ospitare importanti mostre, tra cui “Sicilia Ritrovata” – dal 7 Giugno al 7 Settembre 2012 – durante la quale la Sala San Placido contenuto un cospicuo tesoro proveniente dai Musei Vaticani ma che vanta la manifattura orafa siciliana, nella fattispecie palermitana. Emblematici pezzi in mostra sono il Pastorale argenteo lavorato a sbalzo e cesello, datato XVIII secolo, con sofisticati rami ornamentali che seguono la voluta o ancora il Reliquiario ad ostensorio raggiato in bronzo dorato e argento (1696) anch’esso riccamente lavorato.
Parte integrante dell’itinerario è la Cappella del Crocifisso, commissionata dall’Arcivescovo Giovanni Roano, spagnolo d’origine, posto alla guida dalla Diocesi dal 1673 al 1703. Fu uomo assai dotto ed intraprendente; pertanto si fece committente di numerose opere d’arte per arricchire la sua sede. Non mancò, così, la realizzazione di preziose suppellettili liturgiche e paramenti sacri; capolavori dell’arte orafa siciliana sono il pastorale, l’ostensorio e la palmatoria in filograna d’argento e pietre policrome.
(73)
(74)
51

Sicilia Preziosa
Note al testo 1 M. C. Di Natale (a cura di), Splendori di Sicilia, arti decorative dal Rinascimento al Barocco, Charta Editori, Milano, 2001, p. 23. 2 M. Accascina, L'oreficeria italiana, in Novissima Enciclopedia Illustrata, Firenze, 1934; M. Accascina, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Edizioni Flaccovio, Palermo, 1976. 3 V. Abbate (a cura di), Wunderkammer siciliana alle origini del museo perduto, Electa Editore, Napoli, 2001, p. 67. 4 E. Steingraber, Oreficeria dal Rinascimento al Liberty, Fabbri Editori, Milano, 1996, p. 7. 5 C. Guastella, Orafi e argentieri nella Sicilia feudale, in Kalòs, Anno VIII n° 2 Marzo-Aprile, Edizioni Ariete, 1996, p. 24. 6 E. Steingraber, Oreficeria dal Rinascimento al Liberty, Fabbri Editori, Milano, 1996, p. 121. 7 Ivi. 8 Cit. E. Steingraber, Oreficeria dal Rinascimento al Liberty, p. 136. 9 A. Cottone, L’art déco e il disegno, in Nuove Effemeridi, Anno III n. 31, 1995, p. 42. 10 Cit. A. Cottone, L’art déco e il disegno, p. 48. 11 A. Lipinsky, Oreficeria e argenteria in Europa dal XVI al XIX secolo, DeAgostini, Novara,
1963, p. 23. 12 E. Tartamella, Corallo, Storia e arte dal XV al XIX secolo, Maronda Editrice, 1986, pp. 7-8. 13 Ibidem, p. 14. 14 Ibidem, p. 18. 15 Ibidem, p. 117. 18 Ibidem, p. 124. 17 C. Ciolino, Tesori del Duomo di Messina, in Kalòs, Anno 6 n° 3/4, Maggio-Agosto, Edizioni Ariete, 1994, p. 29. 20 M. C. Di Natale, Il tesoro nascosto della Madonna di Trapani, in Kalòs, Anno 8 n° 1, Gennaio-Febbraio, Edizioni Ariete, 1996, p. 16.
52

Sicilia Preziosa
Note alle immagini
Foto 1, Copertina, Pepita d’oro, provenienza Internet.
Foto 2, Insieme di gemme e pietre preziose, provenienza Internet.
Foto 3, Placca d’oro di epoca romana, provenienza Internet.
Foto 4, Monete d’oro di epoca antica, provenienza Internet.
Foto 5, Monete d’argento di epoca antica, provenienza Internet.
Foto 6, Anello a sigillo di epoca romana, provenienza Internet.
Foto 7, Orecchino in oro e pietre dure di epoca romana, provenienza Internet.
Foto 8, Bracciale in oro e pietre dure di epoca romana, provenienza Internet.
Foto 9, Anello in oro e pietra dura di epoca romana, provenienza Internet.
Foto 10, Stampa antica sulla lavorazione dei metalli preziosi, provenienza Internet.
Foto 11, Stampa antica sulla lavorazione dei metalli preziosi parte II, provenienza
Internet.
Foto 12, Calice in oro di epoca rinascimentale, provenienza Internet.
Foto 13, Calice in argento di epoca rinascimentale, provenienza Internet.
Foto 14, Coppa in oro di epoca rinascimentale, provenienza Internet.
Foto 15, Calice “madonita”, provenienza Internet.
Foto 16, Calice “madonita”, provenienza Internet.
Foto 17, Dama del ‘600 con gioielli alla “moda spagnoleggiante”, provenienza
Internet.
Foto 18, Corona Barocca, provenienza Internet.
Foto 19, Ciondolo in oro e smalti di epoca barocca, provenienza Internet.
Foto 20, Ciondolo in oro e smalti con perle pendenti di epoca barocca, provenienza
Internet.
53

Sicilia Preziosa
Foto 21, Coppia di caraffe in argento lavorato a sbalzo di epoca barocca, provenienza
Internet.
Foto 22, Collana in oro con “pietra stregonia” e ambra pendente di epoca barocca,
provenienza Internet.
Foto 23, Medaglione in oro con gemme preziose e smalti in stile Rococò, provenienza
Internet.
Foto 24, Cammeo del XIX secolo, provenienza Internet.
Foto 25, Cammeo del XIX secolo, provenienza Internet.
Foto 26, Sacchetto con diamanti, provenienza Internet.
Foto 27, Orecchini in oro e pietre preziose (diamanti e smeraldi) in stile Decò,
provenienza Internet.
Foto 28, Pendente a ramo in oro e pietre preziose (rubini e diamanti) in stile Decò,
provenienza Internet.
Foto 29, Ciondolo a croce in oro e pietre preziose (zaffiri, rubini, diamanti) e perle
pendenti in stile Decò, provenienza Internet.
Foto 30, Spilla in oro e smalti in stile Nouveau, provenienza Internet.
Foto 31, Spilla in oro e smalti con pietre preziose (smeraldi, diamanti) e perle
pendenti in stile Nouveau, provenienza Internet.
Foto 32, Particolare di spilla in oro e pietre preziose in stile Decò, provenienza
Internet.
Foto 33, Spilla in oro e pietre preziose (diamanti e smeraldi) in stile Decò,
provenienza Internet.
Foto 34, Spilla in oro e smalti e pietre preziose in stile Nouveau, provenienza
Internet.
Foto 35, Mucchietti di minerali, provenienza Internet.
54

Sicilia Preziosa
Foto 36, Lingotti d’oro, provenienza Internet.
Foto 37, Fase di lavorazione dell’oro, provenienza Internet.
Foto 38, Fase di lavorazione dell’oro parte II, provenienza Internet.
Foto 39, Fase di lavorazione dell’oro parte III, provenienza Internet.
Foto 40, Fase di lavorazione dell’oro parte IV, provenienza Internet.
Foro 41, Lingotti d’argento, provenienza Internet.
Foto 42, Fase di lavorazione dell’argento, provenienza Internet.
Foto 43, Pezzo in argento lavorato a sbalzo, provenienza Internet.
Foto 44, Ramo di corallo, provenienza Internet.
Foto 45, Amuleto dal valore apotropaico in corallo, provenienza Internet.
Foto 46, Scrigno in oro e corallo, provenienza Internet.
Foto 47, Calice in argento e corallo, provenienza Internet.
Foto 48, Presepe in materiali pregiati e corallo, provenienza Internet.
Foto 49, Pendente con “pietra stregonia” in corallo, provenienza Internet.
Foto 50, Fase di lavorazione del corallo con microbulini, provenienza Internet.
Foto 51, Fase di lavorazione del corallo, provenienza Internet.
Foto 52, Barriera corallina mediterranea, provenienza Internet.
Foto 53, Filze di corallo, provenienza Internet.
Foto 54, Stampa ottocentesca dell’incisore Bova circa la pesca del corallo in Sicilia,
provenienza T. Augello, La Sicilia nelle incisioni del Bova.
Foto 55, Busto reliquiario di Sant’Agata in Catania, provenienza Internet.
Foto 56, Tesoro su velluto rosso di San Sebastiano in Acireale, provenienza Internet.
Foto 57, Tesoro su velluto rosso di San Sebastiano in Acireale parte II, provenienza
Internet.
Foto 58, Reliquiario di San Pietro e Paolo in Caltanissetta, provenienza Kalòs.
55

Sicilia Preziosa
Foto 59, Reliquiario di San Marziano in Messina, provenienza Kalòs.
Foto 60, Croce argentea verso in Messina, provenienza Kalòs.
Foto 61, Croce argentea recto in Messina, provenienza Kalòs.
Foto 62, Ostensorio a reliquiario in Messina, provenienza Kalòs.
Foto 63, Ciondolo in oro e perle di epoca antica in Taormina, provenienza Kalòs.
Foto 64, Orecchino a navicella in oro e pietre preziose in Taormina, provenienza
Kalòs.
Foto 65, Anello in oro con pietra dura in Taormina, provenienza Kalòs.
Foto 66, Reliquiario a pendente in oro e smalti con pietre preziose in Trapani,
provenienza Kalòs.
Foto 67, Pendente con “pietra stregonia” in corallo in Trapani, provenienza Kalòs.
Foto 68, Corona di Costanza d’Aragona in Palermo, provenienza Internet.
Foto 69, Particolare della Phiale Aurea presso Himera, provenienza Kalòs.
Foto 70, Particolare della Phiale Aurea presso Himera parte II, provenienza Kalòs.
Foto 71, Phiale Aurea di Caltavuturo presso Himera, provenienza Kalòs.
Foto 72, Sfera d’oro dei Padri Filippini all’Olivella in Palermo, provenienza Kalòs.
Foto 73, Pastorale argenteo in Monreale, provenienza Kalòs.
Foto 74, Ostensorio a reliquiario raggiato in Monreale, provenienza Kalòs.
56

Sicilia Preziosa
BIBLIOGRAFIA Volumi
V. Abbate (a cura di), Wunderkammer siciliana alle origini del museo perduto, Electa,
Napoli, 2001.
M. Accascina, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Flaccovio Editore, Palermo,
1974.
T. Augello, La Sicilia nelle incisioni del Bova, Edizioni Giada, Palermo, 1983.
M. C. Di Natale (a cura di), Ori e argenti di Sicilia, dal Quattrocento al Settecento,
Electa, Milano, 1989.
M. C. Di Natale, G. Cornini, U. Utro (a cura di), Sicilia ritrovata, arti decorative dai
Musei Vaticani e dalla Santa Casa di Loreto, Edizioni Plumelia, Palermo, 2012.
A. Gioli, Monumenti e oggetti d'arte nel Regno d'Italia. Il patrimonio artistico degli
enti religiosi soppressi tra riuso, tutela e dispersione. Inventario dei beni delle
corporazioni religiose, 1860-1890, IPZS, Roma 1998.
A. Lipinsky, Oreficeria e argenteria in Europa dal XVI al XIX secolo, DeAgostini,
Novara, 1963.
A. Lipinsky, Marchi dell’argenteria e oreficeria europee dal XVI al XIX secolo,
DeAgostini, Novara, 1966.
M. Serraino, Storia di Trapani, Vol. II, Corrao Editori, 1992.
E. Steingräber, Oreficeria dal Rinascimento al Liberty, Fabbri Editori, Milano, 1996.
E. Tartamella, Corallo, Storia e arte dal XV al XIX secolo, Maronda Editrici, Palermo,
1986.
57

Sicilia Preziosa
Riviste o Nuove Effemeridi, rassegna trimestrale di cultura, Anno VIII, n° 31, Edizioni Guida,
1995.
o Kalòs, arte in Sicilia, Anno 6 n° 3/4, Maggio-Agosto, Edizioni Ariete, 1994.
o Kalòs, arte in Sicilia, Anno 8 n° 1, Gennaio-Febbraio, Edizioni Ariete, 1996.
o Kalòs, arte in Sicilia, Anno VIII n° 2 Marzo-Aprile, Edizioni Ariete, 1996.
o Kalòs, arte in Sicilia, Anno 10 n° 1, Gennaio-Febbraio, Edizioni Ariete, 1998.
o Kalòs, arte in Sicilia, Anno 10 n° 5/6, Settembre-Dicembre, Edizioni Ariete , 1998.
o Kalòs, arte in Sicilia, Anno 11 n° 1, Gennaio-Febbraio, Edizioni Ariete, 1999.
o Kalòs, arte in Sicilia, Anno 13 n° 1, Gennaio-Marzo, Gruppo Editoriale Kalòs, 2001.
o Kalòs, arte in Sicilia, Anno 14 n° 2, Aprile-Giugno, Gruppo Editoriale Kalòs, 2002.
o Kalòs, arte in Sicilia, Anno 15 n° 1, Gennaio-Marzo, Gruppo Editoriale Kalòs, 2003.
o Kalòs, arte in Sicilia, Anno 19 n° 1, Gennaio-Marzo, Edizione Ariete, 2007.
o Ciao Sicilia, Anno V n° 7, Luglio, Electa, 1989.
o Ciao Sicilia, Anno VII n° 8/9, Agosto-Settembre, Electa, 1991.
o Sikania, Anno V n° 7, Luglio, Krea, 1989.
o Sikania, Anno XV n° 2, Febbraio, Krea, 1999.
58

Sicilia Preziosa
Sitografia
http://www.it.wikipedia.org
http://www.guidasicilia.it
http://www.museodiocesanomonreale.it
http//:www.regione.sicilia.it
http//:www.SalvalarteSicilia.it
http//:www.unipa.it
Fine
59