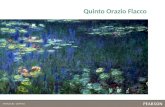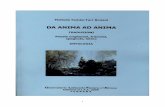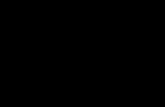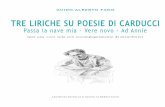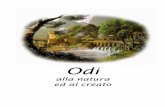ORAZIO - ODI, I, 37 · PDF fileORAZIO ODI, I, 37 Giunta a Roma la notizia della morte di...
Transcript of ORAZIO - ODI, I, 37 · PDF fileORAZIO ODI, I, 37 Giunta a Roma la notizia della morte di...
ORAZIO ODI, I, 37
Giunta a Roma la notizia della morte di Cleopatra (30 a.C), Orazio compose quest'ode per manifestare la propria esultanza e celebrare la definitiva vittoria sulla regina dell'Oriente che, insieme ad Antonio, aveva osato minacciare la recente stabilità raggiunta dall'impero. All'inizio il poeta incita alla gioia per la lieta notizia; fa seguire quindi l'esaltazione per le gesta di Ottaviano, che sconfigge la nemica e fulmineamente la insegue. Poi però tributa un omaggio pensoso alla regina vinta ma non doma: Cleopatra, infatti, preferisce darsi la morte di propria mano, piuttosto che cadere nelle mani del vincitore.
Metro: Strofe alcaica
Nunc èst bibèndum, nùnc pede lìbero
Pulsànda tèllus, nùnc Saliàribus
Ornàre pùlvinàr deòrum
Tèmpus erèt dapibùs, sodàles.
Ante hàc nefàs depròmere Caècubum 5
Cellìs avìtis, dùm Capitòlio
Regìna dèmentìs ruìnas
Fùnus et ìmperiò paràbat
Contàminàto cùm grege tùrpium
Morbò viròrum, quìdlibet ìnpotens 10
Speràre fòrtunàque dùlci
Èbria. Sèd minuìt furòrem
Vix ùna sòspes nàvis ab ìgnibus,
mentèmque lýmphatàm Mareòtico
redègit ìn veròs timòres 15
Caèsar ab Ìtalià volàntem
Remìs adùrgens àccipitèr velut
Mollìs colùmbas àut leporèm citus
Venàtor ìn campìs nivàlis
Haèmoniaè, daret ùt catènis 20
Fatàle mònstrum. Quaè generòsius
Perìre quaèrens nèc mulièbriter
Expàvit ènsem nèc latèntis
Clàsse cità reparàvit òras,
Ausa èt iacèntem vìsere règiam 25
Voltù serèno, fòrtis et àsperas
Tractàre sèrpentès, ut àtrum
Còrpore cònbiberèt venènum,
delìberàta mòrte feròcior:
saevìs Libùrnis scìlicet ìnvidens 30
privàta dèducì supèrbo
nòn humilìs mulièr triùmpho.
Traduzione
Ora si deve bere, e con il piede battere la terra in libertà, ora, era già tempo, amici, di ornare il convito sacro degli dei con vivande dei sacerdoti Salii. Era sacrilegio, prima d'ora, trarre dalle cantine avite il Cecubo riposto, mentre al Campidoglio preparava la regina folli rovine e morte all'impero, lei, col suo greggio immondo di uomini turpi, sfrenata nelle sue speranze, ubriacata dalla dolce sua fortuna. Ma fu follia placata da quella sola nave scampata al fuoco, e la sua mente allucinata dal vino di Mareia Cesare ricondusse alla realtà
paurosa, incalzando con la forza dei remi lei che veloce fuggiva dall'Italia, come sparviero incalza le tenere colombe, come il cacciatore le lepre che corre nelle pianure della nevosa Emonia, per consegnare alle catene quel segno funesto del destino. Ma nobilmente lei cercò la morte; non ebbe femminile timore della spada né ripiegò con la flotta veloce verso coste remote: e osò guardare la sua reggia umiliata con sereno sguardo, coraggiosa a toccare terribili serpenti per assorbire nel suo corpo il nero veleno, resa più fiera dalla morte così deliberata, per sottrarsi ai vascelli nemici, per impedire d'essere condotta, come donna comune, lei, donna regale, al superbo trionfo.
Analisi testuale
Il Carmen I, 37, intitolato "La morte di Cleopatra", inizia con l'anafora "Nunc est bibendum, nunc pede libero...nunc Saliaribus." ripetuta per tre volte per sottolineare la gioia improvvisa della notizia della morte di Cleopatra. "Est bibendum" è una perifrastica passiva impersonale, mentre ritroviamo con "pulsanda" una perifrastica passiva personale, entrambe segno di gioia e d'esortazione di festa. L'ablativo strumentale "Saliaribus dapibus"fa parte di una struttura che in realtà sarebbe "nunc, sodales, tempus erat ornare pulvinar deorum Saliaribus dapibus. "Pulvinar" è la metonimia che sta per letto tricliniare su cui erano poste le immagini degli Dèi per rendere loro omaggio offerte.
Nel verso 4 è usato il verbo all'imperfetto "erat" per sottolineare che l'avvenimento è già avvenuto; in seguito alla fine del verso troviamo "sodales" che è un vocativo, riferito ai compagni esortati a festeggiare.
La seconda quartina è introdotta da "Antehac", termine che è contrapposto all'anafora "nunc", nefas è un sostantivo indeclinabile seguito da erat, che è sottinteso; "cellis avitis" è un ablativo di allontanamento.
Il "dum", che introduce una subordinata, temporale con l'imperfetto "parabat", è seguito da "Capitolio regina", termine molto importante perché rappresenta la contrapposizione dell'iberbato tra Roma, testimoniata dal monte Capitolino, e l'Egitto, regno di Cleopatra ( possiamo definirla come callida iunctura).
"dementis"è la forma arcaica di dementes, ed è un'ipallage perché concettualmente il termine è legato a regina, ma grammaticalmente è vicino a ruinas.
Il termine funus è un'anastrofe, e si può osservare come ci sia un chiasmo negli ultimi due versi: "Capitolio ruinas et funus imperio parabat.".
"cum grege", nel verso 9, è un complemento di compagnia. Il periodo che inizia con "Sed minuit." navis è il soggetto del verbo minuit, mentre il termine mentemque è l'oggetto del verbo redegit. Cesare di cui parla Orazio è Ottaviano, ed è il soggetto della frase;qui possiamo ritrovare un chiasmo con l'ordine "minuit furorem navi set mentem redegit Caesar; "volantem"è un
participio ed è oggetto di adurgens; "remis" sta al posto di navibus ed è quindi una metonimia.;nel verso 18 il termine mollis in realtà è una forma arcaica di molles ed è associato a columbas.
Nel verso 20 "daret ut catenis" è un'anastrofe e sottolinea il desiderio di Ottaviano di riportare Cleopatra a Roma in catene e festeggiare.
Con "fatale mostrum"è chiamata Cleopatra, ormai trattata come il male assoluto di un mostro ma fatale, vale a dire voluto dal fato. In seguito nel testo però si ritrovano degli aggettivi non negativi come mostrum fatale: Orazio fa notare come Cleopatra non sia voluta morire come una "muliebriter, una donnicciola che è avv.di modo, e né abbia temuto la spada, ensem, che è una metonimia rappresentando tutto l'esercito di Ottaviano. Ciò sottolinea il fatto che nonostante le sue caratteristiche negative, Cleopatra sul punto di morte acquista la dignità di un vero eroe.
Questo tema si può riscontrare anche nell'ultima quartina del carmen dove Orazio ha saputo esprimere la dignità di Cleopatra che preferisce la morte piuttosto che la schiavitù. Molti aggettivi la accompagnano:demens, impotens, ebria,furens.
Commento
La lirica civile rivestì per Orazio un significato importante. L'ode per la morte di Cleopatra è un testo molto bello, che riflette con energia la drammatica attualità di momenti decisivi della storia recente e lascia presagire i toni ispirati dalle odi romane che costituiscono per noi, assieme al Carmen speculare, un documento di prima mano sugli scopi e i contenuti dell'ideologia augustea. Celebrando Augusto come salvatore divino, come portatore di un nuovo ordine nel mondo (e/o come restauratore della libera res publica di un tempo), Orazio riesce a elevarsi, almeno a tratti, a momenti di vera tensione poetica, dal timbro sublime, pindarico. Parlare di Orazio come di un poeta augusteo suscita peraltro interrogativi e dubbi. Sappiamo per esempio che il poeta venosino non volle mai farsi cantore epico delle gesta di Augusto. A pressioni in tal senso egli allude già nella satira II e vi ritorna in seguito nelle odi I, 6 (ad Agrippa), II, 12 (a Mecenate) e IV, 15: in questi testi Orazio dichiara la propria inadeguatezza rispetto a compiti così impegnativi; la sua ispirazione, egli afferma, lo conduce a un tipo di poesia diversa, di tono raccolto e intimo, di breve respiro. In questo si legge l'orgoglio che Orazio nutriva per la propria vocazione di poeta che predilige una musa più sincera e più riposta. D'altra parte però anche la lirica greca aveva conosciuto, grazie ad Archiloso, Ipponatte, Alceo, Simonide e Pindaro, una grande tradizione di impegno politico: è da essa che Orazio trae la spinta a conferire alla propria ispirazione nuovi compiti cilvili. Orazio aderì con sincera convinzione alla nuova moralità proposta dal regime; e ciò prese a volte il sopravvento sul poeta malinconico e disincantato, il cantore della fragilità e precarietà dell'uomo.