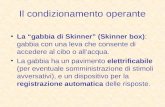Oliva 4043 gabbia
Transcript of Oliva 4043 gabbia

4
A Samuele

5
Introduzione Il 10 giugno 1940 la voce energica di Mussolini annuncia dal balcone di Palazzo Venezia che «la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Francia e Gran Bretagna e di Francia»; l’8 settembre 1943 la voce rauca del maresciallo Badoglio annuncia per radio che «il governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di continuare l’impari lotta, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower». Dal vitalismo aggressivo alla mestizia silenziosa: in mezzo, più di tre lunghi anni e mezzo infiniti, tra sconfitte al fronte, città bombardate, pane nero, alpini che non tornano dalla Russia e paracadutisti che muoiono a El Alamein. La guerra fascista 1940-43 è l’epilogo drammatico di una stagione dove la retorica della parola oscura la ragione: ultima arrivata tra le nazioni industrializzate, l’Italia degli «otto milioni di baionette» entra in conflitto contro il mondo, prima Francia e Gran Bretagna, poi anche Unione Sovietica e Stati Uniti. La disfatta è implicita nella sproporzione tra le ambizioni imperialiste del regime e le possibilità reali di un paese che dispone di tante braccia e pochi carri armati e che per produrre armi deve prima trovare chi gli venda ferro e carbone. Alleato con la Germania di Hitler in un rapporto sospettoso, inizialmente di competizione e subito dopo di subalternità, il fascismo ne segue la parabola, sprofondando la nazione e se stesso nella rotta: «non abbiamo alternative, vincere con la Germania o perdere con essa» afferma il duce nella primavera del 1943, quando gli angloamericani hanno ormai conquistato «Tripoli, bel suol d’amore» e stanno preparando lo sbarco in Sicilia.
Oggetto di numerosissimi approfondimenti storiografici su singole campagne militari, il periodo 1940-43 difetta di quadri d’insieme, per i quali in genere si rimanda al lavoro di Giorgio Bocca, Storia d’Italia nella guerra fascista 1940-43, pubblicato quasi mezzo secolo fa. Dalla constatazione di questo vuoto della bibliografia nasce il lavoro di sintesi proposto in questo volume, dove viene tracciato il profilo del periodo seguendo tre direttrici principali. In primo luogo, le scelte politiche di Mussolini, stretto tra le accelerazioni strategiche di Hitler, le diffidenze reciproche tra Roma e Berlino, i limiti dell’economia nazionale e il peso di un’autorappresentazione ventennale che si decompone alla prova del conflitto. In secondo luogo, le operazioni militari, dalla «guerra parallela» dell’estate-autunno 1940 (la campagna sulle Alpi Occidentali, i movimenti di Graziani in Africa settentrionale e del duca d’Aosta in Africa orientale, l’attacco alla Grecia) alla «guerra subalterna» degli anni

6
successivi, con il Regio Esercito subordinato alla Wehrmacht nei Balcani, in Africa, in Russia. In terzo luogo, il fronte interno con il progressivo raffreddamento del consenso al fascismo e il venir meno del blocco sociale che lo ha sostenuto, sino alla perdita della capacità di controllo del regime (espressa dalle manifestazioni di aperta insofferenza del marzo 1943) e alla sua caduta silenziosa il 25 luglio («Ma che cos’era questo fascismo che si è sciolto come neve al sole?» chiederà Hitler). Accanto a questi percorsi che attraversano cronologicamente tutto il periodo, un approfondimento di cui si trovano ancora poche tracce nella ricerca: i crimini di guerra commessi da reparti del Regio Esercito nella lotta contro la Resistenza partigiana nei Balcani, la dottrina di impiegodella controguerriglia fissata dalla Circolare 3C di Roatta, i campi di concentramento per slavi, sino alle richieste di estradizione per crimini contro i civili avanzate a fine guerra dai governi dei paesi occupati. La conclusione è dedicata all’armistizio dell’8 settembre, ricostruito nei diversi teatri, atto finale di una guerra in cui muore l’Italia fascista.
L’ambizione è che la sintesi possa servire ai più giovani, perché a ottant’anni dallo scoppio del secondo conflitto mondiale la memoria di quanto accaduto sta sfumando. La mia generazione ha avuto la fortuna di nascere quando la guerra era ormai terminata, ma le ferite che aveva lasciato bruciavano ancora e si riversavano nei racconti: nelle famiglie, nelle scuole, nelle piazze, nei mercati, dovunque si ascoltavano storie di rifugi antiaerei, o di farina comprata al mercato nero, o della ritirata nelle steppe russe. Tutti avevano vissuto la guerra, al fronte o a casa, e ne trasmettevano il ricordo in forma semplice e naturalespontanea. Attraverso quei racconti la nostra generazione è cresciuta ed è stata educata a un sistema di valori: abbiamo imparato che cos’è la pace sentendo parlare della paura per le bombe, per il passo degli anfibi sui selciati, per i giovani morti nella neve o nella sabbia; abbiamo imparato che cos’è il benessere sentendo raccontare della fame, della «tessera», dei surrogati senza gusto; abbiamo imparato che cos’è la libertà sentendo ricordare una stagione in cui, prima di parlare, bisognava guardarsi attorno per vedere se c’era qualcuno di troppo che ascoltava.
Quella trasmissione generazionale di memoria, per ovvie ragioni anagrafiche, è venuta meno e il rischio, per i più giovani, è crescere pensando che tutte le garanzie di cui fruiamo oggi siano definitive: la storia dell’umanità insegna che nulla è dato per sempre e che le conquiste vengono conservate solo se si ha la consapevolezza del loro significato. Alla forza educativa delle testimonianze dirette bisogna

7
sostituire la conoscenza del passato, quella che si acquisisce attraverso lo studio della storia, le proposte dei media, le suggestioni della rappresentazione letteraria o cinematografica. Purtroppo nel nostro paese vige un sistema scolastico dove la storia è poco in onore e la storia antica ha assai più spazio della storia contemporanea. Qualsiasi studente ha sentito parlare della battaglia di Canne, o di Annibale, o di Ottaviano Augusto; pochi sanno collocare Stalingrado, lo sbarco in Sicilia, Rommel; quasi nessuno Badoglio, Ciano, Von Ribbentrop. Bisognerebbe prendere atto delle lacune e avere il coraggio di riformare radicalmente i programmi: se non è possibile dedicare maggiore tempo alla storia, allora la si studi dalla Rivoluzione francese in poi e si riducano tutti i secoli precedenti a grandi quadri d’insieme. Da storico, mi piange il cuore; da cittadino, preferisco nuove generazioni consapevoli del loro presente. E il presente è figlio del passato prossimo, non del passato remoto.

8
I La campagna delle Alpi Occidentali
Una dichiarazione avventata [La campagna delle Alpi occidentali è il titolo del capitolo II]
10 giugno 1940, il balcone di piazza Venezia
Lunedì 10 giugno 1940 è una giornata di sole spavaldo, ma e a Roma grava un caldo afoso: quando le vetrate si aprono e Mussolini si affaccia al balcone di Palazzo Venezia sono le 18.00 appena passate e la piazza davanti brulica di camicie nere già inzuppate di sudore. I primi gruppi sono arrivati alle 15.00, gli altri si sono allineati a mano a mano, riempiendo anche via del Plebiscito, corso Umberto (l’attuale via del Corso), via dei Fori Imperiali, la salita che porta a via Nazionale. Adesso lo schieramento è completo, fitto di facce tese, in una selva di gagliardetti, labari, vessilli, stendardi, bandiere. Pietro Capoferri, che regge la segreteria del partito, ordina il «saluto al Duce» e la folla, secondo un rito collaudato, urla in risposta: «A noi!». Il duce fissa la piazza con sguardo marziale: dietro di lui, lo stato maggiore del regime, il ministro degli Esteri Galeazzo Ciano, quello dell’Educazione nazionale Giuseppe Bottai, quello della Cultura popolare Alessandro Pavolini. Subito dopo scende un silenzio grave. Tutti sanno che il duce annuncerà la guerra, tutti la vogliono e tutti la temono. Le mani appoggiate in avanti sulla pietra del davanzale, il labbro inferiore sporgente, la mascella stretta, Mussolini rotea gli occhi sulla folla guardando tutti senza vedere nessuno. Poi, da attore consumato, esordisce con la voce bassa e profonda: «Combattenti di terra, del mare e dell’aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d’Italia, dell’Impero e del regno d’Albania, ascoltate. Un’ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra Patria». I grandi altoparlanti Marelli diffondono le parole con un sottofondo rauco, che è già rumore di battaglia. Il duce alterna il fragore dell’annuncio alle pause di silenzio: la raffica di una frase forte a effetto («È l’ora delle decisioni irrevocabili», ripetuto due volte [nel filmato e nell’audio ripete soltanto «l’ora» non tutta la frase però]perché penetri bene nelle coscienze), un’interruzione che attraversa la folla come un fremito, poi il boato fatale: «La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia».

9
La piazza risponde con urla, applausi, cori, tricolori al vento. Un lungo minuto di frenesia, al di fuori degli schemi convenzionali delle piazze fasciste, che il duce osserva con volto immobile prima di interrompere con un cenno della mano. Difficile stabilire il confine tra l’entusiasmo convinto e l’isteria di massa. Forse quella di piazza Venezia è soprattutto una reazione liberatoria, dove i cittadini in camicia nera si contagiano l’uno con l’altro. Da quando Hitler ha attaccato la Francia tutti sanno che l’Italia fascista entrerà nel conflitto: si tratta solo di decidere quando, tra una settimana, tra un mese, dopo l’estate. Gli italiani sono stati educati per vent’anni alla guerra: nei sussidiari delle elementari, nelle vignette del «Corriere dei Piccoli» e del «Balilla», nelle pagine dei giornali, hanno letto che l’Italia fascista è erede della grandezza delle legioni romane, che la guerra è l’igiene del mondo ed esalta le nazioni giovani, che il maggior orgoglio di una madre è sacrificare il figlio alla grandezza della patria e il maggior onore di un uomo è combattere anonimo per quella stessa grandezza. «Dovere», «ardimento», «energia», «sacrificio» sono concetti che hanno sentito ripetere dai maestri a scuola, dai podestà in piazza, dai cinegiornali dell’Istituto Luce, dai gerarchi in giro per la penisola, spesso dai sacerdoti nell’omelia. «Patria» (insieme a «Duce») è stata la parola più maiuscola del Ventennio. Nessuno può pensare che nel momento in cui sui campi di battaglia d’Europa si decidono i destini del continente, la patria fascista stia a guardare. Per questo le camicie nere di piazza Venezia (e le altre centinaia di migliaia, mobilitate in tutta Italia ad ascoltare in diretta il discorso trasmesso dall’Eiar, da Milano, a Napoli, a Palermo) sanno che dovranno impugnare le armi e combattere: «È l’aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende».
Ma nell’inconscio serpeggia l’inquietudine, come sempre di fronte a ciò che risulta fatale. A frenare ci sono le memorie familiari del 1915-18, i nomi dei tanti che non sono tornati, la consapevolezza che le guerre creano i regni e distruggono i destini. Tra gli aggettivi che Mussolini sceglie, «irrevocabile» è il più pertinente: ciò che succederà da domani segnerà le sorti della nazione, del regime, dei singoli individui e il conflitto sarà comunque una resa dei conti con la storia, nella vittoria come nella sconfitta. In quello stato d’animo sospeso tra attesa e timore, la dichiarazione del 10 giugno è una certezza che scioglie le ansie: se un pericolo incombe e non lo si può evitare, meglio affrontarlo subito. Per questo la frenesia di piazza Venezia ha il sapore irrazionale di un affanno sciolto. Il poeta Libero De Libero, all’epoca docente in un liceo romano, fotografa bene nelle

10
pagine del suo diario uno stato d’animo segnato di fatalismo: «Si parla sempre più della guerra. I giornali sono pieni di notizie guerresche. Mi godo le ore come fossero le ultime. Meglio vivere ora per ora, non temere se domani sarà peggiore di oggi. A chi toccherà, per primo, il colpo della morte? A uno dei miei amici? A me?».1 Giaime Pintor, che cadrà a ventiquattro anni nell’autunno del 1943 in uno dei primi episodi resistenziali, è in piazza con gli occhi al balcone «fetente» (secondo una definizione di Carlo Emilio Gadda) e scrive allo zio Pietro:
Ho finito gli esami e tra due o tre giorni una conversazione privata con il professor Cesarini mi conferirà il titolo di dottore. Queste notizie sommarie sono state interrotte dalla convocazione a piazza Venezia e dal discorso del Duce. Così una decisione che tutti aspettavamo tronca i nostri dubbi e fa di tutte le vicende interrotte un residuo trascurabile.2
Più consapevole (e malinconico) il commento di Galeazzo Ciano, che pure è stato protagonista delle scelte «irrevocabili»: la reazione della folla gli pare scontata e fondamentalmente tiepida («Mussolini parla dal balcone di Palazzo Venezia, la notizia della guerra non sorprende nessuno e non desta entusiasmi veri») e annota nel diario, con un presagio di rovina: «Io sono triste: molto triste. L’avventura comincia. Che Dio assista l’Italia». 3 Analogo il tono di Enrico Caviglia, il vecchio maresciallo del Carso e del Piave: «Purtroppo oggi mi hanno detto che anche il re è deciso a entrare in guerra. Andrà come Dio vorrà e speriamo che vada bene».4 La principessa Maria José prova un malessere profondo, un senso di fastidio preoccupato. [non citiamo virgolettati per Maria Josè?]
Lo stesso discorso del duce tradisce qualche esitazione e nel prosieguo la tensione oratoria cala. Il tono diventa esplicativo: «Noi impugniamo le armi per risolvere Dopo dopo aver sistemato leil problema risolto delle nostre frontiere continentali, il problema delle nostre frontiere marittime. noi Noi vogliamo spezzare le catene di ’ordine territoriale e militare che ci soffocano nel nostro mare, perché poiché un popolo di quarantacinque milioni di abitanti anime non è veramente libero se non ha libero accesso all’oceano». Il richiamo agli spazi dell’Atlantico si intreccia con la lotta contro le plutocrazie occidentali: «È la lotta dei popoli poveri e numerosi di braccia contro gli affamatori che detengono ferocemente il monopolio di tutte le ricchezze e di tutto l’oro della terra». L’Italia proletaria degli otto milioni di baionette è pronta a scagliarsi contro il popolo dei cinque pasti, la giovinezza ardente si contrappone alla decadenza corrotta: «È la lotta dei popoli fecondi e giovani contro i popoli

11
isteriliti e volgenti al tramonto», ribadisce il duce. La folla ascolta, applaude, ma nelle spiegazioni Mussolini non è né incisivo né trascinante: in fondo, ciò che motiva la guerra è solo il fatto che la guerra è stata scatenata, ma è stata scatenata da altri e l’Italia fascista è costretta a rincorrere la storia. Il discorso diventa giustificatorio: «La nostra coscienza è assolutamente tranquilla. Con voi, il mondo intero è testimone che l’Italia del Littorio ha fatto quanto era umanamente possibile per evitare la tormenta che sconvolge l’Europa, ma tutto fu vano».
La parola decolla invece nelle invocazioni, quando la voce si carica di rabbia potente e diventa una frustata che attraversa l’aria: «La parola d’ordine è una sola: vincere. E Vinceremo». Si alza un’ovazione convulsa che sottintende la fine del discorso, invece Mussolini aggiunge ancora una spiegazione: «Vinceremo per dare finalmente un lungo periodo di pace con la giustizia all’Italia, all’Europa, al mondo». Poi ancora un’esortazione: «Popolo italiano, corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore». La folla risponde con tre «sì» prolungati, il duce si ritira dal balcone, si riaffaccia, si ritira di nuovo: . Come ha scritto Marco Innocenti, «gli applausi sono fragorosi ma non travolgenti, non è la folla del 1936 e neanche quella del 1938, al ritorno da Monaco. Più che entusiasmo, è un lungo, sordo clamore, perché un annuncio di guerra è anche un annuncio di angoscia»5. Tra tanti discorsi pronunciati dal duce nel corso del Ventennio, l’arringa del 10 giugno è certamente tra le meno riuscite. Anche se la recitazione (dalla mimica del volto alle variazioni di tonalità) segue il copione solito, il testo è fiacco: né epico, né drammatico, fondamentalmente scolastico nei richiami demagogici, poco convincente perché poco convinto. A saper leggere tra le righe, traspaiono gli indizi di una strategia imposta dai fatti piuttosto che di una scelta liberamente maturata. Strano modo di annunciare una guerra offensiva quello di chiamarla «tormenta che sconvolge», ostentare «la coscienza tranquilla», ribadire che si è fatto «quanto possibile per evitarla».
Quando la finestra si richiude, le camicie nere rompono le righe e si sparpagliano nelle strade della capitale, rientrando senza sussulti. C’è chi si aggrappa all’illusione della vittoria facile, chi si rassicura con il mito della guerra di rapido corso, chi pensa di beneficiare senza sforzo delle avanzate germaniche. Ma le sicurezze vere, le arroganze velleitarie, sono rare tra gli stessi militanti: nei più prevale la rassegnazione a un azzardo già scritto e ora «irrevocabile». Il destino dell’Italia e del fascismo si compie così, in un pomeriggio caldo afoso

12
che annuncia l’estate romana, tra fatalismo, eccitazioni, presentimenti, inquietudini.
I giornali del giorno successivo, per contro, non registrano dubbi e veicolano l’entusiasmo ufficiale. Le veline del MinCulPop vengono trasformate in titoli prepotenti: «Vincere!» o «Vinceremo!» (oppure entrambi, sempre a caratteri cubitali).6 Il «Corriere della Sera» parla di «folgorante annuncio del Duce»; «Oggi» di «Guerra di indipendenza»; la «Gazzetta del Popolo» della «nostra guerra punica»; «Il Messaggero» sente «dalle Alpi all’Oceano Indiano un solo grido di passione e di fede: Duce!»; il «Popolo d’Italia» assicura che «i superbi saranno debellati. Essi non vollero cedere uno, dovranno dare cento»; «La Stampa» è la più sobria, spiega che «scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell’Occidente» e informa che Hitler ha inviato telegrammi a Mussolini e a Vittorio Emanuele III. Inizia la guerra e inizia la comunicazione della guerra con le sue distrazioni fuorvianti e le sue bugie dalle gambe lunghe, destinate a durare sino all’estate del 1943.
Accanto alla celebrazione dell’evento straordinario, le testate nazionali propongono le notizie rassicuranti della vita ordinaria, in una sapiente miscela di eccezionalità e quotidianità: la cronaca mondana, con le nozze tra l’infanta di Spagna Maria Cristina e il conte Enrico Marone Cinzano; le notizie dal Teatro della Scala, con i concerti applauditissimi del giovane salisburghese Herbert von Karajan; la pubblicità, con le sigarette «Macedonia», le pastiglie lassative «Euchessina», le pellicole della Ferrania; le foto di un ragazzo segaligno di ventun anni, Fausto Coppi, partito per il Giro d’Italia come gregario di Gino Bartali e arrivato in maglia rosa all’Arena di Milano. Proprio Coppi può essere considerato il simbolo di quelle giornate: il 9 giugno l’apoteosi, le descrizioni ardite di Orio Vergani («l’airone, magro come un osso di prosciutto di montagna»), gli osanna di un’Italia contadina che nei campioni del ciclismo vede i propri eroi; il 10 il viaggio in accelerato da Milano a Cuneo e di lì in corriera per raggiungere la caserma di Limone Piemonte, a ridosso del fronte alpino, dove indossa la divisa del 38° reggimento fanteria. Biciletta al chiodo, e in ventiquattr’ore dalla maglia rosa al grigioverde. Come l’Italia, dalla festa alla guerra.
Perché entrare in guerra
Il contesto generale è noto. Dopo la dissoluzione della Cecoslovacchia avallata alla conferenza di Monaco, Hitler ritiene

13
giunto il momento di scatenare la guerra, sia perché «sapeva che l’accelerato riarmo degli avversari avrebbe presto vanificato il vantaggio che la Wehrmacht si era faticosamente assicurata negli anni precedenti», sia perché il Reich «non poteva sostenere a lungo, e contemporaneamente, una produzione di beni di consumo capace di soddisfare le aspettative della popolazione e una produzione bellica adeguata ai piani di guerra che si venivano preparando».7 Di qui le accelerazioni del 1939: il 23 agosto il «patto di non aggressione» firmato a Mosca dal ministro degli Esteri tedesco Joachim von Ribbentrop e da quello sovietico Vjačeslav Molotov con la spartizione delle zone di influenza nell’Europa orientale; il 1° settembre l’attacco alla Polonia; il 28 settembre la capitolazione di Varsavia; il 6 ottobre la resa degli ultimi reparti polacchi e l’annuncio al Reichstag della fine della campagna. Nella primavera successiva l’aggressione militare si dirige verso il fronte settentrionale e quello occidentale: nella notte tra il 7 e l’8 aprile l’inizio delle operazioni contro la Norvegia (ufficialmente concluse con l’occupazione l’8 giugno), il 9 aprile la penetrazione e la conquista immediata della Danimarca, il 10 maggio l’attacco alla Francia, il 4 giugno l’evacuazione del corpo di spedizione britannico dal porto di Dunkerque, il 14 giugno la caduta di Parigi. Tra spregiudicatezze diplomatiche (il patto von Ribbentrop-Molotov-Ribbentrop provoca grande disorientamento non solo tra i comunisti, ma anche tra gli stessi nazisti) e avanzate fulminee (sotto il profilo tattico-operativo la campagna contro la Francia è trionfale), in pochi mesi l’Europa è in fiamme e la popolarità del Führer tocca il punto più alto: nessun dubbio che sia stato lui a scatenare il conflitto, lui a stabilire la strategia, lui a vincere. Nella realtà i rapporti di forza sono meno sbilanciati di quanto appaiano:
Gli Alleati vennero sconfitti non perché inferiori in fatto di uomini e mezzi, ma soprattutto perché i loro stati maggiori si mossero sulla base di criteri e principi operativi ormai superati, senza coordinamento tra esercito e aviazione e con i carri armati assegnati alle varie divisioni di fanteria anziché impiegati a massa.8
La percezione dei contemporanei è tuttavia diversa: la Wehrmacht appare invincibile e la Germania nazista una potenza economica e militare destinata a egemonizzare a breve tutto il continente.
Di fronte alle avanzate tedesche della primavera del 1940, Mussolini, che nel settembre 1939 ha scelto la non belligeranza, decide a sua volta di rompere gli indugi e di entrare in guerra. Le ragioni della svolta sono complesse. Sicuramente incidono elementi

14
soggettivi, il timore di essere relegato al ruolo di spettatore del trionfo altrui e di mancare l’occasione storica offerta dall’indebolimento delle democrazie, l’ambizione di sedersi tra i vincitori al tavolo delle trattative, la preoccupazione di mantenere alti il proprio prestigio e la propria immagine internazionale. Il protagonismo politico e le diffidenze verso l’alleato producono una consapevolezza già chiara prima dell’attacco germanico alla Francia, esplicitata in una nota di Mussolini del marzo 1940:
L’Italia non può rimanere neutrale per tutta la durata della guerra senza dimissionare dal suo ruolo, senza ridursi al livello di una Svizzera moltiplicata per dieci. Il problema non è sapere se l’Italia entrerà o non entrerà in guerra, perché l’Italia non potrà fare a meno di entrare in guerra: si tratta soltanto di sapere come e quando.9
La psicologia non è tuttavia chiave di interpretazione esaustiva. Nell’estate del 1939 Mussolini è consapevole dei ritardi militari
dell’Italia e ritiene che siano necessari tre-quattro anni per la preparazione complessiva dell’economia e delle forze armate al conflitto. Di qui i suoi sforzi prima per scongiurare lo scoppio delle ostilità, poi per ritardare il proprio intervento, sperando di precostituire nel frattempo le basi per una pace negoziata e di compromesso della quale essere l’arbitro. Gli spazi di manovra politica sono tuttavia stretti perché il dinamismo e la doppiezza di Hitler cambiano rapidamente gli equilibri. Una testimonianza diretta viene da Dino Grandi:
Nell’ottobre 1939, annunciandomi la mia nomina a Presidente della Camera, Mussolini mi ha detto, scuro in volto: «I Tedeschi ci hanno tradito, facendoci trovare di fronte al fatto compiuto della guerra e dell’intesa con la Russia, ma si accorgeranno presto del grave errore compiuto perché i loro sforzi si infrangeranno contro la linea Maginot, che è imprendibile». Mussolini non concepiva l’alleanza italo-tedesca come strumento di guerra e lo dimostra il fatto che, nonostante la sua letteratura e l’ideologia fascista-nazista, egli non volle entrare in guerra il 31 agosto 1939. In lui c’era la convinzione di una guerra breve e di una successiva pace di compromesso, non di una vittoria tedesca.10
Nella primavera del 1940, di fronte all’attacco alla Francia, il duce esita ancora, sperando in una resistenza dell’esercito transalpino e preparandosi a un ruolo di mediazione, con il quale lucrare prestigio e compensi territoriali. In meno di un mese l’offensiva della Wehrmacht consegue invece risultati travolgenti, che nessun osservatore aveva ipotizzato, e costringe a mutare rapidamente strategia:

15
All’intervento Mussolini si indusse solo quando ebbe la certezza che la Francia era ormai irrimediabilmente fuori gioco e ritenne – come disse il 29 maggio ai massimi capi militari – che la situazione in atto «non permette ulteriori indugi perché altrimenti noi corriamo dei pericoli maggiori di quelli che avrebbero potuto essere provocati con un intervento prematuro e rischiamo di dover assistere alla marcia dei Tedeschi su Marsiglia».
La sconfitta inglese a Dunkerque del 4 giugno e la rocambolesca evacuazione oltre Manica dei soldati britannici accelerano ulteriormente il processo:
Egli credette allora che, dopo la messa fuorigioco della Francia, sarebbe arrivata anche la sconfitta definitiva dell’Inghilterra oppure questa sarebbe stata indotta a negoziare una composizione del conflitto.11
Il duce teme l’espansionismo del Fürher: eliminate la Francia e l’Inghilterra, perché la Wehrmacht non dovrebbe attaccare anche l’Italia e controllare tutto l’Occidente, prima di rivolgersi a est contro il nemico storico bolscevico? Oppure perché non dovrebbe relegare l’Italia a un ruolo subalterno, condizionandone l’economia e paralizzandone l’iniziativa politica? Paradossalmente, lo stesso patto d’acciaio italo-tedesco firmato nell’estate del 1939 è un’alleanza nata più dalla diffidenza e dalla paura che dalle ambizioni militari: il fascismo si illude di poter avere in questo modo uno strumento per tenere a freno la Germania, verificandone da vicino i propositi e i movimenti.
Se i rancori personali e gli stati d’animo impetuosi sono caratteristici della personalità del duce, la decisione del 10 giugno 1940 non nasce da un moto impulsivo, ma da preoccupazioni politiche estremamente realistiche: «Mussolini aveva da un lato paura dei Tedeschi, dall’altro la consapevolezza della inferiorità sotto tutti i profili dell’Italia rispetto alla Germania». Quando decide l’ingresso in guerra, la sua priorità non è il conseguimento manu militari di compensi territoriali, ma la definizione di un ruolo politico dell’Italia nei nuovi equilibri europei come condizione di autonomia (se non di sopravvivenza) della stessa nazione:
Il suo desiderio era che la guerra fosse breve, che i Tedeschi non ne approfittassero per alterare a proprio vantaggio gli equilibri balcanici e mediterranei. Egli sperava di uscirne il meno indebolito possibile e in condizione da potersi porre come punto di riferimento e di aggregazione politica per quei paesi europei che non volevano rassegnarsi a subire più o meno passivamente l’egemonia tedesca e per i quali l’Italia sarebbe divenuta inevitabilmente l’altro polo. Solo così poteva immaginare, se non proprio di trovare a guerra finita un

16
effettivo modus vivendi con un alleato tanto più forte e spregiudicato di lui, almeno di poter tessere un nuovo gioco di equilibri diplomatici.12
Si tratta di una strada stretta e contraddittoria, quasi un vicolo cieco in cui il fascismo si è infilato con le scelte politiche degli anni precedenti: nel momento in cui la situazione dell’Europa precipita, l’azzardo della guerra diventa una prospettiva conseguente, «irrevocabile» quanto inevitabile per un regime che ha destabilizzato gli equilibri continentali, tratto alimento dalla retorica della forza, demonizzato le vecchie democrazie «egoiste» e «corrotte». Chi «non può rimanere neutrale» non è l’Italia, ma l’Italia fascista, che perderebbe la faccia e rischierebbe una crisi dalle prospettive ancora più incerte di quelle che si aprono con l’intervento.
Questi contorni generali si riflettono nel discorso del 10 giugno e, ancor più, nei commenti malinconici di alcuni esponenti del suo gruppo dirigente. I rischi sono evidenti, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta, e bisogna aggrapparsi alla speranza di una improbabile guerra breve per immaginare un equilibrio europeo in cui l’Italia fascista abbia ancora un ruolo politico internazionale significativo. Di qui le esitazioni nella retorica con cui il duce si rivolge alla folla, lo sforzo di giustificare l’aggressione anziché rivendicarla, il registro emotivo non adeguato al messaggio. «Il discorso di Mussolini è stato freddo, secco, pedestre, scandito senza impeto come recitato, senza un sussulto di responsabilità» commenta nelle pagine del suo diario Piero Calamandrei, dopo averlo ascoltato dagli altoparlanti a Firenze, e cogliendo con acume il senso dell’«ora segnata dal destino» aggiunge: «da oggi, qualunque cosa accada, il fascismo è finito. Si può proprio dire che per l’Italia da oggi comincia una novella storia. Forse più tragica e vile. M: ma insomma cambieranno presto i burattini».13
Lo slogan della «guerra di rapido corso»
Le difficoltà dell’Italia nella primavera del 1940 sono aggravate dalla particolare situazione delle forze armate, che negli anni precedenti sono state protagoniste di imprese che ne hanno aumentato il prestigio, ma anche duramente provato il sistema organizzativo. Dapprima c’è stata la «riconquista» della Libia, con i reparti del maresciallo Rodolfo Graziani impegnati in una lotta feroce e capillare per garantire la sovranità territoriale contro la resistenza delle popolazioni nomadi e seminomadi; nel 1935-36 la guerra d’Etiopia, con la mobilitazione di trecentomila uomini e centinaia di aerei e carri

17
per raggiungere l’obiettivo nel minor tempo possibile; subito dopo la proclamazione dell’Impero, la lunga «pacificazione» dell’Africa orientale italiana, – in realtà una repressione energica e sanguinosa della resistenza guerrigliera con il coinvolgimento di quasi centomila uomini del Regio Esercito (oltre a decine di migliaia di ascari); nel 1936 l’intervento nella Guerra civile spagnola a sostegno delle forze di Francisco Franco, con un corpo volontario di quarantatremila legionari; nella primavera del 1939 la campagna in Albania, con ventiduemila uomini al comando del generale Alfredo Guzzoni per trasformare in sovranità ciò che sin dal 1927 era protettorato.
I costi di queste campagne incidono fortemente sul bilancio statale e sull’efficienza dell’apparato militare. Negli stessi anni in cui gli altri paesi europei accumulano armi e sperimentano nuove tecnologie in vista di un conflitto che ormai si profila imminente, l’Italia compromette i propri arsenali con imprese che provocano la perdita o il logoramento di armi, aerei, automezzi:
Le spese eccezionali che furono compiute nei quattro esercizi finanziari dal 1936 al 1939, per un totale di quasi 49 miliardi di lire correnti, furono in gran parte costituite da spese di guerra, ma servirono solo in misura limitata a rinnovare l’armamento e l’equipaggiamento delle forze armate. Il materiale ingente che fu spedito dall’Italia in Africa orientale e in Spagna in parte fu distrutto o consumato durante le guerre, in parte rimase in Africa o fu consegnato al governo di Franco, mentre la ricostituzione delle scorte fu effettuata solo parzialmente. Se si fa il confronto con lo sforzo che in quello stesso quadriennio avevano sostenuto la Germania, la Francia e, in misura minore, l’Inghilterra, si vede che il riarmo italiano era insufficiente e tardivo e che rispetto alle altre potenze la nostra preparazione militare risultava proporzionalmente assai inferiore di quanto non lo fosse negli anni precedenti l’avventura coloniale.14
Come nel 1911-12 l’impresa di Libia disperse risorse preziose alla vigilia della Grande guerra, così l’espansionismo fascista impone alle forze armate uno sforzo pesantissimo nel momento in cui la prospettiva bellica richiederebbe invece investimenti e riorganizzazione: prima ancora che nella politica militare, il limite sta nella politica estera del regime, incapace di prevedere gli scenari futuri, di rapportare le ambizioni alle reali possibilità dell’economia nazionale, di cogliere per tempo le potenzialità e l’inaffidabilità della Germania di Hitler.
L’elaborazione teorica e la predisposizione di eventuali piani di guerra risentono dell’impostazione politica generale del Ventennio, dove le scelte sono innanzitutto subordinate alle esigenze di propaganda interna. Sino al 1935-36, i responsabili militari ritengono

18
possibile solo una guerra sulle Alpi, difensiva contro la Francia e offensiva contro la Iugoslavia: questo indirizzo (che scaturisce dalla stabilità degli equilibri europei, dal rapporto di amicizia con l’Inghilterra e dalle tradizionali mire espansionistiche verso i Balcani) si traduce in un deciso adeguamento della guerra di trincea per quanto riguarda materiali e dottrina di impiego, con sviluppo dell’artiglieria e dell’armamento della fanteria. La convinzione che a determinare l’esito del conflitto sarà il numero dei combattenti porta a «una scarsa attenzione per i mezzi più moderni affermatisi durante la guerra mondiale: vengono infatti trascurati i carri armati (“la natura dei campi di battaglia previsti ne limita molto l’impiego”, sostiene Badoglio), la motorizzazione di truppe e servizi, la collaborazione con l’aviazione».15
Il rovesciamento delle alleanze maturato dopo l’impresa etiopica, con l’avvicinamento alla Germania e la tensione con l’Inghilterra, muta i presupposti politico-strategici, spostando il centro di gravità degli interessi espansionistici italiani dalla frontiera alpina e dai Balcani al Mar Mediterraneo. Ne conseguono un nuovo ruolo per l’esercito e un’elaborazione teorica proiettata verso altri scenari operativi. Il generale Alberto Pariani, dall’ottobre 1936 all’ottobre 1939 sottosegretario alla Guerra e, contemporaneamente, capo di stato maggiore dell’esercito, ritiene inevitabile una guerra contro i franco-inglesi e sostiene che i fronti decisivi saranno Parigi per i tedeschi e per gli italiani l’Africa settentrionale, dove le nostre forze dovranno puntare dalla Libia sull’Egitto per colpire l’economia britannica con l’interruzione del passaggio di Suez. Avallati dal ministro degli Esteri Ciano, studi di fattibilità in questa direzione vengono effettuati nel 1938 da Italo Balbo, allora governatore della Libia, e dallo stesso Pariani.
Queste ipotesi implicano, a loro volta, un rovesciamento dell’impostazione strategica: per realizzare gli obiettivi, occorre che alla guerra di posizione del 1914-18 si sostituisca una nuova guerra di movimento, che il sottosegretario ritiene possibile: «Pariani crede al successo di una guerra fulminea e di sorpresa» annota Ciano nel diario. «Attacco all’Egitto da ovest concentrando truppe in Libia e sbarchi improvvisi a Porto Said e Suez».16 È la cosiddetta «guerra di rapido corso», fatta propria dalla dirigenza militare italiana alla vigilia del conflitto.
Sul piano teorico si tratta di un’intuizione giusta, sostenuta in quegli stessi anni dai maggiori studiosi militari europei, in Francia da Charles de Gaulle, in Inghilterra da James John Frederick Charles

19
Fuller e Basil Liddell Hart, in Germania da Heinz Guderian, in Unione Sovietica da Michail Tuchačevskij. Questi progetti devono però essere collegati a un profondo rinnovamento dei mezzi tecnici, che solo la Germania riesce a realizzare in tempi rapidi:17 la guerra di movimento presuppone disponibilità di divisioni corazzate e motorizzate, di mezzi blindati, di automezzi di ogni dimensione, di aviazione da bombardamento in picchiata. In Italia la «guerra di rapido corso» si riduce invece a uno slogan propagandistico senza serie reali conseguenze pratiche. L’innovazione più significativa è la trasformazione delle divisioni ternarie (costitute cioè da tre reggimenti di fanteria) in divisioni binarie (su due soli reggimenti), stabilita da Pariani con il nuovo ordinamento del dicembre 1938 per rendere i reparti più agili e più manovrabili. Si tratta di un provvedimento efficace sul piano della comunicazione, perché le divisioni passano da 30 a 51, e su quello del consenso interno al mondo militare, perché moltiplica i posti di comando, ma sul piano dell’efficienza sortisce effetti opposti. La manovrabilità è infatti strettamente collegata alla motorizzazione, che viene invece trascurata: priva di adeguati mezzi per spostarsi in modo rapido, la divisione binaria finisce per essere un elemento di debolezza, perché meno resistente agli urti e agli sforzi prolungati rispetto alla precedente divisione ternaria.
La stretta correlazione tra le capacità produttive di una nazione e la sua credibilità militare, elemento caratterizzante delle guerre del XX secolo, dovrebbe essere alla base di qualsiasi ipotesi politico-strategica. Prigioniero delle sue ambizioni e dell’esigenza di alimentare il consenso interno, il fascismo oscilla invece tra la consapevolezza dei limiti italiani, la tentazione dell’avventura in prospettiva predatoria, la rassegnazione a un azzardo imposto dal dinamismo dell’alleato. Che nel 1940 l’Italia non sia militarmente pronta è noto tanto ai responsabili militari quanto ai dirigenti fascisti. Il cosiddetto «promemoria Cavallero» (dal nome del generale che lo consegna a Berlino), inviato da Mussolini a Hitler il 30 maggio 1939, solo una settimana dopo la firma del Patto d’acciaio con cui Italia e Germania si impegnano a sostenersi reciprocamente in caso di conflitto, riconosce la nostra impreparazione militare e politica e l’impossibilità di entrare in guerra prima del 1943:
L’Italia ha bisogno di un periodo di preparazione che può andare a tutto il 1942 per il rinnovamento delle nostre artiglierie di medio e di grosso calibro, per ultimare la costruzione e il rifacimento delle sei navi di linea attualmente in corso, per completare il già iniziato trasferimento di molte industrie di guerra dalla valle del Po nell’Italia meridionale, per spingere innanzi la realizzazione dei piani

20
autarchici che devono rendere vano ogni tentativo di blocco da parte delle democrazie possidenti.18
Al di là dei tempi della preparazione militare, ci sono i limiti del capitalismo italiano: il suo ruolo subordinato rispetto a economie più forti, i ritardi tecnologici, la mancanza di materie prime e la dipendenza dalle importazioni non permettono di cimentarsi in uno scontro mondiale dove vincerà chi riuscirà a produrre più carri armati, più navi da guerra, più bombardieri. La vicenda dei mezzi corazzati è emblematica: dopo che l’esperienza della guerra di Spagna ha dimostrato l’importanza dei mezzi corazzati e l’urgenza di passare dai modelli leggeri a quelli medi e a quelli pesanti, l’industria nazionale avvia le ricerche. I primi carri medi, gli M11/39, vengono sperimentati dall’Ansaldo solo nelle manovre dell’estate 1939, ma risultano lentissimi e menomati dall’impossibilità di brandeggio,19 e perciò vengono quasi subito accantonati. Contemporaneamente la Fiat e la stessa Ansaldo hanno avviato la progettazione dell’M13/40, che costituirà la linea dei carri italiani nella Seconda guerra mondiale: nel modello M13 viene risolto il problema del brandeggio con la collocazione del cannone in torretta girevole, ma la blindatura risulta inefficiente per la pessima qualità dell’acciaio e il motore impiegato è lo stesso dell’M11 (quindi senza riequilibrio del rapporto peso-potenza). Una partenza industriale sbagliata significa trascinarsi negli anni il peso degli errori, perché durante un conflitto la ricerca tecnologica non ha il tempo per trovare rimedi. Sono le contraddizioni di un paese dove l’industrializzazione è in ritardo rispetto a quella delle maggiori potenze europee e non può competere sul piano dell’efficienza produttiva. A questi limiti (oggettivi) si uniscono quelli legati alle oscillazioni convulse della politica estera e alla difficoltà di coordinare produzione industriale ed esigenze tattiche. L’Ansaldo produce nel 1940 una buona autoblinda AB40 (migliorata nel successivo modello AB41), capace di raggiungere la velocità di 75 km/h su strada e 30 km/h fuori strada, di superare pendenze del 40 per cento, e con la doppia guida, anteriore e posteriore. Questa caratteristica originale è utilissima in montagna, dove l’inversione di marcia può realizzarsi anche senza spazio laterale, ed è stata progettata in vista degli scenari strategici precedenti la guerra d’Etiopia e l’alleanza con la Germania. Essa diventa tuttavia inutile in quello che sarà il suo vero terreno d’impiego, il deserto nordafricano, dove tutto manca ma non certo lo spazio per le inversioni di marcia. Un modello d’avanguardia sul piano della ricerca tecnologica,

21
realizzato per la guerra sulle Alpi, viene così destinato alle operazioni tra le dune del Sahara.
A queste criticità strutturali si assommano quelle legate alle indecisioni nelle scelte politiche del 1939-40. Nel dicembre 1939 Mussolini impartisce l’ordine di chiamare alle armi 1 milione di uomini per l’estate del 1940 e nei successivi mesi di febbraio e marzo ricevono la cartolina-precetto le reclute del secondo e terzo quadrimestre 1919 e l’intera classe 1920, ma il numero di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente è troppo esiguo per l’addestramento e l’inquadramento dei nuovi arruolati. Nella primavera gli elementi migliori dei quadri (ufficiali inferiori, sottufficiali, graduati di truppa) vengono sottratti alle unità mobilitate e mandati a istruire le reclute che affluiscono ai depositi, ma, sopravvenute le esigenze di schieramento, il programma addestrativo (il cui compimento è previsto per la metà di luglio) viene interrotto. Ne risulta che allo scoppio delle ostilità solo un terzo del contingente alle armi è costituito da personale sufficientemente istruito e preparato: per gli altri due terzi si tratta o di reclute addestrate individualmente presso i depositi e non ancora amalgamate nei reparti con i commilitoni più anziani, oppure di personale richiamato all’atto dell’emergenza e quindi privo di aggiornamento. Unità eterogenee per classe di leva (dal 1909 al 1920) si trovano così impiegate agli ordini di ufficiali numericamente insufficienti: emblematico il caso degli undici battaglioni alpini Valle assegnati alla I Armata del generale Pintor, nei quali, alla data del 1° maggio 1940, si trovano in servizio soltanto trentadue ufficiali, meno della metà prevista in organico.
Alla vigilia della guerra
Lo sviluppo degli eventi nella primavera del 1940 porta comunque il regime alla scelta annunciata il 10 giugno, andando oltreaccantonando le preoccupazioni per le deficienze militari e per la debolezza dell’economia. L’esercito si presenta alla mobilitazione forte di 1.600.000 uomini distribuiti in 73 divisioni, di cui 19 considerate complete dagli stati maggiori, 34 efficienti ma incomplete (per insufficienza di mezzi di trasporto) e 20 poco efficienti (carenze di armi, di dotazioni, di automezzi e ranghi incompleti al 40 per cento). Di fatto, si tratta di fanterie prive di una vera meccanizzazione. Nel periodo 1935-39 il ministero della Guerra ha acquistato 23.000 automezzi tra autocarri medi e pesanti e trattori d’artiglieria: il numero è considerevole e la dotazione sarebbe adeguata, ma alcune migliaia di

22
questi esemplari sono stati ingoiati dalle campagne in Etiopia e in Spagna.
Un ulteriore limite è dato dall’eccessiva varietà dei modelli: gli acquisti sono stati fatti presso le maggiori industrie nazionali (Fiat, Lancia, Breda, Ansaldo, Bianchi, Isotta Fraschini, Alfa Romeo, OM) senza che il governo orientasse d’autorità la produzione, con la conseguenza di problemi evidenti sia per la formazione di reparti omogenei, sia per la dotazione di ricambi.
Lacune più gravi si riscontrano nelle artiglierie, che già nel 1915-18 hanno rappresentato il punto debole dell’armamento italiano. Un piano organico di ammodernamento viene attivato solo nel 1938, con uno stanziamento straordinario di oltre due miliardi, ma il programma iniziale di 2206 esemplari è risultato inattuabile dalle industrie (Ansaldo e OTO, entrambe controllate dallo Stato attraverso l’Iri) la cui capacità produttiva è di soli 60-70 pezzi mensili. Si pone inevitabilmente il problema del rinnovo degli impianti, affrontato in una serie di incontri da rappresentanti del governo, della Banca d’Italia e delle aziende:
Le industrie si impegnano ad ampliare e modernizzare gli impianti a fronte di un contributo statale pari al 15 per cento del valore delle commesse e garantiscono che in questo modo i programmi possano essere realizzati in tre-quattro anni. Senonché, nell’inverno del 1939-40 tali programmi si dilatano e il 25 maggio 1940 (quando Mussolini ha ormai deciso l’intervento) arrivano a comprendere ben 8252 nuovi pezzi, dalla media gittata del modello 47 alla lunga gittata del 210. I tempi di consegna sono calcolati in cinque anni, ma solo nell’irrealistico presupposto di riuscire a lavorare due turni giornalieri di dieci ore e di importare materie prime per 8 miliardi annui. Di fatto, la previsione più ragionevole è che per completare il programma occorreranno almeno dieci anni, sino al 1950.20
Situazione migliore riguarda le munizioni: esse sono insufficienti rispetto alle richieste dell’esercito, ma queste sono calcolate su medie di fuoco rapportate alla guerra del 1915-18, quando tutti i reparti erano costantemente impegnati. Nel nuovo conflitto i combattimenti risulteranno invece saltuari e mediamente saranno coinvolte in contrasti violenti non più di una decina di divisioni. Il problema del munizionamento non risiederà perciò nelle disponibilità, ma riguarderà il trasporto ai luoghi di impiego, specie oltremare: le emergenze del Mediterraneo costringeranno i reparti alla parsimonia nell’uso dei proiettili e ne limiteranno la capacità di fuoco. Un’altra criticità è rappresentata, per contro, dal carburante: le scorte garantiscono un’autonomia di nove mesi per l’Africa orientale, di setto-otto mesi per il territorio nazionale, di due mesi per la Libia e il

23
Dodecaneso e di uno per l’Albania, troppo poco per un paese che dipende dalle importazioni di petrolio e che dovrà fare i conti con gli ostacoli al trasporto marittimo. Infine, qualche dato sui viveri: la razione giornaliera di carne del soldato italiano è di 250 grammi, quella di zucchero di 20 e quella di caffè di 15. Le razioni francesi e inglesi risultano quasi doppie, rispettivamente 450 e 350 di carne, 48 e 50 di zucchero, 30 e 35 di caffè, oltre alla pancetta (sconosciuta al Regio Esercito) e a grassi in misura incomparabilmente superiore.
Per quanto riguarda la Marina, all’entrata in guerra essa schiera 2 corazzate rimodernate, 8 incrociatori pesanti, 14 incrociatori leggeri, 61 cacciatorpediniere, 72 torpediniere, un centinaio di sommergibili. In tutto 522.000 tonnellate, destinate ad aumentare quasi subito a 640.000 con il varo (estate 1940) di altre due corazzate (Littorio e Duilio): il personale comprende 4500 ufficiali e 160.000 uomini. Per confronto, il tonnellaggio militare tedesco è inferiore a 300.000, mentre quello francese è simile a quello italiano: ; il tonnellaggio britannico è invece il più cospicuo del mondo, 1.900.000 tonnellate, a fronte del 1.600.000 statunitense e del 1.000.000 giapponese. Nel Mediterraneo, la flotta italiana dispone dunque di una forza potenza non indifferente, e la Marina è l’unica forza armata che dal 1922 allo scoppio del secondo conflitto ha avuto uno sviluppo senza improvvisazioni.
Si tratta tuttavia di una flotta consolidata dall’ammiraglio Paolo Thaon di Revel e dai suoi successori in continuità con la politica navale dell’Italia liberale, condividendone i due presupposti strategici: l’aspirazione a un ruolo di potenza nel Mediterraneo e la consapevolezza dell’assoluta impossibilità di affrontare una guerra con la Marina inglese:
Un’alleanza di fatto con la Gran Bretagna, cardine da sempre della politica navale italiana, diventava perciò una scelta obbligata perché doveva garantire all’Italia un certo ruolo nel Mediterraneo e forse anche forme di predominio relativo contro una potenza come la Francia, superiore in un confronto italo-francese, ma inferiore dinanzi a un accordo italo-inglese. Il problema di come vincere la guerra era risolto in partenza da questa alleanza: ciò che importava, era di avere una flotta in grado di figurare adeguatamente in una coalizione già padrona del dominio dei mari.21
Partendo dalla certezza dell’alleanza con la maggior potenza navale del mondo, la Marina italiana non è spinta a sviluppare a qualsiasi prezzo i nuovi mezzi, né a preoccuparsi troppo della protezione del traffico mercantile: di qui la scelta di costruire nuove corazzate da 35.000 tonnellate (cioè del tipo di maggior potenza)

24
rinunciando alle portaerei e a ogni controllo sull’aviazione, la ricerca nel naviglio leggero di prestazioni eccezionali (come la velocità ottenuta a scapito delle qualità nautiche o la potenza dell’armamento pagata con l’insufficienza della corazzatura), gli investimenti sulla quantità trascurando lo sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica (in particolare per quanto riguarda i radar e la strumentazione dei sommergibili). Lo scenario cambia bruscamente con il ribaltamento delle alleanze conseguente alla guerra d’Etiopia: l’alleanza l’intesa con la Germania e il contrasto con le «plutocrazie occidentali» proiettano la Marina in una dimensione strategica per la quale non è attrezzata, né militarmente, né culturalmente (gli ufficiali di Marina hanno un elevato grado di compattezza e di chiusura verso l’esterno, che li porta a un naturale «conservatorismo» nei propri riferimenti). In altre parole, con l’entrata in guerra del 10 giugno 1940 alla Regia Marina vengono affidate responsabilità e richiesti impegni che non corrispondono alla sua organizzazione e travalicano le sue concrete possibilità: fronteggiare la Royal Navy che dispone di un tonnellaggio tre volte superiore, garantire la scorta allescortare le navi mercantili che riforniscono l’Italia di materie prime, trasportare uomini, armi e viveri sullo scacchiere africano, garantire la sicurezza dei mari interni e dei porti della penisola è impensabile per una flotta concepita invece per cooperare con la Marina inglese ed essere socio di minoranza nel dominio del Mediterraneo.
Cinque anni non sarebbero stati comunque sufficienti per trasformare la flotta militare, né l’industria cantieristica nazionale dispone delle risorse necessarie, ma non vengono neppure tentati aggiustamenti nell’illusione (alimentata dallo stesso Mussolini) di poter evitare un conflitto di grandi dimensioni. Quando invece si arriva allo scontro, accade ciò che è evidente sin dall’estate del 1935, quando i vertici della Marina, di fronte alla prospettiva di cambio delle alleanze, dichiarano esplicitamente al duce «di non avere altra possibilità in un conflitto con la Gran Bretagna che una difesa onorevole, ma senza speranza alcuna di risultati positivi, perché la nostra Marina non è che un’avanguardia senza grosso e la lotta ci condurrebbe ad una vera catastrofe».22
L’Aeronautica, nata per iniziativa fascista, riceve la sua fisionomia definitiva sotto la lunga gestione di Italo Balbo (novembre 1926 - novembre 1933), riuscendo rapidamente ad assumere una posizione nel regime non diversa da quella dell’Esercito e della Marina. Proiezione dello spirito di ardimento e della volontà di dominio, sintesi di modernità, progresso tecnico e tensione spirituale,

25
l’Ala azzurra deve lottare contro l’ostilità delle altre due forze armate, che vedono nel suo sviluppo una diminuzione del loro peso politico e dei loro bilanci. Inevitabile che l’Aeronautica reagisca con una dottrina di impiego che rifiuta qualsiasi forma di collaborazione e che cerchi nella stretta rispondenza alle esigenze pubblicitarie del regime la spinta per la sua affermazione: . Mussolini, sulla scia di D’Annunzio, ne coglie prima ancora della sua ascesa al potere le potenzialità propagandistiche, e la gestione di Balbo corrisponde alle esigenze pubblicitariesue aspettative perseguendo una politica di esasperata ricerca di record tecnico-sportivi: negli anni Trenta si susseguono così i primati di velocità media, di velocità massima e di altitudine, le crociere transoceaniche di intere formazioni (Italia-Brasile e ritorno con quattordici velivoli Savoia-Marchetti nel 1930, Orbetello-Chicago-New York-Roma nel 1933), i risultati eccezionali degli idrovolanti (nel 1934 il pilota Francesco Agello raggiunge i 709 km/h con un idrocorsa Macchi-Calstoldi M.C.72).
Per alcuni aspetti l’investimento sull’Aeronautica corrisponde alle tesi di Giulio Douhet, ufficiale del genio, il primo a sostenere che l’aviazione avrebbe svolto un ruolo autonomo e risolutivo nei conflitti futuri: il suo trattato Il dominio dell’aria, pubblicato nel 1921, è un testo anticipatore ed essenziale, subito tradotto nelle diverse lingue e studiato nelle principali accademie militari del mondo. Per altri aspetti, la sua dottrina viene disattesa: «Secondo Douhet, una flotta di bombardieri avrebbe potuto distruggere i centri nevralgici del paese nemico ponendo termine alla guerra in pochi giorni con l’impiego su larga scala di gas asfissianti e per questo tutte le risorse disponibili dovevano essere concentrate nella creazione di un’aviazione potentissima e autonoma».23 Queste tesi diventano la giustificazione teorica per la richiesta di ingenti risorse e per il rifiuto di accettare rapporti di collaborazione con le altre forze, ma non stimolano una riflessione critica sul tipo di aeronautica necessaria né l’elaborazione di una dottrina di impiego conseguente alle scelte di politica estera. L’industria sperimenta e realizza apparecchi capaci di percorrere lunghe distanze, con motori resistenti collaudati con mille ore di funzionamento ininterrotto, mentre gli scacchieri della Seconda guerra mondiale richiederanno aerei in grado di percorrere distanze minori, ma dotati di maggior potenza. Gli apparecchi italiani risultano così leggeri, con scarsa capacità di carico di bombe e blindature modeste.
La mancanza di cooperazione tra l’Aeronautica e le altre due forze armate incide poi sui sistemi di trasmissione: per esempio, i caccia e i bombardieri non hanno possibilità di comunicazioni radio

26
dirette con le navi. In definitiva, l’Ala fascista si presenta in guerra ricca di prestigio e povera di solidità. Sul numero effettivo degli apparecchi, inoltre, vi sono valutazioni paradossalmente soggettive: nel 1933, quando Balbo lascia il ministero, dichiara una forza di 315 aerei, ma Mussolini ne riconosce in efficienza bellica solo 911; nel 1939, quando il successore di Balbo, Giuseppe Valle, lascia a sua volta l’incarico a Francesco Pricolo, consegna un inventario di 5344 apparecchi esistenti e 3184 in costruzione, ma quest’ultimo precisa che effettivamente idonei alla guerra sono solo 650 bombardieri e 190 caccia. Nel 1939-40 la produzione viene accelerata, parallelamente alla radiazione di diversi esemplari: allo scoppio delle ostilità vi sono circa 900 bombardieri impiegabili (di cui 600 di ultima generazione) e 700 fra caccia e assaltatori, più qualche centinaio tra ricognitori terrestri e marittimi e aerei da trasporto. Il personale ammonta a circa 100.000 uomini, di cui 6000 ufficiali e 11.000 sottufficiali.
La maggior parte degli studi sulle campagne del 1940-43 partono dalla deplorazione dell’inefficienza dell’apparato bellico italiano. I ritardi sono indubbi, ma la preparazione bellica non può ridursi a una pura sommatoria di armi e di armati, bisogna tener conto anche delle capacità organizzative e produttive, della gestione dei rapporti tra autorità politiche e vertici militari, dell’impegno del mondo industriale. Contestualizzando il problema in questo modo, emergono le responsabilità del regime, che da un lato propone un’immagine autoritaria e accentratrice, dall’altro si dimostra debole verso le singole amministrazioni militari di cui non scalfisce l’autonomia e il corporativismo, e più debole ancora verso gli industriali, cui non viene imposto un indirizzo coerente con gli obiettivi fissati dalla politica. Lo stato maggiore generale, istituito nel 1925 e affidato sino al dicembre 1940 a Pietro Badoglio, risulta impotente nei confronti degli organismi delle singole forze armate (sottosegretariati e stati maggiori), che si preparano ognuna a una propria guerra e non si preoccupano di elaborare una dottrina di impiego interforze; le industrie addette alla produzione bellica, a loro volta, intrattengono rapporti diretti con i singoli ministeri militari, senza che lo Stato riesca a imporre l’accentramento finalizzato delle commesse e il coordinamento della produzione (nonostante la creazione nel 1935 del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ente privo di reali poteri, non a caso affidato a un anziano generale, Alfredo Dallolio). Al di là dei toni roboanti, verso i poteri forti lo Stato fascista si dimostra più «mediatore» che «dittatore».

27
Per comprendere come mai il regime persegua una politica estera aggressiva senza curarsi di predisporre adeguati strumenti militari bisogna rinviare al modus operandi mussoliniano nell’arco del Ventennio: «Il duce ama “giocare ai soldati”, ostentare uniformi, ricoprirsi di gradi e qualifiche militari, ma al di là di questa facciata egli resta un improvvisatore politico e non fa mai veramente conto sulla forza militare salvo nei conflitti coloniali, quando l’avversario è incomparabilmente inferiore». Puntare su una seria preparazione militare avrebbe significato decidere con grande anticipo la linea di politica estera, mentre l’azione di Mussolini è sempre affrettata ed episodica caccia alle occasioni, pur nel grande binario di aspirazioni imperialistiche. Una vera preparazione bellica avrebbe richiesto un diverso indirizzo politico-economico e la concentrazione delle risorse finanziarie in un’unica direzione, rinunciando a obiettivi teatrali e populistici indispensabili al regime (bonifiche, grande edilizia, colonie marine e montane, case del fascio, Dopolavoro, Maternità e Infanzia, ecc.). «A ben vedere, le rodomontate militari del 1939-40 non sono che la mascheratura, corrusca di ferro, del gioco politico imperniato sull’assurda speranza di una nuova mediazione altrettanto clamorosa ma più redditizia di quella di Monaco del 1938 e solo all’ultimo momento ridotto, per forza di cose, al tentativo di approfittare dei non desiderati trionfi tedeschi».24
Il 4 aprile 1940 Badoglio scrive a Mussolini che «allo stato attuale la nostra preparazione è del 40 per cento», una percentuale che non ha senso perché non rapportata a un’ipotesi precisa di conflitto, ma che vale a indicare lo stato di profondo disorientamento con cui le forze armate si affacciano alle scelte del 10 giugno. Lo scoppio della guerra segna la fine dei bluff: dopo le ubriacature della grandezza imperiale, «l’Italia era ricondotta brutalmente alla sua condizione di Stato semisviluppato, una media potenza che non poteva affrontare il conflitto con un ruolo autonomo, alla pari con le grandi potenze, quindi era costretta a giocare di rimessa, nella speranza che le vicende belliche le offrissero una qualche possibilità di affermazione o di salvezza».25 Nel momento in cui la realtà prende il posto delle parole, per il fascismo (e per l’Italia fascista) arriva il momento drammatico della resa dei conti con le proprie contraddizioni.

28
VERTICI MILITARI DAL 10 GIUGNO 1940 ALL’8 SETTEMBRE 1943
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE (COMANDO SUPREMO)
maresciallo Pietro BADOGLIO sino al 4 dicembre 1940 generale Ugo CAVALLERO 6 dicembre 1940 -1° febbraio 1943 generale Vittorio AMBROSIO dal 1° febbraio 1943
ESERCITO
SOTTOSEGRETARIO ALLA GUERRA
generale Ubaldo SODDU sino al 30 novembre 1940 generale Alfredo GUZZONI 30 novembre 1940 – 24 maggio 1941 generale Antonio SCUERO 24 maggio 1941 - 13 febbraio 1943 generale Antonio SORICE 13 febbraio 1943, ministro dal 25 luglio 1943
CAPO DI STATO MAGGIORE (SUPERESERCITO)
Maresciallo Rodolfo GRAZIANI sino al 24 marzo 1941 (dal giugno 1940 in Libia e sostituito di fatto dal sottocapo Mario Roatta) generale Mario ROATTA 24 marzo 1941 – 20 gennaio 1942 generale Vittorio AMBROSIO 20 gennaio 1942 – 1° febbraio 1943 generale Ezio ROSI, 1° febbraio 1943 – 18 maggio 1943 generale Mario ROATTA, dal 1° giugno 1943
MARINA
SOTTOSEGRETARIO ALLA MARINA E CAPO DI STATO MAGGIORE (SUPERMARINA)
ammiraglio Domenico CAVAGNARI sino all’8 dicembre 1940 ammiraglio Arturo RICCARDI, 8 dicembre 1940 - 25 luglio 1943 ammiraglio Raffaele DE COURTEN dal 25 luglio 1943 ministro e capo di stato maggiore
AERONAUTICA
SOTTOSEGRETARIO ALL’AERONAUTICA E CAPO DI STATO MAGGIORE (SUPERAEREO)
generale Francesco PRICOLO sino al 15 novembre 1941 generale Rino CORSO FOUGIER 15 novembre 1941 - 25 luglio 1943 generale Renato SANDALLI dal 25 luglio 1943 ministro e dal 27 capo di stato maggiore

29
II La campagna delle Alpi occidentali
Il Vallo Alpino del Littorio
Il confine tra l’Italia e la Francia corre per centinaia chilometri lungo il crinale alpino, dalla valle d’Aosta a Ventimiglia, ed è stato fortificato dapprima tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento (come conseguenza dell’adesione dell’Italia alla Triplice Alleanza), quindi rafforzato negli anni Trenta, con un impegno diretto sia al consolidamento del dispositivo di sicurezza, sia alla propaganda di regime. Il territorio delle Alpi occidentali ha caratteristiche differenti sui due versanti: dalla parte italiana vi è una profondità di soli 40 chilometri e le vallate si aprono subito verso la pianura padana e il capoluogo piemontese; dalla parte francese la profondità è di 120 chilometri e varcato lo spartiacque si incontrano altri rilievi montuosi che bisogna attraversare prima di trovare la pianura e raggiungere gli obiettivi importanti. Questo significa che i francesi possono ipotizzare un’offensiva diretta su Torino, come hanno fatto durante le guerre del XVIII secolo contro il Regno di Sardegna, mentre gli italiani devono limitarsi a una strategia difensiva e cercare eventuali sbocchi offensivi in altre direzioni, nel Mediterraneo o sul Reno in appoggio ai tedeschi.
Entro questa cornice, nel 1931 il fascismo decide la realizzazione di un sistema difensivo che più tardi prenderà il nome di «Vallo Alpino del Littorio», secondo una definizione ufficializzata dal sottosegretario alla Guerra Ubaldo Soddu. A sollecitare l’iniziativa è il fervore fortificatorio francese, che nel 1928, su impulso del maresciallo Henri-Philippe Pétain e del ministro André Maginot, inizia la costruzione di quella che si chiamerà appunto «Linea Maginot».1 Il progetto iniziale, contenuto nella circolare dello stato maggiore dell’esercito n. 200 del 6 gennaio 1931, è molto ambizioso e prevede la realizzazione di opere lungo tutto l’arco alpino, da Ventimiglia a Fiume, per un totale di 1851 chilometri di frontiera suddivisi in tre settori: «Vallo alpino occidentale», 487 chilometri con la Francia; «Vallo alpino settentrionale», 720 chilometri con la Svizzera e 420 con l’Austria; «Vallo alpino orientale», 220 chilometri con la Iugoslavia. Nel complesso, il Vallo dovrebbe contare su 3325 impianti, tra forti, batterie corazzate, postazioni per mitragliatrici, sbarramenti anticarro, depositi, sistemi di inondazione difensivi, casermette, torrette-osservatorio, bunker sotterranei, casematte,

30
barriere di filo spinato: per raggiungere le postazioni deve inoltre essere realizzata una rete viaria spesso ardita, tagliata in un terreno roccioso e con pendenze compatibili con lo spostamento rapido delle artiglierie. Nella maggior parte dei casi si tratta di opere di nuova costruzione, da realizzare su punti forti naturali, alture, valloni, strapiombi, speroni di roccia: le fortificazioni campali costruite prima della Grande guerra, in cemento e pietra, sono infatti vulnerabili di fronte ai grossi calibri delle artiglierie più recenti e devono essere demolite o pesantemente ristrutturate, rinforzandole con spessori di cemento armato e corazzature.
Il sistema è caratterizzato dalla non contiguità delle varie componenti, ognuna delle quali costituisce un elemento difensivo autonomo, e prevede l’utilizzo integrato e sistemico di tutte le possibili alternative offerte dalle moderne tecnologie balistiche, in modo da rendere possibile sia il tiro diretto, sia quello fiancheggiante. Il sistema è articolato in tre zone: la prima, la «zona di sicurezza», è la più vicina alle linee nemiche e il suo compito è prevalentemente di osservazione dei movimenti e di rallentamento di un’eventuale avanzata con ostacoli passivi e piccole azioni di fuoco di disturbo; la seconda, la «zona di resistenza», è costituita da due fasce parallele al confine con il compito di stroncare l’attacco nemico con mitragliatrici e batterie di piccolo calibro; la terza, la «zona di schieramento», comprende la massa delle artiglierie e le truppe di fanteria destinate a sostenere la difesa o a ricacciare il nemico che riesca eventualmente a sfondare la linea di resistenza.
Il progetto è al limite delle capacità industriali ed economiche dell’Italia e questo determina sin dall’inizio ritardi e ridimensionamenti. Dopo la guerra d’Etiopia le difficoltà di produzione e rifornimento aumentano, come conseguenza delle sanzioni imposte dalla Società delle Nazioni e della politica autarchica: l’acciaio che arriva dalla Germania (e il carbone per alimentare gli altiforni delle industrie siderurgiche) non sono sufficienti per tutte le putrelle e le feritoie corazzate previste. Alla fine degli anni Trenta i «centri 200» realizzati (cosiddetti dal numero della circolare istitutiva) sono ancora pochi e piuttosto isolati l’uno dall’altro, tanto da non essere in grado di difendersi a vicenda: nel 1938 viene perciò deciso di coprire gli intervalli tra le opere esistenti con la costruzione di numerose piccole strutture monoblocco in calcestruzzo, la cui potenza di fuoco è inevitabilmente modesta, anche se le coperture mimetiche in pietra locale ne rendono difficile l’individuazione.

31
Nell’inverno del 1939 il maresciallo Graziani, appena nominato capo di stato maggiore dell’esercito, emana una nuova circolare (n. 15000/31 dicembre 1939) che intende rivoluzionare il modo di concepire la fortificazione alpina, non più limitandola allo spartiacque, ma estendendola su più sistemi fortificati successivi sino al fondo valle, con opere concepite per essere presidiate in modo permanente e allestite per ospitare la truppa e il suo relativo comando. L’ipotesi è tecnicamente ineccepibile, perché darebbe a ogni struttura fortificatoria la possibilità di resistere anche senza aiuti esterni, ma la guerra ormai incombe e mancano i tempi (e le risorse) necessari. I dati relativi allo stato di realizzazione del Vallo Alpino del Littorio disponibili riguardano l’ottobre 1942 quando, secondo dati fornitile informazioni fornite dal comandante supremo Vittorio Ambrosio, sono state ultimate 1475 opere difensive, altre 450 sono in corso di costruzione e 1400 sono solo progettate. In totale, si tratta della metà di quanto previsto inizialmente e le realizzazioni sono distribuite in modo disomogeneo: gli investimenti hanno infatti privilegiato il Vallo occidentale, soprattutto dopo il 1936 e i nuovi scenari internazionali aperti dall’alleanza con Hitler (delle 1400 opere ferme allo stato progettuale, oltre mille riguardano infatti la frontiera settentrionale con la Germania).
Per la propaganda fascista il Vallo (o «Linea Maginot alpina») è un argomento di facile spendibilità. Nell’immaginario collettivo le «mal difese Alpi» sono un riferimento fondamentale: «chiudere» i valichi significa garantire la sicurezza di tutta la penisola e non a caso sono diventati popolari sin dai primissimi anni di vita gli alpini, con i loro motti «Di qui non si passa», «Sentinelle delle Alpi». Del Vallo si parla nei sussidiari scolastici, nei discorsi ufficiali, negli articoli di giornale: attorno al Vallo si svolgono esercitazioni militari che i cinegiornali ripropongono, tra i pennacchi di fumo delle esplosioni e il rumore sordo delle artiglierie; le opere di sbarramento in alta quota, con le sagome arrotondate delle casematte attaccate alle rocce e le feritoie scure con le bocche da cannone che sporgono, sono immagini di potenza, dove si mescolano insieme gli ingredienti della forza, dell’ardimento, della modernità (il metallo, il cemento armato, gli ingranaggi, il fuoco). Il fiore all’occhiello del Vallo occidentale è il Forte dello Chaberton, la costruzione più audace e, insieme, la più inutile. Realizzato alla fine del XIX secolo a quota 3135, sulla vetta di una montagna dominante rispetto alla città di Briançon e alla prospiciente vallata francese (val de la ClairéeVallée de la Clarée), il forte è un capolavoro di ingegneria militare. Dapprima è stata tracciata

32
la strada di collegamento tra il fondovalle e la cima, quindi spianata e abbassata di 6 metri la cima stessa per permettere la costruzione delle opere, infine creato un gradino roccioso alto circa 12 metri, alla cui base sono state realizzate le strutture fortificatorie, tutte in muratura a cielo aperto. Il forte si sviluppa in lunghezza lungo questo scalino, con due corridoi che danno accesso alle camerate, ai magazzini, alle cucine, al posto comando. Sul tetto sorgono otto torri cilindriche di 7 metri di altezza, sormontate a loro volta da torrette girevoli che ospitano i cannoni da 149/35 A. Spettacolare e aggressivo, lo Chaberton non prevede dispositivi di protezione perché non può essere raggiunto con le armi a tiro curvo dell’epoca: le stesse torrette, dove operano i serventi al pezzo (sette per ogni cannone), dispongono solo di una corazzatura leggera per riparare da eventuali schegge, perché i tiri diretti sono impossibili.
Le innovazioni tecnologiche dei primi decenni del Novecento cambiano però la situazione: nel momento in cui compaiono mortai in grado di colpire con tiro teso, la posizione esposta dello Chaberton si trasforma in un rischio evidente e il forte diventa un obiettivo facilmente vulnerabile. Di qui la decisione, maturata nell’ambito del Vallo Alpino del Littorio, di intervenire ristrutturando la costruzione e portando tutto in caverna. I tempi di realizzazione, tuttavia, non coincidono con quelli della politica estera di Mussolini e allo scoppio della guerra è stata collocata in uno spazio sotterraneo protetto solo dalla vicina batteriadalle vicine batterie del Petit Vallon, mentre le otto torri sono ancora in funzione e in bella mostra sulla vetta della montagna. Dal punto di vista della comunicazione, d’altra parte, esse sono funzionali a un messaggio di potenza proprio per la posizione apparentemente dominante in cui si trovano. Il risultato è che quando si aprono le ostilità con la Francia lo Chaberton (che diventa attivo per la prima e unica volta) apre il fuoco su obiettivi militari nemici senza provocare danni significativi, 2 mentre il giorno successivo viene centrato dagli obici di assedio «Schneider» che, dopo qualche tiro di assestamento, «mettono fuori combattimento sei delle otto torrette, causano nove morti e una cinquantina di feriti, distruggono la teleferica di servizio di collegamento e provocano danni notevoli alle strutture, con sprofondamenti e brecce». 3 L’orgoglio delle fortificazioni littorie si sgretola così in poche ore, presagio malaugurante dell’avventura bellica che sta iniziando.
L’attacco rinviato

33
Alla data del 10 giugno il Regio Esercito schiera sulle Alpi occidentali il Gruppo Armate Ovest, o Armata delle Alpi, per un totale di 315.000 uomini al comando dell’erede al trono, il principe di Piemonte Umberto di Savoia. Ne fanno parte la IV Armata del generale Alfredo Guzzoni, disposta dal monte Dolent (nella zona di Courmayeur, in valle d’Aosta, là dove si congiungono le tre linee di frontiera tra Italia, Francia e Svizzera) al monte Granero (una vetta delle Alpi Cozie, lungo lo spartiacque tra la Val Pellice e la Valle del Po), e la I Armata del generale Pietro Pintor, nel successivo tratto fino al mare, tra la provincia di Cuneo e la Liguria. In totale, 22 divisioni. La maggior parte di queste truppe è stata schierata sul confine nel settembre 1939, ritirata in pianura durante l’inverno e in parte congedata, poi richiamata in aprile e rimandata in fretta in posizione. Lo schieramento è difensivo, secondo il piano strategico su cui è fondata la preparazione della guerra:
Garantire, in un primo tempo, l’inviolabilità della frontiera occidentale, perché in un secondo tempo l’esercito fosse in grado di effettuare eventuali azioni offensive su altri teatri d’operazione. E benché, fin dall’aprile 1939, lo stato maggiore avesse ordinato di compiere studi particolareggiati per azioni offensive in corrispondenza delle principali direttrici operative della frontiera occidentale, tutte le predisposizioni che precedettero e accompagnarono la nostra dichiarazione di guerra, furono tali da far ritenere, almeno sul principio, che non si sarebbe usciti da un contegno strettamente difensivo. Secondo tale criterio era stato regolato lo schieramento delle grandi unità.4
Il 7 giugno, tre giorni prima della dichiarazione di guerra, il nuovo capo di stato maggiore dell’esercito Graziani comunica infatti al principe di Piemonte che «in caso di ostilità, deve mantenersi di fronte alla Francia contegno assolutamente difensivo, sia in terra che in aria. Resta pertanto confermato che non dovrà, senza ordine di questo comando, essere intrapresa alcuna azione oltre frontiera e che nessun reparto o nucleo dovrà varcare materialmente la linea di confine».5
La guerra inizia quindi con un piano operativo che non prevede uno schieramento idoneo all’attacco, ma solo una disposizione di truppe lungo la linea di confine a scopo deterrente e intimidatorio, per indurre la Francia a concessioni territoriali. Tale piano viene mantenuto per alcuni giorni anche dopo il 10 giugno. Il che si spiega non tanto con le esitazioni militari, quanto con i dubbi politici del duce. Mussolini spera che la dichiarazione di guerra sia atto sufficiente per legittimare le aspirazioni italiane e che Hitler accetti il concorso di truppe del Regio Esercito alle operazioni in territorio

34
francese: in questo modo sarebbero garantiti lo status di «alleato», la partecipazione alla spartizione del bottino e un ruolo di mediazione per contenere l’aggressività tedesca. La posizione attendista trova riscontro nell’atteggiamento dei francesi, che, in grave difficoltà sul fronte settentrionale, hanno tutto l’interesse a non far precipitare la situazione su quello meridionale. Il 23 maggio Badoglio ha incontrato l’addetto militare a Roma, generale Henri Parisot, chiedendogli: «Se io non attacco, che fate voi?» e ricevendone in risposta: «Noi non attacchiamo per primi certamente».6 A livello di truppe terrestri il confronto si limita così a piccole scaramucce e a scambi di tiri d’artiglieria (sufficienti, comunque, a distruggere danneggiare pesantemente lo Chaberton): oltretutto nelle Alpi il tempo si mette al brutto, con alternanza di pioggia e nevischio, e non favorisce le operazioni. Dichiarare la guerra senza farla è tuttavia un equilibrismo troppo precario e nei giorni successivi il quadro muta.
In primo luogo, la guerra «arriva» nella penisola. L’iniziativa è dell’Inghilterra, il cui comando aeronautico ha predisposto sin dal 31 maggio un attacco di bombardieri sulle città industrializzate del Nord Italia. L’operazione, denominata ironicamente «Haddock» («merluzzo») [non ne trovo traccia a parte nel libro di Giorgio Bocca], prevede l’intervento di una squadra di Withley Whitley di base a Londra e del 71° stormo di Vickers Wellington che si trova a Salon, nelle vicinanze di Marsiglia. L’11 giugno i Withley Whitley partono dagli aeroporti britannici, ma a Salon i francesi negano la scorta di caccia con la motivazione che tutti gli apparecchi sono stati inviati a nord per fronteggiare l’avanzata germanica e impediscono la partenza del 71° stormo: il principio della «non provocazione» confidato a Badoglio trova conferma. Per intervento di Churchill, preoccupato che la mancata reazione alla dichiarazione di guerra di Mussolini sia scambiata per arrendevolezza, i bombardieri inglesi puntano comunque su Torino e su Genova, dove arrivano nel cuore della notte. Gli obiettivi sulla capitale piemontese sono gli stabilimenti Fiat di Lingotto e Mirafiori, e vengono falliti perché la maggior parte delle 36 bombe da 500 libbre cadono in aperta campagna: alcune colpiscono però le case popolari del centro, uccidendo 14 persone e ferendone alcune decine. Anche a Genova i bersagli (gli stabilimenti Ansaldo e il porto) sono mancati e gli ordigni cadono in mare: tra la popolazione si conta solo qualche ferito. Seppur limitata, l’incursione evidenzia le criticità del sistema difensivo (l’avvistamento è tardivo e la contraerea non contrasta i WithleyWhitley, tanto che Mussolini scriverà subito a Hitler chiedendo la disponibilità di 50 batterie), ma

35
soprattutto proietta in una dimensione inattesa: la guerra in casa. Anche se l’opinione pubblica nazionale non ne ha consapevolezza perché i giornali oscurano la notizia dei morti di Torino, il gruppo dirigente e gli osservatori più accorti percepiscono quello che era evidente sin dal 1937 con il bombardamento di Guernica,7 e cioè che è iniziata una guerra nuova, dove non esistono più il fronte e le retrovie e dove l’intero paese diventa «fronte»: una guerra «totale», nel senso che è coinvolta la totalità della popolazione dei paesi belligeranti.
Un’ulteriore accelerazione verso l’offensiva terrestre avviene il giorno successivo, quando i nostri aerei bombardano alcuni centri della Costa Azzurra e della Corsica (Saint-Raphaël, Calvi, Bastia) e la base della Marina da guerra francese di Tolone. Anche se i danni provocati sono modesti, l’ammiraglio François Darlan ordina una controrappresaglia e il 14 giugno 4 incrociatori in rada a Marsiglia si muovono verso la Liguria, scortati da 5 sottomarini e da alcuni cacciatorpediniere. Un primo gruppo si dirige su Savona e apre il fuoco sui depositi di carburante di Vado, un secondo punta su Genova e batte la zona portuale. Le batterie costiere rispondono all’attacco e una vecchia torpediniera italiana, la Calatafimi, sorpresa mentre depone mine davanti a Capo Arenzano, riesce ad avvicinarsi alle navi nemiche e a lanciare i siluri. Lo scontro è breve e i francesi si ritirano quasi subito con una unità colpita, l’Albatros, mentre gli italiani contano 9 morti e 36 feriti nei depositi della Monteponi-Montevecchi di Vado. Si è trattato di un’azione a breve raggio quasi a carattere dimostrativo, perché sulla Marina francese incombono il pensiero della sconfitta imminente e le incognite sul destino della flotta, tuttavia essa è rivelatrice delle contraddizioni dello schieramento italiano. Supermarina invia soltanto la sera del 14 alcuni cacciatorpediniere in soccorso alle forze della riviera di ponente, perché le nostre unità sono tutte schierate nel Mediterraneo a protezione delle linee di comunicazione. È quantomeno singolare che si pensi ai collegamenti con l’Africa e si tenga la flotta lontana dall’unico teatro di guerra guerreggiata, lasciando sguarnita una delle più importanti zone industriali del paese.
Il fatto determinante per scatenare l’offensiva terrestre sulle Alpi è però il crollo della Francia, ormai giunta «all’ultimo quarto d’ora»: il 14 giugno i tedeschi entrano a Parigi, il 16 si dimette il capo del governo Paul Reynaud, il 17 il vecchio maresciallo Henri Philippe Pétain (che gli è subentrato) prende la decisione di chiedere l’armistizio e di conoscere le condizioni di pace. Ritardare ulteriormente l’attacco significherebbe aver fatto una dichiarazione di

36
guerra solo virtuale. Il duce è teso: «La situazione attuale» dichiara a Badoglio «non permette ulteriori indugi. Se tardassimo ancora potrebbe essere grave nel momento della pace definitiva». 8 L’inquietudine è motivata dal fatto che «una cosa è puntare su una guerra breve, altra cosa trovarsi a dover trattare un armistizio e a dover fronteggiare un dopoguerra totalmente determinati dalle armi tedesche, il che priverebbe pressoché completamente di giustificazione l’intervento italiano nel conflitto e lo renderebbe impossibile da far valere al tavolo della pace».9 Ciano descrive un Mussolini «scontento, turbato da questo improvviso scoppio di pace».10 I tempi sono decisi dalla storia e la storia la sta facendo Hitler: a Mussolini non resta che chiamare Badoglio e i comandanti militari e ordinare di preparare l’avanzata, mutando in pochi giorni lo schieramento da difensivo a offensivo. L’attacco deve iniziare entro il 21 giugno.
La battaglia del 21-24 giugno
La catena di comando sul fronte alpino vede al vertice Umberto di Savoia, ma si tratta di un incarico formale assegnato per coinvolgere direttamente la casa regnante nelle responsabilità del conflitto, perché il principe non ha né le competenze né l’autorevolezza per ricoprire il ruolo. L’effettivo alto comando delle operazioni è affidato al maresciallo Rodolfo Graziani, un uomo dal carattere impulsivo e autoritario, che si è distinto nella conduzione della feroce guerra di riconquista della Libia e nelle operazioni in Africa orientale, ma la cui esperienza di comando a livello di armata è limitata alle guerre coloniali, dove si combatte contro un nemico nettamente più debole e quasi sprovvisto di tecnologie militari moderne. Accanto a lui, in una posizione ambigua che crea subito frizioni, è il generale Soddu: in quanto sottocapo di stato maggiore, egli è inferiore in grado e in autorità a Graziani, ma in quanto sottosegretario alla Guerra è l’ufficiale più vicino a Mussolini. Sin dal primo incontro tra i due ad Alba, a ridosso del fronte, emergono diffidenze e sospetti: Soddu è percepito da Graziani come un intruso venuto a esercitare un controllo occulto e come tale da tenere ai margini delle decisioni; l’altro giudica a sua volta Graziani un velleitario privo di visione strategica adeguata a uno scacchiere europeo. Dei due comandanti d’armata, «Pintor è di gran lunga il migliore: uomo di notevole cultura e di chiara intelligenza è uno dei pochi all’altezza dei tempi. L’altro, Guzzoni, non è inetto, ma

37
ossessionato dall’arrivismo» (10)[questa dovrebbe essere la nota 11 ma manca il testo]. Ciò che manca, in sostanza, è la coesione del gruppo dirigente. Il comando è sistemato su un treno, fermo su un binario morto tra Bra e Alba, nel Cuneese: il mezzo non è funzionale, perché lo spazio per le riunioni allargate e per stendere le cartine topografiche è limitato, ma la scelta corrisponde alla mitologia perdurante del «treno speciale» come strumento e testimone della storia (non a caso qualche giorno dopo Hitler farà firmare l’armistizio ai francesi sullo stesso vagone su cui, nel 1918, la Germania aveva dovuto firma la resa alla fine della Prima guerra mondiale).11 Il re Vittorio Emanuele III ha invece stabilito il suo quartier generale a Ternavasso, presso Torino, nel castello di proprietà di una famiglia di antica nobiltà sabauda, i Thaon di Revel (alla quale appartiene Paolo Thaon di Revel, l’ammiraglio comandante la in capo della Regia Marina nella Grande guerra, uno dei militari più vicini al sovrano).
Lo schieramento francese, che all’inizio delle ostilità con la Germania era di 500.000 uomini, si è progressivamente assottigliato per le esigenze del fronte settentrionale: secondo le stime dei servizi segreti italiani, in linea sono rimasti 50 battaglioni e 100 gruppi di artiglieria, in realtà si tratta di una forza ancora minore, circa 100.000 uomini (per lo più richiamati), distribuiti in 6 divisioni, con soli 65 gruppi, di fronte ai quali si muovono le 22 divisioni del Regio Esercito: a comandare l’Armée des Alpes è il generale René-Henri Orly. Inizialmente i tedeschi hanno suggerito al comando italiano un piano operativo di aggiramento delle Alpi, passando attraverso la trouée de Belfort, un valico agevole di soli 400 metri di altitudine: per raggiungerlo bisogna però effettuare movimenti di truppe da nord, in territori già presidiati dalla Wehrmacht, e il piano viene scartato a priori da Mussolini. Se si tratta di inviare divisioni italiane a marciare insieme alla Wehrmacht su Parigi si sanziona l’alleanza e, sul piano simbolico, l’equipollenza tra le due potenze: se si tratta, invece, di raggiungere un obiettivo comunque secondario per di più appoggiandosi allo schieramento germanico, si ratifica la subalternità.
Di qui la scelta dell’attacco frontale lungo la linea di confine, stabilito dall’ordine operativo n. 2329 del maresciallo Graziani: «Domani 21 giugno, iniziando alle ore tre, la IV e la I Armata attacchino a fondo su tutta la fronte.12 Il peso principale dell’attacco ricade sulle truppe alpine: la divisione «Tridentina» schierata nella zona della Valle d’Aosta, la «Taurinense» tra la valle dell’Orco e la valle della Dora Baltea (affacciata ai colli del Moncenisio e del Monginevro), la «Cuneense» e la «Pusteria» nel settore meridionale,

38
nelle diverse valli del Cuneese (in particolare verso il colle della Maddalena). Entrano in combattimento anche la divisione motocorazzata «Trieste», le divisioni di fanteria «Cosseria» e «Modena», reparti della Milizia. Le operazioni iniziano in mezzo a condizioni atmosferiche sfavorevoli (pioggia battente, neve in quota, nebbie fitte nelle vallate oltre frontiera) e l’avanzata si sviluppa con un complesso di azioni preliminari per superare la zona degli avamposti. L’avanzata La conquista è lenta: tra il 21 e il 24 giugno vengono raggiunte Bourg-Saint-Maurice (alle pendici francesi del Piccolo San Bernando), Langslebourg (oltre il colle del Moncenisio), i paesi più a monte della valle dell’Ubaye (nel settore del colle della Maddalena) e verso la costa i borghi dell’alta val Roja e la cittadina di Mentone. In totale, pochi chilometri di penetrazione, che scalfiscono la prima linea di arresto nemica senza però neutralizzarne le postazioni d’artiglieria che restano pressoché intatte, per cui la successiva battaglia di rottura sarebbe comunque incerta e il grosso dell’armata dovrebbe avanzare esposta al tiro.
Il problema della mancata neutralizzazione è strettamente collegato allo schieramento dei nostri cannoni, che sono in posizione arretrata rispetto al fronte perché posizionati in funzione di un’interdizione difensiva:
Le batterie italiane per la maggior parte erano collocate ai limiti di gittata rispetto agli obiettivi di primo piano e fuori portata rispetto alle fortificazioni avanzate nemiche: la funzione tattica per la quale era stato concepito lo schieramento era quello di colpire un nemico che avanzava, non di aprire la strada a un’avanzata. Per la scarsità di tempo e di strade, fu possibile far assumere posizioni più avanzate solo a poche batterie durante i giorni dell’azione.13
Tra i tanti, è emblematico un episodio nel settore del Piccolo San Bernardo: la mattina del 21 giugno il comandante d’armata Guzzoni prende la testa di un battaglione di bersaglieri motociclisti della divisione «Trieste» che deve varcare il colle e scendere in territorio francese: il generale prevede un facile sfondamento e, attento alla promozione della propria immagine, vuole essere in prima linea nel momento in cui si attraversa il confine.
L’attacco di Guzzoni si infranse però dinanzi alla prima interruzione stradale e al fuoco della Redoute Ruinée (il forte delle Traversette per gli italiani), un vecchio fortino con 45 uomini e qualche mitragliatrice. In quattro giorni di combattimenti i comandi italiani non riuscirono a portare innanzi le artiglierie pesanti per neutralizzarlo; le fanterie lo aggirarono scendendo fino al fondovalle, ma la strada rimase bloccata, bastò una mina per arrestare una colonna di carri L/3, che non riuscirono ad arrivare sino alla cittadina di Bourg-Saint-Maurice.14

39
Ne risulta lo schieramento di un’armata a due velocità, con le avanguardie che sono riuscite a conseguire l’obiettivo prefissato, ma con i mezzi corazzati impossibilitati a raggiungerle.
In questi primi giorni di operazioni è praticamente nullo il contributo dell’Aeronautica. La maggior parte dei 285 apparecchi che decollano per i bombardamenti
rientrarono alla base senza aver individuato gli obiettivi, gli altri sganciarono le bombe senza risultati apprezzabili, sia per le difficoltà dovute al maltempo, sia perché l’impiego contro fortificazioni alpine era, a detta dei comandi, il più assurdo e meno redditizio che si potesse immaginare e non era mai stato previsto negli studi e nelle esercitazioni di pace.15
Il bilancio di quattro giorni di scontri è modesto sul piano dei risultati, ma già significativo su quello delle perdite: 631 morti, 616 dispersi, 2631 feriti, 1141 prigionieri (i caduti francesi sono 37, 150 i dispersi e 42 i feriti). In particolare, tra i feriti ci sono quasi duemila congelati, a testimonianza di un equipaggiamento inadeguato e dell’invio in quota, accanto agli Alpini, di truppe non abituate ai rigori delle Alpi: sono avvisaglie di criticità che non emergono in tutta la loro evidenza solo perché la Francia, ormai collassata dall’invasione tedesca, il 24 firma l’armistizio e le ostilità cessano a partire dalle ore 1.30 del giorno successivo.
L’opinione pubblica di fronte alla guerra guerreggiata
La battaglia delle Alpi (o la «guerra delle cento ore») è di durata troppo breve per suscitare reazioni mirate nell’opinione pubblica italiana, la quale non si discosta quindi dall’atteggiamento di accettazione senza brividi con cui è stato accolto il discorso del 10 giugno. Diversa la situazione nella regione nordoccidentale, dove si attesta il fronte. Per gli aostani, i torinesi, i cuneesi la Francia è da sempre un riferimento geografico, culturale, economico. Alle spalle ci sono la lunga stagione in cui i due versanti delle Alpi sono stati uniti nel Ducato di Savoia e nel Regno di Sardegna, le affinità delle tradizioni e delle attitudini, i tanti emigrati stagionali o permanenti che sono andati a lavorare a Parigi, nelle campagne della Provenza, nelle miniere del Nordest: molte famiglie sono sparpagliate nei due paesi e chi parla il franco-provenzale o il piemontese capisce facilmente chi usa il francese. Le ostilità rompono un tessuto secolare di relazioni sociali e riportano la guerra in un territorio che da più di cent’anni ne era esente. Anche se l’espressione «pugnalata alla schiena» entrerà

40
nell’uso comune solo nel dopoguerra, serpeggia la sensazione che l’aggressione a un avversario ormai allo stremo sia un’azione moralmente dubbia, la maramaldeggiata maramalderia di chi «colpisce un uomo morto». Ma sono soprattutto le ripercussioni economiche e sociali sul campo a determinare in Piemonte una prima scollatura tra regime e opinione pubblica.
Per la zona di frontiera sono stati predisposti, in vista del conflitto, piani di sfollamento che prevedono lo sfollamentol’evacuazione dai villaggi vicini al fronte e il trasferimento degli abitanti nei centri di assorbimento sparsi tra Asti, Alessandria, Vercelli, Savona, Pavia e Genova: sono coinvolti 11 comuni del Cuneese (per un totale di 7000 persone), 4 della provincia di Torino, 5 in quella di Aosta. I prefetti assicurano che l’esodo avviene in un clima di «composta rassegnazione e comprensione»,16 ma non è difficile immaginare il disorientamento e i timori di comunità che devono lasciare il bestiame, le baite e i campi per essere disseminate in case coloniche sparse, dove per mangiare dipendono dalla distribuzione del rancio giornaliero e giorno dopo giorno aspettano di sapere quando potranno rientrare. L’effetto demoralizzatore di questa massa di montanari che scende le valli mentre i soldati le risalgono è noto attraverso qualche lettera di Alpini sfuggita ai controlli della censura.
Scrive il 13 giugno Vincenzo Gonella di Ceva:
Qui a Costigliole ho assistito, cara mamma, a cose commoventi che fanno strappare il cuore, son due giorni che colonne di profughi provenienti dai vicini paesi dei confini arrivano qua a Borgo San Dalmazzo e vengono man mano mandati via sul treno. Mai avevo visto scene così e prego Iddio mai più vederle. Vecchi e vecchi che a stento si trascinano, donne con bambini ancora in fasce chi addormentati chi piangenti, tutte le donne con gli occhi gondi di pianto, povera gente dover abbandonare così tutto. [inseriamo la fonte in nota?]
Gli Alpini sono i più sensibili perché soggetti al reclutamento territoriale: 17 provenendo dallo stesso ambiente delle popolazioni colpite, si identificano facilmente con gli sfollati. Lorenzo Giuliano Muglieris, recluta di Peveragno (quasi all’imbocco della vallata che conduce al colle di Tenda, in provincia di Cuneo), riferisce:
Il giorno 11 gli abitanti hanno ricevuto l’ordine di sgomberare, e alcuni soldati di fuori hanno svaligiato i pollai. I vitelli da latte li hanno venduti tutti al di sotto di lire 50, i capretti da 6 a 10 lire l’uno. Anche le poche mucche le hanno vendute a bassissimo prezzo, faceva compassione vedere tutta quella gente ad andarsene. [inseriamo la fonte in nota?]

41
I profittatori delle disgrazie altrui arrivano nei centri di fondo valle, pronti a lucrare sulla malasorte di chi è costretto a sfollare, e acquistano i capi sottocosto: qualcuno, più spregiudicato, propone di comprare i pochi oggetti di valore (orologi da taschino, medaglioni, collanine d’oro, i ricordi di famiglia di una vita) spiegando che «dove andate i soldi contanti possono servire di più».18
L’esodo imposto dalle autorità nelle alte valli trova riscontro in quello spontaneo che si verifica a Torino. I bombardamenti dell’11 giugno hanno creato panico: le case distrutte di via Priocca, a due passi dal popolare mercato di Porta Palazzo, la minaccia di nuove incursioni, l’impatto emotivo della «guerra in casa» diffondono uno stato d’animo di profonda insicurezza e migliaia di persone si allontanano di propria iniziativa. La prefettura calcola che tra i giorni 12 e 13 partano «circa 50.000 persone», altri 15.000 sono stimati per il giorno 14, 20.000 per il 15. Il giorno 16 giugno il prefetto comunica che «seguito incursione aerea esodo popolazione questa città est finora di oltre 112.000 persone», circa un sesto degli abitanti. Molti tornano nelle campagne piemontesi da cui sono emigrati per il lavoro industriale del capoluogo, ma vi è chi lascia la regione per raggiungere le proprie terre di origine. È il caso, in particolare, dei veneti: il 15 giugno il prefetto di Rovigo avverte di «non poter ricevere altri profughi», mentre quello di Torino replica che «è necessario che per ora non tornino». Analoga corrispondenza con il prefetto di Padova, cui il collega torinese telegrafa il 17 che «ritiensi inopportuno per ora ritorno profughi questa sede».[indichiamo la fonte in nota?]
L’emergenza è grave ma di breve durata: la cessazione delle ostilità permette agli sfollati di rientrare già a fine giugno sia a Torino sia nei villaggi alpini. Gli indennizzi dello Stato sono però modesti e, soprattutto, tardivi: solo nell’esercizio finanziario 1941-42 vengono stanziati due milioni e mezzo per «ricostruzione patrimonio bovino nelle zone del confine occidentale danneggiate dalla guerra».19 Molti, rimasti quasi del tutto privi di sostentamento, devono ricorrere ai meccanismi della solidarietà familiare: altri si ingegnano recuperando materiale ferroso abbandonato e rivendendolo agli stessi profittatori che qualche settimana prima hanno lucrato sul bestiame e che sono rimasti in zona perché un territorio di guerra offre diverse occasioni di guadagno.
La firma dell’armistizio

42
Dopo aver firmato a Compiègne la resa con la Germania, la delegazione francese guidata dal generale Charles Léon Huntziger giunge a Roma in aereo e la sera del 23 giugno, a Villa Incisa, incontra Badoglio, Ciano, Pricolo e Roatta, i quali presentano una bozza di armistizio. A differenza di quello che temono gli uomini del maresciallo Pétain, le condizioni poste sono miti: l’Italia chiede di presidiare il territorio occupato nel corso dell’offensiva, in pratica non più di qualche chilometro di territorio oltre confine.
La modestia delle richieste ha una spiegazione. Il 18 giugno, prima che inizino le operazioni sul fronte alpino, Mussolini e Ciano volano a Monaco a incontrarein quanto Hitler, il quale vuole chiarire le posizioni con l’alleato prima di incontrare i francesi. Le ambizioni territoriali italiane sono note: in una riunione del Gran Consiglio del Fascismo del febbraio precedente, il duce ha parlato della Tunisia, della Corsica, della costa somala e dell’occupazione continentale sino alla linea del Rodano (comprendendo, quindi, i due obiettivi più veicolati dalla propaganda, Nizza e Savoia): nella stessa direzione premono i vertici militari, i quali, nella prospettiva di un’espansione nel Mediterraneo, guardano anche ai porti dell’Algeria. Partendo per Monaco lo stato d’animo di Mussolini è tuttavia contraddittorio:
Il Duce è estremista: vorrebbe procedere all’occupazione totale del territorio francese e pretendere la consegna della flotta. Ma si rende conto che il suo parere avrà un valore consultivo perché la guerra è stata vinta da Hitler, senza un concorso militare attivo dell’Italia. Le sue riflessioni sul popolo italiano e soprattutto sulle nostre forze armate sono stasera di una estrema amarezza. [indichiamo la fonte in nota?]
Le indicazioni che arrivano dal Führer sono in effetti diverse da quelle ambite. Come spiega Ribbentrop a Ciano «conviene fare condizioni moderate di armistizio alla Francia, soprattutto per quanto concerne la flotta, e ciò per evitare una sedizione della Marina francese e il suo trasferimento in massa in Inghilterra».[indichiamo la fonte in nota?] La relativa moderazione dei tedeschi, che stupisce Ciano («trovo un Ribbentrop inconsueto: misurato, sereno, pacifista»20) nasce da calcolo politico:
Hitler non voleva l’occupazione totale della Francia perché militarmente troppo onerosa e pensava che condizioni troppo pesanti o disonorevoli potessero determinare il trasferimento del governo fuori dal territorio metropolitano, oltreché il passaggio delle navi da guerra agli inglesi. [indichiamo la fonte in nota?]

43
Al gruppo dirigente nazista il maresciallo Pétain sembra la persona adatta per un governo collaborazionista, che sgraverebbe la Wehrmacht dagli oneri legati a un controllo capillare del territorio e lascerebbe le truppe libere per gli ulteriori programmi di espansione: di qui le pressioni sull’alleato italiano perché rinunci a pretese troppo ambiziose, a maggior ragione dal momento in cui la guerra è stata dichiarata ma non combattuta. Alle rimostranze di Mussolini, che rivendica il diritto dell’Italia a uno sbocco sull’oceano, i tedeschi rispondono con cordialità ma anche allo stesso tempo con fermezza, ricordando come anche la Germania abbia ambizioni sul Marocco e come queste risalgono addirittura all’inizio del secolo, quando gli sforzi di Guglielmo II sono stati frustrati dall’asse tra Parigi e Londra, le vecchie potenze coloniali:
Mussolini non ignorava che uno dei maggiori punti di frizione con i tedeschi in sede di riassetto postbellico sarebbero stati i loro propositi di insediarsi nel Mediterraneo occidentale, una minaccia che egli poteva cercare di contrastare solo puntando sulla carta del «diritto» dell’Italia a subentrare alla Francia nel Nord Africa.21
Sentirselo dire dalla viva voce di Hitler e Ribbentrop ha il sapore di punto fermo e al rientro la delegazione italiana ha la consapevolezza di essere soccombente.
L’offensiva sferrata il 21 giugno non migliora la posizione di debolezza diplomatica italiana: mentre i tedeschi arrivano sino a Chambéry, il Regio Esercito non riesce a superare gli sbarramenti fortificatori di un paese già sconfitto. Il generale Orly, nel suo rapporto al Comando supremo, conclude che «la battaglia difensiva sulle Alpi è stata sicuramente vinta»; dello stesso avviso è il generale germanico Heinz Mittelhausen[con questa grafia non riesco a trovarlo a parte nel volume di Giorgio Bocca], che a Chambéry ha atteso invano il ricongiungimento con l’armata delle Alpi. Mentre si combatte, Badoglio e Roatta (che ignorano la portata delle limitazioni imposte) preparano una bozza di convenzione che sottopongono a Mussolini la sera del 22 e nella quale sono compresi gli obiettivi noti dell’espansionismo fascista nel Mediterraneo: il duce comunica in modo asciutto che «il testo non va bene e che la zona d’occupazione italiana sarebbe stata limitata ai soli territori che le truppe italiane avrebbero nel frattempo conquistato». I militari sono perplessi e cercano di far tornare il duce sulla sua decisione, ma l’unica clausola ulteriore che riescono a ottenere è «la creazione di una zona smilitarizzata di 50 chilometri a ovest della linea di occupazione e la smilitarizzazione delle piazzeforti di Tolone, Biserta, Ajaccio, Merse

44
el Kebir».22 Il nuovo testo, preparato da Ciano e Roatta, riproduce quello che è stato indicato a Monaco e che i quattro giorni di combattimento non sono in grado di modificare.
Il generale Huntziger, dopo aver letto la convenzione, chiede di poter consultare il suo governo a Bordeaux e l’incontro è aggiornato all’indomani. Quando le delegazioni si rincontrano non c’è nulla da rettificare, salvo la precisazione di un aspetto, che pure non è contemplato da nessuna clausola. Il generale Huntziger (il quale parla su suggerimento di Ciano, che lo ha avvicinato prima dell’inizio dei colloqui) pone la questione degli antifascisti fuorusciti: «Noi abbiamo dato ospitalità in un momento in cui ciò non era contrastato dal diritto internazionale a persone che ora dovremmo consegnarvi. Voi capirete il nostro stato d’animo». Badoglio confabula con Ciano e poi dichiara che l’Italia rinuncia alla consegna degli antifascisti. In realtà, l’Italia non vuole la consegna degli esuli per evitare provvedimenti e processi che il regime non gradisce e per non dare pubblicità a un fatto che l’opinione pubblica è meglio ignori»: 23 processare gli antifascisti significa ammettere che esiste l’antifascismo. Alle 19.15 vengono apposte le firme e data la notizia ai giornali: sei ore dopo cessano le ostilità.
I militari sono delusi (o almeno tali si presentano nelle memorie postume di Badoglio e Roatta): qualcuno sostiene che l’intervento doveva essere fatto nel Mediterraneo, puntando ai porti della Tunisia anziché ai valichi alpini, e dal punto di vista strategico ha ragione. La politica di Mussolini si muove tuttavia lungo altre direttrici e si fonda ancora sull’illusione di riuscire a contenere il potere tedesco sul continente attraverso un ruolo di mediazione: di qui un groviglio di velleità e di timori, e soprattutto una strategia contraddittoria, dove i tempi della politica si impongono a quelli della politica militare anziché coordinarsi con essa. Nella sua fulmineità, la campagna del giugno 1940 è rivelatrice dei limiti che porteranno alla disfatta del 1943, con il duce disorientato alla rincorsa delle scelte di Hitler e i capi militari incapaci di opporsi (spesso persino di obiettare) alle sue decisioni.
Gli italiani apprendono la notizia dell’armistizio al bollettino-radio delle otto di sera (che stanno imparando ad ascoltare ogni giorno, insieme a quello delle tredici, con l’ansia di essere aggiornati sulla guerra). I toni di Gian BattistaGiambattista Arista e Vittorio CrasmerCramer, che si alternano nella lettura, sono squillanti e trionfalistici: non potendo parlare di conquiste, i giornalisti dell’EIAR pongono l’accento sulla rapidità delle operazioni, sulla sconfitta totale

45
del nemico, sulla stima dell’alleato tedesco. Le voci popolari si rincorrono e si gonfiano, fantasticando di occupazione dei porti tunisini e algerini: l’eccitazione per la pace riconquistata sembra far dimenticare il disagio del 10 giugno e la facile vittoria scatena l’opportunismo predatorio. Lo stesso Calamandrei crede agli ingrandimenti coloniali e nel suo diario annota con un senso amaro di impotenza:
Siamo i servitori vigliacchi, che spolpano in cucina gli ossi rimasti nel piatto del padrone ... Eppure questa vergogna è una morbosa illusione letteraria. Se l’Italia si ingrandisce anche attraverso la vergogna, d’ora innanzi essa nel mondo apparirà più grande. Nella storia rimangono i risultati, i fini raggiunti, e si perde la traccia dei mezzi. Mussolini apparirà un grande conquistatore: con poche centinaia di contadini morti conquistò l’impero, si parla già di dargli il titolo di «pater patriae».24
A ristabilire la verità ci pensa un infortunio della propaganda fascista (anche se l’opinione pubblica è troppo distratta per coglierlo): nei giorni successivi Mussolini va a visitare i campi di battaglia alpini e i giornali dedicano ampi servizi fotografici ai suoi spostamenti su e giù per le valli. Negli stessi giorni Hitler visita è a Parigi e si fa immortalare accanto alla tomba di Napoleone. Qualche testata non ha l’accortezza di evitare i confronti e mescola nella stessa pagina le immagini delle due celebrazioni, offrendo uno spaccato plastico dei rapporti di forza in campo.

46
III La guerra parallela in Africa
L’operazione «Leone marino»
Nel momento in cui concede ai francesi condizioni armistiziali relativamente moderate e punta sul collaborazionismo di Pétain, Hitler spera che la Gran Bretagna prenda atto dei rapporti di forza e giunga a un accordo bilaterale, dandogli in questo modo la possibilità di intraprendere la «guerra principale» contro il comunismo sovietico con le spalle coperte a occidente. Prima ancora della fine delle ostilità con la Francia, Berlino ha fatto delle aperture indirette al governo di Londra attraverso il tramite confidenziale della legazione di Svezia. Durante l’incontro di Monaco del 18 giugno, Ribbentrop spiega a Ciano che
nell’opinione del Führer l’esistenza dell’Impero britannico quale elemento di stabilità e di ordine sociale nel mondo è di grande utilità e allo stato degli atti sarebbe impossibile sostituirlo con un’altra organizzazione analoga. Se l’Inghilterra vuole la guerra, sarà la guerra totale, assoluta, spietata, ma Hitler ha molte riserve sull’opportunità di demolire l’Impero britannico. Se Londra rinuncia ad alcune sue posizioni e riconosce il fatto compiuto sul continente, Hitler sarebbe disposto ad addivenire a un’intesa.1
Il governo britannico ha tuttavia un orientamento diverso: il 10 maggio si è dimesso il premier Arthur Neville Chamberlain, il maggior sostenitore della politica dell’«appeasement»2 alla vigilia della guerra, e lo ha sostituito Winston Churchill, a capo di un governo di coalizione nazionale. Il suo discorso di investitura alla Camera dei Comuni, il 13 maggio, è rimasto celebre:
Siamo nella fase preliminare di una delle più grandi battaglie della storia. Dirò alla Camera quello che ho detto a coloro che hanno aderito a questo governo: non ho nulla da offrire se non sangue, fatica e sudore. Abbiamo davanti a noi un calvario del tipo più grave. Abbiamo davanti a noi molti, molti lunghi mesi di lotta e di sofferenza. Voi domandate qual è il nostro obiettivo? Posso rispondere con una sola parola: la vittoria. La vittoria a tutti i costi. La vittoria nonostante tutto il terrore. La vittoria per quanto lunga e difficile la strada possa essere, perché senza la vittoria non c’è sopravvivenza.3
La decisione di resistere a oltranza e di non addivenire ad alcun accordo nasce in Churchill dalla certezza che il programma imperialista del nazismo mira all’assoggettamento di tutta l’Europa: le

47
aperture di Hitler e Ribbentrop sono soltanto un espediente tattico per poter scatenare il proprio potenziale militare verso est in sicurezza, ma una Germania che controlli l’intera parte continentale è destinata immediatamente dopo ad attraversare la Manica e puntare su Londra. Meglio dunque contrastare il nemico subito, prima che ulteriori conquiste ne moltiplichino la forza, giovandosi degli aiuti in armi e viveri offerti dagli Stati Uniti. La rocambolesca (e per molti aspetti eroica) evacuazione delle truppe britanniche da Dunkerque, con la partecipazione di tante imbarcazioni civili, è un’iniezione di fiducia per il governo Churchill, ma la criticità del momento è evidente e ne sono testimonianza le discussioni sull’impiego della flotta del Mediterraneo.
Gli alti gradi dell’Ammiragliato, l’autorità preposta al comando della Royal Navy, 4 sono orientati per uno sgombero preventivo, ritenendo che la base di Gibilterra può essere attaccata dal regime di Francisco Franco o da truppe italo-tedesche attestate in Spagna, quella di Malta ha una difesa minima ed è facilmente vulnerabile, mentre gli italiani possono da un momento all’altro bloccare il canale di Suez con il lancio aereo di mine, oppure minacciare i convogli che entrano nel Mar Rosso con i sommergibili di base in Eritrea: l’indicazione è lo spostamento della flotta nell’Atlantico e l’utilizzo della lunga rotta della del Capo di Buona Speranza per le comunicazioni con le colonie. Il comandante della Mediterranean Fleet, ammiraglio Andrew Cunningham, ritiene invece che l’abbandono del Mediterraneo sia una disfatta psicologica e militare irreparabile e che ci siano le condizioni per mantenere le posizioni: «se gli spagnoli ci lasciano in pace penso che anche con una piccolissima forza si possa presidiare Gibilterra e se gli sforzi nel Mediterraneo orientale e in quello occidentale sono opportunamente coordinati, sento che possiamo tenere gli italiani abbastanza bene impegnati».5
Churchill sposa le tesi di Cunningham: anche se in prospettiva futura sarà prioritario presidiare l’Atlantico per garantire i rifornimenti dall’America, bisogna dimostrarsi determinati di fronte al nemico e non ripiegare su strategie solo difensive. Le vicende belliche del mese di maggio danno loro ragione: la flotta italiana non fa alcun tentativo per sfruttare il fattore sorpresa, Malta non viene attaccata, i bombardieri dell’aeronautica non intervengono. L’11 maggio alcune unità britanniche lasciano il porto di Alessandria e puntano verso ovest per un’azione dimostrativa e per saggiare la reazione della Regia Marina, e constatano la titubanza italiana: «Mi aspettavo» scrive Cunnigham «di non poter trascorrere una sola ora del giorno senza

48
subire incursioni aeree nemiche e invece ci hanno lasciati navigare completamente tranquilli».6
Dunque, il controllo del Mediterraneo (che gli Inglesi hanno sempre considerato il perno del loro impero) non è insidiato: la strategia della «guerra a oltranza per la sopravvivenza» trova una prima, importante conferma. Quando i francesi firmano l’armistizio, il governo di Londra e l’opinione pubblica inglese sono ormai pronti per iniziare la resistenza «a ogni costo» al nazismo. Pochi giorni dopo, il 3 luglio, la Royal Navy realizza un’azione controversa ma spettacolare: una squadra comandata dal viceammiraglio James Fownes Somerville lascia la base di Gibilterra dirigendosi verso la rada di Mers-el-Kébir, sulla costa algerina, dove è ormeggiata una parte della flotta francese, e apre il fuoco, provocando morti tra i marinai e affondamenti tra le unità. Nata dalla preoccupazione che italiani e tedeschi possano impossessarsi delle navi francesi, l’azione ha ripercussioni sulle clausole armistiziali (la smilitarizzazione dei porti tunisini e algerini, voluta da Badoglio e Roatta, viene annullata) ma, soprattutto, assume valore a livello di immagine: anche se non mancano moti di indignazione per un’azione diretta contro reparti che sino a qualche giorno prima erano alleati, l’incursione dimostra che l’Inghilterra di Churchill non soltanto non si arrende, ma è pronta a contrattaccare.
Hitler prende atto della scelta inglese e muta i propri piani strategici: l’attacco all’Unione Sovietica deve essere rinviato e bisogna concentrarsi nell’attacco oltre Manica. Il Führer ne parla esplicitamente il 21 maggio, indicando l’ipotesi di uno sbarco nel Kent e nel Sussex, che viene però ritenuto inattuabile da Wilhelm von Keitel, comandante della Wehrmacht. Vengono allora prese in considerazione le note dell’ammiraglio Erich Raeder, comandante in capo della Marina da guerra germanica, che sin dall’autunno del 1939 ha predisposto un memorandum per l’invasione, prevedendo la cooperazione tra forze della Marina e forze dell’Aeronautica: lo sforzo principale ricade sulla Luftwaffe, che deve annientare l’aviazione nemica e distrarre la Royal Navy dalla Manica, aprendo in questo modo la strada allo sbarco da effettuarsi in punti diversi della costa. Il 2 luglio Hitler emana le prime disposizioni per quella che in codice viene chiamata «Operazione Leone marino» («Unternehmen Seelöwe»). Venti divisioni, impiegate nella campagna di Francia e di cui è prevista la smobilitazione, vengono trattenute in armi, mentre si requisiscono migliaia di natanti fluviali da impiegare nell’attraversamento del canale.

49
Il piano di Raeder, in realtà, è più ambizioso: egli vorrebbe contestualmente attaccare l’Inghilterra nei suoi interessi imperiali, occupare l’Africa del Nord e Gibilterra, impadronirsi delle Canarie con un lancio di paracadutisti, arrivare a Suez. La dimensione marittima è però estranea a Hitler:
La sua ottica rimane sempre quella delle operazioni terrestri, si varca il mare solo per continuare o tentare di continuare le operazioni terrestri, per arrivare a contatto col nemico con carri armati e aerei, le sole armi che egli considera decisive. «Si studino pure eventuali azioni diversive in Africa» egli afferma il 31 luglio di fronte ai vertici militari, «è certo però che solo un attacco contro l’Inghilterra da condurre sul suolo dell’isola può decidere il conflitto».7
Queste decisioni vengono prese dai tedeschi senza consultare l’alleato italiano, che pure dispone di una flotta assai superiore a quella germanica. Come testimonia il viceammiraglio Eberhard Weichold, nel 1940 addetto militare a Roma,
non esisteva nessun piano comune di operazioni marittime per la guerra contro la Gran Bretagna. Gli ufficiali dello stato maggiore di collegamento a Roma erano tenuti esclusi dagli uffici operazioni italiani e venivano brevemente informati dei risultati delle operazioni o da rapporti incolori e preconcetti o da un ufficiale di collegamento. Peraltro l’ammiragliato l’ammiraglio italiano di collegamento a Berlino era trattato in modo analogo.8
Quando l’ambasciatore Alfieri viene informato della nuova prospettiva strategica, Mussolini propone di mandare uomini e aerei per partecipare all’invasione ma Hitler non risponde neppure all’offerta, «anzi è lui che ci offre mezzi aerei per bombardare il canale di Suez» e lo stesso Ciano annota che «evidentemente la sua fiducia in noi e nelle nostre possibilità militari non è eccessiva!». Qualche giorno più tardi il rifiuto tedesco viene ufficializzato: «Hitler ha diretto al Duce una lunga lettera» scrive il ministro degli Esteri sul diario in data 16 luglio «in cui preannunzia come cosa deciso l’attacco all’Inghilterra, ma declina in forma altrettanto cortese che definitiva l’invio di un corpo di spedizione italiano. Spiega questo suo rifiuto con le difficoltà logistiche che sorgerebbero qualora si dovesse rifornire una duplice armata».9
La morte di Italo Balbo
Il vento della guerra soffia e l’Italia vi è ormai rotolata dentro. Rispetto all’«Operazione Leone marino» si propongono dinamiche analoghe a quelle della campagna contro la Francia. Hitler decide i

50
tempi e gli scacchieri, Mussolini li rincorre. I reparti del Regio Esercito non potranno marciare su Londra accanto alla Wehrmacht così come non hanno marciato su Parigi e le alternative restano le stesse: assistere inerti e impotenti alla vittoria tedesca (augurandosi che il crollo inglese non sia totale come quello francese), oppure cercare di combattere condurre una guerra parallela nell’impero coloniale di «casa nostra» attaccando gli inglesi in Africa settentrionale e in Africa orientale. Stesso dilemma e stessi dubbi: combattere ma senza investire tutte le risorse militari disponibili, perché forse in un prossimo futuro le divisioni serviranno per difendere il Brennero dalle mire dell’alleato nazista; sconfiggere gli inglesi ma non troppo, per non contribuire alla dissoluzione della Gran Bretagna che rappresenta pur sempre un elemento di controbilanciamento allo strapotere di Berlino; conseguire vittorie di prestigio spendibili per la propaganda interna e per sedere al tavolo della pace, conservando tuttavia margini di fiducia politica da parte di Londra per legittimare un ruolo di mediazione. È una strettoia diplomatica e militare troppo ardua per essere percorribile con linearità e quindi soggetta a riflettere contraddizioni, reazioni umorali, improvvisazioni, rivalità.
In giugno e luglio non mancano scaramucce iniziali ai confini tra la Libia italiana e l’Egitto inglese, ma senza offensive su larga scala: gli scontri costano tuttavia la vita al governatore della colonia. Dal 1934 la Libia è governata amministrata da Italo Balbo, il quadrumviro che nel corso del Ventennio ha proposto un modello complementare ma non alternativo a Mussolini: personaggio carico di fascino personale, dannunziano nei gesti e nel tratto, con gli occhi neri e grandi e la barbetta a punta, tra gli uomini del regime è il gerarca più popolare per il ruolo avuto alla guida dell’Aeronautica ed è il più autonomo e meno servile rispetto al duce. Nato nel 1896,
Balbo appartiene a una solida famiglia della borghesia ferrarese, che garantisce ai figli buona cultura e un decoroso tenore di vita. Allievo insofferente della disciplina scolastica, giunge alla soglia dei vent’anni senza aver conseguito la licenza liceale, ma con un’esperienza di militanza nei fasci d’avanguardia, una piccola formazione politica antigiolittiana e antisocialista.10
Nel solco di questo orientamento, si arruola volontario alla vigilia della Grande guerra e combatte come ufficiale di complemento nei reparti alpini, anche se la mitologia successiva lo accrediterà come ardito.11 Per tanti aspetti, egli è un tipico figlio di quella stagione storica, bellicista per impazienza e scontento, teso ad affermarsi a ogni costo tra scaltrezza, violenza, seduzione. Quadrumviro a 26 anni,

51
generale della milizia a 27, ministro dell’Aeronautica a 30, protagonista degli spettacolari raid in Brasile e negli Stati Uniti, attorniato da una corte principesca di collaboratori per il gusto personale del fasto, all’interno del gruppo dirigente fascista egli risulta un personaggio scomodo: «Balbo e i suoi» scrive Bottai «non sapevano che vivere di fazione, all’estrema punta, tutto vibrazioni polemiche». 12 Di fatto, il gerarca di Ferrara non costituisce una minaccia alla leadership di Mussolini perché gli manca la capacità di elaborare strategie di lungo periodo, ma è personaggio straripante che il duce non ama e di cui non si fida sino in fondo e per questo nel 1934 viene mandato in Libia come governatore, assommando i poteri che prima avevano Badoglio in Tripolitania e Graziani in Cirenaica. È la tecnica del «promuovere per rimuovere», come Balbo coglie subito («mi manda in Libia a morire di noia», anche se opera perché nessuna reazione a suo favore si registri nel suo feudo di Ferrara, timoroso di compromettere ulteriormente la propria posizione).
Nei sei anni trascorsi nella colonia, il governatore non si illustra per iniziative di particolare significato: a differenza di quello che viene fatto in Somalia dal duca degli Abruzzi Luigi Amedeo d’Aosta, con la grande azienda agricola dello Uebi Scebeli che alimenta i miti del principe-contadino e di un colonialismo italiano lungimirante e benefico, Balbo si limita a spettacolarizzare l’arrivo degli emigrati dalla madrepatria, a battezzare demagogicamente «Balbia» la via consolare litoranea, a organizzare tournée teatrali e musicali per accreditare la Libia italiana di vivacità artistica.
Durante il suo governatorato non è stata realizzata nessuna opera che caratterizzi una politica coloniale preveggente. La Libia arriva alla guerra senza le infrastrutture che permettono a un esercito di operare su più fronti: i porti o sono insufficienti come nella Cirenaica, o mancanti come nella Marmarica, o mal difesi come a Tripoli. Nessuno ha studiato seriamente i rifornimenti via mare per piccolo cabotaggio, con navi leggere, i più sicuri e meno costosi; si è fatta la strada litoranea e non la ferrovia, come dire si è scelta la comunicazione più costosa e più insicura. La frontiera ovest verso la Tunisia francese, a parere dello stesso maresciallo, è praticamente aperta, quella est verso l’Egitto inglese è dovunque mal presidiata.13
L’unica iniziativa militare di Balbo è la costituzione di un reparto di paracadutisti. Mentre in patria lo stato maggiore del Regio Esercito e quello della Regia Aeronautica litigano su chi debba avere il futuro comando dei reparti aviolanciati e le polemiche frenano l’inizio degli addestramenti, Balbo avvia il progetto nel marzo 1938 nell’aeroporto militare di Castel Benito (Ben Gascir), nell’entroterra di Tripoli.

52
L’unità ha le dimensioni di un piccolo battaglione, con 100 uomini divisi in tre compagnie ridottissime di 33 elementi ciascuna. Data la scarsa affluenza di volontari italiani, il reclutamento viene aperto al personale libico, che di fatto costituisce il nerbo del battaglione. I ritmi dell’addestramento sono intensi perché Balbo vuole dimostrare in fretta l’efficienza del suo reparto. A metà aprile iniziano i lanci, durante i quali si verificano numerosi incidenti messi facilmente a tacere dal regime di controllo coloniale; a fine mese il governatore decide di costituire un secondo battaglione e di inquadrare i due reparti in un reggimento, denominato «Fanti dell’aria»; il 23 maggio viene fatta un’esercitazione nella piana di Bir el Gnem, con il lancio di tutti gli uomini disponibili. I risultati sono positivi e l’esempio di Castel Benito diventa subito riferimento nazionale, con gruppi di ufficiali che vengono nella colonia a addestrarsi in brevi corsi preparatori e riportano le competenze in patria (dove infatti poco dopo, presso l’aeroporto di Tarquinia, viene costituita la scuola di paracadutismo).
Poco incisivo sul piano operativo, Balbo è però lucido nel riconoscere l’inadeguatezza dell’organizzazione militare e, a differenza di molti altri, non ha timore a sostenere con Mussolini l’inopportunità della guerra. Ostile sin dal 1936 all’alleanza con la Germania che considera una scelta destinata a portare alla subalternità dell’Italia («Balbo non discute i tedeschi, li odia, ed è quest’odio insanabile che guida tutto il suo ragionamento» annota Ciano14), nella primavera del 1940 cerca di evitare il coinvolgimento della colonia nelle operazioni. L’11 maggio, all’indomani dell’attacco nazista alla Francia, il governatore scrive una lunga lettera al duce in cui prospetta la situazione:
Ieri mi avete detto che per la fine del corrente mese debbo essere pronto in Libia con il minimo indispensabile per entrare in campagna, affermando che entro il corrente maggio mi saranno mandati altri 80.000 uomini, le armi e i viveri per sei mesi d’autonomia. Il generale Soddu mi ha pregato di fargli avere subito l’elenco dei materiali che ritengo necessari. Con questi arrivi, la proporzione tra le truppe ai miei ordini e le avversarie sarà di uno a tre.
Al di là dell’inferiorità numerica in una colonia esposta su due fronti, ciò che preoccupa Balbo è la mancanza di fortificazioni:
Lasciatemi dire che, con grandi unità fornite di limitate e vecchissime artiglierie, ho assolutamente bisogno di poter contare sugli sbarramenti delle due vie d’accesso alla Tripolitania, sulla cinta di Tripoli e su quelle di Tobruk e Bardia.

53
Le osservazioni di Balbo sono realistiche e si sviluppano nella prospettiva di una guerra difensiva: di qui le richieste di «mettere in efficienza le fortificazioni e provvedere adeguatamente alla difesa contraerea», oltre alla comunicazione delle disposizioni prese per l’evacuazione dei civili più esposti.15
Con la dichiarazione del 10 giugno il quadro strategico muta radicalmente: mentre non sono ancora giunti tutti i rinforzi promessi, dall’ipotesi della difesa si passa a quella delle azioni offensive. Balbo è perplesso e pessimista sui risultati, ma è anche uomo del regime e non può opporsi alle decisioni prese. Scrive Ciano:
Ho visto Balbo che si prepara a tornare in Libia. È deciso a fare del suo meglio, ma non crede che si tratti di guerra rapida e facile e afferma che l’armamento a sua disposizione è sufficiente solo per un conflitto di corta durata. Ma se le previsioni in questo senso dovessero fallire? Comunque è un soldato e si batterà con la più accesa decisione.16
Balbo mobilita i propri reparti in vista di futuri ordini di attacco e, nell’immediato, fronteggia alcune incursioni inglesi. Si tratta di azioni di entità modeste, che rientrano nella logica di Churchill di non mostrarsi timoroso e arrendevole, ma sono sufficienti a mostrare evidenziare le criticità dello schieramento italiano. Nonostante Balbo si prodighi in un’attività frenetica per tentare di galvanizzare con la sua presenza le truppe e tempesti Roma con telegrammi per avere subito mezzi e armi controcarro, i risultati sul campo sono negativi. Per fermare le pattuglie inglesi egli è infatti costretto a ricorrere all’aviazione, che viene così subordinata alle esigenze della battaglia terrestre nonostante sia stato proprio lui, come ministro, a sostenere la necessità di impiegare gli aerei solo per fiaccare la resistenza nemica con bombardamenti strategici: «Reparti da bombardamento, da caccia, da ricognizione, senza tener conto delle caratteristiche tecniche delle macchine, furono lanciati nella difficile ricerca e nella ancor più difficile offesa delle autoblinde e dei veloci carri armati nemici» .17 Alla data del 28 giugno, sono già stati persi 60 apparecchi su 315, un quinto della forza totale presente nella colonia. Balbo ribadisce a Badoglio le inadeguatezze:
La sola divisione corazzata inglese che è in linea ha 360 tra autoblinde e carri armati medi. Non si può competere con fucili e mitragliatrici. I nostri carri d’assalto sono ampiamente sorpassati, le mitragliatrici delle autoblinde inglesi li crivellano di colpi che passano allegramente la corazza. Così il combattimento assume le caratteristiche della carne contro il ferro.

54
Mentre il governatore assicura che «non molleremo e faremo miracoli»,18 Mussolini è critico: «Il Duce è molto indignato con Balbo, il quale in Cirenaica ha per ora raccolto una buona serie di insuccessi, nonostante la quantità di uomini a sua disposizione».19 In realtà, la situazione libica non va misurata in termini astrattamente militari, perché è dominata da pressanti esigenze politiche:
Dinanzi alle grandi vittorie tedesche in Francia, che facevano balenare la possibilità di una pace a non lunga scadenza, gli insuccessi iniziali italiani acquistavano un rilievo del tutto spropositato e la decisione di Balbo di lanciare l’aviazione contro le autoblinde britanniche, tecnicamente discutibile, era invece opportuna perché permetteva di ristabilire un equilibrio. L’Africa settentrionale, considerata per anni secondaria, si rivelava invece un teatro importantissimo, l’unico su cui fossero possibili le acquisizioni territoriali che dovevano giustificare l’intervento in guerra.20
L’ultimo messaggio a Balbo parte da Roma il 28 giugno ed è un incitamento ad assumere un atteggiamento offensivo verso est. Scrive Badoglio:
Situazione va chiarendosi nel senso che colonie francesi obbediscono agli ordini del governo Pétain. Allora tu non hai che da far fronte a oriente. Le truppe sul confine con la Tunisia devono servire come deposito rifornimento per quelle a est verso l’Egitto, da esse trarrai ufficiali, soldati, materiali. Concentra tutti automezzi a est, fai di tutto per essere pronto il giorno 15 luglio.21
Il governatore non ha modo di leggerlo perché è partito per un’azione che dovrebbe rincuorare le truppe: un complesso agguato che dovrebbe portare alla cattura di alcune autoblinde inglesi grazie all’attacco combinato di una colonna celere e di uno stormo da caccia. Balbo, accompagnato tra gli altri dall’amico giornalista Nello Quilici, dal segretario del partito a Tripoli Enrico Caretti e dal nipote Lino Balbo, decolla da Derna con un SIAI - Marchetti 79 diretto a Sidi Azeiz, ma in vista di Tobruk vede scorge alte colonne di fumo dovute a un bombardamento inglese e decide di andare a vedere che cosa succede. Nell’agitazione del momento forse l’equipaggio dimentica di effettuare le procedure identificative prescritte, o forse laggiù in basso non le ricevono: d’altra parte l’apparecchio arriva controsole e a terra non è ancora cessato l’allarme per il precedente attacco. Sta di fatto che le armi contraeree dell’incrociatore San Giorgio aprono il fuoco scambiandolo per un mezzo nemico e lo centrano in pieno. Il trimotore S79 si incendia in volo e si schianta a un chilometro dal porto, senza lasciare scampo ai passeggeri. Un altro S79, che segue il primo e che trasporta il generale Felice Porro, comandante

55
dell’aeronautica in Libia, e il generale Giuseppe Tellera, capo di stato maggiore del Comando superiore, riesce con una picchiata a evitare di essere colpito in parti vitali e, nonostante i danni, atterra poco lontano.
L’abbattimento alimenta leggende sulle presunte responsabilità di Mussolini, che avrebbe ordinato il fuoco amico per sbarazzarsi di un possibile concorrente. Si tratta di illazioni prive di fondamento, perché il duce
non aveva alcun motivo per liberarsi di Balbo, tanto più nel momento in cui era impegnato in un’incerta battaglia che doveva procurare una vittoria italiana o un duro colpo al proprio prestigio. La dinamica dell’incidente del 28 giugno permette poi di escludere qualsiasi possibilità di premeditazione, perché troppe furono le coincidenze che si sovrapposero.22
Certo è che con Balbo se ne va un gerarca scomodo e il regime gli dedica manifestazioni di cordoglio solenni, ma sostanzialmente fredde e ufficiali: nessuna di quelle celebrazioni funebri di massa nelle quali il fascismo ha chiamato la popolazione a raccogliersi, nessun discorso pubblico di qualche risonanza, nessuno monumento funebre nei mesi successivi, nessuna presenza nella toponomastica (solo l’Università di Ferrara, due anni dopo, viene intitolata al suo nome). Se in questa rinuncia a celebrare onorare l’eroe caduto incide l’emergenza della guerra, che lascia poco spazio alla dimensione celebrativa, è però certo che la prima ragione vada ricercata nell’indipendenza e nella popolarità di Balbo, sgradite a Mussolini per diffidenza e agli altri gerarchi per invidia. Le dittature non accettano le voci dissonanti, anche quando non si traducono in dissenso aperto. L’appunto sbrigativo e superficiale scritto il 29 giugno da Ciano è significativo:
È morto Balbo, un tragico equivoco ha determinato la sua fine nei cieli di Tobruk. Non meritava questa morte: era esuberante, irrequieto, amava la vita in ogni sua manifestazione. Aveva più impeto che ingegno, più vivacità che acume. Ma era un uomo dabbene, e anche nella lotta politica – che il suo temperamento fazioso ricercava – non si sarebbe mai abbassato a espedienti disonoranti o ambigui.23
Mussolini si limita a una breve commemorazione ufficiale in consiglio dei ministri e a uno scontato telegramma di condoglianze alla vedova. Un anno più tardi, il 28 luglio 1941, lo commemorerà ricorderà in un aeroporto dell’Italia centrale, mettendo soprattutto in rilievo se stesso («egli è stato il mio discepolo. Apparteneva alla generazione italiana alla quale fu da me data questa orgogliosa consegna, vivere pericolosamente»24): troppo poco per un uomo che è

56
stato per vent’anni tra le figure di maggior spicco del fascismo e che nel 1940 è l’unico gerarca ad avere un comando operativo d’armata.
L’attacco all’Egitto
A sostituire Balbo nel comando viene inviato il maresciallo Graziani, che in Libia è stato dall’inizio degli anni Venti al 1934, guidando prima la riconquista della Tripolitania, poi la repressione del ribellismo in Cirenaica. Per alcuni aspetti si tratta di una nomina logica, per altri rinvia all’intento di Badoglio di allontanarlo dall’Italia: «Io non ero affatto convinto che il maresciallo Graziani fosse al suo posto come capo di stato maggiore dell’esercito» scriverà Badoglio nelle sue memorie. «Mancava di adeguata preparazione e non aveva alcuna dimestichezza con i complessi problemi di uno stato maggiore così importante, ma lo ritenevo un buon comandante di truppe e possedeva una precisa cognizione del settore cirenaico-egiziano».25 Le forze presenti in Nord Africa sono costituite dalla V Armata, comandata dal generale Italo Gariboldi e schierata sul confine tunisino, e la X Armata del generale Cesare Mario Berti, disposta a est sul confine egiziano. Il generale Giuseppe Tellera, già capo di stato maggiore di Balbo, mantiene il ruolo e garantisce la continuità organizzativa. Sul piano numerico la situazione è positiva, con 13 divisioni e circa 220.000 uomini, ma i problemi veri sono quelli denunciati da Balbo: poco più di 3000 autocarri, quando ne servirebbe oltre 11.000; 274 carri armati piccoli, anziché un numero almeno doppio di carri medi (secondo le necessità stimate dai comandi); una squadra aerea guidata dal generale Porro cui sono rimasti 255 apparecchi funzionanti, privi peraltro di prese d’aria antisabbia e radiatori supplementari. Come già Balbo, anche Graziani denuncia l’impossibilità di una strategia offensiva e mantiene uno schieramento prudente, nonostante sappia che il duce ha fissato al 15 luglio l’inizio dell’attacco.
Tra tergiversazioni ed espedienti dilatori, Graziani prende tempo, trovando consenso tra i comandanti del suo scacchiere, che il 18 agosto inviano una lettera al duce (sottoscritta dai generali Gariboldi, Berti, Porro e Tellera) in cui si dichiara «all’unanimità che nelle condizioni attuali non è possibile un’offensiva degna di questo nome, ma sono possibili solo piccole operazioni tendenti a mantenere il prestigio sull’avversario». 26 Le settimane vengono impiegate in spostamenti di truppe e di mezzi per dare la sensazione di un fronte in fermento, la costruzione di ridotte e postazioni fisse nel deserto, la

57
predisposizione di reticolati e barriere d’arresto: in realtà, nella divergenza tra le valutazioni dei militari e le indicazioni del duce, si disperdono le forze mescolando insieme approntamenti difensivi e offensive ed esponendo i reparti alle veloci incursioni dei blindati britannici.
Nei mesi di luglio e agosto Mussolini si limita a sollecitazioni perché sul fronte inglese le operazioni sono a loro volta in ritardo. Lo sbarco oltre Manica è infatti subordinato alla capacità della Luftwaffe di Hermann Göring di aprire la strada con i bombardamenti a tappeto degli aeroporti e delle strutture della Royal Air Force britannica (RAF), dei principali centri industriali dell’isola, degli obiettivi strategici. Partendo dalla Germania, dalla Francia e dalla Norvegia, gli apparecchi tedeschi iniziano a metà luglio la cosiddetta «battaglia d’Inghilterra» provocando distruzioni, ma ottenendo risultati molto inferiori alle aspettative: la mancanza di adeguate informazioni sull’apparato difensivo britannico, l’efficacia del sistema di avvistamento predisposto da Londra, l’intercettazione delle comunicazioni radio tedesche, la capacità di interdizione dei caccia Spitfire e Hurricane27 permettono di limitare i danni e di infliggerne a propria volta ai bombardieri della Luftwaffe, tanto che l’«Operazione Leone marino» viene rinviata agli inizi di settembre.
Probabilmente Hitler ha intuito già in agosto che l’esito della battaglia d’Inghilterra non gli è favorevole e che lo sbarco oltre Manica non è quindi praticabile, ma Mussolini non viene informato degli orientamenti strategici in evoluzione, né l’ambasciatore Alfieri a Berlino percepisce qualche variazione. Nella convinzione che lo sbarco sia imminente, il duce si rivolge in modo perentorio a Graziani:
L’invasione della Gran Bretagna è decisa, è in corso di ultimazione come preparativi e avverrà. Circa l’epoca, può essere tra una settimana o tra un mese. Ebbene il giorno in cui il primo plotone di soldati germanici toccherà il suolo inglese, voi simultaneamente attaccherete. Ancora una volta vi ripeto che non vi fisso limiti territoriali: non si tratta di puntare su Alessandria e nemmeno su Sollum. Vi chiedo soltanto di attaccare le forze inglesi che avete di fronte.28
È la strategia della «guerra parallela», una serie di attacchi non coordinati con le operazioni tedesche ma a esse concomitanti, dove il Regio Esercito può ottenere successi parziali e certamente marginali rispetto a quelli della Wehrmacht, ma tuttavia tali da assicurare prestigio al regime e piccoli spazi di espansione per la nostra economia. Nella campagna di Francia gli italiani sono arrivati in netto ritardo e il danno di immagine è stato contenuto solo perché le operazioni sono terminate dopo pochi giorni: in Africa settentrionale

58
Mussolini non vuole correre lo stesso rischio di intempestività e insiste per l’offensiva, nonostante le riserve dei militari. Si tratta di dare seguito ai piani predisposti due anni prima dall’allora sottosegretario alla Guerra Alberto Pariani per l’attacco all’Egitto partendo dalle basi libiche: impegnata a fronteggiare lo sbarco tedesco, l’Inghilterra non potrà inviare rinforzi, né la sua flotta potrà bloccare i trasporti mediterranei della nostra Marina.
Il 7 settembre Graziani compie un ultimo tentativo dilatorio, chiedendo a Mussolini di rinviare l’offensiva alla prima decade di ottobre, ma ne riceve un netto rifiuto e l’ordine perentorio di attaccare subito. Il maresciallo non può che eseguire: il 9 settembre una massa di 7 divisioni appiedate (5 italiane, di cui una di camicie nere, e 2 libiche) riunite nella X Armata varca il confine e si dirige verso Sidi el-Barrani, un villaggio egiziano vicino alla costa mediterranea, là dove un tempo sorgeva la città romana di Zygra. Si tratta di un obiettivo di scarsa importanza strategica, ma spendibile sul piano della propaganda perché sottratto al nemico. Dopo un intenso bombardamento aereo sull’obiettivo finale e su altri villaggi della costa, le divisioni italiane avanzano su due colonne raggiungendo Sidi el-Barrani senza trovare resistenza, perché gli inglesi si limitano a incursioni aeree contro le colonne in marcia e lasciano sul terreno solo qualche pattuglia motorizzata in osservazione e qualche batteria autotrasportata.
Quando entra nel villaggio e vi insedia il comando, Graziani è trionfalistico nella comunicazione con Roma: egli parla di un nemico in disordinato ripiegamento, che ha perso metà dei propri carri armati e numerosi aerei, e di una rapida penetrazione italiana in profondità, per oltre 80 chilometri dal confine. La realtà è più asciutta. In primo luogo, la penetrazione c’è stata, ma in un terreno semidesertico, dove il valore delle distanze è assai diverso dallo scacchiere europeo; in secondo luogo, gli inglesi non sono stati sconfitti in battaglia perché hanno evitato lo scontro preferendo una ritirata tattica; in terzo luogo, tra scaramucce e attacchi aerei i britannici hanno lasciato sul campo 50 uomini, gli italiani 120. Intimamente Graziani ne è consapevole, e le sue scelte successive lo dimostrano: anziché continuare l’offensiva verso Marsa Matruh (il principale centro urbano della costa oltre la frontiera libica), egli suddivide le sue truppe in campi trincerati e inizia la costruzione di una strada e di un acquedotto per l’avanzata successiva, chiedendo contemporaneamente a Badoglio l’invio di rinforzi.

59
Il duca d’Aosta in Africa orientale
L’azione di Graziani dalla Libia verso il delta del Nilo dovrebbe essere combinata con un’offensiva analoga che punti all’Egitto muovendo da sud, dall’Abissinia e dall’Eritrea: un’operazione a tenaglia, per spezzare in due tronconi l’Impero britannico in Africa e prendere il controllo di Suez e del Mar Rosso. Uno studio particolareggiato per un’offensiva che parta dall’Africa orientale italiana (AOI) viene predisposto dal tenente colonnello Federico Cargnelutti già nel gennaio 1940, rielaborato in aprile dal capo di stato maggiore del duca d’Aosta generale Luigi De Biase, e ripreso in forma definitiva in luglio dal console generale della milizia Aldo Marchese. In concomitanza con l’attacco dalle basi libiche, le truppe di stanza in Etiopia dovrebbero avanzare verso il Sudan per poi puntare alla bassa valle del Nilo. Il piano è fatto proprio dal Comando supremo e Badoglio manda indicazioni esplicite in un messaggio del 13 agosto: «Concentrare i mezzi e gli sforzi per un’offensiva contro il Sudan, da svilupparsi insieme a quella che il maresciallo Graziani sferrerà dalla Libia, tendendo al canale di Suez. Si attendono rassicurazioni in merito».29
Nell’AOI la responsabilità di comando è affidata al viceré Amedeo di Savoia, duca d’Aosta, giunto in Etiopia nel gennaio 1938 per sostituire il maresciallo Graziani. La situazione che il principe sabaudo ha trovato è precaria: l’ingresso trionfale delle truppe a Addis Abeba, la fuga di Hailé Selassié e la proclamazione dell’impero tornato dopo secoli sui «colli fatali di Roma»30 hanno concluso le operazioni militari contro l’esercito regolare abissino, ma questo non significa controllo reale del territorio. La durezza dell’occupazione italiana, la politica di espropri della terra, le violenze intimidatorie, unite alle tradizioni di indipendenza del popolo etiope e alla funzione aggregante del clero copto, alimentano da subito una guerriglia che il fascismo non sa affrontare. In una regione come l’Etiopia, priva di strutture centralizzate e retta da una feudalità guerriera forte e poco omogenea, la potenza coloniale dovrebbe cooptare parte della classe dirigente locale nell’esercizio del potere. L’impostazione del regime comporta invece un atteggiamento di intransigenza e l’esclusione degli indigeni da funzioni di responsabilità, che vengono interamente attribuite a funzionari giunti dall’Italia (i quali si rivelano spesso impreparati e ignari dei problemi locali). Questa scelta, che nel 1937 si traduce nella pianificazione organica della segregazione razziale con la negazione dei diritti politici agli africani e l’imposizione a tutta

60
la colonia di consuetudini europee, suscita un diffuso malcontento che si traduce in sostegno al movimento di liberazione abissino.
Di fronte al viceré Graziani si sviluppa una resistenza di massa sostenuta dalla popolazione, con bande di armati che si spostano rapidamente sul territorio conducendo una guerriglia intensa contro i piccoli presidi italiani e le vie di comunicazione. Agli attacchi il viceré risponde con rastrellamenti affidati a reparti di ascari, 31 che infieriscono contro i civili incendiando e razziando, ma di rado intercettano i gruppi armati. In parallelo alle azioni punitive sul territorio, Graziani avvia l’eliminazione sistematica della classe dirigente etiope. L’occasione è data dall’attentato del 19 febbraio 1937, quando due giovani studenti di origine eritrea eludono la sorveglianza e penetrano nel recinto del piccolo Ghebì, nella capitale, un’area dove si svolge una cerimonia per festeggiare la nascita del primogenito del principe Umberto di Savoia. I due attentatori lanciano alcune bombe, uccidendo sette persone e ferendo lo stesso viceré. La rappresaglia è violentissima: in tre giorni di terrore, le strade di Addis Abeba si riempiono di abissini massacrati, 30.000 morti secondo le cifre denunciate nel 1945 dal governo etiope, 6000 secondo i giornali francesi e inglesi dell’epoca.32 Il progetto di pacificazione imposto con le armi si rivela tuttavia fallimentare e le repressioni non fanno che aumentare l’avversione per gli occupanti. Di fatto, gli italiani sono padroni solo dei centri abitati, mentre le zone di campagna passano sotto il controllo dei patrioti etiopi, la cui azione è sostenuta dagli inglesi con l’invio di armi dal vicino Sudan e dal Kenia.
Nell’inverno del 1937 Mussolini decide la sostituzione di Graziani, che si è rivelato inadeguato al compito, e manda al suo posto il duca d’Aosta Amedeo, cugino dell’erede al trono Umberto. La scelta ha una triplice motivazione: Amedeo è una figura che non ha le ruvidezze di Graziani e che può quindi inaugurare una politica meno aspra e più efficace; in secondo luogo, assicurata al fascismo e al duce la gloria della conquista imperiale, si tratta ora di coinvolgere i Savoia nel mantenimento della colonia per evitare che i contraccolpi delle difficoltà ricadano solo sul regime; in terzo luogo, il duca d’Aosta è persona di fascino con un altissimo tasso di popolarità nel paese.
Nato nel 1904, figlio di Emanuele Filiberto (il comandante della III Armata) e della principessa francese Elena d’Orléans, Amedeo è un tipico prodotto dei «ruggenti anni Venti», quando i ceti superiori «relegano nel dimenticatoio convenzioni e riti che si credevano intoccabili e sprigionano voglia di vivere e spensieratezza»: 33 disinvolto, informale, sportivo, sedotto dai miti della velocità e dei

61
motori, affascinato dalla vita in modo tanto profondo quanto spontaneo, è tra i primi a superare le barriere sociali e a fare gruppo con giovani non appartenenti alla nobiltà del sangue, dai personaggi della moda a quelli dello spettacolo, ai nuovi ricchi, ai nuovi potenti. Il volto propone un fascino aggressivo, con i lineamenti moderni, anglosassoni, senza smancerie, che fanno parlare di lui come del «Gary Cooper italiano». Atletico nel fisico e anticonformista negli atteggiamenti, Amedeo penetra a fondo nell’immaginario collettivo: abituati alla regalità fredda di Vittorio Emanuele III o alla correttezza aristocratica del principe Umberto, gli italiani colgono in Amedeo una dimensione nuova del «principe», di cui la propaganda del Ventennio si appropria per proporlo come modello alla generazione più giovane.
Giunto in Etiopia all’inizio del 1938 con il generale Ugo Cavallero cui è affidato il comando militare, il duca propone una politica più conciliante: egli cerca di dare organicità alla presenza italiana, rimpatria i funzionari più compromessi («il 50 per cento dei funzionari coloniali sono inetti e il 25 per cento sono ladri» egli dichiara a Ciano34), promuove la costruzione di strade e di opere pubbliche, contrasta le forme più vistose di corruzione e di speculazione, dove possibile passa dal governo diretto a quello indiretto cooptando personale indigeno. Gli sforzi del duca non mancano di suscitare un iniziale ottimismo e la nuova impostazione potrebbe dare frutti positivi in una prospettiva di medio-lungo periodo, ma sono tempi di emergenza e la richiesta da Roma di pacificare in fretta è incompatibile con la situazione creata dall’occupazione e dai lunghi mesi del terrore di Graziani.
Tra la fine del 1938 e l’inizio del 1939 la situazione militare si aggrava: i contrasti tra Amedeo e Cavallero sulla strategia repressiva da adottare portano all’allontanamento del generale, che viene richiamato in Italia, mentre il comando delle truppe resta affidato al capo di stato maggiore Luigi De Biase. Mancando la necessaria autorità centrale, i governatori delle singole province cominciano ad agire in autonomia con le rispettive truppe, rendendo sempre meno efficace l’azione repressiva e spesso esasperando i conflitti. È il caso dell’Amhara, nel Centronord della colonia, dove gli errori del governatore Ottorino Mezzetti portano allo scoppio di una rivolta e i 65 battaglioni di stanza nella regione sono costretti a rinchiudersi nei fortini. Nonostante la presenza di 200.000 ascari e 88.000 nazionali, la pacificazione dell’AOI è lontana al di là da venire. Il duca d’Aosta è convinto che la strada intrapresa sia corretta sul piano politico e che la semplice repressione non paghi, ma è consapevole di quanto i risultati

62
della sua azione riformatrice siano ancora lontani: «Mi sento bene e sicuro di me, ma è una sensazione che mi viene più dall’istinto che da un ripensamento tecnico, il quale mi porta a conclusioni completamente opposte».35
Il precipitare della situazione internazionale, con l’attacco di Hitler prima alla Polonia e poi alla Francia, stravolge la realtà della colonia perché rende urgente ciò che invece richiede tempo e pazienza. Nei confronti del viceré comincia a crescere la sfiducia: all’inizio del 1939 Mussolini confida di «essere molto scontento della situazione dell’Africa orientale» e, dimenticando di aver voluto lui stesso la nomina, lamenta che «i principi dovrebbero fare i civili»; Ciano annota che
il duca d’Aosta parla con ottimismo della situazione dell’Impero, ma fra tanti che vengono di là è il solo a essere ottimista. Egli raccomanda di evitare il conflitto con la Francia, che riporterebbe in alto mare il processo di pacificazione e metterebbe a repentaglio la conquista stessa. Non ho capito bene se in lui parla il viceré d’Etiopia o il figlio di una principessa francese.36
Graziani lo giudica «debole e troppo in mano ai suoi dipendenti, perché i principi sono abituati al rispetto, non al comando».37
Nelle prime settimane di conflitto le truppe dell’AOI effettuano alcune puntate dimostrative verso il Kenia (Moyale) e il Sudan (Cassala e Gallabat) e conseguono un modesto risultato di prestigio occupando la Somalia inglese (che viene evacuata dal presidio britannico quasi senza resistenza), ma non cancellano i dubbi sulla «tenuta» della colonia). Graziani, diventato nel frattempo capo di stato maggiore dell’Esercito, traccia un quadro impietoso della situazione militare: «la situazione in Africa orientale è molto grave. L’Amhara è in rivolta. Il Goggiam è fuori del nostro controllo. Con la guerra non c’è da frasi illusioni: la rivolta divamperà nello Scioà Scioa e nell’Amhara».38
Perplessità sulle condizioni dell’Etiopia e sfiducia nel duca non impediscono tuttavia a Mussolini e Badoglio di immaginare il duplice attacco all’Egitto e la mobilitazione delle forze in AOI: di qui il messaggio del Comando supremo del 13 agosto. Amedeo, che non ha timori reverenziali nei confronti del regime, risponde a Badoglio ponendo condizioni precise: «condizione assolutamente indispensabile per fare quanto proponete è l’invio entro il 15 settembre di 100 aeroplani, 10.000 gomme e 10.000 tonnellate di carburante». Il 2 settembre egli ribadisce la propria posizione:

63
È mio dovere dirvi con la massima sincerità e con tutta chiarezza che, fino quando non avrò ricevuto questi rifornimenti, io non mi posso assolutamente muovere altro che per difendermi e anche questa difesa, senza rifornimenti, diventerà col tempo sempre più difficile e aleatoria. Ho una certa superiorità numerica sui tre eserciti che mi possono attaccare, ma qualitativamente le nostre truppe sono molto meno addestrate e armate. Non parliamo di forze navali: 8 sommergibili e 8 caccia vecchi. Gli aerei sono uno scherzo: 180 di cui solo 18 nuovi.39
Le valutazioni di Amedeo sono realistiche: se è vero (come sostengono gli ufficiali più offensivisti, a cominciare dal generale De Biase) che un attacco immediato al Sudan, concomitante con quello di Graziani, permetterebbe di sfruttare la superiorità numerica sorprendendo gli inglesi, è altrettanto vero che le condizioni delle forze italiane sono più difficili. I reparti britannici che presidiano il Sudan e il Kenia si trovano infatti in colonie pacificate da molto tempo, possono ricevere in qualsiasi momento rinforzi per mare e per terra dall’Egitto e dal Sudafrica, e in caso di conflitto possono contare sull’appoggio della guerriglia attiva all’interno dell’AOI. Le forze italiane operano invece in un territorio insicuro, con la popolazione indigena ostile e con le comunicazioni interne pregiudicate dalle presenze guerrigliere: gli unici collegamenti con la madrepatria avvengono per via aerea per mezzo dei grossi apparecchi da trasporto S 81, che fanno scalo in Libia e sorvolano il Sudan ad alta quota.
La prudenza del duca d’Aosta indispone alcuni ufficiali (tra cui il generale De Biase, che chiede di essere esonerato dall’incarico), ma finisce per trovare concordi Badoglio e Mussolini. Il 7 settembre il Comando supremo telegrafa a Addis Abeba:
Siamo perfettamente d’accordo che l’esecuzione del vostro piano è subordinata alle possibilità logistiche e che, di conseguenza, se non si riesce a superare le difficoltà inerenti non c’è che da assumere un atteggiamento, che non voglio dire passivo, ma che definisco di attesa.40
La strategia di mantenere una posizione difensiva in AOI viene accettata dal duce sia perché consapevole della criticità della situazione interna alla colonia, sia perché convinto che la vittoria della Germania sull’Inghilterra sia sicura e prossima: di qui la decisione di un attacco alla Gran Bretagna condotto solo dalle truppe in Libia, con l’obiettivo di realizzare significative penetrazioni in Egitto senza preoccuparsi di raggiungere una vittoria decisiva.
La battaglia in mare di Punta Stilo

64
Mentre Graziani attacca in Africa settentrionale e il duca d’Aosta mantiene la difensiva in Africa orientale, la marina, che è concentrata nel Mediterraneo, non assume iniziative offensive, limitandosi a presidiare le rotte verso la Libia per i rifornimenti dell’armata di terra. La logica della guerra d’aggressione vorrebbe iniziative audaci su Malta, che permetterebbero di separare in due tronconi la Royal Navy (uno nella base di Alessandria d’Egitto, a est, e l’altro in quella di Gibilterra, a ovest), ma i limiti della direzione politica condizionano la strategia sul mare così come hanno condizionato quella della campagna contro la Francia. «Vincere una guerra già vinta» è concettualmente complicato, così come sconfiggere un nemico vinto senza sconfiggerlo troppo. Di qui le esitazioni, la velleità di scontrarsi con le corazzate britanniche alternata al timore di sguarnire il Mediterraneo centrale, l’incapacità ad assumere l’iniziativa.
Nella dinamica di un conflitto, tuttavia, intervengono anche fattori imponderabili, accelerazioni dovute più alla fatalità che alla pianificazione: in questo modo la Marina viene coinvolta nel primo scontro in mare aperto, a Punta Stilo, nelle acque dello Ionio davanti alle coste della Calabria. Si tratta di una «battaglia di incontro», vale a dire consensuale ma accidentale, perché i due comandanti (gli ammiragli Inigo Campioni al comando della squadra italiana, e Andrew Cunningham di quella britannica) si incontrano in modo non premeditato. Le navi da guerra italiane sono impegnate in un servizio di scorta a un convoglio di mercantili salpati da Napoli e diretti in Libia, con un carico di carri armati richiesti da Graziani per l’offensiva verso l’Egitto. Badoglio ha raccomandato che «la Marina scorti il convoglio con tutte le unità della flotta perché dobbiamo essere sicuri che questi carri arrivino a destinazione»:41 di qui una scorta diretta, destinata ad accompagnare i mercantili sino a destinazione, e una scorta indiretta, costituita dall’intera flotta e mobilitata dal 6 all’8 luglio per le attività di presidio dell’area del Mediterraneo centrale. La Regia Aeronautica, da parte sua, mette in allarme i propri reparti nell’Egeo e in Libia e predispone un piano di bombardamenti preventivi su Alessandria per bloccare le navi inglesi. Durante la navigazione del convoglio, giunge da Supermarina l’informazione che una flotta nemica si è mossa dalla base di Gibilterra diretta verso est; altre informazioni giungono arrivano il giorno 7 a proposito di movimenti di navi inglesi in movimento provenienti da Malta (impegnate a loro volta in un servizio di scorta). Mentre i mercantili riescono a dirigersi verso la costa libica con la sola scorta diretta, l’ammiraglio Campioni decide di manovrare il resto

65
della flotta per contrastare le navi di Cunningham. Le sue intenzioni sono esplicite: «Nel caso di avvicinamento delle forze nemiche» ha scritto il giorno 5 luglio «intendo agire con massima decisione contro di esse, riunendo i gruppi “Pola” e “Cesare” e lasciando a immediata salvaguardia del convoglio solo la scorta diretta».42 Il giorno 8 le due flotte si avvicinano e, tra manovre diversive, rotte divergenti e schieramenti di squadra, si spostano verso lo Ionio: il 9, alle 13.30, ci sono i primi avvistamenti, meno di due ore dopo gli incrociatori italiani aprono il fuoco. Il numero di unità coinvolte è alto, il più alto di tutti gli scontri nel Mediterraneo della Seconda guerra mondiale.
Cunninghan fa entrare in azione le corazzate Malaya, Royal Sovereign e Warspite, 43 la portaerei Eagle, 8 incrociatori, 14 cacciatorpediniere ; Campioni ha in mare le corazzate Giulio Cesare e Conte di Cavour, 6 incrociatori delle classi Condottieri [è una serie, non una classe]e Duca degli Abruzzi, 16 cacciatorpediniere. Si tratta di forze equilibrate, ma la bilancia sarebbe favorevole all’Italia se si allertassero le due corazzate supermoderne Littorio e Vittorio Veneto, in avanzato stato di addestramento a Taranto, dotate di 18 cannoni potenti da 381/50mm: nonostante il comandante Carlo Bergamini avverta il giorno 8 che è in grado di prendere subito il mare, le due unità vengono lasciate in porto perché Supermarina sottovaluta il significato dello scontro e non vuole rischiare i due gioielli della flotta.
La battaglia dura meno di un’ora. I cacciatorpediniere della Regia Marina colpiscono l’incrociatore Neptune, che subisce danni non gravi, mentre gli ammiragli Pellegrino Matteucci e Riccardo Paladini manovrano gli incrociatori pesanti Trento e Fiume evitando i siluri della Royal Navy; l’ammiraglio Emilio Legnani riesce a sua volta a evitare i colpi delle corazzate nemiche, così come l’ammiraglio Carlo Cattaneo: solo due cacciatorpediniere subiscono danni lievi dai biplani Fairey Swordfish lanciati dalla portaerei Eagle. Alle 15.59 interviene lo scontro diretto tra corazzate e gli inglesi prevalgono: la Warspite colpisce il fumaiolo di poppa della Giulio Cesare con un colpo da 381 sparato da 24.000 metri di distanza, mentre uno degli incrociatori leggeri italiani danneggia a sua volta l’ammiraglia britannica. I danni della Giulio Cesare sono gravi, perché il colpo perfora il ponte di castello provocando un incendio nel locale caldaie, quattro delle quali devono essere spente facendo scendere la velocità a soli 18 nodi; la Warspite mantiene invece il mare senza eccessivi problemi.

66
Di fronte alle difficoltà della Giulio Cesare, Campioni ordina la rottura del contatto: «Ho ritenuto che non fosse assolutamente da consigliare di lasciare la sola Conte di Cavour e gli incrociatori alle prese con lo schieramento delle tre corazzate nemiche»; un ricognitore alzatosi dalla Eagle informa Cunningham che «la flotta italiana fugge in gran disordine verso ovest e sudovest».44 Di fatto, la battaglia navale cessa, perché la Royal Navy non si muove per ostacolare lo sganciamento.
Alle 16.43, a operazioni concluse, giungono sullo Ionio i bombardieri italiani, 14 squadriglie che sganciano i loro carichi, ma, mancando le coordinate precise sulle posizioni, gli aviatori non distinguono tra naviglio amico e naviglio nemico: i bombardamenti continuano sino alle prime luci della sera, tra le comunicazioni concitate dei comandi della Marina che segnalano gli errori di bersaglio. L’ammiraglio Paladini scriverà nella relazione che «le segnalazioni fatte con fumo colorato, con razzi, con speciali pitturazioni delle navi si sono dimostrate inutili nella confusione della battaglia»: ai bombardieri viene detto che la nostra squadra sta ritirandosi con «il nemico a poppa», ma durante uno scontro «mutano di continuo gli schieramenti» e i gruppi di navi sono distanziati tra loro: «gli incrociatori, che stanno a poppa delle navi da battaglia, vengono perciò scambiati per nemici e diventano bersaglio della Regia Aeronautica».45 Nessuna bomba va comunque a segno né sulle navi inglesi né su quelle italiane e le due flotte, a eccezione della Giulio Cesare, escono dalla giornata di Punta Stilo quasi indenni.
Lo scontro del 9 luglio 1940 non incide sugli equilibri nel Mediterraneo e si conclude senza vincitori né vinti: la «ritirata disordinata» della Regia Marina, descritta dal ricognitore britannico e riportata dalla stampa inglese, rientra nei toni celebrativi della propaganda di guerra, ma non corrisponde alla realtà. Se la flotta italiana fosse davvero in rotta, un uomo d’azione come l’ammiraglio Cunningham ne ordinerebbe l’inseguimento. La breve battaglia offre comunque indicazioni importanti. La prima riguarda la volontà di rischiare: mentre le squadre britanniche mobilitano tutte le loro risorse e assumono un atteggiamento aggressivo, la Regia Marina oscilla tra accelerazioni e prudenze. Il fatto che le corazzate dell’ammiraglio Bergamini restino ferme nel porto di Taranto, a poche miglia da Punta Stilo, dimostra che i vertici della Marina non sono mentalmente preparati a un’offensiva su larga scala: tra la voglia di dimostrare la propria capacità di combattimento, che pure anima alcuni comandanti di unità, e la preoccupazione di mantenere integre le navi migliori, si

67
sceglie la via di mezzo. È la stessa logica per cui nelle settimane precedenti non sono stati tentati né il blocco di Malta, né la conquista dei porti tunisini o algerini. Gli inglesi non tardano a cogliere le esitazioni strategiche italiane e si rafforzano nella convinzione che il Mediterraneo è presidiabile e che il loro naviglio può svolgere una funzione decisiva minacciando i convogli che riforniscono le truppe in Africa settentrionale; la Regia Marina, per contro, riflette le contraddizioni della politica di Mussolini e ripropone lo stesso schema delle truppe terrestri (l’attacco ma senza la convinzione di andare sino in fondo, l’avanzata ma senza profondità per non scoprirsi le spalle, la sconfitta del nemico ma non il suo annientamento). Punta Stilo, pur nella sua accidentalità, è frutto di una strategia che crede ancora alla vittoria rapida dei tedeschi e alla possibilità di ottenere riconoscimenti territoriali al tavolo della pace senza correre eccessivi rischi militari.
La seconda indicazione della battaglia riguarda i limiti degli ufficiali italiani, i quali sono bravissimi per preparazione matematica e sistemica, ma non sono padroni dei mezzi come gli inglesi, non sono addestrati all’iniziativa e all’audacia. La Royal Navy è abituata agli oceani, a operare in tutti gli scenari dell’impero, a muoversi in autonomia anche ai livelli più bassi della gerarchia. La Regia Marina è abituata al mar Mediterraneo, alla stretta dipendenza dalla catena di comando, all’applicazione di schemi teorici. Quando si passa dall’ordinarietà delle esercitazioni del tempo di pace alle situazioni di emergenza del tempo di guerra, viene a mancare l’elasticità necessaria per affrontare gli imprevisti. L’ammiraglio Campioni che ordina la rottura del contatto appena vede la Giulio Cesare colpita ne è un esempio; Cunningham, sul fronte opposto, constata invece la difficoltà a colpire da distanze molto forti e parla ai suoi della necessità di «serrare le distanze», il che significa pressare il nemico.
La terza indicazione è la criticità nel rapporto Marina-Aereonautica. La politica del Ventennio, che ha alimentato la popolarità dell’Aeronautica per la sua funzionalità alla propaganda di regime e l’ha riconosciuta come Arma indipendente, ha provocato gelosie, risentimenti e rivalità che Mussolini non si è preoccupato di appianare. La Seconda guerra mondiale dimostrerà che il segreto della vittoria sta nella cooperazione inter-arma e che non si può vincere se sul campo Esercito, Marina e Aeronautica combattono ognuno una propria guerra. Dopo la battaglia di Punta Stilo gli ammiragli denunciano l’inazione dei colleghi e i ritardi con cui i bombardieri sono giunti sul luogo della battaglia, ma il problema va al di là delle inadempienze dei singoli: ciò che non funziona è il sistema della

68
cooperazione. Sommando i tempi occorrenti alle richieste dei comandi navali a quelli necessari alle ritrasmissioni dei comandi aerei, al decollo, al tragitto aereo fino al luogo dello scontro si arriva nel migliore dei casi a due ore, anche quando il combattimento è poco distante dalla costa della penisola e quando le condizioni atmosferiche non ostacolano il volo. Inoltre bisogna considerare che l’aviazione può ricevere più richieste contemporaneamente e non essere in grado di valutare esattamente la situazione tattica: «In altre parole, solo le portaerei possono assicurare alla flotta l’ombrello aereo di cui ha bisogno subito, mentre la battaglia è in corso, ma l’Italia non ha le portaerei, osteggiate dall’Aeronautica che non accetta di avere apparecchi al comando della Marina».46 I bombardamenti da alta quota sono inefficaci, come dimostrano i tanti ordigni fuori bersaglio nel tardo pomeriggio del 9 luglio: i caccia che si alzano dalle portaerei volando a bassa quota possono invece infliggere al nemico severe perdite e difficilmente sono intercettabili dal fuoco di sbarramento delle navi.
Dall’esperienza di Punta Stilo gli inglesi traggono alcune conclusioni: la prima è la necessità di aumentare il numero delle loro portaerei; la seconda è di confermare la presenza nelle basi di Alessandria, Gibilterra e Malta e accantonare qualsiasi ipotesi di allontanamento dal Mediterraneo; la terza è la convinzione di poter contrastare la flotta italiana nello stesso braccio di mare su cui è più forte. Come scrive Cunningham,
la battaglia non è stata priva di importanza, deve aver dimostrato agli italiani che la loro aviazione e i loro sommergibili non possono impedire alla nostra flotta l’ingresso nel Mediterraneo centrale e la minaccia alle loro rotte sul Nord Africa. Ritengo che Punta Stilo abbia anche stabilito una certa superiorità morale nostra.47
Al di là delle considerazioni strettamente militari, la battaglia è certamente una boccata d’ossigeno per una nazione come l’Inghilterra che ha deciso di combattere fino all’ultimo la «per la sopravvivenza»: »; per l’Italia è invece una spia di allarme, i cui segnali pochi ritengono di dover cogliere. L’ammiraglio Paladini, stante la mancanza non colmabile delle portaerei, propone di avere almeno «una nave appoggio da cui catapultare gli aerei pilota per guidare le ondate di bombardieri, evitare il rischio di fuoco amico e individuare correttamente le posizioni delle flotte»,48 ma il Comando supremo non dà seguito alla richiesta e il problema resta senza soluzione.
Le criticità di Punta Stilo sono così confermate di lì a poco, il 19 luglio, quando una nostra divisione di incrociatori leggeri comandata

69
dall’ammiraglio Ferdinando Casardi e mandata a contrastare il traffico britannico tra la Grecia e l’Egitto si incontra a Capo Spada, al largo dell’isola di Creta, con l’incrociatore Sidney scortato da 4 cacciatorpediniere e comandato dal capitano di vascello John Augustine Collins. Lo scontro si sviluppa in prima mattinata. Un siluro inglese centra in pieno la prua dell’incrociatore Bartolomeo Colleoni, che affonda in dieci minuti, mentre un’altra unità, il Bande Nere, colpito, riesce ad allontanarsi verso Tobruk: aver privilegiato la velocità a scapito della corazzatura rende gli incrociatori leggeri della Regia Marina facilmente perforabili. Il fuoco italiano colpisce il fumaiolo di prora del Sidney, ma il colpo non esplode e i danni sono limitati alla struttura esterna, senza il coinvolgimento delle caldaie. Alle 9.00 le unità si allontanano verso le rispettive basi e la battaglia finisce. I bombardieri allertati nelle basi di Rodi e delle isole del Dodecaneso si alzano in volo ma giungono sul posto solo nel pomeriggio, quando le navi sono ormai lontane dal luogo di combattimento (le unità inglesi hanno anche avuto il tempo di salvare diversi marinai italiani naufraghi del Colleoni, tra cui il comandante, il capitano di vascello Umberto Novaro, che morirà per le ferite riportate).

70
IV La guerra parallela nei Balcani
La strategia tedesca tra battaglia d’Inghilterra e attacco alla Russia
All’inizio dell’autunno del 1940 la guerra parallela italiana è ferma: Graziani si trincera in Egitto, il duca d’Aosta è sulla difensiva in AOI, la marina pattuglia il Mediterraneo centrale tenendosi a distanza dalla Royal Navy. I tedeschi sono attivi ma senza conseguire risultati decisivi: i bombardamenti aerei continuano ma non collassano l’Inghilterra, l’ipotesi dello sbarco oltre Manica tramonta, gli attacchi sottomarini non impediscono i rifornimenti americani all’isola, il blocco navale continentale è una parola d’ordine senza effetti. Di fatto, la battaglia d’Inghilterra si trasforma in una guerra di logoramento, esattamente l’opposto della Blitzkrieg veicolata dalla propaganda e realizzata contro la Francia. In agosto Hitler chiede la partecipazione dell’aviazione italiana e Mussolini accetta per ragioni di prestigio, inviando un corpo di spedizione forte di 75 bombardieri B.R.20 e di un centinaio di caccia, ma il trasferimento sulla Manica risulta macchinoso, le incursioni poco efficaci e il loro contributo non cambia certo le sorti dello scontro (quando in gennaio del 1941 il corpo di spedizione rientra in Italia, in compenso, ha perso 43 aviatori e 38 apparecchi, oltre ad aver inferto un colpo negativo di immagine alla leggenda dell’«Ala fascista»).
Più dinamica è la situazione diplomatica: il 27 settembre viene firmato il patto tripartito tra Germania, Italia e Giappone, con il quale i contraenti si riconoscono il reciproco diritto di creare un «nuovo ordine» in Europa e in Asia e lanciano una velata minaccia agli Stati Uniti (l’articolo 3 impegna infatti le potenze dell’Asse Roma-Tokyo-Berlino a darsi l’un l’altrareciproca assistenza qualora una delle tre parti contraenti venga attaccata da una potenza che non sia attualmente coinvolta nella guerra europea o nel conflitto cino-giapponese). Dinamica, soprattutto, è la progettualità di Hitler, il quale si convince presto dell’impraticabilità dell’«Operazione Leone marino» (che il 17 settembre viene rinviata fino a nuovo ordine) ma non rinuncia per questo all’obiettivo principale della sua strategia, la sconfitta del comunismo. Il calcolo è azzardato e contraddice un’impostazione chiara agli stati maggiori tedeschi sin da prima della Grande guerra, la necessità di combattere un nemico alla volta, prima l’attacco a occidente e solo dopo la vittoria completa l’aggressione a

71
oriente (il cosiddetto «piano Schlieffen», peraltro disatteso già nel 1914).1 Hitler ritiene però che la tenace resistenza inglese sia dovuta non tanto agli aiuti americani, quanto alla speranza di un prossimo ribaltamento degli equilibri internazionali e di un appoggio militare da parte di Mosca: l’invasione dell’Unione Sovietica toglierebbe a Churchill l’illusione di poter usare la «spada continentale» russa come strumento strategico militare e finirebbe per far capitolare anche Londra. Nell’autunno-inverno 1940 la Wehrmacht perfeziona così i piani dell’«Operazione Barbarossa», l’offensiva verso l’Unione Sovietica da iniziare indipendentemente dall’andamento dello scontro con l’Inghilterra: il progetto preliminare, predisposto nella tarda primavera del 1940 dal generale Franz Halder, viene perfezionato dallo stato maggiore con la supervisione del comandante in capo delle forze terrestri, il feldmaresciallo Walther von Brauchitsch.2
Sulla decisione di Hitler di accelerare i tempi dell’attacco incidono fattori diversi. Alcuni sono di natura caratteriale (la fretta psicologica di agire, il peso dei condizionamenti ideologici, la convinzione che la sconfitta del comunismo sia, insieme all’annientamento degli ebrei, la sua vera missione storica), altri nascono invece da considerazioni strategiche. Il Führer teme le mosse americane. Nell’estate del 1940 il presidente Roosevelt decide un incremento notevole della produzione bellica, la costruzione della «flotta dei due Oceani» e l’avvio dei preparativi per l’introduzione del servizio militare obbligatorio. Le informazioni giunte a Berlino parlano di contatti tra i comandi militari inglesi e americani per fissare le linee guida di un’eventuale condotta bilaterale della guerra e dell’orientamento degli stati maggiori a localizzare il baricentro della strategia nello scacchiere atlantico ed europeo, perché la Germania è la potenza guida dell’Asse (il principio del «Germany first», al quale americani e inglesi rimarranno fedeli anche in futuro). Se Roosevelt sarà riconfermato alle elezioni presidenziali dell’autunno (come pare verosimile), avrà la meglio sulle tendenze isolazioniste e neutraliste e gli USA entreranno nel conflitto con il peso della loro forza militare e della loro economia. Una vittoria germanica contro l’Unione Sovietica cambierebbe invece il quadro internazionale, come il Führer spiega il 31 luglio 1940 in un monologo al quartier generale:
Una caduta della Russia avrà come conseguenza una straordinaria rivalutazione del Giappone in Asia orientale e questo costringerà gli americani a non intervenire in Europa, privilegiando la difesa dei loro interessi nel Pacifico. Subito dopo la campagna a oriente, oppure dopo una pausa, si potrà giungere a un’ulteriore resa dei conti con l’America.3

72
Hitler cerca di camuffare con scaltrezza i suoi propositi e manda segnali distensivi a Mosca, proponendo incontri col Giappone per la definizione di aree di influenza nell’Asia meridionale, promettendo all’URSS sbocchi nell’Oceano indiano, mantenendo l’impegno agli scambi di materiali sottoscritti con l’accordo Molotov-Ribbentrop. Stalin, da parte sua, non provoca in alcun modo le tensioni con la Germania, convinto che Berlino non attaccherà prima della resa dell’Inghilterra. Contemporaneamente, il Führer crea le premesse per la futura invasione inserendosi intervenendo nelle vicende dell’Europa orientale, con l’obiettivo di includerla in una propria zona di influenza. Il primo passo è l’inserimento diplomatico nei contrasti tra Ungheria, Bulgaria e Romania, ognuna delle quali vuole rettificare i confini a proprio vantaggio. Trattando separatamente con uomini politici dei tre paesi, Ribbentrop promuove un equilibrio di interessi senza impegnarsi con una delle parti e spingendo così l’altra nelle braccia dell’Unione Sovietica. Il secondo passo è il controllo delle risorse petrolifere rumene. L’occasione è data dal generale Ian Ion Antonescu, diventato primo ministro della Romania nel settembre 1940: stretto fra le aspirazioni espansive sovietiche a est e tedesche a ovest, Antonescu sceglie di allearsi con Berlino e chiede a Hitler l’invio di esperti militari per addestramento delle truppe e di reparti armati a garanzia della difesa dei confini. Di fatto, è un’alleanza che permette alla Germania di controllare i pozzi di PloietsiPloiești, nella Grande Valacchia (Romania centromeridionale), all’epoca il più ricco sito petrolifero d’Europa. Il generale Wilhelm Keitel, comandante supremo della Wehrmacht, è esplicito in una nota del 20 settembre:
I compiti della missione militare, che non devono essere resi noti né ai rumeni né alla nostra truppa, sono: a) difendere il territorio petrolifero dalle mire di una terza potenza; b) mettere le forze armate rumene in grado di assolvere compiti secondo un piano orientato verso gli interessi tedeschi; c) nel caso di una guerra con la Russia, preparare l’impiego, partendo dalla Romania, delle forze rumene e tedesche.4
Il dinamismo di Berlino insospettisce Stalin e in un colloquio tra Molotov e Ribbentrop, avvenuto nella capitale germanica il 12-13 novembre, si percepiscono i segnali di un rapporto in deterioramento: mentre i sovietici rivendicano le loro aspirazioni nell’area del Baltico, i tedeschi prospettano loro un’improbabile espansione in India a spese dell’Impero britannico: «Il freddo che Molotov trovò a Berlino non fu solo quello dovuto a una stagione invernale insolitamente rigida, ma dal constatare una strategia tedesca nuovamente animata da una aggressiva Ostpolitik».5 Stalin, che per qualche tempo ha ritenuto che

73
all’interno della dirigenza germanica vi fossero contrasti tra i vertici militari e i capi del nazismo (i primi propensi a una politica di aggressione antisovietica, i secondi favorevoli all’accordo), si persuade che lo scontro è ormai imminente: pur non forzando la situazione perché la sua strategia punta sul fattore tempo per attrezzare il paese, il capo del Cremlino imprime un’ulteriore accelerazione alla produzione di armamenti pesanti e al rafforzamento dell’Armata Rossa.
L’aggressione alla Grecia come scelta politica
Dopo la breve penetrazione di Graziani in Egitto le forze armate italiane entrano in una fase di stasi operativa che dura sino alla fine di ottobre. Mussolini osserva le mosse tedesche e cerca una strategia per proseguire una guerra che, per paradosso, è già stata vinta ma non ha portato risultati. Ciò che Roma sa (o crede di sapere) sui propositi militari e politici della Germania non è molto, frutto di informazioni indirette e spesso incontrollabili: i dispacci dell’ambasciatore Alfieri da Berlino, i colloqui diplomatici di Ciano, le notizie raccolte in Portogallo e in altri paesi neutrali disegnano un quadro frammentario, che si contraddice da un giorno all’altro. I canali ufficiali tedeschi sono estremamente parchi di notizie, spesso addirittura reticenti o muti. Le diffidenze nei confronti dell’alleato, iniziate già nel 1939 nel momento dell’attacco alla Polonia, proseguite nel maggio 1940 di fronte all’invasione della Francia, aumentano nel corso dell’estate del 1940. Il primo «momento caldo» è l’armistizio con Pétain e le condizioni imposte che non prevedono riconoscimenti territoriali per l’Italia; il secondo è il rifiuto tedesco di accettare il contributo di forze italiane per lo sbarco in Inghilterra; il terzo, a metà agosto, sono le informazioni ricevute da Berlino circa l’imminenza dell’«Operazione Leone marino», ritenute attendibili da Mussolini che ordina pertanto l’avanzata a Graziani in Africa, ma che si rivelano infondate subito dopo; il quarto sono i colloqui tra Ribbentrop e Ciano (19-22 settembre a Roma) e tra il duce e il Führer (4 ottobre al Brennero), cordiali nella forma ma evanescenti nella sostanza, con i capi del fascismo che ne escono disorientati sulle reali volontà naziste. Quando a metà ottobre Hitler invia a Roma il generale Wilhelm von Thoma e propone di mandare truppe corazzate tedesche in Africa in appoggio a Graziani, Mussolini intravede una strategia di ingerenza nello scacchiere mediterraneo e rifiuta, fortemente preoccupato sulle prospettive del nuovo ordine internazionale. D’altra parte le

74
informazioni, pur frammentarie, che giungono alla diplomazia fascista lasciano capire che Hitler lavora per la Germania e non per l’Asse: le relazioni con la Francia di Vichy per trasformarla in alleato, l’ipotesi di un trattato franco-germanico che escluda l’Italia dalla Tunisia, dalla Corsica e da Nizza, i contatti tra Berlino e il governo di Belgrado che frenano le aspirazioni di Roma verso la Dalmazia sono elementi che concorrono a disegnare il quadro di un rapporto sempre più fragile e sospettoso. Non meno diffidenti sono, a loro volta, i tedeschi, che da un lato non informano l’alleato perché prevenuti sulla proverbiale tendenza italiana a non tenere i segreti, dall’altro temono che Mussolini possa capovolgere le alleanze: secondo la testimonianza del generale Thoma, la sua missione a Roma con la proposta di cooperazione in Africa nasce dalla volontà di controllare da vicino Mussolini che «Hitler giudicava ambiguo e temeva potesse da un momento all’altro passare dall’altra parte, cosa che sarebbe risultata più difficile con le truppe mescolate al fronte».6
In questa atmosfera si inserisce l’azione tedesca in Romania, con truppe e aerei mandati a difendere i pozzi di PloieștiPloesti. A Roma (dove si è all’oscuro del mutamento in corso nell’atteggiamento di Hitler verso l’Unione Sovietica) questa nuova manifestazione del dinamismo tedesco nei Balcani colpisce sfavorevolmente e suscita una forte irritazione, sia per ragioni di prestigio, sia per la scarsa considerazione che Berlino dimostra verso l’alleato, sia per le tradizionali ambizioni di espansione italiana nell’area: di qui nascerebbe, secondo una vulgata accreditata dalla pubblicistica, la decisione di attaccare la Grecia, frutto di un improvviso e irrazionale scatto umorale di Mussolini («questa volta Hitler saprà dai giornali che ho occupato la Grecia» avrebbe detto il duce)7. Le reazioni emotive fanno parte del meccanismo decisionale in regime di dittatura, ma non possono essere l’unica chiave interpretativa. Le attenzioni della Germania per la Romania non sono una sorpresa. Ribbentrop ne ha fatto cenno a Ciano a fine settembre, in un ulteriore colloquio a Berlino, riferendosi al «possibile invio di formazioni d’istruzione come richiesto dal generale Antonescu»; il 4 ottobre se ne è parlato al Brennero, tanto che il sottosegretario Soddu, riferendo a Graziani dei colloqui, sostiene che «ci dobbiamo affiancare alla missione tedesca con l’invio di un reggimento, presumibilmente il 3° granatieri». 8 Mussolini può essere sorpreso dalla rapidità dell’intervento tedesco, dall’ampiezza della missione inviata a Bucarest e dal mancato coinvolgimento dei granatieri italiani, non certo dall’operazione in sé.

75
Al di là della rabbia, nella scelta di invadere la Grecia agiscono considerazioni politico-militari. Tramontata l’ipotesi di una rapida conclusione del conflitto con l’Inghilterra e sfumati con essa gli eventuali spazi per un ruolo di mediazione, Mussolini intuisce che la guerra sarà lunga, che la Germania la condurrà con obiettivi egemonici sull’Europa e sul Mediterraneo, che la condizione di alleato non garantirà affatto l’Italia, che Berlino si muoverà sul piano diplomatico e su quello militare in totale autonomia. Nell’ottica del duce, un’iniziativa italiana nei Balcani diventa l’unica via percorribile per controbilanciare l’influenza germanica e per «sparigliare le carte» tra gli scacchieri. Come coglie il vecchio generale Caviglia,
Mussolini, accortosi di essere giuocato dal collega, decide di attaccare la Grecia, alleata dell’Inghilterra, e inizia l’azione rompendo le uova nel paniere di Hitler. La spiegazione della campagna è tutta qui: Mussolini sente che gli interessi tedeschi sono in contrasto con quelli italiani, che la Germania ha un’influenza ormai preponderante in tutte le capitali dell’Europa orientale, che l’Italia è quindi, a poco a poco, «buggerata». Egli non può far da spettatore inerte, ha bisogno a tutti i costi di assumere a sua volta un’iniziativa forte.9
Alla luce degli avvenimenti successivi, si tratta di una decisione discutibile: sul piano diplomatico essa toglie al fascismo la possibilità di aspirare a un ruolo di terziarietà e, di fatto, lo pone ancor più alle dipendenze della guerra tedesca; sul piano militare essa disperde le forze del Regio Esercito su un nuovo scacchiere, mentre sarebbe necessario concentrarle in Africa settentrionale per ottenere una vittoria sugli inglesi. Il risultato di disorientare i tedeschi è comunque raggiunto, tanto che il 28 ottobre, mentre inizia l’offensiva, Hitler si precipita a Firenze:
Già da alcuni giorni erano trapelate a Berlino notizie che Mussolini avesse intenzione di attaccare la Grecia e la Wilhelmstrasse aveva proposto di compiere un intervento energico su Roma per dissuaderla. Hitler aveva però bloccato l’idea temendo che l’intervento potesse inasprire Mussolini e spingerlo a decisioni anche più pericolose. Inoltre egli pensava di avere ancora tempo per agire ed era convinto che l’attacco non partisse prima delle elezioni americane, previste per il 5 novembre.10
Quando riceve la comunicazione ufficiale, il Führer si irrita profondamente e decide il viaggio a Firenze, dove però giunge quando i reggimenti sono ormai in movimento oltre il confine greco-albanese. Secondo il punto di vista tedesco, l’azione è «un grave errore, un’avventura destinata a un sicuro insuccesso militare per le caratteristiche del terreno e per la stagione scelta, e comporterà gravi

76
complicazioni politiche per tutto l’Asse». Nell’incontro fiorentino, Hitler è costretto «a fare buon viso a cattivo gioco e rassegnarsi a sua volta al fatto compiuto», ma non muta opinione, come dimostra il fatto che Berlino per il momento non rompe le relazioni diplomatiche con Atene. Rientrato nella sua capitale, egli esprime con i collaboratori la rabbia per un’azione «inutile e pazzesca», attribuendone la colpa non al duce («l’unico grand’uomo che l’Italia abbia») ma a Ciano, ritenuto il responsabile dell’attacco, e a «quel mondo fossile, quella mafia aristocratica» dei capi militari. Nelle ultime settimane della sua vita il capo del nazismo arriverà a considerare la campagna di Grecia la vera causa della sconfitta, perché «la situazione creata nei Balcani costringerà a ritardare di alcune settimane l’attacco alla Russia, impedendo di raggiungere gli obiettivi prefissati prima dell’inverno». 11 Forse si tratta di una sopravvalutazione delle conseguenze, ma è certo che la campagna crea maggiori problemi all’alleata Germania che alla nemica Inghilterra.
L’attacco del 28 ottobre 1940
Un primo piano per l’invasione della Grecia è stato predisposto dal generale Carlo Geloso sin dalla primavera del 1939, prevedendo la dislocazione di 11 divisioni in Albania e un attacco concomitante verso la Tracia da parte della Bulgaria per tenere impegnate parte delle truppe elleniche; un secondo piano viene elaborato nell’estate dal successore di Geloso, Sebastiano Visconti Prasca, e nell’ipotesi di un’azione unilaterale da parte del Regio Esercito dispone la concentrazione di 20 divisioni in Albania e l’immagazzinamento dei rifornimenti necessari per alimentare un contingente tanto numeroso. L’azione dovrebbe procedere dall’Epiro e le venti divisioni sono necessarie nella prospettiva di dover fronteggiare una mobilitazione massiccia da parte dei Greci. Nell’ottobre 1940 le divisioni disponibili sono solo 8 e tra queste la divisione alpina «Julia» dispone di un organico fortemente ridotto. Nonostante questi limiti, la decisione viene presa ugualmente e la campagna inizia con ostentato ottimismo: Mussolini è sicuro di ottenere una vittoria rapida, sia perché convinto della superiorità del combattente italiano rispetto a quello greco, sia per le assicurazioni fornite da Ciano e dal luogotenente generale in Albania, Francesco Jacomoni.12 Secondo costoro in Grecia ci sono forze pronte ad appoggiare le truppe italiane e ad approfittare dell’occasione per abbattere il regime di Ioannis Metaxas e liquidare le tendenze filoinglesi; la Ciamuria (la costa dell’Epiro abitata da

77
popolazioni albanesi) sta preparandosi all’insurrezione indipendentista, mentre con una facile azione di corruzione sono già stati ottenuti appoggi all’interno dello stesso governo:
Ciano inculcò la convinzione che non si trattava di una guerra, perché lui aveva già provveduto alla vittoria ‘comprando’ alcuni uomini politici e generali greci. La Ciamuria al momento dell’invasione sarebbe insorta contro la Grecia, l’esercito ellenico non avrebbe combattuto ed un governo filoitaliano era già quasi pronto per sostituirsi a quello di Metaxas.13
Il 15 ottobre a Palazzo Venezia Mussolini incontra i vertici militari per fissare l’inizio della campagna: sono presenti Badoglio, Roatta, Soddu, Visconti Prasca, oltre a Ciano e Jacomoni. Non mancano controinformazioni sulla situazione ellenica: il colonnello Luigi Mondini, addetto militare ad Atene, ha segnalato il grande sforzo di mobilitazione dei greci, con il richiamo delle classi già congedate e l’invio di reparti verso il confine albanese. 14 Dopo l’introduzione di Ciano sulla situazione generale, i capi militari si dividono. Il generale Sebastiano Visconti Prasca, comandante delle forze italiane in Albania al quale spetterebbe la direzione delle operazioni, smentisce il suo stesso piano e assicura che cinque o sei divisioni sono sufficienti per occupare l’Epiro, mentre i successivi rinforzi permetteranno di arrivare ad Atene:
Le forze greche non ammontano che a 30.000 armati veri, gli altri sono richiamati senza armamento e senza disciplina, e noi abbiamo una superiorità di due a uno. Conquistato l’Epiro in pochi giorni, prima della stagione delle piogge, possiamo poi attestarci in attesa delle altre divisioni dalla madrepatria e puntare in un secondo tempo verso sud sulla capitale.15
Il sottosegretario Soddu e Roatta sono perplessi ma tacciono, mentre Badoglio, che qualche giorno prima parlando con Ciano ha minacciato di dimettersi in caso di attacco e ha sostenuto che servono almeno tre mesi per la mobilitazione, si limita a sollevare obiezioni sulla tempistica, chiedendo un rinvio di qualche giorno. La faciloneria di Ciano e di Jacomoni è contagiosa, ma soprattutto è evidente la determinazione del duce, comunque deciso all’intervento per le ragioni politiche conseguenti alle iniziative tedesche in Romania: «I militari vedono gli aspetti tecnici» egli spiega «ma in questo momento vi sono elementi di carattere politico generale sulla base dei quali si deve agire». Di fronte alla volontà del capo, gli stati maggiori mettono da parte le proprie esitazioni e non traducono i dubbi in rilievi tecnici e meno che mai in opposizione. Emblematica, in questo senso, la posizione di Badoglio:

78
Pur essendo istintivamente ostile alla guerra alla Grecia per le difficoltà oggettive e pur non mutando opinione, il 15 ottobre egli finì non solo per accettare il punto di vista di Mussolini secondo cui l’azione in Epiro e a Corfù doveva essere iniziata subito con le sole truppe sul posto, ma finì anche per aiutarne di fatto l’accettazione da parte degli altri capi militari che, come lui, erano inizialmente contrari.16
Qualche giorno dopo, scrivendo all’addetto militare a Berlino generale Efisio Marras, il comandante supremo allude infatti alle ragioni politiche dell’intervento: «Circa la Grecia forse era meglio evitarla, date le scarsissime disponibilità nostre e dato il nessun aiuto in materiali che sinora ci hanno dato gli alleati, ma nella situazione che si è determinata l’operazione è apparsa inderogabile».17
Il piano di operazioni, dettagliato da Visconti Prasca nei giorni immediatamente successivi, prevede l’inizio dell’attacco per il 26 ottobre, poi spostato al 28. Partendo dalle posizioni in Albania, 2 divisioni di fanteria («Ferrara» e «Siena») e la divisione corazzata «Centauro» devono impossessarsi dell’Epiro, sboccando dalla valle del Drino, mentre sul litorale si muove un raggruppamento con un reggimento di granatieri e due gruppi di squadroni; più a nord, un secondo corpo d’armata deve coprire la fascia di confine greco-albanese per impedire eventuali infiltrazioni nemiche e scongiurare il pericolo di un aggiramento (ne fanno parte le divisioni «Parma» e «Piemonte» alla frontiera con la Macedonia); la divisione alpina «Julia», che è in Albania sin dalla primavera del 1939 per presidiare le zone montane più aspre, deve invece occupare i passi di Metzovo e Drisko per impedire che le truppe elleniche, provenendo dalla Tessaglia, si congiungano con quelle dell’Epiro. Altre due divisioni, «Arezzo» e «Venezia», sono invece di vigilanza alla frontiera iugoslava per prevenire un eventuale intervento di Belgrado nel conflitto (saranno spostate al fronte non appena sarà chiaro che la Iugoslavia non intende muoversi).
L’impostazione della campagna sconta un limite di fondo ed è il presupposto che la Grecia rinunci a battersi travolta dalle contraddizioni interne e che l’attacco del Regio Esercito si riduca a un movimento logistico:
L’offensiva condotta con schieramento lineare e fronti amplissime [va bene?] era basata sulla convinzione di dover affrontare una marcia militare anziché una battaglia. Di qui l’insufficienza di personale e di mezzi, la scarsa attenzione per l’organizzazione logistica, la mancanza di scorte e di riserve.18
Il governo Metaxas è invece capace di coinvolgere l’opinione pubblica dinanzi alla minaccia di aggressione, riuscendo a chiamare

79
sotto le armi centinaia di migliaia di uomini (all’inizio del 1941 saranno quasi mezzo milione) e a sostenerne il morale grazie alla mobilitazione popolare: si tratta di un fenomeno che i vertici del fascismo hanno totalmente e incomprensibilmente sottovalutato e che la diplomazia italiana ad Atene ha segnalato senza le necessarie sottolineature. A questo limite politico si aggiunge quello legato alle condizioni atmosferiche, che vedono le montagne tra l’Albania e la Grecia coinvolte in un ottobre rigido, con piogge intense e prolungate e con precipitazioni nevose anticipate. Non si tratta, tuttavia, di accidentalità, perché l’autunno avanzato dovrebbe sconsigliare operazioni in una zona montuosa, solcata da torrenti che possono diventare impetuosi, con poche strade (per la maggior parte non asfaltate) destinate a riempirsi di fango: in un tale quadro ambientale, i movimenti degli attaccanti sono necessariamente lenti e gli ostacoli naturali favoriscono la difesa. Visconti Prasca è comunque fermo nella sua convinzione: «L’operazione è stata preparata in modo da dare l’impressione di un rovescio travolgente in pochi giorni» assicura, e Mussolini il 25 gli scrive a titolo di viatico:
Caro Visconti, voi sapete, e se non lo sapete ve lo dico io adesso, che mi sono opposto a tutti i tentativi fatti per togliervi il comando. Credo che gli eventi, ma soprattutto l’opera vostra, mi daranno ragione. Attaccate con la massima decisione e violenza. Il successo dell’azione dipende soprattutto dalla sua rapidità.19
All’alba del 28 ottobre le prime colonne varcano il confine e travolgono i piccoli posti avanzati dei greci, ma è subito chiaro che le operazioni non saranno facili. Come scrive Emilio Faldella a proposito delle azioni degli alpini della «Julia» fra le montagne del Pindo,
i reparti hanno superato il confine sotto una pioggia torrenziale, che durava da vari giorni. Nelle zone più alte del Gramos, neve e tormenta flagellavano gli alpini del «Tolmezzo». La piena dei ruscelli e dei torrenti rendeva estremamente faticoso il procedere dei reparti. A sera il «Tolmezzo» era in fondo a val Belica, a monte di Gramosti; il «Gemona» sul contrafforte dello Stauros; il «Cividale» sulle pendici sud dello stesso contrafforte. Le piogge, che da tempo flagellavano la zona, avevano trasformato i sentieri in torrenti di fango; il Sarandaporos, la Vojussa e tutti i torrenti loro affluenti si presentavano come fiumane vorticose e muggenti, praticamente inguadabili.20
In queste condizioni l’avanzata dei battaglioni risulta lenta e faticosa, mentre i reparti greci concentrano il tiro di artiglieria nei passaggi obbligati e sui tratti scoperti. Lo scenario del Pindo si ripropone sugli altri settori: dappertutto si sconta l’impraticabilità delle strade e le difficoltà dei rifornimenti, per cui nell’avanzata i

80
soldati devono trasportare tutto l’occorrente (dai viveri alle scorte di munizioni). Le divisioni di fanteria, impegnate nel settore centrale dello schieramento su una linea lunga 60 miglia100 chilometri, penetrano per qualche chilometro ma scontano le stesse difficoltà logistiche. L’apporto dei carri L/3 è pressoché nullo, l’aviazione (che dovrebbe appoggiare l’avanzata) non riesce a decollare per il maltempo, le piccole unità che penetrano più in profondità finiscono per restare isolate. In particolare, emerge una forte criticità nel settore delle trasmissioni: «Le stazioni radio in dotazione alle unità dipendevano dalle condizioni atmosferiche, funzionavano quando il clima era secco come in Africa settentrionale, tacevano o singhiozzavano quando pioveva o faceva freddo»,21 con il risultato di collegamenti difficili e impossibilità di coordinare i movimenti dei reparti.
Fiducioso sui risultati, il 30 ottobre Mussolini si è trasferito nel suo «comando tattico» di Grottaglie, in Puglia, per sovrintendere alla vittoria, ma le notizie che giungono dal fronte sono sconfortanti: dopo tre giorni, il duce rientra a Roma a Palazzo Venezia, rabbuiato da un andamento che pregiudica l’investimento politico fatto nella campagna. Ancora peggiori le notizie successive: il 4 novembre, dopo una settimana di attacchi, il fronte è fermo, impaludato nel fango dell’autunno greco, e le truppe sono provate nel fisico e nello spirito; il 5 i reparti ellenici contrattaccano costringendo in alcuni punti gli italiani ad arretrare; il 7 il Comando generale truppe Albania, constatato il fallimento dell’offensiva, ordina il ripiegamento generale sulla linea di confine; il 9 novembre Visconti Prasca è sollevato dal comando e sostituito con Ubaldo Soddu, che lascia il sottosegretariato alla Guerra e vola a Tirana. «Il Duce è molto risentito con Jacomoni e Visconti Prasca che avevano prospettato l’operazione troppo facile e sicura» annota Ciano. «Non credo sia ancora da fasciarsi la testa, ma molti cominciano a farlo»:22 nessun riferimento alle ipotesi di colpo di Stato contro Metaxas, che lo stesso ministro degli Esteri ha accreditato prima dell’inizio della campagna e di cui non c’è stata traccia. Per i capi del fascismo le sconfitte sono occasione di rese dei conti, mai di autocritiche.
Gli alpini della «Julia» al ponte di Perati
La pubblicistica, così ricca di contributi sulla campagna di Russia, non ha dedicato altrettanta attenzione alla campagna di Grecia, anche se le condizioni nelle quali i soldati del Regio Esercito hanno

81
dovuto operare e le perdite subite non sono state meno drammatiche della ritirata del Don. Un’eccezione è costituita dalle vicende della divisione «Julia» e dalla resistenza opposta ai greci al ponte di Perati, consacrata da una canzone nata nei giorni della campagna diventata simbolo del sacrificio dell’unità alpina: «Sul ponte di Perati bandiera nera / è il lutto della Julia che fa la guera / la mejo gioventù che va sotto tera». La divisione entra in linea il 28 ottobre lasciando nelle basi carreggio, bagagli e cucine, e portando con sé il 60 per cento delle salmerie e riserve vivere per 4-5 giorni: sfruttando la mobilità dei reparti alpini e l’abitudine a operare in quota muovendosi a piccoli gruppi, la «Julia» avanza in profondità per più giorni, conquistando posizioni sino a 40 chilometri oltre il confine, ma resta isolata, con soli 5 battaglioni, una potenza di fuoco ormai in esaurimento e senza rifornimenti né collegamenti né rifornimenti con le retrovie. Il 7 novembre, quando Visconti Prasca ordina il ripiegamento, alla divisione viene assegnato il compito di sbarrare la vallata della Vojussa, abbandonando sotto la pressione del contrattacco nemico il territorio conquistato a prezzo di dieci giorni di sforzi e marce estenuanti.
Le due settimane seguenti sono per la «Julia» le più tragiche di tutta la campagna. Truppe esauste per i disagi e l’asprezza del cammino, il maltempo, la scarsezza di cibo e di riposo, mal equipaggiate e ormai a corto di munizioni, sono costrette a retrocedere a stretto contatto del nemico, ad aprirsi il varco con ripetuti assalti alla baionetta, a contrattaccare per svincolare i reparti investiti e alleggerire la pressione, col rischio incombente di un accerchiamento totale. Anche i greci, che dispongono di armamenti simili a quelli del Regio Esercito, scontano le difficoltà del terreno e del maltempo, ma hanno a loro vantaggio il fattore morale: aver fermato l’invasione e costretto gli italiani al ripiegamento galvanizza l’opinione pubblica e le truppe, mentre tra i reparti italiani si diffonde la sfiducia e il disorientamento.
Appena insediatosi al posto di Visconti Prasca, Soddu cerca di organizzare la difesa restringendo il fronte, ma quando le indicazioni giungono in prima linea i battaglioni della «Julia», che già non erano a pieno organico all’inizio dell’attacco, sono ormai decimati dalle perdite. Il 16 novembre la difesa degli alpini è praticamente ridotta al ponte sulla Vojussa di Perati:
Dal 17 i greci iniziarono incessanti attacchi alla testa di ponte di Perati premendo specialmente sul battaglione «L’Aquila» e rinnovando ogni giorno i reparti lanciati contro le nostre linee, estendendo e intensificando

82
progressivamente lo sforzo. La pressione del nemico era tale che sembrava poter travolgere le difese da un momento all’altro. Poiché si erano verificate qua e là infiltrazioni nemiche, il comando dell’8o corpo d’armata decise di restringere il fronte su una breve linea ad arco che, dalla destra del Sarandaporos, poco a monte della confluenza di questo corso d’acqua con la Vojussa, passando per il Dosso Melissopetra e quota 568, raggiungeva la Vojussa a valle di ponte Perati. Il 19 la nuova linea era presidiata dai battaglioni «L’Aquila», «Cividale» e «Tagliamento». Il 20 i greci attaccavano il tratto di fronte tenuto dal «Tagliamento» per la sinistra della Vojussa, ma erano arrestati dalla tenace resistenza del battaglione.
Il 21 l’attacco si ripete, con impiego di maggiori forze, dirigendosi verso le ali dello schieramento italiano: la resistenza, alternata a contrattacchi di alleggerimento, si protrae per oltre sei ore, ma gli ellenici sono in grado di far affluire sul campo nuove forze e riprendono l’attacco con reparti freschi:
Il comando dell’8o corpo d’armata, vedendo che gli Alpini stavano per essere sopraffatti, ordinò allora alla «Julia» di ripiegare lungo la Vojussa su Premeti e Ura Petrani, dopo aver fatto saltare tutti i ponti, e di portarsi alle difese dell’alta val Lengatica, dove si temeva una possibile incursione dei greci.23
Nella ritirata i reparti alpini mantengono la loro intelaiatura, forti di una coesione specifica legata al reclutamento territoriale, ma le perdite sono drammatiche e superano un terzo degli effettivi. Le testimonianze dei superstiti descrivono scenari inquietanti, ancor più se paragonati alla superficialità velleitaria con cui Ciano, Jacomoni, e Visconti Prasca hanno prospettato la campagna. Scrive l’alpino Arturo Gazzini del «Cividale»:
Nell’avanzata, la notte del 3 novembre sapemmo che eravamo già circondati dal nemico in quelle valli incassate tra le rudi montagne del Pindo. Stremati dal freddo e dalla fame, senza munizioni dopo sei giorni di avanzata privi di rifornimenti, gli alpini e gli artiglieri alpini rimasero disseminati in innumerevoli scontri. Ma ci attendeva ben presto il ponte di Perati. Mi trovai in mezzo a quella furibonda battaglia: il bosco bruciava, si calpestavano i morti e si scavalcavano i feriti, i fanti giù nella conca venivano travolti e maciullati dalle granate, i bersaglieri abbandonavano i loro mezzi che non potevano muoversi nel fango e si improvvisavano alpini, e tutti combattevamo con furore per salvare il salvabile. Appena attraversata la passerella di legno facendo il segno della croce, sotto un fuoco micidiale di mitragliatrici, vidi dall’altra sponda persino gente annegare nel fiume e poi la passerella dove ero appena passato che veniva colpita e bruciava, i legni che penzolavano nel vuoto. Avevo gli occhi sbarrati, era l’inferno dappertutto.24

83
Nelle parole di Giovanni Zanette, autore di Tempesta sulle alpi albanesi, la riscoperta gioiosa del gusto di lavarsi in una pausa dei combattimenti lascia intendere la drammaticità dei momenti più duri:
E ci si lava, anche! L’attendente ha sciolto la neve nella gavetta, sopra il pezzo di assicella sacrificato sul rogo al nume della pulizia; la pelle respira con delizia attraverso i pori liberati dal sudiciume, mentre il sole l’asciuga, in queste rare giornate, incastonate come turchesi fra le nebbie opache e la rabbia della tormenta.25
Scrive invece Manlio Cecovini in Ponte Perati, la divisione Julia in Grecia:
C’è una credenza tra i montagnini che insegna a non rimettere a rischio la propria vita finché non sia completamente superata la paura di un precedente rischio mortale. Ma purtroppo non ci fu dato scegliere, e solo pochi giorni dopo che avevo riportato intera la mia pelle in batteria, mi ritrovai in mezzo ai pasticci con un cuore così stretto e un senso di infelicità così intenso che mi sorpresi a domandarmi perché mai proprio io, di tanti uomini che c’erano al mondo e se la passavano alla meno peggio, proprio io dovevo essere lì alla mercé di una granata che avesse scelto per suo punto d’impatto i dintorni dell’osservatorio.26
Lo storico degli Alpini Aldo Rasero ricostruisce così la nascita della «leggenda della Julia» tra i soldati italiani in Grecia:
Verso la metà del mese di novembre 1940 sul fronte greco-albanese i greci attaccarono le nostre linee con forze inattese e considerevoli. Il nostro comando, per far fronte alla precaria situazione che si è creata, manda affrettatamente in linea tutti gli uomini e i reparti disponibili. Quelli diretti verso la zona di Ponte Perati incrociano colonne provenienti dalla prima linea e tra questi numerosi sono gli alpini. E sorge naturale negli ultimi arrivati, più per un senso di solidarietà che di curiosità, il desiderio di conoscere a quale reparto appartengono. La risposta è sempre la stessa, breve, incisiva, decisa, che denuncia il malcelato orgoglio frammisto alla innata modestia dell’alpino: Julia. Raramente un accenno al battaglione o al reggimento, ma sempre quel nome che è già circondato da un alone di leggenda. Julia. Il nome viene ripetuto dagli ultimi arrivati con un senso di ammirazione perché sono note le vicende di questa divisione, che si è spinta audacemente nello schieramento nemico ed è dovuta arretrare combattendo strenuamente perché lasciata priva di rinforzi, di rifornimenti, di viveri, di munizioni.27
Che si tratti di una leggenda spontanea, nata tra i soldati e non da un’operazione costruita dalla propaganda di guerra, è confermato da Giovanni Zanette:
La leggenda della Julia era nata da poche settimane proprio su queste montagne, non per retorica degli inviati speciali, ma spontaneamente, in mezzo ai

84
combattimenti, tramandata da alpino ad alpino, da conducente a conducente. Se ne parlava in linea nelle lunghe notti di veglia o sotto la tenda rischiarata dalla fiamma rossastra del grasso antiassiderante mentre fuori c’era la tormenta e il vento sbatteva i teli. Se ne parlava nelle retrovie, nei posti di ristoro di Durazzo e di Valona per far impallidire di paura i poveri diavoli appena sbarcati che ancora non conoscevano questa terra d’Albania. A poco a poco la Julia al ponte di Perati era assurta a valore di simbolo. Era qualcosa che apparteneva a ciascuno di noi, e tuttavia sopra di noi come uno sprazzo di cielo. Lassù sembravano essersi raccolte tutte le cose che ci erano state tolte o che avevamo perduto lungo il cammino, e là avremmo potuto ritrovarle: era il paese, la patria, il suono delle nostre campane, il riso delle nostre donne, la giustificazione della vita e della morte. Perciò, quando fossimo tornati al nostro paese, non avremmo detto «ero di questo quel reparto», ma «ero con la Julia, combattevo a fianco della Julia, mi trovavo sul fronte della Julia».28

85
V L’inverno delle sconfitte
La notte di Taranto
Se l’estate del 1940 è la stagione delle attese e l’autunno quella delle velleità, l’inverno 1940-41 è la stagione delle sconfitte, in cui la strategia della guerra parallela naufraga e lascia il posto a quella (umiliante e gravida di conseguenze) della guerra subalterna: di fatto, la parabola del fascismo e di Mussolini è segnata sin dai primi mesi del conflitto, anche se l’alleanza con la Germania nazista permetterà al regime di sopravvivere sino al 25 luglio 1943.
Negli stessi giorni in cui Graziani arresta la sua offensiva a Sidi el-Barrani e l’armata in Grecia è costretta al ripiegamento, la Marina inglese infligge una severa punizione a quella italiana. Il dinamismo nella Royal Navy nel Mediterraneo corrisponde all’atteggiamento voluto da Churchill: né passività, né eccesso di cautela, ma misure di sicurezza e, appena possibile, contrattacchi. I danni subiti in patria durante la battaglia d’Inghilterra hanno bisogno di essere compensati da successi ottenuti in mare, sia per confortare l’opinione pubblica interna, sia per dimostrare al nemico la propria vitalità. L’ammiraglio Cunningham immagina di realizzare un’azione spettacolare il 21 ottobre, nel 135° anniversario della battaglia di Trafalgar, quando Horatio Nelson sconfisse la Francia di Napoleone: l’attacco dovrebbe ridurre la potenzialità offensiva della Regia Marina impedendole di dare il proprio contributo alle campagne di Grecia e d’Egitto, mentre la data caricherebbe l’impresa di suggestioni storiche e ne moltiplicherebbe l’effetto psicologico.
Il piano, studiato dallo stato maggiore dell’ammiraglio sin da fine agosto, prevede l’attacco al porto di Taranto, dove alcune importanti navi da guerra italiane sono all’ancora in Mar Grande e in Mar Piccolo. La difficoltà di attuazione deriva dal fatto che per un’operazione del genere, da realizzarsi con bombardieri e siluranti, la portaerei Eagle risulta troppo lenta e con una capacità di carico insufficiente. Per questo Londra invia nel Mediterraneo l’Illustrious, varata nel 1939, lunga oltre 200 metri e con a bordo 36 apparecchi:1 inizialmente utilizzata come scorta nell’Atlantico, l’unità attraversa Gibilterra solo a fine ottobre e per questo l’attacco a Taranto viene posticipato. Frattanto nella base di Malta sono giunti velivoli da ricognizione di provenienza americana, i bimotori Glenn Martin

86
Maryland e i caccia Fairey Fulmar, assai più efficaci dei lenti quadrimotori Sunderland: l’attività di sorvolo a bassa quota si moltiplica, e gli inglesi riescono ad avere un quadro esatto delle posizioni delle navi italiane e della situazione nella base di Taranto.
L’incursione scatta nella notte dell’11 novembre, con un’azione combinata per disorientare la Regia Marina. Da Gibilterra si muovono alcune navi per colpire Cagliari e fingere un’azione sulla Sardegna, mentre da Alessandria d’Egitto escono tre formazioni: la più numerosa si dirige a Malta, a protezione di un convoglio mercantile, e si tiene poco a est dell’isola come riserva tattica; la seconda, formata da incrociatori e cacciatorpediniere, si dirige verso il canale d’Otranto a minaccia dei collegamenti tra l’Italia e l’Albania, con l’obiettivo di confondere le difese in Puglia; la terza, con l’Illustrious e le navi di scorta,2 punta invece verso le acque ioniche, per raggiungere alle 20.30 un punto distante 170 miglia da Taranto e 40 da Cefalonia, la posizione da cui devono alzarsi in volo gli aerei per l’attacco alla base.
Il piano funziona: Supermarina ritiene che le navi partite da Alessandria siano di scorta a ai convogli e si concentra su quelle dirette verso la Sardegna. Il giorno 10 l’aviazione compie un’incursione di bombardieri sulla flotta di Gibilterra, infliggendo danni lievi ma compiacendosi perché nel pomeriggio questa inverte la rotta e, dopo un leggero attacco al porto sardo, riprende la navigazione verso ovest. La mattina dell’11 il sommergibile Topazio attacca il gruppo navale britannico che si dirige verso Malta, ma le navi da guerra non si muovono per ingaggiare battaglia. La convinzione è che si tratti di ordinaria amministrazione e che l’azione principale sulla Sardegna sia stata scoraggiata.
L’attacco inglese parte alle 20.50 con il decollo della prima ondata composta da 2 «bengalieri» (che devono lanciare bengala lungo la costa del Mar Grande per creare una cortina luminosa alle spalle degli ancoraggi e rendere ben visibili le navi in rada), 6 aerosiluranti (destinati a colpire le corazzate, i bersagli più importanti) e 4 bombardieri (con obiettivo gli incrociatori e il naviglio minore); la seconda ondata parte alle 21.34, con 5 aerosiluranti, 2 bengalieri e un solo bombardiere. Gli aerei arrivano dal Golfo di Taranto provenienti da sudest, poi compiono una manovra aggirante e attaccano da sudovest.
Il dispositivo di difesa della piazzaforte di Taranto dispone di una rete di scoperta aerea con tredici stazioni aerofoniche ed è munita di artiglierie antiquate ma ancora efficienti: in mancanza di radar, si

87
tratta di una situazione tattica accettabile, non diversa da quella britannica a Malta.
L’idoneità delle armi era però quasi esclusivamente dedicata a reagire a incursioni di aerei in quota: non risulta che nessuno avesse contemplato la probabilità o l’eventualità di bombardamenti a bassa quota o addirittura a volo radente, e ancor meno la possibilità di aerosiluramento sia in Mar Grande sia in Mar Piccolo, tanto che le ostruzioni retali disposte a protezione delle grandi navi erano parziali e del tutto insufficienti allo scopo (inoltre esse erano di un’altezza di soli 10 metri, mentre i siluri inglesi erano regolati per un’immersione a quasi 11 metri e potevano quindi passare tra la rete e il fondo del mare raggiungendo i bersagli).3
Ai limiti tecnici dei sistemi di difesa si aggiungono le lacune (e la sottovalutazione) nella raccolta delle informazioni. I voli dei ricognitori britannici sulla piazzaforte, che si moltiplicano a partire da metà ottobre, dovrebbero allertare il comando del dipartimento marittimo e indurre a cercare un ancoraggio più protetto per le grandi navi o al loro trasferimento in altre basi:
I comandi, pur coscienti che qualcosa stava maturando, non assunsero alcuna misura preventiva, né chiesero rinforzi di aviazione da caccia negli aeroporti vicini. D’altra parte, il peggio che si poteva pensare era che si sarebbe trattato di incursioni in quota, cui avrebbero potuto provvedere le artiglierie della contraerea.4
Taranto viene messa in stato d’allarme alle 22.25, quando la rete d’ascolto registra rumori di aerei in rapido avvicinamento da sudest. Alle 22.50 le batterie di Capo San Vito iniziano il fuoco di sbarramento, ma i «bengalieri», volando a bassa quota, sfuggono ai proiettili e alle 23.00 illuminano a giorno la costa orientale del golfo, seguiti dai bombardieri che sganciano le prime bombe: la contraerea dirige allora il tiro in quella direzione, non rendendosi conto che nello stesso momento gli aerosiluranti, spenti i motori alla quota di 1350 metri, planano in silenzio verso le corazzate all’ancora in Mar Grande, che ben risultano alla vista sullo sfondo illuminato dai bengala. Si tratta di un’azione ardita e tecnicamente perfetta: gli aerosiluranti sganciano le loro armi alla distanza di 350 metri dai bersagli e alla quota di soli 9 metri dal livello del mare. Le difese contraeree non hanno il tempo di capire ciò che sta accadendo e non sono in grado di reagire né alla prima ondata (la cui incursione dura sino alle 23.30), né alla seconda, che giunge sulla rada alle 24.00 e colpisce per circa trenta minuti.

88
Alla 1.30, quando a Taranto viene dato il segnale di cessato allarme, la situazione per la Regia Marina è drammatica. Su undici lanci, cinque vanno a segno: tre siluri colpiscono la Littorio, uno ciascuno la Conte di Cavour» e la Duilio; 52 marinai perdono la vita. L’azione diversiva dei bombardieri arreca danni a varie installazioni a terra e colpisce in acqua gli incrociatori Libeccio e Trento e per non perdere definitivamente le navi è giocoforza portarle a incagliarsi su bassi fondali, da dove sarebbe possibile il recupero: il primo incaglio, alle 0.45, è quello della Duilio; un quarto d’ora dopo tocca alla Conte di Cavour, che viste le cattive condizioni non può navigare per molto e viene fatta arenare su fondali medio-bassi, tanto da rimanere sommersa sino all’altezza delle torri di grosso calibro, con l’equipaggio costretto ad abbandonarla (nonostante i lavori di riparazione, la nave non rientrerà più in servizio); la Littorio, con tre squarci, viene portata a incagliarsi alle prime luci dell’alba, mentre i due incrociatori hanno danni superficiali e possono dirigersi verso il bacino di riparazione. Per la Marina britannica (la cui aviazione imbarcata lamenta solo la perdita di due apparecchi) si tratta di un successo oltre le aspettative, realizzato grazie alla pianificazione attenta e alla perfetta cooperazione tra Cunningham e l’ammiraglio Lumley Lyster, comandante della divisione portaerei: l’episodio è destinato a essere iscritto nell’albo delle migliori tradizioni della Royal Navy e celebrato come «Taranto night».
Mentre le unità navali britanniche rientrano a Malta e ad Alessandria, Supermarina ordina l’evacuazione delle navi da battaglia da Taranto e le trasferisce a Napoli, La Spezia e Messina. Il colpo subito è grave sul piano dell’immagine: Ciano parla di «giornata nera, di cui Mussolini pare non aver valutata tutta la gravità» e prende di mira le responsabilità del Comando supremo lamentando che «Badoglio disse che, attaccando la Grecia, avremmo subito dovuto spostare la flotta, non più sicura. E perché non lo si è fatto dopo quindici giorni dall’inizio delle operazioni nei Balcani?».5 I limiti dei comandi sono evidenti e non riguardano soltanto Badoglio e le mancate predisposizioni, ma anche la Marina e l’Aeronautica: mentre gli inglesi si avvicinano a sole 170 miglia da Taranto, la nostra flotta rimane ferma nel porto, allertata e pronta a muoversi ma immobile all’ancora; le attività di ricognizione non danno una visione d’insieme dei movimenti nemici; l’attacco a bassa quota sorprende completamente la difesa; l’assegnazione ai fronti terrestri degli apparecchi disponibili annulla la possibilità di concorso aereo alle operazioni navali. Al di là degli inevitabili scambi di accuse tra

89
politici e militari e tra gli stati maggiori tra loro, è l’organizzazione della guerra fascista a rivelare le sue insufficienze.
Gli effetti negativi della notte di Taranto vanno oltre il piano dell’immagine e della guerra psicologica e incidono sugli equilibri militari nel Mediterraneo. Come scrive Supermarina in una nota del dicembre successivo,
Dopo l’azione aerosilurante del 12 novembre, gli inglesi hanno potuto assicurarsi senza difficoltà la prevalenza in entrambi i bacini del Mediterraneo, così che è venuto meno uno dei postulati strategici su cui poteva fondarsi la nostra condotta delle operazioni: affrontare cioè con superiorità di forze l’una o l’altra delle due frazioni nella Mediterranean Fleet.6
Il commento di Cunningham è più tecnico e meno drastico:
Taranto deve essere ricordata per aver dimostrato, una volta per tutte, che la marina ha nell’aviazione navale la sua più potente arma. Il colpo ha ridotto, se non abolito interamente, la minaccia che la flotta nemica possa interferire nella nostra ininterrotta successione di convogli per la Grecia e ci ha permesso di diminuire il numero delle nostre corazzate nel Mediterraneo occidentale.7
Certo è che le perdite di tre corazzate sulle cinque disponibili ridimensiona le possibilità della Regia Marina e rafforza la tendenza alla passività che l’ha caratterizzata nei primi mesi di conflitto.
Il contrattacco greco
Il comandante dell’esercito greco è Alexandros Papagos; nato ad Atene nel 1883, formatosi all’Accademia militare di Bruxelles, è un ufficiale di comprovata fede monarchica, che nella sua carriera ha attraversato le fasi convulse della storia politica greca. Nell’ottobre 1935 ha partecipato al colpo di Stato che ha rovesciato il governo repubblicano e permesso il ritorno al trono di re Giorgio II: il suo ruolo è stato premiato con la nomina a ministro della Guerra e negli anni successivi ha riorganizzato e riequipaggiato l’esercito, avvalendosi degli aiuti inglesi in materiali e istruttori. Quando Mussolini prepara l’attacco nei Balcani, egli assume il comando delle truppe e, in perfetta sintonia con il primo ministro Metaxas, anima la resistenza del paese, convinto che l’alleanza con l’Inghilterra sia la sola garanzia per l’indipendenza di Atene. All’inizio delle operazioni, i greci temono un’offensiva di consistenza ben maggiore di quella che effettivamente viene espressa sul campo, perché l’Italia fascista è accreditata di un potenziale bellico da grande potenza. Le azioni dei primi giorni rivelano invece le debolezze del Regio Esercito, la

90
temutissima aviazione dei grandi risultati sportivi non decolla neppure, i carri armati e le artiglierie non riescono a muoversi tra le mulattiere infangate dell’Epiro. Nel momento in cui lo scontro si riduce all’assalto da parte di fanterie appiedate, i difensori sono avvantaggiati dalle posizioni e dalla conoscenza del terreno e riescono a contenere l’avanzata nemica.
Il mancato sfondamento ha ripercussioni profonde e opposte sui due fronti: mentre tra gli italiani produce una sfiducia diffusa che aumenta a mano a mano che si constatano le difficoltà logistiche, la mancanza di coordinamento e di rifornimenti, le perdite di uomini, tra i greci la determinazione a resistere si trasforma in convinzione nelle proprie forze, poi in euforia per la capacità di contrasto, infine in volontà di contrattaccare. Il coefficiente morale sale tra i reparti e tra la popolazione civile, il governo Metaxas si rafforza facendo appello all’orgoglio nazionale, dietro i combattenti di prima linea c’è la mobilitazione dell’intero paese («I greci ci odiano» scrive il generale Mario Girotti, comandante della «Julia» «alla fanteria avversaria si è unita nell’attacco la popolazione epirota»8).
Fermata l’offensiva di inizio novembre con la perdita di pochi chilometri di territorio, il giorno 10 il generale Papagos inizia il contrattacco, sfruttando il disorientamento delle truppe italiane e il loro sbilanciamento, con alcune unità avanzate ma con le salmerie rimaste in posizione arretrata. L’azione sfonda facilmente nella Macedonia centrale, dove un sistema debole nelle giunture tra divisione e divisione crea spazi vulnerabili in cui si infilano le fanterie elleniche. In Epiro la «Julia» riesce a rallentare la marcia nemica per qualche giorno, ma non ricevendo il cambio è costretta a sua volta a ripiegare. Quando Soddu assume il comando al posto di Visconti Prasca invia al fronte tutti i rinforzi disponibili, ma si tratta di spostamenti caotici, con unità mandate «su posizioni sconosciute o non ben definite, dove talvolta devono apprendere a proprie spese in quale direzione si trovi il nemico».9
La sera del 14 novembre il generale Gabriele Nasci, comandante del 21o corpo d’armata operante nel settore macedone, decide di arretrare sul Morova Morava meridionale, ma nel frattempo i greci hanno raggiunto Ersekë, oltre il confine albanese, il cui presidio si è ritirato lasciando sguarnito il fianco sinistro della divisione «Bari». Al di là del valore simbolico di un villaggio del regno d’Albania occupato dai nemici, l’esposizione impedisce alla «Bari» di raggiungere la «Julia» e determina la rottura anche sul Pindo.

91
Piove o nevica, mancano viveri, medicine, ospedali, le divise di panno autarchico si lacerano o s’induriscono senza proteggere dal freddo, il caos regna nelle retrovie. Un reparto alpino appena sceso dagli aerei sul campo di Coriza viene preso sotto il fuoco dell’artiglieria nemica: i morti vengono stesi sulle piste, i feriti rimessi sugli aerei e rispediti in Italia dopo essere rimasti pochi minuti sul suolo albanese, il tempo di essere colpiti. Nei valloniNella valle del Devoli battaglioni di fanteria battuti dai colpi di mortaio ripiegano con dure perdite. Siamo al disastro, se non anche alla vergogna.10
Il generale Soddu e i comandanti ritengono indispensabile una ritirata profonda, di almeno 50 chilometri, Mussolini insiste perché si resista sulla linea di confine, ordina un affannoso invio di rinforzi dalla madrepatria, chiede al generale Giuseppe Santoro, sottocapo di Stato maggiore dell’Aeronautica, di «radere al suolo tutte le città greche con più di 10.000 abitanti». La confusione politica e quella logistica si intrecciano in un quadro disarmante di velleità e frustrazioni. Come ricorderà Mario Roatta,
appena era disponibile un mezzo qualsiasi di trasporto per il personale (nave da guerra, piroscafo, aereo), gli uomini vi si imbarcavano, sovente a piccoli lotti, e il mezzo partiva. Le armi pesanti, le stazioni radio, le cucine, le coperte, il bagaglio, il materiale sanitario, le munizioni, i quadrupedi, seguivano invece sui mezzi acconci al loro trasporto appena possibile. Così gli uomini sbarcati disponevano soltanto delle armi leggere e dell’equipaggiamento e munizioni individuali. A un certo punto, a fine novembre, avemmo in sofferenza in Puglia più di trentamila quadrupedi con i loro conducenti. Lo Stato maggiore non ha mai potuto far arrivare in Albania neppure un reggimento che fosse accompagnato da tutti i suoi mezzi di vita e di azione.11
Il 21 novembre la ritirata in profondità diventa inevitabile e la nuova linea è stabilita sulle posizioni di monte Cytetit-Ferit Haskiut-Bregu e Breshave-Valomone (2373)-Lenijes-Mali Haisht-Nikolara-Gostanches-Mali Velushesla nuova linea è posta fra il monte Cytetit-Ferit e Mali Velushes[lo trovo citato in rete in questo modo (regioesercito.it) a parte in Giorgio Bocca], decine di chilometri dal confine greco-albanese: lo stesso giorno la retroguardia del 4° bersaglieri lascia Korca Korça (italianizzata in CorizzaCoriza [così nella citazione sopra]), la sesta città più grande dell’Albania, capitale dell’omonima prefettura, che viene occupata dagli ellenici. Per i Greci è una vittoria tanto straordinaria quando inattesa, che Metaxas comunica per radio a un popolo festante, mentre a Londra, intervenendo alla Camera dei Comuni, il ministro degli Esteri Edward Halifax tributa un elogio solenne all’«eroico popolo greco». Per il fascismo è una sconfitta bruciante, che assommandosi agli

92
affondamenti di Taranto e alla stasi in Africa ridimensiona del tutto le ambizioni imperialiste del regime e l’immagine di Mussolini.
Nonostante la ritirata su posizioni arretrate, la situazione militare nei Balcani non si stabilizza. Mario Vercellino, chiamato da Soddu a comandare il settore macedone, lamenta che «siamo senza comunicazioni e quasi senza automezzi, le notizie arrivano solo a mezzo di corrieri, per rifornire la nuova linea io non posso disporre che di mulattiere e tratturi di montagna e i muli sono pochissimi». Il comandante del settore dell’Epiro, Carlo Geloso, chiede un ritiro su posizioni ancora più arretrate e denuncia a sua volta che «tra poco sarò senza alcuna riserva degna di tal nome. Le divisioni “Bari” e “Centauro”, duramente provate, hanno bisogno di essere raccolte in seconda linea per riordinarsi, la “Ferrara” è ridotta a un pugno di uomini, la “Siena” in condizioni analoghe».12 Mussolini, che non vuole credere al pessimismo dei generali in Albania e che ancora a metà novembre ha assicurato che «spezzeremo le reni alla Grecia», invia sul posto come suo inviato speciale il sottosegretario all’Aeronautica Francesco Pricolo, ma ne riceve la sconfortante conferma:
I comandanti hanno molti dubbi sullo spirito di combattività di truppe stanche e di reparti ormai frammisti, a volte disordinati e male inquadrati. Le truppe hanno l’impressione di essere state male impiegate, malamente assistite e si sentono depresse per aver subito l’umiliazione della sconfitta da parte di truppe greche.13
Per qualche giorno la pressione ellenica si allenta, perché il generale Papagos teme che gli italiani abbiano predisposto campi minati e non vuole rischiare le proprie truppe: la pausa permette ai nostri comandi di rabberciare la linea di difesa, ma già a fine mese il contrattacco riprende perché non bisogna lasciare al nemico la possibilità di riorganizzarsi. Il 28 novembre quattro battaglioni di euzones, soldati scelti di fanteria da montagna al comando del generale Georgios Tsolakoglu, 14 occupano Pogradec, altra città albanese, affacciata sul lago di Ocrida, vicina al confine ma anche a soli 130 chilometri da Tirana. Il 6 dicembre entrano a Saranda (italianizzata in Santi Quaranta), cittadina della costa jonica a 50 chilometri dal porto di Valona; due giorni dopo sono ad Argirocastro, anch’essa capitale di omonima prefettura, città storica situata nel Sud dell’Albania. La linea del fronte arretra ulteriormente, il Regio Esercito è in ritirata verso il mare, sull’orlo del collasso. Mentre in Europa il timore di qualche mese prima si trasforma in dileggio e a Mentone i doganieri francesi espongono un cartello (che sarà ritirato

93
solo per la protesta della commissione d’armistizio) in cui si legge «Grecs, arretez-vous. Ici France», i vertici nazisti coniugano sconcerto e disprezzo: «una spaventosa orgia di dilettantismo, impareggiabile e inspiegabile se non col fatto che gli Italiani, dopo tutto, sono una razza neolatina» annota Goebbels nel diario. «Gli italiani sono oggi al livello più basso per quanto concerne l’opinione mondiale, ma purtroppo hanno portato allo sfacelo l’intero prestigio militare dell’Asse e ora noi dovremo attaccare».15 Hitler, che il 20 novembre scrive al duce, è più misurato nei toni ma perentorio nell’analisi:
La conseguenza psicologica di questa situazione è grave perché pesa sfavorevolmente sui preparativi diplomatici in pieno sviluppo e rafforza le tendenze dei paesi balcanici a non impegnarsi a nostro favore; dal punto di vista militare è ancora più grave perché porta l’Inghilterra ad avere basi aeree nelle vicinanze del bacino petrolifero di Ploesti Ploiești e se le grandi raffinerie dovessero essere distrutte il danno sarebbe irreparabile.
Seguono due pagine di indicazioni operative, «misure di carattere politico e misure di carattere militare da adottarsi per far fronte a una situazione che si presenta paurosa», in cui il Führer assume non più il ruolo di socio di maggioranza dell’Asse ma di capo unico dell’alleanza, prefigurando i prossimi scenari della «guerra subalterna». Per i Balcani egli prospetta un intervento militare tedesco da effettuarsi in primavera, per il Mediterraneo chiede a Mussolini di sbarrare le rotte inglesi e di minare con aerei a grande autonomia il canale di Suez, per l’Africa settentrionale di rinunciare al delta del Nilo e limitarsi a puntare su Marsa Matruh (porto a 240 km da Alessandria), da dove possono alzarsi i bombardieri per colpire la rada di Alessandria e il canale.16 Mussolini non si risente per il carattere prescrittivo delle indicazioni («Mi aspettavo dal Duce una reazione violenta» osserva Ciano, «invece no, sembra non attribuire importanza a un documento che invece ne ha molta» 17 ) e risponde con un’imbarazzata promessa di riscatto:
L’andamento negativo delle operazioni in Grecia sono un fenomeno passeggero, dovuto ad un vero diluvio che ha bloccato le truppe e alla defezione quasi totale delle truppe albanesi. Io sto preparando un numero sufficiente di divisioni (trenta) per schiacciare la Grecia e non ho preoccupazioni per il futuro.18
La rivoluzione ai vertici militari

94
Anche se la stampa di regime occulta la verità sul fronte greco e parla di «ordinato ripiegamento» in attesa di «rinnovare lo slancio offensivo», è evidente che anziché arrivare ad Atene in poche settimane il Regio Esercito è ridotto a difendere prima il confine albanese, poi la costa ionica: l’Italia fascista sta perdendo la guerra, e la sta perdendo contro un paese privo di tradizioni militari, dopo aver educato per vent’anni le nuove generazioni a credere nell’onnipotenza delle nostre armi. Le sconfitte richiedono dei colpevoli e quando non si vogliono (o non si possono) individuare i responsabili veri si ricorre ai capri espiatori. Al di là delle colpe primarie di Mussolini, è evidente che il ruolo politico di Ciano e Jacomoni è stato determinante nella decisione di attaccare e nella sottovalutazione del nemico. Il duce ne è consapevole e prova verso di loro un sordo rancore ma rimuovere il genero (al di là delle implicazioni familiari, con la figlia Edda ostinata nel difendere comunque il marito) significa smentire se stesso per averlo elevato al ruolo di «delfino» e riconoscere responsabilità dirette del fascismo; analogamente, Jacomoni non può diventare capro espiatorio sia perché politicamente legato a Ciano, sia perché è a sua volta genero di Ugo Cavallero, il generale gradito ai tedeschi su cui Mussolini punta per rinnovare il vertice militare.
La prima «testa» a saltare è quella di Visconti Prasca, anche se nel quadro gerarchico delle forze armate egli occupa una posizione di seconda fila e non è abbastanza noto al grande pubblico per funzionare da parafulmine: è lui a impostare la campagna ed è lui a fallire l’attacco. I rovesci in Grecia hanno però bisogno di una vittima più illustre, un nome radicato nell’immaginario collettivo la cui rimozione dia il senso di una svolta radicale. Il comandante supremo Pietro Badoglio è l’uomo adatto per dare peso all’epurazione. La sua storia politica e militare non manca di ambiguità; coinvolto nella ritirata di Caporetto, ma misteriosamente assolto dalla Commissione d’inchiesta; nel 1917 braccio destro del generale Luigi Capello silurato dopo la rotta, e nel 1918 braccio destro del nuovo comandante supremo Armando Diaz; uomo di riferimento della classe dirigente liberale disposto nel 1922 a disperdere con le armi la marcia su Roma, e nel 1925 nominato dal fascismo capo di stato maggiore generale e poco dopo «maresciallo d’Italia»; in privato scettico sull’entrata in guerra nel giugno 1940 e del tutto contrario alla campagna di Grecia, ma nelle riunioni ufficiali accondiscendente e incapace di opposizione.
Per tutti gli italiani Badoglio rappresenta la monarchia e le forze armate: anche se nei fatti è uomo del regime (governatore della

95
Tripolitania, della Cirenaica, dell’Eritrea, commissario dell’AOI, viceré in Etiopia), nell’opinione comune è percepito soprattutto come un generale e un senatore di Vittorio Emanuele III. A Mussolini non è mai piaciuto e gli incarichi che gli ha attribuito sono stati uno strumento per ingraziarsi il gruppo dirigente militare e coinvolgerlo nella gestione fascista dello Stato; non è mai piaciuto neppure ai tedeschi, che lo considerano inaffidabile come il re, amico dei francesi, massone.
Espressione di un mondo troppo conservatore e prudente che si allinea alla politica dell’Asse solo per l’impossibilità di opporsi, opportunista nei comportamenti, spesso evasivo negli interventi e recalcitrante a prendere posizioni nette, Badoglio si presta a essere considerato il responsabile di una guerra condotta senza preparazione, senza aggressività, senza volontà di vittoria: è un generale di Vittorio Veneto, cresciuto tra trincee e baionette, messo al posto di comando in un conflitto del tutto diverso, dove ci si muove tra aerei e carri armati. Dimenticando che «otto milioni di baionette» sono stati state una delletra le sue parole d’ordine preferite, Mussolini decide di sostituire il maresciallo giocando sulla contrapposizione di immagine tra il vecchio e il moderno. Il gruppo Ciano-Jacomoni è assolutamente favorevole, perché questo significa scaricare i propri errori politici sulla conduzione militare. Altrettanto favorevoli i tedeschi, anche perché il 15 novembre Badoglio e Keitel si sono incontrati a Innsbruck e il comandante della Wehrmacht è rimasto sfavorevolmente impressionato dai discorsi del collega italiano, troppo trasparente nel disegno di ribaltare sul fascismo le colpe dell’insuccesso greco.
A portare l’attacco è Roberto Farinacci, da sempre uno dei gerarchi più ostili al maresciallo. Il 23 novembre egli pubblica nel suo giornale «Regime fascista» un corsivo anonimo (scritto in realtà da Emilio Canevari, un ufficiale di stato maggiore allontanato per una vicenda amministrativa ma stimato da Mussolini):
Il Duce ha parlato chiaro, la moderna Cartagine sarà sconfitta e la Grecia finirà con le ossa rotte. Noi siamo certi che tutto questo si realizzerà, anche se qualche imprevidenza e intempestività dello stato maggiore generale ha permesso a Churchill di avere uno sciocco diversivo.19
L’attacco a Badoglio è esplicito, e oltretutto viene fatto da un foglio a tiratura nazionale, l’unica voce ufficiale del regime (insieme al «Popolo d’Italia») a essere distribuita quotidianamente in tutta la penisola.

96
Badoglio va dal duce a chiedere la pubblicazione di un’immediata smentita da parte del «Regime fascista», minacciando in caso contrario le dimissioni, quindi prende una licenza di otto giorni e si reca in Lombardia, ospite dell’industriale Vittorio Necchi in una tenuta di caccia presso Pavia. Il maresciallo è convinto che l’attacco alla sua persona possa essere usato per coagulare intorno a sé la solidarietà di casta, presentandolo come attacco all’esercito e all’istituzione militare. In effetti non mancano voci di alti ufficiali indignati, ma non ci sono prese di posizione tali da fermare il progetto epurativo: «Nelle forze armate la critica e il malcontento verso il partito fascista e Ciano in primis erano radicati, ma anche Badoglio era criticato, e pesantemente, per l’atteggiamento poco fermo e ambiguo in occasione della vicenda greca. 20 Lo stesso Vittorio Emanuele prende le distanze dal maresciallo e confida al suo aiutante di campo Paolo Puntoni:
Non bisogna credere che Badoglio alla fine sia insostituibile. Sono anzi persuaso che in questo caso non tutto il male verrà per nuocere. A suo tempo non ha fatto nulla di decisivo per impedire la guerra alla Grecia, adesso fa di tutto per scaricare la colpa del disastro sulle spalle degli altri.
Comprendendo che la situazione non evolve nella direzione sperata e sentendosi isolato, Badoglio rientra in fretta a Roma la mattina del 3 dicembre e si reca dal sovrano («mi ha fatto un’impressione disastrosa» dirà questi al ministro della Real Casa, il duca Pietro Acquarone. «Fisicamente è distrutto, intellettualmente è intorpidito»21). Il giorno dopo è a colloquio con il duce, il quale lo tratta con freddezza e gli annuncia che è orientato a sostituirlo con il generale Cavallero. Giunto con l’intenzione di ritirare ritrattare le dimissioni, Badoglio non può che confermarle e ritirarsi nella sua residenza di Grazzano Monferrato, in attesa che la storia gli offra una nuova occasione di protagonismo.
Qualche giorno dopo, il 7 dicembre, l’epurazione si estende alla Marina, dove viene rimosso l’ammiraglio Domenico Cavagnari, capo di stato maggiore e sottosegretario, che paga la notte di Taranto e, in generale, l’atteggiamento passivo della flotta; al suo posto viene nominato l’ammiraglio Arturo Riccardi. Il 9 è la volta di Inigo Campioni, rimosso dal comando della squadra navale dove gli succede Angelo Iachino (anche se Campioni non verrà scaricato ma nominato sottocapo di stato maggiore, incarico da cui sarà rimosso nell’estate del 1941). Scompare dalla scena politico-militare anche il vecchio quadrumviro Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, da quattro anni

97
governatore della colonia delle Isole italiane dell’Egeo, sostituito nel Dodecaneso dal generale Ettore Bastico e costretto a ritirarsi a vita privata a Torino (da dove si muoverà solo il 25 luglio 1943 per partecipare alla decisiva riunione del Gran Consiglio, organismo di cui ha continuato a far parte).
La stampa di partito si scatena negli attacchi a Badoglio, le accuse di incapacità si trasformano presto in sospetti di «tradimento» e di «intesa col nemico»: oltre a Farinacci, si distingue nelle denunce Adelchi Serena, che ha da poco sostituito Ettore Muti nella segreteria del PNF, e che sprigiona una prosa velenosa e allusiva. Per fare abbassare i toni è costretto a intervenire lo stesso Mussolini, preoccupato che le esagerazioni siano controproducenti e approfondiscano le distanze tra regime e militari. La rivoluzione al vertice deve infatti servire a inaugurare una stagione nuova e il duce è convinto di aver trovato l’uomo giusto, il personaggio forte a cui affidare il riscatto. È il generale Ugo Cavallero, nato a Casale Monferrato nel 1880, veterano della guerra di Libia e della Grande guerra, con alle spalle una carriera di successo tra esercito e industria privata: sottosegretario alla Guerra dal 1925 al 1928, poi amministratore delegato del gruppo Ansaldo, quindi richiamato in servizio e nominato comandante delle truppe in AOI alle dipendenze di Amedeo d’Aosta. Cavallero è un militare sui generis, più attento alla politica che alle faccende marziali, sospettato di discutibili trascorsi affaristici. Non gli mancano i nemici, tra i quali Bottai che lo bolla come «un perfetto venditore di vasetti che ha trovato le vie segrete del cuore di Mussolini, un ottimista di maniera, ipocrita, che farebbe riverenze anche ai vespasiani».22 Ha però amici influenti: i tedeschi lo considerano il miglior amico del Reich nell’esercito italiano, Enno von Rintelen (rappresentante della Wehrmacht presso il Comando supremo) afferma che «nei limiti delle sue possibilità egli viene sempre incontro a tutti i desideri tedeschi».23 Soprattutto, Cavallero è un uomo intelligente, di ottime relazioni sociali, buon organizzatore sul campo, certo più adatto alla guerra industriale moderna dei vari Badoglio o Graziani che, al suo confronto, sembrano uomini di altri tempi.
Prima di affidargli il Comando supremo, Mussolini lo invia in Albania per constatare sul campo la situazione: le notizie che arrivano sono sempre più allarmanti, Soddu giudica che non ci sia possibilità di ripresa con le armi e auspica una «soluzione politica», intendendo per tale un armistizio con i Greci mediato da Hitler; Ciano riconosce che le zone di Valona e Durazzo (i due porti attraverso cui passano i

98
rifornimenti dalla madrepatria) sono investite dal nemico e che «le nostre truppe hanno dietro le spalle il mare».24 Cavallero è meno pessimista: secondo lui le posizioni possono essere tenute per alcuni giorni e l’invio dall’Italia di due divisioni complete di armamento ed equipaggiamento può bastare per stabilizzare il fronte. Mussolini vorrebbe lasciare a Cavallero il comando del fronte greco-albanese, ma un ulteriore cambio al vertice è difficile da sostenere perché Soddu ha sostituito Visconti Prasca appena un mese prima.
Nel corso delle settimane di dicembre si trascina così una situazione difficile e pericolosa: incursioni dei Greci, che conquistano posizioni, raggiungono Porto Palermo, arrivano a Elbasan (54 chilometri da Tirana), minacciano Durazzo; dall’altra parte, difese affannose del Regio Esercito, continue richieste di rinforzi da parte dei comandanti Vercellino, Geloso e Soddu, panico a Palazzo Venezia dove si pensa persino di mandare Ciano a Berlino per chiedere l’aiuto urgente di reparti germanici. Intanto si registrano movimenti navali che fanno temere uno sbarco inglese a sostegno delle truppe greche. Il 26 dicembre il duce decide di richiamare Soddu a Roma e di conferire il comando a Cavallero, che poche ore dopo parte per Tirana. A Roma si vivono i momenti più difficili da quando il fascismo è arrivato al potere, e lo dimostra una decisione improvvisa del duce, a metà strada tra il rancore e la demagogia: dall’inizio di gennaio i gerarchi lasceranno i loro incarichi ministeriali e andranno al fronte per dimostrare alla nazione che il regime non fa favoritismi a nessuno. Ciano, Pavolini e Riccardi in aviazione, Grandi, Ricci, Starace, Biggini, Bottai in reparti di fanteria sul fronte greco.
Quando li vede apparire al comando del suo corpo d’armata, il generale Gabriele Nasci dice ciò che pensa l’uomo della strada: «Se a Roma possono farne a meno, perché non li hanno mandati prima? E se non servono, perché li mandano qui che c’è da fare?».25 Al fronte gli uomini del regime resteranno quattro mesi, senza distinguersi né per coraggio né per doti militari: solo Bottai assumerà un comando effettivo, esercitandolo con dignità e confermando anche sul campo di essere uno degli elementi migliori della classe dirigente fascista. «Volontarizzati» per forza, essi portano al fronte le rughe di un regime che, alla prova della guerra, vede la distanza tra i proclami e la realtà, come scrive Ciano prima di raggiungere il 6o stormo a Bari:
Parto con poca convinzione e di conseguenza anche con entusiasmo ancor minore. Tutti i camerati la pensano così e molti non lo nascondono: Grandi non pensava di tornarsene, a quarantacinque anni, a pestare la neve con gli scarponi da alpino, tanto vecchi ch’egli li considerava ormai fuori uso.26

99
Diverso, invece, l’impatto di Cavallero:
Egli porta in uno stato maggiore abulico e demoralizzato il suo attivismo, le sue qualità di manager. Tutto è da rifare, tutto da riordinare. I servizi logistici devono essere fatti, più che rifatti; le strade sono impraticabili e vengono reclutati operai albanesi per la manutenzione; il porto di Durazzo, che in novembre ha ricevuto solo 1100 tonnellate al giorno, viene attrezzato con nuovi pontili per arrivare alle 3000; nel Nord viene migliorato il porto di San Giovanni di Medua, adeguatamente protetto con difese antiaeree. Sulla linea del fronte si decide l’attestamento su posizioni difendibili, anche se questo comporta il sacrificio di parte ulteriore del territorio: si migliorano le trasmissioni, per poter stabilire i collegamenti tra i reparti; l’arrivo di unità equipaggiate dall’Italia (le divisioni «Arezzo», «Cagliari», «Cuneense») permette la sostituzione delle unità più provate. La stagione invernale contribuisce alla stabilizzazione del fronte, sconsigliando i greci dall’attaccare in profondità e limitando le ostilità a scontri di prima linea. Il resto lo fa la politica internazionale, con il timore del governo Metaxas per un possibile intervento germanico dalla Bulgaria e la mobilitazione di truppe a difesa di quel confine.27
I greci tentano un’offensiva a gennaio su Berat (nell’Albania meridionale, a ridosso di Valona) e a febbraio su Tepeleni Tepelenë (nella prefettura di Argirocastro), ma si tratta di azioni poco incisive perché l’esercito ellenico è a sua volta esausto e la battaglia di arresto ha successo. Quello che Cavallero chiama con orgoglio fascista il «muro», 250 chilometri di linea difensiva dal mare al lago di Ocrida, sembra reggere all’urto e scongiurare un ripiegamento disonorevole verso le navi. Ciò che il Regio Esercito non riesce a fare sono le azioni di attacco: quando Cavallero e Mussolini decidono, in marzo, un’offensiva di media potenza lungo la valle Deshnice Dëshnicë per risollevare l’immagine della guerra fascista, la fanteria si butta in avanti preceduta dal fuoco di artiglieria senza riuscire a superare i trinceramenti greci e l’attacco si arena dopo due giorni di combattimenti tanto aspri quanto inutili. Potrebbe riaprirsi la situazione dell’ottobre precedente, ma il quadro internazionale sta cambiando: la Germania di Hitler prende l’iniziativa nei Balcani dove tra poco inizierà una guerra diversa, con altri protagonisti e con il Regio Esercito agli ordini della Wehrmacht.
Gli inglesi in Cirenaica
Le sconfitte dell’inverno 1940-41 non risparmiano nessun fronte e all’inizio di dicembre tocca all’Africa settentrionale. Da metà settembre Graziani ha dedicato energie e risorse a fortificare le posizioni di Sidi el-Barrani prima di una nuova avanzata. Il suo

100
dispositivo è l’ordinaria amministrazione delle guerre coloniali nordafricane, lo stesso già sperimentato dal maresciallo in Libia e dai francesi in Algeria: grandi campi trincerati, posti in genere su un’elevazione del terreno e cinti da un muro di pietre, e, dentro, dormitori, ospedali da campo, scuderie, magazzini, mense. Ci sono grossi presidi nelle piazzeforti della litoranea e da ognuna si irradiano le piste verso le posizioni fortificate dell’interno, in un sistema rigido, esposto alle manovre aggiranti delle colonne motorizzate.
È un modello difensivo vecchio, che non tiene conto della mobilità introdotta dalle innovazioni tecnologiche. Graziani e il suo stato maggiore sono culturalmente estranei alla modernità e lo dimostrano in alcune scelte particolari. Poiché siamo in pieno deserto, la priorità è garantirsi i rifornimenti d’acqua e i soldati vengono impiegati per settimane a costruire un acquedotto di 120 chilometri, per il quale è necessario requisire tutti i tubi disponibili sottraendoli all’irrigazione civile: un esercito moderno dovrebbe invece organizzare ricerche nella falda freatica, scavare pozzi, oppure organizzare un servizio di piccolo cabotaggio con bettoline che navigano lungo la costa (come in effetti fanno gli inglesi). Insieme all’acquedotto, avanza verso Sidi el-Barrani la strada litoranea, un’opera ambiziosa, molto larga, con massicciata regolare e copertura d’asfalto: più che il frutto dell’emergenza bellica, sembra una via consolare concepita per rivaleggiare con la «via Balbia» (costruita però da Italo Balbo in tempo di pace).
Mussolini sollecita ripetutamente il maresciallo a proseguire l’offensiva, nella consapevolezza che il tempo passato dagli italiani a preparare le difese è tempo guadagnato dagli inglesi per far affluire rinforzi. In una lettera del 26 ottobre, alla vigilia dell’attacco alla Grecia, i suoi toni sono sferzanti:
A quaranta giorni dalla presa di Sidi el-Barrani io mi pongo questo quesito: questa lunga sosta a chi ha giovato? A noi o agli inglesi? Non esito un minuto solo a rispondere: ha giovato di più, anzi esclusivamente, al nemico che ha accumulato tali forze e tali mezzi nel Delta da rendere infinitamente più oneroso il nostro attacco.28
Le pressioni del duce cadono però nel vuoto: la formazione dei quadri militari italiani rimane ancorata agli schemi della Grande guerra e anche gli ufficiali come Graziani, che sembrano conformarsi al modello dell’arditismo fascista, sul piano tattico sono estranei alle manovre audaci. L’armata del deserto resta ferma, preoccupata dalla forza del nemico: le informazioni del SIM (il servizio segreto del Regio Esercito) parlano di due divisioni corazzate dotate di 250 carri medi e

101
pesanti, 800 apparecchi, 7 divisioni di fanteria indiane e australiane, più altre divisioni in Grecia e in Palestina pronte a intervenire. A fronte di questo spiegamento, il Regio Esercito schiera 220.000 uomini con 125 aerei da bombardamento e 300 carri leggeri L/3. La forza degli inglesi è in realtà molto inferiore: tra il canale di Suez e il fronte italiano essi hanno la 7a divisione corazzata, la 4a divisione di fanteria indiana e una mista neozelandese-sudafricana; gli aerei schierati sono la metà di quelli ipotizzati dal SIM, i carri armati pesanti poco più di 50, quelli medi 175. La differenza di fondo sta nelle caratteristiche tecniche dei mezzi corazzati: mentre i tank britannici sono armati con cannoni da 37 millimetri e, sebbene lenti, sprigionano una forza di fuoco imponente, i nostri L/3 sono veloci ma con una corazzatura fragile e armati solo di mitragliatrici (verranno infatti chiamati ironicamente «tankette»). Nel momento dell’ingaggio, gli L/3
possono solo manovrare per sfuggire ai colpi nemici, ma non hanno capacità di vera offesa e se vengono raggiunti dai proiettili controcarro non hanno scampo.
In settembre il generale Archibald Percival Wavell, dal 1939 a capo del Middle East Command con responsabilità su Medio Oriente, Africa e Balcani, ha temuto che Graziani marciasse subito su Marsa Matruh e ha predisposto un piano di contenimento flessibile, con azioni manovrate e contrattacchi locali per rallentare l’avanzata: in questa prospettiva si sono preparati i reparti della Wester Desert Force, le tre divisioni operanti in Egitto al comando del tenente generale Richard O’Connor. Di fronte all’inattesa stasi operativa, Wavell e O’Connor hanno il tempo per rinforzare le loro posizioni e predisporre un contrattacco (denominato «Operazione Compass») che ha come obiettivo minimo quello di scompaginare i preparativi italiani e come obiettivo massimo quello di riprendere Sidi el-Barrani. La premessa del piano è che pattuglie esploranti britanniche hanno accertato l’esistenza di una vasta zona sguarnita nel dispositivo italiano tra Sofafi e Nibeiwa, (avamposti di Sidi el-Barrani verso il deserto meridionale), un varco molto grande nel quale deve cercare di inserirsi la 7a divisione corazzata per raggiungere la costa; contemporaneamente a questa manovra avvolgente, la 4a divisione indiana attaccherà frontalmente Sidi el-Barrani, appoggiata dal mare dalla flotta di Cunningham.
Nella notte tra l’8 e il 9 dicembre gli inglesi compiono l’avvicinamento alle nostre linee, con un balzo in avanti di 100 chilometri, senza essere avvistati dall’unico ricognitore in volo. Solo all’1.30 di notte il comando della 1a divisione libica segnala una

102
insolita prolungata attività aerea del nemico, e alle 3.00 Graziani mette in stato d’allarme le fanterie e ordina all’aviazione di tenersi pronta al decollo. L’attacco britannico scatta all’alba e sortisce effetti devastanti, con le linee italiane presto sbandate e in ritirata. Sull’esito della battaglia incidono la sorpresa strategica, perché il Regio Esercito è convinto di doversi preparare a una futura offensiva ed è costretto invece a fronteggiare un attacco, e la sorpresa tattica, per la mancata segnalazione dell’avanzata nemica e la mobilitazione tardiva, ma ancor più incidono la superiorità dei mezzi corazzati britannici, la cooperazione tra forze terrestri e navali, la capacità di manovrare negli spazi del Sahara:
La fanteria inglese punta su Nibeiwa, dal nord, le colonne corazzate dal sud e ogni resistenza è subito travolta. Il generale Pietro Maletti, al comando di uno speciale raggruppamento libico intitolato al suo nome, viene colpito e muore accanto a una mitragliatrice. I nostri carri L/3 vanno al contrattacco in tre ondate successive e saltano come scatole di fiammiferi colpiti dagli obici inglesi; la 7a corazzata britannica continua a salire come un rullo compressore alla velocità media di 20 km/h, perché i carri pesanti non devono perdere il contatto, e risulta travolgente per reparti che non sanno come contrastarla e presto si ritirano. Machtila[non riesco a trovare questa grafia], sulla costa, è schiacciata dalle cannonate delle navi da battaglia e praticamente rasa al suolo. [manca fonte]
Il risultato sul campo induce O’Connor a mutare il piano tattico e ad anticipare l’attacco a Sidi el-Barrani penetrando dal deserto, senza aspettare lo schieramento sulla costa della 4a divisione indiana. La prontezza delle decisioni e la capacità di cogliere le opportunità senza aspettare autorizzazioni dall’alto è, da sempre, l’elemento vincente in battaglia:
Le truppe corazzate investono la cittadina e sotto i colpi di cannone la sabbia finissima si alza come una nebbia che riduce la visibilità a 50 metri; i difensori vedono sbucare all’improvviso la sagoma tozza del carro che si avventa a schiacciare uomini e armi; le colonne attaccanti aggirano i capisaldi, penetrano nel cuore della piazzaforte. [manca fonte]
Alle 10.30 il generale Sebastiano Gallina si arrende con tutto il suo stato maggiore e gli inglesi lo trasferiscono in aereo al Cairo, utilissimo alla propaganda di guerra britannica perché testimonianza di una vittoria che si va allargando oltre ogni previsione.29 Frattanto un’intera divisione motorizzata, la «Catanzaro», viene bloccata dalle avanguardie corazzate del generale Paul Michael O’Moore Creagh, mentre marcia verso Sidi el-Barrani su quella che è stata affrettatamente battezzata la «via della vittoria». Visti annientati i

103
pochi carri della scorta, i fanti si ritirano verso Bardia, in territorio libico, ma una parte di loro si sbanda e si arrende praticamente senza combattere: oltre duemila uomini vengono avviati ai campi di prigionia scortati da poche guardie armate, altra immagine spendibile per la propaganda nemica e per la guerra psicologica. L’11 dicembre tutte le posizioni fortificate costruite oltre il confine libico sono conquistate dagli inglesi.
Il crollo repentino del primo schieramento semina il disorientamento nel comando italiano. Graziani scrive il 12 dicembre a Mussolini che «minaccia travolgimento intero fronte cirenaico est palese» e medita un ripiegamento generale delle sue forze verso la Tripolitania. In realtà le piazzeforti del litorale cirenaico – Bardia, Tobruk, Derna – non sono ancora investite dall’attacco e ci sono margini di difesa. Mussolini, alle prese in quegli stessi giorni con la rivoluzione ai vertici delle forze armate e con i rovesci in Grecia, oscilla tra l’indignazione e lo sforzo di spronare: «Fra Bardia e Tobruk vi sono cannoni e uomini sufficienti per infrangere l’attacco nemico». Ciano è sbigottito:
Graziani telegrafa poco e senza precisione, non sappiamo come stiano davvero le cose in Africa. Sono passati quattro giorni dall’attacco inglese, ma il maresciallo non si è ancora ripreso dal colpo subito e d’altro lato pare che i suoi nervi fossero molto scossi fin dall’attentato a Addis Abeba.30
Qualche giorno dopo, il 15 dicembre, i toni sono ancora più drammatici: dopo aver scritto alla moglie inviandole le proprie disposizioni testamentarie e dicendole che «con le unghie non si possono spezzare le corazze»,31 il maresciallo si rivolge di nuovo a Mussolini dichiarando di essere «nelle condizioni di un capitano che comanda una nave in procinto di affondare perché presenta falle da ogni parte». L’ipotesi è di ritirarsi sino fino a Tripoli e di asserragliarsi nella piazzaforte per combattere «sino all’ultimo soldato» perché il confronto sul campo è impari ed è impossibile «sostenere la lotta della pulce contro l’elefante. Duce, la salvezza della Libia oggi è solo affidata alla volontà del nemico, al fatto che decida di attaccare subito o ritardare l’avanzata».32 Mescolando retorica, pessimismo e denuncia, Graziani si abbandona ad affermazioni gravi, soprattutto perché fatte da un uomo di vertice del gruppo dirigente militare, che ha condiviso sino a poco prima le scelte del regime. Ciano è sferzante:
Graziani è sconvolto e non sa prendere decisioni. Mi hanno raccontato che ha sempre avuto tanta paura degli attentati e in Italia faceva circondare la villa di

104
Arcinazzo da ben diciotto carabinieri di guardia. In Libia si è fatto un rifugio in una tomba romana a Cirene, profonda venti o trenta metri.
Mussolini non è da meno: «Ecco un altro uomo col quale non posso arrabbiarmi perché lo disprezzo».33
L’immagine di un comandante nascosto in una tomba romana è poco marziale e ancor meno fascista, ma sostituire Graziani nel dicembre 1940 è politicamente difficile. La rivoluzione ai vertici militari è servita per scaricare sugli stati maggiori le responsabilità delle sconfitte, rimuovere il maresciallo (il cui nome nell’immaginario collettivo è legato alla riconquista fascista della Libia) rischierebbe di confondere i contorni dell’operazione e coinvolgere il regime. Nel panorama delle alte gerarchie del Regio Esercito, d’altra parte, non emergono nomi particolarmente affidabili sui quali puntare. Graziani resta dunque al suo posto di comando e la campagna nell’Africa settentrionale prosegue sulla falsariga di quanto accaduto il 9-11 dicembre a Sidi el-Barrani: impostazione rigida della difesa, predisposizioni fortificatorie incomplete, inferiorità nell’armamento pesante.
La prima posizione in territorio libico a cadere è Bardia, pochi chilometri oltre il confine: a presidiarla ci sono 45.000 uomini al comando del generale Annibale Bergonzoli, soprannominato «barba elettrica» per il suo dinamismo, ma le difese sono modeste, il fosso anticarro è stato scavato in fretta e risulta poco profondo, i carri armati disponibili sono soltanto 37. L’attacco frontale viene portato il 2 gennaio dalla 7a divisione corazzata e dalla 6a divisione australiana del generale Iven Mackay (che ha sostituito la 4a divisione indiana),34 in tutto 22.000 uomini con 26 carri pesanti e quasi 150 pezzi d’artiglieria. Prima dell’inizio della manovra terrestre, l’aviazione inglese ha sorpreso quella italiana nei diversi aeroporti libici, distruggendo a terra 74 apparecchi: i pochi velivoli che riescono a decollare non sono in grado di incidere sull’esito della battaglia perché ormai il dominio dell’aria è nelle mani della RAF. L’assalto a Bardia dura tre giorni, il Regio Esercito, al di là di episodi isolati e individuali, si difende senza coordinamento e senza energia: tra le truppe si è diffuso lo scoramento, l’idea che i carri armati inglesi siano indistruttibili si è ingigantita da un discorso all’altro, il pessimismo di Graziani si è trasmesso a tutti i livelli di comando.
In una battaglia moderna il coefficiente morale non è elemento decisivo, ma sicuramente contribuisce sulla volontà di resistenza: in Africa settentrionale, ormai, nessuno vuole sacrificarsi in scontri dall’esito scontato, quando i carri inglesi avanzano il dispositivo si

105
sgretola, gli artiglieri abbandonano i pezzi, i fanti alzano le mani o sventolano la bandiera bianca della resa. Bardia cade il 5 gennaio e 30.000 soldati vengono fatti prigionieri. O’Connor non ha neppure bisogno di accelerare i tempi: per raggiungere Tobruk impiega quindici giorni senza essere infastidito dall’aviazione (il generale Porro non vuole arrischiare i 50 bombardieri e i 40 caccia rimasti in Africa, riservandoli all’estrema difesa di Tripoli) e occupa la città il 22 gennaio dopo un solo giorno di attacco; il 31 entra a Derna, 100 chilometri più a ovest, evacuata da Graziani per evitare l’accerchiamento; il 5 febbraio elimina un centinaio di carri superstiti a Beda Fomm, mentre aerei bombardano Bengasi; il 6 accerchia le truppe italiane in ripiegamento, una parte delle quali riesce ad aprirsi un varco (nello scontro muore il generale Giuseppe Tellera, capo di SM di Graziani), ma i più sono fatti prigionieri (tra loro il generale Bergonzoli, che era riuscito a evitare la cattura a Bardia); il 7 entra a Bengasi, capitale della Cirenaica e seconda città della Libia, anch’essa evacuata prima dell’attacco.
I dati della vittoria inglese sono eclatanti: 130.000 prigionieri, 1300 cannoni e 400 carri distrutti o catturati, migliaia di automezzi messi fuori combattimento, una penetrazione di centinaia di chilometri, a fronte di soli 2000 britannici morti o feriti.
Fu la peggiore delle sconfitte italiane, per di più ampiamente mediatizzata: i filmati delle interminabili colonne di prigionieri, cenciosi e disorientati come tutti i prigionieri, fecero il giro del mondo, consolidando lo stereotipo dell’italiano che non si batte. Da parte inglese tutto funzionò al meglio. Le difese statiche italiane furono sopraffatte dalla combinazione dell’attacco frontale dei carri e della fanteria e dell’aggiramento di forze corazzate mobili ben addestrate al movimento in ambienti desertico. Dalla parte italiana tutto funzionò al peggio, da Graziani ai comandi sempre incapaci di iniziativa, fino alle truppe poco addestrate, male impiegate e presto rassegnate alla sconfitta contro gli invincibili inglesi.35
Nessun comandante e nessun osservatore britannico aveva previsto un crollo così repentino da parte del Regio Esercito: l’avanzata è stata quasi automatica, come «risucchiata» dai vuoti della difesa. Giunto davanti al deserto della Sirte, O’Connor decide di fermarsi per raccogliere e riorganizzare le sue forze e il suo superiore Wavell concorda: forse l’intelligence britannica sa che in quelle stesse ore è salpato da Napoli un convoglio che trasporterà a Tripoli i primi reparti tedeschi destinati alla costituzione del Deutsche Africa Korps; o forse, più semplicemente, i comandanti britannici ritengono di dover stabilizzare la conquista non programmata di un territorio tanto vasto. L’arresto dell’avanzata non cambia comunque la situazione del Regio

106
Esercito, dove Graziani presenta le proprie dimissioni: «Duce, gli ultimi avvenimenti hanno fortemente depresso i miei nervi e le mie forze, tanto da non consentirmi di tenere più il comando nella pienezza delle mie facoltà. Vi chiedo pertanto di essere richiamato e sostituito». Mussolini dapprima prende tempo, poi lo richiama a Roma e lo congeda, affidando il comando al generale Italo Gariboldi, un ufficiale non più giovane (è nato a Lodi nel 1879) e dalla carriera prestigiosa ma non rapida, che è in Libia dall’inizio della campagna e che da metà dicembre è a capo della X armata: la sostituzione di un comandante con un suo subalterno è prassi insolita, che evidenzia il carattere punitivo del provvedimento e che spiega l’istituzione, poco dopo, di una commissione d’inchiesta sull’operato del maresciallo.36
Su Graziani (che trascorrerà gli anni successivi a Roma senza incarichi, per poi rilanciarsi politicamente con l’adesione alla Repubblica di Salò) sono stati espressi giudizi severi. Giorgio Bocca lo descrive come un ufficiale che
fa spicco nella modesta schiera dei comandi superiori con il suo italiano da fureria, l’umorismo involontario, la boria di chi si pone, essendo una nullità, a misura della storia; egli è il peggio del classismo conservatore del gruppo piemontese e dell’arditismo fascistico alla Muti. Graziani è la piccola borghesia agraria, permeata di patriottismo astratto, disponibile a ogni esperienza totalitaria, spavalda nel successo, pallida e lacrimosa nelle avversità.37
Il suo comportamento in Libia è certamente deficitario sul piano strategico, così come lo è nelle comunicazioni con Roma, sospese tra la protesta e la paura. La sconfitta in Africa settentrionale va però al di là delle responsabilità individuali: nella sua radicalità, essa è la punta di diamante di una profonda crisi di sistema e la dimostrazione definitiva che l’Italia fascista non è in grado di combattere una guerra parallela a quella tedesca, neppure su fronti secondari (come l’Africa) o contro nemici di secondo piano (come la Grecia). Mentre a Berlino si comincia a pensare che l’Italia stia contribuendo a far perdere una guerra già vinta, da Roma partono le richieste di aiuto militare diretto come «estrema ratio» per evitare il tracollo.
Dal cannoneggiamento di Genova alla battaglia di Capo Matapan
Mentre le operazioni procedono trionfalmente in Africa, la flotta inglese prepara un’altra azione spettacolare come quella di Taranto, da realizzarsi nel cuore dei mari italiani. L’ammiraglio James F. Somerville, comandante delle forze navali di Gibilterra (denominate

107
«Forza H»), predispone un piano per colpire il porto di Genova e infliggere alla Regia Marina un grave scacco politico-strategico andando a sfidarla nelle sue acque più interne.
Approvato da Cunningham e sostenuto con convinzione dallo stesso Churchill per le possibili ricadute mediatiche, l’attacco viene sferrato il 9 febbraio: la Forza H, dopo aver attraversato nottetempo il canale tra Maiorca e Minorca, si affaccia nel golfo di Genova all’altezza di Rapallo e punta verso ponente. Il grosso della flotta italiana è concentrato a La Spezia, dove alle prime luci dell’alba si registra un attacco dell’aviazione inglese con apparecchi decollati dalla portaerei Ark Royal, ai quali risponde la contraerea: si tratta di un’azione diversiva per confondere gli italiani e «coprire» l’obiettivo principale. Le navi non subiscono danni e l’ammiraglio Iachino, temendo l’arrivo di successive ondate di bombardieri, ordina alla flotta di prendere il largo dirigendosi verso la Corsica, ma solo alle 7.30 riceve informazioni sulla presenza di unità nemiche in avvicinamento a Genova. Come a novembre nella notte di Taranto, il malfunzionamento del sistema di ricognizione e di avvistamento permette alla Royal Navy di arrivare indisturbata a poche miglia dalla costa. Alle 8.15 inizia il cannoneggiamento inglese da una distanza di circa 18.000 metri: l’incrociatore da battaglia Renown mette sotto tiro i cantieri navali di Sestri Ponente, la corazzata Malaya la zona portuale e i bacini di carenaggio, l’incrociatore Scheffield gli impianti industriali della Val Polcevera. Alle 8.45 l’azione di fuoco finisce e la Forza H si dirige a sud, riunendosi alla portaerei Ark Royal e alla sua scorta:
L’ammiraglio Iachino incrocia in una zona quanto mai propizia per intercettare il nemico di ritorno dalle acque liguri, perché fra la Corsica e la costa francese vi sono appena 80 miglia, ma la notizia del bombardamento su Genova lo raggiunge solo alle ore 9.00 e le navi inglesi sono segnalate in navigazione verso ovest mentre stanno dirigendosi a sud.38
Il risultato è che Sommerville può fare rotta verso Gibilterra, dove rientra indisturbato il giorno dopo, mentre in Italia si contano i danni: quasi 300 vittime civili, oltre ai danni materiali agli impianti e una imbarazzante dimostrazione di fragilità difensiva e di impotenza.
Il colpo più grave alla Regia Marina viene inflitto a fine marzo a Capo Matapan, al largo del Peloponneso. La corazzata Vittorio Veneto, seguita da una squadra di incrociatori pesanti e da una di incrociatori leggeri, oltreché da numerosi cacciatorpediniere, si spinge verso Creta per intercettare il traffico britannico tra l’Egitto e la Grecia. Si tratta di operazioni sollecitate dai tedeschi, i quali stanno

108
preparando l’invasione nei Balcani e non vogliono che siano rafforzate le difese nemiche: in un incontro di qualche settimana prima a Merano l’ammiraglio Erich Raeder ha accusato il collega Riccardi di atteggiamento dimesso verso la Royal Navy e i vertici navali italiani, pungolati nell’orgoglio, hanno reagito predisponendo un piano, curato dallo stesso capo di SM, che prevede due incursioni offensive, una a nord e una a sud di Creta.
L’intera operazione è affidata al fattore sorpresa, perché se le navi italiane vengono avvistate prima di arrivare nelle acque di Creta, la Royal Navy avrebbe il tempo di far allontanare i convogli mercantili e intercettare il nemico con la Mediterranean Fleet di stanza ad Alessandria d’Egitto. Indipendentemente da quanto risulterà molto più tardi (e cioè che gli inglesi hanno decrittato i radiomessaggi della Luftwaffe e forse sono a conoscenza anche degli ordini di operazione italiani), sarebbe prudente rientrare già il 27 marzo, quando un ricognitore nemico avvista le forze della Regia Marina in avvicinamento e sfuma così la possibilità di sorprendere il nemico. Iachino, che guida l’operazione dalla nave ammiraglia Vittorio Veneto, decide tuttavia di proseguire: la pressione politica è tale che desistere potrebbe risultare un’ulteriore prova di debolezza e il malinteso senso del prestigio finisce per condizionare le considerazioni tattiche. Un primo scontro con incrociatori britannici avviene presso l’isoletta di Gaudo, a sud di Creta, nella mattinata del 28: l’avanguardia italiana, comandata dall’ammiraglio Luigi Sansonetti, colpisce gli incrociatori Orion e Gloucester, prima di essere a sua volta attaccata da aerosiluranti. L’arrivo dell’aviazione britannica induce Iachino a non far proseguire l’azione verso levante, e a concentrare le forze a nord dell’isola, nel braccio di mare tra Creta e il Peloponneso, mentre le navi inglesi colpite guadagnano la rada di Alessandria.
I movimenti della flotta italiana e la presenza di grandi unità sono però noti alla Royal Navy, sia per le intercettazioni, sia per gli avvistamenti. Nel pomeriggio del 28 Cunnigham ordina un attacco combinato di bombardieri in quota e di aerosiluranti, che si alzano in volo senza contrasto da parte dell’aviazione italiana nell’Egeo. Un aerosilurante del tipo Albacore, decollato dalla portaerei Formidable, riesce ad avvicinarsi alla Vittorio Veneto e lanciare un siluro prima di essere a sua volta abbattuto dalla contraerea. La corazzata viene colpita all’elica esterna di sinistra e si ferma: bloccato uno dei timoni è bloccato e sono state imbarcate 4000 tonnellate d’acqua, con appoppamento e un lieve sbandamento sulla sinistra. La nave riesce a

109
rimettersi in moto dopo pochi minuti, ma la velocità è ridotta a 16 nodi. Iachino chiede ripetutamente la copertura aerea della Regia Aeronautica e della Luftwaffe e predispone la sua formazione per rientrare verso le basi dell’Italia meridionale: i danni alla corazzata sono rilevanti e per evitarne l’affondamento bisogna raggiungere al più presto un porto amico.
Gli aiuti aerei ritardano e Cunningham approfitta per un secondo attacco contro le navi in ritirata: alle 19.28 un altro aerosilurante colpisce a poppa l’incrociatore pesante Pola, mettendo fuori uso tutto l’impianto elettrico e impedendo alla nave qualsiasi attività di bordo. Quando Iachino viene informato delle condizioni del Pola, fermo in mezzo al mare e isolato dal resto della flotta, decide di distaccare l’intera I divisione, comandata dall’ammiraglio Carlo Cattaneo, per andare a soccorrerlo. «Inviare un’intera divisione navale per tentare il rimorchio di una sola unità, quando, da un punto di vista della nautica e della manovra, sarebbero state sufficienti due cacciatorpediniere, è un errore tattico drammatico»,[manca nota] tanto che Cattaneo chiede due volte conferma. Certamente Iachino non ha capito di trovarsi a contatto con il grosso della Mediterranean Fleet, sottovalutando il fatto che gli apparecchi britannici sono partiti da una portaerei e quindi in zona ci devono essere le grandi navi da battaglia, perché gli inglesi non lasciano mai le loro portaerei senza la maggior protezione possibile. Di fronte alla reiterazione dell’ordine, Cattaneo comanda comunque alle navi di invertire la rotta e tornare indietro verso sudest, alla ricerca del Pola: in questo modo egli va diritto nella bocca della Mediterranean Fleet, che è in acqua con tutta la sua potenza di fuoco.
Lo scontro avviene al largo del Capo Matapan, dove le unità si incrociano nella notte, ed è uno scontro micidiale e brevissimo, quattro minuti di fuoco dalle 22.27 alle 22.31. Le unità italiane non hanno scampo e soccombono in un massacro di uomini e di mezzi, cinicamente (ma realisticamente) ribattezzato «il tiro a segno di Matapan»: 39 le corazzate Warspite e Valiant aprono il fuoco sull’incrociatore Fiume, che viene colpito in pieno da cinque proiettili sparati da 3500 metri di distanza, la Barham spara sull’altro incrociatore Zara; vengono colpiti e vanno in fiamme i cacciatorpediniere Vittorio Alfieri e Giosuè Carducci, oltre a naviglio minore. Mentre le altre navi italiane si sganciano frettolosamente dirigendosi verso ovest, il Mediterraneo davanti a Capo Matapan è un luccicare di fiamme, tra i corpi dei marinai feriti che annegano e le invocazioni dei naufraghi. Il cacciatorpediniere inglese Jervis, frattanto, individua nel buio la sagoma del Pola: accorgendosi che

110
l’equipaggio è a bordo, il comandante ne ordina l’evacuazione, poi silura la nave che affonda con una forte esplosione, mentre i suoi 250 marinai salgono prigionieri a bordo delle unità inglesi. Per qualche ora le unità britanniche perlustrano il mare con i riflettori, recuperando altri naufraghi, e finendo le navi già colpite con nuove bordate, che le fanno affondare definitivamente. All’alba vengono segnalati aerei della Luftwaffe in avvicinamento e Cunningham decide di rientrare, senza tentare l’inseguimento alla Vittorio Veneto e al resto della flotta italiana, che può così rientrare nei porti di Taranto e Brindisi (mentre la nave ospedale Gradisca salpa dalla Puglia in direzione opposta).
Quella di Capo Matapan è un’assurda notte in cui si sovrappongono errori strategici e tattici. Discutibile la decisione iniziale di Supermarina di agire per soddisfare interessi politici e pressioni germaniche, e ancor più discutibile impiegare una squadra da battaglia per condurre la guerra al traffico (che deve invece essere affidata a mezzi navali leggeri e veloci e all’aviazione); sbagliato proseguire l’operazione quando è venuto meno il fattore sorpresa; fatale la decisione di far tornare indietro un’intera divisione per raggiungere il Pola immobilizzato; gravissime la mancata copertura aerea, l’approssimazione delle segnalazioni, la sottovalutazione delle capacità reattive del nemico. Destinata ad alimentare polemiche e palleggiamenti di responsabilità nel dopoguerra, la battaglia di Capo Matapan costa alla Regia Marina 2303 marinai morti, tre incrociatori pesanti e due cacciatorpediniere affondati, una corazzata gravemente danneggiata e un colpo mortale all’immagine dell’Arma. La Mediterranean Fleet lamenta solo la perdita dell’incrociatore Bonaventure, colpito dal sommergibile Ambra del tenente di vascello Mario Arillo durante la navigazione di rientro.
L’Amba Alagi e l’impero che non si può difendere
I contraccolpi delle sconfitte in Africa settentrionale, in Grecia e in mare non tardano a farsi sentire in Africa orientale, dove i britannici, finita la stagione delle grandi piogge, si preparano all’offensiva. Truppe inglesi e sudanesi al comando del generale William Platt vengono destinate ad attaccare l’Eritrea, mentre in Kenia, sotto il comando del generale Alan Cunningham, vengono concentrate due divisioni africane e una sudafricana. Si tratta di reparti forniti di molta artiglieria moderna, carri armati medi e pesanti, aerei da bombardamento e da caccia, assai più numerosi e recenti di quelli italiani. In gennaio viene inoltre inviata dall’Egitto sul fronte eritreo la

111
4a divisione indiana, che era stata impegnata nella riconquista di Sidi el-Barrani. Il duca d’Aosta capisce che l’Impero è al tramonto, indifendibile da un attacco per l’insufficienza dei mezzi a disposizione, minato all’interno da una guerriglia che non ha mai cessato di agire e che dall’andamento della guerra ha tratto slancio e vigore (oltreché rinnovati rifornimenti di armi da parte degli inglesi). Amedeo è esplicito con Mussolini: in un lungo telegramma datato 16 dicembre 1940, egli scrive che
gli inglesi faranno convergere sul nostro fronte tutta la loro aviazione e probabilmente buona parte delle loro unità motorizzate per un colpo a fondo contro di noi che, riuscendo, segnerebbe il principio della fine dell’Impero. Come si vede, tutto fa credere che le poco liete previsioni da me formulate nei mesi scorsi minacciano di avverarsi. Quando saranno tornati gli apparecchi nemici, probabilmente inviati a rinforzo del Nord Africa, e se con essi verranno anche quelli che si trovano là, la nostra aviazione sarà messa fuori causa in breve tempo.
Con un sussulto di orgoglio patriottico, il duca assicura che «tutti gli italiani si batteranno fino all’ultimo sangue», ma non può fare a meno di ricordare che
se dovessimo cedere sotto l’urto di forze preponderanti, non so che cosa potrà succedere, perché tutta la nostra forza è imperniata su battaglioni indigeni. Di questi, gli eritrei e i somali di vecchia fedeltà si batteranno, ma gli altri, e sono la maggioranza, quando cominceranno a cedere crolleranno in pieno e ci abbandoneranno, se pure non passeranno dalla parte del nemico.40
Amedeo d’Aosta è facile profeta. Il 19 gennaio 1941 le forze britanniche avanzano nel bassopiano occidentale eritreo occupando Agordat dopo alcuni giorni di confusi combattimenti. La resistenza italiana si irrigidisce a Cheren, situata in una conca circondata da monti impervi, dove la difesa è ben diretta dal generale Nicola Carnimeo, uno dei migliori ufficiali italiani della Seconda guerra mondiale.41 La battaglia, iniziata il 2 febbraio, continua per una decina di giorni, durante i quali gli attacchi degli anglo-indiani vengono respinti con gravi perdite dei reparti italiani e di quelli italo-eritrei, e costringono il generale Platt a sospendere l’offensiva per un mese in attesa di rinforzi. L’attacco riprende però il 15 marzo e dopo dodici giorni gli italiani sono costretti ad abbandonare Cheren, posizione chiave per il possesso dell’Eritrea e dell’Abissinia settentrionale. La resistenza della piazzaforte da parte del generale Carnimeo è durata cinquantasei giorni, meritando gli elogi degli stessi inglesi.
Durante queste operazioni inziali, il duca d’Aosta dimostra un notevole coraggio personale che conferma il carattere ardimentoso al

112
quale ha legato negli anni precedenti la propria immagine pubblica, ma, contemporaneamente, palesa gravi limiti di comando. Incerto nelle decisioni da prendere, troppo spesso a consulto con i suoi generali quando servirebbe invece tempestività d’azione, esitante nell’applicare i piani predisposti, egli si rivela incapace di cogliere le urgenze tattiche e di concentrare le forze là dove lo scontro assume rilevanza strategica. Oltre vent’anni di carriera militare, spesi tra l’artiglieria e l’aviazione, non sono di per sé sufficienti a formare un vero comandante: 42 tra gli ufficiali ai suoi ordini, d’altra parte, nessuno è in grado di vincerne i dubbi e di supportarlo in modo adeguato. Egli imposta la difesa dell’AOI con quattro comandi di scacchiere affidati ai generali Luigi Frusci (settore Nord), Pietro Gazzera (settore Sud), Guglielmo Nasi (settore Est) e Gustavo Pesenti (settore Giuba, verso la Somalia). Scrive il 14 febbraio 1941 a Mussolini:
Per reggere bisogna reggere ovunque, perché se un solo pilastro cede, tutto l’edificio crolla quasi di colpo. Di fronte alla dura realtà informerò la mia azione a questi concetti: finché in ogni regione dell’Impero vi sarà la nostra bandiera, un comandante e un gruppo di soldati, l’Impero non potrà mai dirsi perduto.43
Orgogliosi sul piano delle dichiarazioni di principio, questi presupposti si rivelano fallimentari sul campo, portando a un colpevole frazionamento di forze che apre la strada alla vittoria britannica. Come annota il colonnello Giuseppe Pizzorno, capo di stato maggiore dello scacchiere Nord del generale Fusci, «avveniva che, mentre la battaglia infuriava al Nord, in Somalia, nel Gimma, nell’Amhara le forze erano pressoché intatte e un altro cospicuo numero di unità agguerrite restava immobilizzato nel Goggiam e nello Scioà Scioa per la sicurezza interna, in un impiego sterile e logorante».44 La caduta di Cheren (uno degli scontri più sanguinosi di tutta la Seconda guerra mondiale, che costa ad ambo le parti combattenti 50.000 tra morti e feriti) è la conseguenza dell’incapacità del duca di muoversi secondo una visione strategica d’insieme. Mentre il generale Platt concentra tutti i suoi sforzi nella conquista della posizione, Amedeo ne sottovaluta l’importanza e non manda i rinforzi necessari, pur disponendo di truppe non distanti occupate in operazioni minori: la difesa, che avrebbe potuto inchiodare le divisioni inglesi per un lungo periodo impedendo al comando britannico di trasferirle in Egitto per rafforzare il fronte dell’Africa settentrionale, si esaurisce così in meno di due settimane, preludendo al crollo definitivo dell’Impero.

113
Dopo la caduta di Cheren, il ripiegamento degli italiani diventa una ritirata spesso caotica, costellata di scontri confusi che comportano molte perdite, ma che non valgono a frenare l’avanzata nemica. Il generale Platt il 3 aprile occupa Asmara, il 7 raggiunge Massaua (dove cattura quanto resta della flotta italiana in AOI), e il giorno successivo entra a Addis Abeba, dove reinsedia come imperatore d’Etiopia Hailé Selassié. Frattanto, i reparti del generale Cunningham hanno iniziato il loro attacco sul fronte meridionale, muovendo dal Kenia: il 14 febbraio hanno occupato Chisimaio, quindi varcato il Giuba, incontrando una resistenza debolissima, e il 25 sono entrati a Mogadiscio. Dalla Somalia i britannici puntano su Harar, mentre altre truppe sbarcano nella Somalia settentrionale e altre ancora marciano verso Addis Abeba, dove si ricongiungono con i reparti di Platt che hanno operato nello scacchiere settentrionale. In due mesi è crollato l’Impero che Mussolini aveva proclamato tanto solennemente il 9 maggio 1936. Caduta Addis Abeba, le forze italiane superstiti si raccolgono in tre nuclei di resistenza: uno nel Gimma, guidato dal generale Gazzera, che capitolerà il 4 luglio; un secondo nel Goggiam, guidato dal generale Nasi, che resisterà sino al 27 novembre; un terzo, guidato dallo stesso duca d’Aosta, all’Amba Alagi.
Fra tutte le decisioni militari prese da Amedeo, la più inspiegabile e irrazionale resta quella di aver scelto come ultimo baluardo proprio l’Amba Alagi, che il maresciallo Caviglia definisce uno «scoglio senz’acqua e senza viveri». Anche se la posizione sembra una formidabile fortezza, ricca di gallerie e caverne naturali, essa è infatti aggirabile da ogni lato e per sopportare un attacco andrebbe in ogni caso fortificata, munita di artiglierie di grosso calibro e presidiata da forze ben più numerose delle poche migliaia di uomini che sono scampati al crollo dell’Eritrea. Difesa da alcuni biografi del duca come «estremo tentativo di sbarrare la via che consentiva a Platt di congiungersi con Cunningham e di impedire loro di accorrere subito in Egitto a difesa del canale» e bollata da altri come «una puerile mossa imprevidente, una ragazzata dal punto di vista militare», la decisione di ritirarsi sull’Amba Alagi viene presa all’ultimo momento, poco prima di abbandonare Addis Abeba il 3 aprile, ed è probabilmente «motivata da considerazioni storico-sentimentali, dal ricordo del maggiore Toselli e della sua disperata e sfortunata resistenza nel dicembre 1895».45
Il carattere del duca d’Aosta si accorda con una tale scelta di natura emotiva: di fronte al crollo di un’intera esperienza culturale e

114
umana, il raccordo con le tradizioni storiche che la retorica del Ventennio ha più celebrato sembra assumere un valore catartico (anche se, come sarà osservato, «Toselli si fece uccidere, mentre il Viceré capitolò arrendendosi, seppur onorevolmente, agli inglesi»46). Sotto il profilo militare, si tratta comunque di una scelta perdente e tatticamente improponibile: «Portarsi all’Amba Alagi e non in una località eccentrica al di fuori delle grandi strade, significava farsi catturare al più presto dal nemico irrompente».47 È quanto accade di lì a poco. Il 4 maggio il generale Edward Mosley Mayne inizia l’assedio, prima simulando un’azione verso il passo Falagà, sul fianco destro dello schieramento italiano, poi concentrando l’offensiva dalla parte opposta, verso il passo Togorà, sul fianco sinistro. Un forte contingente di guerriglieri etiopici, guidati da ras Sejum Mangascià, attacca frattanto da tergo, circondando i circa 7000 uomini al comando del duca, le cui posizioni sono sottoposte ai bombardamenti aerei e terrestri. Per qualche giorno la resistenza è vigorosa, animata dalla presenza stessa di Amedeo: «
Gli atteggiamenti del duca sono molto simili a quelli di Toselli. Lo stesso vitalismo, la stessa eccitazione, gli stessi impulsi romantici. Nel suo diario egli scrive: «Meglio vivere tra le cannonate, le pallottole, la terra e la sporcizia, che lindo e pulito con le gambe sotto al tavolo pieno di carte.48
L’8 mattina il ridotto dell’Amba Alagi è però completamente accerchiato e investito da ogni parte; il 13 ogni resistenza appare inutile e il giorno successivo lo stesso Mussolini autorizza il duca a trattare la resa «secondo quanto vi detta la vostra coscienza di uomo e di soldato». Il 17 (dopo che è caduto in un agguato anche il generale Giambattista Volpini, amico di vecchia data di Amedeo, e dopo che lo stesso viceré è stato ferito all’avambraccio da una scheggia di granata), viene firmato il documento che stabilisce le modalità della resa. «Rifiutatami la facoltà di restare sull’Amba, sia pure con l’impegno di cessare ogni ostilità contro gli inglesi» telegrafa il duca a Roma «ho ottenuto l’onore delle armi. Agli ufficiali sarà conservata permanentemente la pistola, le truppe nazionali e indigene rimaste fedeli sfileranno in armi dinanzi ai reparti inglesi che renderanno gli onori. Io seguo il mio destino confortato di aver fatto tutto il mio dovere».49 Il 19 maggio le truppe italiane, frazionate in scaglioni di trecento uomini che marciano a due minuti di distanza l’uno dall’altro, lasciano il forte Toselli sfilando tra le truppe inglesi che presentano le armi, e si avviano verso i campi di prigionia. Il giorno successivo è la volta del viceré e di alcuni ufficiali che sono rimasti con lui: la sera

115
sono a Adi Ugri dove vengono trattenuti sino al 5 giugno, il 6 volano a Khartum e l’indomani a Nairobi; di qui si avviano alla destinazione finale, un villino di caccia a Donyo Sabouk, 100 chilometri dalla capitale keniota.
Come è stato fatto per Cheren, la propaganda di guerra sfrutta l’episodio dell’Amba Alagi per esaltare le virtù guerriere degli italiani, parlando enfaticamente di «Termopili d’Italia» e ribadendo che, nonostante gli insuccessi e le perdite di territorio, il destino di Roma è ancora e per sempre in Africa. La figura di Amedeo d’Aosta si carica di suggestioni eroiche e gli onori militari tributati dagli inglesi sono celebrati come una vittoria: «L’Amba Alagi era vicina, vicinissima, era dentro il petto di tutti gli italiani» scrive Romualdo Pantini in un articolo significativamente intitolato Tempo d’epopea «e quando, dinanzi a quel pugno di eroi laceri, consunti, esausti, il nemico presentò le armi, noi ci sentimmo sollevati oltre tutte le tristezze e i dolori. Ecco perché, oggi, noi sentiamo veramente che sull’Amba Alagi è riscolpita con parole incancellabili la certezza del trionfo finale».50 La celebrazione di Amedeo «eroe dell’Amba Alagi» si completa con Vittorio Emanuele III, che gli conferisce immediatamente la medaglia d’oro al valor militare, ma non vale a cancellare la sostanza: trionfalmente celebrato nel 1936 per il suo ritorno «sui colli fatali di Roma», nella primavera del 1941 l’Impero non c’è più e per dissolverlo sono stati sufficienti pochi mesi di guerra.51

116
VI La guerra subalterna
L’incontro nel Nido d’Aquila di Berghof
Un alleato che conquista la Polonia e la Francia, attacca l’Inghilterra, prepara l’invasione della Russia; un altro che perde l’Impero, metà Albania, tutta la Cirenaica, le navi da battaglia più importanti. In un conflitto come quello scatenato da Hitler nel 1939, dove la comunicazione delle operazioni militari ha importanza quasi quanto le operazioni stesse e dove la tenuta del fronte interno è fattore decisivo per la vittoria, l’Asse non può permettersi di vedere l’Italia sconfitta. Intervenire a sostegno del Regio Esercito nei Balcani e in Africa settentrionale è oneroso dal punto di vista delle risorse umane e materiali, ma per Berlino il crollo del fascismo lo sarebbe ancora di più dal punto di vista politico: di qui la scelta strategica di Hitler, la moltiplicazione dei fronti per riparare agli errori dell’alleato. Paradossalmente, Mussolini riesce con le sconfitte a ottenere uno dei risultati cui mirava con le vittorie.
Nella visione del duce, la presa d’armi del 10 giugno era in funzione di esercitare una funzione [va bene la ripetizione?] moderatrice su Hitler e non permettere che i tedeschi stravincessero, perché una Germania troppo forte era un pericolo per l’Italia stessa ... Di qui una strategia attenta più al dopoguerra che alla guerra, con campagne scatenate per contrastare i futuri propositi tedeschi anziché per conseguire risultati credibili sul campo.1
Per intervenire nei due fronti meridionali dove gli italiani arretrano, la Wehrmacht deve disperdere energie sottraendole al fronte orientale e questo condizionerà la campagna di Russia sino alla sconfitta di Stalingrado. «L’Italia sta diventando il nostro tallone d’Achille» scrive Goebbels «ma non possiamo farci niente. Siamo obbligati a tentare di cancellare le sue sconfitte con le nostre vittorie, o l’Italia finirà nel niente».2 L’obiettivo di indebolire il Reich è così raggiunto per la via più impensata: ma non garantirà a Mussolini, ormai uscito dalla ribalta storica, nessun ruolo di mediazione. La Russia sarà la sconfitta di entrambi i dittatori e trascinerà con sé la lenta agonia dei due regimi.
L’incontro decisivo per trasformare le disfatte della «guerra parallela» nelle rivincite della «guerra subalterna» avviene il 19 e 20 gennaio 1941 nel Nido d’Aquila del Berghof, la residenza privata di Hitler nelle Alpi salisburghesi. Oltre al Führer e al duce, che hanno

117
due incontri faccia a faccia da soli, sono presenti i responsabili della politica estera e militare, Ciano, Ribbentrop, Keitel, Guzzoni, Jodl, oltre agli ambasciatori Alfieri e Mackensen. Manca solo Cavallero, rimasto in Albania a cercare di fermare i greci e stabilizzare il fronte. In due giorni di colloqui (meno tesi di quanto temuto dalla delegazione italiana) si stabilisce che la Germania, pur evitando mosse affrettate nocive al prestigio delle sue forze armate, intervenga presto in prima persona sia per liquidare la partita greca, sia per sostenere l’Italia contro gli inglesi in Libia e nel Mediterraneo. Di fatto, questo significa che d’ora innanzi la Wehrmacht decide tempi e modi delle campagne e che il Regio Esercito si uniforma a queste linee, inserendosi nella strategia globale di Berlino. Formalmente, però, i comandi restano autonomi e l’Italia si risparmia l’umiliazione di vedersi ridotta a uno Stato satellite come la Romania di Antonescu. I militari germanici sono scettici rispetto a questa indicazione e vorrebbero che le forze armate italiane venissero poste sotto comando tedesco o, almeno, che un maresciallo di primo piano della Wehrmacht andasse a Roma come ufficiale di collegamento per esercitare una supervisione. A spingere per una soluzione più moderata è lo stesso Hitler e nella sua scelta convergono valutazioni politiche e spinte personali.
Il Führer ha una scarsa considerazione per il popolo italiano e per le sue tradizioni storiche: conformemente a una certa cultura piccolo-borghese del suo tempo, egli, più che alla romanità (sfociata oltretutto nel cattolicesimo romano), guarda con simpatia alla grecità e considera gli italiani, in quanto mediterranei, razzialmente inferiori, anche se non al livello dei francesi ormai sulla via della «nigrizzazionenegrizzazione». Questa sua scarsa considerazione per il popolo gioca però tutta a favore di Mussolini, che egli ritiene l’unica grande personalità della penisola,
un uomo di Stato incomparabile che ogni giorno deve fare i conti con le mille difficoltà procurate dalla monarchia, dall’internazionale dei preti che ha sede a Roma, da una classe dirigente civile e militare composta ancora in buona parte da reazionari aristocratici, fossili senza contatto alcuno con la realtà e con il popolo.3
Ai suoi occhi, Mussolini conserva il merito decisivo di «aver compreso tutta la portata del pericolo bolscevico, alzato per primo la bandiera della riscossa portandola alla vittoria e averlo fatto non solo sul terreno della lotta armata, ma anche su quello della lotta delle idee». Costringere l’Italia ad accordi umilianti sarebbe ingiusto nei confronti del duce, che Hitler, uomo introverso e in fondo sprezzante

118
verso gli stessi collaboratori che ha portato al potere con lui, considera «il mio unico amico, senza il quale sarei solo al mondo».4 Offendere Mussolini significherebbe danneggiare la fiducia reciproca tra i due dittatori, che costituisce l’anello di collegamento più prezioso dell’Asse.
Al di là degli slanci emotivi, ci sono tuttavia considerazioni di carattere politico. Condizioni troppo pesanti possono rompere il precario equilibrio tra i due paesi, inducendo magari l’Italia a cambiare fronte come insegnano i precedenti del 1914, quando era re lo stesso Vittorio Emanuele III che è ancora sul trono adesso; oppure possono indebolire un regime già fiaccato dagli insuccessi militari, dando forza alle correnti ostili al duce e all’alleanza con la Germania che albergano nei vertici militari e nei circoli di corte. Un sovvertimento politico a Roma e una defezione militare dell’Italia aprirebbero le porte all’intervento inglese nella penisola, lascerebbero a Londra il controllo pressoché incontrastato del Mediterraneo e graverebbero la Wehrmacht di un fronte meridionale continentale:
Indebolire Mussolini con imposizioni onerose e lasciar crollare completamente l’Italia fascista non era solo al di fuori della concezione politica di Hitler, ma avrebbe anche portato alla costituzione di un fronte meridionale tedesco nel Sud dell’Italia e nell’Europa sudorientale, costringendo a rimandare chissà per quanto l’attacco a una Russia che intanto stava armandosi e organizzando la propria economia di guerra; senza contare, inoltre, che la mancanza di contrasto da parte della flotta italiana avrebbe permesso a Londra di trasferire gran parte della Mediterranean Fleet nell’Atlantico.5
Di qui discende il mantenimento della condizione di alleato su un piano formale di parità, anche se nella sostanza l’Italia continua a essere esclusa dalle scelte strategiche di fondo (nessun cenno viene fatto nei colloqui all’«Operazione Barbarossa»), mentre diventa subalterna sul piano operativo: negli scacchieri comuni i comandanti tedeschi, a tutti i livelli, potranno infatti rifiutare gli ordini italiani se li riterranno pericolosi per le loro truppe.
Sul piano militare, l’incontro di al Berghof porta a un primo impegno germanico nell’Africa settentrionale. Sin da fine dicembre Marras, addetto militare a Berlino, ha sollecitato l’invio di una divisione corazzata, spiegando a Keitel che «con ogni probabilità non si riuscirà a conservare la Cirenaica e senza l’aiuto tedesco tutta la Libia sarà perduta»: ». Hitler conferma nell’incontro di gennaio la prossima partenza di un’unità di sbarramento e Mussolini accetta, senza definire le modalità di impiego e le dipendenze operative: la guerra subalterna è implicita nei rapporti di forze, senza bisogno di

119
specificazioni. Il generale Hans von Funck, inizialmente designato per il comando, si reca in Libia in missione di ricognizione il 30-31 gennaio e al suo ritorno offre un quadro della situazione assai più desolante di quello descritto dai comandi italiani: poiché al Regio Esercito non restano in Africa che quattro divisioni prive di artiglieria e di mezzi corazzati, utili al massimo per una resistenza nel baluardo di Tripoli, la divisione corazzata germanica non sarebbe sufficiente a evitare la catastrofe.
Di qui la decisione di Hitler di mandare forze più ingenti, a cominciare dalla 5a divisione leggera, 9300 uomini con 2000 automezzi e armi controcarro da imbarcare subito da Napoli:
Nel caso in cui la Gran Bretagna avesse conquistato tutta l’Africa settentrionale italiana, sarebbe stata infatti in grado di impiegare le truppe disponibili per occupare la Siria e, dopo, avrebbe potuto spingere la Turchia a un intervento nei Balcani, e Berlino riteneva che questo doveva essere evitato a ogni costo.6
Le nuove dimensioni dell’intervento, che viene denominato «Operazione Girasole», richiedono un comandante più esperto e alto in grado del generale di brigata Von Funck. La scelta cade su Erwin Rommel, un ufficiale che ha comandato nel 1939 il battaglione di protezione personale di Hitler e nella campagna di Francia la 7a divisione corazzata, la prima a superare la Mosa: abile nella manovra (in cui si è distinto già nella Grande guerra, quando era solo tenente, con le infiltrazioni in profondità durante la battaglia di Caporetto), teorico militare apprezzato sino a diventare negli anni Trenta comandante dell’Accademia di guerra di Wiener Neustadt, egli giunge in Libia il 15 febbraio, quando Graziani è stato congedato e sostituito dal generale Gariboldi. Le asprezze di carattere di Graziani avrebbero sicuramente creato attriti tra i comandanti, mentre con Gariboldi, uomo anziano non privo di buon senso, le intese sono più facili: il generale italiano non ha né la personalità né il prestigio per contrastare il decisionismo di Rommel, dietro il quale stanno comunque le ragioni del più forte.
Il loro primo incontro è chiarificatore: al mattino Gariboldi, ignaro degli accordi intercorsi, propone la ritirata su Tripoli e Rommel non si ferma a replicare, preferendo fare un lungo giro di ricognizione sul terreno e consigliando al suo interlocutore di sentire i comandi a Roma. In giornata arriva Roatta e mette al corrente Gariboldi delle decisioni prese, comunicandogli che il comando supremo in Nordafrica resta nelle mani italiane, ma le due divisioni tedesche non potranno essere divise e formeranno un’unità organica comandata da

120
Rommel; quest’ultimo, di fronte a un ordine che non condivide, potrà rivolgersi direttamente al Führer per avere il parere definitivo; le truppe aeree, inoltre, sono poste agli ordini del generale FrolichStefan Fröhlich. Di fatto, la direzione in Libia passa all’Africa Korps, e Gariboldi si adegua, come emerge da un messaggio di qualche giorno successivo in cui annuncia la dislocazione della sua V Armata nella zona desertica:
Nelle condizioni in cui sono attualmente i reparti, questo spostamento sarebbe sconsigliato ma per ottemperare agli ordini superiori e aderire ai desideri tedeschi, visti anche i termini degli accordi intervenuti, ho deciso di dislocarli secondo quanto richiesto.7
L’arrivo di Rommel e dell’Afrikakorps
Al suo arrivo in Libia, Rommel ha quarantotto anni e appare nel pieno delle sue energie fisiche e intellettuali. La propaganda nazista lo predilige tra gli uomini d’armi e lo presenta come il generale modello, e perché sia tale
gli inventa un padre operaio e un passato nazista di comandante delle truppe d’assalto in camicia bruna a Monaco. In verità Rommel è figlio di un professore di matematica e di una signora della buona borghesia sveva, non ha mai comandato formazioni armate del partito, non è mai stato iscritto al medesimo, non ha mai abbandonato il servizio nella Wehrmacht.
Per molti aspetti egli è lontano dal tratto di eversione rivoluzionaria del mondo nazista e vede nella politica hitleriana di conquista la semplice continuazione dell’espansionismo guglielmino. Il suo fascino sta però nella condotta militare aggressiva e irruente, nello stile poco ortodosso rispetto alla prassi dell’ufficialità prussiana, nel gusto della sfida.
Rommel affascina Hitler con le decisioni fulminee, la memoria portentosa, il coraggio personale. «Voi colonnello cosa fareste al mio posto?» gli ha chiesto alle porte di una Praga ostile appena occupata. «Salirei su una macchina aperta e attraverserei la città senza scorta» ha risposto Rommel, e così Hitler ha fatto. Nel maggio 1940, durante l’attraversamento della Mosa, scende nell’acqua fino a metà petto per lavorare al ponte di barche con i suoi soldati, cosa che nessun generale della Prussia avrebbe fatto. Il Comando supremo gli ordina di rallentare i movimenti, ed egli invece viola la consegna e arriva sino a Cherbourg, sulla Manica, aprendo il fuoco contro le navi inglesi in fuga.8

121
Le sue concezioni tattiche irrompono sullo scacchiere nordafricano, sino ad allora irrigidito nelle esitazioni di Graziani, ribaltandone la logica.
Nelle prime settimane Rommel ispeziona la Tripolitania e la Sirte e rafforza le linee difensive, portando l’organizzazione teutonica in un settore che sino ad allora ha visto disorientamento e approssimazione. I carri armati e i mezzi che il nostro comando considera persi vengono riparati in officine attrezzate con meccanici preparati, strumenti e pezzi di ricambio; lungo la costa è organizzato un servizio di trasporti per piccolo cabotaggio utilizzando le bettoline; le piazzeforti sono difese con fossati profondi e le artiglierie protette in appositi bunker; i diversi punti di osservazione vengono collegati in modo da garantire comunicazioni immediate. Quando giunge in Libia la 15a divisione corazzata e si completa la costituzione dell’Africakorps, Rommel sprigiona tutto il suo dinamismo vulcanico, dimostrando che la sua unità è in continuo movimento ma che mantiene sempre i contatti tra i reparti e la compattezza. Alla forza aggiunge le astuzie. I carri armati appena sbarcati vengono fatti sfilare con fragore nel viale principale davanti al parco allestito per gli alti ufficiali, poco dopo virano in una strada laterale e ripercorrono lo stesso viale a uso e consumo degli eventuali informatori inglesi ma anche delle truppe italiane che devono riprendere fiducia; sulla litoranea, in una grande officina poco distante dalla capitale, vengono montate sagome di tank su vecchie Volkswagen per ingannare la ricognizione aerea nemica sulle reali consistenze delle forze corazzate.9 Rommel non è mai fermo, per dare a tutti la dimensione della sua presenza si sposta da un punto all’altro della Tripolitania utilizzando il mezzo che capita, un areo cicogna, un’autoblinda, una motocicletta. Tutto questo contagia le unità del Regio Esercito, abituate alla dispersione tattica sul terreno immenso del deserto e a non vedere mai Graziani, che ha comandato le operazioni dal quartier generale di Cirene: truppe demoralizzate dalla sconfitta scoprono così una dimensione moderna dell’organizzazione militare, che colpisce soprattutto gli ufficiali più giovani e ne rivitalizza la combattività.
A fine marzo, Rommel passa alla controffensiva. A Berlino, dove si è recato il 19 marzo per relazionare sulla situazione trovata in Africa, gli sono stati assegnati compiti limitati: un’azione a breve raggio in Cirenaica, con l’obiettivo di tenere impegnate le truppe inglesi mentre l’esercito continentale inizierà la campagna nei Balcani, considerata la vera priorità strategica. Per l’alto comando dell’OKW, l’alto comando della Wehrmacht, la Libia è solo un fronte

122
secondario dove bisogna ottenere il massimo risultato con il minimo dispendio di uomini e mezzi. Rommel non è però un comandante abituato alla prudenza e ai freni, né la natura della guerra nel Sahara si presta alle piccole offensive: una puntata esplorativa, la conquista di una piazzaforte possono aprire chilometri di spazio non presidiati nei quali gli attaccanti sono naturalmente indotti ad avanzare. Di qui la decisione del comandante dell’Africakorps di concentrare le forze contro il punto avanzato di El-Agheila, ma senza escludere la prosecuzione su Bengasi, su Derna, eventualmente su Tobruk e Bardia. Lo sforzo offensivo si basa sulla mobilità della 5a divisione leggera e su una parte dei carri armati della 15a, ma vi concorrono anche le forze di Gariboldi, con le divisioni «Ariete», «Brescia» e «Trento».
La strategia di Rommel è un azzardo che gli inglesi non hanno preso in considerazione, convinti che prima della tarda primavera il fronte africano sarebbe rimasto fermo e che i generali italiani sconfitti non avrebbero preso iniziative. Per questo Wavell, in accordo con Churchill, ha disposto lo spostamento di alcuni reparti in Grecia, nel tentativo di sostenere un ulteriore sforzo offensivo degli ellenici, o di rafforzarli contro un eventuale attacco tedesco dalla Bulgaria. Lo stesso O’Connor si trasferisce lontano dal fronte, andando al Cairo a preparare una futura offensiva in Tripolitania, mentre in Cirenaica lo sostituisce il generale Philip Neame per gestire l’ordinaria attività di presidio. Si tratta di una scelta più politica che militare: la Gran Bretagna vuole dimostrare ai paesi neutrali che non abbandona chi, per restarle amico, si trova coinvolto nella guerra. Sul piano strategico si rivela tuttavia un grave errore, perché lo spostamento di truppe non cambia la situazione nei Balcani mentre compromette quella nordafricana: le linee di rifornimento dal Cairo a Bardia e a Tobruk e da qui a Bengasi e a El-Agheila sono troppo lunghe, mentre gli uomini e i mezzi distratti verso la Grecia creano vuoti che indeboliscono la disposizione sul campo.
Rommel si rende conto delle fragilità nemiche e decide di intervenire subito, prima che gli inglesi correggano la loro posizione in campo. Il 30 marzo parte l’attacco a El-Agheila (al confine tra la Sirte e la Cirenaica), condotto dall’8o battaglione mitraglieri appoggiato dal grosso della 5a divisione leggera e i britannici sono costretti a ritirarsi lasciando sul campo 30 carri leggeri e 50 autoblinde. L’avanzata prosegue per i villaggi successivi, Marsa el Brega e Aghedabia, sulla strada per Bengasi, dove gli inglesi perdono 7 carri armati pesanti che li inducono ad accelerare la ritirata. Quando

123
i ricognitori tedeschi si accorgono che non sono in marcia verso la prima linea truppe britanniche di riserva, Rommel punta su Bengasi, anche se la 15a divisione corazzata non è ancora tutta schierata in campo. Si tratta di un rischio calcolato: egli intuisce che il comando inglese sopravvaluta le sue forze e sa che l’unico modo per confermarlo in questo convincimento è premerlo alle spalle. Le ricognizioni parlano di alcuni battaglioni in ritirata dalla capitale, di preparativi difensivi a Tobruk, di rinforzi ancora lontani in Marmarica (la regione a cavallo tra Libia ed Egitto).
Gli inglesi sono stati colti di sorpresa e il generale Neame, inesperto di guerra nel deserto, non si dimostra all’altezza del compito. Rommel entra a Bengasi il 3 aprile, prosegue per Derna, il 9 inizia l’attacco a Tobruk, con un dispositivo che affida alle divisioni «Brescia» e «Trento» l’azione lungo la litoranea da occidente, e ai tedeschi quella da sud appoggiati da gruppi dell’«Ariete». Intanto le avanguardie hanno aggirato le posizioni di Tobruk e, tagliando per il deserto, hanno raggiunto Bardia, poi il vecchio confine tra Libia e Egitto, quindi sono entrate a Sollum, già in territorio egiziano. Sul piano dell’immagine è una rivincita totale, che si completa con i prigionieri eccellenti: di fronte ai rovesci, O’Connor si precipita in Libia ma nella notte tra il 7 e 8 aprile viene catturato da una pattuglia di bersaglieri insieme ad altri due generali; il giorno successivo anche Neame cade nelle mani di una colonna mobile tedesca.10 La difesa di Tobruk è tuttavia più complessa e profonda di quanto Rommel immagini: lo sbarramento di artiglieria dei difensori, ai quali Wavell ha ordinato di tenere la piazzaforte a ogni costo, rallenta gli attaccanti, che sono costretti a fermarsi a 4 chilometri dalla città; dal mare, le unità navali di Cunningham appoggiano la difesa e riforniscono gli assediati di armi e viveri.
Nel momento in cui viene meno il fattore sorpresa, l’azzardo diventerebbe troppo pericoloso. Berlino, d’altra parte, non è disposta a mandare in Africa altre divisioni, nonostante le richieste di Rommel, sicuro di poter arrivare in qualche settimana a Suez con due divisioni in più. Il comandante dell’Africakorps, pronto al rischio calcolato ma non all’avventatezza, decide così di interrompere la prima controffensiva. Sul piano numerico le perdite degli inglesi sono modeste: a differenza di quanto accaduto con le truppe di Graziani, essi sono riusciti a sganciarsi e hanno lasciato sul campo solo 3000 uomini, perdite analoghe a quelle degli attaccanti. Sul piano delle posizioni sul campo, essi hanno però perso tutto ciò che avevano

124
conquistato due mesi prima e l’Asse ha recuperato la linea di confine, con la sola eccezione di Tobruk.
Per la propaganda di guerra si tratta di argomenti da veicolare nell’immaginario collettivo con i toni del trionfo. L’arrivo in Italia dei generali di Sua Maestà Britannica catturati dai bersaglieri della divisione «Ariete» è la rivincita dopo un inverno di rovesci, la riconquista della Cirenaica un’iniezione di fiducia per un’opinione pubblica quantomeno disorientata. Il bollettino del Comando supremo comunica l’8 aprile che «le forze corazzate e motorizzate italo-tedesche, superate con brillante manovra le resistenze opposte da reparti nemici, hanno raggiunto Derna»; il 10 si parla di «rastrellamento della vasta zona rioccupata, con unità che hanno bombardato e mitragliato concentramenti di truppe nemiche»; l’11 di «nemico in fuga ormai accerchiato» e di «violenti incendi nel porto di Tobruk provocati da nostri bombardamenti aerei»; il 12 di «migliaia di prigionieri e ingenti quantità di materiali abbandonati dal nemico».11
A ben guardare, le vittorie fulminee di Rommel aggravano ancor di più la portata delle sconfitte precedenti e incidono ulteriormente sui rapporti di forza all’interno dell’Asse: alla notizia della rioccupazione di Bengasi Mussolini è colpito come «da un fulmine a ciel sereno» e oscilla tra «lo stupore, la soddisfazione e il disappunto»;12 Gariboldi, che chiede ragione a Rommel di una strategia ritenuta rischiosa, riceve in risposta un radiogramma del Comando supremo della Wehrmacht che lascia all’Africakorps piena libertà di azione.13 L’effetto mediatico è tuttavia riconfortante e serve a coprire la disfatta che, in quegli stessi giorni, travolge l’Impero con l’abbandono di Addis Abeba da parte del viceré Amedeo d’Aosta. Ne è testimone indiretto un antifascista come Piero Calamandrei, che in data 9 aprile si chiede con amarezza rassegnata:
ma che fessi sono questi inglesi? Riperduta tutta la Cirenaica, i tedeschi a Tobruk. E chi può dire che non abbiano ragione gli spregevoli uomini di buon senso quando affermano che la Germania ci renderà anche Addis Abeba? E se gli inglesi dopo queste delusioni si scoraggiassero? Forse hanno ragione i francesi di Vichy, che giuocano la partita sulla vittoria di Hitler.14
Tra i soldati italiani in Africa, l’«effetto Rommel» ha il merito di scuotere dall’apatia e di smontare il mito dei carri inglesi invincibili. Uno scrittore come Mario Tobino, dal 1940 al ’42 mobilitato in Libia come ufficiale medico, registra da Tripoli i cambiamenti:
aspettavamo l’attacco degli inglesi e invece sbarcarono i tedeschi. Fino allora le nostre truppe erano sbarcate tra grande confusione e con le facce scure, per far

125
scendere a terra una divisione ci volevano al minimo tre giorni e dieci per ritrovare tutti i pezzi e ricomporla. La mattina dopo, coi guanti bianchi sopra le mani, sicuri, sbarbati, i tedeschi sfilarono invece per Tripoli e poi non si fermarono un minuto di più e si diressero verso il deserto della Sirte.
I rapporti con il Regio Esercito sono sbrigativi:
a noi italiani non dissero molte cose, come se non ci fossimo, facendoci appena un sorriso come a significare che erano arrivati e ora sistemavano tutto loro.
La supponenza è però sostenuta dai risultati, gli imperforabili carri britannici prendono fuoco, l’inarrestabile avanzata diventa a sua volta ritirata:
l’esercito italiano, così ridotto in miseria morale e materiale, riprese un leggero respiro; per l’orgoglio segretamente ferito, per essere costretto a stare in contatto con un esercito che conduceva modernamente la guerra, per imparare facilmente guardando, l’esercito italiano si modificò un poco nell’ordine e nell’onestà: e l’«Ariete», una divisione di soldati solidi e seri, si mosse verso il nemico insieme ai tedeschi.15
L’invasione della Iugoslavia e della Grecia
Il sostegno germanico ai fronti italiani nasce dalla necessità di consolidare il fianco meridionale prima di rompere il patto con Stalin e attaccare l’Unione Sovietica: l’Africa settentrionale serve a tenere impegnate parte delle truppe inglesi nel Mediterraneo, ma i Balcani sono ancora più strategici e non possono essere affidati alla fragile linea difensiva approntata da Cavallero in Albania. Di qui la decisione di una campagna contro la Grecia da svolgersi prima dell’inizio dell’attacco a oriente. Al controllo dei Balcani la Germania nazista ha pensato sin dalla primavera del 1940, quando ha cercato la penetrazione per via diplomatica, riuscendo ad attrarre nella propria zona di influenza prima la Romania di Antonescu, poi l’Ungheria del conte Pál Teleki («l’Ungheria riconosce il mutamento dell’egemonia in Europa e vi si adegua» dichiara il primo ministro al Parlamento di Budapest annunciando di aver concesso il libero transito alle truppe germaniche),16 poi ancora la Bulgaria di re Boris III (che si incontra direttamente con Hitler e dà il via a una feroce repressione antifascista all’interno del paese).
Le pressioni sul Regno di Iugoslavia sono invece state vanificate dall’attacco italiano alla Grecia, che ha preoccupato il governo di Belgrado, rendendolo diffidente e refrattario alla trattativa. Il reggente Paolo Karagjeorgjević, principe di Iugoslavia, che nel 1934 è

126
diventato reggente dopo l’assassinio del fratello, re Alessandro I,17 mantiene una posizione di neutralità durante tutto l’autunno-inverno e allerta le truppe sul confine albanese in funzione difensiva. Nel febbraio-marzo 1941, mentre la Wehrmacht ammassa reparti in Romania e Ungheria, si moltiplicano le pressioni e le minacce di Berlino sul reggente e sul governo di Dragiša Cvetković, i quali finiscono per cedere «sia per la consapevolezza dell’impreparazione militare del paese, sia per l’ossessione del bolscevismo, che avrebbe potuto trarre occasione dalla incompetenza degli stati maggiori per sollevare il popolo contro l’inviso autoritarismo della reggenza».18 Quando il 25 marzo Cvetković si reca a Vienna per firmare l’alleanza con il Reich, a Belgrado viene però compiuto un colpo di Stato antitedesco fulmineo e incruento, che porta all’arresto del reggente Paolo e alla sua sostituzione con re Pietro II, dichiarato maggiorenne anche se avrebbe compiuto i diciotto anni solo qualche mese più tardi: il nuovo esecutivo, guidato dal generale Dušan Simović, denuncia ufficialmente il patto appena sottoscritto, mentre in tutto il paese «straordinarie acclamazioni e manifestazioni salutano il cambiamento di governo».19
Il pieno successo del colpo di Stato, sostenuto in chiave antitedesca dall’esercito, dai ceti intellettuali, dal clero e dalla gerarchia ortodossa, suscita la reazione violenta di Hitler e del gruppo dirigente nazista, preoccupati per le possibili ripercussioni politico-militari sullo scacchiere balcanico, ma anche irritati per l’enfasi data all’episodio da parte della propaganda di guerra angloamericana (Churchill parla infatti pubblicamente di «eterna gratitudine agli eroici iugoslavi», mentre il «New York Times» definisce il colpo di Stato di Belgrado «il lampo che illumina le tenebre»).20 La macchina della comunicazione di massa nazista si mette immediatamente in moto: adottando lo stesso procedimento usato nel 1938 contro la Cecoslovacchia, viene lanciata una violenta campagna contro la Iugoslavia, con la denuncia di una serie di atrocità del tutto immaginarie e la descrizione di un paese in preda al caos provocato dagli agenti segreti britannici. Nel contempo, l’ufficio operazioni della Wehrmacht riprende piani di invasione predisposti nei mesi precedenti e li rielabora tenendo anche conto della situazione sul fronte greco-albanese: in pochi giorni nasce così l’«Operazione Castigo», un’offensiva destinata a occupare Iugoslavia e Grecia, a espellere gli inglesi dai Balcani e ad assicurare all’Asse il controllo di tutta l’area continentale meridionale.

127
I comandi italiani vengono informati dei propositi offensivi, senza essere coinvolti direttamente nella predisposizione del piano: Cavallero è in Albania, dove è riuscito a fermare l’avanzata greca ma non a riconquistare i territori perduti, nonostante siano arrivati molti rinforzi e disponga di oltre 230.000 uomini, e per i tedeschi è sufficiente che egli mantenga la linea del fronte albanese, bloccando la maggior parte delle truppe elleniche. A Mussolini ne parla l’ambasciatore Mackensen e il duce si affretta a scrivere a Hitler che
ho dato personalmente ordine al generale Cavallero di sospendere la nuova offensiva il cui inizio era imminente: reparti di fanteria stanno affluendo verso la frontiera nord e prendono posizione sulle tre direttrici di un eventuale attacco jugoslavo. Desidero anche dirvi, Führer, che se la guerra alla Jugoslavia sarà inevitabile, essa sarà molto popolare in Italia.21
La «nuova offensiva» di cui parla il duce è, in realtà, una prospettiva di lungo periodo, perché gli attacchi di inizio marzo, fatti in sua presenza, non hanno sortito alcun risultato, e l’impostazione difensiva sul confine iugoslavo è l’opposto della strategia di invasione fulminea concepita dalla Wehrmacht, ma a Berlino non importa replicare. La sostanza politica è che, ormai, l’Asse è entrato nella dimensione della «guerra subalterna», come dimostra il fatto che né Mackensen né Hitler fanno cenno alla futura organizzazione dei Balcani occupati. Sarà la Germania a stabilire le zone di competenza, così come è il comando dell’OWK a stabilire il piano dell’«Operazione Castigo». Per completare il disegno di attacco concentrico al cuore della Iugoslavia, Keitel chiede il contributo delle truppe del Regio Esercito schierate nella Venezia Giulia, e Mussolini aderisce senza porre condizioni sui futuri assetti. All’inizio di aprile tutti i dettagli sono definiti: la II Armata del generale Vittorio Ambrosio deve puntare sulla direttrice dalmata scendendo lungo la costa sino a Zara e penetrare in Slovenia verso Lubiana; gli ungheresi operano nel settore orientale, con la III Armata del generale Elemér Gorondy-Novak destinata a marciare sulla Voivodina e a raggiungere Novi Sad. Il peso dell’offensiva ricade però sulla Wehrmacht, con un attacco da più direzioni: la XII Armata del generale Wilhelm List, partendo dalle basi in Bulgaria, deve muovere verso Skopje e Monastir per impedire l’arrivo di aiuti inglesi dalla Grecia; la II Armata di Maximilian von Weichs deve attaccare da nord, partendo dall’Austria e dall’Ungheria; il 41o gruppo corpo corazzato, partendo dalla Romania, deve marciare su Belgrado. In totale i tedeschi impiegano 21 divisioni, una forza analoga a quella lanciata contro la Francia, mentre all’aviazione di

128
Göring è affidato il compito di aprire la strada all’invasione con bombardamenti a tappeto.
Le operazioni iniziano all’alba del 6 aprile con le incursioni della IV Flotta aerea su Belgrado e sugli aeroporti militari iugoslavi: tre giorni di bombardamenti pressoché indisturbati, che nella capitale provocano 17.000 morti e la distruzione del centro storico. La difesa contraerea è inefficiente e limitata a pezzi di artiglieria della Grande guerra, mentre «l’aviazione non ha neppure il tempo di decollare e la maggior parte degli apparecchi viene distrutta al suolo dagli Stuka in picchiata».22 Lo stesso 6 aprile le armate varcano le frontiere dalle diverse direttrici e l’esercito iugoslavo collassa: impreparazione militare, sproporzione tra le forze in campo, divisioni nel gruppo dirigente paralizzano la difesa, con reparti che si sbandano e altri che si arrendono. Il risultato è una resa quasi senza combattimenti, un intero paese conquistato in due settimane di avanzata con pochissime perdite. Il 10 aprile le armate dell’Asse entrano a Zagabria, l’11 a Lubiana, il 12 a Belgrado, mentre il giovanissimo re Pietro II e il governo si ritirano prima a Sarajevo, poi in Montenegro, quindi raggiungono in volo una base inglese in Palestina. Il 17 aprile l’alto comando iugoslavo si arrende.
La rapidità della vittoria permette di realizzare subito la seconda parte del piano, la conquista della Grecia. Senza la necessità di rallentare la marcia per riorganizzarsi dopo la prima penetrazione, e prima ancora della resa iugoslava, la Wehrmacht il 12 aprile entra in Tessaglia, il 13 le forze di Cavallero passano all’offensiva verso l’Epiro, le truppe corazzate partite dalla Bulgaria stabiliscono una testa di ponte tra Skopje e il Monte Olimpo e muovono verso il cuore della Macedonia. Il generale ellenico Papagos, efficace nel contenimento sinché ha avuto di fronte le truppe italiane, si disorienta di fronte a un attacco così articolato e massiccio:
Prima egli esita contando su una diversa combattività dell’esercito iugoslavo e sulla possibilità che questo attacchi alle nostre spalle, poi, nonostante i consigli inglesi, insiste nella resistenza a oltranza, e solo quando i tedeschi ormai dilagano ordina la ritirata. Ma ormai il fronte della Tessaglia è rotto, le colonne corazzate passano per i varchi aperti nella linea Metaxas dalla 5a e 6a divisioni alpine, infrangono la linea di resistenza allestita dal corpo di spedizione britannico sul fiume Aliacmone, minacciano Salonicco e Gianina, mentre gli italiani rioccupano Argirocastro e Coriza: dopo quarant’otto ore la Grecia è isolata a est e sta per cadere lo schieramento a ovest.
Mentre gli inglesi, comprendendo che la partita balcanica è persa, ritirano rapidamente le loro truppe e le reimbarcano verso l’Egitto e la

129
Palestina, in Grecia (dove il 29 gennaio è morto il primo ministro Metaxas, sostituito da Alexandros Korizis) la sconfitta travolge il sistema gerarchico militare e politico:
Il generale Pitsikas, comandante delle armate sul fronte albanese, chiede ad Atene di trattare e richiede un intervento politico, ma la risposta tarda ad arrivare. I suoi ufficiali lo scavalcano e, riuniti in assemblea, danno mandato a un altro generale, Georgios Tsolakoglu, di trattare con i tedeschi e si preparano a costituire un governo provvisorio. Il presidente del consiglio Korizis, vedendo il paese perduto e sentendo la fragilità del suo potere, si suicida il 18 mattina, dopo solo tre settimane dall’insediamento. La mattina del 20 i parlamentari greci offrono la resa al generale Josef Dietrich, comandante della divisione corazzata «Adolph Hitler», chiedendo il riconoscimento del governo provvisorio e ponendo come condizione che l’armistizio sia solo con i tedeschi e non con l’Italia (dalla quale non si sono stati battuti sul campo).23
I comandi tedeschi chiedono l’autorizzazione a Berlino ma Hitler, pressato da Mussolini, decide che le armate greche devono arrendersi senza condizioni sia alla Germania sia all’Italia: anche se la vittoria militare è della Wehrmacht, l’umiliazione politica dell’alleato non serve nella prospettiva futura. Iugoslavia e Grecia dovranno essere sottoposte a un regime occupazionale e per il controllo di un territorio che si dimostrerà ostile all’Asse servirà un Regio Esercito collaborativo, da impegnare nelle operazioni faticose e senza gloria della controguerriglia. Ai greci sconfitti non resta che accettare il duplice armistizio, che viene firmato il 23 aprile. Il 28 le avanguardie tedesche e italiane sono ad Atene.
I giornali italiani rilanciano le notizie dal fronte con l’enfasi di un regime che deve recuperare credibilità: La Dalmazia che ritorna titola «il Messaggero»; «I greci indignati vanno a caccia di inglesi» commenta «Il Telegrafo» di Livorno; «E ora li cacceremo dall’Africa» annuncia la «Gazzetta del Popolo». Mussolini, ribaltando le dinamiche dei fatti, rivendica il merito della vittoria alle truppe italiane, che hanno fiaccato quelle greche nei mesi precedenti. Scrive a Cavallero:
In quest’ora di vittoria, devo riconoscervi l’indiscutibile merito di avere preparato, durante quattro mesi, le condizioni necessarie e sufficienti per raggiungerla. Tali condizioni consistevano nello spezzare come avete fatto ogni ulteriore conato controffensivo nemico e nel dare a tutti l’impulso materiale e morale per la riscossa.24
Churchill reagisce indignato e alla Camera dei Comuni denuncia:
questo sciacallo frustrato, Mussolini, che per salvare la sua pelle ha reso l’Italia vassallo dell’impero di Hitler, viene a fare capriole di fianco alla tigre tedesca con

130
latrati non solo di appetito, ma anche di trionfo. Tutto questo è ridicolo e spregevole.25
Gli italiani accolgono la notizia della vittoria con atteggiamento perplesso: un anno di guerra ha smontato le certezze e sostituito l’entusiasmo del Ventennio con l’apatia. Non ci sono ancora né rifiuto né opposizione, ma comincia a maturare il distacco, lo stesso che nel giugno 1940 hanno provato per prime le popolazioni alpine evacuate per la campagna contro la Francia. Lo coglie con efficacia Calamandrei:
La Iugoslavia si è arresa, la Grecia sta crollando, La Dalmazia, Lubiana sono in mano nostra. Eppure c’è in tutti, d’intorno, un senso di assoluta indifferenza: come se le vittorie e le sconfitte della patria non riguardassero più gli italiani. Venti anni fa. L’occupazione di una sola città della Dalmazia avrebbe riempito le piazze di tumulti di gioia. Oggi tutti se ne fregano: vincere o perdere è lo stesso, «basta che ’u tempo passi…». La stessa apatia nel popolo e nelle classi colte: all’università, dove credevo trovare gli animi in tumulto, assoluta inerzia tra professori e studenti: c’è già la coscienza del nostro servaggio.26
I paracadutisti a Creta
Per rinforzare l’ottimismo della propaganda di guerra, subito dopo l’entrata delle avanguardie in Atene, il Regio Esercito realizza un’azione sulle Isole Ionie e lo fa con uno spettacolare lancio di paracadutisti su Cefalonia e Zante. Il 30 aprile le due compagnie disponibili (in totale 150 uomini, il nucleo iniziale di quella che nel giugno 1942 verrà battezzata «divisione Folgore») partono dal campo di addestramento di Tarquinia e si lanciano su Argostoli, il principale centro di Cefalonia. Il significato dell’incursione è assai più politico che militare: riconquistare dall’aria la dimensione imperiale che in quegli stessi giorni sta tramontando sull’Amba Alagi con la sconfitta del duca Amedeo d’Aosta. Il paracadutista si presta meglio di ogni altro combattente a esaltare l’immaginario fascista: il dominio del coraggio e della volontà sulla natura, la fusione della modernità delle macchine e della potenza delle armi, ne fanno l’espressione dell’ardimento allo stato puro.
Sul piano militare l’operazione manifesta limiti vistosi. Per i contrasti tra Esercito e Aeronautica dei 6 aerei SM82 previsti solo 3 vengono messi a disposizione, col risultato che metà degli effettivi restano a terra a Tarquinia. Al momento del lancio i piloti giungono sulle posizioni a velocità elevata e una parte dei paracadutisti, disorientati dal vento, non possono evitare incidenti: su 75 uomini

131
lanciati, 15 si infortunano al momento di toccare il suolo e tra questi 8 in modo grave. Il successo è comunque garantito dalla resa immediata del presidio greco: i soldati ellenici, prostrati dalle notizie dell’avanzata tedesca e sbalorditi dagli armati che scendono dal cielo, non si rendono conto delle dimensioni limitate dell’attacco e si consegnano senza sparare. I paracadutisti possono così prendere possesso di Cefalonia e, in concorso con altre truppe sbarcate dal mare, occupare la vicina Zante. Per la stampa è una straordinaria iniezione di argomenti e una modesta azione, dagli evidenti limiti operativi, si trasforma nel trionfo del coraggio. Uno dei nomi più illustri del giornalismo del tempo, Orio Vergani, conia l’espressione «Arditi dell’aria», saldando il presente alla memoria della Grande guerra e alle tradizioni originarie del fascismo: la guerra non significa più sudore, fango, marce faticose, ma tecnologia applicata al combattimento, saldezza di virtù morali, sfida al destino.
Qualche settimana più tardi, con ben altre dimensioni, i tedeschi realizzano un’azione analoga a Creta, denominata «Operazione MerkurMercurio» (Unternehmen Merkur). Nel corso delle operazioni contro la Iugoslavia e la Grecia, «il Comando della Wehrmacht discute la questione se, per rendere sicuro il fianco sud dell’Europa occupata, sia meglio conquistare Malta oppure Creta, le due basi inglesi nel mezzo del Mediterraneo». Keitel e Halder ritengono che si debba puntare su Malta, da dove si controllano i collegamenti tra l’Italia e l’Africa, ma Hitler, influenzato dal capo di stato maggiore dell’aeronautica Hans Jeschonnek e dal generale Kurt Student, comandante dell’11o Corpo aereo, decide per Creta: «la scelta strategica è determinata dal fatto che Hitler teme possano partire da Creta attacchi aerei britannici contro la regione petrolifera romena di PloieștiPloiesti, ritenuta fondamentale per l’“Operazione Barbarossa”».27
Progettata da Student, l’Operazione Merkur Mercurio inizia il 20 maggio con 3000 paracadutisti lanciati nella parte nordoccidentale dell’isola, destinati a impadronirsi dell’aeroporto di Maléme; altri vengono paracadutati nelle vicinanze della capitale, Candia, con obiettivo il porto, e altri ancora su Suda; frattanto le truppe della 5a divisione da montagna vengono imbarcate su battelli requisiti a Salonicco e al Pireo, che si dirigono verso l’isola scortate da alcuni cacciatorpediniere italiani. Gli scontri sono violentissimi: il corpo di spedizione neozelandese del generale Bernard Freyberg 28 infligge gravi perdite ai paracadutisti, molti dei quali vengono colpiti prima ancora di toccare terra, mentre alcuni aerei sono abbattuti dalle

132
artiglierie; la flotta di Cunningham, a sua volta, colpisce parte del naviglio partito dalle coste greche. La conquista dell’aeroporto di Maléme permette tuttavia alla Wehrmacht di aviosbarcare altre truppe, con le quali riesce a sfondare le difese britanniche. Autorizzato da Churchill, il 27 maggio Freyberg inizia il ripiegamento e nei giorni successivi, sacrificando le retroguardie, riesce a reimbarcare una parte del suo contingente dai porti della costa merdionale.
L’operazione termina il 1° giugno: dei 32.000 soldati del Regno Unito presenti a maggio a Creta, solo 18.000 evitano la morte o la prigionia, ma l’impresa è costosissima anche per i tedeschi. I reparti aviotrasportati di Student perdono metà degli effettivi e 271 aerei su 600: gli attacchi dall’aria fatti nella primavera del 1940 sulla Norvegia e sul Belgio avevano ottenuto risultati stupefacenti perché del tutto inattesi, ma a Creta i difensori sono prepararti e riescono a infliggere danni tali che inducono i comandi militari (non solo della Werhamcht) a cambiare tattica: da allora in poi i paracadutisti vengono utilizzati in combattimenti terrestri accanto ai reparti di prima linea, oppure lanciati su posizioni strategiche per azioni limitate di piccolo cabotaggio. Hitler stesso rigetterà due proposte di Student per conquistare dall’aria Cipro e, successivamente, Malta.29
La divisione del bottino
Che l’unico vincitore nei Balcani sia la Germania si capisce nel momento dell’organizzazione del territorio conquistato. Ciano (che a fine aprile si congeda insieme agli altri gerarchi e torna a fare il ministro degli Esteri) lo annota a proposito della prima decisione presa da Berlino, riconoscere ad Atene un governo provvisorio affidato al generale Tsolakoglu, pur sussistendo l’occupazione territoriale da parte degli eserciti dell’Asse:
Questa storia mi piace poco, perché è chiaro che questo generale si propone di salvare l’unità nazionale ed etnica della Grecia. Mi sembra che il meno che si possa fare sia richiedere ai tedeschi di lasciarci il governo civile dei territori che ci spettano, altrimenti temo che l’utile a noi riservato sarà molto modesto.30
Nei giorni successivi Mussolini, Ciano, Roatta, Cavallero, Buffarini Guidi, 31 lo stesso Vittorio Emanuele III ragionano sui possibili scenari, spaziando dall’annessione di tutta la Dalmazia, all’allargamento del Dodecaneso alle Sporadi e alle altre Isole egee, al controllo diretto su Slovenia e Croazia, ma le linee di pertinenza vengono stabilite a Berlino. Quando Ribbentrop incontra Ciano è

133
perentorio: «La linea di confine è definitiva e non si discute».32 Decisa unilateralmente, la ripartizione sancisce la fine della Iugoslavia come Stato. Berlino assume il controllo delle zone più ricche o militarmente strategiche: la parte settentrionale della Slovenia, la Voivodina, il Kosovo settentrionale, la Serbia. All’Italia vengono invece assegnati la parte meridionale della Slovenia inclusa la capitale Lubiana (che vengono annesse alla madrepatria come «provincia di Lubiana»), la costa dalmata (che costituisce il «governatorato di Dalmazia»), buona parte del Kosovo e della Macedonia occidentale, l’Erzegovina e parte della Bosnia, mentre il Montenegro (la terra natale della regina Elena), inizialmente destinato a costituire un regno indipendente affidato a un membro della dinastia dei Petrović, 33 viene trasformato in governatorato militare italiano per il rapido insorgere di resistenze all’occupazione. La parte più vasta del territorio iugoslavo smembrato viene onorato del titolo di Stato indipendente di Croazia, dove il potere è esercitato dal movimento nazionalfascista e antiserbo degli ustascia di Ante Pavelić,34 ma la corona è affidata al principe di Spoleto Aimone di Savoia (fratello minore del duca Amedeo d’Aosta e nipote di re Vittorio Emanuele III, Aimone assume il nome di Timoslav Tomislavo II ma rimane a Roma, senza mai salire effettivamente sul trono di Zagabria).35
Per quanto riguarda la Grecia, viene confermato il governo provvisorio del generale Tsolakoglu (un ufficiale di sentimenti antitaliani, peraltro privo di capacità organizzativa e di autorevolezza) e l’assetto definitivo della regione viene rinviata a fine conflitto: il controllo del territorio viene però affidato alle truppe di occupazione, con i tedeschi insediati nelle aree di Salonicco e Atene, oltreché a Creta centroccidentale e nelle Sporadi settentrionali: all’Italia è assegnata la parte continentale (Epiro, Tessaglia, Ellade, Peloponneso), oltre alla parte orientale di Creta e alle Isole egee minori).
In termini politici, l’ampiezza dell’area assegnata complessivamente all’occupazione italiana è lusinghiera, soprattutto se confrontata con i risultati negativi ottenuti sul campo. Più che un atto di generosità verso l’alleato, si tratta di conseguenze del ruolo marginale occupato dai Balcani nella strategia nazista:
Che per Hitler la campagna nei Balcani fosse una pura necessità militare e non un’operazione cui egli fosse interessato per via di un particolare obiettivo, risultò chiaramente già dal riordino dei territori occupati. A Hitler importava solo difendere gli interessi dell’economia bellica tedesca e le linee di comunicazione con le «riserve» militari situate nella cintura di sicurezza strategica del Sudest. La

134
maggior parte dei territori poteva essere lasciata all’Italia, dove era prevedibile una sfibrante azione di guerriglia contro la quale ben potevano logorarsi le divisioni del Regio Esercito.
Riassumendo sinteticamente il parere di Hitler sul problema Grecia, il capo dell’ufficio operativo dell’OKW Alfred Jodl afferma:
Se le truppe d’occupazione italiane vengano o no a capo del governo di Tsolakoglu, questo a noi non interessa, è escluso che la Germania faccia da arbitro tra Grecia e Italia e che il governo greco si rivolga per queste questioni al comandante in capo tedesco.36
La previsione dello svilupparsi di movimenti di resistenza all’occupazione non tarda a confermarsi esatta e sin dall’estate del 1941 il Regio Esercito è impegnato massicciamente: la II Armata del generale Ambrosio viene dislocata nei territori iugoslavi, il 14o corpo d’armata in Montenegro, l’XI Armata del generale Carlo Geloso in Grecia.
L’esercito mantiene nei Balcani una forza di 600-650 mila uomini, che non va commisurata al totale degli uomini alle armi, ma a quello delle forze efficienti. Su 65 divisioni disponibili nel 1941-42, la metà fu destinata ai Balcani, da 30 a 35 a seconda dei momenti. Più di quante ne furono inviate su tutti gli altri teatri, tre volte quante ne restavano in Italia nel 1943 per fronteggiare gli anglo-americani.37

135
VII I «maiali» nella rada di Alessandria d’Egitto
Teseo Tesei, Elios Toschi e le incursioni subacquee
Accanto alle sconfitte terrestri e navali della «guerra parallela» e alle rivincite assai più politiche che militari della «guerra subalterna», c’è una terza dimensione del periodo 1940-43 sulla quale tanto si è spesa la propaganda coeva e dalla quale si è altrettanto astenuta la memoria successiva: le imprese nelle basi britanniche di Gibilterra, Malta e Alessandria dei reparti d’assalto subacquei, più conosciute come le incursioni dei «maiali». Dopo la guerra d’Etiopia e il nuovo orientamento della politica estera che trasforma la Royal Navy da storica alleata in nemica, la Regia Marina, conscia della propria inferiorità, mette allo studio la creazione di reparti speciali, originali nella concezione e nell’impiego, mezzi d’assalto di piccole dimensioni che possano alleggerire la pressione delle forze navali nemiche attraverso il forzamento delle loro basi e l’attacco in porto al naviglio pesante. Nessun ammiraglio pensa di poter vincere il confronto nel Mediterraneo con questi strumenti, ma nell’improponibilità di un riarmo che permetta di colmare le distanze bisogna ricorrere all’ingegno per limitare i danni. Il problema è duplice: da un lato si tratta di studiare i mezzi utili a superare gli sbarramenti difensivi e a infliggere il maggior danno possibile al nemico; dall’altro, addestrare ed equipaggiare gli uomini destinati a questo tipo di missioni.
Tra le diverse proposte, viene deciso di puntare sullo sviluppo del progetto di due tenenti del genio navale, Teseo Tesei ed Elios Toschi, già esperti sommergibilisti. Essi inventano una sorta di «torpedine umana» (come la chiamano nella prima formulazione), un piccolo sottomarino silurante, a propulsione soltanto elettrica, guidato da due uomini che stanno a cavalcioni del mezzo: «La particolarità strabiliante» scriverà Elios Toschi «è che gli uomini d’equipaggio, stando a cavallo del piccolo siluro subacqueo e muniti di autorespiratore a grande autonomia, potranno posarsi sul fondo del mare e su questo camminare, agire e dirigersi dove vogliono, senza essere visti dal nemico».1 È l’invenzione di quelli che diventeranno gli SLC, i siluri a lenta corsa, abitualmente chiamati i «maiali» (secondo la tradizione, il soprannome deriva dallo stesso Tesei che un giorno, prendendo a calci un SLC con il motore fermo, esclama: «Questo maiale non vuol partire»).

136
Il primo esemplare viene realizzato nell’ottobre 1935 dal silurificio San Bartolomeo di La Spezia e subito iniziano le prove in vasca, presto seguite da quelle in mare. I risultati sono soddisfacenti: Tesei e Toschi lavorano al miglioramento del mezzo, di cui vengono a mano a mano prodotti nuovi modelli perfezionati, mentre vengono sollecitate ricerche per la messa a punto degli equipaggiamenti, dagli autorespiratori, alle mute per gli operatori, agli orologi e alle bussole subacquee. Il mezzo è lungo circa 6 metri, una sorta di sommergibile tascabile a forma di siluro, diviso in tre sezioni: nella prima, di forma arrotondata per favorire la navigazione, è collocata la carica (300 chili di tritolo) con i relativi congegni di scoppio; nella parte centrale sono ricavati i posti per i due incursori, il pilota e il palombaro suo secondo, che siedono cavalcioni come su una motocicletta e procedono dotati di respiratori subacquei con un’autonomia di qualche ora; nella terza vi sono il motore, le eliche, i timoni di profondità e di direzione. La strumentazione è essenziale: un profondimetro, una bussola magnetica luminosa, un orologio, una livella a bolla per il controllo dell’assetto, quanto basta per le brevi navigazioni notturne cui sono chiamati.
Contemporaneamente alle attività di perfezionamento tecnico, iniziano le attività di addestramento del personale, reclutato tra i marinai dei sommergibili. Poiché le incursioni richiedono totale segretezza sui mezzi usati e sulle modalità d’attacco, viene deciso di creare una base isolata e nascosta in un’ansa del mare a Bocca di Serchio. La sede iniziale è un vecchio casolare della proprietà Salviati, spartano negli arredi e nei servizi: al piano terra la cucina e il deposito dei materiali, a quello superiore le stanze. In seguito vengono costruiti altri edifici adibiti ad alloggi e magazzini, ma sempre con i tratti di essenzialità funzionale al particolare tipo di addestramento.
L’attività è severa: lunghe immersioni nel Tirreno, spostamenti a piedi sott’acqua con trasporto di cariche esplosive, esercitazioni notturne nelle temperature più rigide, acquisizione della piena padronanza tecnica dei mezzi e, soprattutto, tanta ginnastica, per rinforzare la muscolatura e sviluppare l’agilità. A Bocca di Serchio affluiscono volontari, selezionati sulla base della idoneità fisica e della solidità psicologica. Sono tutti giovani figli del Ventennio, educati ai miti dell’eroismo guerriero e della grandezza della patria. Con l’ardore incosciente dell’età, essi si vedono protagonisti di una prossima stagione nella quale troveranno consacrazione i valori fondanti della loro formazione: l’onore, il coraggio, la «bella morte», la gloria. «Quale» guerra si combatte e quale legittimità essa possa avere, non sono domande che li coinvolgono: i corpi speciali (vale per gli

137
incursori subacquei come per gli arditi, per i paracadutisti) sono impostati per combattere e seguono sino fondo il regime che li porta alla lotta. I reparti d’assalto della Marina aggiungono al quadro d’insieme un elemento specifico di forte impatto psicologico: la sfida alla superpotenza britannica, l’attacco di un piccolo manipolo di uomini contro i porti più protetti, l’eterna suggestione di Davide che vince Golia. Per loro non si tratta semplicemente di dimostrare la capacità di combattenti: si tratta di colpire quasi a mani nude le grandi corazzate della Royal Navy, di agire con l’astuzia e l’ardimento contro la grande flotta che da due secoli domina i mari e gli oceani del mondo.
Nel 1938 lo stato maggiore riconosce la necessità di dare autonomia alla nuova specialità e costituisce la I flottiglia Motoscafi armati siluranti (o I flottiglia MAS, successivamente denominata X Flottiglia MAS, per dare al nemico, in caso di cattura, la sensazione che i reparti siano numerosi), affidata al comando del capitano di fregata Paolo Aloisi (sostituito nel febbraio 1940 dal pari grado Mario Giorgini, quindi da Vittorio Moccagatta): l’unità si occupa sia dell’addestramento del personale, sia della messa a punto e dell’utilizzo dei mezzi d’assalto. Per quanto riguarda il problema dell’avvicinamento dei mezzi all’obiettivo, il comandante Aloisi e i suoi uomini ritengono che la soluzione migliore sia quello di utilizzare i sommergibili, in modo che il rilascio in mare possa avvenire a una distanza minima dalle basi nemiche.
La tecnica dell’attacco è spericolata: una volta messi in acqua il più vicino possibile all’obiettivo, gli SLC avanzano verso l’imboccatura del porto nemico a una velocità che non supera i due nodi, con i due uomini d’equipaggio che tengono solo la testa fuor d’acqua per respirare e orientarsi. In caso di pericolo, il mezzo si immerge per non essere scorto. Superate le ostruzioni difensive metalliche cercando un varco sottostante o aprendone uno con il tagliarete, i «maiali» si dirigono verso la nave da colpire e, giunti a qualche decina di metri dal bersaglio, si immergono e procedono sin sotto la carena cercando di individuarne la parte centrale, dove l’esplosione risulta più devastante: è l’operazione tecnicamente più difficile, perché avviene al buio, nel freddo delle profondità marine, e gli incursori non hanno che i propri sensi per orientarsi. Raggiunto l’obiettivo, il pilota mantiene il controllo del mezzo, mentre il palombaro prima fissa una cima tra le due alette di rollio che stanno sul fianco della carena, quindi stacca la testa del siluro con l’esplosivo e lo collega alla cima stessa, regolando la spoletta a orologeria perché

138
lo scoppio avvenga dopo circa due ore. A questo punto l’operazione di attacco è conclusa: l’equipaggio si allontana dalla nave e cerca di tornare al sommergibile avvicinatore, oppure di raggiungere la riva e dileguarsi sulla terraferma (in questo caso solo dopo aver attivato il congegno di autodistruzione del «maiale», perché i nemici non possano scoprirne i segreti). In realtà, le possibilità di rientrare sono minime, perché se il sommergibile stazionasse troppo a lungo nelle vicinanze del porto nemico correrebbe il rischio di essere individuato dalle difese: il destino pressoché certo degli incursori (se non muoiono durante le fasi dell’attacco per qualche incidente) è quello di essere catturati.
Sul piano strategico, le esaltazioni degli incursori di Bocca di Serchio hanno una loro legittimità: l’unica possibilità della Regia Marina per confrontarsi con la flotta mediterranea britannica sarebbe un attacco improvviso, da lanciare con i mezzi d’assalto nelle primissime ore del conflitto. Per fare questo sarebbero però necessarie due condizioni: da un lato, disporre di mezzi d’assalto e di operatori preparati in quantità adeguata alle esigenze di un attacco di massa; dall’altro, avere comandanti della Regia Marina dinamici, pronti alle operazioni offensive. Entrambe queste condizioni mancano. I mezzi si limitano a qualche decina di unità e gli incursori all’altezza sono forse ancora di meno, perché lo stato maggiore sostiene l’esperienza della I flottiglia MAS, ma non ha mai pensato di farne una struttura portante della propria strategia. Gli investimenti nella ricerca ne sono una prova: gli uomini di Bocca di Serchio non sono supportati da tecnici esterni ma provvedono in proprio allo sviluppo dei mezzi, col risultato che i siluri a lenta corsa sono mezzi semiartigianali, assai più «capricciosi» che complessi, soggetti a inconvenienti (funzionamento difettoso delle batterie e delle pompe, instabilità sull’acqua, problemi nel sistema di esplosione dei siluri). A questo si aggiunge che anche l’equipaggiamento, pur studiato e prodotto al di fuori della base, presenta molti limiti: le mute subacquee sono fatte con materiali non garantiti, facili agli strappi, mentre gli autorespiratori talvolta perdono le riserve di ossigeno e costringono gli uomini immersi a risalire rapidamente in superficie.
Nel momento in cui scoppia il conflitto e la Regia Marina viene coinvolta nelle pagine buie di Punta Stilo, di Capo Matapan, di Taranto, del bombardamento di Genova, gli incursori subacquei rappresentano una riserva di potenzialità offensive da spendere con qualche operazione fortunata: se non bastano a cambiare gli equilibri

139
nel Mediterraneo, queste azioni possono però servire a veicolare nell’opinione pubblica un’immagine di ardimento.
Da Creta a Gibilterra
La flotta britannica dispone di tre basi principali nel Mediterraneo: quella strategicamente più importante è Malta, munitissima nelle sue fortificazioni di La Valletta, posta a ridosso dei collegamenti tra l’Italia e la Libia, in posizione centrale rispetto alle operazioni su tutto lo scacchiere. Il limite di Malta è però la sua vulnerabilità rispetto agli attacchi aerei: partendo dagli aeroporti della Sicilia e dell’Italia meridionale, gli apparecchi della Regia Aeronautica e della Luftwaffe possono colpire obiettivi sull’isola. L’ammiraglio Cunningham decide perciò di concentrare le sue maggiori unità nei porti di Gibilterra e di Alessandria d’Egitto, lontane dalle basi operative dell’aviazione nemica. Gibilterra è una roccaforte naturale, con una base realizzata sul versante atlantico, che costringe gli attaccanti a superare preliminarmente lo stretto; Alessandria è invece un centro dotato di ogni sistema difensivo da terra, dall’aria e dal mare. In entrambi i casi, si tratta di porti molto distanti dall’Italia e questo aumenta i problemi per l’impiego dei mezzi d’assalto: l’azione richiede giorni di navigazione per l’avvicinamento, col rischio di essere avvistati dal nemico e con la probabilità che nel frattempo mutino le condizioni tattiche dell’attacco (diverse condizioni meteomarine, partenza improvvisa dei bersagli, variazioni nei dispositivi di vigilanza e difesa). La pianificazione e la preparazione di un attacco richiedono perciò molto tempo e la buona riuscita è legata a condizioni favorevoli che in parte non dipendono dalla capacità degli incursori.
Il primo tentativo di incursione subacquea risale a fine agosto 1940: sollecitata dai comandi della Regia Marina, la Flottiglia MAS prepara un attacco ad Alessandria con quattro SLC e destina come equipaggi gli elementi migliori, da Tesei e Toschi a Gino Birindelli.2 Gli operatori e i siluri vengono imbarcati il 17 agosto a La Spezia sulla torpediniera Calipso con destinazione la baia di Menelao, in Cirenaica, nel golfo libico di Bomba; lì il 21 successivo li raggiunge il sommergibile Iride, comandato dal tenente di vascello Francesco Brunetti, destinato al trasporto degli incursori sino all’imbocco del porto di Alessandria, e la motonave Monte Gargano, che issa la bandiera dell’ammiraglio comandante la Marina italiana in Libia. Quando il passaggio del personale e dei mezzi dalla Calipso all’Iride è

140
ormai completato, giungono però tre aerosiluranti inglesi che, volando a una quota di 30-40 metri, centrano in pieno l’Iride e la Monte Gargano: il sommergibile si inabissa sulla prua e affonda in pochi secondi, senza che l’equipaggio possa uscire dal portello, mentre l’affondamento della motonave è più lento e i marinai possono buttarsi in acqua, da dove la Calipso li trae in salvo. L’area scelta per il trasbordo è d’altra parte a rischio, perché i controlli e gli attacchi aerei degli inglesi sulle coste libiche sono frequenti: il comandante della flottiglia MAS, Giorgini, ha proposto di usare come base d’attacco l’Egeo, meno sorvegliato, ma non è stato ascoltato: in qualche modo, gli affondamenti del golfo di Bomba sono una tragedia annunciata. Il seguito è una corsa contro il tempo, con gli incursori di Bocca di Serchio impegnati non a minare le navi ancorate ad Alessandria, ma a cercare di mettere in salvo i marinai dell’Iride, imprigionati a 20 metri di profondità. L’operazione è complicatissima perché il portello si è incastrato nella struttura metallica e non si riesce a sbloccarlo: la soluzione si trova solo il mattino del 22, legandolo con un cavo di acciaio a un motopeschereccio, che riesce finalmente a strapparlo dal suo seggioliberarlo. Dei 9 membri dell’equipaggio, 2 sono morti e altri 2 moriranno dopo il salvataggio per emorragie interne: solo cinque riescono a sopravvivere.
La missione è fallita prima ancora di iniziare, ma a Bocca di Serchio si continua a lavorare. Proprio in quelle settimane, viene messo a punto un sistema diverso per trasportare i siluri sui sommergibili, con la realizzazione di grandi cilindri a tenuta stagna, uno collocato a proravia della torretta e due a poppavia, all’interno dei quali si possono conservare gli SLC. Il primo utilizzo dei cilindri si ha un mese dopo, il 21 settembre 1940, quando parte da La Spezia il sommergibile Gondar, come l’Iride comandato dal tenente Brunetti e con a bordo tre equipaggi di incursori. La navigazione sino al Mediterraneo orientale procede tranquilla e nella notte tra il 28 e il 29 il Gondar raggiunge le acque egiziane, ma quando sta per rilasciare i siluri riceve un messaggio dai comandi di Roma in cui si ordina di rientrare a Tobruk. La comunicazione è dovuta al fatto che Supermarina ha saputo che molte unità della Mediterranean Fleet hanno lasciato Alessandria e che la base è dunque senza bersagli importanti. Brunetti inverte la rotta e si dirige verso la Libia, ma dopo poche miglia il sommergibile è avvistato dal cacciatorpediniere australiano Stuart D00, che lo mette sotto caccia investendolo con scariche intermittenti di bombe di profondità. Nonostante i tentativi di sfuggire all’attacco, il Gondar è colpito più volte e alle 8.30 del 29

141
settembre è costretto a emergere: gli uomini dell’equipaggio hanno appena il tempo di abbandonare il mezzo, e il sommergibile si inabissa, mentre i marinai vengono catturati. Anche la seconda missione fallisce e Alessandria d’Egitto sembra diventare un obiettivo impraticabile.
Nei mesi successivi altre iniziative vengono abbozzate, in appoggio alle operazioni terrestri nella campagna d’Africa: una ha successo a Suda, sulle coste cretesi, dove nel marzo 1941 l’incrociatore York viene danneggiato dai barchini esplosivi (mezzi più elementari dei MAS, che devono essere lanciati contro il bersaglio col bloccaggio del timone e immediatamente abbandonati dal pilota che si getta in mare). Si tratta di un’operazione minore, che non ha grande impatto propagandistico sia perché Suda è una località pressoché sconosciuta, sia perché il barchino è una sorta di proiettile a pelo d’acqua e non ha il fascino dell’attacco dalle profondità marine. Fallisce invece l’attacco a La Valletta nella notte del 25-25 luglio 1941, un’azione combinata tra mezzi di superficie e mezzi subacquei, decisa per l’insistenza di Tesei, nonostante le perplessità di altri incursori: i barchini esplosivi sono infatti mezzi per azioni rapide, che in brevissimo tempo possono essere portati alla massima potenza e velocità e lanciati contro il bersaglio senza preoccuparsi del rumore o della scia; i siluri a lenta corsa sono invece concepiti per incursioni occulte, da realizzarsi in tempi lunghi nel silenzio e nell’oscurità. In parte per il malfunzionamento dei mezzi, in parte perché gli inglesi si accorgono dell’incursione, l’attacco fallisce e muoiono gli incursori, tra cui Tesei e il comandante Moccagatta.
Gibilterra e il mito dello Scirè
A Vittorio Moccagatta subentrano come responsabili della X MAS dapprima Junio Valerio Borghese, quindi il capitano di fregata Ernesto Forza. Entrambi decidono che è ora di impiegare in modo più deciso i siluri: se le loro azioni riescono, la violazione dei porti può avere effetti devastanti, perché le cariche esplosive poste sotto la carena delle navi provocano danni maggiori rispetto a quelli dei barchini lanciati a pelo d’acqua e dei bombardamenti dall’aria. Rinunciato all’obiettivo di Malta (che nel prosieguo della campagna d’Africa e nello stabilizzarsi del fronte perde di nuovo importanza strategica), Forza e Borghese decidono di puntare su Gibilterra. Non si tratta di una novità tattica. Una prima azione sulla base all’estremità occidentale del Mediterraneo è stata fatta nel settembre 1940,

142
interrotta perché nel frattempo la flotta britannica è uscita dalla base; una seconda è stata realizzata un mese dopo, nella notte tra il 29 e il 30 ottobre. Il sommergibile Scirè, con i tre siluri nei cilindri e a bordo i sei incursori, ha iniziato il viaggio di avvicinamento da La Spezia il 21 ottobre e il 26 è giunto nei pressi del faro di Punta Almina, a ridosso di Gibilterra. Per tre notti consecutive, Borghese ha cercato inutilmente di superare lo stretto in immersione: le insidie dei fondali, il susseguirsi di intense correnti di marea e i grandi sbalzi dell’intensità dell’acqua hanno costretto lo Scirè a tornare indietro. Il passaggio è riuscito la notte del 29: dopo essere rimasto sino al pomeriggio in immersione a 72 metri di profondità, posato su un fondo pietroso, verso le 17.00 il sommergibile ha cominciato a scivolare verso bassi fondali, trascinato dall’intensa corrente di marea. Il comandante ha fatto risalire il mezzo sino a una quota di 57 metri e ha iniziato il passaggio.
Lo stretto è pattugliato sorvegliato dagli inglesi, in superficie ci sono transiti di cacciatorpediniere e di motovedette di pattuglia e per non essere scorto lo Scirè ha dovuto mantenersi in profondità: Borghese ha trovato difficoltà a mantenerlo in quota, ma ha insistito nel tentativo e alle 20.00 lo stretto è stato superato. Nel buio della notte, il sommergibile è emerso e ha rilasciato i tre siluri, che sono avanzati silenziosi. Due di essi hanno avuto varie avarie e gli incursori hanno dovuto abbandonarli, mentre il terzo, con Gino Birindelli e Damos Paccagnini, è invece riuscito a penetrare nel porto e a dirigersi verso la corazzata Barham, ma quando è giunto a 70 metri dall’obiettivo hanno smesso di funzionare gli autorespiratori: per i due incursori è diventato impossibile trascinare la testata del siluro sott’acqua e sono dovuti riemergere. Individuati dai marinai inglesi della base, sono stati entrambi catturati, dopo essere riusciti a fare affondare il mezzo.3 Un’analoga azione senza esito c’è stata il 15 maggio 1941: lo Scirè è di nuovo riuscito a superare lo stretto e a sbarcare gli incursori a poca distanza da Gibilterra, ma ancora il cattivo funzionamento dei mezzi e degli autorespiratori ha impedito l’attacco.
Il quarto tentativo di forzare Gibilterra viene deciso da Forza e Borghese nella tarda estate del 1941 e viene pianificato al meglio. Prima dell’imbarco sullo Scirè, i siluri vengono controllati in ogni particolare, così come gli autorespiratori e il resto dell’equipaggiamento, provati più volte nelle immersioni a Bocca di Serchio. Un nuovo fallimento potrebbe minare la credibilità dei reparti d’assalto, pregiudicandone la stessa esistenza. Il sommergibile inizia il

143
trasferimento il 16 settembre, il 18 attraversa lo stretto nelle stesse difficili condizioni delle altre volte, aggravate dalle precauzioni prese dagli inglesi dopo la cattura di Birindelli e Paccagnini: oltre alle forti correnti di marea, vi sono l’impiego incrociato di motovedette, il lancio intermittente di bombe di profondità, l’ascolto subacqueo con ecogoniometri, l’uso continuo e a tutto spettro dei proiettori. L’abilità di Borghese permette allo Scirè di passare inosservato in mezzo alle difese nemiche, e nella tarda serata del 19 settembre i tre siluri vengono messi in acqua a poca distanza dall’imboccatura del porto.
Gli obiettivi fissati dal comandante sono ambiziosi: per gli equipaggi di Decio Catalano e Giuseppe Giannoni e di Amedeo Vesco e Antonio Zorzoli, la grande nave da battaglia Nelson; per l’equipaggio di Licio Visintini e Giovanni Magro la portaerei Ark Royal. La presenza nella base degli incrociatori Hermione e Sheffield, segnalata dalle ricognizioni aeree, permette eventuali attacchi alternativi. Le operazioni di avvicinamento e di penetrazione oltre le ostruzioni avvengono lentamente ma senza incidenti: questa volta i siluri e gli autorespiratori sono all’altezza e non creano problemi di mal funzionamento. Nel buio della notte, gli incursori non riescono però a individuare i bersagli previsti: le navi all’ancora sono molte, i profili delle une nascondono quelli delle altre, l’area da perlustrare è ampia e bisogna spesso muoversi in immersione per non essere intercettati. Dopo due ore di ricerca, quando ormai si avvicina l’alba, i tre equipaggi decidono di puntare su altre unità: Catalano la motonave armata Durham, un mezzo moderno e veloce, di circa 11.000 tonnellate; Vesco la nave cisterna Fiona Shell; Visintini la petroliera militare Denbydale.
Le cariche esplosive vengono staccate dal siluro e i palombari le fissano alla carena dei rispettivi obiettivi: tutto avviene secondo le regole imparate a Bocca di Serchio, nel più assoluto silenzio e senza destare sospetti nell’accorta vigilanza difensiva. Terminate queste operazioni i sei incursori si allontanano, affondano gli SLC e raggiungono nuotando la costa spagnola, dove grazie alla complicità del regime franchista è stato possibile predisporre un piano di salvataggio da parte della missione italiana di Algeciras. Tra le 8.30 e le 9.00 si odono le esplosioni: le navi sobbalzano sul mare, dalla Fiona Shell, carica di nafta e di benzina, si diffonde un incendio. L’incursione è riuscita: la Denbydale (prima unità della Royal Navy a essere colpita all’interno della base di Gibilterra) viene gravemente danneggiata a prua; la Fiona Shell si squarcia in due e affonda tra le fiamme del suo carico; la Durham viene trainata dai rimorchiatori

144
verso una secca e lì lasciata incagliare. In totale, secondo le stime dello stato maggiore italiano, sono state messe fuori combattimento oltre 37.000 tonnellate di naviglio militare.4 Dopo questo successo, gli incursori subacquei sono pronti per l’impresa che li consegnerà alla leggenda, l’attacco riuscito alla base di Alessandria d’Egitto del 19 dicembre 1941.
Lo Scirè dall’isola di Lero ad Alessandria d’Egitto
Il 9 dicembre 1941 il sommergibile Sciré giunge a Portolago, nell’isola di Lero (nel Dodecaneso), dopo una navigazione iniziata a La Spezia cinque giorni prima: al comando vi è sempre il principe Junio Valerio Borghese, da poco promosso capitano di fregata. Il trasferimento, nelle acque irrequiete del Mediterraneo in guerra, è stato relativamente tranquillo: solo al largo della costa siciliana lo Scirè ha avvistato un sottomarino inglese in emersione e per un tratto le due imbarcazioni hanno proceduto di fatto fianco a fianco, ma nessuno ha lanciato l’allarme. Forse gli inglesi non si sono accorti del sottomarino italiano, o forse avevano altri obiettivi da raggiungere: certo è che dopo un’ora hanno cambiato rotta e si sono allontanati, silenziosi come erano apparsi. Per il resto della navigazione, nessuna emergenza. All’alba dell’8 lo Scirè si è trovato a navigare tra rottami che galleggiavano sulle onde, resti di un convoglio colpito nella notte, ma non si sono visti naufraghi, solo giubbotti di salvataggio che nessuno aveva avuto tempo di indossare: il principe Borghese ha potuto proseguire la traversata sino alla destinazione prevista, raggiunta la sera del 9.
Per due giorni l’equipaggio (oltre al comandante, 3 ufficiali e 32 tra sottufficiali e marinai) riposa e riprende le forze, perché la navigazione a bordo di un sottomarino richiede uno sforzo fisico notevole, con il caldo e l’umidità che rendono l’aria mefitica: . il giorno L’11 arrivano a Lero 10 assaltatori subacquei, gli equipaggi degli SLC destinati a entrare in azione nella prossima impresa. I dieci uomini sono stati trasferiti in aereo da Roma a Rodi, quindi traghettati a Portolago: il comandante Borghese ha voluto evitare loro la navigazione dall’Italia perché risparmiassero energie. Essi sono divisi in 5 equipaggi, 3 destinati all’azione e 2 di riserva. Il primo equipaggio ha come guidatore il marchese Luigi Durand de la Penne, nato a Genova nel 1914, appartenente a una nobile famiglia di origine francese, figlio di un capitano di fregata della Regia Marina: uomo intrepido, dal carattere burbero ma capace di spunti di simpatia, egli

145
coniuga l’audacia caratteriale, che lo avvicina al modello comportamentale fascista, al forte senso delle istituzioni, che dopo l’armistizio dell’8 settembre lo porterà a partecipare alla guerra di liberazione e dopo il 1948 a una lunga militanza parlamentare nelle file del Partito liberale.5 Il suo secondo è un sottufficiale valtellinese nato a Sondalo nel 1912, Emilio Bianchi: alto e asciutto nel fisico, marinaio quasi per caso, palombaro imbarcato sulla nave idrografica Ammiraglio Magnaghi, poi sull’incrociatore Fiume, Bianchi nel 1937 entra a far parte della I flottiglia MAS come sergente e diventa assaltatore subacqueo. Nelle azioni, il suo ruolo principale è quello di fissare la testata esplosiva alla carena della nave.6
Il secondo equipaggio è formato da due istriani: il capo guida è il capitano del genio navale Antonio Marceglia, nato a Pirano nel 1915, come Durand de la Penne audace e lealista: dopo l’armistizio parteciperà anche lui alla guerra di liberazione accanto alle truppe alleate, per poi lasciare la Marina, entrare nel mondo della finanza, e diventare membro del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Il suo secondo è il marinaio scelto Spartaco Schergat, il più giovane del gruppo, nato a Capodistria nel 1920, volontario dal marzo 1940, privo di istruzione superiore ma affidabile e intrepido sul piano operativo: anche lui dopo la guerra lascerà la Marina per trovare un modesto impiego statale come custode all’università di Trieste. Affiatati tra loro, legati dalla comune origine istriana, precisi nell’esecuzione delle operazioni, dal punto di vista militare sono uno degli equipaggi dei SLC meglio assortiti.7
Il terzo equipaggio è invece formato da meridionali: il pilota è Vincenzo Martellotta, nato a Taranto nel 1913, un ufficiale che prima ha studiato all’Istituto superiore di guerra di Torino e presso il Politecnico di questa città ha conseguito la laurea in Ingegneria industriale, quindi si è formato all’Accademia navale di Livorno. Tra gli assaltatori subacquei giunti a Lero, è quello ad avere la maggiore competenza specifica, prezioso non solo nel momento dell’azione, ma anche per risolvere i problemi tecnici inevitabili in mezzi meccanici che operano al limite delle possibilità. Con Martellotta vi è un salernitano, il marinaio scelto Mario Marino, nato nel 1914, volontario dal 1934, un «veterano» che prima di diventare assaltatore subacqueo ha partecipato alla guerra d’Etiopia e a quella di Spagna. 8 La trasversalità sociale e regionale della composizione è simbolica: l’aristocratico e il custode, l’ingegnere e il futuro uomo di finanza, uomini nati sul mare e uomini nati tra le montagne, i meridionali, gli istriani, i lombardi, i liguri. Probabilmente l’aggregazione è frutto del

146
caso, ma certo rinvia all’immagine di nazione in guerra che il regime propone, con classi sociali e gruppi regionali rimescolati in uno stesso sforzo di affermazione: non è un elemento secondario, in un’impresa dove la spendibilità propagandistica è ancora maggiore dell’efficacia militare.
L’obiettivo dell’incursione è la rada di Alessandria d’Egitto: il comandante Ernesto Forza e il principe Borghese preparano l’azione avvalendosi delle poche informazioni disponibili. Alcune indicazioni per studiare la rotta vengono da documenti recuperati nel relitto del cacciatorpediniere britannico Mohawk, affondato il 16 aprile 1941 nei bassi fondali della costa tunisina durante una missione contro il convoglio Tarigo, diretto in Africa settentrionale con rifornimenti per lo più tedeschi: i sommozzatori italiani, intervenuti subito dopo la battaglia, hanno recuperato l’attrezzatura radar e trovato numerosi materiali, tra cui alcune mappe indicanti i campi minati attorno ad Alessandria d’Egitto. Dalle conoscenze geografiche si sa invece che il fondale ha una profondità di 17 metri e per questo si pensa che le ostruzioni possano essere comunque superate. Un aiuto più consistente viene dalle ricognizioni aree che, partendo dagli aeroporti della Grecia ormai saldamente occupata dall’Asse, cercano di localizzare le navi britanniche. La Mediterranean Fleet, infatti, non è un’entità statica, ma una flotta in piena attività: «Le navi da guerra entrano ed escono di frequente da Alessandria e di frequente effettuano sortite, quasi a filo di costa, per bombardare le linee e le retrovie italo-tedesche in Libia».9 Per operare efficacemente, bisogna che gli incursori sappiano quali sono le navi ormeggiate e quale la loro posizione, in modo da individuare i bersagli da colpire nonostante il buio. Le ricognizioni aeree, tuttavia, sono fortemente contrastate dal tiro della contraerea e ciò che individuano non è così accurato da consentire di definire un piano di operazioni particolareggiato. Come sempre quando si tratta di incursioni, l’impresa di Alessandria d’Egitto dovrà per buona parte affidarsi alla capacità di iniziativa e di improvvisazione sul campo.
Ciò che Forza e Borghese definiscono in modo preciso, in base alla fase lunare del mese, è che l’operazione debba svolgersi tra il 14 e il 20 dicembre, la più adatta per le condizioni del cielo e delle maree. In quei giorni lo Scirè dovrà lasciare Lero e avvicinarsi all’obiettivo, fermandosi a circa 5 miglia dalla costa: per ovviare alla mancanza di informazioni certe, si stabilisce che il sottomarino giunga in prossimità della costa nelle ore diurne (nonostante i bassi fondali aumentino il rischio di essere avvistato) perché possa orientarsi sul

147
rilevamento dei pochi punti elevati presenti. Una volta sganciati in mare, gli equipaggi degli SLC dovranno navigare per circa due ore e mezzo prima di raggiungere l’imboccatura del porto: dopo di che ognuno agirà sulla base delle indicazioni dell’ultima ora, che il comandante Forza trasmetterà da Atene dopo le ultime osservazioni aeree. Nessun piano viene invece fatto per il recupero degli equipaggi: a differenza dell’operazione su Gibilterra, l’Egitto è territorio nemico e non è verosimile inviare missioni. Gli equipaggi sanno che, se sopravvivono, saranno comunque fatti prigionieri.
Lo Scirè inizia la navigazione il 15 dicembre tra immersioni e riemersioni, il 17 è a 50 miglia da Alessandria, ma contrariamente alle previsioni meteorologiche il tempo peggiora e l’attacco deve essere rimandato. Borghese mantiene in zona il sommergibile, mentre a bordo sale la tensione, poi il 18 le condizioni del mare migliorano, il vento cessa e l’acqua si fa placida e piatta: nel primo pomeriggio da Atene giungono informazioni finalmente dettagliate, che indicano la presenza nel porto delle corazzate Queen Elizabeth e Valiant con i relativi punti di ormeggio e, forse, quella di una portaerei. È l’ora di entrare in azione. Alle 15.00 lo Scirè raggiunge l’isobata di 400 metri, dove inizia l’area pericolosa per la presumibile presenza di mine e bisogna navigare in profondità. Borghese scende a oltre 60 metri e avanza cauto e lento vero la costa, mentre il fondale diminuisce rapidamente; alle 17.00 il sommergibile è a quota 50 metri, alle 18.30 è a 17 metri e si trova a poco più di un miglio a nord del molo di ponente del porto commerciale. A bordo, il principe Borghese affida gli incarichi agli incursori: l’equipaggio Durand de la Penne - Bianchi attaccherà la corazzata Valiant, al posto d’ormeggio n. 57; Marceglia-Schergat la nave ammiraglia Queen Elisabeth, posto d’ormeggio n. 61; Martellotta-Marino cercheranno la portaerei e, in assenza di questa, attaccheranno una nave cisterna carica, disponendo poi ordigni incendiari per cercare di provocare un vasto incendio.
Quando arriva a soli 14 metri di profondità, il sommergibile si ferma e sale in affioramento per la messa a mare dei tre «maiali». Sono le 20.47 di una notte chiara e stellata ma senza luna, non c’è un soffio di vento, il Mediterraneo offre il suo incanto notturno. Per un momento, il conflitto appare remoto: «Ricordo che la guerra non mi sembrò mai così lontana come in quel momento» dirà Durand de la Penne.10 Alle 21.30 i tre equipaggi salgono a cavalcioni sui «maiali» e si mettono in rotta, mentre la torretta dello Scirè scompare sott’acqua e il sommergibile riprende la via di Lero, che raggiungerà la sera del 21 dicembre.

148
Gli inglesi non sono riusciti ad avere nessuna informazione preventiva sull’attacco italiano, che è stato preparato e condotto in assoluta segretezza: tuttavia, dopo gli episodi di Gibilterra, non possono ignorarne il rischio. L’ammiraglio Cunningham scrive infatti a Londra il 14 novembre parlando di possibili attacchi di incursori e chiedendo l’invio di nuovi materiali di sorveglianza, in particolare di radar del tipo 271, adatti alla localizzazione di piccoli bersagli, e di ecogoniometri, apparecchi che grazie alla riflessione di ultrasuoni rilevano ostacoli sommersi. Le richieste saranno soddisfatte dall’ammiragliato di Londra ma i materiali arriveranno ad Alessandria d’Egitto dopo l’attacco del principe Borghese: nel frattempo, le misure di sorveglianza restano quelle ordinarie di una base avanzata in tempo di guerra. L’unico rafforzamento è rappresentato da motovedette che pattugliano l’imboccatura del porto muovendosi lentamente e gettando a intervalli regolari cariche in profondità per interdire azioni subacquee.
L’atteggiamento di apparente sottovalutazione deriva da un’eccessiva sicurezza sull’inviolabilità di Alessandria e sulla resistenza delle reti metalliche e degli altri apparti difensivi che bloccano l’accesso; inoltre, gli inglesi suppongono che dopo la sconfitta di Capo Matapan gli italiani non siano più in grado di agire nel Mediterraneo orientale, dove da mesi non effettuano azioni significative. L’inchiesta condotta dalla Marina britannica appurerà che nella notte tra il 18 e 19 dicembre lo sbarramento esterno resta aperto a intervalli per un totale di oltre cinque ore: entrano nel bacino due incrociatori, nove cacciatorpediniere, un peschereccio in avaria, una baleniera norvegese, mentre escono sette unità minori. Inoltre, tra le 00.55 e le 1.26, viene inspiegabilmente interrotto per mezz’ora il lancio delle minicariche subacquee da 2,5 etti. Indubbiamente vi sono smagliature nel sistema difensivo, che spaziano dalla carenza di pattuglie in mare al malfunzionamento dei posti di osservazione, alla mancata individuazione preventiva dello Scirè in navigazione su fondali poco profondi. Quali che siano le ragioni della leggerezza inglese, Durand de la Penne e gli altri incursori sanno approfittare con freddezza delle opportunità, perché le imprese più improbabili riescono quando il valore dei protagonisti si intreccia con la fortuna delle circostanze.
I tre SLC si muovono lentamente verso il porto navigando in superficie e l’avvicinamento avviene senza intralci: verso la una i tre equipaggi giungono all’estremità del molo esterno e i palombari si preparano a immergersi davanti alle ostruzioni metalliche per provare

149
a sollevarle, così come tante volte è stato fatto durante le esercitazioni. All’improvviso, la sorpresa: nel buio si vedono avanzare i profili di tre grandi imbarcazioni, che navigano senza luci a una velocità di circa 10 nodi e che si dirigono verso il porto. Gli incursori non possono saperlo, ma si tratta di tre cacciatorpediniere della squadra dell’ammiraglio Philip Vian, di ritorno dalla battaglia della Sirte. All’improvviso, si accendono il faro principale e le luci di segnalazione del porto, mentre le reti di ostruzione subacquee si schiudono: si apre un varco per far entrare i cacciatorpediniere e gli inglesi non adottano nessuna misura di sicurezza mirata. Nessuna motovedetta di pattuglia accanto alle navi da guerra, nessun fascio di luce per controllare il mare, nessuno strumento di intercettazione attivo. Senza bisogno di consultarsi tra loro, gli equipaggi degli SLC capiscono che è il momento di entrare in azione e, navigando in immersione, si infilano dietro ai cacciatorpediniere senza che i nemici si accorgano di nulla Quando lo sbarramento si richiude, alle 1.15, l’impenetrabile base di Alessandria d’Egitto è stata violata dagli incursori italiani, con la Royal Navy che ha inconsapevolmente aperto loro l’accesso. Una volta entrati nel porto, i tre SLC entrano in azione separatamente, ognuno verso gli obiettivi che sono stati assegnati.
La «Queen Elisabeth», la «Valiant» e la «Sagona» colpite
L’azione più lineare e perfettamente riuscita è quella degli istriani Antonio Marceglia e Spartaco Schergat, ai quali è assegnata la nave ammiraglia di Cunningham, la Queen Elisabeth: essi scivolano fra le navi ormeggiate, scorgono lungo un molo due incrociatori, più avanti un mercantile, quindi la nave da battaglia francese Lorraine in stato di internamento. Poco oltre, a circa 300 metri di distanza, emerge la sagoma imponente della Queen Elisabeth. Il «maiale» si avvicina, giunto a soli 30 metri Marceglia si immerge. L’impossibile, vagheggiato nei mesi di esercitazione, si sta avverando: l’ammiraglia della Mediterranean Fleet è a portata di cariche esplosive, una massa enorme di ferro e di armamenti che due piccoli uomini soli possono affondare.
«L’assetto dell’apparecchio è pesante» scrive Marceglia, «la sua velocità di caduta aumenta via via che si scende. Sento un acuto dolore all’orecchio, poi finalmente tocchiamo il fondo a 13 metri sollevando una nuvola di fango». Il «maiale» inizia a strisciare sul fondo, il rumore di un motore alternativo (probabilmente la centrale elettrica di bordo) si fa sempre più forte via via che ci si avvicina.

150
Schergat va in ricognizione risalendo a nuoto verso la carena, poi ridiscende facendo segno al suo capo guida di proseguire ancora di qualche metro: nuova ricognizione, e questa volta la posizione è giusta.
Do aria alla cassa di emersione, l’apparecchio si muove e salendo urta con violenza contro lo scafo della nave. Siamo in corrispondenza dell’aletta di dritta, alla quale assicuro l’apparecchio con un morsetto, mentre il palombaro raggiunge l’altra aletta per assicurare il collegamento.
Fissato il cavo, Schergat stacca la carica ma comincia a sentirsi male, perché la lunga permanenza nella respirazione in ossigenocon il respiratore e il lavoro a 10 metri di profondità gli hanno prodotto un inizio di avvelenamento da ossigeno, con le caratteristiche scosse epilettiche. Nonostante tutto, il palombaro rimane ancora sott’acqua: Marceglia lo aiuta nel trasportare la testa esplosiva dell’SLC, che viene attaccata alla cima a un metro e mezzo dalla chiglia, la distanza ritenuta ideale per arrecare il maggior danno possibile alla nave. I due uomini risalgono sul «maiale» e si allontanano:
Alle 3.25 allago la cassa di emersione, mi stacco dalla nave e ricado sul fondo, riprendendo a strisciare. Le condizioni del mio secondo si sono fatte quanto mai precarie, mi fa ripetuti segni di risalire, finalmente do aria alla cassa di emersione, ma la risalita diventa agitata e usciamo dall’acqua in mezzo ad un ribollio.
Da bordo della Queen Elizabeth qualcuno si accorge dell’increspatura dell’acqua e da poppa viene acceso un piccolo riflettore che perlustra lo specchio attorno: Marceglia mette la testa sott’acqua, Schergat fa uno sforzo estremo e lo imita nonostante i sintomi dell’avvelenamento. Dopo qualche minuto il riflettore si spegne e il «maiale» può allontanarsi facendo in senso inverso la rotta di arrivo, mentre Schergat, respirando l’aria pura della notte, si riprende in fretta. L’equipaggio raggiunge una zona dove l’acqua sembra profonda:
Qui ci leviamo i respiratori, li sventriamo e li affondiamo. Poi appesantisco l’apparecchio, metto in moto l’autodistruttore e affondo il nostro SLC 222. A nuoto ci dirigiamo lentamente verso una banchina, alle 5.30 circa tocchiamo terra.11
Mentre i due incursori cercano di allontanarsi, alle 5.47 nel porto si sente l’eco sorda di un’esplosione subacquea; verso le 6.00 una seconda, quindi subito dopo una terza. Quest’ultima è dovuta alla carica fissata da Marceglia e Schergat, che solleva la Queen Elizabeth e la lascia ricadere con un grande squarcio nella chiglia: l’ammiraglio Cunnigham, che è riunito a bordo con i suoi ufficiali per esaminare la

151
situazione dopo le due esplosioni precedenti, viene sbalzato in aria per oltre un metro e ricade pesantemente. Nella sua relazione, gli effetti dell’attacco sono riassunti nel linguaggio asciutto dei danni constatati:
Tre locali caldaie erano allagati e non riuscimmo a ottenere vapore. Lo sbandamento fu compensato allagando i compartimenti dall’altro lato, ma, con qualche migliaio di tonnellate di acqua a bordo, la Queen Elizabeth era molto bassa sul livello del mare. Facemmo affiancare un sommergibile da ciascun lato che ci assicurasse forza motrice e in ventiquattro ore riuscimmo a produrne noi stessi, ma vi era uno squarcio di oltre 4 piedi quadrati sotto il locale delle caldaie prodiere, e la nave era per il momento fuori combattimento.12
Più complesso nella fase iniziale ma ugualmente perfetto nell’esecuzione è l’attacco di Vincenzo Martellotta e Mario Marino. Entrati nel porto, essi cercano la portaerei di cui si è ipotizzata la presenza, ma non hanno indicazioni di ormeggi né la certezza che la nave sia effettivamente ad Alessandria. Silenziosi, essi navigano a pelo d’acqua tra le sagome scure della Mediterranean Fleet, un’ora di ricerca fra tante unità allineate, cacciatorpediniere, incrociatori, mercantili, navi cisterna, tutte senza luci per non favorire le incursioni aeree. Martellotta decide di dirigersi verso l’area d’ormeggio delle petroliere e puntare al bersaglio alternativo fissato dal comandante Borghese, una nave cisterna da far esplodere sperando di scatenare un incendio nelle acque portuali: la più grossa che i due incursori individuano è la Sagona, battente bandiera norvegese, una petroliera di 16.000 tonnellate. Accanto a essa è ormeggiata una nave più piccola, che a distanza Martellotta scambia per un’altra petroliera, mentre si tratta del cacciatorpediniere Jervis.
Pur con qualche difficoltà nelle immersioni dovute alla perdita dello stringinaso e alla conseguente respirazione nasale di anidride carbonica, i due riescono a fissare la testata esplosiva alla carena della petroliera, poi fanno scendere l’SLC a 17 metri di profondità, avviano l’autodistruttore e abbandonano l’apparecchio tornando a galla. Alle 6.00 la carica distrugge la poppa della Sagona e provoca un allagamento della sala motori, rendendo inutilizzabile la nave, ma non danneggia in modo grave i serbatoi dei carburanti e la fuoruscita di nafta è minima. In compenso, l’esplosione coinvolge il vicino cacciatorpediniere Jervis, che viene seriamente danneggiato nello scafo mentre a bordo si sviluppa un principio di incendio.
La vicenda più controversa è quella dell’SLC 221, il siluro caposquadra della missione. Entrati nella base nemica, Durand de la Penne e Bianchi raggiungono agevolmente l’ormeggio della Valiant, dove alcune reti parasiluri, sorrette da galleggianti sferici di metallo,

152
proteggono l’ancoraggio della corazzata. Superato l’ostacolo in superficie, gli incursori si trovano a 30 metri dalla nave, un’enorme montagna nera di 32.000 tonnellate, ma le loro condizioni fisiche non sono perfette: il guidatore ha le mani intirizzite dal freddo e manovra con difficoltà il mezzo, mentre il suo secondo fatica a respirare, intossicato dal troppo ossigeno della sacca-polmone assorbito durante la lunga immersione. Il «maiale» comunque viene fatto scendere sino a depositarsi sul fondale ed è direzionato verso il centro della nave da battaglia. Quando i due uomini stanno per iniziare le operazioni di inserimento della carica esplosiva, l’apparecchio si inceppa all’improvviso e non si riesce a rimetterlo in funzione: forse le eliche si sono incastrate, forse il motore è andato in avaria. Quaranta minuti di sforzi, tra strattoni, soste per riprendere energia, appesantimento e alleggerimento del siluro, di nuovo strattoni. Alla fine il «maiale» è posizionato proprio sotto la chiglia:
Non trovo le alette di rollio, ma la larghezza della nave è tale che considero essere in buona posizione. Torno sull’apparecchio, metto immediatamente in moto le spolette per evitare che un’eventuale bomba mi impedisca di portare a termine la missione. Ormai sono allo stremo, non posso fare altre operazioni di fissaggio se non appesantire il siluro, poi riesco solo a risalire in superficie lungo lo scafo. Appena a galla mi tolgo il respiratore e lo affondo: sono sotto le torri di prua.
Durand de la Penne nuota per allontanarsi, ma dopo pochi metri viene avvistato e chiamato da bordo: poiché continua a nuotare verso la banchina, gli inglesi lo illuminano con un proiettore e gli sparano una raffica di mitragliatore. A quel punto non resta che raggiungere la boa più vicina e attendere il nemico:
Vado sotto bordo e mi dirigo verso la boa di prua della corazzata e lì, con mio stupore, trovo Bianchi, che mi dice di essere svenuto e di essersi ripreso in superficie. Ho il tempo di dirgli che l’apparecchio è a posto e le spolette sono in moto, poi arriva un motoscafo con due marinai inglesi armati che ci prendono in consegna.
I due incursori vengono portati sulla Valiant, dove salgono dal barcarizzo di poppa. I due incursori vengono perquisiti sulla nave e aiutati in modo brusco a togliersi il vestito impermeabile, ma il dileggio sembra prevalere sulla preoccupazione:
Gli inglesi pronunciano frasi irridenti convinti che la nostra missione sia fallita, ci dicono che siamo solo degli «italiani». Sulla nave tutto resta calmo, non c’è nessuna allerta. Viene un ufficiale, ci chiede chi siamo e da dove veniamo e ci dice beffardo che non abbiamo avuto fortuna.

153
L’ammiraglio Cunningham, intanto, avvertito dell’arresto di due nemici attaccati a una boa nel porto, ordina che vengano portati sulla sua corazzata, dove vengono sono inutilmente interrogati, poi rinchiusi in un locale tra le due torri, ben sotto la linea di galleggiamento. Sono le 5.00 passate, non manca molto all’esplosione. Bianchi si siede per terra e si addormenta, mescolando in quel momento di abbandono la consapevolezza psicologica della missione e la stanchezza fisica accumulata. De la Penne rimane invece vigile e parla con i soldati inglesi. Alle 5.30 egli chiede di vedere l’ammiraglio Morgan:
Vengo portato a poppa alla sua presenza, gli dico che fra pochi minuti la sua nave sarebbe saltata, che non c’era più nulla da fare e che, se voleva, poteva mettere in salvo l’equipaggio. L’ammiraglio mi chiede ancora dove ho messo la carica e siccome non rispondo mi fa riportare sottocoperta. Mentre attraverso i corridoi sento gli altoparlanti che danno ordine di sgomberare la nave e vedo gente che corre verso poppa.
Alle 5.47, l’esplosione:
La nave ha una scossa fortissima. Le luci si spengono e i locali vengono invasi dal fumo. La nave si sbanda sulla sinistra di 4 o 5 gradi. Sono circondato da maniglioni che erano attaccati al soffitto e che sono cascati. Sento intanto che la nave appoggia verso il fondo e che continua a sbandare lentamente sulla sinistra.
Passato lo stordimento per l’esplosione,
i soldati di scorta salgono in confusione la scaletta, io li seguo perché non è prudente rimanere lì sotto. Trovato il portello aperto, esco all’aria e vedo la confusione prodotta dalla nostra impresa.13
Dopo Durand de la Penne e Bianchi anche gli altri quattro incursori vengono catturati dagli inglesi, Martellotta e Marino appena raggiunto un molo, Marceglia e Schergat fuori dalla base, da cui sono incredibilmente riusciti a uscire (trasferiti nei campi di prigionia in Palestina, vi rimarranno sino all’autunno del 1943): nella rada, intanto, galleggiano pezzi di ferro, assi di legno, brandelli di fune, dappertutto c’è odore di nafta, mentre i fasci di luce dei proiettori vengono mossi convulsamente e i cicalini d’allarme suonano in tutte le navi. La Mediterranean Fleet è stata attaccata, nessuno ha ancora capito come e nessuno sa se l’attacco si è concluso oppure è solo iniziato. «Tutti noi pensavamo che la marina italiana fosse incapace e inefficiente, persino vigliacca» scrive un guardiamarina inglese. «Con l’attacco degli incursori al nostro porto più sicuro, dovemmo ricrederci e riconoscere l’ingegnosità dei suoi uomini».14

154
Le conseguenze dell’attacco
I danni provocati dall’impresa degli SLC sono considerevoli: delle tre navi da guerra colpite, la Valiant, con uno squarcio lungo oltre 24 metri, rimane in riparazione per quattro mesi e solo nell’aprile 1942 riprende il mare, assegnata alla Eastern Fleet per operare contro i giapponesi; la Queen Elisabeth, dopo alcune riparazioni sommarie, nel settembre 1942 viene inviata negli Stati Uniti per un rifacimento radicale e rientra in Inghilterra nel 1943, aggregandosi anch’essa nel gennaio successivo alla Eastern Fleet; il Jervis resta due mesi in bacino di carenaggio prima di tornare a essere operativo nel Mediterraneo. Al di là delle perdite materiali, ci sono gli effetti psicologici dell’azione del 19 dicembre. La stampa britannica non dà alcuna informazione sull’entità e le modalità dell’accaduto, limitandosi a parlare di «un attacco sventato da parte di siluranti nemici» e proponendo immagini rassicuranti. Come racconta Cunningham nelle sue memorie,
allo scopo di sostenere il morale dei nostri soldati (perché si sa che certe notizie circolano, anche se la stampa le tace) e per ingannare il nemico facendogli credere che fossimo incolumi, arrivammo al punto di eseguire una fotografia la quale mostrava la cerimonia dell’alzabandiera con il picchetto, la bandiera e me a poppa, e la Queen Elizabeth apparentemente come al solito.15
Pubblicata su alcune testate britanniche, la fotografia è un’emblematica ostentazione di sicurezza.
Gli italiani hanno l’esigenza opposta: scoprire ciò che è avvenuto e subito dopo farlo sapere all’opinione pubblica. Rientrato a Lero, lo Scirè ha comunicato l’esito felice dell’avvicinamento e fornito dettagli sulla messa in acqua dei tre siluri a lenta corsa, ma la fase finale dell’impresa è ignota perché gli incursori sono stati fatti prigionieri e non hanno potuto fornire notizieinformazioni. Qualche notizia è giunta attraverso informatori locali, che hanno ripreso voci circolate tra i soldati egiziani in servizio al porto e riferito di navi affondate: la loro attendibilità è comunque da verificare. L’unica strada perseguibile è quella dei rilevamenti aerei, difficili da realizzare sulla base di Alessandria per l’allerta della contraerea, tanto che la Luftwaffe ha sospeso i sorvoli del porto. Ciò che i ricognitori tedeschi rilevano negli ultimi giorni di dicembre, perlustrando il Mediterraneo centrale, è solo che le due corazzate britanniche non sono più uscite in mare e quindi si può presumere che abbiano subito danni.
Supermarina sollecita un intervento mirato al 47o stormo della Regia Aeronautica, di stanza nell’isola di Rodi, e a partire dal 23

155
dicembre vengono effettuati sei voli di ricognizione di altura, a 7000 metri di altezza. I primi cinque non ottengono risultati, ma il sesto, effettuato il 6 gennaio 1942, permette di effettuare le fotografie planimetriche del porto egiziano. Al posto di pilotaggio è il tenente Trona, l’osservatore è il guardiamarina Ugo Schleifer, che così racconta:
Il 6 gennaio le condizioni favorevoli del tempo mi consentirono di scattare le fotografie. Il nostro aereo fu colpito dalla contraerea, ma la perizia del primo pilota, poi abbattuto nel canale di Sicilia, riuscì a limitare i danni e a riportarci alla base. Il giorno successivo venni convocato dall’ammiraglio Inigo Campioni, governatore civile e militare dell’Egeo, il quale si complimentò con me e mi riferì che gli specialisti del reparto fotografico, dopo attento esame delle lastre, avevano appurato che vi figuravano due corazzate inclinate e fuori uso.16
L’8 gennaio la notizia è confermata a Supermarina e il bollettino di guerra n. 585, pubblicato lo stesso giorno, informa che
nella notte tra il 18 e 19 dicembre, mezzi d’assalto della Regia Marina penetrati nel porto di Alessandria attaccarono due navi da battaglia inglesi ivi ormeggiate. Ora soltanto si è avuta conferma che una nave da battaglia classe Valiant rimase gravemente danneggiata e fu immessa in bacino dove trovasi tuttora.
Il giorno successivo il bollettino n. 586 precisa specifica che «dopo ulteriori precisi accertamenti, è risultato che oltre alla Valiant fu danneggiata anche una seconda nave da battaglia del tipo Barham».17 Che la seconda nave sia l’ammiraglia Queen Elizabeth si saprà solo più tardi, così come più tardi giungeranno notizie della petroliera Sagona e del cacciatorpediniere Jervis, ma ci sono comunque informazioni sufficienti per costruire il mito e la stampa si scatena: Violata la base inespugnabile di Alessandria d’Egitto titola il «Corriere della Sera» del 10 gennaio 1942; Atto di arditismo, affondate le corazzate inglesi incalza «Il Telegrafo» dello stesso giorno; la «Gazzetta del Popolo» parla di «quattro uomini a nuoto più forti della flotta inglese». Nello sviluppo della cronaca, tutti gli espedienti retorici vengono messi al servizio della celebrazione: la temerarietà dell’impresa, la sproporzione tra i mezzi d’attacco e l’imponenza della difesa, l’abnegazione degli incursori. Le testate danno molto spazio allo Scirè e al comandante Borghese, perché i particolari noti riguardano la prima fase dell’impresa, mentre sulla seconda si scrive per congetture: il sommergibile che scivola tra le mine fino all’imbocco del porto è l’immagine dell’insidia che minaccia il nemico là dove si sente più protetto, il ribaltamento attraverso il coraggio dei reali rapporti di forza.

156
La punta di massimo successo coincide però anche con l’inizio del declino degli incursori subacquei. L’impiego degli SLC è infatti legato al fattore sorpresa, intesa non solo come imprevedibilità temporale dell’azione, ma soprattutto come novità del mezzo impiegato: nel momento in cui gli inglesi vengono colpiti due o tre volte, il fattore sorpresa viene meno. Stupisce, semmai, che sia stato possibile replicare ad Alessandria d’Egitto ciò che è stato fatto poco prima a Gibilterra. Certo è che dall’inizio del 1942 i sistemi di sorveglianza e di sicurezza vengono rafforzati in tutte le basi navali e che il mare antistante viene pattugliato per decine di miglia: in questa prospettiva, i sommergibili avvicinatori rischiano di essere facilmente individuati.
A fare le spese di questo nuovo quadro operativo è proprio lo Scirè, dal marzo 1942 passato al comando del tenente di vascello Bruno Zelik. Nell’agosto successivo, il sommergibile parte da Lero e si dirige verso il porto di Haifa, dove i britannici hanno una base minore e dove devono essere rilasciati gli equipaggi di incursori. Individuato da aerei in perlustrazione mentre naviga in bassi fondali in prossimità dell’imboccatura del porto, lo Scirè viene attaccato con bombe di profondità dalla corvetta Islay e appena emerge è bersagliato dalle batterie costiere: gli uomini non hanno il tempo di mettersi in salvo, e il sommergibile affonda portando con sé tutti i 60 membri dell’equipaggio. Esito ugualmente tragico, una missione su Gibilterra del 7 dicembre 1942: tre SLC riescono a raggiungere l’accesso al porto, ma il primo equipaggio viene travolto e ucciso al momento della penetrazione dall’esplosione di una serie di bombe da getto; degli altri due equipaggi, un uomo cade in mare per effetto delle cariche di profondità e scompare, due vengono catturati e solo l’ultimo riesce a raggiungere la costa spagnola.
L’altra ragione che determina il declino dei reparti d’assalto è la perdita della maggior parte dei quadri. Tranne gli attacchi a Gibilterra (dove sono possibili le operazioni di recupero), tutte le azioni operazioni comportano il sacrificio degli incursori. Si tratta di un profilo professionale che non si sostituisce facilmente: per attaccare con gli SLC occorrono attitudini fisiche e psicologiche particolari e un lungo periodo di addestramento. Per continuare nelle operazioni la X flottiglia MAS prepara un nuovo modello di incursore, i cosiddetti «uomini gamma», nuotatori d’assalto dotati di autorespiratori capaci di percorrere lunghe distanze portando con sé piccole cariche esplosive. L’«uomo gamma» non ha difficoltà a penetrare oltre le ostruzioni ed è assai più difficilmente individuabile dai sistemi di

157
vigilanza rispetto a un mezzo come il «maiale» o il «barchino», ma la sua capacità offensiva è ridotta: le cariche portate a nuoto (dette «bauletti» o «cimici») possono provocare qualche danneggiamento, non certo affondare grandi unità nemiche. È il caso di un’impresa fatta a Gibilterra il 14 luglio 1942, con i nuotatori d’assalto che partendo dalla costa di Algeciras raggiungono gli obiettivi, ma provocano danni a piccole navi mercantili senza determinarne l’affondamento o la messa fuori uso. Di fatto, la notte di Alessandria d’Egitto del 19 dicembre 1941 segna l’apice e l’inizio della fine delle incursioni subacquee.

318
Capitolo I 1 Libero De Libero, Borrador. Diario 1933-1955, Roma, Nuova ERI, 1994, p. 187. 2 Giaime Pintor, Doppio diario 1936-1943, Torino, Einaudi, 1978, p. 73. 3 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, Milano, Rizzoli, 1980, p. 442. 4 Enrico Caviglia, I dittatori, le guerre e il piccolo re. Diario 1925-1945, a cura di Pier Paolo Cervone, Milano, Mursia, 2009, p. 172. 5 Marco Innocenti, L’Italia del 1940. Come eravamo nel primo anno della guerra di Mussolini, Milano, Mursia, 1990, p. 43. Il riferimento è alla conferenza di Monaco del settembre 1938 tra Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia, convocata per discutere delle rivendicazioni tedesche sui Sudeti, durante la quale Mussolini sembra assumere il ruolo di garante della pace europea e come tale viene osannato al suo ritorno in patria. 6 MinCulPop è l’abbreviazione, usata spesso in senso spregiativo, del ministero della Cultura popolare, istituito nel 1937 con compiti riguardanti l’organizzazione della cultura e della propaganda di regime. Inizialmente il ministero è affidato a Dino Alfieri: nell’ottobre 1939, quando questi viene nominato ambasciatore a Berlino, ne diventa titolare Alessandro Pavolini. 7 Gerhard Schreiber, La seconda guerra mondiale, Bologna, il Mulino, 2004, p. 19. 8 Idem, p. 38. 9 La nota di Mussolini è riportata in Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, in Africa Settentrionale. La preparazione al conflitto, Roma, Edizioni Ufficio Storico SME, 1955, p. 163. 10 Le considerazioni di Grandi (autore dell’ordine del giorno che il 25 luglio 1943 determina la caduta del duce) sono contenute nelle «note di diario», scritte in Portogallo nel 1943-45, in un momento in cui l’autore non può essere sospettato di voler attenuare le responsabilità del duce (la citazione è tratta da Renzo De Felice, Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943. 1. Dalla guerra «breve» alla guerra lunga, Torino, Einaudi, 1990, p. 93. 11 Idem, p. 91. 12 Idem, pp. 104-105. 13 Piero Calamandrei, Diario 1939-1945, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015 (1982), vol. I, p. 208. 14 Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna, Milano, Feltrinelli, 1974, vol. 10, p. 50. 15 Giorgio Rochat e Giulio Massobrio, Breve storia dell’esercito italiano dal 1861 al 1943, Torino, Einaudi, 1978, pp. 219-20. 16 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., p. 98. 17 Sono note le polemiche di De Gaulle e Liddell Hart contro il conservatorismo degli alti comandi francese e inglese, in particolare quelle contro la «linea Maginot», imponente e inutile sbarramento difensivo verso la Germania, figlio dell’esperienza della Prima guerra mondiale, anacronistico nello scenario di vent’anni dopo (e che invece, nell’autunno del 1939, Mussolini considera ancora «invalicabile»).

319
18 Il «promemoria Cavallero» del 30 maggio 1939 è riportato in I documenti diplomatici italiani, Roma, edizioni ministero degli Affari esteri, 1952, serie VIII, 1935-39, vol. 2 (23 maggio - 11 agosto 1939). 19 «Brandeggio» è la rotazione orizzontale del cannone: con il modello M11 è possibile sparare solo frontalmente e ogni variazione di tiro implica lo spostamento di posizione del carro. 20 Lucio Ceva, Storia delle Forze Armate in Italia, Torino, Utet, 1999, p. 265. Il cannone 47/32 (più comunemente chiamato «elefantino») è un’arma controcarro con una gittata di 7000 metri, impiegato come arma di accompagnamento per garantire alle fanterie maggiore potenza di fuoco anche contro mezzi blindati, ed è il pezzo di artiglieria più diffuso nel Regio esercito: oltre al pezzo campale, il cannone costituisce infatti l’armamento principale dei carri M13 e in Africa settentrionale viene installato sulle camionette desertiche e sulle autoblindo. L’obice 210/22 è invece un pezzo di artiglieria di grosso calibro utilizzato per l’interdizione lontana, capace di colpire ad oltre 15.000 metri di distanza. 21 Giorgio Rochat e Giulio Massobrio, Breve storia dell’esercito italiano dal 1861 al 1943, cit., p. 227. 22 Giorgio Rochat, Militari e politici nella preparazione della campagna d’Etiopia. Studio e documenti 1932-1936, Milano, Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia - Franco Angeli, 1971, p. 225. Le citazioni sono tratte da una relazione inviata al duce nel settembre 1935 da Pietro Badoglio, capo di stato maggiore generale, dopo una riunione allargata con gli ammiragli responsabili della Marina. 23 Lucio Ceva, Storia delle Forze Armate in Italia, cit., pp. 278-79. 24 Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Esercito, In Africa settentrionale. La preparazione del conflitto. L’avanzata su Sidi El Barrani, Roma, Tipografia Regionale, 1955, p. 161. 25 Giorgio Rochat, Le guerre italiane 1935-1943. Dall’impero d’Etiopia alla disfatta, Torino, Einaudi, 2005, p. 239. Capitolo II 1 Nel periodo tra le due guerre mondiali la costruzione di linee difensive fortificate è comune a tutti gli Stati europei: nascono così in Germania la «Linea Sigfrido», in Iugoslavia la «Linea Rupnik», in Grecia la «Linea Metaxas», in Unione Sovietica la «Linea Stalin», nei Paesi Bassi la «Waterlinie» («linea d’acqua»). 2 In particolare, una delle granate da 149/35 colpisce una torretta di avvistamento corazzata del vicino forte francese di Janus: l’acciaio viene parzialmente distorto, ma non perforato. 3 Edoardo Castellano, Distruggete lo Chaberton!, Torino, edizioni Il Capitello, 1984, p. 45. 4 Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, La battaglia delle Alpi Occidentali, Roma, Edizione Ufficio Storico SME, 1947, p. 115. 5 Idem, p. 128.

320
6 Quirino Armellini, Diario di guerra, Milano, Garzanti, 1946, p. 19. Il generale Quirino Armellini (1889-1975) era addetto presso il comando supremo del maresciallo Badoglio. 7 Il bombardamento di Guernica (noto per l’omonimo quadro di Pablo Picasso) fu un’incursione compiuta dalla Legione Condor dell’aviazione tedesca il 26 aprile 1937, durante la guerra civile spagnola, e colpì duramente la cittadina basca: si è a lungo sostenuto che all’operazione parteciparono anche tre aerei italiani Savoia-Marchetti S-79, ma mancano documentazioni certe. 8 Mario Montanari, L’Esercito italiano alla vigilia della 2a guerra mondiale, Roma, Edizione Ufficio Storico SME, 1982, p. 486. 9 Renzo De Felice, Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943. 1. Dalla guerra «breve» alla guerra lunga, Torino, Einaudi, 1990, p. 116. 10 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, Milano, Rizzoli, 1980, p. 443. 11 L’armistizio viene firmato il 22 giugno a Compiègne, nel dipartimento dell’Oise, perché in quel luogo, nel 1918, si erano svolte le trattative per la resa della Germania guglielmina. Il vagone su cui era stata sottoscritta la resa era stato portato dai francesi al Musée des Invalides: per ordine di Hitler (attentissimo al valore simbolico e propagandistico dei gesti), esso viene trasferito a Compiègne e in seguito a Berlino, dove andrà distrutto durante uno dei tanti bombardamenti alleati. 12 Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, La battaglia delle Alpi Occidentali, Roma, Edizione Ufficio Storico SME, 1947, p. 139. 13 Carlo Silvestri, I responsabili della catastrofe italiana, Milano, CEBES, 1946, p. 121. 14 Giorgio Rochat, Le guerre italiane 1935-1943. Dall’impero d’Etiopia alla disfatta, Torino, Einaudi, 2005, p. 250. 15 Vincenzo Gallinari, Le operazioni del giugno 1940 sulle Alpi occidentali, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore [manca anno e numero di pagina]. 16 Telegramma del prefetto di Asti Li Voti, datato 13 giugno 1940, citato in Gianni Perona, «Ripercussioni sociali ed economiche della guerra con la Francia in Piemonte 1940-1943», in AA.VV., Guerra e Resistenza nelle regioni alpine occidentali: 1940-1945, a cura di Ettore Passerin d’Entrèves, Milano, Franco Angeli, 1980, p. 110. 17 Il reclutamento del Regio Esercito era a base nazionale e i reggimenti erano formati da giovani provenienti da due diverse regioni e inviati in servizio in una terza: stante la frammentarietà culturale e linguistica della penisola, in questo modo le autorità disponevano di reparti impermeabili all’influenza della società esterna e potevano utilizzare i coscritti in attività di ordine pubblico (sino alla Grande guerra, l’impegno armato più frequente), cosa che sarebbe risultata impossibile o rischiosa se i coscritti avessero dovuto reprimere manifestanti della loro stessa terra. Nel 1872, quando vennero istituite le prime compagnie di Alpini, venne invece fatta un’eccezione perché bisognava disporre di uomini abituati alla quota e conoscitori della montagna, quindi di montanari: di qui l’adozione del reclutamento territoriale, con le compagnie di stanza nelle stesse vallate dove i coscritti alpini erano nati e cresciuti. L’eccezione era resa possibile dalle caratteristiche delle vallate delle Alpi, fondate sulla piccola proprietà terriera

321
contadina (con un’economia povera al limite della sopravvivenza, ma senza la contrapposizione di classe tra latifondisti e braccianti) e dove la popolazione era conservatrice, cattolica, fedelmente monarchica. 18 Gianni Perona, «Ripercussioni sociali ed economiche della guerra con la Francia in Piemonte 1940-1943», cit., pp. 120-121. 19 Idem, p. 123.[da modificare in autore titolo, cit. se vengono aggiunte altre note] 20 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., p. 443. 21 Renzo De Felice, Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943. 1. Dalla guerra «breve» alla guerra lunga, Torino, Einaudi, 1990, p. 131. 22 Emilio Faldella, L’Italia e la Seconda guerra mondiale. Revisione di giudizi, Bologna, Cappelli, 1960, p. 180. 23 Carlo Sforza, L’Italia dal 1914 al 1940 quale io la vidi, Milano, Mondadori, 1954, p. 168. 24 Piero Calamandrei, Diario 1939-1945, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015 (1982), vol. I, p. 220. Capitolo III 1 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, Milano, Rizzoli, 1980, p. 443. 2 Con il termine «appeasement» si intende la politica della pacificazione a prezzo di concessioni, attuata dal leader inglese nel 1938 a Monaco di fronte alle pretese di Hitler sui Sudeti. La sua scelta, considerata di arrendevolezza, era stata contrastata dal ministro degli Esteri Anthony Eden, che il 21 febbraio di quell’anno si era dimesso, sostituito dal conte di Halifax Edward Wood. Presentatosi come vincitore dopo Monaco per aver garantito la pace, Chamberlain fu invece criticato da Churchill, secondo il quale «si poteva scegliere tra il disonore e la guerra, è stato scelto il disonore e si avrà la guerra». Dopo le dimissioni conseguenti all’inizio delle operazioni tedesche in Francia, che smentivano la sua strategia, Chamberlain conservò la guida del Partito conservatore, ma si ritirò a vita privata nel settembre 1940 per l’aggravarsi delle condizioni di salute e morì il 9 novembre successivo per un tumore. 3 Winston Churchill, La Seconda guerra mondiale, Milano, Mondadori, (1949)prima edizione 1948, 2012, vol. II, p. 28. 4 L’Ammiragliato (creato all’inizio del XV secolo) era originariamente costituito da una sola persona, il Lord grand’ammiraglio (Lord High Admiral), che rappresentava una delle nove maggiori cariche dello Stato. Nel XVIII secolo l’istituzione venne riformata e sostituita con una commissione di tre alti ufficiali, alla testa della quale vi era il Primo Lord dell’Ammiragliato, affiancato da un viceammiraglio e da un contrammiraglio. Dall’11 maggio 1940 al 25 maggio 1945 la carica fu ricoperta da Victor Albert Alexander, conte di Hillsborough (1885-1965). 5 Andrew Cunningham, Odissea di un marinaio, Milano, Garzanti, 1952, p. 57. 6 Idem, p. 73. 7 William L. Shirer, Storia del Terzo Reich, Torino, Einaudi, 1967, p. 830. 8 Giorgio Bocca, Storia d’Italia nella guerra fascista 1940-43, Bari, Laterza, 1969, p. 192.

322
9 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., pp. 449-50. 10 Giorgio Rochat, Balbo, Torino, UTET, 1986, p. 9. 11 Sino al 1915 l’accesso ai corsi di ufficiale di complemento era riservato a chi avesse conseguito la licenza liceale finale degli studi secondari; i vuoti aperti nelle fila degli ufficiali dalla guerra e la necessità di inquadrare una massa di milioni di soldati indussero però le autorità militari ad abbassare i requisiti scolastici per la nomina, che scesero all’ammissione al penultimo anno della scuola superiore. In guerra Balbo fu in forza al battaglione alpino «Pieve di Cadore» e fu insignito della medaglia d’argento per aver guidato il suo plotone all’attacco del monte Valderoa il 27 ottobre 1918 (dove il battaglione perse quasi metà degli effettivi). Nel Ventennio l’agiografia, che voleva legittimare tutti i membri della classe dirigente fascista con un presunto trascorso eroico, alimentò il mito di Balbo combattente tra gli arditi. In realtà si tratta di un’altra cosa: «i plotoni d’assalto, che nel 1918 furono costituiti in ogni reggimento di fanteria e in ogni battaglione alpino, non vanno confusi con gli arditi dei reparti d’assalto, che avevano un addestramento specifico, un armamento privilegiato e un impiego autonomo. Il plotone di Balbo aveva preparazione e compiti più limitati (il che non significa meno difficili e rischiosi) e continuava a far parte organica del “Pieve di Cadore”» (Giorgio Rochat, Balbo, cit., p. 21): in senso stretto, Balbo era «un ardito reggimentale degli Alpini». Al termine del conflitto Balbo fu infatti tra i fondatori dell’«Alpino», inizialmente giornaletto dell’8o reggimento di stanza nel Friuli e dal gennaio 1920 organo ufficiale dell’ANA (Associazione nazionale Alpini). 12 Giuseppe Bottai, Vent’anni e un giorno, Milano, Garzanti, 1949, p. 186. 13 Giorgio Bocca, Storia d’Italia nella guerra fascista 1940-43, cit., pp. 175-76. 14 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., p. 439. 15 Lettera di Italo Balbo a Benito Mussolini datata 11 maggio 1940, in Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, In Africa settentrionale. La preparazione al conflitto, Roma, Ufficio Storico SME, 1955, pp. 76-77. 16 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., p. 438. 17 Giuseppe Santoro, L’aeronautica militare italiana nella Seconda guerra mondiale, Roma, Edizioni Esse, 1957, vol. I, p. 272. 18 Lettera di Balbo a Badoglio del 16 giugno 1940, in Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, In Africa settentrionale. La preparazione al conflitto, cit., p. 116. 19 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., p. 444. 20 Giorgio Rochat, Balbo, cit., p. 295. 21 Telegramma di Badoglio a Balbo datato 28 giugno 1940, in Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, In Africa settentrionale. La preparazione al conflitto, cit., p. 134 22 Giorgio Rochat, Balbo, cit., p. 300. 23 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., p. 446. 24 Cfr. «Corriere della Sera», 29 luglio 1941. 25 Pietro Badoglio, L’Italia nella Seconda guerra mondiale, VeronaMilano, Mondadori, 1946, p. 48.

323
26 Il messaggio inviato il 18 agosto 1940 da Graziani e dai suoi generali a Mussolini è riportato in Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, In Africa settentrionale. La preparazione al conflitto, cit., p. 131. 27 La complessa organizzazione di avvistamento, comando e controllo che gestì la battaglia d’Inghilterra è nota come «sistema di Dowding», dal nome del suo principale artefice, il maresciallo dell’aria sir Hugh Dowding, comandante responsabile del Comando caccia della RAF: basato su stazioni radar sistemate lungo le coste, il sistema riusciva a intercettare gli incursori appena si avvicinavano e trasmetteva le informazioni a un centro di smistamento che a sua volta allertava i caccia e le postazioni contraeree. 28 Messaggio di Mussolini a Graziani, datato 18 agosto 1940, in Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, In Africa settentrionale. La preparazione al conflitto, cit., p. 205. 29 Il messaggio di Badoglio al duca d’Aosta del 13 agosto 1940 è riportato in Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa orientale. La caduta dell’Impero, Bari, Laterza, 1982, p. 368. 30 La sera del 9 maggio 1936 Mussolini, dal balcone di Palazzo Venezia, proclamò, tra il tripudio della folla, che «dopo quindici secoli l’impero riappare sui colli fatali di Roma»: fu uno dei discorsi più riusciti del duce e segnò il momento del suo maggior consenso interno e internazionale. 31 All’origine del corpo degli ascari (dal termine arabo askar, che significa «soldato») vi è un gruppo di mercenari noti con il nome turco di «Basci Buzuk» («teste matte»), fondato in Eritrea dall’avventuriero albanese Sangiak Hassan nella seconda metà del XIX secolo. Inizialmente al servizio dei ras locali, i mercenari di Hassan vengono arruolati nel 1885 dal colonnello Tancredi Saletta, primo comandante del corpo di spedizione italiano in Africa orientale. Le formazioni rimangono nei decenni successivi e nel 1935-36 l’esercito di occupazione vi fa ampio ricorso. Essi sono inquadrati nelle forze regolari ma sottoposti a una particolare disciplina impartita dai loro graduati, gli sciumbasci: questi fanno largo uso di punizioni corporali, per le quali utilizzano il curbasc, uno scudiscio di pelle di ippopotamo. Organizzati in battaglioni, essi per consuetudine possono portare al seguito la loro famiglia e da questo deriva la loro tradizionale fedeltà: nel momento in cui combattono, infatti, essi difendono anche i propri familiari attendati nei dintorni del campo di battaglia. 32 La strage indiscriminata fu seguita dalla rappresaglia mirata, con arresti e fucilazioni tra i cadetti della scuola militare di Olettà e, soprattutto, tra il clero. La città conventuale di Debrà LebanòsDebre Libanos fu aggredita il 19 maggio dalle truppe del generale Pietro Maletti (che nell’estate del 1940 guiderà una colonna nell’attacco all’Egitto): 297 monaci e 23 laici, sospettati di connivenza con la resistenza, furono prelevati dai conventi e dalle chiese e fucilati; qualche giorno dopo la stessa sorte toccò a 129 diaconi, in un primo tempo risparmiati per la loro giovane età. 33 Annie Goldmann, Gli anni ruggenti (1919-1929), Firenze, Giunti, 1994, p. 11. 34 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., p. 151. In particolare, il duca si scontrò con il ministro delle Colonie Attilio Teruzzi, un uomo di scarso valore assurto al potere per meriti squadristici, il quale non gli perdonava la perdita di un appalto di

324
opere pubbliche concesso a certi suoi prestanome e calcolato in 600 milioni di lire, ma annullato da Amedeo quando si accorse che il valore reale della commessa non superava i 50 milioni. 35 Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa orientale, cit., p. 337. 36 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., p. 264. 37 Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa orientale, cit., p. 347. 38 Giorgio Rochat, Il colonialismo italiano, Torino, Loescher, 1973, p. 185. 39 Angelo Del Boca, Gli italiani nell’Africa orientale, cit., p. 369. 40 Idem, p. 375. 41 Giorgio Giorgerini, La guerra italiana sul mare. La Marina tra vittoria e sconfitta 1940-1943, Milano, Mondadori, 2001, p. 168. 42 Giorgio Giorgerini, Da Capo Matapan al Golfo Persico. La Marina militare italiana dal fascismo alla Repubblica, Milano, Mondadori, 1989, p. 476. 43 Nella battaglia di Punta Stilo la Warspite è la nave ammiraglia di Cunningham, che la chiamava affettuosamente «The Old Lady», perché entrata in servizio prima della Grande guerra e successivamente rimordernata. 44 Giorgio Bocca, Storia d’Italia nella guerra fascista, cit., p. 198. 45 Giorgio Giorgerini, La guerra italiana sul mare, cit., p. 179. 46 Giorgio Bocca, Storia d’Italia nella guerra fascista, cit., p. 209. 47 Andrew Cunningham, Odissea di un marinaio, cit., p. 267. 48 Giorgio Giorgerini, La guerra italiana sul mare, cit., p. 221. Capitolo IV 1 Elaborato nel 1905 dal capo di stato maggiore Alfred Graf von Schlieffen dopo l’accordo stipulato tra Francia, Gran Bretagna e Russia (la cosiddetta Entente cordiale), il piano definisce la strategia della Germania in previsione di una guerra su due fronti: la Wehrmacht dovrà concentrare le sue unità sul Reno e dilagare di sorpresa attraverso il Belgio e i Paesi Bassi verso ovest, mantenendosi sulla difensiva a est: dopo aver ottenuto la rapida sconfitta degli anglo-francesi grazie alla sorpresa e alla superiorità numerica, potrà concentrare le truppe sul confine orientale. Già disatteso dal comandante in capo Helmuth von Moltke nel 1914, che non ebbe l’audacia di sguarnire il fronte orientale e quindi non riuscì nello sfondamento a occidente, il piano venne disatteso di nuovo nel 1941, seppure in forme diverse. 2 Proveniente da una famiglia prussiana di antiche tradizioni militari, Walther von Brauchitsch (1881-1948) divenne comandante in capo della Heer (la forza armata di terra della Wehrmacht) nel 1938 e in questa funzione guidò tutte le operazioni successive, dall’invasione della Polonia a quella della Francia, alle campagne in Iugoslavia, in Grecia, in Africa settentrionale, in Russia: nel novembre 1941 si oppose alla decisione di Hitler di attaccare a ogni costo Mosca, sostenendo la necessità di un attestamento difensivo in attesa del superamento dell’inverno. Per questo venne esonerato dall’incarico, assunto dallo stesso Führer, e trascorse ai margini gli ultimi anni del conflitto. 3 Klaus Hildebrand, Il Terzo Reich, Bari, Laterza, 1983, p. 83.

325
4 La nota del generale Wilhelm Keitel è riportata in Andreas Hillgruber, La strategia militare di Hitler. Come il Führer progettò la conquista dell’Europa, Milano, Rizzoli, 1986, p. 244. 5 Gustavo Corni, Hitler stratega, Firenze, Giunti, 2014, p. 34. 6 Basil Henry Liddell Hart, Storia di una sconfitta. Parlano i generali del Terzo Reich, Milano, MondadoriRizzoli, 1971, p. 271. 7 Accreditata dalla pubblicistica sin dall’immediato dopoguerra, questa versione è confermata in una pagina del diario di Ciano, che in data 12 ottobre scrive: «Hitler mi mette sempre di fronte al fatto compiuto. Questa volta lo pago della stessa moneta: saprà dai giornali che ho occupato la Grecia» (Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, Milano, Rizzoli, 1980, p. 470). 8 Renzo De Felice, Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943. 1. Dalla guerra «breve» alla guerra lunga, Torino, Einaudi, 1990, p. 297. 9 Enrico Caviglia, I dittatori, le guerre e il piccolo re. Diario 1925-1945, a cura di Pier Paolo Cervone, Milano, Mursia, 2009, p. 288. 10 Renzo de Felice, Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943, cit., p. 307. Wilhelmstrasse è uno dei viali più importanti di Berlino ed è dedicato al re di Prussia Federico Guglielmo I: sino al 1945 ospitava la Cancelleria e il ministero degli Esteri e il suo nome veniva usato per intendere, per estensione, la diplomazia germanica. 11 Idem, p. 319. 12 Francesco Jacomoni di San Savino (1893-1973) era un diplomatico di carriera e aveva sposato Maja Cavallero, figlia del maresciallo d’Italia Ugo Cavallero: dal 1936 era stato nominato ministro consigliere a Tirana, dopo l’invasione del 1939 luogotenente generale del Regno d’Albania. 13 Il generale Ioannis Metaxas (1871-1941), chiamato al governo nel 1936 dal re Giorgio II per gestire una difficile situazione di tensioni sociali, dichiarò quasi subito lo stato d’emergenza, instaurando un regime dittatoriale sul modello del fascismo italiano; in politica estera egli era però legato all’Inghilterra, che considerava arbitro del Mediterraneo e sola garanzia della propria indipendenza. [manca riferimento biblio della citazione] 14 Luigi Mondini, Prologo del conflitto italo-greco, Milano, GarzantiRoma, Treves, 1945, pp. 155 e sgg. 15 Mario Montanari, L’Esercito italiano nella campagna di Grecia, Roma, Ufficio Storico SME, 1999, p. 68. 16 Renzo De Felice, Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943, cit., p. 301. 17 Mario Montanari, L’Esercito italiano nella campagna di Grecia, cit., p. 588. 18 Promemoria per il generale Cavallero scritto dal tenente colonnello Domenico Fornara, capo dell’ufficio operazioni del Comando superiore in Albania (idem, p. 329). 19 Idem, p. 132. Sebastiano Visconti Prasca (1883-1961), che per alcuni anni era stato addetto militare a Belgrado e conosceva bene l’area balcanica, era entrato nelle grazie di Mussolini nel 1933, quando il duce aveva letto in anteprima il suo libro di strategia militare Guerra decisiva, in cui si teorizzava una guerra lampo movimentista e rapida. Le opposizioni al suo incarico (cui fa cenno Mussolini) nascevano da contrasti avuti con Badoglio quando era ufficiale addetto allo stato

326
maggiore generale, ma traevano spunto dal fatto che nel 1940 egli era generale di corpo d’armata, mentre quella in campo era un’armata e il comando spettava a un generale con grado superiore. Per non violare le regole della gerarchia militare il problema fu risolto in modo formale, schierando sul campo due corpi d’armata e omettendo la loro riunificazione ufficiale in un’armata. 20 Emilio Faldella (a cura di), Storia delle truppe alpine 1872-1972, Milano, Edizioni Cavallotti-Landoni, 1972, vol. II, p. 1207. 21 Giorgio Rochat, Le guerre italiane 1935-1943. Dall’impero d’Etiopia alla disfatta, Torino, Einaudi, 2005, p. 267. 22 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., p. 475. 23 Emilio Faldella (a cura di), Storia delle truppe alpine 1872-1972, cit., p. 1215. 24 La testimonianza è riportata in Giulio Bedeschi (a cura di), Fronte greco-albanese: c’ero anch’io, Milano, Mursia, 1977, p. 14. 25 Giovanni Zanette, Tempesta sulle alpi albanesi, Milano, Mursia, 1967, p. 55. 26 Manlio Cecovini, Ponte Perati. La divisione Julia in Grecia, Milano, Longanesi, 1966, p. 254 27 Aldo Rasero, Alpini della Julia, Milano, Mursia, 1972, p. 23. 28 Giovanni Zanette, Tempesta sulle alpi albanesi, cit., p. 34. Capitolo V 1 La Illustrious, progettata nella seconda metà degli anni Trenta nell’ambito del riarmo deciso dal governo inglese di fronte alle minacce alla pace in Europa, è la prima di quattro unità portaerei (le altre furono la Formidable, la Victorious e la Indomitable) impiegate dalla Royal Navy nella Seconda guerra mondiale, in particolare nello scacchiere mediterraneo. Si trattava di modelli dotati di molta robustezza, i primi nella storia delle costruzioni navali con un ponte di volo corazzato: benché duramente provate durante il conflitto, nessuna di loro fu affondata. 2 La scorta dell’Illustrious era composta dagli incrociatori Gloucester, Berwick, Glasgow, York e 4 cacciatorpediniere. Il piano prevedeva l’impiego di 30 apparecchi tra bombardieri e aerosiluranti, ma per vari eventi accidentali il numero si ridusse a 20. 3 Giorgio Giorgerini, La guerra italiana sul mare. La Marina tra vittoria e sconfitta 1940-1943, Milano, Mondadori, 2001, p. 218. 4 Idem, p. 229. 5 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, Milano, Rizzoli, 1980, p. 478. 6 Ufficio Storico della Marina, La Marina italiana nella Seconda guerra mondiale, Roma, Ufficio Storico della Marina militare, cit., vol. IV, p. 248. 7 Andrew Cunningham, Odissea di un marinaio, Milano, Garzanti, 1952, p. 130. 8 La relazione del generale Mario Ghirotti, datata 8 novembre 1940, è riportata in Sebastiano Visconti Prasca, Io ho aggredito la Grecia, Milano, Rizzoli, 1946, p. 143. 9 Aldo Rasero, 5° Alpini, Rovereto, Edizioni Manfrini, 1964, p. 353. 10 Giorgio Bocca, Storia d’Italia nella guerra fascista 1940-43, Bari, Laterza, 1969, pp. 246-47. 11 Mario Roatta, Otto milioni di baionette, Milano, Mondadori, 1946, p. 132.

327
12 Le dichiarazioni dei generali Mario Vercellino e Carlo Geloso sono riportate in Giorgio Bocca, Storia dell’Italia nella guerra fascista 1940-1943, cit., p. 248. 13 Idem, p. 254. 14 Georgios Tsolakoglu (1886-1948), dopo essere stato tra i protagonisti delle operazioni contro l’Italia, nella primavera successiva firmò la resa di fronte all’invasione delle forze dell’Asse, nonostante gli ordini contrari di Alexandros Papagos: le autorità d’occupazione lo posero allora a capo di un governo collaborazionista. Nel dopoguerra fu catturato e condannato a morte per tradimento, pena commutata in ergastolo. 15 Joseph Paul Goebbels, Fred Taylor (a cura di), I diari di Goebbels (1939-1941), a cura di Fred Taylor, Milano, Sperling & Kupfer, 1984, p. 246. 16 La lettera di Hitler a Mussolini del 20 novembre 1940, scritta da Vienna, è interamente riportata in Renzo De Felice, Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943. 1. Dalla guerra «breve» alla guerra lunga, Torino, Einaudi, 1990, pp. 322-326. 17 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., p. 480. 18 Renzo De Felice, Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943, cit., p. 327. 19 «Regime fascista», 23 novembre 1940. 20 Renzo De Felice, Mussoli l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943, cit., p. 341. 21 Paolo Puntoni, Parla Vittorio Emanuele III, Bologna, il Mulino, 1993, p. 25. 22 Giuseppe Bottai, Vent’anni e un giorno, Milano, Rizzoli, 2008 (1949), cit., p. 99. Giuseppe Bottai, Vent’anni e un giorno, Milano, Garzanti, 1949, p. 99. 23 Enno von Rintelen, Mussolini l’alleato: ricordi dell’addetto militare tedesco a Roma (1936-1943), Roma, Edizioni Corso, 1952, p. 176. 24 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., p. 493. 25 Giorgio Bocca, Storia d’Italia nella guerra fascista, cit., p. 257. 26 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., p. 502. 27 Giorgio Bocca, Storia d’Italia nella guerra fascista, cit., p. 264. 28 La lettera di Mussolini al maresciallo Graziani, datata 26 ottobre 1940, è riportata in Renzo De Felice, Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943, cit., p. 395 29 Il generale Sebastiano Gallina (1873-1945) fu portato prigioniero nel campo per alti ufficiali indiano di Dehradun (India settentrionale, vicino alla catena dell’Himalaya), dove ebbe gravi problemi di carattere medico: nel 1943, ormai settantenne, le autorità inglesi lo rimpatriarono per motivi umanitari. Ritiratosi a vita privata a Trana, nelle vicinanze di Torino, il 9 gennaio 1945 venne ucciso insieme a numerosi altri civili sul trenino che collegava Giaveno con Torino durante un mitragliamento a bassa quota dell’aviazione britannica, che aveva scambiato il convoglio per un trasporto di truppe tedesche. 30 Le corrispondenze tra Graziani e Mussolini e i commenti di Ciano sono riportati in Renzo De Felice, Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943, cit., pp. 402-405. Il riferimento di Ciano è all’attentato subito da Graziani, all’epoca viceré di Etiopia, il 19 febbraio 1937 nella capitale etiope. 31 Giorgio Bocca, Storia d’Italia nella guerra fascista, cit., p. 266. 32 La lettera di Graziani a Mussolini del 15 dicembre 1940 è riportata in Renzo De Felice, Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943, cit., p. 407.

328
33 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., p. 495. 34 Si trattò del primo scontro della Seconda guerra mondiale alla quale prese parte un’unità australiana: il luogotenente generale Iven Giffard Mackay (1882-1966) era originario di Grafton, nel Nuovo Galles del Sud, e aveva già partecipato alla Grande guerra nel 4o battaglione di fanteria, impegnato nella penisola di Gallipoli sul fronte anglo-turco. 35 Giorgio Rochat, Le guerre italiane 1935-1943. Dall’impero d’Etiopia alla disfatta, Torino, Einaudi, 2005, p. 297. 36 La commissione d’inchiesta sull’operato di Graziani fu istituita nel novembre 1941 e presieduta dall’ammiraglio Thaon di Revel. La relazione fu consegnata al duce nel marzo 1942 con giudizi severissimi sul maresciallo. Mussolini rimase indeciso tra la denuncia al tribunale militare oppure la liquidazione in via amministrativa con la collocazione a riposo, scegliendo alla fine di lasciare in sospeso la vicenda. Nel gennaio 1943, secondo quanto affermato da Graziani stesso nella sua autobiografia, il duce gli fece dire dal sottosegretario Scuero che, dopo aver letto il suo memoriale, «era ridivenuto per lui quello di prima e che perciò non doveva più parlare di questa vicenda» (Romano Canosa, Graziani, il maresciallo d’Italia dalla guerra d’Etiopia alla Repubblica di Salò, Milano, Mondadori, 2004, p. 283). 37 Giorgio Bocca, Storia d’Italia nella guerra fascista, cit., p. 265. 38 Giorgio Giorgerini, La guerra italiana sul mare, cit., p. 259. 39 Idem, p. 312. 40 La lettera del duca d’Aosta a Mussolini del 16 dicembre 1940 è riportata in Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa orientale. La caduta dell’Impero, Bari, Laterza, 1982, p. 389. 41 Nicola Angelo Carnimeo (1887-1965), laureato in giurisprudenza ma ufficiale di carriera dal 1909, nel 1940 fu nominato comandante della 2a divisione coloniale nell’AOI. Catturato dagli inglesi dopo la caduta di Cheren e internato in un campo di prigionia, gli venne riconosciuto il merito di aver difeso egregiamente la piazzaforte e aver resistito per due mesi, nonostante una evidente inferiorità di forze e di mezzi. Dopo la fine della guerra e il congedo col grado di generale di corpo d’armata, ricoprì la carica di consigliere di Stato alla 3a sezione consultiva di Roma. 42 Come tutti i principi di Casa Savoia, anche Amedeo ricopre i ruoli militari più per dovere istituzionale che per vocazione. In servizio in Libia negli anni Venti durante la «riconquista» di Graziani, nel 1931 accetta le proposte di Italo balbo ed entra nell’aviazione, andando a comandare il 21o stormo di stanza a Gorizia e facendo rapidamente carriera sino al grado di generale di squadra aerea. La sua presenza nell’«Arma Azzurra» è garanzia di prestigio, ma la sua partecipazione alla vita militare è saltuaria: spesso si trattiene nella reggia triestina di Miramare, dove ha fissato la sua residenza. 43 La lettera del duca d’Aosta a Mussolini del 14 febbraio 1941 è riportata in Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa orientale, cit., p. 424. 44 Giuseppe Pizzorno, Da Cassala a Cheren. Lo scacchiere nord in AOIAO, Roma, Tipografia Regionale, 1959, p. 90.

329
45 Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa orientale, cit., pp. 479-80. Il maggiore Pietro Toselli fu protagonista di un episodio di valore durante la guerra d’Africa di fine Ottocento, contro il negus Menelik II: circondato sull’altopiano dell’Amba Alagi, egli resistette per l’intera giornata del 7 dicembre 1895 agli attacchi delle truppe abissine, sinché fu costretto a ordinare la ritirata. Ultimo a lasciare le posizioni, Toselli venne raggiunto dagli attaccanti e ucciso. Della figura del maggiore si appropriò subito la propaganda patriottica, trasformandola in un’icona del sacrificio e dell’abnegazione del soldato italiano. 46 Emilio Canevari, La guerra italiana. Retroscena della disfatta, Roma, Tosi, 1949, vol. II, p. 411. 47 Idem, p. 420. 48 Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa orientale, cit., p. 489. 49 Idem, p. 493. 50 Romualdo Pantini, Tempo d’epopea, in «Gli Annali dell’Africa italiana», n. 2/1941, p. XII. 51 Il duca d’Aosta si trasformò in leggenda meno di un anno dopo, quando morì in prigionia. Dietro la statuarietà della corporatura e la robustezza dei muscoli, Amedeo aveva sempre nascosto una salute fragile, esposto come la madre Elena d’Orléans (e prima ancora la nonna Maria Vittoria) alle insidie delle complicazioni polmonari. Dopo alcune crisi giovanili di emottisi, il morbo si ripresentò nell’inverno 1941-42. Ammalatosi di malaria subito dopo Natale, il duca in gennaio venne trasferito al General Hospital di Nairobi e in seguito, per ricevere cure più appropriate, al Maya Cunbery Nursing Home: quando la malaria sembrava domata, subentrarono però le complicazioni polmonari. Il decorso era rapidissimo e alle 3.45 del 3 marzo, a soli quarantadue anni, il duca moriva. In realtà la sua morte non sembrò colpire nel profondo né il duce, né la corte, né gli altri uomini di potere (solo la principessa Maria José si commosse sinceramente) ma fu sfruttata come occasione di cordoglio nazionale, un momento di celebrazione collettiva del sacrifico estremo per la grandezza della patria. Capitolo VI 1 Renzo De Felice, Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943. 1. Dalla guerra «breve» alla guerra lunga, Torino, Einaudi, 1990, p. 283. 2 Joseph Paul Goebbels, Fred Taylor (a cura di), I diari di Goebbels (1939-1941), a cura di Fred Taylor, Milano, Sperling & Kupfer, 1984, p. 432. 3 Renzo De Felice, Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943. 1. Dalla guerra «breve» alla guerra lunga, Torino, Einaudi, 1990, pp. 374-75. 4 Giuseppe Bottai, Diario 1935-1944, cit., p. 216. Theo Morell, il medico personale di Hitler e una delle persone che lo conosceva meglio, interrogato dall’ambasciatore Alfieri su quale fosse tra i gerarchi nazisti il più vicino al Führer, rispose: «Io credo che l’unico e grande amico del Führer sia il Duce. Dopo ogni loro incontro, il Führer è come rinfrancato, più sicuro e più vivace, credo per la pienezza di vita e di gagliardia che si espande da Mussolini. Io spesso ho pensato che questi due geni vadano così d’accordo perché la loro intima natura ha caratteri così diversi: Mussolini pratica tutti gli sport, Hitler nessuno; Mussolini pare che stia con tutte e due le gambe robuste piantato nella pienezza della vita,

330
Hitler ha invece piuttosto la tendenza all’ascetismo, a credere nella sua particolare religione del destino» (Renzo De Felice, Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943, cit., p. 376). 5 Andreas Hillgruber, La strategia militare di Hitler. Come il Führer progettò la conquista dell’Europa, Milano, Rizzoli, 1986, p. 390. 6 Idem, p. 401. 7 Ufficio Storico dello SME, La prima offensiva britannica in Africa settentrionale, Roma, Ufficio Storico dello SME, 1979, vol. I, p. 371. 8 Giorgio Bocca, Storia d’Italia nella guerra fascista 1940-43, Bari, Laterza, 1969, pp. 272-73. 9 Erwin Rommel, Guerra senza odio, cit.Milano, Garzanti, 1959, p. 17. 10 Gli ufficiali inglesi catturati in Libia vennero portati in Italia, nel campo di prigionia di Vincigliata, vicino a Firenze, dove rimasero sino all’autunno del 1943 riuscendo poi a fuggire e a nascondersi nell’Appennino tosco-emiliano. Con l’aiuto di alcuni partigiani romagnoli essi riuscirono a rientrare in patria nel dicembre 1943: O’Connor ottenne poi il comando dell’8o Corpo d’armata in Normandia, partecipando allo sbarco e alle successive operazioni sino alla fine della guerra. 11 Arrigo Petacco, 1941, giorno per giorno attraverso i bollettini del Comando supremo, Milano, Leonardo, 1989, pp. 119-121. 12 Pietro Maravigna, Come abbiamo perduto la guerra in Africa, Roma, Tosi, 1949, p. 235. 13 Ufficio Storico dello SME, La prima offensiva britannica in Africa settentrionale, cit., vol. I, p. 403. 14 Piero Calamandrei, Diario 1939-1945, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2015 (1982), vol. I, p. 373. 15 Mario Tobino, Il deserto della Libia, Mondadori, Milano, 1964, pp. 97-98. 16 Mario Pacor, Italia e Balcani, Milano, Feltrinelli, 1968, p. 175. Il conte Pál Teleki, pur avvicinandosi alla Germania nazista, era profondamente contrario ad azioni aggressive nei Balcani e nel dicembre 1940 aveva firmato un patto di amicizia con la Iugoslavia: nella primavera del 1941, di fronte alle manovre tedesche contro Belgrado, ebbe una forte crisi di coscienza e il 3 aprile si suicidò con un colpo di pistola nel Palazzo Sandor di Budapest, lasciando una lettera di dura accusa contro l’aggressione militare. 17 L’assassinio avvenne a Marsiglia, durante una visita di Stato, e fu opera di un commando di ustascia, i fascisti croati: nell’attentato morì anche il ministro degli Esteri francese, Jean-Louis Barthou. L’erede legittimo, Pietro II, avrebbe dovuto salire al trono nel settembre 1941, al compimento del diciottesimo anno di età. 18 Stephen Clissold (a cura di), Storia della Jugoslavia. Gli slavi del sud dalle origini a oggi, Torino, Einaudi, 1969, p. 229. 19 Idem, p. 241. 20 Arrigo Petacco, L’esodo. La tragedia negata degli Italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, Milano, Mondadori, 1999, p. 30. 21 La lettera di Mussolini a Hitler datata 28 marzo 1941 è riportata in Renzo De Felice, Mussolini l’alleato. L’Italia in guerra 1940-1943, cit., p. 424.

331
22 John Killen, Storia della Luftwaffe, Milano, Sugar, 1968, p. 252. Lo Junkers JU-87 detto abitualmente Stuka (in tedesco Sturzkampfflugzeug, letteralmente «aereo da combattimento in picchiata») fu il bombardiere tattico più importante e più propagandato messo in campo dalla Luftwaffe: era immediatamente riconoscibile per il carrello fisso. Mentre i bombardieri convenzionali sganciavano grappoli di bombe su un’area vasta, i bombardieri in picchiata come gli Stuka si dirigevano verticalmente verso il bersaglio, sganciando una sola bomba e ottenendo una precisione tale da poter centrare bersagli piccoli come un carro armato o una casamatta. 23 Giorgio Bocca, Storia d’Italia nella guerra fascista 1940-43, cit., pp. 298-99. 24 La lettera-telegramma di Mussolini a Cavallero, datata 26 aprile 1941, è riportata in Mario Cervi, Storia della Guerra di Grecia, Milano, Sugar, 1965, p. 355. Su suggerimento di Ciano, il testo venne dato all’Agenzia Stefani e in questo modo fatto conoscere alla diplomazia internazionale: questo provoca la reazione indignata di Churchill. 25 Idem, p. 367. 26 Piero Calamandrei, Diario 1939-1945, cit, pp. 376-77. 27 Andreas Hillgruber, La strategia militare di Hitler, cit., pp. 518-19. 28 Dopo la battaglia di Creta, il corpo di spedizione neozelandese del generale Bernard Freyberg partecipò alle operazioni nel Nordafrica e successivamente alla campagna d’Italia: nel febbraio 1944 fu protagonista della battaglia di Montecassino, durante la quale fu bombardato l’antico convento benedettino, erroneamente ritenuto da Freyberg un caposaldo della difesa tedesca. 29 La lezione di Creta viene recepita anche dai comandi inglese e americano: durante lo sbarco in Normanda del 1944 i paracadutisti saranno lanciati in azioni alle spalle delle linee tedesche, ma solo in funzione di supporto alle fanterie assaltatrici dal mare. 30 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., p. 506. 31 Guido Buffarini Guidi (1895-1945), aderente ai Fasci di combattimento sin dalla loro costituzione, dal 1933 al febbraio 1943 fu sottosegretario all’Interno: poiché la titolarità del ministero era dello stesso Mussolini, di fatto esercitò le funzioni di ministro. 32 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, cit., p. 477. 33 I Petrović erano stati la dinastia regnante del Montenegro sino alla costituzione del Regno di Iugoslavia: a essa apparteneva la regina Elena. 34 Ante Pavelić (1889-1959) fu il fondatore nel 1929 del movimento «ustascia» (in croato «insorti»): profondamente avverso alla dinastia regnante dei Karagjeorgjević e alla supremazia dei Serbi nel regno, egli si rifugiò in Italia per evitare l’arresto e risiedette a Bologna, da dove continuò a dirigere il movimento. Negli anni Trenta il fascismo consentì la creazione nella penisola di vari campi di addestramento per ustascia, da cui partirono spedizioni incaricate di compiere atti terroristici nel Regno di Iugoslavia e all’estero: tra queste, l’assassinio nel 1934 del re Alessandro I durante una visita a Marsiglia cui si è già accennato (cfr. nota 17). 35 Secondo la linea di successione dinastica sabauda, la corona di re di Croazia sarebbe spettata al duca Amedeo, che in quel periodo era però impegnato in

332
Etiopia come viceré. Il duca di Spoleto Aimone (nato nel 1900) era un ufficiale di marina, allora comandante il dipartimento navale di La Spezia. Il nome «Timoslav Tomislavo II» fu coniato dalla diplomazia fascista su indicazione degli ustascia, legati alla tradizione di Timoslav Tomislav Trpimirović, primo re di Croazia nel 925 con il nome di Timoslav Tomislav I. Anche se Aimone non andò mai a Zagabria, la sua nomina è significativa della compromissione dei Savoia con il sistema di potere nazista in Europa 36 Andreas Hillgruber, La strategia militare di Hitler, cit., p. 520. 37 Giorgio Rochat, Le guerre italiane 1935-1943. Dall’impero d’Etiopia alla disfatta, Torino, Einaudi, 2005, p. 383. Capitolo VII 1 Elios Toschi, In fuga oltre l’Himalaya, Milano, Edizioni Europee, 1948, p. 45. Per la loro realizzazione Tesei e Toschi si ispirano alla «mignatta» di Raffaele Paolucci e Raffaele Rossetti, realizzata nell’estate del 1918 e sperimentata a Pola negli ultimi giorni della Grande guerra: si trattava di un piccolissimo sottomarino, un mezzo d’assalto semisubacqueo, costituito da una specie di grosso siluro munito di una testa esplosiva distaccabile. In grado di operare in affioramento, la «mignatta» poteva avvicinarsi al bersaglio, minarlo e farlo saltare in aria, per poi allontanarsi con i due operatori. Con la «mignatta» il 1° novembre 1918 venne fatta affondare la Viribus Unitis, nave ammiraglia della Marina imperiale di Vienna. 2 Nato a Pescia (Pistoia) nel 1911, Gino Birindelli si formò all’Accademia di Livorno e, prima di essere aggregato alla I flottiglia MAS, fu ufficiale sui sommergibili. Dopo le imprese di Alessandria e Gibilterra e la cattura da parte degli inglesi, partecipò alla guerra di Liberazione e nel dopoguerra venne posto al comando del battaglione «San Marco», seguendo i vari gradi della carriera sino al comando in capo della squadra navale. Congedatosi dalla Marina, fu parlamentare eletto nelle liste del Movimento sociale. Morì a Roma nel 2008. 3 La corazzata Barham venne affondata il 25 novembre 1941 dal sommergibile tedesco U331, comandato dal capitano di fregata Diedrich von Tiesenhausen. Quando i siluri colpirono la nave, esplosero i depositi di munizioni e la Barham affondò in pochi minuti perdendo i due terzi dell’equipaggio. 4 La Marina britannica ammetterà perdite per 22.000 tonnellate, ma la differenza è data dai diversi sistemi di misurazione: Londra calcolava infatti le tonnellate di stazza o di portata, Roma considerava invece il dislocamento o peso totale. 5 Dopo l’attacco di Alessandria, Luigi Durand de la Penne fu portato prigioniero prima in Palestina, quindi in India, infine in Gran Bretagna, da dove fu liberato nel febbraio 1944 per essere impiegato nel gruppo mezzi di assalto di Mariassalto, che combattevano accanto agli Alleati nella campagna d’Italia. Nel marzo 1945 fu decorato a Taranto con medaglia d’oro e ad appuntargli la decorazione fu l’ammiraglio inglese Charles Morgan, che nel 1941 era il comandante della Valiant colpita dal SLC di de la Penne. Nel dopoguerra, dopo un’esperienza diplomatica in Brasile, entrò in politica e nella seconda legislatura fu eletto alla Camera dei deputati nel collegio di Genova nelle liste del Partito liberale, venendo poi riconfermato sino al 1976. Nel 1972-73 fa parte del secondo governo

333
Andreotti come sottosegretario alla Marina mercantile. Posto in aspettativa dalla Marina e iscritto nel Ruolo d’onore, raggiunse il grado di ammiraglio di squadra. Morì a Genova nel 1992. L’anno successivo la Marina Militare ribattezzò col suo nome il cacciatorpediniere lanciamissili Animoso, realizzato nel cantiere navale di Riva Trigoso e varato nel 1989. 6 L’ingresso in Marina di Emilio Bianchi fu quasi causale: secondo una sua testimonianza, egli lesse a Sondrio un manifesto che diceva: «Vuoi girare il mondo? Entra in Marina». Curioso di novità e desideroso di viaggiare, fece domanda e fu arruolato, nonostante non sapesse nuotare e non avesse mai visto il mare. Nel dopoguerra egli continuò la carriera nella Marina militare, diventando ufficiale del CEMM (Corpo equipaggi militari marittimi) e congedandosi con il grado di capitano di corvetta: eccezionalmente longevo, trascorse la lunga vecchiaia a Torre del Lago, non distante da dove aveva fatto le prime esercitazioni da incursore subacqueo, e morì ultracentenario a Viareggio il 15 agosto 2015. 7 Entrambi lasceranno la Marina dopo il 1945, Marceglia dedicandosi al mondo della finanza sino a diventare membro del Consiglio Superiore della Banca d’Italia, Schergat trovando più modestamente un’occupazione come custode dell’università di Trieste. [già nel testo]Prigioniero prima in Palestina poi in India, Marceglia fu liberato nel febbraio 1944 e partecipò alla guerra di liberazione accanto agli anglo-americani. Spartaco Schergat rimase invece in Palestina sino all’ottobre 1944, quindi partecipò come il suo comandante alle operazioni di Mariassalto. Sia Marceglia che Schergat fecero parte di quella cospicua maggioranza delle comunità giuliano-dalmate che dopo la guerra lasciarono la propria regione entrata a far parte della Repubblica iugoslava: Marceglia si stabilì a Venezia, dove morì nel 1992, Spartaco Schergat a Trieste, dove morì nel 1996. 8 Anche Vincenzo Martellotta partecipò dopo l’8 settembre alla guerra di liberazione accanto agli alleati, rimanendo poi in Marina sino al 1960, quando venne collocato in ausiliaria: morì a Castelfranco Emilia nel 1973. Mario Marino, dall’ottobre 1944 impegnato nelle azioni di Mariassalto, restò a sua volta sotto le armi, ottenendo nel 1962 il passaggio al ruolo ufficiali e congedandosi nel 1977 col grado di capitano di corvetta. Morì a Salerno nel 1982. 9 Giorgio Giorgerini, Attacco dal mare. Storia dei mezzi d’assalto della Marina italiana, Milano, Mondadori, 2007, p. 254. 10 La testimonianza di Luigi Durand de la Penne è riportata in Luciano Garibaldi e Gaspare De Sclafani, Così affondammo la Valiant. La più grande impresa navale italiana della Seconda guerra mondiale, Torino, Lindau, 2010, p. 19. 11 La relazione di Antonio Marceglia è riportata in Idem, pp. 211-12. 12 Andrew Cunningham, Odissea di un marinaio, Milano, Garzanti, 1952, p. 218. 13 La relazione di Luigi Durand de la Penne è riportata in Junio Valerio Borghese, Decima flottiglia MAS. Dalle origini all’armistizio, Milano, Garzanti, 1950, pp. 193-94. Sull’attacco alla Valiant le versioni di Durand de la Penne e del suo secondo Emilio Bianchi sono state divergenti nella rivendicazione dei meriti dei singoli, ma sostanzialmente concordi nella ricostruzione dinamica di fondo (cfr. Gianni Oliva, Combattere. Dagli arditi ai marò, storia dei corpi speciali italiani, Milano, Mondadori, 2017, pp. 38-44).

334
14 La testimonianza del guardiamarina Frank Wade è riportata in Jack Greene e Alessandro Massignani, Il Principe Nero. Junio Valerio Borghese e la Decima Mas, Milano, Mondadori, 2007, p. 118. 15 La testimonianza di Andrew Cunningham è riportata in Giorgio Giorgerini, Attacco dal mare, cit., p. 237. 16 La testimonianza di Ugo Schleifer, contenuta in una lettera privata inviata al comandante Vittorio di Sambuy, è riportata in Idem, p. 429. 17 Arrigo Petacco, 1942. Giorno per giorno attraverso i bollettini del Comando supremo, Milano, Leonardo, 1989, pp.17-18.