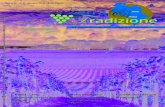Numero 7
-
Upload
charta-sporca -
Category
Documents
-
view
223 -
download
1
description
Transcript of Numero 7
NUMERO VII - GIUGNO/SETTEMBRE 2012
In questo numero
Spazio al marginedi Stefano Tieri
Le mie intenzioni erano di scri-vere un articolo sulla televisio-ne: la sua “neolingua” sempli-ficatrice (al punto che lo stesso pensiero ne risulta semplifica-to), eletta a modello e rapida-mente assimilata dai parlanti; l’imposizione di un discorso (del discorso) e l’esclusione di ogni altro discorso che di fatto – vedendogli negato lo spazio – si estingue; la pretesa di Verità delle sue violente e false im-magini, finalizzate ad onorare il simulacro dell’unico Dio super-stite, il Consumo.
Mi rendo conto però di non es-serne capace. Non più, almeno: non la accendo oramai da cin-que anni ed uno strato di polvere ne ha ricoperto lo schermo (non più) riflettente. Nel frattempo il palinsesto che ricordavo è stato – pezzo a pezzo – sostituito e le nuove parole hanno preso il po-sto delle vecchie. Ho totalmente perso coscienza di cosa essa sia, di quel che rappresenta per il telespettatore, della sua forza distruttiva.
La nostra “civiltà”, in virtù del-la sua particolare natura, può essere conosciuta solamente standoci dentro, rimanendone perennemente immersi. Questo perché è in una tale e continua evoluzione che, collocandosene al di fuori (anche solo per poco), si perde la percezione della sua realtà, così repentina nei mu-tamenti. E allora si diviene un estraneo (o meglio un apoli-de, dal momento che questa “civiltà” ha ormai avvelenato, esportando il proprio modello di vita, quasi ogni luogo abitato del pianeta).Al tempo stesso, però, è proprio questo “essere dentro” che to-glie legittimità ad una qualsiasi critica: chiunque infatti potrà maliziosamente infangare colui che, avendo vissuto in un dato
I
sistema (da cui ha ricevuto sostenta-mento), da solerte paladino si permette di criticarlo. La compromissione insom-ma è totale, e la critica perde ogni sua forza.Vale perciò la pena rimanere? Cosa impedisce di fuggire e di scalare le alte cime per costruirvi una solitaria capan-na? È presto detto: la pretesa totalizzan-te, propria del “democratico” Occidente, di convertire ognuno e riqualificare (per trarne profitto) ogni cosa. Essa raggiun-gerà anche gli oppositori e i fuggiaschi, ed infine busserà alla porta della capan-na; porgerà una carta che annuncia, riba-dito il diritto di proprietà su quella terra, la costruzione di un nuovo centro com-merciale che spazzerà via quella piccola costruzione abusiva.«Un uomo, dovunque vada, sarà sem-pre inseguito dagli altri uomini che lo
Si accorpa e si chiude
In una prospettiva di ottimizzazione dei fondi (e riduzione delle spese), in piena dinamica aziendale, nascono i mega-diparti-menti dalla fusione, da una parte, delle facoltà di Giurisprudenza e Tradutto-ri e Interpreti e, dall’altra, dalle facoltà di Lettere e Filosofia e Scienze della Formazione. Sebbene per-vasi da un certo scetticismo (che ormai, visti i tempi, ci è congeniale), aspettiamo di vedere quanto queste nuove realtà sapranno dare agli studenti.Non possiamo invece che rammaricarci per la prossima chiusura del dipartimento di Italiani-stica (la foto mostra il suo giardino), unico edificio in Campo Marzio ad essere aperto anche la sera, che ha ospitato le conferenze da noi organizzate.
acchiapperanno con le loro sporche isti-tuzioni e, se possono, lo costringeranno persino ad appartenere alla loro disperata massoneria», scrive Henry D. Thoreau (fuggito lontano dalla società americana ottocentesca alla ricerca di una dimensio-ne più genuina dell’esistenza) in Walden.Cosa rimane quindi da fare? Se il discorso non può essere minato (anche perché, in quanto unico, viene legittimato dal suo stesso non presentare alternative), se ne creino degli altri o, appena è possibile riconoscerne qualcun altro ai margini, gli si dia subito spazio, prima della sua scomparsa.Il resto verrà da sé: tolto il monopolio, la scarna ossatura del discorso unico mostrerà tutta la sua fragilità, le sue debolezze, la sua finzione. Basterà allora un soffio, ed il vento delle alte cime rinfrancherà l’arida vallata.
Scontro tra penne Sulla Decrescita
-----Going down with a bang
di Giulio Rosani-----
Relazionidi Tommaso Tercovich
-----Gelatina d'argento
Lewis Hinedi Marco Sinuello
-----Don ChisCiottidi Ruben Salerno
II
Architettura contemporanea. Las Vegasdi Srdjan Zlokapa
Che Las Vegas sia una città in cui convivono molteplici rimandi all’eterotopia foucaultiana è indubbio. Come nelle città utopiche di Moro e Campanella bisogna attraversare una barriera, il deserto del Mojave (1) per raggiungere una città altra rispetto alla media statunitense, così capace di sovvertire i riti del vivere quotidiano da far as-somigliare paurosamente il rito del matrimonio a quello del fare benzina in una sfavillante stazione di servizio.Ma come tutti gli spazi eterotopici Vegas, pur es-sendo una città diversa rispetto alla media ame-ricana, rivela in maniera più palese i dispositivi governamentali che agiscono nella società con-temporanea.A Las Vegas l’opulenza e l’architettura della Roma imperiale non sono un ricordo ma vivono nei co-lonnati delle hall dei casinò dove camerieri in toga dal sorriso impeccabile distribuiscono calici di vino accanto a un autentico arrembaggio di un ga-leone spagnolo eseguito da agilissime comparse. Uno spettacolo che si ripete ogni ora intrappolan-do il XVI secolo e la Roma imperiale in un eterno ritorno asservito alle necessità dello spettacolo e del consumo. L’architettura di Las Vegas infatti non utilizza le forme del passato per cercare un’espressione for-male che appartenga alla sua epoca ma cerca nella suggestione storica la sospensione del giudizio che inizia il fruitore al mondo dell’enterteinment.Utilizzare l’occhio colto di un architetto come Robert Venturi è utile per cogliere la quantità di anacronismi volontari che lo spazio di un casi-nò come il Ceasars Palace riesce a contenere. Il colonnato anteriore del casinò in pianta rimanda al Bernini di San Pietro, mentre in alzato per lin-guaggio architettonico e scala ricorda l’opera di Yamasaki – quello delle Torri Gemelle per quelli che l’architettura non la masticano –. L’edificio in sé è una torre in stile Giò Ponti-Pirellone flessa a racchiudere lo spazio in maniera barocca.
Las Vegas rispetta quindi a pieno il quarto principio dell’eterotopia, mettendo gli uomini in condizione di non percepire il tempo non solo dal punto di vi-sta della rappresentazione. Si pensi agli spazi di Las Vegas che sono degli shed eterotopici, climatizzati e privi di finestre nei quali grazie all’illuminazione artificiale l’alternanza tra dì e notte viene abolita per lasciare spazio a una realtà amniotica fatta di moquettes le quali assorbendo la luce fanno brillare ancora di più le luci delle slot machines.All’esterno invece i cartelloni pubblicitari si occupano di negare la notte, di giorno i colori sgargianti ammiccano ai passanti, di notte quan-do i colori sarebbero invisibili i neon si accen-dono mantenendo la capacità del billboard di sedurre inalterata.
Quindi vivere Las Vegas vuol dire vivere una gior-nata eterna la cui scenografia è un mondo anacro-nistico, senza storia e senza epoche.Ma Las Vegas non è solo luogo dell’eterotopia del tempo, è anche luogo dell’eterotopia della nave, del viaggio di nozze, il non luogo inteso come spazio dei flussi che non viene abitato da un gruppo fisso di in-dividui ma oltrepassato da un flusso di clienti, proprio come tutti gli spazi del contemporaneo – la stazione, il centro commerciale, per non parlare dei learning center e di altre realizzazioni del nostro tempo.Si pensi alle grandi distese di moquette delle sale da gioco attraverso le quali passano migliaia di ameri-cani alla ricerca della felicità, ultima frontiera da su-perare istituzionalizzata dalla costituzione mericana attraverso la pursuit of happyness.Questa città ci pone a gran voce la domanda se libertà e spirito critico siano necessarie per appagare il desi-derio di felicità. Gli spazi di tale città rappresentano una netta presa di posizione a riguardo.Ma anche se Vegas è negazione del proprio tempo: essa è possibile solamente nella nostra epoca, nelle no-stre condizioni sociali, nei nostri equilibri di potere.Sotto questo punto di vista diventa interessante “Ze-ropoli” di Bruce Begout che rivela quali sono i mec-canismi sociali e economici che le “stranezze” di Las Vegas celano. La città infatti è la metafora in termini spaziali e so-ciali dei meccanismi propri di un sistema economico caratterizzato dal matrimonio tra capitale e spettacolo.Possiamo sintetizzare il ragionamento di Begout uti-lizzando due dispositivi che Las Vegas mette in moto al fine di convincere il cittadino, diventato consuma-tore, a liberarsi del frutto del proprio lavoro, il dena-ro. La forma dello spazio e l’architettura non sono altro che strumenti messo in moto per raggiungere tale scopo.Il primo dispositivo è il gioco. Las Vegas è un’isola nel deserto tenuta viva dal denaro: questa città non poterebbe essere scissa dal desiderio che l’americano emersoniano prova verso l’affermazione di sé attra-verso il rischio individuale e l’avventura. Il gioco po-trebbe essere visto come un simulacro dell’avventura che Thoreau aveva vissuto a Walden. Il giocatore però basa la sua esperienza non sul rifiuto di un insie-me di regole ma sull’accettazione delle regole. L’av-ventura del giocatore è molto più simile all’avventura del consumatore in un grande centro commerciale, si è liberi di scegliere il prodotto ma non si è liberi di es-sere altro che consumatori all’interno di tale spazio.L’idividualismo di Thoreau che concepiva la disob-bedienza civile e l’espressione delle minoranze si trasforma nel suo opposto: nell’omologazione del consumatore e nella massificazione.
La doppia catenaria che sorreggendo la copertura dei primi drive in della Mc Donald’s
forma il logo dell’azienda è testimone di come il valore semantico dell’architettura
oltrepassi quello spaziale
Il Golden Nugget subisce molteplici trasformazioni della sua pelle per arrivare negli
anni ‘60 a diventare un edificio insegna
Il secondo dispositivo è lo stordimento. Las Ve-gas porta agli estremi le tecniche di persuasione arrivando a utilizzare l’arma dello stordimento per adescare nelle sale del gioco i potenziali clienti. Non a caso Begout cita “Fear and Loathing at Las Vegas” di Hunter Thompson, dove il protagonista tossicodipendente non è più un hippie ribelle ma un impiegato vacanziero a Las Vegas. Lo stordimento non ha più quel carattere di rifiuto ma diventa par-te della vita di un membro integrato della società, meccanismo che favorisce il consumo. Las Vegas è qualcosa di molto più forte di qualunque sostanza psicotropa.Venturi spiega gli espedienti architettonici che ven-gono utilizzati per sopire lo spazio e quindi l’au-tocoscienza, poiché lo spazio altro non è che una forma primigenia di autocoscienza.La parte a mio avviso più interessante in tale analisi riguarda la commistione tra grande dimensione e cartellonistica nel sostituirsi alla percezione. Ven-turi infatti attribuisce ai cartelloni illuminati di Las Vegas la capacità di appiattire lo spazio e proiettare l’utente in un mondo bidimensionale, di giorno in-vece sono i meccanismi della grande scala e del-la grande velocità a obbligare l’uomo ad affidarsi a un sistema semantico di cartelloni. Si pensi agli incroci a quadrifoglio dove per raggiungere una de-stinazione alla propria sinistra bisogna imboccare, seguendo un cartellone una via che porta alla pro-pria destra. Lo stordimento è la chiave del successo quando si tratta di vendere piacere, Las Vegas è una città costruita per stordire.Non c’è quindi da chiedersi quale sia lo spazio che rappresenta Las Vegas, e quindi forse la nostra epo-ca, perché tale città lotta con tutte le sue forze per abolire lo spazio. Per abolire quindi l’autocoscien-za e lo spirito critico.
In una serie di scatti Venturi dimostra come colo-ri sgargianti e neon facciano funzionare i billboard
ugualmente bene sia di giorno che di notte.
III
Era questo il ritornello di una canzone dei “99Posse” del lontano ‘92. Sono
cambiate un po’ di cose nel panorama po-litico italiano, anzi diciamo europeo, ma il tema del reddito minimo fa ancora discu-tere. Proprio quest’anno infatti la nostra ministra del lavoro, a due precarie che la interrogavano in merito all’argomento, ha risposto che in un paese come l’Italia, dove c’è il sole nove mesi l’anno, con una misu-ra del genere gli italiani invece di andare a lavorare si siederebbero a mangiare la pasta con il pomodoro. Alle gaffe della Fornero ci siamo abituati in fretta e la polemica con la ministra non vuole essere il centro di quest’articolo.
Penso possa essere molto più interessante, invece, approfondire il dibattito sul tema del reddito minimo. L’argomento è tuttora oggetto di dibattito politico, ma la storia della nascita ed evoluzione di questo con-cetto è da datarsi molto indietro nel tempo. Già nell’opera di Thomas More “L’Utopia” (1516) si può individuare la proposta di un reddito minimo, e Tom Paine, deputato gi-rondino alla Convenzione Nazionale, fu il primo a proporre l’istituzione di un reddito minimo universale. Ma è con la rivoluzio-ne industriale e l’affermarsi del modo di produzione capitalista che la proposta del reddito minimo inizia ad imporsi nel dibat-tito politico. Non intendo in questo articolo, dunque, farne una trattazione sistematica ed esaustiva, ma semplicemente fare chiarezza su alcune ambiguità di significato e lancia-re qualche suggestione e spunto di rifles-sione.In primo luogo, la terminologia che viene utilizzata per indicare questo tipo di mi-sura è assai varia: reddito di base, salario garantito, reddito di cittadinanza, reddito di esistenza, reddito minimo universale, o ancora, nel dibattito internazionale, basic income. Questi termini però non sono esat-tamente sinonimi e non indicano le stesse misure.Forse il termine a noi più familiare è quel-lo di “reddito di cittadinanza”, ma esso, in realtà, presenta alcuni problemi dato che, a seguito dei processi di migrariato e globa-lizzazione il criterio a cui fare riferimento dovrebbe piuttosto essere quello della resi-denza. Potremmo per ora, quindi, indicare con il termine “reddito minimo” le misu-re di erogazione di un reddito previste dai vari welfare per chi si colloca al di sotto di quella che, di volta in volta, viene calcolata come soglia di povertà.Una qualche forma di reddito minimo, in-teso in questo senso, fa ormai parte dei sistemi di welfare di tutti i paesi europei, ad esclusione proprio dell’Italia, eccettuata qualche sperimentazione su base regionale, e della Grecia. Anche nel nostro paese, tut-tavia, grazie anche alla spinta di reti come quella di San Precario, la proposta di un reddito minimo incondizionato, sganciato cioè dalla prestazione lavorativa o dall’ob-
bligo di accettare una proposta di lavoro, e cumulabile con altri redditi, ha preso posto nell’arena della discussione politica.A questo proposito molto interessanti sono le analisi fatte dal docente di economia dell’università di Pavia, Andrea Fumagal-li. Il docente, membro tra le alte cose del BIEN “Basic Income European Network” (una rete nata dall’incontro di studiosi e sindacalisti attorno al problema del reddi-to minimo universale nel 1986), in un suo articolo, pubblicato sul sito del “Collettivo UniNomade” nel novembre 2011, distingue tre diverse concezioni del reddito minimo, riferendole alle rispettive posizioni teoriche che le sottendono. Il reddito minimo come lo abbiamo fin qui delineato è riferibile, secondo la divisione che propone il docen-te, ad un’impostazione social-liberista, una posizione cioè che, riconoscendo il primato del mercato, mira a regolamentarne gli ef-fetti distorsivi tramite interventi di welfa-re, uno dei quali appunto sarebbe il reddito minimo, inteso come erogazione, in forma di sussidio, seppur incondizionato (cioè, a prescindere dalla condizione professiona-le, a tutti coloro che si trovino al di sotto della linea di povertà relativa). La misura a cui però il docente dedica più spazio e attenzione è quella conosciuta con il nome di “reddito di esistenza” o “reddito minimo universale”. Per spiegare come esso vine inteso vorrei rifarmi alla definizione che nel testo “Il reddito minimo universale” (2006), ne danno i suoi autori, Philippe Van Parijs e Yannick Vanderborght: con questa misu-ra «intendiamo un reddito versato da una comunità politica a tutti i suoi membri, su base individuale, senza controllo delle ri-sorse né esigenza di contropartite». Questa prospettiva fa leva sul fatto che ogni indi-viduo ha diritto, prescindendo da qualsiasi altra condizione, ad essere partecipe della ricchezza sociale prodotta. Ci sono però delle premesse teoriche che ci possono for-se aiutare a comprendere meglio e a farci un’idea ragionata sull’adeguatezza o meno di una proposta del genere.Sono in molti oggi a parlare dell’afferma-zione di un nuovo modello di capitalismo, un capitalismo che ha mutato in parte il suo modello di produzione e accumulazio-ne della ricchezza. Indichiamo questo fase del capitalismo con il nome “capitalismo cognitivo”, in cui il modello di produzione fordista-taylorista è stato in parte sostituito da altri fattori di accumulazione quali la co-noscenza, la finanziarizzazione e in genera-le tutte le produzioni immateriali di saperi, e che si fonda sull’utilizzo di capitali detti intangibili (formazione, educazione, etc).
Sulla scia di quest’analisi il professor Fu-magalli considera, nell’articolo sopra cita-to, come sia ormai diventato difficile, alla luce di questi cambiamenti, sostenere una divisione netta tra tempo di vita e tempo di lavoro. Proviamo ad esempio a pensare al terzo settore, in cui buona parte dell’attività
lavorativa non viene più svolta nei tradizio-nali posti di lavoro. In quest’ottica la divi-sione tra tempo di lavoro e tempo di vita di-viene molto più difficilmente sostenibile e di conseguenza sfumano tra loro il concetto di reddito e quello di salario. Un importante passo in questa direzione era già stato sta-to fatto dalle analisi femministe, grazie alle quali il lavoro di cura svolto all’interno del-la propria famiglia è stato concettualizzato come lavoro: ciò ha infatti aperto le strade al riconoscimento di altre possibili forme di lavoro non salariato. Da questo punto di vista, riprendendo cioè l’idea che il tempo di lavoro nell’orario ufficiale deputato ad esso, sia solo una frazione del tempo so-ciale di produzione, il reddito di esistenza diventa uno strumento distributivo e non re-distribuivo, perché acquista il valore di una retribuzione a un contributo che ogni indi-viduo dà alla cooperazione produttiva. Sa-rebbe quindi da considerarsi come uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano.Vi è anche un’altra argomentazione di or-dine teorico che giustifica l’introduzione del reddito d’esistenza. Seguendo un orien-tamento libertario “di sinistra” possiamo considerare che, in linea teorica, il valore della terra e delle risorse naturali spetta in parti uguali a tutti gli esseri umani (Steiner, 1992). Nella situazione in cui siamo sareb-be difficile pensare che si possa far giu-stizia in questo senso dando ad ognuno un pezzo di terra dello stesso valore, dobbiamo però ricordare che ogni mezzo di produ-zione trae la sua origine da risorse naturali che non appartenevano a nessuno. Se ci tro-viamo d’accordo, si tratterebbe d’istituire una “tassa unica” di livello tale da coprire la rendita fondiaria, calcolata in un ipotesi di mercato perfetto, delle parti di suolo e sottosuolo oggetto di sfruttamento privato. Anche in quest’ottica il reddito universale non è assistenzialismo ma la distribuzione, ai legittimi proprietari delle risorse, di una quota equa di ricchezza sociale prodotta. L’unico sistema oggi esistente che possa darci un esempio valido in questo senso è l’Alaska, in cui vi è un reddito minimo uni-versale finanziato attraverso i dividendi del petrolio, nel cui Stato si trova un importante giacimento.
Per concludere sul piano della tutela del lavoratore, il reddito minimo universale costituirebbe un disincentivo ai lavori de-gradanti e al lavoro nero, dato che diminui-rebbe la ricattabilità del lavoratore. Inoltre, essendo cumulabile con altre fonti di reddi-to, la situazione finanziaria dell’individuo migliorerebbe dall’accesso al mondo del lavoro; non disincentiverebbe perciò l’at-tività lavorativa, ma annullerebbe la dipen-denza finanziaria da sussidi e faciliterebbe, dunque, l’uscita da situazioni di disoccupa-zione e marginalizzazione.Il discorso sarebbe ancora lungo e articola-to, ma questi sono degli spunti su cui inizia-re a riflettere.
“ ‘O salario garantito”?di Giulia Zanon
IV
Uno spettro si aggira per l’Europa...di Marco Sinuello
I nizio con le primissime paro-le del Manifesto del Partito
Comunista dei signori Marx ed Engels perché, nel numero pre-cedente di Charta Sporca, un articolo di Lorenzo Natural in risposta al mio “Strada o soprae-levata” dipingeva il mio discorso come uno degli ultimi superstiti della corrente marxista secon-do cui l’arte dev’essere veicolo per la politica, che l’arte non può esser altro se non un modo per raggiungere le coscienze, le orecchie e i cuori delle masse. Con questo piccolo articolo spe-ro di riuscire a chiarire la mia visione delle cose, anche perché credo che in un certo senso sono stato frainteso e sfrutto l’occa-sione inoltre per rispondere al-meno in parte alle domande che mi sono state poste da Luca Lo-pardo in forma privata, e questo per il semplice fatto che spero in tal modo di coglier due piccioni con una fava e lungi da me voler strumentalizzare queste righe a mio favore (spero non si parli di autocelebrazione in questo caso e non perché mi spaventi la criti-ca, ma per un faccia a faccia con la mia moralità che cerca sempre di seguire le stesse regole).
È vero che il mio passato è stato attraversato dallo spettro del mar-xismo ma credo che con gli anni sono maturato abbastanza per sa-per tralasciare ideologie e affini e saper affidare il mio sguardo – critico o meno – a qualcosa che possa stare, per quanto possibile per la razza umana, super partes; è anche vero che uno dei perio-di che mi ha arricchito di più sia culturalmente che in generale nel mio trascorso, è stato quello pas-sato a lavorare in acciaieria in mezzo al post-proletariato, visto che oramai si dice sia morta que-sta classe dal sapore antico. Ora detto questo e avendo buttato le mie carte sul tavolo, continuerò con le volontà primarie di questo aggregato disordinato di caratteri messi insieme per l’occasione.
Mi rammarica leggere l’articolo di Lorenzo quando riprende le parole di Mao sull’impossibilità naturale di avere un’arte libera dai legami troppo stretti della po-litica, un’arte che non possa es-sere indipendente, che non possa esprimere realmente quello che vuole perché costretta dalle più svariate limitazioni; questo for-
se significa che non sono stato chiaro, forse che non sono ca-pace di esprimermi chiaramente anche utilizzando un vocabola-rio semplice, quindi figuriamoci uno dantesco (per così dire); ma ridurre l’espressione artistica ad un mero mezzo di trasporto, ad un freddo veicolo di un messag-gio non era il mio fine e non lo è mai stato. Non so in che stereotipo dovrei cadere per aver scritto quello che ho scritto, e quello che an-drò qui a spiegare in forma più chiara, spero, ma personalmente non mi sento il prodotto della cultura scolastica e uniforma-ta di cui Lorenzo mi farebbe portavoce. Ho il brutto vizio di scrivere ogni cosa basandomi in buona parte su ciò che ho vis-suto, ma mi dà profondamente fastidio ripetere i grandi nomi del passato e del presente senza apportare qualcosa di mio, senza filtrare quello che leggo, osservo e sento attraverso la mia indivi-dualità, senza la libertà di poter aggiungere io qualcosa e senza la libertà di sapere che qualcun altro potrebbe arricchire il tutto con la sua visione delle cose.
Qualche tempo fa si parlava tra amici del concetto di arte, di cosa sia l’arte per ognuno di noi, di cosa essa rappresenti per ognuno di noi, e rileggendo l’articolo di Lorenzo mi fa sorridere che dalla mia bocca sia uscito: “l’arte è la ricerca della bellezza soggettiva, qualunque cosa essa possa si-gnificare”; adesso, sulla sedia e con davanti una pagina virtuale su cui digitare lettere penso che forse Mao o Marx non sarebbero contenti di questa mia conclusio-ne, ma poco importa, anzi non importa proprio. Il mio non vo-leva essere un monito contro la libertà di espressione culturale, ma un richiamo all’umiltà e alla semplicità – che forse erronea-mente viene vista come bassezza di linguaggio e di messaggio – degli attori in gioco. Non mi ritengo un artista e nep-pure mi interessa la corona d’al-loro ma a mio modo esprimo le mie sensazioni, il mio vissuto e le mie conoscenze (quel poco che posso dire di sapere) attra-verso svariati metodi artistici, che comprendono la scrittura, il disegno e la fotografia e attra-verso di essi cerco di esternare quello che in altre forme non
riuscirei a trasmettere. Soprat-tutto con il disegno e la fotogra-fia mi ritrovo spesso a cercar di racchiudere in essi non soltanto una forma armonica o per così dire artistica (perdonatemi l’uso scorretto o inesatto del termine), ma cerco sempre di racchiudere tra le forme che scelgo, che sia-no esse tracciate con la matita a formare una figura, catturate dal sensore della mia macchina o sputate dalla mia biro, un signi-ficato che a volte è tutt’altro che immediato, tutt’altro che chiaro ed è qui che interviene il mio lato più popolare per così dire, quel lato che non mi consente di fermarmi all’ “opera” finita ma che mi spinge a far si che il suo significato possa venir colto da tutti, di modo che tutti abbiano assoluta libertà di esprimere al-meno un giudizio su di essa, di modo che anche io stesso grazie alle sensazioni trasmesse da chi la guarda possa arricchirmi ma senza lasciarmi influenzare.
Mi sarebbe piaciuto riportare le parole esatte di un artista dei nostri giorni e che seguo oramai da qualche anno, Davide Van de Sfroos, conosciuto ai più per la sua presenza a Sanremo; tutta-via cercherò di proporre un con-cetto riportato in un suo dvd e che esprime un po’ questa idea: parlando del suo rapporto con il suo pubblico e parlando dei suoi testi e delle sue canzoni usava la metafora delle increspature dell’acqua create da un sassolino lanciato nel lago; inizialmente le increspature si espandono verso l’esterno ma poi, grazie anche al movimento dell’acqua, ritornano all’origine: è in questo modo che Davide vede il suo scambio con le persone (il termine “massa” è a dir poco spregevole), la sua crea-zione, in questo caso la musica, si arricchisce nello stesso tempo in cui le persone che la ascoltano si arricchiscono del messaggio che lui vuole dare.
L’esempio di un cantante folk vi sembra troppo popolare, pas-siamo a qualcosa di più altiso-nante? Gaber, in una sua celebre canzone, recita così: “la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione”; non so se gli esempi musicali sono all’altezza ma non credo che ci sia biso-gno di barcamenarsi molto per spiegare un concetto. Come ho
detto prima non voglio tagliare le gambe a nessuno, non voglio che tutta l’arte e la cultura rientri in un grande carro guidato dagli “interessi” politici, ideologici e chi più ne ha più ne metta, dico solo che un’opera d’arte possa regalare molto di più anche al suo autore, se questo riesce a far-ne comprendere la bellezza e il significato al maggior numero di persone possibile, dando il via ad un rapporto che non è solo uni-laterale, ma bilaterale, o meglio multilaterale. Non significa cam-biare il messaggio, modificare il linguaggio o la forma dell’ope-ra, significa fare l’opera d’arte come si vuole, ma poi se neces-sario spiegarla anche in termini meno altisonanti e avvicinare in questo modo uno spettro più ampio di persone, per portarle grazie ad una iniziale semplifi-cazione del messaggio al livello (passatemi il termine) iniziale, forse così avremo risvegliato un barlume anche dove prima non ne vedevamo la benché minima possibilità.
Magari può sembrare un discor-so da profeta, ma non è quello che vuol essere; questo vuol es-sere solo un invito a condividere maggiormente quello che indivi-dualmente si produce, un invito a lasciar da parte gli individua-lismi e cominciare a creare mo-tivi di partecipazione, un invito a guardarsi intorno soprattutto oggigiorno dove non c’è bisogno di politicizzare l’arte, ma sem-plicemente condividerla per dare un senso non solo estetico ma anche etico al tutto. Se poi fare arte significa saper snocciolare nomi a discapito della condivi-sione, preferisco condividere di più e conoscere qualche nome in meno.
Chiudo l’articolo con quella che per qualcuno potrebbe essere una provocazione, anche se spe-ro tuttavia che non lo sia: dopo aver riletto diverse volte l’ar-ticolo di Luca mi chiedo se nel 2012 il semplice fatto di voler condividere qualcosa di proprio con il maggior numero di perso-ne possibile debba ancora essere taggato come un comportamento marxista e non semplicemente NORMALE.
V
Il primo grande romanzo dello scrittore franco-algerino Albert Camus (1913-1960), L’Étranger (Lo straniero), pubblicato nel 1942, pone numerosi spunti d’analisi inter-essanti: qui ho deciso di analizzarne uno, apparentemente secondario, ma in verità meritevole di interesse critico, ossia la cosiddetta condizione di “mediterraneità” provata ed esaltata dall’autore stesso.Preme qui sottolineare la forte componente autobiografica – almeno per quanto con-cerne il tinteggio psicologico del personag-gio – del romanzo: Meursault, il protago-nista, è lo specchio dello scrittore. Ciò che appare interessante è la condizione del per-sonaggio principale: Meursault è costante-mente colpito dai raggi di sole. E sia il sole, il grande caldo, sia la vita all’aperto sono fattori della condizione del giovane Camus. Albert intravedeva nella nuova Algeria una terra da cui poter ripartire da zero, tema focale, tra l’altro, del romanzo incompiuto Le Premier Homme (Il primo uomo), che avrebbe dovuto rappresentare un ipotetico epos della famiglia Camus, a partire dalla figure del padre di Albert: «il Primo Uomo […] rappresentava la prima generazione di franco-algerini1; era il padre di Albert Ca-mus, ucciso durante la prima guerra mon-diale […], ma era anche Albert stesso, che cresceva in un vuoto storico e culturale, accentuato dall’analfabetismo della sua famiglia e simboleggiato dall’assenza di libri nella sua casa. “Immagino, dunque, un primo uomo che parte da zero”, spiegava già nel 1945 ad un giornalista che l’intervistava; “che non sa né leggere né scrivere, che non ha morale né religione. Sarebbe, se volete, un’educazione senza educatore”»2.Un’Algeria immersa nel mondo mediterra-neo, fatto di sole, caldo e mare, tratti che, secondo Camus, non sono soltanto delle mere peculiarità climatico-paesaggistiche, ma simboli di una condizione umana ben precisa, quella che lo scrittore chiama, ap-
punto, Méditerranéité. È Francesco di Pilla a spiegarci questa condizione dello scrittore e – di riflesso – del personaggio-Meursault: «la sola verità che ci è data è il corpo, che deve corrompersi; proprio perciò assume un’amarezza e una nobiltà che non devono essere tradite. È quel che fanno, invece, les bons esprits, che preferiscono la poesia, af-faire d’âme, alla verità che non osano guard-are in faccia; eludono, ed è proprio questo il materialismo più ripugnante: il peccato contro la vita non tanto consiste nel disper-arsene quanto nello sperare in un’altra vita, sottraendosi all’implacabile grandezza di questa. Le nostre vere ricchezze – un corpo giovane nel sole, il tepore dell’acqua, i cor-pi bruni delle donne, i silenzi estivi e la loro noia – non hanno futuro, le nostre gioie sono e debbono essere senza speranza; perché sperare equivale a rassegnarsi, alleggerisce e vanifica il valore unico di tali verità rela-tive, le sole che abbiano un senso»3.Continua, poi, lo stesso di Pilla: «Camus riconosce e rivendica quest’etica del sole e della carne come propria di tutto un popolo, il popolo fanciullo d’Algeria dagli elemen-tari principî; dalle facili felicità, generosa-mente abbandonato a una furia di vivere che rasenta lo spreco per la natura stessa del suo paese, in cui tutto vien dato per essere tolto; proprio perché nato per l’orgoglio e per la vita esso avverte con più ripugnanza il sen-timento della morte, e si affetta a vivere, nel presente sans mythes, sans consolation, gioca tutto sulla carne e muore senza sper-anza: non bara»4.
È il sole cocente a fare da sfondo ai due momenti chiave della prima parte del ro-manzo: il funerale della madre e l’omicidio dell’uomo arabo. Mentre si svolge il cor-teo funebre, il sole avvolge tutta la scena, contribuendo alla grande stanchezza di Meursault e alla sua estraneità. Similmente, l’omicidio dell’arabo avviene in seguito a una banale rissa tra Raimondo (amico del protagonista) e alcuni uomini d’etnia araba su una spiaggia di Algeri; anche in questo caso il grande caldo emanato dal sole in-veste Meursault. Il dolore provocatogli dal sole – lo stesso sole che lo aveva accompagnato durante il corteo funebre, talmente forte da avergli fat-to desiderare al più presto il ritorno a casa dall’ospizio di Marengo – farà scatenare la «sventura» in cui andrà incontro Meursault, compiendo l’efferato omicidio, avvolto da un calore solare quasi apocalittico: «A causa di quel bruciore che non potevo più sopportare ho fatto un movimento in avanti. Sapevo che era stupido, che non mi sarei liberato dal sole spostandomi di un passo. Ma ho fatto un passo, un solo passo in avan-ti. E questa volta, senza alzarsi, l’arabo ha estratto il coltello e me l’ha presentato nel sole. La luce ha balenato sull’acciaio e fu come una lunga lama scintillante che mi colpisse alla fronte. In quello stesso mo-
mento, il sudore dalle mie sopracciglia è colato di colpo giù sulle palpebre e le ha ricoperte di un velo tiepido e denso. Non sentivo più altro che il risuonar del sole sul-la mia fronte e, indistintamente, la sciabola sfolgorante sprizzata dal coltello che mi era sempre di fronte. […] È allora che tutto ha vacillato. Dal mare è rimontato un soffio denso e bruciante. Mi è parso che il cielo si aprisse in tutta la sua larghezza per lasciar piovere fuoco. Tutta la mia persona si è tesa e ho contratto la mano sulla rivoltella»5.
Ciò che è importante sottolineare non è sol-tanto l’omicidio in sé, ma l’atteggiamento che tiene il protagonista in queste determi-nate situazioni: Meursault non è di per sé un assassino, ma viene spinto ad agire istintiva-mente dalle condizioni climatiche – che as-sumono anche il ruolo di condizioni sociali: è la Méditerranéité a influire sull’uomo e a farlo rispondere all’essenzialità delle cose. Lì sulla spiaggia Meursault non ha pensato, ha agito senza dover rendere conto a una morale che in lui non ha mai attecchito. Sulla spiaggia Meursault era solo con se stesso, di fronte all’arabo, spoglio di ogni altra sovrastruttura, solo tra il mare e il sole algerini. Herbert R. Lottman cita come par-adigma di questa condizione la conclusione di un poema giovanile di Camus – Méditer-ranée – pubblicato postumo, insieme ad al-tri poemi giovanili:
Méediterranée, oh! mer Méditerranée!Seuls, nus, sans secrets, tes fils attendent la mort.La mort te les rendra, purs, enfin purs6.
Così sarà, nel finale, anche per Meursault: solo, nudo, senza segreti, attenderà la morte, avendo compreso che «l’unica catar-si consentita all’uomo assurdo sta nella dis-persione della coscienza»7 e che attraverso essa troverà la purezza.
NOTE:1 Per franco-algerini Camus intendeva quella «razza bastarda, fatta di miscugli imprevis-ti» (Lottman, H. R., Albert Camus. A Biog-raphy, New York, Doubleday & Co., 1979; trad. it. di C. Mattioli, Camus, Milano, Jaca Book, 1984, p.21). 2 Ibid.3 di Pilla, F., Albert Camus, Lecce, Milella, 1974, p. 474 Ibid..5 Camus, A., Lo straniero, Milano, Bompi-ani, 1970, trad. it. di A. Zevi, p. 756 «Mediterraneo, oh! mare Mediterraneo! / Soli, nudi, senza segreti, i tuoi figli atten-dono la morte. / La morte te li renderà, puri, finalmente puri».7 Federici, F., Introduzione, in Camus, A., Il mito di Sisifo, Milano, Bompiani (I Satel-liti), 1971, trad. it. di A. Borelli, p. 13.
Méditerranéité ed etica del sole ne L’Étranger di Albert Camusdi Lorenzo Natural
VI
Relazionidi Tommaso Tercovich
Lo ammetto, questa estate sono stato alla ricerca. Alla
ricerca del nostro Bildungsro-man. Tra romanzi soft-porno pri-mi in classifica, storie di anarchi-ci e gialli con intrighi mondiali ambientati a Trieste (non ridete) ecco finalmente una sana ricerca verso il romanzo di formazione di una generazione. Mi sono fermato a cent’anni fa. Ancora quella ge-nerazione che per molti aspetti si trovò ad affrontare un periodo di transizione come il nostro.Persone, reali o fantastiche non importa, come giovani spec-chi della realtà in movimento dell’inizio del Novecento. Una generazione di uomini sull’orlo della guerra. Il concetto di guerra non è uni-voco e può ben rappresentare lo stato emotivo collettivo di questo momento come del secolo prece-dente.
Volendo trovare dei caratte-ri generali: Violenza (istinto), gioco delle Probabilità (caos) e dominio sulla Natura (ragione). Guerra come incertezza che si vive oggi verso il futuro, guer-ra come scontri (mi vengono in mente TAV e Grecia), guerra come ragion-tecnica che incide sulle scelte di molti. Tra Stati in bancarotta, debito come catena e la nebulosa della cultura in cui ognuno cerca sé stesso.Emil e Tonio sono i protagonisti delle due novelle: “Demian” di Hermann Hesse e “Tonio Krö-ger” di Thomas Mann. Due pila-stri della letteratura tedesca, due storie esemplari di giovani uomi-ni in cui ho voluto cercare un filo, un filo che porti a pensare a noi e a oggi.È dalla strada che partono en-trambe queste storie: la strada simbolo delle generazioni alla ricerca. La percorrono in coppia Tonio con Hans, l’amico simbolo della bellezza e della perfezione, frutto di un passato aristocratico che si avvia al disfacimento, ma che in Hans esprime il suo pupillo. Allo stesso modo anche Emil con Kromer passeggiano, il secondo incarna le tentazioni e la “strada sbagliata”, quella che conduce al male. La strada è indubbiamente contrapposta in entrambi i casi alla scuola, stabile edificio simbo-lo di autorità e tradizione, ma che non riesce a influire sulle espe-rienze dei due protagonisti, che lo percepiscono come superato.I due testi nascono con qualche
anno di differenza: Demian scrit-to nel 1917, ma pubblicato nel ’19, Kröger nel 1903. In più biso-gna dire che il racconto di Hesse nasce anche sotto l’impulso del-la psicanalisi a cui lo scrittore si sottopone in quegli anni. Come Emil si scopre attraverso Demian (l’amico bambino/adulto che rap-presenta il Bene) e Kromer (che incarna lo spirito maligno), così Tonio trova nel suo stesso nome il dualismo: Tonio è Antonio, nome che richiama musica, arte e Sud mentre Kröger parla di borghesia nordica.
Entrambi non si trovano più nell’ambiente della fanciullezza, i tempi passati, ma in un presen-te di incertezze e turbolenze che portano i due a muoversi.La volontà porta i protagonisti a ricercare la propria umanità, l’essere Uomo completo prima di qualsiasi altra cosa. Perché «non si vorrà mica considerare uomini tutti i bipedi che passano per la strada soltanto perché camminano eretti e la gestazione dei loro figli dura nove mesi», occorre intuire le proprie possibilità di crescita. Entrambi sentono di dover vive-re nuove esperienze lontano dal-la terra natale. Esperienza come
quella guerra che in Demian arri-verà alla fine del romanzo mentre in Tonio Kröger eccheggia sola-mente.Esperienza è quella del disprezzo verso di sé e verso il mondo ester-no che porta i due a staccarsi e a raggiungere la solitudine. Emil dice: «ognuno deve essere garan-te di se stesso», mentre Tonio si spinge in Italia e in Danimarca (la tematica del viaggio) alla ricerca di sé, disprezzato sia dagli artisti che dai borghesi, da cui è visto come «sviato».Tonio scopre la sua vita in mez-
zo «ai due mondi», mentre Emil vede il suo mondo come Abraxas, che contiene il bianco e il nero, il divino e il diabolico.Infine è il testo di Hesse che com-pie i passi più decisi: «non so se un giorno lei e io e qualcun al-tro rinnoveremo il mondo, ma si vedrà. Dentro di noi però lo dobbiamo rinnovare ogni giorno, altrimenti non contiamo niente». E ancora: ognuno deve «trovare il proprio destino, non un destino qualunque, e viverlo tutto e senza fratture dentro di sé». «C’è da disperare, [...] da tutto ciò non possono derivare giorni sere-ni. Questi uomini che si associa-
no così timidamente, sono pieni di paura e di cattiveria, e non c’è uno che si fidi dell’altro. Stanno attaccati a ideali che non lo sono più e lapidano chiunque ne eriga uno nuovo». La guerra è inarre-stabile, seguendo i tre caratteri citati sopra: «ciò mostrerà quan-to poco valore hanno gli ideali odierni e servirà a spazzare via gli dèi dell’età della pietra, il mondo com’è oggi vuol perire e perirà». Ma non è una visione definitiva: alcuni possono svegliarsi, aspirare alla felicità, ad un futuro. Soltan-to se con la volontà saranno pron-ti a ogni prova. Un insegnamento è sicuramente quello di dubitare, il dubbio verso ogni chiesa, che sia Dio o Patria.
Seguendole come fili mi sono chiesto se queste connessioni fra testi, storie, vite e idee potessero ben rappresentare un nuovo con-cetto di cultura: allora in guerra, oggi in un mondo in disfacimento. Entrambi i protagonisti rifiutano l’autorità come risultato di una tradizione o di una conoscenza solo superficiale. Essere liberi nella propria mente e cercare di vivere nel proprio agire morale in modo autentico, significa ritrova-re il concetto di morale. L’idea di un uomo che attraverso le relazio-ni con tutto ciò che lo circonda, cui è legato strettamente, possa affrontare le situazioni concrete. Attraverso un incessante lavorio interiore di ricerca e scoperta che deve essere spinto dalla volontà. La cultura, cioè leggere, ascolta-re, scrivere, guardare, conoscere, pensare, dipingere e anche vi-vere nel mondo più quotidiano, sono delle relazioni. Che portano ad una messa in discussione sia dell’idea di solitudine, ma anche dell’idea di massa: l’individuo non può più essere eremita in una società globalizzata e anzi deve cercare di migliorarla, altrimenti la subisce; allo stesso modo anche eliminare l’idea di massa e omo-logazione perché l’autenticità è espressione individuale e delle relazioni che la costruiscono. Una cultura delle relazioni che come una rete possa pescare dall’idea di una cultura nebulosa e perife-rica. Una cultura delle relazioni che sia forte e non più considerata come vezzo intellettuale o gioco di denaro.
Una cultura delle relazioni che sia soluzione e non solo risposta.
inserto letterario
Terza Pagina
VII
Che cos’è Trieste? A chi è nato e cresciuto qui, e anche a chi l’ha soltanto sfiorata in un viaggio, la domanda non può non essersi presentata mentre se ne percorrono le viuzze, se ne ascoltano le parole, se ne ammirano le bellezze. Eppure la risposta sfugge.Un luogo? Un’espressione? Un saluto? Forse uno Spirito, di colore turchino, «fra una Slovenia verde e un’Italia sempre più grigia». A leggere questo racconto, premiato lo scorso giugno nel concorso letterario “My Trieste” e che abbiamo l’onore di ospitare su Charta Sporca, le idee si chiariscono: Trieste non può che essere una Poesia.Buona lettura.
Stefano Tieri
Giovinezze triestineAutunnoI.
Mia nonna tiene in mano un bastone nodoso col quale rompe i ricci spinosi delle castagne e ne raccoglie i frutti. Ha appeso al braccio uno di quei sacchetti trasparenti che ti danno al supermercato per la verdura e lo riempie pazientemente. Lo stringe forte alla pancia: ai miei occhi di bambino anche lei è un bastone nodoso. Un corniolo, ma fragile quanto un ramo di fico. Io le incespico dietro ed il terriccio umido, in pendenza, frana sgretolandosi in un fruscio di foglie e scricchiolii di rami.Corro seguendo i suoi capelli tinti di biondo, un biondo riccio di castagna schiacciato nella terra.«Su, che appena ne abbiamo abbastanza andiamo a raccogliere le noci a Prosecco» mi dice.«Sì, nonna!» e scivolo e respiro ombra e selvatico.A Prosecco c’è la Napoleonica, con le sue pareti di roccia che per me sono montagne, sono strapiombi a picco sul mare, dove da qualche parte ci sarà certamente un castello - o è il formaggino? - nel quale la Perla di Labuan mi aspetta ed io un giorno la dovrò salvare. Il mio praho è ormeggiato laggiù, nel molo G a metà fra Barcola e Miramare. Mentre mia nonna raccoglie le noci io mi abbarbico alla ringhiera e guardo in basso. Sono troppo piccolo per comprendere la vastità dell’Adriatico, del Mediterraneo, dell’Atlantico, tanto immensi da fare paura. Per me significano solo avventure e penso di avere la vista così sviluppata che Grado è Bari. Fra qualche anno capirò le distanze e, da una Napoleonica toccata dagli ultimi raggi del sole, vedrò la città sommersa dalla nebbia, con qualche scaglia di mare che brilla perduta nella foschia. Capirò che gettandomi in quella fessura avrò mille direzioni da prendere e che mi perderò. Ma ora no: il mondo è piccolo se sei piccolo, e se allungo la mano scombino il cielo d’Italia.
InvernoII.
Il Carso geme sotto i miei piedi, la brina ha indurito ogni zolla, ogni filo d’erba. Guardo i miei amici: abbiamo quindici anni e stiamo già per entrare tutti sotto terra, sotto questa sottile crosta di roccia. L’allegria si raffredda nell’aria mentre scarpiniamo fra sassi e sterpaglia. Queste sono rocce calcaree, ci hanno detto, che quando piove vengono levigate dall’acqua ed è così che nei millenni si sono aperte le grotte. Il Carso vuol dire grotta, per me, scavato come un gruviera da mille rigagnoli secolari. Abbandoniamo gli zaini su uno dei fianchi con il quale la dolina si chiude. Ecco, più in là - e ci dicono subito di stare attenti - si apre la voragine. È stretta, ci passeremo davvero? Gli adulti armeggiano con spit e corde. I moschettoni tintinnano mentre vengono sbatacchiati fra le mani indurite. Mentre ci mettiamo la tuta, l’imbrago, maniglia, kroll, discensore e freno guardo gli alberi.Sono tristi, sono caduti anche loro in letargo. Ci passano in rassegna mentre sfiliamo: guide ed alberi, alberi che diventano guide e ci squadrano come a chiedersi fra
I girasoli Appesi a bruciare dei fioritre vecchi biechi, tre girasoli tre secchi servi dagli occhi ciechi nati da un seme innaffiato appena vivi siamo, eternamente a impigliarci noi due, i rammendatori ma come morti siamo, attorcigliati come uno splendido mazzo di stecchi raccoglitrice gobba, nel covile stendesti la schiena cruda, lo sguardo pietroso là nascondesti una mano per farti l’amore sugli sterpacci il tuo ansimare giace a seccare per terra appeso a bruciare con loro e pure Galileo fissò, finché confuse le grandi macchie con le macchie degli occhi non vedi più - che siamo appesi a bruciare? in due facciamo una cenere a stento, una ghirlanda concisa lasceremo stecchito o spuntare quel seme non vedi, spuntare già secco. Tre girasoli appesi a bruciare tre galilei, perché guardammo ciechi tocchiamo davvero, o solo speriamo nel tatto?
Piero Rosso
IIIV
Otto marzoDonne che tengono una ghirlanda
di glicine e polline di mimoseombreggiante sul viso
scendono via Fabio Severoe meriggia il sole sereno e tiepido
a questo gruppo di amiche.Si accovaccia sul loro collo
luccica gli occhi, si accalora brevenei sorrisi che spuntano con le parole.
Le segue così dagli spazi apertifra i palazzi da cui uno le scorgevaghe, compiaciute si guardano
allegre a passo a passo,la camminata è lungafino al Molo Audace.
Lì vedono il sole balenaresul mare che vorrebbe coglierei fiori intrecciati sulle loro teste
e farne un campo luminoso.Le amiche si siedono ridarelle
senza un pensiero, le parolesbocciano continue dalle labbra;
un ragazzo, una lezione, un profumouna diceria o qualcosa di agognato.
A notte ci ripenserannopronte a riveder le foto scattate
forse già a letto spogliatenostalgiche di un bel nudo addosso
o già lievemente sonnacchiosestufe e affaticate per una festa
le coperte pesanti sul seno,gli ultimi pensieri alla ghirlanda
che attirò gli sguardidivertiti, attoniti o stupiti
e a quei due ragazzottiincrociati per caso per strada
furbetti ma onestiche le dissero: “o belle principesse”.
Uno rise, le ragazze riserofu detta qualcosa, dimenticata.
Ora però è tarda notte, in una camerettatutto in silenzio, tranne il vento
una di quelle si strugge teneramentemordicchia le labbra, mormora piacere,
ai piedi delle lenzuola, la ghirlanda:glicine senerella di mimosecome un lampo affumicato
ma è un’ombra già negli occhi socchiusi.
Angelo da Baciocchi
loro: “Sono davvero pronti a ciò che li aspetta?”. La betulla sussurra indifferente che sì, siamo pronti; i pini ci guardano con bonaria severità paterna, ma tutti gli altri tacciono in greve silenzio. Il primo di noi scuote il contenitore del carburo, l’acqua corrode la pietra, sprigiona acetilene risucchiato dal tubo e - fsss - divampa la fiamma biforcuta. Siede davanti all’imbocco della fessura, si attacca alla corda, striscia sul sedere e il muschio si rompe liberando terra nera e umidità. Scivola giù, grattando gli strumenti contro la roccia. Lo salutiamo, la risposta ci giunge attutita. Ora sei nella grotta, amico mio, nell’oscurità, che penzoli e ti dirigi verso la luce dell’accompagnatore alla prima sosta. Coraggio, quel buio ci inghiottirà tutti, saremo tutti nelle viscere della terra come un seme nell’ombra.
PrimaveraIII.
Mio nonno ci guarda, poi torna a chinarsi sull’insalata. Il grosso mandorlo che era all’ingresso è morto di siccità l’anno scorso, altrimenti ci avrebbe accolti con la sua chioma bomba di fiori. Ma prima i rami si sono piegati, inermi, poi una grossa spaccatura è esplosa sul fianco, un mese dopo restava di lui solo mezzo metro di tronco. Una volta mio bisnonno, contadino anche lui, passeggiando col figlio incontrò il parroco e questi gli disse: “La ga visto? Ringraziemo el buon Dio che finalmente el ne ga mandà la piova!” “Sì, - rispose lui - ma xe lo steso dio che no ne la ga mandada per un mese.”A marzo mio nonno guarda il campo e le cavedagne dove l’erba continua tenacemente a spuntare nonostante lui sarchi e sarchi con una marra monotona e silenziosa quanto lui. Si leva e sibila aspramente «Anno de erba, anno de merda», poi ci guarda e annuiamo, ma non basta questo a toglierci la città di dosso. Ho diciott’anni, nonno, e a questa età puoi vivere solo in città.Puglie di Domio, nasci dove muore la val Rosandra. Il confine è vicino e la valle è una fenditura nella terra, nel Carso. L’alabarda di San Giusto dev’essere passata di qua prima di cadere in mezzo alla piazza, tagliando la terra, sennò come si spiega la Rosandra? Zelena Slovenija, vieni qui ad affondare anche tu, come la Bora. Sei uno squarcio, Rosandra, sei una ferita, Rosandra, fra una Slovenia verde e un’Italia sempre più grigia. Ma Trieste no, Trieste è turchina.
EstateIV.
Ora è notte e le vie sono deserte. Ha finito di piovere e mille specchi giallastri riflettono i lampioni di piazza Ponterosso. Trascino i miei vent’anni per queste strade come un brandello assente o un fantasma. Carrozze, cavalli, commercianti, borghesi... ne è passata di vita qui, per queste stesse strade. La statua di Joyce mi sorride lontana, ma non mi basta oggi una statua a consolarmi. Del resto i triestini sono sempre stati gente sulle loro: burberi e franchi come il Carso, orgogliosi del loro essere a metà fra due mondi e di aver creato e mantenuto proprio da questo contrasto una loro fiera non-identità, un’identità tutta triestina. E se la pelle era terra aspra, impossibile, nel cuore avevano la generosità del mare.Ecco, come una breccia è questo canale dove il mare penetra nella città e rispecchia i palazzi nel dire: “Guarda, Trieste, sei nella terra e nel mare, questo sei tu, questa è la tua vera anima”. Intingo due dita in questo specchio d’acqua ripensando alle mie genti: poco distante da qui la Mariangela Martinoli salpava chiudendo nel suo grembo di ferro mio nonno paterno; poco più in là i genitori di mia madre partivano per il periplo dell’Istria come viaggio di nozze. E mi chiedo se è rimasto, in questo vasto mare, un singolo grumo d’acqua intatto che ne conservi le tracce, se nel suo infinito mutare si è mantenuta anche solo una goccia identica, nella quale loro si siano riflessi, dove un giorno possa anch’io dire specchiandomi: sono come loro, ho vissuto.
Ettore Spada
Il sontuoso abbaiare di Isabella
Il pacchetto era finito. Gli rimaneva, in fondo al cappottone bolscevico, un ultimo sigaro aromatizzato al caffè. Non era mai stato un fumatore, non era buono. Mai provato a inalare nemmeno una cicca. Paura di iniziare, di soccombere al vizio. Aveva sempre avuto pure la fobia del volo, forse perché non aveva letto Erica Jong. A 32 anni si poteva dire che avesse realizzato il suo unico obiettivo: non lavorare. Mai. Per nessuna ragione. Oh dio, qualche lavoretto l’aveva fatto, roba di massimo due giorni, caricare, scaricare, montare, smontare, tutto rigorosamente in nero e alla paga di un nero. Ma così, per gioco, mica gli serviva nulla. I suoi, prima di morire schiantati da un coca-party (o almeno questo era quanto soleva raccontare sua nonna ai vicini), avevano messo via una somma non indifferente. Pietro doveva tutto alla nonna, che l’aveva educato alla parsimonia e al rigore intellettuale. Era stato un ottimo studente al liceo, laureandosi poi in filosofia; tesi su Kant, cieli stellati sopra di me e legge morale dentro di me, l’Immanente e quant’altro. Faceva il colto per rimorchiare le donne con seni pesanti e labbra rosse. Rimediava parecchie chiavatine, fighetto com’era gli andava bene. Per il resto, passava la sua vita a guardare il soffitto fumando sigari accesi con gli editoriali di Ernesto Galli della Loggia, leggendo libri di seconda mano e ascoltando dischi. Pianoforte, soprattutto. Classico, moderno, jazz. Dei nuovi gli piaceva Ludovico
XI
Preludio in A ed E minore
Elena è andata al mare:ama la vela, l’acqua salata,ma teme l’alta marea che sale.
E’ amata da Enea, che le canta la serenata:“Ah, Elena, che serata!L’aere sa da sale,è banale,ma è senza malsane stranezze...e le stelle! Che belle!”
“Ah Enea” geme Elena,“Spera che la barca tenga, perché è alta la marea!”
“Fa’ vedere... ah! Alta?Ma se è bassa! Sta’ calma...!”
“E’ alta, è alta!”
“Aspetta...”
Ma la barca è andata,Enea cade, ed Elena sa che è persa...
Ally Terante
Einaudi, o forse era Michael Nyman. Adorava Nils Frahm, Snippet lo mandava in delirio. So a che pensate, ma no, non beveva. Se non vino buono, ma il vino buono costa denari e quindi lavoro, fatica, sudore addirittura. Nulla aveva senso, lui l’aveva capito. In questo era un genio innato; nell’aver percepito l’idiozia di voler stare al passo col declino occidentale a spese di quel minimo di dignità, pudore e sensatezza che i suoi contemporanei andavano progressivamente perdendo, sgomitando e sbranandosi come cani rognosi attorno a un misero ossicino consunto in un oceano di Coca-Cola. Laddove gli altri tenevano sincronizzati tre orologi per polso, districandosi tra viagra e antidepressivi, bambini da portare a scuola e mogli in carriera perennemente incazzate, Pietro teneva in casa un orologio rotto, del quale ammirava la perfetta ostinazione nel segnare l’ora giusta due volte al giorno. Una vita meravigliosa, che ogni tanto certe zecche provavano a rovinargli. Per esempio Lucio, imprenditore, tre volte divorziato, un infarto all’attivo e due passioni sfrenate: eroina e pesca. Capitava che lo chiamasse senza motivo, giusto per invidia: era troppo tranquillo, Pietro, la sua atarassia era segretamente desiderata dai più, la cui pavida soggiacenza al presente impediva loro ogni anelito emulativo.“Che fai, Pietro, lavori? Ahahah.”“In realtà stavo andando alle poste. Ritiro la pensione di nonna.”“Un giorno devi venire in barca con me, ti mostro il nuovo ecoscandaglio. Ho speso un occhio, credo che la mia famiglia si scioglierà.”“Credo che poche cose siano più inutili di un ecoscandaglio.”“L’inutile è quasi sempre foriero di sublime. Tranne l’uomo.” Pietro pensò che in fondo Lucio non era male. Un personaggio bipolare, tossicomane, ma che sapeva godersi la vita. Odiava il calcio, come tutti gli ultimi esseri umani decenti rimasti sulla Terra; approfittava delle partite della nazionale per darsi alla pesca di frodo. A suo modo, un mezzo genio.“Pietro, perché non ti trovi un lavoro?”“Non so fare nulla.”“Entra in Polizia, allora.”“Ma Cristo, ho una dignità. E poi sto bene, a casa.”“Almeno Isabella ti tiene compagna, ah!, che meraviglia di cagna. E che guaiti!”“Non più, purtroppo. Mordeva. L’ho fatta abbattere”. Aggiunse che andava di fretta, poi salutò e riappese.A proposito di Isabella, magnifica setter irlandese, in molti avrebbero ritenuto la sua esecuzione un abominio. La sua ex gliela rinfacciava continuamente: “I CANI NON SI TOCCANO! E POI TU NON SEI NEMMENO CONTRO LE SPERIMENTAZIONI SUGLI ANIMALI!”, urlava, dandosi un ultimo colpo di phard.
Il parcheggio alle poste, manco a dirlo, era pieno. Per un attimo pensò di lasciare l’Alfa in sosta vietata, ma una vigilessa chiatta e orripilante pattugliava la zona. Si infilò a pettine in uno spazio a pagamento, mise venti centesimi in macchinetta e corse dentro, dove lo attendeva una coda immensa. Tra scaffali ricolmi di premi Strega e scevri di sentimento, guardava le scarpe delle donne in sala, interrogandosi sul grottesco scenario cui non riusciva ad abituarsi: ballerine, con strass e fiocchi e in tinta kiwi, erano disseminate ovunque. Giusto un paio di tacchi 12, ma Pietro si chiese come potesse uno scoglio arginare il mare. Dopo mezz’ora fu il suo turno. Pietro fece quel che doveva fare. Non leggendo altro che gli editoriali di Galli della Loggia, era scarsamente aggiornato sulle ultime nefandezze di Stato. Fu quindi sorpreso quando trovò nella busta di nonna 180 euro in meno del solito. Chiese spiegazioni all’impiegata, passabile ma satolla di sciatteria.“Qual è il problema?” Chiese lei senza il benché minimo savoir faire.“Qui ci sono 492 euro. E gli altri 180? Fino a un mese fa la nonna prendeva 670 euro.”“Lei dove vive, scusi? Monti ha tagliato sulle pensioni.”“Sta scherzando?”“Perché dovrei? Mi pare giusto. I pensionati sono il cancro del sistema. Gente schifosa, che ha tirato la cinghia e ammassato soldi una vita intera per comprarsi una casetta, mettendo i pericolo il neo-liberismo. Si rende conto che dobbiamo ringraziare il capitalismo se viviamo in un mondo evoluto, dove ciascun individuo ogni week-end può andare al cinema a vedere un nuovo film in 3D? E poi chi avrebbero dovuto colpire, secondo Lei? Gli evasori, magari? Si rende conto che è solo grazie a loro se noi parastatali veniamo lasciati in pace dall’opinione pubblica? Non fosse per i politici e altri criminali, verremmo linciati.”Pietro rimase basito, mentre l’impiegata si riassestava la coda malamente mechata.“Cosa fa stasera?” le chiese“Vado in palestra, perché?”“Immaginavo. Lasci perdere, passo a prenderla dopo il lavoro.” La piantò lì, senza salutarla. Funzionava sempre. Quella sera non fece eccezione. Ci diedero alla grande, parlando tutta la notte. Lei parve capire molte cose. Il mattino dopo se n’era già andata, quando Pietro si svegliò, col mal di testa e l’alito cattivo. Aveva voglia di fumare, ma, acceso con un corsivo di Pierluigi Battista, il sigaro non gli recò il solito gaudio. Sentiva dalla finestra di fronte aberranti cacofonie curde. Forse avrebbe cercato un lavoro. Poi, ripensandoci, si girò e si rimise a dormire.
Gervaso Pandora
X
Cari lettori,A giugno due “chartasporchisti” hanno partecipato al concorso letterario My Trieste, venendo entrambi premiati con il secondo e con il terzo posto. Questo è un qualcosa che mi rende fiero di proporvi oggi i due brani, e siccome Stefano si è occupato di introdurre le “Giovinezze triestine” io vorrei dire qualcosa de “I bachi da seta”.È un racconto forte, dove la moralità del nostro secolo è un pugno alla bocca dello stomaco. Questo mi colpisce più d’ogni altra cosa ogni volta che leggo qualcosa di Piero: una pacata riflessione può nascondere mille rovelli e mille drammi. Trieste può essere tutto perché ha molto, ma non sempre deve essere qualcosa di esteriore. In questo caso non appare che in fondo al racconto un molo Audace quasi dimenticato, mentre quello che invece conta sono i pensieri nascosti e tessuti in se stessi all’infinito come le spelaie. Così tutti noi siamo alla fine bachi che si affannano intorno a qualcosa, che si rintaniamo e aspettano di bollire, sembra dirci l’autore. Eppure c’è da chiedersi, alla fine, se si possa davvero essere così sereni e aspettare tranquillamente il fatidico snap!, se sia giusto che l’uomo si chiuda nel proprio bozzolo e aspetti una morte improvvisa senza fare altro che rosicare la propria foglia di gelso.Giovanni Benedetti
I bachi da setaCarissima,il contratto è scaduto e con un po’ di difficoltà ho lasciato la casa in cui ho vissuto questi ultimi tre anni; cambiare sistemazione non mi spaventa: la casa è nulla rispetto al paese. Al momento dormo da un caro amico fuori città, mi sono mosso da Coventry con entusiasmo.Non puoi immaginare che sorpresa: il mio letto è in una mansarda di legno, in mezzo a decine di filari di bachi da seta. Pensa il tuo amico disteso, la notte, tra settecento scricchiolii: questi bruchi mangiano e mangiano le foglie di gelso senza pace. Il mio amico mi ha detto che è da un po’ di anni che li coltiva, in piccola quantità, e che non gli è possibile sostenere un impianto maggiore; pure il tessuto che ricava è poco filo. Passo delle ore a guardarli, fanno un rumore che mi ricorda una vecchia conoscente che abitava in una villa a Monfalcone. Suo marito era morto col numero al braccio, poco dopo il tatuaggio; lei era rimasta vedova e sola, passava le giornate in compagnia di una pendola di legno e ottone. Io e mio padre andavamo a trovarla una volta ogni tanto e le portavamo un pezzo di strudel dalla bottega di fronte. Suo marito era stato interrogato per sapere dove fosse suo fratello, antifascista, e poiché non aveva voluto rispondere, fu mandato in Risiera accusato di essere partigiano. Durante il tragitto però era riuscito a rubare il fucile alla guardia nel retro, a uccidere lei e il guidatore, entrambi ragazzi di vent’anni. Come ripeteva la vedova però, bisognava decidere: o mi, o ti. Il marito riuscì ad arrivare fino alla porta di casa, ma lei non lo sentì nemmeno bussare: era stato raggiunto da altri soldati e tramortito davanti casa senza poter chiamare. Nemmeno un urlo. Un suo compagno di fuga scrisse una lettera alla vedova raccontandole dell’impresa, e i vicini di casa le raccontarono quello che avevano visto dal balcone. Il marito venne mandato in Risiera e infine ucciso. Tutto si svolse in silenzio, questo la tormentò: che lei fosse in casa mentre gli strappavano il dito dal campanello.Resto in questa stanza la maggior parte delle ore, ormai ho imparato a conoscere i diversi rumori. Ho letto un libro e osservo questi animali fare quello che facciamo anche noi: affannarsi attorno a una cosa; ci vogliono quindici bachi per fare un grammo di seta. Cara Anamarija, noi siamo come loro, ci rintaniamo da qualche parte e moriamo prima di uscire.Il baco è il secondo animale più studiato, perché è fondamentale per l’economia. Nei diversi mesi che ho passato in questa soffitta li ho visti ingozzarsi fino a raddoppiare, poi salire al bosco quand’era il momento; lì si sono nascosti nella prima spelaia, tessuta tracciando con la testa il simbolo dell’infinito. Nonostante ciò sono morti bolliti. Quando gliene parlo, durante le cene, il mio amico non capisce; con calma gli dico che in fondo potrebbe anche smetterla, che non gli è necessario per vivere, ma lui risponde che ormai è un abitudine, che non ci si può lamentare delle tradizioni. Io gli dico che anche i nostri capelli sono stati usati per fare i tessuti, anche la nostra pelle ha ricoperto le lampade nei salotti; lui mi dice di non esagerare, e di quietarmi. Allora mi passa l’appetito, appena finita la cena ritorno alla mia mansarda e guardo i bruchi, fra di loro cerco quello che mi rappresenta. Sera dopo sera non solo scopro che esso esiste, e l’ho individuato in un magro bruco impaurito che prima di ogni morso si guarda intorno, ma anche che in questi filari c’è la mia terra. Ogni volta che li guardo scopro i miei compaesani: c’è la vecchia vedova; c’è mio padre e mio fratello; c’è il prete di Sant’Ambrogio, quel vermone che si dimena rimproverando tutti a destra e a manca; c’è il panettiere di Panzano che di notte lasciava la moglie a dormire e invitava gli amici a bere in bottega fino al mattino, e d’estate se passavi presto ti metteva un panino in borsa e un bicchiere in mano, tanto che una volta sono andato a prendere il pane e sono tornato a casa ubriaco; e ci sei tu, Anamarija, quel vermetto bianco con le macchie, indaffarata a scoprire il nuovo ramo di gelso, sembri straniera. Guardo dall’alto il paese che si dimena, mi chiedo quando bolliremo. Ora sono qui in Inghilterra, ad attraversare le scorciatoie previste dai vecchi piani industriali; ho lasciato che queste architetture mi affascinassero e ora rimarrò ad ammirarle in attesa. Aspetto lo snap! dei nervi, e questo sarà l’arrivederci, ma fino in fondo sono sereno. Ricordo, quando venivo a trovarti a Trieste, ci sedevamo sul molo a guardare la costa e indovinavamo l’Istria. Adesso capisco perché l’animale più studiato è l’uomo: è fondamentale per l’economia.Con affetto,Michele
Piero Rosso
XI
Gelatina d’argento - Lewis Hinedi Marco Sinuello
È un giorno caldo di fine Marzo a Madrid quando decido, insieme ad un’amica fran-
cese, di andare a visitare un’esposizione foto-grafica di Lewis Hine. Inizialmente il nome non mi diceva niente ed infatti non avevo sottolinea-to l’evento sul giornale con la penna rossa come sono abituato a fare, per richiamare con maggior attenzione gli eventi che mi interessano; ma poi cerco su internet per puro caso e mi accorgo che il tipo è parecchio conosciuto, se non altro per la inflazionata foto degli operai seduti su di una trave d’acciaio durante la costruzione dell’Em-pire State Building di New York negli anni ’30. Così raccolgo le mie cose, la macchina fotogra-fica, contatto Claudia su facebook e si va verso la fundacion Mapfre per cibarci dei 180 scatti del sociologo americano, perché prima che foto-grafo è questo che era Lewis Hine. Lewis nasce nel 1874 ad Oshkosh - una città del Wiskonsin che nella seconda metà del XIX secolo aveva sviluppato una fiorente industria del legname – che lascerà dopo aver risparmiato abbastanza soldi da permettersi gli studi al college; Chica-go, Columbia e New York saranno le universi-tà che sceglierà per studiare sociologia e sarà proprio con questi studi e con il suo passato da lavoratore in cui secondo me risiede il suo rap-porto con la macchina fotografica. La macchina fotografica fu infatti per Lewis un mezzo di dif-fusione culturale e di inchiesta sociale, un mez-zo che cercò di diffondere anche tra gli studenti a cui insegnò nei suoi anni dietro la cattedra, un mezzo che utilizzò per promuovere riforme so-ciali attraverso la testimonianza data dalle sue fotografie che sapevano trasmettere senza filtri e senza scrupoli le condizioni lavorative dei bambini impegnati nelle varie fabbriche e nelle miniere statunitensi di inizio secolo.
«La fotografia non sa mentire,
ma i bugiardi sanno fotografare»
Nella ruggente America di inizio secolo, le macchine e l’automazione – soprattutto nel mondo del lavoro e a maggior ragione nel mondo industriale – avevano preso il sopravvento sull’uomo e sul lavoratore che, grazie o a causa della prima guerra mondiale, si era visto trascinato verso un progresso che pareva inarrestabile, un progresso che secondo i suoi sostenitori non avrebbe che
portato benessere a tutti, anche se questo, e fin dall’inizio fu evidente, avrebbe previsto qualche vittima sacrificale. È in questo scenario fatto di iperproduzione, successo, imprenditoria che Lewis si occupa di quella miriade di persone costituita da operai, lavoratori, emigranti, donne e bambini sulle cui spalle si poggiava – e perché non possiamo dire continui a farlo – la fortuna dell’elite della società dell’epoca. Così è grazie alla sua fotocamera che l’Uomo come in una forma di rinascimento dell’età industriale conquista il centro dell’obiettivo, il centro delle macchine da lavoro e il centro della vita; è in questo modo di scattare le foto che Lewis vuole portare l’attenzione del lettore e dell’osservatore (uso lettore perché i suoi lavori di inchiesta vennero pubblicati in libelli per conto di diverse associazioni, libelli per i quali egli stesso curava la descrizione delle foto) verso le persone che rendevano ogni giorno possibile il “progresso”, verso quegli uomini, quelle donne e quei bambini senza i quali le macchine ogni mattina non potevano essere messe in moto, non potevano essere riparate e non potevano produrre; quelle macchine che grazie alla sensibilità insita in lui e grazie
ai trascorsi “scolastici”, attraverso gli studi di psicologia, ora diventano subordinate all’Uomo, ritornando ad essere serve dell’Uomo e non padroni dell’Uomo e della sua vita. Ma il fine del sociologo non si ferma nel voler denunciare le condizioni lavorative, non si ferma nel voler riportare l’Uomo al centro del lavoro e della vita, non si ferma a “colpire” la gente estranea a questo mondo ma vuole che la sua opera, la sua inchiesta, le sue fotografie raggiungano con il loro messaggio anche i soggetti fotografati.I primi decenni del secolo scorso accolsero tra le altre trasformazioni anche la comunanza degli spazi pubblici – soprattutto dopo la prima guerra mondiale – tra le varie classi sociali; fino ad allora infatti le giornate per chiunque trascorrevano in ambienti separati, la vita di un operaio difficilmente si sarebbe “scontrata” con quella di un medio borghese o di un aristocratico, ora invece tutto queste cominciava a cambiare, lo scenario vitale di operai, burocrati, borghesi ed aristocratici diveniva gradualmente lo stesso sbattendo in faccia alla buona società i volti e le mani annerite dalle polveri industriali di quanti permettevano il benessere dei pochi. È in queste sfumature della vita che Lewis interviene di rimando sui suoi soggetti attraverso le istantanee: attraverso di esse infatti egli volle far emergere l’orgoglio dei lavoratori per quello
che facevano – coscienza di classe? - cercando di nobilitare il lavoro e mettere nuova luce sulle mani incallite e sulle facce impolverate dei migranti, utilizzati in gran numero per i lavori che gli americani non volevano accettare. Lewis però non vuole fermarsi a inorgoglire i lavoratori, vuole spingersi oltre ed eroicizzare i lavoratori stessi, immolarli ad una condizione quasi di super-uomini perché altro non potevano essere per sopportare simili condizioni di lavoro, è cosi che i sorrisi compaiono sui volti ora consapevoli della loro importanza per la società dell’epoca. L’esaltazione del lavoratore è portata alla vetta più alta grazie ad un trittico di Lewis Hine del 1925 chiamato “Man at work”; sotto le tre foto una dicitura manoscritta dal fotografo recita:
“Not in clanging fights and desperate marches only is heroism to be looked for. But on every bridge and building that is going up to-day.
On freight-trains, on vessels and lumber-rafts, in mines, among the fireman and policeman. The demand for courage is incessant and the supply never falls. These are our soldiers, our
sustainers, the very parents of our life”1
Nonostante i suoi ultimi anni di vita non furono facili in quanto la sua metodologia di ricerca e di approccio alla fotografia e alla sociologia sembravano superati, Hine continuò comunque il suo lavoro divenendo freelance con la stessa forza espressiva e con le stesse convinzioni, anche se con un cambiamento di stile, negli attimi finali molto più attento all’astrattismo seppur negli stessi ambiti lavorativi. È forse questa sua sensibilità, il suo pionierismo per quel che riguarda il fotogiornalismo, la convinzione interiore, che in questo periodo di crisi ritrova – se mai l’avesse persa – l’attualità della sua opera e del suo lascito, costituito dai libretti e dalle numerose gelatine d’argento sulle quali il tempo sembra quasi non aver posato le sue grinfie.
1 L’eroismo non si ricerca solo nel fragore delle lotte e nelle marce disperate. Ma sopra ad ogni ponte e palazzo che oggi viene costrui-to. Sopra i treni merci, sopra le navi e sopra le zattere, nelle miniere, tra il pompiere e il poli-ziotto. La richiesta di coraggio è incessante e il rifornimento non cala mai. Questi sono i nostri soldati, coloro che ci sostengono, i veri genitori della nostra vita.
XII
Going down with a Bang!di Giulio Rosani
M entre ragionavo sulla si-tuazione economica come
ci viene mostrata ultimamente da giornali e telegiornali, non ho potuto fare a meno di paragonare l’andamento del mercato alla fine della vita di una stella. Ad alcuni sembrerà strano, altri forse sapran-no poco di quello di cui sto parlan-do, quindi fornirò prima una breve descrizione del fenomeno chiamato “supernova” e poi spiegherò come questo si collega alla situazione at-tuale.In una stella agiscono principal-mente due aspetti fisici: la gravità e la termodinamica. La prima cerca di raggruppare materia in alcuni punti tramite l’attrazione gravitazionale, creando disomogeneità nello spa-zio. L’altra vorrebbe invece portare tutto lo spazio ad uno stato omoge-neo, perciò a temperatura e densità uguali in ogni punto. Quindi la ter-modinamica vorrebbe sparpagliare la materia, nel nostro caso la stella, ma la gravità impedisce che ciò accada. Quando queste due azioni sono in equilibrio la stella è stabi-le, e questo avviene perché il peso degli strati esterni viene contrasta-to dall’energia emessa sotto forma di radiazione dalle fusioni nucleari che avvengono al centro della no-stra stella. Essa non collassa né si sparpaglia fin quando è stabile e ha carburante da bruciare. Quando
finisce il carburante la stella smette di emettere la radiazione sufficien-te a supportare il suo peso e inizia a collassare riscaldando il gas di cui è composta. A questo punto, se la massa è sufficiente può riaccender-si, in caso contrario continua a col-lassare, morendo. Se il nucleo della stella è composto di ferro, questo non può più accendersi perché la reazione risulta svantaggiosa dal punto di vista energetico. Inizia la via verso una supernova. Per arri-vare a questo punto la stella deve avere massa maggiore di 8 masse solari, altrimenti la sua evoluzione si ferma prima di formare ferro nel nucleo ed essa evolve in una nana bianca, senza farsi notare troppo.Il collasso della stella di 8 o più masse solari genera energia cineti-ca, ovvero il gas inizialmente fermo viene messo in moto verso il centro della stella. L’energia ottenuta dal moto del gas si traduce in calo-re aumentando la temperatura di questo. Aumentare la temperatura significa generare pressione verso l’esterno che potrebbe contrastare la gravità. Questo effettivamente potrebbe funzionare se non fosse che analizzando l’andamento della pressione in una stella, soprattutto in questo caso, ci accorgiamo che questa dipende dalla massa. Un aumento di pressione quindi equi-vale ad un aumento di massa, che
equivale ad un aumento di gravità. La stella quindi combatte la gravità generando altra gravità. Si capi-sce che la cosa non funziona ed il collasso non si ferma. La densi-tà nel centro aumenta sempre più rapidamente, in quanto il collasso è sempre più veloce non venendo frenato da nessuna forza contraria. Si arriva a questo punto ad una densità tale che gli elettroni vengo-no catturati dai protoni dei nuclei a formare neutroni. La cattura elet-tronica è dovuta anche al fatto che i nuclei ormai non esistono più, i fo-toni (la luce generata dalla materia caldissima ottenuta dal collasso) ad alta energia rilasciati durante il collasso li hanno “spaccati” tutti. Ovviamente tutto questo avviene nel nucleo, al centro della stella. Si nota che la pressione dovuta al gas di neutroni, di cui ora è costituito il nucleo, è molto diversa, più alta, rispetto a quella dovuta al gas di protoni ed elettroni che costituiva il nucleo prima. Questo permette uno stop repentino al collasso, che quindi si arresta istantaneamente, o quasi, e va a creare uno sciame di neutrini con elevatissima energia cinetica (99% dell’energia dovu-ta al collasso finisce qui) nonché un’onda d’urto (l’1%, ma ha co-munque livelli spaventosi di ener-gia) che spazza via gli strati esterni della stella. È questa fase la famosa
supernova. Quello che resta è una stella di neutroni, poca cosa rispet-to alla stella che c’era prima, in ter-mini di massa almeno.Per quanto riguarda le analogie con la situazione economica attuale posso dire che:– L’economia come la conoscia-mo ha finito il carburante, non è più in grado di sostenersi da sola.– Siamo in una fase di collasso in cui chi dovrebbe tirarci fuori da questo impiccio non fa altro che combattere la crisi con i metodi che l’hanno generata. Analogo al combattere gravità generando ul-teriore gravità della stella. Questa però non essendo intelligente non può fare altro, noi dovremmo al-meno capire che è il caso di cam-biare metodo fin quando siamo ancora in tempo.– La densità di “giramento di balle” è in rapido aumento e il collasso rischia di essere fermato da qualcosa che porta ad un’esplo-sione, dei cittadini. Positivo il fatto che il collasso si sia fermato, un po’ meno che dopo la supernova, reale o economica che sia, quello che resta sono macerie.Come conclusione vorrei poter esprimere la mia speranza in un’il-luminazione intellettuale che porti coloro che governano a cambiare strada prima che la gente decida che è il caso di fare il botto.
Don ChisCiotti e i suoi mulini a ventodi Ruben Salerno
Sono trascorsi vent’anni dal-le celeberrime stragi di ma-
fia di Capaci e via D’Amelio.In questi due decenni si sono susseguiti blitz mirabolanti delle forze dell’ordine, proces-si sontuosi, scandali televisivi, giornate della memoria. Le ma-fie però esistono ancora e sono, forse, più forti di prima.
Per dar riscontro a questa tesi basta leggere ciò che dicono (o non dicono) i giornali: revoca del 41bis a Troia (uno dei man-danti delle stragi), processo a Dell’Utri progressivamente in-sabbiato, video-poker evasori per 98 miliardi di euro che pat-teggiano e se la cavano con una multa di 2,7 mld, fondi europei per le energie rinnovabili ru-bati... Insomma la mafia è ben lungi dall’essere debole.
I più stimati intellettuali e ra-dical-chic però insegnano, da
Impastato a Saviano, che que-sta è un fenomeno culturale e sociale, che si deve combattere la mafiosità e che per farlo bi-sogna partire dalla gente comu-ne e istruirla.Così, dal buon cuore di un pre-te idealista e incazzato, nasce Libera: associazioni, nomi e numeri contro le mafie, che in questi vent’anni si è data da fare per sensibilizzare l’opi-nione pubblica su un tema così delicato, da Nord a Sud.Negli anni le attività si sono fatte sempre più numerose e partecipate. Fiaccolate, raduni nazionali, magliette comme-morative, lettura dei nomi di tutte le vittime, tutte iniziative accompagnate da bagni di folla in visibilio stile Ventennio. In essa si sono unite associazioni e sottoassociazioni preesisten-ti, per arrivare fino ai presidi universitari. Per farla breve, Libera, dall’essere un piccolo
embrione di rivoluzionari one-sti, si è trasformata in una ma-croorganizzazione in grado di schierare ai suoi raduni nazio-nali oltre 150.000 persone. Le attività si sono ampliate, hanno cominciato a esser premiati i contadini e i commercianti che si rifiutano di pagare il pizzo, si è creato un vero proprio mar-chio commerciale (LiberaTer-ra) e una redazione (LiberaIn-formazione). Le iniziative spa-ziano dal teatro alla fotografia, dai libri alla televisione.Sicché, alla ricorrenza dei vent’anni dalle Stragi, i vari responsabili di Libera girano il paese a tenere conferenze e dibattiti sul lavoro svolto e sui prossimi obiettivi.
Lo scorso 14 luglio, al teatro Verdi di Muggia (Ts) si è tenuto uno di questi incontri. La scel-ta della cittadina istriana non è casuale, infatti ha dato i natali
a Edi Cosina, poliziotto del-la scorta di Borsellino, ucciso anch’egli nell’attentato del ‘92.
A tenere banco, sul palco, i tre dell’Ave Maria: Don Ciotti, Felice Romano (segretario na-zionale del SIULP) e Lorenzo Frigerio (LiberaInformazione).In platea non mancava nessu-no, c’era tutta la componente “democratica’’ della giunta co-munale, gli intellettuali locali e ovviamente tutti gli adepti di associazioni e presidi. Ognuno orgoglioso della propria appar-tenenza e pronto a spellarsi le mani come Fantozzi quando parlava il Duca Conte.
L’incontro aveva per tema il punto della situazione dopo vent’anni, quasi fosse un giro di boa. Così,oltre alla smisurata retorica di rito dalle forti tinte autocele-brative, si sono accennati anche
XIII
di
Cari lettori,augurandovi un Buon Tutto per questa gior-nata, che spero per voi sia una giornata di sole, vi invito a ripercorrere con me una vi-cenda risalente a qualche giorno fa.Quel dì mi svegliai rintontito e attanagliato dal seguente quesito: “Cos’è una botte?”Non so perché nella mia mente nacque una domanda così balzana e inaspettata, ma vi posso dire che da subito tentai di trovarvi una risposta.Uscii di casa di buonora e mi recai nella soli-ta osteria, che frequento abitualmente. Appe-na entrato, mi trovai di fronte un lunghissimo tavolo posto in orizzontale, a mo’ di Ultima Cena. Seduti dietro al tavolo stavano quat-tro uomini, che riuscii a classificare subito a causa del loro abbigliamento. Un fisico, un filosofo, un aviatore e un letterato (niente-popò-di-meno-che Jonathan Swift, con tanto di lillipuziano sulla spalla).A tutti rivolsi il suddetto quesito, sperando che almeno uno mi desse una risposta soddi-sfacente. Ora vi riporto quello che i quattro mi dissero.Fisico: “Tanto per cominciare, le dico che la botte o tino, è tanto utile quanto difficile da trasportare.
La sua forma cilindrica con un rigonfia-mento al centro e la chiusura su entrambi i fondi servono per il trasporto. Infatti, quan-do la botte non viene trasportata attraverso quell’affascinante moto di rotolamento, deve stare in posizione verticale. Da qui si può ca-pire perché è doppiamente chiusa.
Per quanto riguarda l’utilità, invece, viene facile comprendere che è un ottimo conte-nitore, dato che garantisce un eccezionale isolamento termico del vino. Inoltre, la botte è ottima per i lunghi trasporti, che richedono anche mesi, dato che avvengono per mare.
Tanto di cappello, quindi, al nobile mestiere dei bottai, ai quali vanno i miei complimenti vivissimi.
Poi, le parlerei volentieri del paradosso idro-statico della botte di Pascal.
Si pensi ad una botte riempita d’acqua e chiusa, sul fondo della quale viene esercitata dal liquido una pressione di poco inferiore a quella massima che la botte può sopportare.
Se si pone un tubicino al di sopra d’essa e lo si riempie progressivamente d’acqua, ecco che, una volta raggiunta la quota limite, la pressio-ne del liquido provoca la rottura della botte.
Il paradosso sta nel fatto che, anche sosti-tuendo il tubicino con altri tubi di diametro maggiore e di diverse forme, la quota limi-te d’acqua a cui corrisponde la rottura della botte è sempre la stessa.
Pascal, a suo tempo, fece una scommessa, af-fermando che sarebbe riuscito a far scoppia-re una botte con un bicchier d’acqua. Vinse la scommessa! E ora sapete come fece!”
Filosofo: “Io le descriverò un mio collega carissimo, Diogene o Il Socrate pazzo. Un uomo, che oltre ad avere un’intelligenza ol-tremodo fuori dal comune, aveva anche la bizzarra abitudine di vivere in una botte.Egli riteneva che gli uomini conducessero una vita “artificiale”, ricca di illusioni e di false sicurezze. Sosteneva che i valori tradi-zionali della società (la ricchezza, l’onore, il potere) potessero portare solo al male; e che invece valori come la sofferenza e l’umiltà potessero condurre l’uomo verso la bontà.Diogene, esibizionista al massimo, dato che viveva in una botte, diceva che gli uomini avrebbero dovuto imparare dagli animali, in particolar modo dai cani. Infatti, quest’ul-timi, a differenza degli esseri umani, sono pienamente “liberi” sotto ogni aspetto. I cani possono eseguire liberamente le loro prati-che fisiologiche quando ne hanno bisogno, possono girare nudi senza inibizioni e posso-no distinguere istintivamente i loro amici dai
nemici, senza bisogno di parole. Per questi motivi, Diogene defecava in pubblico, insul-tava gli esseri umani che gli si avvicinavano e conduceva la sua vita liberamente, facendo tutte le cose insite nella natura umana, ma che la società opprime.Desidererei, poi, ricordarle il celebre episo-dio, divenuto ormai leggenda, dell’incontro fra Diogene e Alessandro Magno. Infatti, quando Alessandro si avvicinò alla sua bot-te per conoscere di persona il filosofo di cui aveva tanto sentito parlare, egli gli rispose:” Spostati, perché mi fai ombra!”. ”Aviatore: “Io sarò breve! Le dirò che il primo velivolo sperimentale della storia si chiama “botte volante”. Era un semplice monoplano in legno, con una fusoliera, un’elica e un mo-tore radiale. Spiccò il volo per la prima volta nel 1923 e fu chiamato così dai fiorentini per la sua caratteristica forma a botte.Quindi, caro ospite, se mi chiedete cos’è per me la botte, le dirò:”Per me la botte è questo straordinario velivolo”. ”Jonathan Swift: “Io le parlerò della “Favola della Botte”, un mio scritto che ritengo vera-mente geniale.Si tratta di una favola. Un pamphlet filoso-fico e satirico, una parodia del mondo della religione, della moda, della politica, del sa-pere. Con questo scritto ho voluto mettere a soqquadro quasi tutte le certezze dell’uomo moderno.Se leggerà la versione del mio testo a cura di Gianni Celati, ne saprà certo di più.Il titolo in inglese è : “A tale of a Tub”, un’espressione che in italiano corrisponde-rebbe a una “panzana”, una “frottola”.Lascio a lei la lettura del mio libro, spe-rando che la mia introduzione possa averla interessata. Non continuo, anche perché, se uno scrittore si mette a scriver troppo e con i cosiddetti “paroloni”, rischia di diventare estremamente noioso.
E secondo voi? Cos’è una botte?Saluti!
contenuti interessanti. Si è par-lato di disoccupazione, di ceci-tà ecclesiastica e di giovani.Don Ciotti, con voce soffoca-ta dal dolore, ha fatto notare come la mafia, al contrario del Paese, punti sui giovani. Per ogni arresto infatti è in grado di rinnovare l’organico pescando da una vasta “cantera” di gio-vani disperati, che per un toz-zo di pane e protezione accet-tano di collaborare anche solo come corrieri, facendo proli-ferare la “zona grigia”, ovvero quell’area di semi illegalità in cui sguazza la mafiosità.Per intendersi, si accetta il mi-nore dei mali, in modo da non aver grane né con la mafia né
con il potere costituito. Quasi si trattasse di entità diverse e a se stanti, ma questa è un’altra storia...
Il dibattito è continuato senza interruzione per oltre due ore, durante le quali è emerso for-temente il bisogno di sentirsi bravi e buoni. I vertici di Li-bera, com’è la moda politica negli ultimi anni, hanno coper-to di lodi sperticate l’attività giovanile e i fanti della propria crociata, esaltandone le qualità smisurate e gli eroismi, quasi si fossero dimenticati che gli eroi emergono dalle sconfitte, quasi non si fossero accorti che per fronteggiare un male così
grande non bastano le buone intenzioni.Non è sufficiente riunirsi una volta alla settimana e dire che la mafia è cattiva per sconfig-gerla, non basta fare le foto ai raduni nazionali per lavarsi la coscienza.Questo tipo di attività non può sconfiggere una realtà così in-tricata. Neppure la violenza del generale Mori negli anni ’30, con oltre 40.000 mila uccisio-ni, ha estirpato la mafia.
Le grida del povero Don Ciotti non riescono a sovrastare la ca-otica indifferenza dei molti. La vasta partecipazione alle mani-festazioni di Libera sembra un
semplice spostamento di masse per lo più ignare, rese fiacche dalla modernità e pronte a in-neggiare a chiunque sventoli una bandiera, ben lungi però dall’esser disposte a fare qual-cosa.Per sconfiggere la mafia ci vuole altro: servono istruzione superiore e non viziata, leggi univoche e non aggirabili, uo-mini responsabili al governo. Per dirla con una parola, serve uno Stato.Questi però invece che fa? Per dirla con De André:“Si costerna, s’indigna, s’im-pegna, poi getta la spugna con gran dignità.”
“Cos’è una botte?”di Solivagus Rima
XIV
“Cosa ne pensi del nuovo film di Allen?” è la domanda che tra i cine-amanti ricorre con pun-tualità ogni anno.Ebbene, vuoi per la sagacità dell’autore, che imprime un marchio di fabbrica ad ogni sceneggiatura, vuoi per il cast sempre azzeccato e non banale, i suoi film certo non passano inosservati.Per chi poi è un suo fan, come la sottoscritta, l’attesa per la nuo-va produzione è sempre parteci-pata e un po’ ansiosa: di vedere come se la sia cavata e soprat-tutto di vedere tra quali strata-gemmi e fili d’ironia si districa per fotografare uno spaccato della società contemporanea.In fondo l’originale capacità di Woody Allen è proprio questa: mostrarci le bellezze e soprat-tutto le storture della nostra vita, dal suo punto personalis-simo di vista, il che comprende una forte dose di sarcasmo, di disillusione e di cinismo (tratti imprescindibili dalle sue ope-re; ma si sa, o lo si ama o lo si odia!). Allora, ogni argomento, dall’amore alla morte, nei suoi film è trattato con una profonda leggerezza mai abbandonata ai cliché (sono invece le mille fra-si di Allen a diventare aforismi), sempre sul confine della battuta di spirito che davanti allo scher-mo ti fa ridere e quando torni a casa ti fa riflettere.Da quando poi ha intrapreso questo omaggio al caro Vecchio Continente, con “Vicky, Cristi-na Barcellona” e “Midnight in Paris”, oltre a sentirlo ancora più vicino, non aspettavo altro che il mio cineasta si misurasse con l’Italia, con Roma ovvia-mente. Mi rendo certo conto che questi film, essendo delle visio-ni di un americano in Europa, corrono il rischio di risultare, in
alcuni passaggi, un po’ troppo rarefatti ai nostri occhi, quasi sognanti, ma forse con “Mid-night in Paris” più che con tutti gli altri Woody ci ha dimostrato che questa caratteristica può di-ventare un valore aggiunto.L’annuncio dell’uscita di “To Rome with Love” non è inatte-so: lo stesso regista ci propone il lungometraggio come il de-gno compimento della “saga”, dedicato ai film di Cinecittà e soprattutto al suo amato Fellini.Forte di questo carico di aspet-tative vado a vederlo, natural-mente al cinema, e mi accorgo, con molta sorpresa, che la cu-riosità aveva fatto prede moltis-sime persone, anche quelli che in occasione di altri suoi film non seguono Allen con altret-tanta foga: i primi giorni le file erano talmente lunghe che la gente veniva invitata a vedere
un altro film o a tornare per lo spettacolo successivo.All’uscita mille voci, una bolgia di commenti positivi mescolati a critiche pontificanti che non ti lasciano nemmeno il tempo di pensare, finché sento qual-cuno porre la fatidica domanda: “Cosa ne pensi del nuovo film di Allen?” e l’altro un po’ im-barazzato, forse per non esser-si fatto ancora un’idea precisa, risponde, per non sbilanciarsi, che l’ha trovato “simpatico”.Il fatto è che è realmente sim-patico, divertente, alcune bat-tute sono davvero acuminate, ma possiamo dire che Allen può fare, e ha fatto, di meglio.Nel film vengono raccontate quattro storie tutte ambientate nell’Urbe.La prima vede il ritorno di Wo-ody Allen come attore nei panni di un padre nevrotico, che dap-
prima giunge a Roma per incon-trare il futuro sposo della figlia, ma poi non farà altro che inve-stire le sue attenzioni sul suoce-ro, un originale cantante lirico; la seconda è una paradossale e, a volte, al limite del grottesco riflessione sulla notorietà, che vede il nostro Roberto Benigni nei panni di un impiegato me-dio, diventato improvvisamente famoso; nella terza due provin-ciali sposini si scontrano con la veracità della capitale, ma dopo un malinteso con una escort (Penelope Cruz) e l’incontro con un importante attore (An-tonio Albanese), decideranno di ritornare a casa; infine la quarta storia, forse quella più “allenia-na”, vede un giovane architetto (Jesse Eisemberg) districarsi tra la propria fidanzata e la sua pro-vocante amica (Ellen Page), con Alec Baldwin negli originalissi-
mi panni di “grillo parlante” che dovrebbe far desistere il ragaz-zo dal cadere nella trama di am-miccamenti di quest’ultima.Non mi sento di sottoscrivere le critiche mosse ad Allen, ovvero di essere scaduto nel rappresen-tare un’Italia di stereotipi dove tutti sono cantanti d’opera, pa-parazzi o ricchi amatori: il re-gista ha semplicemente costru-ito quattro storie attorno alle cose che più ama o che più lo divertono dell’Italia. Da cui il “Rigoletto”, i fotoreporter che ci rimandano direttamente alle immagini de “La Dolce Vita”, il rapporto potente-escort che non poteva passare inosservato agli occhi di un così scaltro sa-tirico e infine la giovinezza e la sensualità (delle quali la quarta storia sembra il simbolo) che la Città eterna riesce ancora a rac-chiudere.
Ci potevamo forse aspettare che le bellezze romane fossero fotografate in modo da supe-rare il più patinato effetto car-tolina, ma purtroppo le rovine delle terme, la Cappella Sistina e piazza del Popolo diventano soltanto i palcoscenici di sketch più o meno riusciti.Ripensando al lungometraggio nel suo complesso, l’unica cosa che realmente non funziona è il fatto che manchi una storia si-gnificativa. Una storia che fun-ga da collante alle mille gag e che soprattutto coinvolga, emo-zioni; senza la quale il nuovo lavoro del cineasta newyorchese si pone lontanissimo dal prece-dente ambientato a Parigi, a cui Allen aveva donato moltissimo di sé, facendone un capolavoro degno di “Annie Hall” o di al-tri.Con “To Rome with Love” egli ha voluto fare un’operazio-ne completamente diversa. Ha chiamato molti più attori au-toctoni che non in tutti gli altri film, creando così una pellicola dal forte accento italiano in cui i soliti personaggi, un po’ psi-canalisti un po’ malati, cedono il passo ai protagonisti carica-turali di queste storie, che sono esagerate e diverse, ognuna trai-nata lungo i bizzarri binari della riflessione che l’ha innescata, ma in fondo tutte un po’ povere di vitalità.Bisogna anche dire che rimane un film godibile e spensierato, da vedere un sabato sera, maga-ri davanti una pizza.Ed è possibile che il nostro Wo-ody Allen non avesse, stavolta, una pretesa diversa.
“Non si cammina sempre sulle rose,
quando si va in giro per il mondo”
...parole al vento...
(Knut Hamsun, Un viandante suona in sordina)
Cosa ne pensi del nuovo film di Allen?di Alina
ScontrPennetra
XV
Stefano Tieri: Bisogna ripensare radicalmente il nostro stile di vita: se ogni società umana adottasse il modus vivendi americano l’umanità avrebbe bisogno delle risorse di cin-que pianeti (si legga a tal proposito “No PIL! Contro la dittatura della ricchezza” di Gadrey Jean e Jany-Catrice Florence). C’è chi, come l’economista Serge Latouche, sta in questi anni teorizzando un modello politico di «decrescita». Modello da molti (erroneamente) confuso proprio con la recessione che stiamo vivendo: «nella recessione tutti i beni che erano merci restano merci, solo che la gente non ha il denaro per comprarli. Nella decrescita alcuni beni vengono pro-dotti e scambiati al di fuori del mer-cato, mentre le merci che rimangono nel mercato richiedono meno sprechi per essere prodotte», chiarisce Mari-no Badiale sulle colonne di “Alfabe-ta”. Nella decrescita vi è, insomma, una volontaria riduzione dei consumi e al tempo stesso, tramite l’autopro-duzione dei beni essenziali a vivere, l’indebolimento della dittatura del mercato. Non più economia globale ma locale, non più competizione ma cooperazione, e di conseguenza non più massa ma comunità. Decrescita significa consumare solo il necessario (il passo difficile sta nell’eliminare i «falsi bisogni»), lavorare meno per vivere meglio, riappropriarsi del bene più grande che possiede l’uomo: il suo tempo, ovvero la vita stessa.
Lorenzo Natural: Effettivamente ci troviamo in un momento storico in cui questo sistema sta giungendo al capolinea. Tuttavia, non ritengo la decrescita la giusta cura per uscirne. Innanzitutto, sarebbe più opportuno parlare di a-crescita, piuttosto che di decrescita, come lo stesso Latouche afferma, in quanto lo stesso termine porta semanticamente una cognizione economica in sé.
Ciononostante, la decrescita parte da un presupposto – a mio modo di ve-dere – errato: la limitatezza delle ri-sorse. Come afferma Matteo Rovatti, «in realtà l’umanità avrebbe raggiunto il suo limite demografico assoluto già nella preistoria, se non avesse com-piuto scoperte come la conquista del fuoco, la costruzione di utensili e so-
prattutto l’agricoltura, che permette di sfamare molte più persone della cac-cia, a parità di territorio impiegato»: ciò che quindi oggi riteniamo irrag-giungibile, magari tra cinquant’anni non lo sarà più, e credo che questo sia storicamente oggettivo. Nell’uomo ri-siede da sempre la volontà di superare i limiti che puntualmente lo ostacola-no, non tanto per un’intrinseca traco-tanza (hýbris), ma proprio per l’idea di sviluppo che dalle caverne ci ha portato alla scienza odierna. Questo, ovviamente, tenendo ben presente le deviazioni che hanno preso alcune conquiste scientifiche e, ovviamen-te, l’esasperazione di consumi e di sprechi quotidiani: ma, per uscirne, è proprio la crescita, lo sviluppo – e non la decrescita volontaria – la ricetta per acquisire una conoscenza e una con-sapevolezza radicata. Dallo sviluppo deve crescere un’alternativa alla bar-barie odierna, non dallo sterminazio-nismo regressivo che la decrescita, seguendo l’ideologia malthusiana.
Stefano: La critica terminologica la accolgo solo in parte: se la parola co-struita col prefisso “de” presuppone il concetto di cui afferma il contrario, non avviene lo stesso quando essa è preceduta dall’alfa privativo? “A-crescita” non dà analogamente spazio alla crescita, già solo nominandola? Il tuo ragionamento secondo me è viziato dal pregiudizio proprio della civiltà occidentale: costruisci il di-scorso collocandone i presupposti nel futuro, declinazione del tempo che di per sé non esiste (non ora, almeno). È assurdo costruire una previsione su elementi che non abbiamo, confi-dando nella speranza di una qualche rivoluzionaria scoperta scientifica. Nietzsche non aveva timore di avvi-cinare la scienza alla religione, anche per l’atteggiamento messianico che entrambe suscitano: «È pur sempre una fede metafisica quella su cui ripo-sa la nostra fede nelle scienza» (“Ge-nealogia della morale”), una fede che – appunto – non ha corrispondenze nell’immanenza del tempo presente. Cioran afferma: «Come si può fare a meno di indignarsi per l’assurdità del tempo, per la sua marcia nel futuro, e per tutte le insensatezze riguardan-
ti l’evoluzione e il progresso?» (“Al culmine della disperazione”); io ag-giungo un’altra interrogativa retorica: come si può vivere il proprio presente senza avere come interlocutore pri-vilegiato l’oggi (e quindi l’attuale equilibrio dell’ecosistema, quotidia-namente violato)?
Lorenzo: Se la mettiamo in termine di temporalità, qualsiasi alternativa socio-politica come anche la decre-scita stessa si occupa del presente e del futuro della società e della comu-nità di cui si occupa. Questo credo sia semplicemente fisiologico.
Ciò che mi preme sottolineare è che la decrescita pone le sue basi sul passa-to: pensare che un modello di politica sociale, economica e comunitaria ri-preso fondamentalmente dal medio-evo possa essere attualizzabile hic et nunc è errato. Quella che la decrescita descrive come “ritorno all’economia di sussistenza” rappresenta ora un modello inapplicabile: se pensiamo che sessanta milioni di cittadini italia-ni possano decrescere siamo lontani dalla realtà. Inoltre, la decrescita non propone un’alternativa valida in que-sto momento storico che possa trovare applicazione a macchia d’olio: anzi, il principio malthusiano – e ripreso poi anche da altri seguaci, tra cui Mas-simo Fini – secondo il quale “siamo in troppi su questo mondo”, non solo evita di porsi un’applicabilità su larga scala, ma sembra quasi strizzare l’oc-chio a una visione sterminazionista del mondo. Il ritorno all’agricoltura biologica, ad esempio, è incompati-bile con il tasso demografico attuale: se fino al 1800 un ettaro di terreno coltivato a mais equivaleva a duemila chilogrammi di raccolto, oggi, con lo sviluppo economico, lo stesso ettaro ne garantisce quasi sei volte tanto; ed è per questo che la popolazione è au-mentata esponenzialmente. Ritornare indietro, oggi, vorrebbe dire accettare miliardi di morti.
Stefano: porti giustamente in evi-denza il problema della sovrappo-polazione, ma è erroneo credere che chi sostiene la decrescita voglia sem-plicemente riproporre condizioni di vita medievali (anche perché, come osservi, il contesto è completamen-
te diverso): eliminare il superfluo (e i «falsi bisogni») non significa fare a meno, ad esempio, dei pannelli ad energia solare, in grado di rendere indipendente a livello energetico, con un limitato impatto ambientale, una piccola realtà.
E qui arriviamo al punto: le comunità che oggi vivono in questo modo sono in genere di piccole dimensioni (si agisce a livello locale, in quanto uno degli obiettivi è l’autosufficienza eco-nomica della comunità). Ti domandi perciò come si potrebbe “convincere” la parte rimanente dei cittadini, ov-vero la maggioranza. Forse non sarà possibile, ma non per questo la decre-scita avrà svolto un ruolo meno im-portante: già solo l’esistenza di que-ste comunità – un esempio concreto di vita “altra” – spinge chi ne entra a conoscenza a porsi delle domande, a mettere in discussione la propria fede nella crescita (perché di fede si tratta, non di ratio). Parlare di decrescita, scrive dopotutto Latouche, è come lanciare una provocazione. Sta all’in-dividuo saperla cogliere.
Lorenzo: Se si pone come provo-cazione, come sasso lanciato nello stagno, il discorso assume una co-erenza diversa e anche un ipotetico obiettivo definito. Ciò che non mi convince è, invece, la sua apllicabi-lità a un contesto più ampio, nonché il fondamento castrante che pone alla fisiologia umana dell’invenzio-ne, dello sviluppo, della crescita. Ciononostante prendere coscienza come comunità - e non solo come singoli - dei problemi che la decresci-ta evidenzia deve essere uno sprone a trovare alternative per saper in un certo senso dominare ciò che il pro-gresso ci ha inevitabilmente presen-tato e saper non solo scappare dalla macchina (macchina dalla quale è difficile scappare: «on n’échappe pas à la machine», direbbe Gilles Deleu-ze), ma piuttosto domarla. E per fare ciò, anche se potrebbe sembrare un discorso paradossale e vizioso, l’uni-ca strada percorribile è trovare attra-verso lo sviluppo e la crescita stessa una ricetta che ci salvi dal lato oscuro della modernità.
Sulla decrescita
Direttore Responsabile: Stefano Tieri
Impaginazione e grafica: Alberto Zanardo
Sito Web:www.chartasporca.tk
Per contattarci:[email protected]
Σταυρόλεξο - cruciverba
ORIZZONTALI 1. Come Mosè, Romolo ed Ercole; 10. Due cardinali; 16. L’opera più famosa non pervenutaci di Cicerone;
17. ; 19. La nota sigla romana; 20. Impugnatura d’arma medievale; 21. Il signore delle carte; 26. Iniziali di Eco; 27. Fece intuire la legge di Gravitazione Universale; 29. Iniziali di Cocciante; 31. Lo dice chi è rassegnato; 32. Lo sono Pietro, Nicolò e Sebastiano; 33. Nel centro di Forlì; 34. Racconto greco; 36. In Informatica si usa la due; 37. No problem; 39. Adesso… a Mezzogiorno; 40. Organizzazione Mondiale della Sanità; 42. Secondo nome di questa testata; 44. Iniziando l’atrio; 45. Congiunzione alternativa; 47. E’ stato barattato con un biglietto per il teatro delle marionette; 50. Profondo o relativo; 52. Monarca tragico (di Shakespeare); 54. Manie; 55. Muovi!; 57. Impediva il passaggio per Tebe; 59. Il Giovane adottato dal Vecchio; 61. Mi manca a Termini; 62. Fa affermare il contrario di quello che precede; 65. Può esserlo l’olio; 67. A volte manca; 68. Lo è troppo il pomeriggio (per Celentano); 69. Pordenone; 70. Centro Universitario Sportivo; 71. Per non continuare; 72. Nome di un recordman olimpico; 73. Comprensione immedesimante; 76. Rock band guidata dai fratelli Gallagher; 77. Serie con Marissa, Seth e Summer; 78. Figlio inglese; 79. La “voce della natura nell’animo dell’uomo”; 80. Poco…poco.
VERTICALI 1. Naomi e Gisele; 2. Range Rover; 3. Sposò Desdemona in segreto; 4. Componente indispensabile per la Barcolana; 5. Arnesi dispari; 6. Tropical Storm Allison Recovery Project; 7. Se greco; 8. Tre in lotteria; 9. Au; 11. Si tirano; 12. Voluntary Service Overseas; 13. Seconda e terza in reparto; 14. Lo è la pelle di drago; 15. O va in paradiso o va “all’incontrario”; 18. Primo re d’Italia nel 476; 22. Le pari della 27; 23. Adessoconosci; 24. Riga alternata; 25. Chiassoso; 28. Rese famoso George Clooney; 30. Ci lottava Zeno; 34. Centrali dell’isola di Saffo; 35. La speranza di Cicerone; 36. L’ultimo specchio di Julia Roberts; 38. Cin-cin latino; 41. Un tipo di forza militare; 43. Ci si sono cimentati Orazio, Manzoni e Foscolo; 46. Quello del Gobi è freddo; 48. Terna presa tra le 21; 49. Capitale del nord; 51. La dottrina di Seneca; 53. Dove si cerca il Togo; 56. Cane a pois rossi; 58. Né sì né no; 59. Breve filmato pubblicitario; 60. Quasi vino; 61. …kwondo; 63. E’ il padre di tutti i vizi; 64. Ora latina; 65. Il nome greco del pianeta rosso; 66. Pari in acqua; 68. Asso senza congiunzione; 72. User Interface; 74. Alcune di pane; 75. E’ inglese.
Orizzontali VerticaliL’indovinello
michelangiolesco:
Di due madri son molti figliolini
Che l’un per uno si somiglian tutti,
C’hanno altrettanti fratei consobrini
Simili e in simil modo, ma più brutti.
Soltanto nel gioco è possibile per l’uomo essere veramente libero. (Juli Zeh)
di Manuela e Sara