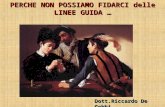Non possiamo non dirci
Click here to load reader
-
Upload
sigismondimarco -
Category
Education
-
view
277 -
download
2
description
Transcript of Non possiamo non dirci

DANTE E ROMA
Nell’affrontare questo tema, molto impegnativo, si ha come l’impressione di dover condensare l’oceano in una goccia. Roma e Dante, ovvero: due infiniti. E in che modo conciliare il parodosso di due infiniti? Forse con la vivente sintesi dell’Uomo – macrocosmo in microcosmo: essere finito ma infinito – che sia Roma sia Dante racchiudono e rappresentano nella sua maestosa e insieme risibile, problematica complessità. “Umana commedia” potremmo chiamare il capolavoro del Poeta Sommo, se tutto in essa non tendesse in verticale, sulla linea vertiginosa di uno sguardo proteso a Dio, Sommo Bene da cui procede, fino al superno punto in cui s’illuia. Ma è la divinità dell’uomo che, nel gorgo ineffabile, finisce per rivelarsi: è “la nostra effige” che gli pare pinta dentro il Suo mistero. Sostenuta dagli apparati teologici e filosofici del Medioevo, la visione che Dante ha del mondo nasce dalla ferma convinzione che la Verità esiste. Il senso ultimo dell’universo è stato rivelato dalle Scritture: la conoscenza non è avventura di ricerca personale (pensiamo al “folle volo” di Ulisse), ma adeguazione a un patrimonio già dato una volta per tutte. Ogni elemento dell’esistente, dal basso all’alto, rientra dunque in un ordine mirabile: ogni cosa trova una giustificazione e un proprio fine. Per questo la Commedia può raccogliere tutti gli aspetti della realtà, dallo sterco di Malebolge al tripudio di luce dell’Empireo. L’uomo intero vi aderisce, vi si raffigura. Su di noi, sulla nostra essenza, sui termini entro cui siamo racchiusi, Dante ha scritto fra le parole più alte che labbra umane abbiano mai pronunciato. Ed è grande poeta perché anzitutto uomo, nella pienezza delle umane passioni. Congeniale dunque a Roma, la capitale del mondo: città che dell’Uomo, della sua divina umanità (o umana divinità) è specchio di storica e metastorica rappresentazione. Tutte le strade portano a Roma perché nel cuore di Roma, nel fondo di Roma, c’è il richiamo eterno dell’Uomo. Così come oggi a Dante, alla sua prodigiosa ricchezza di significati umani, veniamo e torniamo dalle direzioni più diverse e lontane: lecturae, trasmissioni televisive, addirittura un’Opera-musical… Eccolo, l’uomo Dante, in un memorabile ritratto di Cesare Marchi, con quel «nasone a rampino che pareva volesse agganciare la non lontana punta del mento sporgente, mascella volitiva, occhi d’uccellaccio arrabbiato. Era quello che usa dire un uomo interessante, un po’ orso, con artigli di velluto, i dolci artigli della poesia». Rispetto al tema di Roma occorre distinguere fra il Dante reale, nella sua concreta esperienza biografica, e il Dante ideale, proiettato in esperienza di pensiero. Nel primo caso parleremo di “Dante a Roma”; nel secondo (che il primo racchiude) di “Dante e Roma”. E già, perché Dante a Roma c’è stato, almeno una volta: un soggiorno che gli cambia la vita, in tutti i sensi, e lascia tracce indelebili nel corpo stesso della sua opera. Tracce così vive e precise che sembra difficile dubitare della visione diretta di ciò che nomina e descrive. Gli studiosi si sono da sempre sguinzagliati sulle orme del Dante visitatore, per raccogliere i suoi “souvenirs” romani. Fra i quali ricordiamo i più celebri, probabilmente nati dall’esperienza del Giubileo del 1300: lo smistamento dei pellegrini in due colonne a doppio senso su Ponte S. Angelo:
Come i Roman per l’esercito molto, l’anno del giubileo, su per lo ponte hanno a passar la gente modo colto che dall’un lato tutti hanno la fronte verso ‘l castello e vanno a Santo Pietro dall’altra sponda vanno verso il monte
(Inf. XVIII, vv. 28-33);

la “pina bronzea di S. Pietro” cui viene paragonata la faccia “lunga e grossa” del gigante Nembrotte (Inf. XXXI, vv. 57-58); Montemario (Montemalo), messo dall’avo Cacciaguida in relazione con il colle Uccellatoio di Firenze (Par. XV, vv. 109-110); e la “Veronica nostra”, reliquia già famosissima, esposta per l’occasione a S. Pietro: era l’immagine di Cristo stampata nel panno che la leggendaria Veronica gli aveva offerto perché si asciugasse il viso, durante la salita al Calvario (Par. XXXI, vv. 103-111). Nel nome di Montemalo può riassumersi la suggestiva visione dall’alto che, della Città Eterna, si apriva a quanti arrivassero da nord. Uno sguardo che poteva allungarsi fino al mare, nelle distese del cielo infiammato dal sole quando «quel da Roma» (cioè colui che guarda da Roma) «il vede quando cade» (cioè lo vede tramontare) «tra Sardi e Corsi» (cioè tra Sardegna e Corsica, nel mar Tirreno): sono i vv. 79-81 del XVIII del Purgatorio, e Dante sta probabilmente rievocando l’esperienza di uno degli ineffabili, struggenti tramonti romani, visto da Montemario. Ma i cercatori di tracce spesso esagerano: come il Bassermann, che invocava l’esplorazione dell’interno del Colosseo per la concezione dantesca della struttura infernale. È anche da escludere la tradizione della locanda dell’Orso, che mai poté ospitare Dante poiché quattrocentesca. Che Roma vide Dante al suo arrivo? Come apparve ai suoi occhi? Desolata, invero, e decaduta. Una campagna, intorno, arida e giallastra d’argilla e di secchi pascoli, sparsi di armenti e di greggi. Radi casali, circondati di orti e vigne. E un minaccioso sorgere, a sbarrare le strade irregolari, pietrose e sconnesse, di rozze torri e castelletti. Il centro della città era fortificato: non per comune difesa, ma per contrasto prepotente di famiglie (Savelli, Pierleoni, Orsini, Colonna, Frangipani, Annibaldi). Isolate, in mezzo alla campagna, le basiliche di S. Paolo e S. Lorenzo. La Roma medievale aveva soppiantato e in parte distrutto quella classica, ristrettasi a un quarto. Trentacinquemila abitanti contro i novantamila della florida Firenze. E, tuttavia, la presenza del papa garantisce Roma nella sua funzione di città-santuario, meta costante di pellegrinaggi (con buona pace dei romani che ci campano: bottegai, locandieri, artigiani, contadini, cambiavalute, etc.). Parleremo tra breve della grande occasione che, anche e specialmente in senso economico, rappresentò per tutti il Giubileo del 1300. Ora però non è più possibile differire l’urgenza di un passo a ritroso, che ci consenta di illuminare lo scenario storico, italiano ed europeo, in cui ci stiamo muovendo. L’Italia è lacerata dal contrasto fra Guelfi e Ghibellini, sul modello originario della Germania (discendenti gli uni dal duca Welff, fondatore della casa di Baviera; gli altri dagli Hohenstaufen, duchi di Svevia e signori del castello di Weibling): i primi aperti verso il potere di Roma; i secondi rigidi difensori dell’indipendenza da ogni ingerenza pontificia. Papa e Imperatore, dunque: le massime autorità medievali. È tuttavia un contrasto da adattare al “particulare” italiano, irto di faziosità localistiche, in coincidenza di certi interessi: contrassegnato dunque dal trasformismo, da un furbesco ondeggiare tra papato e impero a seconda delle circostanze. Perché, ad esempio, Firenze è guelfa? Perché i banchieri fiorentini (che prestano fiorini ai principi di tutta Europa) amministrano gli affari della Chiesa, riscuotendo in suo nome le “decime” in tutto l’orbe cattolico. I finanzieri del papa sono potentissimi giacché protetti da una garanzia metafisica: il papa può scomunicare i debitori insolventi. Così i fiorentini si infilano ovunque: Bonifacio VIII li definisce «quinto elemento del mondo». Getta così il suo occhio goloso sulla Toscana per farne suo feudo. E com’è questa Firenze guelfa? Una città in pieno sviluppo economico, dominata dal ceto borghese e imprenditoriale. Con gli “Ordinamenti di Giustizia” di Giano della Bella (1293), le leve del potere sono nelle mani dei mercanti. Gli aristocratici vengono esclusi dalle cariche pubbliche; poi, con i “Temperamenti” del 1295, possono accedervi purché iscritti ad una corporazione. Dopo la vittoria sui ghibellini di Arezzo a Campaldino, l’11 giugno 1269 – battaglia cui partecipa pure Dante, ventiquattrenne, tra i 150 fenditori a cavallo – i guelfi fiorentini si dividono in due correnti, fieramente nemiche: guelfi bianchi, afferenti alla famiglia dei Cerchi (capitanata da Vieri dei Cerchi); e guelfi neri, afferenti alla famiglia dei Donati (capitanata da Corso). I neri sono filopontifici a oltranza: Bonifacio VIII ha assegnato agli Spini, di parte nera, il monopolio degli affari della Curia. Quindi – non illudiamoci – i bianchi sono contro Roma soprattutto per la delusione di essere esclusi da quegli affari.

Ma Dante, iscrittosi all’Arte dei Medici e degli Speziali, scende nell’arengo politico per impegno etico e civile, non per accordi o compromissioni nelle anticamere dei guelfi. Imparentato coi Donati per mezzo della moglie Gemma (cugina secondaria di Corso), amico di Forese, è tuttavia dalla parte dei Bianchi, vicino loro per temperamento, ideali, simpatia. Dopo qualche incarico diplomatico (in qualità di ambasciatore di Firenze e mediatore politico), viene eletto priore, il 15 giugno 1300. È proprio al bimestre priorale che più tardi farà risalire la causa di tutte le sue sventure. Oltre che a Bonifacio VIII. E chi è questo Benedetto Caetani di Anagni, papa Bonifacio VIII? Un uomo che, in forza e a dispetto del proprio ruolo, è pienamente implicato nelle vicende che insanguinano di fiera discordia la lotta tra le famiglie patrizie romane. Odia i Colonna per la loro tendenza ghibellina, ma anche perché appoggiano i francescani spirituali; i quali non riescono a consolarsi per la caduta del loro idolo (Celestino V), e considerano Bonifacio VIII un papa illegittimo, usurpatore, simoniaco, incarnazione stessa della chiesa temporale che condannano e che, annunciando il prossimo avvento del regno dello Spirito Santo, ambiscono riformare (ma anche perché Bonifacio VIII ha abrogato gli atti sottoscritti da Celestino a loro favore). Bonifacio odia i Colonna al punto di bandirgli contro addirittura una crociata, di cui naturalmente approfittano gli Orsini per annientare i loro avversari, e che porta all’assedio di Palestrina, roccaforte colonnese, di cui Bonifacio ordina la distruzione. Pontefice discutibile ma abilissimo uomo politico, Bonifacio costringe vescovi, arcivescovi e abati ad accettare prestiti forzosi, col tasso del 60%, dalla banca degli Spini di Firenze, cui è interessato il nipote Jacopo. Gli Spini lo riforniscono anche di pellicce e velluti. Veste con paludamenti orientaleggianti, più da satrapo che da pastore d’anime. Incede nei cortei con la spada in una mano, nell’altra la croce: preceduto da un araldo che proclama a pieni polmoni essere il papa sovrano universale. Pieno di albagia e di fasto; iracondo, beffardo, privo di simpatia umana: «amato da pochi, odiato da moltissimi, temuto da tutti», scrive il Muratori. Autoritario, non tollera obiezioni. È ammalato di grandeur teocratica. Ed ecco il suo trionfale colpo di genio: il Giubileo. Già preannunciato nel Natale del 1299, viene promulgato ufficialmente con la bolla papale del 22 febbraio 1300: verrà concessa indulgenza plenaria a tutti i fedeli, purché giungano a Roma, entro l’anno, a pregare sulle tombe di S. Pietro e S. Paolo. Visita da prolungarsi per almeno 15 giorni, per i forestieri, e 30 giorni, per i residenti. Esclusi soltanto i “nemici della Chiesa”: gli odiati Colonna, re Federico d’Aragona e i cristiani trafficanti con i Saraceni. L’affluenza è senza precedenti: Roma diventa una Babele di lingue e costumi. A decine di migliaia, da tutta Europa, ci si fa romei. Dall’alto dei colli, così, si può godere la scena grandiosa: uno spettacolo di moltitudini affluenti da tutti i punti cardinali: a piedi, a cavallo, sui carri, carichi di bagagli: anziani sulle spalle dei giovani, come Anchise su Enea. Arrivati in vista della Città Eterna, come naufraghi che scorgono la terra, i pellegrini cantano: «O Roma nobilis… : O Roma nobile, regina del mondo, la più eccellente di tutte le città, rossa per il rosso sangue dei martiri, candida per i bianchi gigli delle vergini, noi ti salutiamo e ti benediciamo per tutti i secoli: salve». Nella calca, più d’uno muore schiacciato. I romani si organizzano per l’accoglienza. Vettovaglie abbondanti e a buon mercato, ma alberghi piuttosto costosi. In tutta Roma è grande il commercio di reliquie, immagini sacre e reperti antichi. I pellegrini si fanno anche turisti: si soffermano estatici a contemplare le rovine, col libro dei Mirabilia in mano. Un sentimento di stupore che provò anche Dante, «veggendo Roma e l’ardua sua opra», se lo utilizza nel XXXI del Paradiso per dipingere quello, tanto maggiore, che lo pervade dinanzi alla mistica rosa dei beati. Bonifacio può assaporare nella sua pienezza il senso della propria autorità. E poi, che non guastava affatto, furono floridi i conti dell’Anno Santo: sulle tombe dei due apostoli, dall’alba al tramonto, monete di tutte le nazioni venivano rastrellate da due instancabili chierici: «rastellantes pecuniam infinitam», scrive un cronista dell’epoca. Nella concezione bonifaciana, coerentemente espressa in decreti e bolle (di cui il vertice è rappresentato dalla Unam Sanctam del 1303), la sfera del potere ecclesiastico è dilatata al punto di assorbire e sottomettere quello temporale. La potestà papale non conosce praticamente più limiti: è plenitudo potestatis, di origine divina: ogni umana creatura deve essere perciò interamente

sottomessa al papa. Ma Bonifacio si dimostra miope nell’avvertire i limiti della sua autorità. E forse alza i toni nella misura in cui sente che il terreno comincia a mancargli sotto i piedi. Anche lo strumento della scomunica, a forza di usarlo, ha perso di efficacia. Gli imperatori di Germania (come Adolfo di Nassau o Alberto d’Austria) si disinteressano dell’Italia, il «giardin de lo ‘mperio», ma la Chiesa sembra incapace di riempire il vuoto di potere, legando a sé le genti e realizzando il principio guelfo: «i rematori che guidano la navicella di Pietro sonnecchiano», scrive Dante nella VI Epistola. A Firenze, frattanto, le ostilità fra Bianchi e Neri si aggravano: ormai è guerra aperta. Bonifacio ha nominato Matteo d’Acquasparta legato papale per la Toscana: dovrebbe in teoria pacificare le opposte fazioni, ma in realtà si adopera segretamente a rafforzare i Neri. Ma poi, subìto un attentato da un popolano, abbandona la città. Bonifacio chiama allora il conte Carlo di Valois, fratello di Filippo IV il Bello. Gli chiede di assoggettare i ghibellini italiani. Lo alletta con grandi promesse: il titolo di senatore e la mano di Caterina di Courtenay. Il Valois, truppe mercenarie al seguito, si reca direttamente ad Anagni. Presi gli accordi necessari, Bonifacio – il 3 settembre 1301 – lo nomina capitano generale dello Stato della Chiesa, e gli affida il compito di riportare la pace in Toscana. Il papa è certo di poterlo utilizzare per i suoi fini egemonici: lo manda alla “fonte dell’oro”. Carlo di Valois muove da Anagni prima del 20 settembre e alla metà di ottobre è a Siena. Dante è fra i più accesi nel subodorare l’imminenza del pericolo; fra i più tenaci nel capeggiare una minoranza oltranzista filo-popolare, di irriducibile opposizione alle mire del papa. Viene decisa un’estrema e tardiva mossa: inviare un’ambasceria presso Bonifacio. Uomini fiorentini – fra cui Dante – e forse anche messi di Bologna, partono ai primi di ottobre: troppo tardi.
Giunti li ambasciatori in Roma, il Papa gli ebbe soli in camera, e disse loro in segreto: «Perché siete voi così ostinati? Umiliatevi a me: e io vi dico in verità, che io non ho altra intenzione che di vostra pace. Tornate indietro due di voi; e abiano la mia benedizione, se procurano che sia ubbidita la mia volontà» (Cronache del Compagni).
Tra i due mandati indietro, sicuramente non c’è Dante (personaggio ormai molto in vista). Resta invece a Roma, in attesa di nuove istruzioni: almeno fino ai primi di novembre, quando gli giunge notizia (ma forse a Siena, sulla via del ritorno) che a Firenze la situazione è precipitata, e quindi avverte la vanità del suo incarico. I Bianchi sono caduti, messi in fuga dal nuovo governo nero. È il caos: violenze, repressioni, distruzioni, incendi e saccheggi di case (compresa quella di Dante). Torna pure Matteo d’Acquasparta. Dante, condannato in contumacia prima a un’ammenda di 5000 fiorini, poi alla pena di morte, non metterà più piede a Firenze. Glielo preannuncia l’avo Cacciaguida in Paradiso:
Qual si partì Ippolito d’Atene per la spietata e perfida noverca
tal di Fiorenza partir ti conviene.
Sull’ambasceria romana sono state sollevate varie ipotesi: se ad esempio sia stata ricevuta da Bonifacio nel palazzo di Anagni o a Roma in Vaticano; se dunque Dante si sia spinto fino alla città natale del Caetani, dove questi era solito trattenersi fino all’autunno inoltrato. Oppure, altra ipotesi: il Compagni, scrivendo che Dante «era anbasciatore in Roma», potrebbe riferirsi a una precedente ambasceria fiorentina (11 novembre 1300). In tal caso Dante a Roma ci sarebbe stato una volta sola: come romeo e, al tempo stesso, come ambasciatore. Un unico soggiorno, nell’autunno dell’Anno Santo. Risulterebbe peraltro strana, e provocatoria verso la terrificante suscettibilità di Bonifacio, la partecipazione all’ambasceria da parte di un uomo che, nel corso del 1301, come mai prima di allora, aveva potentemente tuonato contro le ingerenze pontificie. Unico o duplice il soggiorno, sta di fatto che Roma è presente in Dante come esperienza ben più profonda di quanto potrebbe apparire dai ricordi singoli di cose, luoghi, episodi. Importa un’interpretazione globale del suo mondo: di un pensiero che si accende e si focalizza proprio dopo l’incontro con Roma. Nella Commedia non c’è reminiscenza di terra e di popoli che non sia

comprensiva di rammarichi, rimbrotti, polemiche astiose. Un posto a sé ha invece Roma, la cui immagine eterna (più che storica) ricorre con la stessa intensità di Firenze: tuttavia, a differenza di quella, sempre positiva, gloriosa, degna di venerazione. Ne parla sempre con religioso turbamento, reverenza, amore, commozione. Eppure questo alto amore nasce da un’iniziale indifferenza, se non avversione. Lo ricorda nel secondo libro della Monarchia, il tempo in cui “vaneggiava”, meravigliandosi che il popolo romano avesse potuto trionfare ovunque senza incontrare sufficienti resistenze. E nel De vulgari eloquentia la grandezza antica di questo popolo viene addirittura derisa nella presente incarnazione di un rozzo popolaccio, che puzza e parla male: «pare che puzzino anche per pervertimento di costumi e atteggiamenti», dice Dante dei romani del Trecento. Quello che parlano è un “tristiloquium”: il più brutto di tutti i volgari italiani. I romani danno del tu, ma al contempo sono fastidiosamente presuntuosi per una gloria di cui non sono eredi. Questo fastidio per la plebe rozza e incivile, che Dante probabilmente avvertì durante il suo o i suoi soggiorni romani, non inficia assolutamente il rispetto sacrale per il significato altissimo della Città Eterna. Tuttavia è probabile anche che, prima di vederla con i propri occhi, non avesse egli inteso, di Roma, quello «spezial nascimento e spezial processo, da Dio pensato e ordinato», di cui ci parla nel quarto libro del Convivio. La storia di Roma, cioè, benché già ne conoscesse gli stupendi frutti letterari, non era ancora entrata pienamente dentro la sua vita, restando sostanzialmente estranea all’impegno di pace e giustizia della stagione politica fiorentina. Poi invece, galeotto anche lo spettacolo umano del Giubileo (dove, mire teocratiche a parte, si respirò un’autentica vibrazione religiosa), Dante scopre Roma nella sua grandezza storica ed ecumenica, e scorge, sotto le incrostazioni, la santità come suo volto più vero. Non ovviamente la Roma storica di Bonifacio VIII, centro di intrighi e di potere («là dove Cristo tutto dì si merca», scrive in Par. XVII, v. 51), ma la Roma della duplice universalità, eternamente cristiana ed imperiale, trasfigurata dalla sua reale condizione di decadenza. È questa la Roma che, come un termine ideale, gli si accende nella mente e dentro il cuore. Perché a un certo punto Dante, come in un lampo di rivelazione, capisce che non c’è contrasto, se non storico, fra Impero e Chiesa, aquila e croce: che la Roma imperiale e la Roma cristiana sono perfettamente integrate in un unico disegno provvidenziale. È proprio la giustificazione provvidenziale della Storia a riscattare il passato alla luce della sapienza di Dio. Non la violenza e il sopruso hanno generato il potere romano, ma la ragione divina: Roma dalla mano stessa di Dio è stata condotta a dominare e quindi ordinare il mondo, onde venisse quell’«ottima predisposizione», cioè la pace propizia alla nascita del Cristo. Tutta la storia antica viene quindi recuperata alla luce di questa preparazione, di questa prefigurazione. Si conciliano così i fatti della storia con le verità della fede: le ragioni della Roma pagana con quelle (più alte) della Roma cristiana. Ecco perché Dante sceglie Virgilio, il cantore delle origini di Roma e il profeta della nascita di Cristo (secondo l’interpretazione tardoantica e medievale della IV Egloga), come guida per il viaggio ultraterreno. Roma allora è città santa ed eletta: per la consacrazione del sangue dei martiri; per le memorie dell’alba della Chiesa; per le reliquie prestigiose che custodisce; perché è apostolicum culmen, sede del soglio pontificio; perché è Colei di cui Cristo ha confermato l’impero; perché tutto ciò che appartiene alla sua storia non è accaduto senza divina ispirazione. Leggiamo ad esempio nel IV libro del Convivio che Davide, capostipite della stirpe di Maria, nasce nell’esatto momento in cui Enea approda alle rive del Tevere. Roma è “alma”, cioè nutrice degli uomini, perché detiene e custodisce il senso delle più alte universalità morali del mondo; perché è nodo cardinale del tempo, nello scenario dei popoli e delle generazioni; perché è arca di civiltà, sintesi di tutto il passato e di tutto il futuro, nell’altezza millenaria del suo “imperium”; perché infine è la madre del diritto, nel suo umano e divino riconoscimento, al di fuori del quale non c’è che trionfo dell’anticristo, cioè anarchia, caos, brado scatenarsi della cupidigia, e il mondo non è altro che “aiuola feroce”. Ed eccolo allora rivendicare l’origine romana di Fiesole, poi tradita dai corrotti fiorentini; e raccogliere le anime del Purgatorio alla foce del Tevere, come a dire che Roma è la luce che brilla nell’abisso, il senso e il nome della salvazione; e affidare all’imperatore Giustiniano, il raccoglitore del Corpus Iuris, l’apologia di una storia che ricapitola, in una sintesi mirabile e fulminante, il sigillo solenne di un destino che trascende i confini della terra.

Questa Roma ideale, attivata dall’esperienza toccante del Giubileo e nutrita dal dolore dell’esilio, diventa metafora e specchio della Gerusalemme celeste: Cristo ne è il primo cittadino. Roma, dunque, è al centro della autobiografia politico-religiosa di Dante. La stessa Commedia è, per molti versi, proprio l’elogio e la rincorsa di Roma, della sua legge morale, della sua civiltà. L’esperienza dell’esilio, dicevamo, permette a Dante di allargare e approfondire gli orizzonti, da Firenze all’Italia al mondo intero. Sono ormai lontani gli anni del priorato e dell’ambasceria romana. Dante è cambiato: non è più il giovane animoso pronto a sfidare le ire del papa pur di restare coerente con se stesso, quale strenuo difensore delle libertà comunali. La sua concezione politica evolve. Bersaglio resta la corruzione in cui versa la Chiesa: solo che prima veniva attaccata dalla parte dei diritti del Comune fiorentino (per la gelosa difesa della sua autonomia), ora – con sguardo più ampio – dalla parte dei diritti dell’Impero. L’esule ha rotto con la «compagnia malvagia e scempia» dei fuoriusciti guelfi e, pur facendo «parte per se stesso», si è avvicinato agli ambienti ghibellini: nutre infatti ammirazione per l’istituzione imperiale e speranza nella sua restaurazione. Da qui il vivo interesse di Dante per alcuni personaggi della dinastia sveva, e la benevola commossa partecipazione nel descriverli: Manfredi, «biondo,bello e di gentile aspetto», che gli sorride dolcemente come un simbolo meraviglioso dell’età passata (Purg., III); Corradino di Svevia (Purg. XX); e Costanza d’Altavilla, madre di Federico II, trasfigurata in luce di santità nel III del Paradiso; da qui anche la suprema illusione per la discesa in Italia del nuovo imperatore Enrico VII di Lussemburgo, l’«alto Arrigo» cui Dante dedica la sua VII Epistola e dal quale spera, per qualche tempo, la possibilità di un ritorno in extremis a Firenze. Lo spettacolo delle città italiane lacerate da lotte civili, sopraffazioni e violenze, e il quadro di una Chiesa mondanizzata e corrotta, i cui membri, invece che pastori, sono “lupi rapaci”, lo inducono a ricercare la «cagion che il mondo ha fatto reo». Gli risponde Marco Lombardo alla metà del Purgatorio (XVI canto), quindi dell’intera Commedia: è colpa del libero arbitrio, giacché Dio aveva invece disposto che due potestà provvedessero a guidare gli uomini sulla retta via:
Soleva Roma, che ‘l buon mondo feo due soli aver, che l’una e l’altra strada facean vedere, e del mondo e di Deo. L’un l’altro ha spento; ed è giunta la spada col pasturale, e l’un con l’altro inseme per viva forza mal convien che vada.
La celebre teoria dei “due soli” va a ribaltare la metafora teocratica e ierocratica di Innocenzo III («così come la luna riceve la sua luce dal sole e per tale ragione è inferiore a lui, similmente il potere regio deriva dall’autorità papale lo splendore della propria dignità»), ma per converso anche le teorie di chi sosteneva derivare la potestà pontificia da quella, suprema, dell’imperatore. Il papa ha usurpato il potere temporale. I pastori della Chiesa puttaneggiano coi re della terra. La confusione dei due poteri ha prodotto danni infiniti e sanguinosi. La degenerazione risale addirittura al peccato originale, alla colpa di Adamo: da allora una certa infirmitas rende l’uomo esposto al continuo rischio di cadere. Per questo Dio ha fornito due rimedi di salvezza, che sono strumenti per sfuggire alla tentazione e appigli per mantenersi saldi: Impero e Chiesa. Il primo preposto alla felicità terrena, garantendo con l’esercizio legittimo del suo diritto la pace universale; il secondo preposto alla letizia celeste. Due soli: due poteri fondati in sfere perfette e autonome: capaci, quando necessario, di riequilibrarsi a vicenda, nel senso che se l’imperatore commetterà errori il papa lo consiglierà al retto governo, e viceversa. La «cagion che il mondo ha fatto reo» va individuata non tanto nella vituperata (e poi dimostrata falsa) donazione di Costantino, il quale ebbe sì il torto di volgere «l’aquila contra il corso del cielo», cioè di trasferire l’impero da Roma a Bisanzio, ma fece la donazione «sotto buona intenzion» (Par., XX, v. 56), come dote che il papa riceveva non a titolo personale, bensì a vantaggio dei poveri; non

tanto in questa, dunque, ma soprattutto nella latitanza di un imperatore in grado di porsi come executor iustitiae, supremo regolatore della vita civile, facendo rispettare le leggi ed obbligando così la Chiesa a tornare alla sua missione spirituale. Solo se è in pace e in concordia l’umanità può seguire la guida del papa e giungere alla salvezza. L’opera della chiesa ha il suo presupposto indispensabile nell’azione efficace dell’imperatore. Ma il fine della Chiesa, in assoluto, è più alto di quello dell’Impero, così come il cielo sta più in alto della terra: l’imperatore deve al papa una certa naturale reverenza. Questo progetto di restaurazione politico-religiosa è grandioso ma in realtà anacronistico, ormai superato dal corso effettuale della storia, che aveva sancito la crisi irreversibile dei due poteri universali e il progressivo emergere dei poteri locali, l’aurora del concetto di nazione. La costruzione poetica della Commedia nasce proprio da questa magnifica utopia regressiva, conseguente al rifiuto di un presente caotico: da un’ansia profetica e visionaria di palingenesi, di universale rigenerazione. C’è una grande, messianica speranza: che il mondo tornerà purificato. Il Veltro scaccerà la lupa, cioè la cupidigia che tutto avvelena. E il poeta si autoproclama profeta della nuova età, attraverso il messaggio lanciato dal suo sacro poema. Potrà così finalmente realizzarsi il terzo tempo di quella Roma «onde Cristo è romano», e di cui Beatrice gli annuncia che sarà «sanza fine cive» (Purg. XXXII, vv. 101-102), dopo la premessa dell’Urbe antica, il completamento di quella cristiana, e il trionfale epilogo di una Roma equamente imperiale e papale.
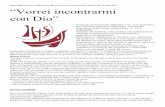


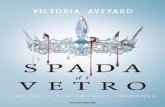



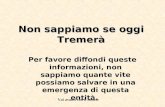

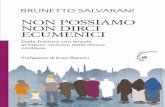


![Untitled-1 [] · 2020. 4. 5. · BALLIAMO. POSSIAMO INVITARE TUTTI 1 NOSTRI SENTIMENTI PERCHE ANCHE SE SIAMO TRISTI E SPAVENTATI POSSIAMO ANCORA CANTARE INSIEME! RICORDA CHE NON SEI](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/60e3d4a256b44a353f3ea7cf/untitled-1-2020-4-5-balliamo-possiamo-invitare-tutti-1-nostri-sentimenti.jpg)